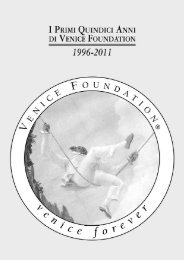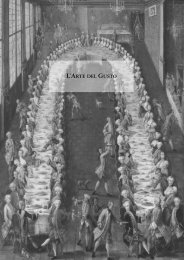NEWS N. 24 - The Venice International Foundation
NEWS N. 24 - The Venice International Foundation
NEWS N. 24 - The Venice International Foundation
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mariano Fortuny: la seduzione<br />
dell’arte decorativa<br />
CLAUDIO FRANZINI<br />
Eclettico, transdisciplinare per antonomasia, Mariano Fortuny,<br />
influenzato dallo spirito e dalla vita veneziana in una<br />
fusione armonica di acqua e cielo, arte e silenzio, ha percorso<br />
diverse “narrazioni” costituite da forma, luce e colore.<br />
Dotato di una straordinaria curiosità e vitalità in un sovrapporsi<br />
di molteplici esperienze ciò che emerge dall’opera di Fortuny è<br />
l’espressione formale di materie riplasmate<br />
e rimodellate con intuizioni<br />
originali, tra la conoscenza delle<br />
arti del passato e la sperimentazione<br />
delle tecniche, in un meraviglioso<br />
equilibrio tra sapere antico e modernità<br />
novecentesca. Una sorta di sogno<br />
di un’altra epoca. Il suo processo<br />
costitutivo procede con la convinzione<br />
e la sicurezza che l’unità del<br />
suo fare è data dai materiali utilizzati<br />
in quel determinato momento,<br />
nell’assidua ricerca di applicazioni e<br />
relazioni tra linguaggi diversi.<br />
In questa traiettoria singolare e discontinua, e per certi versi<br />
anomala, Fortuny, nella progettazione, nella creazione e nel brevetto<br />
di diversi oggetti (grafica, applicazioni<br />
scientifiche o produzioni seriali)<br />
si colloca come una sorta di<br />
protodesigner, sulla scia dell’esperienza<br />
di fine Ottocento ricca di fermenti<br />
culturali e dibattiti destinati a rivalutare<br />
la qualità creativa, la ma-<br />
[205] Disegno di brevetto per stoffa<br />
plissettata e ondulata, 1909.<br />
[204] Autoritratto fotografico di<br />
Mariano Fortuny y Madrazo.<br />
nualità artigianale, l’arte decorativa,<br />
ma più in generale l’arte applicata.<br />
Le istanze di progresso nell’impiego<br />
di nuovi sistemi produttivi, artigianali ma connotati da una nuova<br />
e forte espressione artistica, sorte soprattutto in Inghilterra dalle<br />
idee di John Ruskin e riprese da William Morris fondatore del<br />
gruppo Arts and Crafts, s’indirizzavano innanzitutto a una riqualificazione<br />
di carattere funzionale ed estetico e crearono le premesse<br />
al movimento Art Nouveau che si sviluppò in vari paesi con caratteristiche<br />
diverse. In Italia in particolare, giova ricordarlo, queste<br />
influenze arrivarono in modo frammentario, quando ormai le spinte<br />
Art Nouveau in Europa erano già in declino, e solo nel 1902 all’Esposizione<br />
delle Arti Decorative di Torino raggiunsero un momento<br />
di confronto tra manufatti di carattere regionale e desideri<br />
di stilizzazione nazionale. Nonostante gli sforzi, queste creazioni<br />
d’arte applicata risultarono degli eclettismi individuali poco supportati<br />
da produzioni di industrie artistiche o Scuole di Arti e Mestieri,<br />
quest’ultime promosse da istituzioni pubbliche nazionali che<br />
miravano allo sviluppo di tradizioni popolari di un paese che aveva<br />
raggiunto una sua unità in tempi relativamente recenti.<br />
In questo contesto Venezia si offrì con una peculiarità carica di<br />
significati che vanno ricercati in un programma per la città, fortemente<br />
perseguito dagli intenti di forze culturali e sociali che pur in<br />
un ambito d’immaginazione figurativa e artistica, vollero connotare<br />
un’idea di Venezia come luogo mistico e simbolo della bellezza<br />
e del fasto. Fu un percorso inevitabile: un numero rilevante di artisti,<br />
artigiani e piccoli imprenditori dagli inizi del Novecento sino<br />
agli anni trenta conversero fattivamente, in una paradossale “innovazione<br />
conservatrice”, in un accostamento ideale di “ricostruzione<br />
simbolica”, di bellezza effimera e scenografica, a volte ambigua e<br />
contraddittoria.<br />
Trasferitosi nella città lagunare nel 1889, proveniente da Parigi,<br />
dove compie la sua formazione, Mariano Fortuny y Madrazo<br />
completa gli studi artistici frequentando l’Accademia di Belle Arti<br />
entrando così in contatto immediato con il milieu intellettuale e<br />
culturale veneziano che da lì a breve tempo porterà all’istituzione<br />
della Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia. Conosce i pittori<br />
Cesare Laurenti, Mario de Maria, Ettore Tito, i critici e letterati<br />
Antonio Fradeletto, Pietro Selvatico, Pompeo Molmenti, Angelo<br />
Conti, ma anche Ugo Ojetti, il barone Giorgio Franchetti,<br />
Hugo von Hofmannsthal, Gabriele D’Annunzio, l’attrice drammatica<br />
Eleonora Duse. Uomo profondamente colto e sensibile, Mariano<br />
in questi anni si consacra ad attività che gli sono congeniali, in<br />
una continua alternanza di interessi tra pittura, illuminotecnica,<br />
scenografia e teatro.<br />
Alla fine dell’Ottocento Mariano<br />
prende possesso di uno studio: la soffitta<br />
di un imponente edificio gotico,<br />
il Palazzo Pesaro Orfei nelle vicinanze<br />
di campo San Beneto, che diverrà<br />
nel corso degli anni prima la-<br />
boratorio e poi la sua residenza definitiva.<br />
Al di là delle esperienze pittoriche<br />
che lo portano a progettare<br />
decorazioni murali e vetrate per edifici,<br />
opere mai realizzate, Fortuny si<br />
[206-207] Laboratorio all’ultimo<br />
piano di Palazzo Pesaro degli<br />
Orfei e, a sinistra, pubblicità con<br />
piantina della sua manifattura.<br />
confronta anche con la grafica e la<br />
cartellonistica; nel febbraio del 1898<br />
disegna il nuovo frontespizio della<br />
rivista di letteratura e arte Il Marzoc<br />
c o diretta da Enrico Corradini; nel<br />
1899 crea un’a f f i c h e p u b b l i c i t a r i a<br />
per un azienda che produce un burro<br />
speciale da tavola, “Tenuta di Sirchera”<br />
in provincia di Cremona. Nel<br />
campo del design illuminotecnico,<br />
tra il 1900 e il 1906, progetta e brevetta<br />
lampade ad arco, lampade a<br />
diffusione di luce indiretta e sistemi<br />
complessi di illuminazione per le<br />
scene teatrali e miscelatori per la regia<br />
illuminotecnica (ciò che ora viene<br />
comunemente chiamato mixer<br />
luci) che verranno per molti anni<br />
impiegati in innumerevoli teatri di<br />
[208-209] Mariano Fortuny con l’elettricista<br />
Giachetti nel 1906 in un teatro parigino e,<br />
in alto, la lampada a luce indiretta e<br />
diffusa ideata da Mariano.