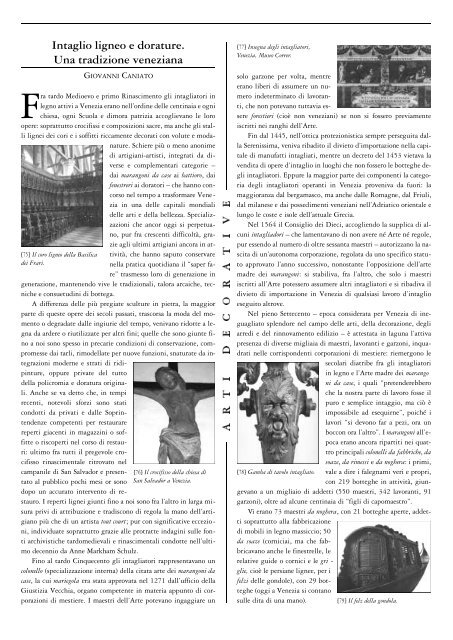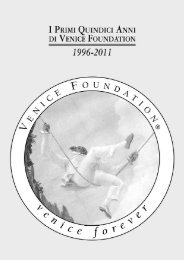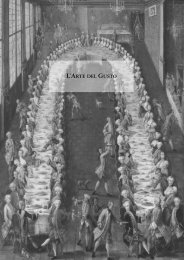NEWS N. 24 - The Venice International Foundation
NEWS N. 24 - The Venice International Foundation
NEWS N. 24 - The Venice International Foundation
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Intaglio ligneo e dorature.<br />
Una tradizione veneziana<br />
GIOVANNI CANIATO<br />
Fra tardo Medioevo e primo Rinascimento gli intagliatori in<br />
legno attivi a Venezia erano nell’ordine delle centinaia e ogni<br />
chiesa, ogni Scuola e dimora patrizia accoglievano le loro<br />
opere: soprattutto crocifissi e composizioni sacre, ma anche gli stalli<br />
lignei dei cori e i soffitti riccamente decorati con volute e modanature.<br />
Schiere più o meno anonime<br />
di artigiani-artisti, integrati da diverse<br />
e complementari categorie –<br />
dai marangoni da case ai battioro, dai<br />
fenestreri ai doratori – che hanno concorso<br />
nel tempo a trasformare Venezia<br />
in una delle capitali mondiali<br />
delle arti e della bellezza. Specializzazioni<br />
che ancor oggi si perpetuano,<br />
pur fra crescenti difficoltà, gra-<br />
[75] Il coro ligneo della Basilica<br />
dei Frari.<br />
zie agli ultimi artigiani ancora in attività,<br />
che hanno saputo conservare<br />
nella pratica quotidiana il “saper fare”<br />
trasmesso loro di generazione in<br />
generazione, mantenendo vive le tradizionali, talora arcaiche, tecniche<br />
e consuetudini di bottega.<br />
A differenza delle più pregiate sculture in pietra, la maggior<br />
parte di queste opere dei secoli passati, trascorsa la moda del momento<br />
o degradate dalle ingiurie del tempo, venivano ridotte a legna<br />
da ardere o riutilizzate per altri fini; quelle che sono giunte fino<br />
a noi sono spesso in precarie condizioni di conservazione, compromesse<br />
dai tarli, rimodellate per nuove funzioni, snaturate da integrazioni<br />
moderne e strati di ridipinture,<br />
oppure private del tutto<br />
della policromia e doratura originali.<br />
Anche se va detto che, in tempi<br />
recenti, notevoli sforzi sono stati<br />
condotti da privati e dalle Soprintendenze<br />
competenti per restaurare<br />
reperti giacenti in magazzini o soffitte<br />
o riscoperti nel corso di restauri:<br />
ultimo fra tutti il pregevole cro-<br />
cifisso rinascimentale ritrovato nel<br />
campanile di San Salvador e presentato<br />
al pubblico pochi mesi or sono<br />
dopo un accurato intervento di re-<br />
[76] Il crocifisso della chiesa di<br />
San Salvador a Venezia.<br />
stauro. I reperti lignei giunti fino a noi sono fra l’altro in larga misura<br />
privi di attribuzione e tradiscono di regola la mano dell’artigiano<br />
più che di un artista tout court; pur con significative eccezioni,<br />
individuate soprattutto grazie alle protratte indagini sulle fonti<br />
archivistiche tardomedievali e rinascimentali condotte nell’ultimo<br />
decennio da Anne Markham Schulz.<br />
Fino al tardo Cinquecento gli intagliatori rappresentavano un<br />
colonello (specializzazione interna) della citata arte dei marangoni da<br />
case, la cui mariegola era stata approvata nel 1271 dall’ufficio della<br />
Giustizia Vecchia, organo competente in materia appunto di corporazioni<br />
di mestiere. I maestri dell’Arte potevano ingaggiare un<br />
[77] Insegna degli intagliatori,<br />
Venezia, Museo Correr.<br />
solo garzone per volta, mentre<br />
erano liberi di assumere un numero<br />
indeterminato di lavoranti,<br />
che non potevano tuttavia essere<br />
forestieri (cioè non veneziani) se non si fossero previamente<br />
iscritti nei ranghi dell’Arte.<br />
Fin dal 1445, nell’ottica protezionistica sempre perseguita dalla<br />
Serenissima, veniva ribadito il divieto d’importazione nella capitale<br />
di manufatti intagliati, mentre un decreto del 1453 vietava la<br />
vendita di opere d’intaglio in luoghi che non fossero le botteghe degli<br />
intagliatori. Eppure la maggior parte dei componenti la categoria<br />
degli intagliatori operanti in Venezia proveniva da fuori: la<br />
maggioranza dal bergamasco, ma anche dalle Romagne, dal Friuli,<br />
dal milanese e dai possedimenti veneziani nell’Adriatico orientale e<br />
lungo le coste e isole dell’attuale Grecia.<br />
Nel 1564 il Consiglio dei Dieci, accogliendo la supplica di alcuni<br />
intagliadori – che lamentavano di non avere né Arte né regole,<br />
pur essendo al numero di oltre sessanta maestri – autorizzano la nascita<br />
di un’autonoma corporazione, regolata da uno specifico statuto<br />
approvato l’anno successivo, nonostante l’opposizione dell’arte<br />
madre dei marangoni: si stabiliva, fra l’altro, che solo i maestri<br />
iscritti all’Arte potessero assumere altri intagliatori e si ribadiva il<br />
divieto di importazione in Venezia di qualsiasi lavoro d’intaglio<br />
eseguito altrove.<br />
Nel pieno Settecento – epoca considerata per Venezia di ineguagliato<br />
splendore nel campo delle arti, della decorazione, degli<br />
arredi e del rinnovamento edilizio – è attestata in laguna l’attiva<br />
presenza di diverse migliaia di maestri, lavoranti e garzoni, inquadrati<br />
nelle corrispondenti corporazioni di mestiere: riemergono le<br />
secolari diatribe fra gli intagliatori<br />
in legno e l’Arte madre dei marango<br />
ni da case, i quali “pretenderebbero<br />
che la nostra parte di lavoro fosse il<br />
puro e semplice intaggio, ma ciò è<br />
impossibile ad esequirne”, poiché i<br />
lavori “si devono far a pezi, ora un<br />
boccon ora l’altro”. I marangoni all’epoca<br />
erano ancora ripartiti nei quattro<br />
principali colonelli da fabbriche, da<br />
soaze, da rimessi e da noghera: i primi,<br />
[78] Gamba di tavolo intagliato. vale a dire i falegnami veri e propri,<br />
con 219 botteghe in attività, giungevano<br />
a un migliaio di addetti (550 maestri, 342 lavoranti, 91<br />
garzoni), oltre ad alcune centinaia di “figli di capomaestro”.<br />
Vi erano 73 maestri da noghera, con 21 botteghe aperte, addetti<br />
soprattutto alla fabbricazione<br />
di mobili in legno massiccio; 50<br />
da soaze (corniciai, ma che fabbricavano<br />
anche le finestrelle, le<br />
relative guide o cornici e le gri -<br />
glie, cioè le persiane lignee, per i<br />
felzi delle gondole), con 29 botteghe<br />
(oggi a Venezia si contano<br />
sulle dita di una mano). [79] Il felz della gondola.