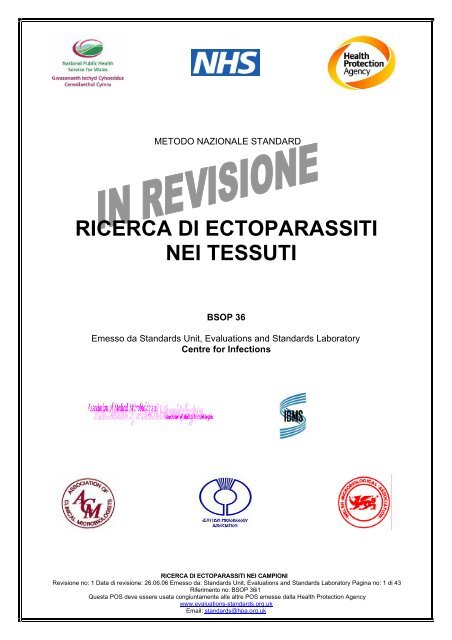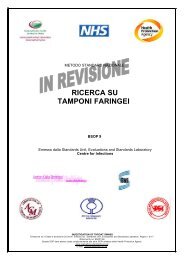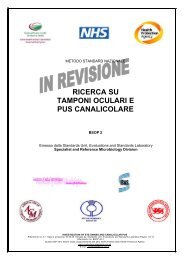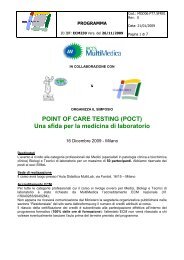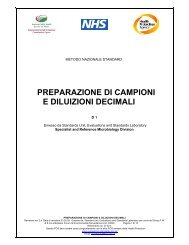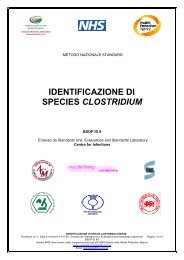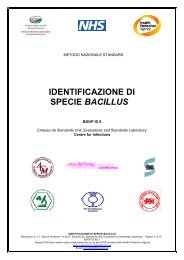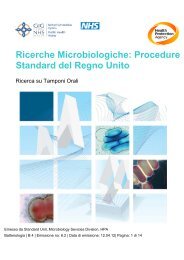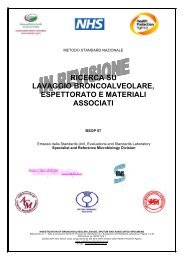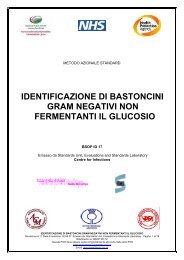RICERCA DI ECTOPARASSITI NEI TESSUTI - italbioforma
RICERCA DI ECTOPARASSITI NEI TESSUTI - italbioforma
RICERCA DI ECTOPARASSITI NEI TESSUTI - italbioforma
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
METODO NAZIONALE STANDARD<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong><br />
<strong>NEI</strong> <strong>TESSUTI</strong><br />
BSOP 36<br />
Emesso da Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory<br />
Centre for Infections<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione: 26.06.06 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina no: 1 di 43<br />
Riferimento no: BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente alle altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
STATO DEI METO<strong>DI</strong> NAZIONALI STANDARD<br />
I Metodi Nazionali Standard, che includono le procedure operative standard (POS), algoritmi e linee guida,<br />
promuovono l’adozione di elevati livelli di qualità, contribuendo ad assicurare la possibilità di confronto delle<br />
informazioni diagnostiche ottenute in laboratori diversi. Ciò consente la standardizzazione della sorveglianza<br />
sostenuta dalla ricerca, sviluppo e verifica, promovendo nello stesso tempo la salute pubblica e la fiducia del paziente<br />
nelle proprie strutture sanitarie. I metodi sono ben referenziati e rappresentano un buon standard minimo per la<br />
microbiologia clinica e per la salute pubblica. Comunque, utilizzando i Metodi Nazionali Standard, i laboratori<br />
dovranno tenere in considerazione le esigenze locali e potranno intraprendere ricerche addizionali. I metodi<br />
forniscono inoltre un punto di riferimento per un loro ulteriore sviluppo.<br />
I Metodi Nazionali Standard sono stati sviluppati, revisionati ed aggiornati con una procedura aperta di consenso ove<br />
le opinioni di tutti i partecipanti sono state tenute in adeguata considerazione ed i documenti elaborati riflettono il<br />
consenso della maggior parte degli stessi.<br />
I rappresentanti di alcune organizzazioni professionali, incluse quelle il cui logo appare sulla prima pagina, sono<br />
membri dei gruppi di lavoro che sviluppano i Metodi Nazionali Standard. L’inclusione del logo di una organizzazione<br />
nella prima pagina implica sostegno agli obiettivi ed al processo di preparazione dei metodi standard. I componenti di<br />
queste organizzazioni scientifiche hanno partecipato allo sviluppo dei Metodi Nazionali Standard ma le loro opinioni<br />
personali non rispecchiano necessariamente quelle dell’organizzazione di cui sono membri. L’elenco attuale delle<br />
organizzazioni professionali partecipanti può essere ottenuto tramite e-mail all’indirizzo standards@hpa.org.uk.<br />
Le prestazioni dei metodi standard sono condizionate dalla qualità di reagenti, strumentazione, procedure<br />
commerciali o prove messe a punto in loco. I laboratori dovrebbero assicurare che queste siano state validate e<br />
dimostrate idonee allo scopo prefissato. Devono essere adottate procedure di controllo di qualità interno ed esterno.<br />
Nonostante siano state osservate le più scrupolose attenzioni nella preparazione di questa pubblicazione, la Health<br />
Protection Agency o qualsiasi organizzazione di sostegno non può essere ritenuta responsabile dell’accuratezza o<br />
dell’utilizzo o di qualsiasi conseguenza derivante dall’uso o da modifiche delle informazioni contenute in questo<br />
documento. Queste procedure sono intese solamente come una risorsa generale per i professionisti che esercitano<br />
in questo settore, operanti nel Regno Unito, pertanto si dovrà ricorrere ad altri consulenti quando ritenuto necessario.<br />
Se si apportano modifiche a questa pubblicazione, si deve porre in evidenza dove sono state apportate modifiche al<br />
documento originale. La Health Protection Agency (HPA) dovrà essere informata in ogni circostanza.<br />
La HPA è una organizzazione indipendente che ha lo scopo di proteggere la salute della popolazione. Ad essa<br />
confluiscono esperienze professionali già appartenenti ad organizzazioni ufficiali. Maggiori informazioni riferibili alla<br />
HPA possono essere ottenute al sito www.hpa.org.uk<br />
La HPA è un’organizzazione che mira ad essere completamente in accordo con le direttive Caldicott. Ciò significa<br />
prendere ogni possibile precauzione per prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni sui pazienti e di<br />
garantire che le informazioni relative agli stessi siano mantenute in condizioni di sicurezza 1 .<br />
Maggiori dettagli possono essere ottenuti dal sito web www.evaluations-standards.org.uk. Contributi allo sviluppo dei<br />
documenti possono essere forniti contattando l’indirizzo standards@hpa.org.uk.<br />
Per cortesia prendere nota che la bibliografia è attualmente formattata con il software Reference Manager. Se si<br />
modifica o si cancella il testo senza avere installato nel computer il Reference Manager; la bibliografia non sarà<br />
aggiornata automaticamente.<br />
Riferimento suggerito per questo documento:<br />
Health Protection Agency (2006). Investigation of specimens for ectoparasites. National Standard Method Emissione<br />
1. http://www.hpa-standardmethods.org.uk/pdf_sops.asp.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 2 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
IN<strong>DI</strong>CE<br />
IN<strong>DI</strong>CE ............................................................................................................................................. 3<br />
PROCEDURA <strong>DI</strong> MO<strong>DI</strong>FICA ........................................................................................................... 4<br />
SCOPO DEL DOCUMENTO ............................................................................................................ 5<br />
INTRODUZIONE .............................................................................................................................. 5<br />
1.0 CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA ............................................................................. 39<br />
2.0 PRELIEVO DEL CAMPIONE .…............................................................................................ 39<br />
3.0 TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE ........................................................ 39<br />
4.0 PROCEDURA SUL CAMPIONE .......................................................................................... 40<br />
5.0 PROCEDURA <strong>DI</strong> REFERTAZIONE ..................................................................................... 40<br />
6.0 LIMITI .................................................................................................................................... 41<br />
7.0 SEGNALAZIONI ALL’HPA (SERVIZI LOCALI E GENERALI CDSC ED AL CENTRO<br />
CDSC PER LE INFEZIONI) ………………………….………………………………………….…<br />
8.0 RINGRAZIAMENTI E CONTATTI ………………………………………………………….…… 41<br />
BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………………………………..… 42<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 3 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk<br />
41
PROCEDURA <strong>DI</strong> MO<strong>DI</strong>FICA<br />
Documento di riferimento<br />
controllato<br />
Titolo del documento<br />
controllato<br />
BSOP 36<br />
Ricerca di ectoparassiti nei campioni<br />
Ciascun Metodo Nazionale Standard possiede una registrazione separata con le modifiche. Le modifiche di questa<br />
revisione sono riportate in questa pagina. Le precedenti modifiche sono disponibili presso la standards@hpa.org.uk.<br />
Qualora vi sia una revisione di pagine o vengano emesse pagine nuove il proprietario di ciascun documento<br />
controllato dovrebbe aggiornare la copia in laboratorio.<br />
Modifica<br />
Numero/<br />
Data<br />
Emissione no.<br />
Scartata<br />
Inserita<br />
Emissione<br />
no.<br />
Pagina Sessione(i) interessate Modifica<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 4 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Tipo(i) di campione(i): Artropodi ectoparassiti<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong><br />
<strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Sanguisughe<br />
SCOPO DEL DOCUMENTO<br />
Questa POS descrive l’infezione originata da artropodi, più precisamente da ectoparassiti e sanguisughe. Sono<br />
riportate descrizioni ed illustrazioni che differenziano gli ectoparassiti di comune riscontro nel Regno Unito da quelli<br />
associati a viaggi all’estero.<br />
INTRODUZIONE<br />
E’ importante accertare se nel paziente un ectoparassita causa i sintomi dell’infezione o funge da potenziale vettore<br />
della malattia. Gli ectoparassiti sono riconoscibili per dimensioni, colore ed aspetto. Il ricorso ad un’appropriata<br />
classificazione può essere utile all’identificazione di un ectoparassita2 .<br />
Questa POS descrive i più importanti ectoparassiti umani: pulci, pidocchi, cimici dei letti, zecche ed acari. Sono<br />
incluse anche larve di mosche, sebbene solo poche specie siano parassiti obbligati dei mammiferi.<br />
Gli artropodi ectoparassiti non sono correlati strutturalmente fra loro e formano un gruppo biologico più che<br />
tassonomico. Per la maggior parte gli artropodi parassiti sono ectoparassiti (vivono al di fuori dei loro ospiti), ma<br />
alcune specie sono associate più strettamente al proprio ospite umano ed agli animali.<br />
La morfologia di pulci, pidocchi, cimici dei letti, zecche ed acari presenta alcune caratteristiche specifiche di<br />
adattamento alla vita da ectoparassita. Queste comprendono assenza di ali, presenza di setole e protuberanze<br />
appuntite, strutture terminali sulle zampe atte ad avvinghiarsi a peli/piume dell’ospite ed una struttura corporea<br />
chitinizzata resistente. Tali caratteristiche riducono la possibilità di allontanamento del parassita da parte dell’ospite<br />
(l’ospite può infatti procedere ad accurata pulizia o a grattamenti in risposta a qualsiasi infestazione).<br />
BIOLOGIA DEL VETTORE ECTOPARASSITA<br />
In generale pulci, cimici dei letti, zecche ed acari di importanza clinica non sono ospite specifici. Sono principalmente<br />
zoofili ma si comportano da opportunisti nell’uomo.<br />
Al contrario, i pidocchi sono estremamente ospite specifici e trascorrono il loro intero ciclo vitale sull’ospite. Essi sono<br />
trasmessi per contatto fisico ravvicinato o tramite indumenti infestati. Sono i vettori del classico tifo epidemico, della<br />
febbre da trincea e di una tipica febbre ricorrente detta da pidocchio.<br />
Per completare il loro ciclo vitale tutti questi ectoparassiti possono richiedere un unico abbondante pasto o piccole e<br />
regolari assunzioni di sangue. Oltre alla trasmissione della malattia, i loro morsi causano sulla cute lesioni a lenta<br />
guarigione, che possono poi infettarsi con batteri. Si deve inoltre ricordare il ruolo delle feci e dei corpi stessi degli<br />
ectoparassiti come causa di risposte allergiche, quali asma, dermatite e rinite allergica, patologie in continuo<br />
aumento.<br />
TRASMISSIONE DELLA MALATTIA<br />
Gli ectoparassiti rappresentano vettori di malattia particolarmente efficienti perché trascorrono prolungati periodi in<br />
contatto con l’ospite. La trasmissione può avvenire: per inoculazione tramite saliva, come nella febbre della boscaglia<br />
originata dall’acaro; per inoculazione da rigurgito, come nella peste; per contaminazione fecale, come nel tifo<br />
petecchiale; per contaminazione da secrezione, come nella febbre ricorrente prodotta da zecche; per contaminazione<br />
da schiacciamento del vettore, come nella febbre ricorrente causata da pidocchi.<br />
Pulci, zecche ed acari trasmettono una varietà di patogeni animali e le malattie trasmesse all’uomo sono<br />
prevalentemente delle zoonosi. Gli ectoparassiti artropodi sono vettori di virus (arbovirus), rickettsie (febbri tifoidee),<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 5 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
infezioni batteriche (febbre ricorrente, peste) e da protozoi (babesiosi, febbre della Costa dell’Est). La maggior parte di<br />
queste malattie è diffusa in tutto il mondo e molte di loro, come la peste o le infezioni correlate alla zecca o all’acaro,<br />
sono localizzate, causando focolai ristretti che non coinvolgono l’uomo. Non è documentato che le cimici siano<br />
importanti vettori di patogeni per l’uomo.<br />
La trasmissione di patogeni da ectoparassiti può avvenire con modalità diverse e fra queste sono di particolare<br />
interesse quelle trans-stadio e trans-ovarica. La trasmissione trans-stadio si manifesta quando un patogeno è<br />
conservato in un vettore durante gli stadi successivi della sua evoluzione (vale a dire, acquisito allo stadio larvale,<br />
passato alla ninfa e trasmesso alla forma adulta). Nella trasmissione trans-ovarica il patogeno è trasmesso alla<br />
generazione successiva attraverso l’uovo. Entrambi i tipi sono esempi di trasmissione verticale attraverso la<br />
popolazione del vettore ed in queste circostanze una malattia può essere mantenuta in un’area senza il passaggio<br />
all’ospite umano.<br />
PULCI<br />
Le pulci (ordine: Siphonaptera) sono veri insetti (Classe Insecta) e come tali hanno un corpo segmentato,<br />
chiaramente suddiviso in testa, torace, ed addome. Nello stadio adulto il torace è dotato di sei zampe.<br />
Sono parassiti obbligati degli animali vertebrati. Di solito non sono ospite specifico e, quando sono affamate, si<br />
procurano un pasto di sangue da qualsiasi ospite presente. In ogni modo, per sviluppare con successo le proprie<br />
uova la pulce femmina richiede nutrimento ematico ottenuto dall’ospite primario. Fra le numerose specie di pulci solo<br />
un numero ridotto è di qualche importanza clinica ed occorre notare che le malattie da loro trasmesse sono<br />
principalmente zoonosi (malattie degli animali). Se fungono da vettori di malattia, le pulci devono accedere pertanto<br />
alla popolazione umana ed animale.<br />
Descrizione: le pulci sono insetti piccoli (1-8mm di lunghezza), ovali, privi di ali, con colore variabile dal giallo scuro al<br />
nero. Il corpo è appiattito lateralmente, possiede una cuticola brillante, cerea, dotata di setole e numerose spine<br />
robuste. La maggior parte delle specie presenta due di occhi ben sviluppati ed un paio di antenne claviformi inserite in<br />
pieghe dietro gli occhi. Alcune pulci sono dotate di pettini: aculei digitiformi della cuticola periorale (pettine genale) o a<br />
collare sul primo segmento toracico (pettine pronotale). In alcune specie è presente una serie di spine nel secondo<br />
segmento toracico (serie mesopleurica).<br />
Disegno schematico di femmina di pulce (Illustrazione da C.<br />
Whitehorn)<br />
Ciclo vitale: Le pulci presentano una metamorfosi completa; gli stadi immaturi non assomigliano alla forma adulta, ed<br />
occupano nicchie ecologiche molto diverse. In media la forma adulta vive 6 – 12 mesi e si suppone possa vivere 2<br />
anni. Se una femmina di pulce incontra un ospite primario, può maturare le uova e durante il ciclo vitale ne può<br />
deporre 300 -1000 (in media 3 – 25 al giorno). Le uova si schiudono dopo 2 – 14 giorni, con uscita di larve simili a<br />
bruchi. Le larve delle pulci sono allungate, prive di arti e coperte di rade e lunghe setole. Il loro addome è dotato di un<br />
paio di processi anali digitiformi. Si nutrono di detriti organici presenti nel nido (o casa) dell’ospite. L’alimento della<br />
forma larvale include spesso sangue parzialmente digerito presente nelle feci delle pulci adulte. Le larve presentano<br />
due mute e maturano dopo 2 – 3 settimane. Producono seta e si avvolgono in un bozzolo all’interno del quale vanno<br />
incontro alla successiva mutazione in pupa. Lo stadio di pupa dura 1 – 2 settimane; la pulce adulta perde l’involucro<br />
pupale e resta inattiva all’interno del bozzolo finché viene indotta ad emergere da stimoli specifici. Dopo la loro<br />
fuoruscita le pulci adulte possono copulare immediatamente e la produzione di uova può iniziare entro 1 – 2 giorni dal<br />
pasto ematico.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 6 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Patologia da morsi di pulce: Quando si alimenta, la pulce inietta nel derma saliva per prevenire la coagulazione del<br />
pasto ematico. Ciò determina nel sito del morso un prurito intenso che dura alcuni giorni. Si manifesta una tipica<br />
ipersensibilità nelle persone esposte a morsi ripetuti. Il morso della pulce è caratterizzato da una sottile macchia scura<br />
circondata da cute rossastra edematosa.<br />
Pulci clinicamente importanti: Le specie che hanno la maggior importanza per l’uomo sono; Xenopsylla cheopis<br />
(pulce della peste), Pulex irritans (pulce umana) e Tunga penetrans (pulce penetrante). Esistono inoltre numerose<br />
pulci di animali e volatili che si nutrono in modo opportunistico sull’uomo ed i cui morsi possono provocare gravi<br />
disturbi. Consultare Lane e Crosskey 2 per la definizione dei generi e delle specie di pulci clinicamente importanti.<br />
Preparazione del materiale: Prima della preparazione le pulci adulte devono essere uccise e conservate in etanolo<br />
70%. Trasferire la pulce in un vetrino da orologio contenente una soluzione di idrato di potassio (KOH) al 10% per 24<br />
ore o più, fino a rischiaramento del contenuto corporeo. Trasferire la pulce direttamente in un vetrino da orologio<br />
contenente acido acetico glaciale per almeno 2 ore, poi in olio di garofano per 2 – 24 ore fino allo schiarimento delle<br />
cavità corporee ed alla visualizzazione dei genitali. Montare il campione intero in Euparal ed aggiungere il<br />
coprioggetto. Con molta delicatezza si può esaminare immediatamente il campione. Per ottenere un preparato<br />
permanente, il campione deve essere posto in un essiccatore per 4–6 settimane a 55°C. Etichettare il vetrino con:<br />
identificazione, numero di riferimento e dati di raccolta.<br />
Xenopsylla cheopis (pulce della peste o del ratto tropicale)<br />
A distribuzione cosmopolita, la pulce è principalmente un ectoparassita dei ratti. E’ il vettore della peste e del tifo<br />
murino.<br />
Descrizione: Questa pulce si distingue dagli altri generi per l’assenza del pettine genale e pronotale e la presenza di<br />
una sutura mesopleurica nel secondo segmento toracico.<br />
Xenopsylla cheopis Xenopsylla cheopis<br />
Fotografia (Illustrazione da C. Whitehorn).<br />
© LSHTM<br />
Peste: La peste è un’infezione batterica causata dalla Yersinia pestis. E’ una zoonosi e l’infezione ha come serbatoio<br />
naturale diversi roditori selvaggi (peste silvestre); occasionalmente è trasmessa ai ratti domestici (peste urbana), che<br />
sono meno resistenti alla malattia ed in gran parte muoiono. Le pulci di questi ultimi, cercano allora ospiti alternativi.<br />
Le Y. pestis prelevate con un pasto ematico da un ospite infetto si moltiplicano rapidamente nello stomaco della<br />
pulce. I batteri formano un bolo vischioso, che blocca lo stomaco e impedisce una normale alimentazione alla pulce.<br />
Quando la pulce tenta di alimentarsi, il sangue viene a contatto con il bolo di batteri e non entra nello stomaco. La<br />
pulce rigurgita poi il sangue contaminato, infettando il nuovo ospite.<br />
Tifo murino: Il tifo murino è una rickettsiosi causata dalla Rickettsia mooseri. E’ una zoonosi del ratto e dei topi. Le<br />
rickettsie sono ingerite con un pasto ematico da un ospite infetto, si moltiplicano nell’intestino delle pulci senza<br />
causare un’occlusione e le forme infettive sono emesse con le feci. La trasmissione si verifica quando le pulci infettate<br />
sono schiacciate sulla pelle, strofinate sulle membrane mucose o inalate. Una via di trasmissione dell’infezione può<br />
essere pure rappresentata dall’ingestione di pulci infette.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 7 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Pulex irritans (pulce umana)<br />
A distribuzione cosmopolita, la pulce è principalmente un ectoparassita di mammiferi dotati di folta pelliccia, quali<br />
maiali, cinghiale e cervi, ma si rinviene anche nell’uomo. E’ conosciuta sopratutto per le morsicature fastidiose,<br />
mentre negli USA è vettore della peste.<br />
Descrizione: la pulce si differenzia dagli altri generi per la mancanza di pettine genale e pronotale e la presenza di<br />
una sutura ispessita fra le antenne. P. irritans non è dotata di sutura mesopleurica.<br />
Pulex irritans Pulex irritans<br />
Fotografia della testa e del torace © LSHTM (Illustrazione da C. Whitehorn).<br />
Tunga penetrans (la pulce penetrante)<br />
Presente in Africa tropicale, America Centrale e Meridionale, questa pulce è un ectoparassita dell’uomo, del bestiame<br />
domestico e dei roditori. Le infestazioni di questa pulce causano la tungiasi: la femmina scava gallerie nella cute<br />
dell’ospite e diviene un ospite permanente.<br />
Descrizione: La pulce si distingue dagli altri generi per le dimensioni ridotte (1 mm) e l’assenza dei pettini genale e<br />
pronotale; ha segmenti toracici compressi ed una testa dall’aspetto particolare.<br />
Tunga penetrans Tunga penetrans<br />
Fotografia della testa e del torace (illustrazione da C. Whitehorn)<br />
© LSHTM<br />
Tungiasi: Il maschio e la femmina della pulce penetrante si alimentano di sangue ed il maschio abbandona l’ospite<br />
dopo il pasto. La femmina (dopo fecondazione) scava una galleria nella cute dell’ospite fino ad essere completamente<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 8 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Incastrata, con la sola parte superiore dell’addome esposta. I siti preferiti sono il piede. le dita e le unghie del piede,<br />
ma può essere interessata qualsiasi altra parte del corpo. Dopo la digestione del pasto ematico, la femmina matura le<br />
uova e si gonfia assumendo l’aspetto di un piccolo pisello. L’aumento di dimensione crea un considerevole fastidio<br />
all’ospite. Dopo 8 – 10 giorni le femmine raggiungono la loro massima dimensione e le uova mature sono diffuse<br />
dall’apertura genitale. Nell’arco di una due settimane sono prodotte circa 20 uova. Le uova cadono nel terreno e si<br />
schiudono dopo 3 -4 giorni. Le larve e le pupe sono rinvenibili in terreni sabbiosi e ben drenati. L’intero ciclo vitale è<br />
completato in media in 35 giorni; lo stadio larvale richiede infatti 10 – 14 giorni e la fase di pupa dura 5 – 14 giorni.<br />
Quando la femmina muore rimane inclusa nella cute, provocando un’infiammazione che può evolvere in infezioni<br />
secondarie. Si possono manifestare perdita delle dita dei piedi, tetano e gangrena.<br />
PULCI <strong>DI</strong> ANIMALI ED UCCELLI<br />
Numerose pulci di animali e di uccelli possono mordere l’uomo e provocare fastidiose lesioni. Inoltre possono agire<br />
come ospiti intermedi di tenie. I generi più importanti sono, Ctenocephalides (pulci del gatto e del cane),<br />
Ceratophyllus (pulci degli uccelli) ed in minor grado Nosopsyllus (pulci del ratto) e Leptopsylla (pulci del topo) 2 .<br />
Descrizione: Le pulci degli animali e degli uccelli sono tutte dotate di un pettine pronotale. Il numero di spine del<br />
pettine pronotale è importante per la loro identificazione. Le specie Leptopsylla e Ctenocephalides possiedono anche<br />
un pettine genale.<br />
Ctenocephalides felis (pulce del gatto)<br />
A distribuzione cosmopolita, C. felis è un ectoparassita del gatto e del cane, ed è la pulce che morde più<br />
frequentemente l’uomo nel Regno Unito. Può essere distinta dalla pulce del cane per la testa allungata 2 della forma<br />
adulta e per la distribuzione delle setole nella parte posteriore della tibia. C. felis può fungere anche da ospite<br />
intermedio delle tenie del cane (Dipylidium caninum) e del topo (Hymenolepis diminuta).<br />
Descrizione: La pulce del gatto si distingue dagli altri generi per la presenza di un pettine genale (di 7 -8 elementi),<br />
un pettine pronotale e la presenza di una sutura mesopleurica. La sua testa è doppia in lunghezza e in altezza ed<br />
appuntita anteriormente. La parte posteriore della tibia è dotata di sei protuberanze setolose lungo il margine dorsale 2 .<br />
Ctenocephalides felis Ctenocephalides felis<br />
Fotografia della testa, primo e secondo Riproduzione della testa e del primo segmento<br />
segmento toracico. Nota i pettini visibili toracico.<br />
© LSHTM (Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 9 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Ctenocephalides canis (pulce del cane)<br />
Ctenocephalides felis<br />
Riproduzione della tibia posteriore.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn).<br />
Le formazioni circolari illustrano l’origine di<br />
setole addizionali non rappresentate<br />
A distribuzione cosmopolita, C. canis è presente nei gatti e nei cani, e può morsicare anche l’uomo. E’ meno diffusa<br />
nel Regno Unito rispetto alla pulce del gatto, dalla quale si distingue per la testa rotondeggiante e la disposizione<br />
delle setole sulla parte posteriore della tibia. C. canis può fungere da ospite intermedio della tenia Dipylidium<br />
caninum.<br />
Descrizione: La pulce del cane si distingue dagli altri generi per la presenza di un pettine genale (7 -8 elementi), un<br />
pettine pronotale e la presenza di una sutura mesopleurica. La testa della C. canis è meno del doppio in lunghezza<br />
rispetto altezza e anteriormente è rotondeggiante. La parte posteriore della tibia è dotata di otto protuberanze<br />
setolose lungo il margine dorsale 2 .<br />
Ctenocephalides canis Ctenocephalides canis<br />
Fotografia della testa, primo e (Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
secondo segmento toracico.<br />
© LSHTM<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 10 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Ceratophyllus (pulce dell’uccello) e Nosopsyllus (pulce del ratto)<br />
Ctenocephalides canis<br />
Riproduzione della tibia posteriore.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn).<br />
Le formazioni circolari illustrano l’origine di<br />
setole addizionali non rappresentate<br />
Entrambi questi generi sono assegnati alla famiglia Ceratophillidae e condividono un certo numero di caratteristiche<br />
morfologiche. Possono essere distinti solo dall’esame dei genitali. La pulce comune del pollo (Ceratophyllus gallinae)<br />
è presente ovunque ed è un ectoparassita del pollame domestico e degli uccelli selvatici (quali piccioni, storni e<br />
passeri). Queste specie possono opportunisticamente mordere l’uomo e provocare lesioni particolarmente fastidiose.<br />
La pulce del ratto (specie Nasopsyllus) ha anch’essa una corologia cosmopolita ed è un ectoparassita per un certo<br />
numero di specie dei roditori.<br />
Descrizione: Queste pulci si distinguono dagli altri generi di rilievo medico per la presenza di un pettine pronotale, di<br />
una sutura mesopleurica e di un arco pleurico ben sviluppato (sito fra il terzo segmento toracico e l’addome<br />
Specie Nasopsyllus<br />
Fotografia della testa, primo e<br />
secondo segmento toracico.<br />
© LSHTM<br />
Specie Nasopsyllus<br />
Rappresentazione della testa e del torace<br />
Nota l’arco pleurico nel terzo segmento toracico.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 11 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Leptopsylla (pulce del topo)<br />
Presenti nelle Regioni Paleartica, Neartica ed Afrotropicale i membri del Genere Leptopsylla sono ectoparassiti<br />
principalmente per i piccoli roditori.<br />
Descrizione: Queste pulci si distinguono dagli altri generi per una posizione caratteristica della testa (che appare<br />
ripiegata), per la presenza di un pettine pronotale, di un ridotto pettine genale e per l’assenza degli occhi.<br />
Specie Leptopsylla<br />
Fotografia della testa, primo e<br />
secondo segmento toracico.<br />
© LSHTM<br />
Tabella 1: Pulci associate all’uomo<br />
Genere Ospite Testa Pettine<br />
genale<br />
Pulex<br />
Xenopsylla<br />
Tunga<br />
Uomo &<br />
animali<br />
Specie Leptopsylla<br />
Rappresentazione della testa, primo, secondo<br />
e parte del terzo segmento toracico.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Pettine<br />
pronotale<br />
Occhi Sutura<br />
mesopleurica<br />
normale assente assente presente assente<br />
Ratti normale assente assente presente presente<br />
Uomo e animali<br />
domestici<br />
rivoltata<br />
all’insù assente assente presente assente<br />
Ctenocephalides Gatto/cane normale presente presente presente presente<br />
Ceratophyllus<br />
Nasopsyllus<br />
Uccelli normale assente presente presente presente<br />
Ratti normale assente presente presente presente<br />
Leptopsylla Topi ripiegata presente presente assente presente<br />
Ceratophyllus e Nasopsyllus possiedono anche un arco pleurico localizzato fra il terzo segmento toracico e l’addome.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 12 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
PIDOCCHIO UMANO<br />
I pidocchi (Ordine Anoplura) sono veri insetti (Classe Insecta) e come tali possiedono un corpo segmentato<br />
chiaramente suddiviso in testa, torace ed addome. Negli stadi di ninfa e di adulto il torace è dotato di sei zampe.<br />
Durante il loro ciclo vitale i pidocchi sono parassiti obbligati di ospiti vertebrati. Sono specifici per ospite, per il quale<br />
possono manifestare preferenze regionali. Tre sono le specie riscontrate nell’uomo e di queste solo una, il Pediculus<br />
humanus, è vettore di malattia.<br />
Descrizione: I pidocchi umani sono piccoli insetti privi di ali (lunghezza 2 – 3,5 mm), col colore che varia dal crema al<br />
marrone scuro in funzione dell’ospite. Il corpo, appiattito a livello dorso-ventrale, ricoperto da un tegumento coriaceo,<br />
è distintamente suddiviso in testa, torace e addome, ma il torace e l’addome sono fusi fra loro. La testa è dotata di<br />
due piccoli occhi e di un paio di corte antenne, il torace di tre paia di zampe con potenti unghie per avvinghiarsi<br />
all’ospite. I pidocchi umani sono classificati in due generi, specie Pediculus (pidocchio del corpo e del capo) e specie<br />
Pthirus (pidocchio del pube o piattola).<br />
Specie Pediculus<br />
Rappresentazione di un maschio di pidocchio<br />
(Illustrazione da Whitehorn)<br />
Ciclo vitale 3,4 : I pidocchi presentano una metamorfosi incompleta, con stadi immaturi che assomigliano all’adulto, ed<br />
occupano la stessa nicchia ecologica. Trascorrono il loro intero ciclo sull’ospite e si allontano solo per trasferirsi su un<br />
nuovo ospite. L’adulto del pidocchio del capo vive in media 22 giorni e, nel corso della vita, le femmine depositano<br />
circa 50 uova; quello del corpo vive in media 30 giorni e le femmine depositano circa 100 uova; le piattole adulte<br />
vivono in genere 22 giorni e le femmine depositano circa 50 uova. In tutti i casi, le uova si schiudono dopo 6 – 8 giorni<br />
(a 35°C) e fuoriesce una piccola ninfa. Gli stadi ninfali sono tre e per il pidocchi del capo e del corpo richiedono circa<br />
9 giorni. Per la piattola lo sviluppo della ninfa richiede 15 – 17 giorni. Durante il giorno i pidocchi che infestano l’uomo<br />
necessitano di pasti regolari e sono molto sensibili alle variazioni della temperatura e dell’umidità.<br />
Patologia da morso di pidocchio 3, 4 : I pidocchi sono dotati di organi buccali distinti contenuti in una borsa ventrale.<br />
Quando un pidocchio si alimenta si attacca alla cute utilizzando una proboscide munita di denti e trafigge la cute con<br />
stili aghiformi. La saliva è inoculata nella ferita per prevenire la coagulazione ed il sangue è succhiato attraverso una<br />
bocca simile ad un tubo flessibile. I morsi dei pidocchi umani provocano un arrossamento puntiforme di 2 – 3 mm di<br />
diametro. La sensibilità ai morsi dei pidocchi si sviluppa in settimane o mesi (in funzione del livello di esposizione) e,<br />
una volta consolidata, l’irritazione cutanea può diventare grave. L’abitudine dei pidocchi di alimentarsi regolarmente<br />
espone l’ospite a ripetute dosi di saliva e in alcuni soggetti si potranno manifestare reazioni tossiche e sintomi di<br />
affaticamento, irritabilità e depressione (la persona si sente ammalata).<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 13 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Pidocchi di importanza clinica: Solo il pidocchio del corpo Pediculus humanus è vettore di malattia, infatti,<br />
trasmette il tifo esantematico, la febbre quintana e la febbre ricorrente. La necessità dei pidocchi di nutrirsi<br />
regolarmente comporta comunque un grande disturbo da morsicature associato a tutte tre le specie.<br />
Preparazione del materiale: I pidocchi devono essere uccisi in acqua calda (85°C) e conservati in etanolo 70%<br />
prima della preparazione. Trasferire i pidocchi in un vetrino di orologio contenente 10% di soluzione di idrato di<br />
potassio (KOH), Trafiggere le membrane inter-segmentali dorsali con un sottile ago e lasciare i pidocchi nella<br />
soluzione per 24 ore. Il KOH penetra e dissolve i tessuti corporei. Esercitare poi una lieve pressione sul corpo<br />
utilizzando un ago smussato per rimuovere i contenuti liquefatti. Lavare per tre volte i pidocchi in acqua distillata (10<br />
minuti per lavaggio). Disidratare con etanolo a concentrazione progressiva: 80% (5 minuti), 90% (5 minuti) 100% (5<br />
minuti) ed infine trasferire in un vetrino di orologio contenente cellosolve per 15 minuti. Montare il campione intero in<br />
Euparal e coprire accuratamente con coprioggetto. Il campione può essere esaminato immediatamente facendo<br />
attenzione. Per ottenere una preparazione permanente su vetrino il campione deve essere inserito in un essiccatore<br />
per 4 settimane a 55°C.<br />
Pediculus humanus (pidocchio del corpo)<br />
Il pidocchio del corpo, a distribuzione geografica cosmopolita, è frequente in popolazioni migranti, dove le persone<br />
non sono in grado di lavarsi o cambiare frequentemente gli indumenti. I pidocchi umani dotati di maggior resistenza<br />
possono sopravvivere alcuni giorni lontano dall’ospite negli abiti infestati.<br />
Descrizione<br />
Adulto: Le specie di Pediculus del corpo sono insetti di forma allungata, che crescono all’incirca sino a 4 mm. Le<br />
regioni corporee sono distintamente differenziate e le zampe sono dotate di unghie di moderate dimensioni. Le<br />
femmine sono lievemente più larghe dei maschi. I pidocchi del capo e del corpo sono praticamente identici e sono<br />
differenziabili per il loro posizionamento sull’ospite. I pidocchi del corpo si rinvengono negli indumenti, in modo<br />
particolare nelle cuciture a contatto con pieghe inguinali, ascelle, fianchi, collo e spalle. Si attaccano ai peli solo<br />
quando si nutrono e non si riscontrano mai sulla testa.<br />
Pediculus humanus<br />
Rappresentazione del corpo di<br />
femmina di pidocchio. Nota:<br />
apice addominale biforcato.<br />
(Illustrazione da Whitehorn)<br />
Pediculus humanus<br />
Rappresentazione di uovo<br />
incollato a materiale fibroso.<br />
(Illustrazione da Whitehorn)<br />
Uovo: Le uova delle specie Pediculus sono piccole (lunghezza 0.8 mm), di color crema5 e di aspetto ovale. Nella<br />
parte distale dell’uovo è presente un opercolo perforato, che consente scambi gassosi per l’embrione. Le uova dei<br />
pidocchi del corpo e della testa sono così simili che la loro sede sull’ospite rappresenta il metodo principale di<br />
differenziazione delle due specie. Le uova del pidocchio del corpo si rinvengono sugli indumenti aderenti a materiale<br />
fibroso, specie nelle cuciture della biancheria. Sono occasionalmente incollate ai peli del corpo, ma le uova del<br />
pidocchio del corpo non si rinvengono mai sulla testa.<br />
Tifo epidemico originato dal pidocchio: Il tifo originato dal pidocchio è una malattia causata dalla Rickettsia<br />
prowazekii. Le rickettsie sono ingerite dall’ospite tramite pasto ematico e si moltiplicano nel lume e nelle cellule<br />
epiteliali dell’intestino del pidocchio. Queste occasionalmente si rompono, rilasciando gli agenti infettivi che sono<br />
immessi nelle feci. Le rickettsie presenti nelle feci emesse rimangono infettive per l’uomo per più di tre mesi e la<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 14 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
trasmissione della malattia si verifica quando vengono graffiate all’interno della cute, oppure sfregate sulle mucose o<br />
inalate. Persone prive di pidocchi possono quindi essere infettate dalla forma tifoidea. R. prowazekii è stata isolata<br />
anche dallo scoiattolo volante Americano, ma la sua rilevanza nella trasmissione dell’infezione rimane incerta.<br />
Febbre quintana: La febbre quintana è una malattia di tipo batterico causata dalla Bartonella quintana. I batteri sono<br />
ingeriti dall’ospite con pasto ematico e si moltiplicano nel lume dell’intestino, ma non invadono le cellule epiteliali.<br />
Dopo 5 – 10 giorni gli agenti infettivi contaminano le feci ed abbandonano il vettore. La modalità di trasmissione ed i<br />
sintomi sono simili a quelli della forma tifoidea, ma la malattia è meno grave. Volatili selvatici ed altri roditori possono<br />
essere serbatoi di malattia.<br />
Febbre ricorrente epidemica del pidocchio: La malattia è causata dalla spirocheta Borrelia recurrentis. L’uomo è la<br />
sola riserva della malattia. Le spirochete sono ingerite dal pidocchio con pasto ematico e penetrano nell’intestino per<br />
moltiplicarsi nel sistema emolinfatico. La trasmissione si realizza quando i pidocchi sono ingeriti dall’uomo o sono<br />
schiacciati sull’epidermide escoriata o fra i denti. La malattia è talvolta riscontrata in soggetti che non sono infestati da<br />
pidocchi.<br />
Pediculus capitis (pidocchio della testa)<br />
A distribuzione cosmopolita, l’infestazione è riscontrata principalmente negli asili e nelle scuole elementari. La<br />
trasmissione dei pidocchi avviene per contatto da testa a testa. I pidocchi non sono in grado di sopravvivere se<br />
rimossi dall’ospite.<br />
Descrizione<br />
Adulto: Sono poche le differenze morfologiche fra i pidocchi del capo<br />
e quelli del corpo, comunque possono essere distinti grazie alla loro<br />
localizzazione sull’ospite. I pidocchi del capo sono rinvenibili solo sui<br />
peli del cuoio capelluto.<br />
Pediculus capitis - maschio<br />
Fotografia della testa e del torace<br />
© LSHTM<br />
Uova: Le uova della specie Pediculus sono piccole (0.8 mm di lunghezza) di<br />
colore crema 5 e di aspetto ovale. Nella parte distale presentano un opercolo<br />
superficiale perforato, che consente scambi gassosi per l’embrione. Le uova del<br />
pidocchio della testa si differenziano da quelle del pidocchio del corpo per<br />
localizzazione; le prime si trovano solo sui peli del cuoio capelluto e non sono<br />
rilevabili in altre parti del corpo.<br />
Pediculus capitis - uovo<br />
Rappresentazione di uovo aderente allo stelo di un capello<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 15 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Pthirus pubis (pidocchio del pube)<br />
A distribuzione cosmopolita, l’infestazione è principalmente riscontrata negli adulti sessualmente attivi. Si manifesta<br />
sui peli più grossi del corpo quali quelli del pube, ciglia, barba e baffi. La trasmissione del pidocchio del pube si<br />
realizza per stretto contatto fisico.<br />
Descrizione<br />
Pthirus pubis<br />
Fotografia di piattola<br />
© LSHTM<br />
Pthirus pubis<br />
Rappresentazione di femmina di piattola<br />
Adulto: Il Pthirus pubis è un insetto rotondeggiante, compatto (1.0 – 1.4 mm di diametro), dotato di grandi unghie sul<br />
secondo e terzo paio di zampe. L’addome è ridotto come dimensione e numero di segmenti, e non si distingue bene il<br />
torace dall’addome. Pthirus assomiglia ad un minuscolo granchio e da ciò il suo nome comune di “pidocchio<br />
granchio”.<br />
Uova: Le uova del Pthirus pubis sono piccole (0.8 mm di lunghezza), di color crema 5 e di aspetto ovale. Nella parte<br />
distale è presente un opercolo perforato rilevato che consente scambi gassosi per l’embrione. L’aspetto dell’opercolo<br />
permette di differenziare le uova del pidocchio del pube da quelle del pidocchio delle testa e del capello.<br />
Pthirus pubis – uovo<br />
Fotografia di uovo aderente<br />
al pelo.<br />
Nota: opercolo rilevato<br />
Pthirus pubis – uovo<br />
Rappresentazione di uovo<br />
aderente al pelo<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Anche se le uova della piattola si possono rinvenire sulla testa dell’ospite, solitamente sono presenti nelle sole aree<br />
con peli più grossi, quali sopracciglia, ciglia, barba e baffi. Le uova della piattola non sono riscontrate sui peli del cuoio<br />
capelluto.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 16 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
CIMICI<br />
Le cimici, (Ordine Hemiptera) sono veri insetti (classe: Insecta) e come tali possiedono un corpo segmentato<br />
chiaramente suddiviso in testa, torace ed addome. Negli stadi di ninfa e di adulto il torace è dotato di sei zampe.<br />
Le cimici sono parassiti ematofagi obbligati degli animali vertebrati. Sono principalmente insetti notturni e durante il<br />
giorno si nascondono nelle fenditure e negli interstizi. Solo due specie sono associate all’uomo. Cimex lectularius<br />
(cimice comune) e Cimex hemipterus (cimice tropicale). Sebbene queste due specie si nutrano principalmente del<br />
sangue dell’uomo possono mordere anche mammiferi e uccelli. L’importanza sanitaria delle cimici è controversa, ma<br />
comunque esse sono responsabili di morsicature moleste.<br />
Descrizione: Le cimici adulte sono piccole (lunghezza 5 mm, larghezza 3 mm),<br />
ovali,di colore variabile dal giallastro al marrone, che diventa colore rosso scuro<br />
dopo un pasto recente. Il corpo è appiattito dorso ventralmente e suddiviso<br />
distintamente in testa, torace ed addome. La testa è piccola, dotata di due occhi<br />
e di due antenne divise in 4 segmenti. Ripiegata sotto la testa c’è una<br />
proboscide (un rostro diviso in tre segmenti), che viene ruotata anteriormente<br />
quando la cimice si nutre. Il torace è suddiviso in tre segmenti e l’aspetto del<br />
primo (pronoto) consente di distinguere la cimice comune da quella tropicale.<br />
Nella parte dorsale il secondo e terzo segmento sono parzialmente nascosti da<br />
due strutture simili ad ali prive di funzione. Le zampe sono ben sviluppate. Se<br />
disturbate, le pulci possono muoversi molto rapidamente.<br />
Fotografia di Cimex<br />
lectularius (Ventrale).<br />
© LSHTM<br />
Si può distinguere il maschio dalla femmina esaminando l’addome. Quello del maschio è più ristretto, lievemente<br />
appuntito, con contorno asimmetrico. L’addome della femmina è arrotondato e simmetrico.<br />
Cimex lectularius<br />
Rappresentazione del maschio della cimice<br />
Visione dorsale<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Cimex lectularius<br />
Rappresentazione della femmina della cimice<br />
Visione ventrale<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Con l’osservazione ventrale, il segmento terminale del maschio è dotato di un paramero ricurvo a forma di uncino (o<br />
pene), i genitali esterni. Nella femmina, il quarto segmento addominale è dotato di una distinta fessura nella parte<br />
sinistra della linea mediana che si apre nella tasca copulatoria.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 17 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Ciclo vitale: Le cimici vanno incontro ad una metamorfosi incompleta e gli stadi immaturi e le forme adulte occupano<br />
nicchie ecologiche identiche. Le femmine delle cimici incollano le uova nelle fenditure e negli interstizi delle pareti e<br />
dei mobili. Durante il ciclo vitale ogni femmina può deporre fino a 300 uova, in funzione delle condizioni ambientali e<br />
della disponibilità di pasti ematici. Le uova hanno forma allungata, sono di colore dal crema al rosato, dotate di<br />
opercolo con lunghezza di circa 1 mm. Si schiudono dopo circa 10 giorni e ne fuoriesce la ninfa del primo stadio. Gli<br />
stadi delle ninfe sono 5 e ciascuno richiede un pasto ematico per facilitare la trasformazione nello stadio successivo.<br />
Le ninfe possono sopravivere per 4 mesi senza pasto ematico e la forma adulta più di un anno. Il tempo medio per il<br />
completamento del ciclo è di 10 settimane, ma lo sviluppo delle cimici è in gran parte condizionato da temperatura,<br />
umidità, disponibilità di un ospite ed habitat.<br />
Segni e sintomi 6 : Si ritiene che le cimici siano trasportate nelle abitazioni da mobili ed effetti letterecci infestati. Si<br />
rinvengono nelle locazioni più disparate, da quelle di lusso ad alloggi di scarsa qualità, e principalmente, in quelli a<br />
destinati a brevi periodi di residenza, quali gli alberghi e gli ostelli. La diffusione locale avviene quando le cimici<br />
possono transitare su condutture, rampe e tubature del riscaldamento centrale che congiungono ambienti adiacenti.<br />
Sono richieste in media 7 settimane perché l’infestazione di un locale sia rilevabile anche in quelli adiacenti. Questo<br />
tipo di diffusione può manifestasi in assenza di pressione competitiva.<br />
La reazione ai morsi delle cimici varia molto da individuo ad individuo.<br />
Alcune persone non sono sensibili alla loro saliva e non si accorgono<br />
neppure di essere state morsicate. Ma nella maggior parte dei casi, circa<br />
15 – 30 minuti dopo la suzione, si manifesta nella sede del morso un<br />
gonfiore pruriginoso che dura alcuni giorni. L’intervallo fra il momento della<br />
suzione e la comparsa della reazione dipende dalla condizione<br />
immunologica dell’ospite. Durante la fase di suzione l’ospite non avverte<br />
generalmente alcuna sensazione nella sede del morso.<br />
.<br />
Fotografia della specie Cimex<br />
durante il pasto.<br />
© LSHTM<br />
Di solito le morsicature si trovano sulla testa e sulle spalle della persona, in quanto aree esposte fuori da lenzuola e<br />
coperte strettamente rimboccate. L’area è più diffusa se si utilizzano piumini scarsamente aderenti o se le cimici sono<br />
presenti in altro tipo di arredamento.<br />
Le cimici adulte, se disturbate, secernono odori da apposite ghiandole. Le locazioni molto infestate possono essere<br />
riconosciute per il tanfo dolciastro e di muffa proprio di queste secrezioni. Ulteriori segni di infestazione possono<br />
essere le deposizioni puntiformi di feci in prossimità dei luoghi di riposo e la presenza di esuvie (cuticole larvali).<br />
Importanza clinica: In laboratorio, le cimici sono state infettate con virus di epatite B, HIV e Trypanosoma cruzi, ma<br />
le possibilità che le cimici siano vettori effettivi di patogeni per l’uomo sono scarse.<br />
Preparazione del materiale: Le cimici devono essere uccise in acqua calda (85°C) e poi conservate in etanolo 70%.<br />
Per l’identificazione non è richiesto il montaggio su vetrino, ma è sufficiente collocarle in un vetrino d’orologio<br />
contenente etanolo 70% e l’osservarle al microscopio di dissezione (stereomicroscopio).<br />
Cimex lectularius (Cimice comune)<br />
Nel Regno Unito la cimice comune è la specie maggiormente responsabile delle infestazioni domestiche. Negli ultimi<br />
cinque anni c’è stato un incremento significativo dei casi in questo campo senza capirne le cause. Le cimici<br />
continuano ad essere associate alla miseria o alla scarsa igiene, fattori da approfondire in merito a questa<br />
problematica pestilenza.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 18 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Descrizione: Le cimici comuni sono lunghe circa 4.5 mm e larghe 3<br />
mm. Sono decisamente più piccole delle cimici tropicali ed hanno un<br />
addome più arrotondato. L’osservazione della superficie dorsale del<br />
corpo evidenzia il pronoto (primo segmento toracico) espanso<br />
lateralmente in un margine concavo.<br />
Cimex hemipterus (cimice tropicale)<br />
Cimex lectularius<br />
Rappresentazione della testa e<br />
pronoto x 30<br />
Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Questa specie è diffusa ai tropici e, come conseguenza dell’aumento del turismo internazionale, ci si aspetta sempre<br />
la possibilità di un suo ingresso nel Regno Unito. Negli anni recenti è stato segnalato un numero ristretto di casi di<br />
infestazione domestica di cimici tropicali.<br />
Descrizione: Le cimici tropicali sono lunghe circa 5 mm e larghe<br />
2,5 mm. Sono lievemente più larghe delle cimici comuni ed hanno<br />
un addome lievemente più allungato. L’osservazione della<br />
superficie dorsale del corpo rileva un pronoto (primo segmento<br />
toracico) arrotondato e privo del solco laterale.<br />
Cimex hemipterus<br />
Rappresentazione della testa e<br />
pronoto x 30.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 19 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
ACARI<br />
Gli acari (Sottoclasse Acari) sono aracnidi (Classe Aracnidi) e, come tali, sono dotati di un corpo affusolato privo di<br />
segmentazioni fra collo, torace ed addome. Nelle forme adulte il corpo è dotato di otto zampe.<br />
Sono aracnidi microscopici, ritrovabili in nicchie ecologiche diverse. Si ritrovano nel suolo, nell’aria e nell’acqua e si<br />
alimentano di piante, materiale organico, vari microrganismi ed occasionalmente anche di vertebrati. Il numero degli<br />
acari di importanza clinica associati all’uomo è particolarmente ristretto. Per la loro identificazione richiedono il<br />
montaggio su vetrino e l’osservazione con microscopio composto.<br />
Descrizione: Gli acari sono molto piccoli e la loro dimensione varia da<br />
0.09 ad 1.0 mm di lunghezza (un numero ridotto di specie può<br />
raggiungere 15 mm di lunghezza). Il corpo è ricoperto di una cuticola<br />
flessibile, dotata di numerose setole spesso raggruppate in modo<br />
caratteristico. Non si osserva alcuna suddivisione del corpo in testa<br />
torace ed addome, ed il cospicuo apparato buccale può essere confuso<br />
con la testa. La sua struttura è costituita da palpi e da cheliceri,<br />
(apparati di taglio e penetrazione). Gli stadi adulti e quelli di ninfa hanno<br />
otto zampe, quelli larvali sei. Pertanto le larve possono essere confuse<br />
con gli insetti, tranne che per l’assenza di segmentazione corporea. Gli<br />
acari possono essere distinti dalle zecche perché sono privi di ipostoma<br />
dentato prominente nell’apparato buccale e dell’organo di Haller sui<br />
tarsi delle zampe anteriori. Anche se sono generalmente molto più<br />
piccoli delle zecche, non sono le dimensioni la caratteristica principale<br />
per differenziare i due gruppi (consultare Zecche). Sulla superficie del<br />
corpo gli acari presentano regioni sclerotizzate, chiamate scudi che,<br />
associate alle setole che da loro protrudono, rappresentano caratteri<br />
utili all’identificazione.<br />
Ciclo vitale: Gli acari si sviluppano con un ciclo vitale incompleto, e gli<br />
stadi immaturi ed adulti possono occupare nicchie ecologiche<br />
completamente differenti. I cicli vitali sono descritti in sezioni specifiche<br />
per ciascun acaro di importanza clinica, ma qui di seguito vengono<br />
elencate le loro caratteristiche comuni: evoluzione dall’uovo alla larva a<br />
sei zampe, dalla larva allo stadio/i di ninfa ad otto zampe, dalla ninfa<br />
all’adulto. Le femmine degli acari producono un numero limitato di uova,<br />
relativamente voluminose, che si schiudono per far nascere la larva.<br />
Dopo essersi nutrita, la larva si trasforma per dare origine alla ninfa e<br />
questa può andare incontro ad 1 – 3 stadi di sviluppo, di protoninfa,<br />
deutoninfa e tritoninfa a seconda delle specie. Almeno una stadio della<br />
ninfa è inattivo. La ninfa può eventualmente trasformarsi nella forma<br />
adulta.<br />
Ciclo vitale semplificato dell’acaro<br />
Generalità dell’acaro<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
(Illustrazione da Whitehorn)<br />
Acari di importanza clinica: Gli acari ectoparassiti di importanza clinica sono il Sarcoptes scabiei (acaro della<br />
scabbia, acaro pruriginoso), le specie di Demodex (acari dei follicoli) e gli acari trombiculidi (chiggers). Alcuni acari<br />
degli animali e degli uccelli possono mordere l’uomo in assenza del loro ospite primario, come ad esempio il<br />
Dermanyssus gallinae (acaro del pollo). Fare riferimento a Lane, Crosskey e Baker per la classificazione in famiglie e<br />
generi degli acari parassiti 7 .<br />
Preparazione del materiale: Prima della preparazione gli acari devono essere uccisi e conservati in etanolo 70% o in<br />
soluzione di Oudeman*. Trasferire gli acari con corpo molle, o scarsamente sclerotizzato, su vetrino in una goccia di<br />
liquido di Hoyer**, aggiungere il coprioggetto ed esaminare con cautela. Prima del loro montaggio su vetrino gli acari<br />
sclerotizzati devono essere trasferiti in lattofenolo per 4 -72 ore fino a chiarificazione.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 20 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Raggiunta questa condizione, gli acari devono essere risciacquati in acqua distillata per tre volte (10 minuti per ogni<br />
risciacquo) e montati in terreno di Hoyer secondo la procedura prima descritta. Oppure, per una preparazione<br />
permanente, inserire il vetrino in termostato a 50°C per 4 giorni e sigillare il coprioggetto con smalto chiaro per<br />
unghie. Contrassegnare il vetrino con identificazione, numero di riferimento e data di raccolta 7 .<br />
Per conservazioni a lungo termine, prevenire la disidratazione del campione con la soluzione di Oudeman, costituita<br />
da 87 parti di etanolo 70%, 5 parti di glicerina e 8 parti di acido acetico glaciale.<br />
**Il terreno di Hoyer è costituito da 50 ml di acqua distillata, 30 g di gomma Arabica cristallina, 200 g di idrato di<br />
cloralio e 20 mL di glicerina.<br />
*** Il lattofenolo è costituito da 50 parti di acido lattico, 25 parti di cristalli di fenolo e 25 parti di acqua distillata.<br />
Sarcoptes scabiei (acaro mite)<br />
A distribuzione cosmopolita, il Sarcoptes scabiei causa la scabbia nell’uomo e può attaccare persone appartenenti a<br />
qualsiasi condizione socio-economica. Numerose altre specie di Sarcoptes provocano la scabbia negli animali da<br />
compagnia ed in quelli domestici, ma non vivono sull’uomo. Gli acari della scabbia scavano gli strati superiori della<br />
cute nutrendosi di tessuti del derma. I sintomi clinici sono determinati dalla sensibilizzazione nei confronti loro e delle<br />
loro feci. Gallerie lunghe e permanenti sono prodotte solo dalla femmina dell’acaro, che è in grado di vivere sull’uomo<br />
sino a due mesi. La scabbia è trasmessa da persona a persona esclusivamente per contatto fisico stretto e<br />
prolungato.<br />
Descrizione: Gli acari della scabbia sono molto piccoli; i maschi misurano 0.2 mm e le femmine 0.3 – 0.4 mm. Hanno<br />
una cuticola striata con squame e setole dotate di particolari funzioni. Le zampe sono corte e quelle anteriori<br />
possiedono setole (pulvilli) atte ad avvinghiarsi alla cute dell’ospite.<br />
Sarcoptes scabiei<br />
Rappresentazione della femmina dell’acaro<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Sarcoptes scabiei<br />
Rappresentazione del maschio dell’acaro<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
I maschi possono essere distinti dalle femmine per la presenza di pulvilli sulle zampe anteriori, utilizzati per<br />
mantenersi sulla femmina durante l’accoppiamento.<br />
Ciclo vitale: La femmina dell’acaro depone le uova nel solco mentre scava gallerie nella cute. Le uova sono ovali e<br />
lunghe da 0.1 a 0.15 mm. Si schiudono dopo 3 – 8 giorni e ne escono larve a sei zampe. Queste migrano sulla<br />
superficie cutanea e penetrano in un follicolo pilifero, oppure scavano nello strato corneo e danno luogo ad una<br />
“nicchia di muta”. Dopo 2 -3 giorni la larva si muta in ninfa a otto zampe. Due stadi da ninfa precedono la forma<br />
adulta. L’accoppiamento avviene quando il maschio adulto penetra nella “nicchia di muta” della femmina, che,<br />
fecondata, ingrandisce la nicchia ed inizia la sua migrazione scavando nella cute. Il ciclo completo richiede 10 – 14<br />
giorni e gli acari adulti vivono 4-5 settimane. Necessitano 2 – 4 mesi ad una popolazione media di 20 acari adulti per<br />
sviluppare un caso clinico di scabbia.<br />
.<br />
Patologia: Quando un soggetto è infestato per la prima volta dal Sarcoptes, i sintomi compaiono raramente nel primo<br />
mese (2 -6 settimane). La sintomatologia clinica insorge solo quando i pazienti si sono sensibilizzati agli acari e si può<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 21 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
sviluppare rapidamente (1-4 giorni) dopo la sensibilizzazione e nelle infestazioni successive. La scabbia esordisce<br />
con un’eruzione cutanea generalizzata, rappresentata da papule rilevate pruriginose in corrispondenza di ogni galleria<br />
dell’acaro. Il prurito intenso può essere uno dei sintomi più frequenti e si manifesta sulla maggior parte del corpo<br />
soprattutto di notte. Il grattamento può comportare la rottura della cute e la formazione di pustole. La maggior parte<br />
delle gallerie è situata fra le dita dei piedi e le pieghe delle ginocchia e dei gomiti. Può anche essere coinvolta la cute<br />
di scroto, pene, ginocchia, natiche e mammella. Sul corpo può comparire un esantema allergico simmetrico a partire<br />
dalla parte inferiore delle braccia fino ai polpacci ed attorno alla vita, ma non nella parte superiore del dorso. Negli<br />
immunodepressi si può manifestare una condizione, nota come scabbia crostosa “Norvegese”, in cui il paziente non<br />
reagisce agli acari presenti nella cute ed il loro numero aumenta in modo incontrollato. Questa situazione produce un<br />
ispessimento squamoso della cute ed una forma clinica molto contagiosa. Nei bambini e negli anziani la scabbia può<br />
presentarsi in modo atipico, con coinvolgimento del viso e del cuoio capelluto e rare gallerie.<br />
Sarcoptes scabiei<br />
Fotografia di femmina di acaro in preparazione su vetrino<br />
Nota: uovo di grandi dimensioni fra le zampe posteriori.<br />
© LSHTM<br />
Diagnosi: La diagnosi di scabbia si basa sull’aspetto e distribuzione dell’esantema e sulla presenza di gallerie.<br />
Quando possibile, la diagnosi deve essere confermata con l’isolamento da raschiamento cutaneo di acari, uova o<br />
depositi fecali. Osservare con lente d’ingrandimento la superficie della cute per il rilievo di gallerie. Rivolgere<br />
particolare attenzione a mani, pieghe fra le dita e pieghe del polso. Deporre una goccia di olio minerale sulla cute ove<br />
sia evidente una galleria. Utilizzando un bisturi sterile raschiare lo strato corneo della cute e raccogliere il materiale su<br />
un vetrino da microscopio in una goccia d’olio. Esaminare il preparato con obiettivo 10x.<br />
Demodex spp. (acari del follicolo)<br />
L’acaro del follicolo è ospite della cute nella maggior parte degli adulti, in modo particolare nelle donne, e di solito non<br />
comporta alcuna conseguenza patologica. E’ ospite specifico e sull’uomo si possono rinvenire due specie: Demodex<br />
follicularum, isolato dai follicoli dei capelli, e D. brevis, riscontrato nelle ghiandole sottocutanee. L’intero ciclo vitale si<br />
realizza nel follicolo.<br />
Descrizione: Le specie Demodex sono molto piccole in lunghezza (0.1 – 0.4 mm) e<br />
molto atipiche, in quanto presentano un aspetto vermiforme. Il corpo è striato<br />
trasversalmente e presenta quattro paia zampe tozze, poste anteriormente dietro<br />
all’apparato buccale. L’acaro vive nel follicolo e nelle ghiandole sebacee con la testa<br />
rivolta in basso, e si alimenta di tessuti sottocutanei e di essudati. L’infestazione si<br />
manifesta principalmente nell’area facciale, sulle palpebre e sul naso.<br />
Specie Demodex<br />
Rappresentazione di pidocchio adulto<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn).<br />
Patologia: Possono causare dermatite nei soggetti sensibilizzati, che si manifesta<br />
come acne, acne rosacea, impetigine contagiosa o blefarite.<br />
:<br />
Diagnosi: Spremere i contenuti dei pori follicolari attorno alla piega naso-labiale e<br />
strisciare su vetrino da microscopio. Esaminare il preparato con obiettivo 40x.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 22 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Acari Trombiculidi (chigger/acari della febbre della boscaglia)<br />
Specie Demodex<br />
Fotografia di acaro, preparato su vetrino<br />
a 340 ingrandimenti.<br />
Diaframma del condensatore in posizione 1<br />
per ottenere il massimo contrasto.<br />
© LSHTM<br />
Le larve degli acari trombiculidi sono parassiti dei vertebrati e sono note come chiggers, cimici della mietitura ed acari<br />
del graffio pruriginoso. Possono causare dermatiti nell’uomo e nel Sud-Est asiatico sono vettori della ‘rickettsiosi<br />
“originata dal chigger” (febbre della boscaglia). Le ninfe e le forme adulte sono predatori liberi.<br />
Descrizione: Le larve sono ovali, dal color bianco crema al rosso-arancio e di dimensioni molto piccole.(0.15 -0.3 mm<br />
di lunghezza). Sono dotate di tre paia di zampe che terminano con due unghie robuste. I palpi e l’apparto buccale<br />
sono larghi, di dimensioni notevoli, simili ad una testa. Zampe e corpo sono ricoperti da sottile peluria piumosa. Sulla<br />
parte dorsale si può osservare uno scudo, nella parte anteriore del corpo, dal quale esce un certo numero di setole.<br />
Ciclo vitale: Le femmine degli acari depongono le uova su lettiere di foglie o su terreno umido. Le uova si schiudono<br />
dopo circa una settimana e le larve rimangono all’interno del guscio per altri 5 – 7 giorni prima di fuoriuscire. Sono<br />
esapodi e cercano un ospite idoneo alla propria nutrizione arrampicandosi su uccelli e mammiferi di passaggio. La<br />
nutrizione sull’uomo dura 2-10 giorni e poi le larve, sazie, cadono sul terreno, vi penetrano e si mutano in protoninfe<br />
ad 8 zampe. Lo stadio di protoninfa è inattivo. Nella settimana successiva avviene la trasformazione in deutoninfa,<br />
stadio di vita libera con nutrizione sugli animali del suolo. Le deutoninfe sono attive per circa 2 settimane e poi vanno<br />
incontro ad un ulteriore periodo di quiescenza (tritoninfa) prima di trasformarsi nello stadio adulto. L’intero ciclo vitale<br />
richiede in genere 40 -75 giorni.<br />
Rappresentazione di acaro trombiculide (larva)<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Leptotrombidium akamushi – larva<br />
Fotografia di un vettore della febbre della boscaglia<br />
dal Giappone.<br />
© LSHTM<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 23 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Patologia: Le larve si attaccano alla cute dell’ospite utilizzando il loro potente apparato buccale ed iniettano la saliva<br />
nei tessuti del derma. La saliva induce la digestione dei tessuti che sono poi ingeriti dalla larva. Le ripetute<br />
inoculazioni di saliva portano alla formazione di un canale di alimentazione che si estende verticalmente nella cute<br />
dell’ospite. I morsi producono un’intensa dermatite pruriginosa, con formazione di pustole e papule poche ore dopo<br />
l’esposizione. Questa condizione è nota come “prurito da cimice del raccolto” o “graffio pruriginoso”. In Asia sono<br />
presenti acari che sono vettori della “Rickettsia tsutsugamushi”, agente causale della ‘rickettsiosi causata dal chigger’,<br />
nota anche come febbre della boscaglia. Nei casi in cui l’acaro è infettato, il morso non è doloroso ma si forma<br />
un’escara nel sito di esposizione. L’escara è una crosta compatta, nera ed aderente, di 3 – 6 mm di diametro,<br />
circondata da un sottile margine di colore rosso. I sintomi della “rickettsiosi causata dal chigger-” sono tipici anche di<br />
altre forme tifoidee e comprendono stato febbrile e dolenzia ai linfonodi.<br />
Diagnosi: si può avvalere della localizzazione e tipologia delle lesioni (stilostomi) sulla superficie cutanea. Gli acari<br />
attaccano di preferenza le aree attorno ai fianchi ed ai genitali dell’uomo. Se in un ospite sono presenti degli acari, si<br />
possono rimuovere abbastanza difficilmente e si deve porre particolare attenzione nell’isolare un campione per<br />
l‘esame microscopico. Per la ricerca degli acari, ogni materiale prelevato dal paziente deve essere sospeso in liquido<br />
di Berlese su un vetrino da microscopio ed esaminato con obiettivo 10x. Per ottenere il massimo contrasto<br />
posizionare ad 1 il diaframma del condensatore. Nella definizione diagnostica può essere utile l’anamnesi di eventuali<br />
viaggi.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 24 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Dermanyssus gallinae (acaro del pollo)<br />
Noto come acaro rosso del pollo od acaro del pollo, il Dermanyssus gallinae è un parassita del pollame e degli uccelli<br />
selvatici ed ha una distribuzione cosmopolita. In assenza degli ospiti usuali (quando gli uccelli si ricoprono di piume e<br />
abbandonano il nido) gli acari cercano attivamente nuovi ospiti e morsicano l’uomo.<br />
Descrizione: Gli acari, a digiuno, sono lunghi circa 0.7 mm<br />
e di color grigio. Sono soliti alimentarsi di notte, aumentando<br />
di volume fino ad 1 mm di lunghezza ed assumendo un<br />
colore rosso brillante. Sono dotati di zampe ben sviluppate e<br />
di un grande rostro.<br />
I cheliceri sono lunghi, a forma di frusta, affusolati verso<br />
l’estremità, molto fragili e possono rompersi durante la<br />
procedura di preparazione. La superficie dorsale del corpo è<br />
dotata di uno scudo. Lo scudo anale della superficie ventrale<br />
è a forma di coppa.<br />
Dermanyssus gallinae<br />
Rappresentazione della superficie dorsale<br />
di acaro femmina<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Dermanyssus gallinae<br />
Fotografia del rostro e delle zampe anteriori<br />
© LSHTM<br />
Dermanyssus gallinae<br />
Rappresentazione della superficie ventrale<br />
di acaro femmina<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Ciclo vitale: Le uova sono depositate nel materiale del nido dell’ospite e nelle fessure ed interstizi del pollaio. Il ciclo<br />
vitale è molto rapido e, in condizioni ottimali, può essere completato in una settimana. Sono state riscontrate<br />
infestazioni in abitazioni, ospedali e stazioni delle metropolitane, originate di solito da nidi abbandonati.<br />
Patologia: I morsi di D. gallinae sono dolorosi ed irritanti.<br />
Diagnosi: Gli acari sono visibili ad occhio nudo e possono essere prelevati dall’ospite o dai siti di permanenza<br />
ambientali (fessure ed interstizi di mobili o pareti). Prima della preparazione per l’identificazione l’acaro del pollame<br />
richiede un periodo di chiarificazione in lattofenolo.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 25 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
ZECCHE<br />
Le zecche (Sottoclasse: Acari) sono aracnidi (Classe: Arachnida) e come tali sono dotate di un corpo con segmenti<br />
fusi fra loro, che non presenta alcuna divisione fra testa, torace ed addome. Negli stadi adulti il corpo è dotato di otto<br />
zampe.<br />
Le zecche sono parassiti obbligati di ospiti vertebrati ed hanno un notevole impatto economico come ectoparassiti del<br />
bestiame e come vettori di malattia negli animali e nell’uomo 7 . Molte di loro si alimentano in modo opportunistico<br />
sull’uomo e possono essere responsabili della trasmissione di zoonosi virali, rickettsiosi, infezioni batteriche e<br />
protozoarie.<br />
Descrizione: Le zecche di solito hanno dimensione variabile da 1 a 30<br />
mm. Il dorso è ricoperto da un robusto tegumento cutaneo. Non è<br />
suddiviso in testa, torace ed addome, ma il rostro (struttura che<br />
sostiene l’apparato buccale) è di dimensioni notevoli e può essere<br />
confuso con la testa. Le zecche sono di solito più grandi degli acari, ma<br />
ciò non può essere considerato un carattere differenziale fra i due<br />
gruppi. La presenza di un ipostoma dotato di denti (parte mediana<br />
dell’apparato buccale) e quella dell’organo di Haller (sui tarsi del primo<br />
paio di zampe) distinguono in modo netto le zecche dagli acari<br />
Rappresentazione della visione ventrale del rostro della<br />
zecca, che ne pone in evidenza la base, l’ipostoma con i<br />
denti (segnalati dalla freccia) e le appendici dell’apparato<br />
buccale.<br />
(Illustrazione da Whitehorn)<br />
Rappresentazione di femmina di<br />
zecca dura<br />
(Illustrazione da Whitehorn)<br />
Rappresentazione della zampa anteriore<br />
che mostra l’organo di Haller (segnalato<br />
dalla freccia) di tipo sensoriale<br />
(Illustrazione da Whitehorn)<br />
Le zecche presentano un ciclo vitale incompleto, con forme adulte, ninfe e larve che occupano nicchie ecologiche<br />
simili. Da adulte e da ninfe le zecche sono dotate di otto zampe, da larve di sei. Gli stadi larvali possono essere<br />
confusi con gli insetti, tranne che per l’assenza della suddivisione corporea. Due sono le principali famiglie di zecche:<br />
zecche molli (famiglia Argasidae) e zecche dure (famiglia Ixodidae).<br />
Zecche molli- Argasidae<br />
Le zecche molli sono dotate di un tipico corpo dall’aspetto ovale, con dimensione di 4–15 mm. Dispongono di un<br />
tegumento cutaneo robusto, che può essere di aspetto granulare o con piccoli tubercoli. L’apparato buccale è sito<br />
nella parte ventrale del corpo e pertanto non è visibile dalla parte superiore. L’assenza dello scudo dorsale e la<br />
localizzazione ventrale dell’apparato buccale facilitano la differenziazione fra zecche molli e zecche dure. Vi è un<br />
dimorfismo sessuale minimo nelle zecche molli.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 26 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Ciclo vitale: Il ciclo vitale delle zecche molli è un po’ più complesso di quello<br />
delle zecche dure a causa di un maggior numero di stadi ninfali ed una vita più<br />
lunga negli adulti. Le uova si aprono per generare larve a sei zampe, la larva si<br />
trasforma in ninfa ad otto zampe (sono possibili da 2 a 8 stadi larvali, a seconda<br />
della specie), per poi dare vita alle forme adulte con otto zampe. Le zecche<br />
molli ingeriscono un numero di pasti maggiore rispetto a quelle dure ed in un<br />
tempo inferiore (15–120 minuti), pertanto sono rinvenute raramente adese ai<br />
pazienti. Le larve assumono solo un pasto ematico, ma nei successivi stadi di<br />
ninfa e di adulto vengono ingeriti due o più pasti. Le zecche molli sono note<br />
come zecche di un solo ospite, in quanto sono solitamente associate ad un<br />
ospite di una sola specie durante tutto il corso della loro vita. Dopo ogni pasto<br />
ematico le femmine depositano una piccola quantità di uova e possono vivere<br />
per più di una decade. Le zecche molli trascorrono più del 99% del loro tempo<br />
lontane dall’ospite. Sono molto resistenti alla disidratazione ed al digiuno ed<br />
entrano in uno stato di torpore per sopravvivere a condizioni avverse.<br />
Visione dorsale di una<br />
zecca molle.<br />
(Illustrazione da Whitehorn)<br />
Importanza clinica delle zecche molli: Le zecche molli di rilevanza medica sono Ornithodoros, Otobius ed<br />
Argas.<br />
Ornithodoros moubata<br />
Vettore della febbre<br />
ricorrente.<br />
© LSHTM<br />
Il genere Ornithodoros comprende un certo numero di importanti e fastidiose<br />
specie che mordono l’uomo e sette specie riconosciute in grado di trasmettere la<br />
febbre ricorrente originata dalle zecche. I componenti di questo genere possono<br />
essere riconosciuti per la cuticola scura mammellonata e l’assenza di una linea<br />
laterale fra le superfici dorsale e ventrale del corpo. Ornithodoros moubata è<br />
probabilmente il vettore più importante delle febbre ricorrente da morso di zecca<br />
nell’Africa tropicale, ma la malattia è presente anche nell’America del Sud e<br />
Centrale.<br />
Otobius megnini (zecca spinosa dell’orecchio) è in primo luogo un ectoparassita dei bovini e dei cavalli, ma può<br />
attaccare l’uomo in modo opportunistico. La cavità dell’orecchio è la sede di attacco preferita della larva e della ninfa,<br />
e le ninfe vi possono rimanere adese per alcuni mesi. Le ninfe variano di dimensione, da 4 a 8 mm, e possono essere<br />
riconosciute per la presenza di spine fitte e scure sulla superficie dorsale. La cuticola è priva di una chiara linea<br />
laterale fra le superfici dorsale e ventrale. L’otobius è riscontrabile solo nelle aree particolarmente calde ed aride<br />
delle Americhe, Africa ed India. Le forme adulte delle specie di zecche Otobius non si alimentano.<br />
I componenti del genere Argas sono presenti ovunque e sono associati soprattutto agli uccelli. Queste zecche<br />
attaccano l’uomo in modo opportunistico e producono morsicature particolarmente dolorose. Possono mordere l’uomo<br />
in tutti gli stadi vitali (larva, ninfa ed adulto), ma le larve Argas rimangono adese ai loro ospiti e continuano ad<br />
alimentarsi per un certo numero di giorni. Il corpo della zecca è lievemente levigato, con superfici corporea dorsale e<br />
ventrale separate da un’evidente striscia di cellule rettangolari appiattite.<br />
Inviare tutte le zecche molli ad una struttura di riferimento per l’identificazione.<br />
Zecche dure - Ixodidae<br />
Le zecche dure sono riconosciute per la presenza di uno scudo, di apparato buccale visibile dalla superficie dorsale e<br />
per un evidente dimorfismo sessuale negli adulti. Lo scudo è una piastra rigida posta sulla parte dorsale del corpo. In<br />
alcune specie può essere colorato. Nei maschi lo scudo ricopre completamente la parte dorsale, mentre nelle<br />
femmine e negli stadi immaturi si trova sulla parte anteriore del corpo (per consentire il completo riempimento durante<br />
il pasto). Le femmine sono distinguibili dalle ninfe per la presenza sia di un’apertura genitale sulla superficie ventrale<br />
che di aree porose sulla base del rostro.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 27 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Amblyomma variegatum<br />
Fotografia di maschio e di femmina<br />
© LSHTM<br />
Ciclo vitale: Il ciclo vitale della zecca dura è relativamente semplice, con uova che si schiudono per rilasciare una<br />
larva a sei zampe; questa si trasforma in ninfa ad otto zampe, che poi diventa una zecca adulta, sempre ad otto<br />
zampe. Ogni stadio richiede un solo pasto prima di evolvere, ma possono essere necessari più anni per il<br />
completamento dell’intero ciclo vitale. Le zecche dure si alimentano lentamente e restano adese all’ospite per alcuni<br />
giorni. Sono spesso definite zecche multi–ospite, perché, durante il ciclo vitale, sono associate di norma a due o tre<br />
specie di ospiti (ad esempio, larva–topo, ninfa-coniglio, adulto–pecora). Le femmine producono un singolo<br />
agglomerato di uova e muoiono dopo breve tempo. Le zecche dure trascorrono il 90% dei loro tempi di quiescenza<br />
distanti dall’ospite, andando incontro ai vari processi di sviluppo. Sono molto sensibili all’essiccamento ed alle<br />
temperature estreme.<br />
Zecche dure di importanza medica: Nel Regno Unito i componenti del genere Ixodes sono ritenuti vettori della<br />
malattia di Lime. Due delle specie più comunemente segnalate sono Ixodes ricinus e Ixodes hexagonus. Il genere<br />
può essere riconosciuto dall’esame del solco anale presente sulla superficie ventrale della zecca8 .<br />
Rappresentazione del solco anale delle<br />
zecche appartenenti al genere Ixodes<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Solco anale<br />
Rappresentazione del solco anale di tutte le<br />
altre zecche dure<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Per le Ixodes il solco anale circonda anteriormente l’ano. Per tutti gli altri generi di zecche il solco anale circonda l’ano<br />
posteriormente.<br />
Il rischio di trasmissione di malattia si riduce se il paziente è stato morsicato da una zecca Britannica appartenente ad<br />
un altro genere.<br />
Inviare all’appropriata struttura di riferimento qualsiasi specie diversa dalla Ixodes acquisita all’estero.<br />
Malattia di Lime: La malattia di Lime è un’infezione batterica causata dalla spirocheta Borrelia burgdorferi. Si tratta di<br />
una zoonosi associata alle foreste e ad habitat di brughiera. Le riserve più importanti sono i roditori (topo della foresta<br />
e di campagna). Nelle zecche a digiuno le spirochete sono circoscritte all’intestino medio e solo dopo l’inizio del pasto<br />
migrano verso le ghiandole salivari. La rapida rimozione delle zecche (entro 24 – 48 ore dall’attacco) è pertanto<br />
importante per la riduzione del rischio di trasmissione della malattia.<br />
Paralisi da zecca: La paralisi da zecca è causata dall’inoculo nell’ospite di una neurotossina (presente nella saliva)<br />
durante il pasto della femmina. E’ noto che un certo numero di zecche dure causa questa condizione patologica, ma<br />
nessuna è originaria del Regno Unito. Cinque, sette giorni dopo l’attacco l’ospite può presentare affaticamento,<br />
torpore e dolore muscolare, sintomatologia che può evolvere rapidamente verso una paralisi parziale, convulsioni ed<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 28 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
insufficienza respiratoria, a meno che la zecca sia stata localizzata ed attentamente rimossa. I sintomi permarranno<br />
fino a quando ogni parte dell’apparato buccale rimarrà nell’ospite.<br />
Rimozione delle zecche: La rimozione forzata delle zecche determina spesso un danneggiamento dell’apparato<br />
buccale ed il rischio che alcuni residui restino nella cute del paziente. L’apparato buccale ha inoltre delle<br />
caratteristiche importanti per l’identificazione delle zecche e pertanto è essenziale che venga rimosso con tecnica<br />
corretta. Usare con cautela (ma sicurezza) pinze sottili e prelevare l’apparato buccale della zecca il più vicino<br />
possibile alla cute del paziente. Ruotarlo in senso orario mentre si allontana la zecca dalla cute. Un’azione decisa ma<br />
appropriata consente la rimozione della zecca senza danneggiarne l’intera parte. Trasferire la zecca in una provetta<br />
sterile ed inviare per l’identificazione. Sterilizzare le pinze, pulire e disinfettare il sito della ferita. Controllarlo nei giorni<br />
successivi per verificare la comparsa di qualsiasi manifestazione eritematosa.<br />
Preparazione del materiale: Le zecche devono essere uccise in acqua calda (85°C) e conservate in etanolo 70%.<br />
Una volta rimosse dall’etanolo, le forme adulte devono essere esaminate con microscopio da dissezione ed osservate<br />
in condizione asciutta. La morfologia corporea è più chiara dopo l’evaporazione dell’etanolo. Le ninfe e le larve<br />
devono essere preparate su vetrino in terreno di Hoyer* ed esaminate con microscopio composto. Fare riferimento<br />
alle classificazioni in famiglie delle zecche di Lane e Crosskey ed all’intero testo di Hillyard8 per la classificazione delle<br />
zecche dell’Europa nord-occidentale.<br />
Il terreno di Hoyer è costituito da 50 ml di acqua distillata, 30 g di gomma Arabica cristallizzata, 200 g di idrato di<br />
cloralio e 20 ml di glicerina7 .<br />
Ixodes ricinus (zecca comune della pecora, zecca a seme di ricino o zecca dei boschi)<br />
Questa zecca è presente nell’Europa nord-occidentale e nella maggior parte della Regione Paleartica Occidentale, in<br />
modo particolare nei pascoli delle pecore delle Isole Britanniche.<br />
Descrizione: E’ fornita una descrizione succinta di tutti gli stadi, ma quello della ninfa e della femmina adulta sono i<br />
più consultati. Si prega di fare riferimento a P. Hillyard (pg. 74–76) per le illustrazioni delle strutture di seguito<br />
specificate8 .<br />
Larva: La lunghezza della larva a digiuno è di circa 1 mm. Lo stadio larvale è dotato di sole 3 paia di zampe e lo<br />
scudo ricopre solo parzialmente la superficie dorsale del corpo. I palpi (segmenti 2 e 3) sono più lunghi della<br />
larghezza della base del rostro. I denticoli dell’ipostoma sono disposti in due o tre serie, 3/3 nella parte distale, poi sei<br />
o sette di 2/2. Sulla superficie ventrale della base sono presenti le auricole come proiezioni distinte. Lo scudo è più<br />
largo che lungo e di aspetto esagonale. Le coxe dalla 1 alla 3 sono dotate di distinti speroni esterni e la coxa 1 di un<br />
piccolo sperone interno.<br />
Ninfa8 : La lunghezza della ninfa a digiuno è di 1.3 –1.5 mm. Le ninfe sono dotate di 4 paia di zampe, uno scudo che<br />
ricopre solo parzialmente la superficie dorsale, e mancano del poro genitale sulla superficie ventrale. I palpi (segmenti<br />
2 e 3) sono più lunghi della larghezza della base del rostro. Lo scudo è di aspetto quasi circolare, le auricole (strutture<br />
poste sulla superficie ventrale della base) assomigliano a triangoli divergenti e la coxa 1 (primo segmento della prima<br />
zampa) è dotata di uno sperone interno (appendice appuntita della coxa) più sviluppato rispetto a quello esterno.<br />
Rappresentazione della faccia dorsale<br />
della ninfa di Ixodes ricinus<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Rappresentazione della faccia ventrale<br />
della ninfa di Ixodes ricinus<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 29 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Maschio adulto 8 : La lunghezza del maschio è di 2.4 – 2.8 mm. Lo scudo ricopre la superficie dorsale del corpo. I<br />
palpi sono corti e larghi. L’ipostoma è dotato di denti prominenti. Lo sperone interno della coxa 1 è tre volte più lungo<br />
di quello esterno. Il tarso 1 (di profilo) si assottiglia gradualmente.<br />
Femmina adulta 8 : La lunghezza della femmina a digiuno è di 3.0–3.6 mm. Lo scudo ricopre parzialmente la<br />
superficie dorsale del corpo; sulla superficie ventrale è presente un’apertura genitale; due aree porose sono<br />
riscontrabili sulla base dorsale del rostro. I palpi (segmenti 2 e 3) sono più lunghi rispetto alla larghezza della base del<br />
rostro. Lo scudo è lievemente più lungo che largo e chiaramente rotondeggiante nella parte posteriore. Le auricole<br />
sono assenti. La coxa 1 è dotata di uno lungo sperone interno. Il tarso 1 (di profilo) si assottiglia gradualmente.<br />
L’apertura genitale è sita fra le coxe 4.<br />
Ixodes hexagonus (zecca del riccio)<br />
Presente in modo diffuso nell’Europa Occidentale, questa zecca è un parassita di ricci, volpi, tassi e cani.<br />
Frequentemente I. hexagonus morde l’uomo.<br />
Descrizione: E’ fornita una descrizione succinta di tutti gli stadi, ma, per l’identificazione, quelli di ninfa e di femmina<br />
adulta sono i più comunemente utilizzati. Si prega di fare riferimento a P. Hillyard (pg. 88 – 90) per le rappresentazioni<br />
delle strutture di seguito riportate 8 . La descrizione delle larve della zecca è riprodotta da Arthur 9 . In modo particolare<br />
per le larve di I. ricinus (pg 33) e di I. hexagonus (pg 65).<br />
Larva: La lunghezza della larva a digiuno è di circa 1 mm. La larva è dotata di sole 3 paia di zampe e lo scudo ricopre<br />
solo parzialmente la superficie dorsale del corpo. I palpi (segmenti 2 e 3) sono all’incirca lunghi come la larghezza<br />
della base del rostro. I denticoli sono sistemati distalmente su due o tre file di 3/3, poi in circa quattro file di 2/2. Le<br />
auricole sono presenti come creste ispessite. Lo scudo è di solito più lungo che largo e a forma di cuore. La coxa 1 è<br />
dotata di un largo sperone interno, ma mancano altri speroni.<br />
Ninfa 8 : La lunghezza della ninfa a digiuno è di 1.2–1.4 mm. Le ninfe sono dotate di 4 paia di zampe e di uno scudo<br />
che ricopre solo parzialmente la superficie dorsale; manca l’apertura genitale sulla superficie ventrale. I palpi<br />
(segmenti 2 e 3) sono lievemente più corti della larghezza del rostro alla base. Lo scudo è più lungo che largo e di<br />
aspetto esagonale. Le auricole sono assenti. Lo sperone interno dalla coxa 1 è corto, quelli esterni delle coxe 1 – 4<br />
sono ridotti od assenti.<br />
Rappresentazione della superficie dorsale<br />
di ninfa di Ixodes hexagonus<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Rappresentazione della superficie ventrale<br />
di ninfa di Ixodes hexagonus<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Maschio adulto 8 : La lunghezza del maschio è di 3.5-3.8 mm. Lo scudo ricopre la superficie dorsale del corpo, che è<br />
grossolanamente ovale. I palpi sono corti e larghi. L’ipostoma è quasi privo di denti. Lo sperone interno sulla coxa 1 è<br />
lungo. Il tarso 1 (visto di profilo) è chiaramente scalinato in prossimità dell’apice.<br />
Femmina adulta 8 : La lunghezza della femmina a digiuno è di 3.5 – 4.0 mm. Lo scudo ricopre parzialmente la<br />
superficie dorsale; è presente l’apertura genitale sulla superficie ventrale e si riscontrano due aree porose sulla base<br />
dorsale del rostro; i palpi (segmenti 2 e 3) sono lievemente più corti della larghezza della base (del rostro). Lo scudo<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 30 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
ha una caratteristica forma a cuore o esagonale. Sono evidenti tracce di auricole. La coxa 1 è dotata di un lungo<br />
sperone interno. Il tarso 1 (di profilo) è chiaramente scalinato in prossimità dell’apice. L’apertura genitale è localizzata<br />
fra le coxe 3.<br />
MIASI DA LARVE <strong>DI</strong> MOSCA<br />
La miasi è causata da larve di mosca (larve di Ditteri) che invadono gli animali vertebrati per nutrirsi di tessuti viventi o<br />
necrotici, di liquidi corporei o di alimenti ingeriti dall’ospite 10 . Nei loro stadi larvali le mosche che provocano la miasi<br />
sono parassiti obbligati o facoltativi; nel primo caso si possono sviluppare su o in un’ospite vivente, nel secondo<br />
anche su materiale organico in putrefazione. In funzione della loro capacità di attaccare l’ospite i parassiti facoltativi<br />
possono essere invasori primitivi, secondari o terziari degli animali vertebrati. Gli invasori primari danno inizio alla<br />
miasi, quelli secondari o terziari attaccano l’ospite solo dopo che la miasi è stata iniziata da altre specie. Si deve<br />
comunque notare che gli invasori primari (la mosca verde Lucilia sericata) richiedono sempre condizioni<br />
predisponenti, quali una ferita o una scarsa igiene, che stimolino la deposizione delle uova. Non inizieranno mai la<br />
miasi su animali puliti e sani. Una condizione, nota come pseudomiasi, si può manifestare quando le larve o le uova di<br />
alcune specie sono ingerite accidentalmente o transitano vive attraverso l’intestino dell’ospite.<br />
Descrizione: Le larve della miasi non hanno un aspetto uniforme perché originano da diverse famiglie di ditteri.<br />
Quelle di importanza clinica hanno comunque due forme principali: la classica cuneiforme e quella più arrotondata<br />
vermiforme. Il corpo è suddiviso in 12 segmenti, il primo dei quali costituisce la testa, i successivi tre formano il torace<br />
e gli ultimi otto l’addome. Comunque vi è una scarsa differenziazione fra i segmenti. Il primo contiene lo scheletro<br />
cefalofaringeo (parti buccali), che presenta caratteri tassonomici importanti per l’identificazione. Il secondo segmento<br />
è dotato anteriormente di un paio di spiracoli che lo congiungono, per mezzo di due segmenti tracheali, agli spiracoli<br />
posteriori siti sul 12° segmento corporeo (terminale). Gli spiracoli e le trachee rappresentano l’apparato respiratorio<br />
della larva della mosca e forniscono inoltre caratteristiche utili per l’identificazione. Le larve della miasi non sono<br />
dotate di zampe, ma alcune specie presentano rigonfiamenti corporei, formazioni appuntite e strutture che facilitano la<br />
locomozione e prevengono l’allontanamento dall’ospite.<br />
Miasi di importanza clinica da larve di mosca: Nel Regno Unito i generi inviati per l’identificazione sono soprattutto<br />
Lucilia (mosca verde), Calliphora (mosca blu), Oestrus (estro degli ovini) e Sarcophaga (moscone della carne) 11 .<br />
Cordylobia (mosca di Tumbu e mosca di Lund) e Dermatobia (human bot-fly) sono entrambi generi tropicali,<br />
riscontrabili occasionalmente in viaggiatori che rientrano dall’estero nel Regno Unito. Alcuni generi sono noti come<br />
importanti agenti di miasi e molti altri hanno scarso rilievo clinico. Questa POS prenderà in considerazione solo i<br />
generi inviati di solito per l‘identificazione. Tutte le descrizioni incluse sono riferibili a larve del terzo stadio, tranne<br />
quella relativa a Oestrus ovis, in cui è descritta la larva del primo stadio. Consultare Lane e Crosskey 2 per le chiavi<br />
dicotomiche d’identificazione delle famiglie e dei generi delle larve della miasi.<br />
Preparazione del materiale: Le larve della miasi devono essere uccise con immersione in acqua calda o bollente<br />
(90° -100°C) per 15–30 secondi e poi conservate in etanolo 70% prima della preparazione. Prendere la larva e<br />
tagliare l’ultimo segmento, che è dotato di spiracoli posteriori. Porre il segmento ed il corpo in una provetta contenente<br />
potassa caustica al 5% (KOH), trasferire in bagno di acqua e riscaldare lentamente fino all’ebollizione. Rimuovere dal<br />
bagno e lasciare raffreddare il contenuto per 10 minuti. Lavare bene in acqua il corpo ed il segmento posteriore (due<br />
lavaggi di circa 5 minuti ciascuno). Trasferire il corpo della larva su un vetrino ed iniziare a spremere il contenuto del<br />
corpo fuori dalla cuticola. Per estrarre tutti i tessuti del corpo può essere necessario ripetere la procedura di bollitura<br />
in KOH per due o tre volte. Disidratare la cuticola corporea ed il segmento posteriore, aumentando la concentrazione<br />
dell’etanolo (70%, 90% ed assoluto) ogni volta per cinque minuti. Immergere nuovamente in alcool assoluto per<br />
cinque minuti prima di trasferire in cellosolve (2-etossietanolo) per ulteriori cinque minuti. Montare il campione al<br />
centro di un vetrino da microscopio direttamente in euparal. La cuticola corporea deve essere posizionata<br />
lateralmente nella metà superiore del vetrino ed il segmento posteriore al di sotto (cuticola esterna rivolta verso l’alto).<br />
Posizionare il coprioggetto ed esaminare il campione attentamente. Per ottenere un preparato permanente, porre il<br />
campione su vetrino in una stufa a 55°C per 4–6 settimane. Etichettare il vetrino con: identificazione, numero di<br />
riferimento e dati di raccolta.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 31 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Lucilia - Mosca verde<br />
Le mosche verdi hanno una distribuzione cosmopolita. Le femmine depositano le uova in ferite non curate o su tessuti<br />
sporchi. Le larve si nutrono direttamente di tessuti o su escare necrotiche. Le femmine depositano le uova anche su<br />
carni o pesci crudi e cotti e, se queste sono ingerite, si può manifestare una miasi intestinale 5 .<br />
Descrizione: Le larve del genere Lucilia hanno l’aspetto classico della “larva”, con un segmento anteriore sottile<br />
dotato di uncini buccali che si allargano fino al segmento posteriore, che appare tronco.<br />
Specie Lucilia<br />
Rappresentazione di larva al terzo stadio.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
La larva adulta è lunga circa 14 mm ed è da bianco a crema. Gli spiracoli posteriori sono posti sulla superficie del<br />
segmento terminale, e ciascuno è costituito da tre sottili fessure circondate da un anello perimetrale dotato di un unico<br />
occhiello.<br />
Specie Lucilia<br />
Visione posteriore del<br />
segmento terminale<br />
della larva al terzo stadio.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Lucilia species<br />
Fotografia degli spiracoli<br />
posteriori © LSHTM<br />
Non sono presenti scleriti orali accessori (un piccolo sclerite addizionale è presente fra i rostri buccali).<br />
Lucilia spp.<br />
Fotografia dei segmenti anteriori che evidenziano<br />
lo scheletro cefalofaringeo e gli spiracoli anteriori.<br />
© LSHTM<br />
Lucilia spp.<br />
Rappresentazione dello scheletro cefalofaringeo<br />
Notare la mancanza di scleriti orali accessori<br />
fra i rostri buccali.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 32 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Calliphora – Mosche blu<br />
Le mosche blu hanno una distribuzione cosmopolita. Le femmine depositano di solito le uova su materiale organico in<br />
putrefazione e generalmente attaccano l’uomo come invasori secondari. Possono deporre uova anche sulla carne<br />
fresca e, se questa viene in seguito ingerita, si può sviluppare una miasi.<br />
Descrizione: Le larve del genere Calliphora sono<br />
lievemente più larghe di quelle del genere Lucilia, ma<br />
hanno la stessa conformazione corporea e colore identici.<br />
La larva matura è lunga circa 17 mm. Gli spiracoli<br />
posteriori sono localizzati sulla superficie del segmento<br />
terminale e ciascuno è formato da tre sottili fessure,<br />
circondate da un anello perimetrale con un distinto<br />
occhiello. Le specie di Calliphora sono distinguibili da<br />
quelle di Lucilia per la presenza di uno sclerite orale<br />
accessorio fra i rostri buccali.<br />
Calliphora<br />
Specie Calliphora<br />
Fotografia dello scheletro cefalofaringeo<br />
Nota: presenza di sclerite orale<br />
accessorio fra i rostri buccali.<br />
© LSHTM<br />
Spiracoli posteriori della specie<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Specie Calliphora<br />
Rappresentazione dello scheletro cefalofaringeo<br />
Nota: presenza di sclerite orale<br />
accessorio fra i rostri buccali.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 33 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Cordylobia anthropophaga – Mosca Tumbu<br />
La mosca Tumbu è presente nell’Africa sub-Sahariana. Le femmine depositano le uova nel suolo sabbioso<br />
umido o su indumenti stesi all’ombra ad asciugare (siti contaminati da sudore, feci od orina sono particolarmente<br />
favorevoli). Le larve emergono dopo 2 giorni e formano gallerie nei tessuti sottocutanei quando sono stimolate<br />
dall’ospite. Rimangono nel derma, formando ciascuna un rigonfiamento simile ad un foruncolo. Sono necessari 3<br />
stadi larvali, che si completano in 8–12 giorni. La larva matura emerge dal “foruncolo e cade a terra per<br />
trasformarsi in pupa.<br />
Descrizione: Le larve del genere Cordylobia hanno un<br />
aspetto simile ad un bruco, essendo carnose ed<br />
arrotondante ad entrambe le estremità. Una larva matura di<br />
C. anthropophaga è lunga all’incirca 12 mm e larga 5 mm.<br />
Dal terzo all’undicesimo segmento il corpo è densamente<br />
ricoperto di spine sottili. Gli spiracoli posteriori sono siti sulla<br />
superficie del segmento terminale. Ogni spiracolo è dotato<br />
di tre fessure leggermente sinuose, circondate da un anello<br />
perimetrale che non è dotato d’occhiello. Cordylobia anthropophaga<br />
Rappresentazione della larva al terzo stadio.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Cordylobia anthropophaga - Rappresentazione degli<br />
spiracoli posteriori della larva al terzo stadio.<br />
Cordylobia rodhaini – Mosca di Lund<br />
C. anthropophaga<br />
Fotografia degli spiracoli posteriori.<br />
© LSHTM<br />
La mosca di Lund è presente nelle foreste pluviali dell’Africa tropicale; il suo aspetto ed il suo ciclo biologico sono<br />
simili a quelli della mosca Tumbu.<br />
Descrizione: La larva di C. rodhaini assume l’aspetto di un verme e, nella forma matura, è lunga 17-33 mm e larga 8<br />
mm. Il corpo è ricoperto da numerose e grosse spine. Gli spiracoli posteriori sono posti sulla superficie del segmento<br />
terminale.<br />
Cordylobia rodhaini – Rappresentazione degli spiracoli<br />
della larva al terzo stadio.<br />
C. rodhaini.<br />
Fotografia degli stigmi posteriori della larva<br />
al terzo stadio. © LSHTM<br />
Ogni spiracolo è formato da tre fessure a serpentina, non circondate da un anello perimetrale ma hanno un occhiello<br />
non ben definito.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 34 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Dermatobia hominis – La bot-fly umana<br />
La bot-fly umana è presente nell’America Centrale e Meridionale. Le femmine delle mosche depositano gruppi di uova<br />
su zanzare e altre mosche ematofaghe, ma anche su zecche. Questi “vettori” ricercano un ospite e mentre si nutrono,<br />
le uova della bot-fly si schiudono (stimolate dalla temperatura e dagli odori dell’ospite). Le larve scavano gallerie nella<br />
cute, formando singoli rigonfiamenti simili a foruncoli. Sono noti tre stadi larvali che, per il loro completamento,<br />
richiedono 6 -12 settimane. Le larve mature emergono poi dal ”foruncolo” e cadono sul terreno per diventare pupe. I<br />
“foruncoli” sono dolorosi per periodi brevi durante la nutrizione della larva, lo sono meno durante le fasi di sviluppo. I<br />
liquidi che drenano dalla ferita (feci delle larve e liquidi corporei dell’ospite) possono costituire uno stimolo a deporre<br />
in loco le uova per altre mosche della miasi.<br />
Descrizione: Le larve hanno un caratteristico “aspetto a pera” con un rigonfiamento anteriore ed una parte posteriore<br />
assottigliata. L’aspetto corporeo rende particolarmente difficile la loro rimozione quando sono annidate nell’ospite.<br />
Una larva matura misura circa 20 mm di lunghezza ed 8 mm nella parte più larga. I segmenti anteriori e centrali sono<br />
dotati di numerose formazioni spinose, quelli posteriori non hanno spine ma su quello terminale sono presenti piccoli<br />
denti. Gli spiracoli posteriori sono racchiusi in una cavità del segmento terminale e sono formati da tre fessure strette<br />
prive di anello perimetrale e di occhiello.<br />
Dermatobia hominis<br />
Rappresentazione della larva al<br />
secondo stadio.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Oestrus ovis –estro nasale della pecora<br />
Dermatobia hominis<br />
Rappresentazione della larva al<br />
terzo stadio.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
Dermatobia hominis<br />
Visione posteriore del<br />
segmento terminale per<br />
evidenziare gli spiracoli.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
La larva dell’estro nasale della pecora è diffusa in tutto il mondo ed è presente soprattutto dove sono allevate pecore<br />
e capre. La femmina di mosca deposita la prima forma larvale viva preferibilmente nella sede nasale dell’ospite,<br />
seguita da occhi, bocca ed orecchio. Le persone, specie chi lavora con il bestiame, possono essere occasionalmente<br />
coinvolte. I casi più frequenti sono legati a pazienti che riferiscono di essere stati colpiti all’occhio da un corpo di<br />
piccole dimensioni, con insorgenza di una condizione infiammatoria dolorosa nelle ore successive. Può essere<br />
formulata diagnosi di congiuntivite catarrale acuta. L’Oestrus non è di solito invasivo nell’uomo. Il primo stadio larvale<br />
non è in grado di svilupparsi successivamente, ma può rimanere vitale per dieci giorni, provocando disagio al<br />
paziente durante questo periodo. La larva deve essere rimossa dal sacco congiuntivale da un oculista.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 35 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Descrizione: Le larve del primo stadio sono molto piccole (lunghezza 1.0 mm), di forma allungata, ovale e<br />
trasparente; i voluminosi rostri buccali, particolarmente visibili, hanno importanza diagnostica.<br />
Oestrus ovis<br />
Fotografia di larva al primo stadio.<br />
© LSHTM<br />
Oestrus ovis<br />
Rappresentazione dei segmenti anteriori<br />
della larva al primo stadio.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
I poderosi rostri buccali sono ricurvi ad uncino e possono essere retratti nella struttura corporea. Su ogni segmento<br />
corporeo sono presenti spine di piccole dimensioni; l’ultimo è dotato di due prominenze, entrambe fornite di un certo<br />
numero di piccoli uncini.<br />
Sarcophaga – mosconi della carne<br />
Le mosche della carne hanno una distribuzione cosmopolita. Le femmine depositano le larve al primo stadio<br />
direttamente su materiale organico o sulle feci, e di solito attaccano l’uomo solo come invasori secondari. L’eccezione<br />
è rappresentata dalla Wohlfahrtia magnifica, che è un invasore primario obbligato. Le specie di Sarcophaga sono<br />
conosciute come infestatrici delle piaghe da decubito nei pazienti anziani. Le femmine depongono le uova anche sui<br />
generi alimentari e, se questi vengono ingeriti, si potrà manifestare una miasi intestinale.<br />
Descrizione: Le larve del genere Sarcophaga hanno un aspetto classico, con un segmento anteriore sottile, dotato di<br />
uncini buccali, che si congiunge ad un segmento posteriore tronco. La larva matura è lunga circa 16 -22 mm.<br />
Specie Sarcophaga<br />
Rappresentazione di larva al terzo stadio.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn) Sarcophaga species<br />
Visione posteriore del segmento terminale.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn)<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 36 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Gli spiracoli posteriori sono posti in una cavità profonda del segmento terminale e possono risultare non visibili<br />
quando questa è chiusa. Gli spiracoli sono costituiti da tre fessure diritte circondate da un anello perimetrale aperto<br />
privo di occhiello.<br />
Specie Sarcophaga<br />
Rappresentazione degli spiracoli posteriori<br />
della larva di terzo stadio.<br />
(Illustrazione da C. Whitehorn<br />
SANGUISUGHE<br />
Specie Sarcophaga<br />
Fotografia degli spiracoli posteriori<br />
© LSHTM<br />
Descrizione: Le sanguisughe 12-14 (Euhirudinea) sono anellidi ermafroditi, che si alimentano succhiando sangue e<br />
liquidi tissutali dai loro ospiti. Si conoscono forme acquatiche e terrestri.<br />
Le sanguisughe acquatiche sono cosmopolite. Le specie terrestri 15 si trovano nel Sud Est Asiatico, nelle isole del<br />
Pacifico, nel Subcontinente indiano, nel Sud America. Abitano nelle foreste pluviali tropicali e sono particolarmente<br />
moleste quando si attaccano alla cute dell’uomo e degli animali. I singoli morsi di queste sanguisughe hanno di solito<br />
scarsa rilevanza clinica e non sono associati ad infezioni o a trasmissione di malattie, anche se numerosi agenti<br />
patogeni, inclusi virus di origine ematica (virus I e II dell’immunodeficienza, virus dell’epatite B), sono costantemente<br />
presenti nel corpo delle sanguisughe 16 .<br />
Sono descritte infezioni iatrogene con specie Aeromonas, specialmente nell’utilizzo clinico delle sanguisughe (in<br />
genere di Hirudo medicinalis, ma non solo 17 ) Queste sanguisughe vivono in simbiosi con batteri del genere<br />
Aeromonas, che, in coltura pura, colonizzano spesso il loro intestino 18, 19 , dove possono essere presenti anche altri<br />
potenziali batteri patogeni 17, 20 .<br />
H. medicinalis può essere applicata per ridurre la congestione da intervento di chirurgia plastica o vascolare, oppure<br />
dopo interventi ricostruttivi vascolari. I tessuti congesti possono essere particolarmente sensibili all’infezione da<br />
specie Aeromonas.<br />
Quando una sanguisuga attaccata alla cute termina il proprio pasto, di solito si stacca in modo spontaneo. La perdita<br />
di sangue, se non arrestata con fasciatura appropriata (durante la nutrizione la sanguisuga inietta un anticoaugulante,<br />
l’irudina), può continuare per parecchi minuti o ore.<br />
Una sanguisuga attaccata deve alimentarsi per un certo periodo, fino a quando dalla ferita esce sangue. Il che<br />
consente l’allontanamento di ogni microrganismo introdotto nella lesione.<br />
Le sanguisughe usate a scopi clinici devono essere applicate ad un solo paziente.<br />
Il primo sospetto di una morso da sanguisuga selvatica è spesso rappresentato dal riscontro di sangue nel vestiario,<br />
conseguenza di un rigurgito da pasto recente e del distacco dall’ospite. Piuttosto che staccare direttamente dal<br />
paziente la sanguisuga terrestre, alcuni 15 preferiscono farlo applicando al suo corpo il calore ustionante di una<br />
sigaretta o di un fiammifero, oppure utilizzando una soluzione salina ad elevata concentrazione, o alcool, evitando in<br />
tal modo che parti dell’apparato buccale rimangano incastrate nella ferita. La soluzione ottimale è però controversa.<br />
Alcune sanguisughe dell’America del Sud non hanno mandibole e si nutrono inserendo una proboscide nella parte<br />
profonda dei tessuti dell’ospite. La loro rimozione forzata può far rimanere una lunga porzione tubulare di tessuto di<br />
sanguisuga nell’ospite.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 37 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Alcune delle specie acquatiche (nasofaringee) sono in grado di causare gravi malattie nell’uomo e negli animali,<br />
talvolta ad esito letale. Si possono trovare nelle acque dolci di alcune zone del Medio Oriente e dell’Africa, nel sub<br />
continente Indiano ed in Cina.<br />
Queste sanguisughe sono piccole e di aspetto filamentoso quando si attaccano all’ospite, penetrano nei corpi degli<br />
animali che si abbeverano e dell’uomo che si di disseta, oppure in persone che si bagnano in acque superficiali,<br />
inserendosi nelle mucose del nasofaringe e della cavità buccale, occasionalmente in quella esofagea o nell’albero<br />
tracheobronchiale. Prima di emergere completamente sviluppate, le sanguisughe possono rimanere attaccate per<br />
alcune settimane. La crescita all’interno dell’ospite è talvolta drammatica, ed una specie, la Dinobdella ferox, può<br />
raggiungere la lunghezza di 250 mm.<br />
Le sanguisughe acquatiche (nasofaringee) possono penetrare anche nell’uretra o nella vagina di nuotatori e<br />
bagnanti, oppure attaccarsi alla congiuntiva.<br />
Di conseguenza possono provocare ostruzioni, epistassi, emottisi, ematemesi ed anemie di grave entità. Possono<br />
essere rimosse chirurgicamente in visione diretta 15, 21 - l’applicazione di cocaina e di soluzioni saline ipertoniche può<br />
facilitare il loro distacco. Per raggiungere la loro sede o per migliorare ostruzioni respiratorie che pongono a rischio la<br />
sopravvivenza dell’ospite, può essere necessario ricorrere ad una tracheostomia.<br />
Protezione: Una protezione completa contro le sanguisughe è per lo più impossibile. Nei climi tropicali i repellenti<br />
chimici sono efficaci solo per un periodo limitato a causa della sudorazione. Le sanguisughe terrestri sono molto esili,<br />
agili, e sono in grado di insinuarsi attraverso gli occhielli di uno stivale e dovunque, tranne che negli indumenti di<br />
tessuti molto fitti. I viaggiatori dovrebbero comunque indossare pantaloni impermeabili trattati con sostanze repellenti,<br />
quali il dietil toluamide, infilati in robusti stivali.<br />
Nei luoghi in cui sono presenti le sanguisughe nasofaringee, l’acqua da bere deve essere filtrata con una rete a<br />
maglie strette o ancor meglio bollita.<br />
Per svariati motivi all’estero è’ sempre sconsigliato nuotare o fare il bagno in acque superficiali non trattate.<br />
La profilassi antibiotica può essere indicata se si applicano sanguisughe a tessuti congesti nell’ambito di un<br />
trattamento post operatorio 17 . In questa evenienza possono essere indicati la ciprofloxacina 22 ed agenti beta –<br />
lattamici ad ampio spettro 20 , in funzione della sensibilità agli antibiotici delle specie Aeromonas delle quali la<br />
sanguisuga è portatrice.<br />
Le sanguisughe ad uso medico devono essere applicate ad un solo paziente.<br />
Conservazione dei campioni: Le sanguisughe devono essere narcotizzate in alcool 15% per renderle disponibili alla<br />
classificazione anatomica. Una volta narcotizzate, devono essere allungate e appiattite per la loro fissazione in alcol<br />
70% o formalina 5%. I campioni inseriti vivi in formalina o in alcol concentrato si contraggono in modo violento, si<br />
irrigidiscono e non si può procedere alla loro classificazione.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 38 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
1.0 CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA 23-32<br />
Il personale deve calzare guanti, protezioni da laboratorio e lavorare in un ambiente pulito e ben illuminato.<br />
Per il lavoro di routine è richiesto il Livello di Contenimento 2. Se si sospettano organismi del Gruppo di<br />
Rischio 3, è necessario disporre di una cabina microbiologica di sicurezza e di un ambiente di<br />
Contenimento di Livello 3.<br />
Ogni campione contaminato da liquidi corporei o da sangue di pazienti deve essere immerso in formalina<br />
10%, con un rapporto 1:3 (campione: formalina), per almeno 30 minuti prima dell’inizio della procedura.<br />
I campioni devono essere manipolati con pinze o spazzole sottili. Durante la lavorazione del materiale è<br />
preferibile l’uso di forbici sterili al bisturi.<br />
I campioni vivi devono essere uccisi prima dell’identificazione, tranne che sia richiesto l’isolamento di agenti<br />
patogeni. Se c’è rischio di fuga durante la lavorazione, si devono manipolare con grande attenzione e<br />
conservare in frigorifero. L’uccisione avviene con acqua calda (90°C) (zecche, pidocchi, cimici, larve di<br />
mosche della miasi), con acetato di etile (coleotteri e mosche adulte) o con etanolo 70% (acari). Per<br />
preparare i campioni da uccidere con vapori di acetato di etile si deve usare una cappa chimica. Fare<br />
riferimento alle sezioni appropriate per ulteriori approfondimenti.<br />
Alcuni campioni possono richiedere tempo per lo schiarimento in soluzione di idrato di potassio prima<br />
dell’identificazione; in questo caso deve essere indossata una protezione idonea.<br />
L’alcol ed i solventi organici come l’Euparal non devono essere usati in prossimità di una fiamma viva e<br />
devono essere manipolati in area ben ventilata. Non si devono utilizzare solventi nelle cabine<br />
microbiologiche di sicurezza, perché comportano rischio di incendio e possono danneggiare i filtri HEPA.<br />
I contenitori dei campioni in alcol devono essere chiusi in modo ermetico e conservati a loro volta in<br />
contenitori metallici dotati di chiusura.<br />
Le manipolazioni che possono generare aerosol infettivi devono essere eseguite in cabina microbiologica di<br />
sicurezza.<br />
Le linee guida precedentemente esplicitate devono essere supplementate con la COSHH locale e con la<br />
valutazione del rischio<br />
2.0 PRELIEVO DEL CAMPIONE<br />
I campioni devono essere manipolati con attenzione per evitare danneggiamenti alle strutture tassonomiche<br />
necessarie per l’identificazione. Quando possibile, i campioni devono essere prelevati direttamente dal<br />
paziente o dal suo ambiente e poi inseriti in un contenitore asciutto, sterile ed impermeabile.<br />
3.0 TRASPORTO E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE<br />
E’ meglio uccidere i campioni prima del loro invio per posta. Tutti i corpi molli (zecche, pidocchi, pulci,<br />
cimici, larve di mosca della miasi) devono essere immersi in acqua calda, trasferiti e trasportati in etanolo<br />
70%. Quelli duri (inclusi i coleotteri e le mosche adulte) devono essere esposti a vapori di acetato di etile e<br />
trasportati asciutti. Gli acari possono essere uccisi e trasportati in etanolo 70%. Per successive informazioni<br />
fare riferimento alle sezioni appropriate.<br />
Allegare una breve anamnesi del paziente e dettagli inerenti a qualsiasi viaggio all’estero.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 39 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
Prima di aprire la confezione che contiene il campione, controllare al suo interno se l’insetto/aracnide è<br />
ancora vivo. Prima dell’esame i campioni ancora vivi devono essere uccisi in acqua calda o con vapori di<br />
acetato di etile,e, se è possibile una loro fuga dopo l’apertura del contenitore, li si deve assiderare in<br />
frigorifero.<br />
Per garantirne la classificazione tassonomica, le sanguisughe vive devono essere narcotizzate con etanolo<br />
al 15% e poi appiattite per la fissazione in alcol 70% o formalina 5%. I campioni vivi, messi a contatto con<br />
formalina o alcol concentrato, si contraggono in modo violento, si irrigidiscono e non sono classificabili.<br />
Conservare i campioni originali, il materiale preparato in laboratorio e le copie dei referti seguendo le linee<br />
guida del laboratorio stesso.<br />
4.0 PROCEDURA SUL CAMPIONE<br />
I campioni devono essere manipolati con attenzione, usando pinze o pennellini per evitare danni alle<br />
strutture anatomiche utili all’identificazione tassonomica.<br />
I campioni conservati in formalina o lavati in acqua formolata possono essere più rigidi e più difficili da<br />
manipolare. Si raccomanda di trasferirli in etanolo 70% il più presto possibile.<br />
Alcuni campioni di pulci possono richiedere un periodo di chiarificazione prima dell’esame. Di solito basta<br />
immergerli in KOH 5% per alcuni giorni.<br />
Fare riferimento alla sezione appropriata per ulteriori approfondimenti.<br />
4.1 IDENTIFICAZIONE<br />
Classificare il campione nella famiglia tassonomica, e, se possibile, anche nel genere e specie.<br />
Definire il ciclo vitale.<br />
Annotare gli aspetti identificativi.<br />
Segnalare qualsiasi associazione a malattie.<br />
4.2 INVIARE AL LABORATORIO <strong>DI</strong> RIFERIMENTO<br />
Gli ectoparassiti considerati in questa POS rappresentano campioni rari per i laboratori del Regno Unito e<br />
devono essere inviati ad un laboratorio di riferimento per la conferma.<br />
5.0 PROCEDURA <strong>DI</strong> REFERTAZIONE<br />
5.1 TEMPO <strong>DI</strong> REFERTAZIONE<br />
I risultati delle colture clinicamente urgenti devono essere comunicati per telefono o inviati per via<br />
elettronica.<br />
Referto scritto: entro 72 ore indicando che, se necessario, verrà inviato un altro referto<br />
Segnalare al laboratorio di riferimento anche i risultati di ogni ricerca supplementare o di prove addizionali<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 40 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
6.0 LIMITI<br />
I parassiti descritti in questa POS rappresentano campioni rari per i laboratori del Regno Unito e devono<br />
pertanto essere esaminati da personale esperto. L’identificazione è soggettiva, quindi deve essere<br />
controllata da una seconda persona e confermata da un laboratorio di riferimento.<br />
7.0 SEGNALAZIONE ALLA HPA (SERVIZI LOCALI E<br />
NAZIONALI ED AL CENTRO CDSC PER LE INFEZIONI) 33<br />
Anche se gli insetti e gli aracnidi non hanno rilevanza clinica e non richiedono di per sé denuncia, le<br />
malattie da loro trasmesse possono esigerla.<br />
Fare riferimento a:<br />
Singola POS per l’identificazione dell’agente (Consultare BSOP 31 – Ricerche su campioni diversi dai<br />
parassiti ematici).<br />
Pubblicazioni della Health Protection Agency:<br />
“ Reporting to the CDR: A guide for laboratories”<br />
“ Hospital infection control: Guidance on the control of infection in hospital”<br />
Fare riferimento alle Linee guida attuali del CDSC e indicazioni del COSURV<br />
Linee guida locali<br />
8.0 RINGRAZIAMENTI E CONTATTI<br />
Questo Metodo Nazionale Standard è stato sviluppato, revisionato e controllato dallo Standard Method<br />
Working Group for Bacteriology (http://www.hpa-standardmethods.org.uk/wg_bacteriology.asp). Si<br />
ringraziano per l’importante collaborazione Cheryl Whitehorn e la London School of Hygiene and Tropical<br />
Medicine. Si ringraziano inoltre i numerosi operatori dei laboratori di microbiologia, le organizzazioni<br />
specialistiche che hanno fornito informazioni e commenti durante lo sviluppo di questo documento e il<br />
Redattore Medico per la revisione finale.<br />
I National Standard Method sono emessi dalla Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory,<br />
Centre for Infections, Health Protection Agency London.<br />
Per altre informazioni prendere contatti con:<br />
Standards Unit<br />
Evaluations and Standards Laboratory<br />
Centre for Infections<br />
Health Protection Agency<br />
Colindale<br />
London<br />
NW9 5EQ<br />
E-mail: standards@h<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione 26.06.06 Emesso da: Standard Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina 41 di 43<br />
Riferimento BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente con le altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
BIBLIOGRAFIA<br />
1. Department of Health NHS Executive: The Caldicott Committee. Report on the review of patientidentifiable<br />
information. London. December 1997.<br />
2. Lane RP, Crosskey R W, editors. Medical Insects and Arachnids. Kluwer Academic Publishers;<br />
1993.<br />
3. Nuttall GHF. The biology of Pediculus humanus. Parasitol 1917;10:80-186.<br />
4. Nuttall GHF. The biology of Phthirus pubis. Parasitol 1918;10:383-406.<br />
5. Busvine JR, editor. Insects and Hygiene: the Biology and Control of Insect Pests of Medical and<br />
Domestic Importance. 3rd ed. Chapman and Hall; 1980.<br />
6. Boase CJ. Bed-bugs - reclaiming our cities. Biologist 2004;51:9-12.<br />
7. Baker A, editor. Mites and Ticks of Domestic Animals: an Identification Guide and Information<br />
Source. The Stationary Office Books; 1999.<br />
8. Hillyard PD, Barnes R S K, Crothers J H, editors. Ticks of North-west Europe (Synopses of the<br />
British Faunas). Backhuys Publishers; 1996.<br />
9. Arthur DR. British ticks. London: Butterworths; 1963. p. 33, 65.<br />
10. James MT, editor. The Flies that Cause Myiasis in Man (Miscellaneous Publication no. 631 -<br />
United States Dept. of Agriculture). U.S. Govt. Printing Office; 1947.<br />
11. Zumpt F, editor. Myiasis in Man and Animals in the Old World. Butterworth and Company Limited;<br />
1965.<br />
12. Sawyer RT, editor. Leech Biology and Behaviour: Anatomy, Physiology and Behaviour. Vol 1.<br />
Oxford University Press; 1986.<br />
13. Sawyer RT, editor. Leech Biology and Behaviour: Feeding, Biology, Ecology and Systematics. Vol<br />
2. Oxford University Press; 1986.<br />
14. Sawyer RT, editor. Leech Biology and Behaviour: Bibliography. Vol 3. Oxford University Press;<br />
1986.<br />
15. White GB. Ectoparasites: Leeches and leech infestation, myiasis, jigger fleas, scabies, louse<br />
infestation. In: Cook GC, Zumla A, editors. Manson's Tropical Diseases. 21st ed. Edinburgh: WB<br />
Saunders Company; 2003. p. 1599-600.<br />
16. Nehili M, Ilk C, Mehlhorn H, Ruhnau K, Dick W, Njayou M. Experiments on the possible role of<br />
leeches as vectors of animal and human pathogens: a light and electron microscopy study.<br />
Parasitol Res 1994;80:277-90.<br />
17. Mackay DR, Manders EK, Saggers GC, Banducci DR, Prinsloo J, Klugman K. Aeromonas species<br />
isolated from medicinal leeches. Ann Plast Surg 1999;42:275-9.<br />
18. Indergand S, Graf J. Ingested blood contributes to the specificity of the symbiosis of Aeromonas<br />
veronii biovar sobria and Hirudo medicinalis, the medicinal leech. Appl Environ Microbiol<br />
2000;66:4735-41.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione: 26.06.06 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina no 42 di 43<br />
Riferimento no: BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente alle altre POS emesse dalla Health Protection Agency<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk
19. Graf J. Symbiosis of Aeromonas and Hirudo medicinalis, the medical leech. American Society for<br />
Microbiology News 2000;66:147-53.<br />
20. Nonomura H, Kato N, Ohno Y, Itokazu M, Matsunaga T, Watanabe K. Indigenous bacterial flora of<br />
medicinal leeches and their susceptibilities to 15 antimicrobial agents. J Med Microbiol<br />
1996;45:490-3.<br />
21. Cundall DB, Whitehead SM, Hechtel FO. Severe anaemia and death due to the pharyngeal leech<br />
Myxobdella africana. Trans R Soc Trop Med Hyg 1986;80:940-4.<br />
22. Fenollar F, Fournier PE, Legre R. Unusual case of Aeromonas sobria cellulitis associated with the<br />
use of leeches. E J Clin Microbiol Infect Dis 1999;18:72-3.<br />
23. Advisory Committee on Dangerous Pathogens. 2004 Approved List of Biological Agents.<br />
http://www.hse.gov.uk/pubns/misc208.pdf. p. 1-17.<br />
24. Public Health Laboratory Service Standing Advisory Committee on Laboratory Safety. Safety<br />
Precautions: Notes for Guidance. 4 th ed. London: Public Health Laboratory Service (PHLS); 1993.<br />
25. Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002. General COSHH. Approved Code<br />
of Practice and Guidance, L5. Suffolk: HSE Books; 2002.<br />
26. Health and Safety Executive. 5 steps to risk assessment: a step by step guide to a safer and<br />
healthier workplace, IND (G) 163 (REVL). Suffolk: HSE Books; 2002.<br />
27. Health and Safety Executive. A guide to risk assessment requirements: common provisions in<br />
health and safety law, IND (G) 218 (L). Suffolk: HSE Books; 2002.<br />
28. Health Services Advisory Committee. Safety in Health Service laboratories. Safe working and the<br />
prevention of infection in clinical laboratories and similar facilities. 2 nd ed. Suffolk: HSE Books;<br />
2003.<br />
29. BS EN 12469: 2000. Biotechnology - performance criteria for microbiological safety cabinets.<br />
London: British Standards Institution (BSI); 2000.<br />
30. BS 5726: 1992. Microbiological safety cabinets. Part 2. Recommendations for information to be<br />
exchanged between purchaser, vendor and installer and recommendations for installation.<br />
London: British Standards Institution (BSI); 1992.<br />
31. BS 5726: 1992. Microbiological safety cabinets. Part 4. Recommendations for selection, use and<br />
maintenance. London: British Standards Institution (BSI); 1992.<br />
32. Advisory Committee on Dangerous Pathogens. The management, design and operation of<br />
microbiological containment laboratories. Suffolk: HSE Books; 2001.<br />
33. PHLS, CDSC. Reporting to the PHLS Communicable Disease Surveillance Centre: a reference for<br />
laboratories. May. 2001.<br />
<strong>RICERCA</strong> <strong>DI</strong> <strong>ECTOPARASSITI</strong> <strong>NEI</strong> CAMPIONI<br />
Revisione no: 1 Data di revisione: 26.06.06 Emesso da: Standards Unit, Evaluations and Standards Laboratory Pagina no: 43 di 43<br />
Riferimento no: BSOP 36i1<br />
Questa POS deve essere usata congiuntamente alle altre POS emesse dalla Health Protection Agency y<br />
www.evaluations-standards.org.uk<br />
Email: standards@hpa.org.uk