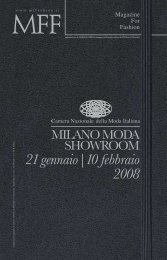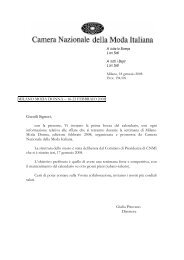Un pomeriggio a Palazzo Donn'Anna di Leonardo ... - Informacibo
Un pomeriggio a Palazzo Donn'Anna di Leonardo ... - Informacibo
Un pomeriggio a Palazzo Donn'Anna di Leonardo ... - Informacibo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Un</strong> <strong>pomeriggio</strong> a <strong>Palazzo</strong> <strong>Donn'Anna</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Leonardo</strong> Colombati<br />
[Questo mio articolo su Raffaele La Capria è stato pubblicato su Nuovi Argomenti, n. 31,<br />
"Ancora una poesia", luglio-settembre 2005]<br />
1.<br />
Il giorno deciso alla fine è arrivato. Poso il vassoio con gli avanzi della<br />
colazione sul tavolo della cucina, apro le imposte del salotto, afferro il<br />
libro dallo scaffale e cinque minuti dopo sono già alla guida, lungo la<br />
strada che da Roma mi porterà a Napoli.<br />
Il motivo del mio viaggio è “uno e trino”: voglio al tempo stesso visitare<br />
un palazzo, rivivere un romanzo e capire un uomo. Il palazzo è <strong>Palazzo</strong> Donn’Anna, il<br />
romanzo Ferito a morte e l’uomo è Raffaele La Capria. La fusione <strong>di</strong> questi tre<br />
elementi nel crogiuolo della mia intermittente immaginazione – che, sciaguratamente,<br />
è sempre libresca – dovrebbe produrre un’immagine definitiva del sentimento della<br />
malinconia, nell’accezione privatissima <strong>di</strong> nostalgia per un tempo non solo perduto ma<br />
pure mai vissuto. A sua volta, la lega si scomporrà <strong>di</strong> nuovo in tre parti, che sono poi i<br />
miti su cui si fonda tutta l’opera del mio scrittore del cuore: la Bella Giornata,<br />
l’Occasione Mancata e l’Armonia Perduta.<br />
Invi<strong>di</strong>o a La Capria innanzitutto la tecnica con cui misura il tempo: dato un giorno –<br />
uno e quello solo – è possibile andare avanti e in<strong>di</strong>etro nella propria vita come sulla<br />
tastiera <strong>di</strong> un pianoforte. Graham Greene l’aveva già postulato: una storia non ha<br />
principio né fine; si sceglie arbitrariamente un certo momento dal quale ricordare e<br />
prevedere. Ma in La Capria, tale proce<strong>di</strong>mento è niente affatto arbitrario: egli<br />
m’appare come un Lacaille che infallibilmente misura la parallasse della Luna. «Sono<br />
lo scrittore <strong>di</strong> unico libro che raccontava sempre <strong>di</strong> una giornata e che non riuscì mai a<br />
finire perché lo scriveva sempre daccapo», confesserà in un’intervista [1].<br />
Di quale giorno sta parlando? Lette le prime pagine <strong>di</strong> Ferito a morte siamo portati a<br />
credere che sia quello in cui Massimo De Luca si risveglia mollemente dal suo sogno<br />
subacqueo, mentre suo padre prende il caffè in terrazza ed esclama: «Che giornata!<br />
L’odore della bella giornata, proprio l’odore» [2]. Massimo, intanto, si rigira tra le<br />
lenzuola, mentre il sogno si <strong>di</strong>legua, e sente « il palazzo che naviga nel mare, la luce<br />
che preme sulla finestra e scoppia dalle fessure delle imposte. Apre gli occhi. Oscilla<br />
sulla parete bianca il grafico d’oro, trasmette irrequieto senza soste il messaggio: è<br />
una bella giornata – bella giornata» [3].<br />
È un mattino dell’estate del ’54. Nel dormiveglia, Massimo è sprofondato nel suo<br />
appartamento sottomarino («ombre come alghe viola, e gelo in tutto il corpo» [4]) ed<br />
ha appena sprecato la Grande Occasione <strong>di</strong> arpionare una spigola («l’occhio fisso, <strong>di</strong><br />
celluloide, il rilievo delle squame, la testa corrucciata <strong>di</strong> una maschera cinese» [5]).<br />
Ogni volta che rileggo l’incipit <strong>di</strong> Ferito a morte non posso fare a meno <strong>di</strong> associare<br />
Massimo a Gregor Samsa, il commesso viaggiatore che vive in Charlotte Strasse<br />
assieme alla sorella e ai genitori; uno dei personaggi più realistici che la letteratura ci<br />
abbia mai regalato, malgrado una mattina, al risveglio, egli si ritrovi trasformato in un<br />
gigantesco insetto. Così come Massimo vede avverarsi la Cosa Temuta – «una pigrizia<br />
maledetta che costringe il corpo a <strong>di</strong>sobbe<strong>di</strong>re, la vita che nel momento decisivo ti<br />
abbandona» [6], la spigola che «passa lenta […] e scompare» [7] – allo stesso modo<br />
Gregor, <strong>di</strong>steso sulla schiena dura come una corazza, osserva il proprio «ventre<br />
convesso, bruniccio, spartito da solchi arcuati» e non s’accorge (non se ne accorgerà<br />
mai) <strong>di</strong> avere delle piccole ali sotto le elitre. Questa osservazione anatomica non è
desunta dal racconto <strong>di</strong> Kafka, che non parla <strong>di</strong> ali, ma in<strong>di</strong>rettamente da un’intuizione<br />
<strong>di</strong> Nabokov, gran conoscitore <strong>di</strong> insetti. Secondo il russo, l’animale che Kafka<br />
vagamente descrive ne La metamorfosi sarebbe un coleottero: «ha un enorme ventre<br />
convesso <strong>di</strong>viso in segmenti e una solida schiena arrotondata che fa pensare alle<br />
elitre. Nei coleotteri queste elitre nascondono piccole fragili ali che possono allargarsi<br />
e portare l’insetto per chilometri in un volo brancolante» [8].<br />
In ciò, Gregor Samsa, è un personaggio <strong>di</strong> sconcertante realismo: come molte<br />
persone – come ad esempio Massimo De Luca – non sa <strong>di</strong> poter volare.<br />
2.<br />
Sbuco dal tunnel in piazza della Repubblica, svolto a destra, verso il mare, e sono a<br />
Mergellina. Prendo la strada <strong>di</strong> Posillipo e dopo un paio <strong>di</strong> tornanti lo vedo: il <strong>Palazzo</strong><br />
Donn’Anna.<br />
«La facciata anteriore, più esposta al mare, è un po’ sbilenca, ha ceduto alla base o è<br />
solo l’impressione? Come se il vai e vieni delle onde ne avesse cariate le fondamenta.<br />
Vento e salmastro scavano le pietre <strong>di</strong> tufo, tutte granulose, concave, sporgono solo i<br />
punti con la calce e i mattoni, un continuo inavvertibile sgretolio, se ci passi un <strong>di</strong>to<br />
sopra o ci appoggi una mano senti il fruscio della polverina gialla che viene via. Negli<br />
ultimi trecent’anni il palazzo ha resistito agli umori del mare, agli scossoni delle onde e<br />
delle bombe, ma i secoli lo vinceranno con la pazienza, millimetro per millimetro, fino<br />
a quando le tranquille acque napoletane canteranno vittoria in una bella giornata<br />
come questa (…) e i pesci nuoteranno nelle stanze irriconoscibili per le incrostazioni<br />
marine, l’erosione <strong>di</strong> alghe e molluschi litofagi. Solo questione <strong>di</strong> tempo» [9].<br />
I La Capria si trasferirono nel palazzo nel 1932, quando Raffaele aveva <strong>di</strong>eci anni. «<strong>Un</strong><br />
palazzo come quello», racconta, «che si <strong>di</strong>ceva abitato dagli spiriti e si presentava<br />
come una rovina emergente dal mare, non era veramente appetibile all’epoca, e mio<br />
padre <strong>di</strong>ede prova <strong>di</strong> avere una natura più artistica e bohémien <strong>di</strong> quanto sospettassi,<br />
quando prese la sua decisione» [10].<br />
<strong>Palazzo</strong> Donn’Anna fu costruito alla fine del Seicento dal viceré <strong>di</strong> Napoli Ramiro<br />
Gusman, duca <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>na, dove prima sorgeva il cinquecentesco <strong>Palazzo</strong> della Sirena.<br />
Era il suo regalo per la bellissima moglie, donna Anna Carafa. Sono quelli gli anni in<br />
cui a Napoli regnava «un’Armonia solare e me<strong>di</strong>terranea, non lontana da quella che<br />
conobbero i greci, sì, qualcosa <strong>di</strong> simile, forse. In quell’Armonia tutto si teneva, Vico e<br />
Pulcinella, Napoli e l’Europa, le gran<strong>di</strong> idee e l’ultima canzonetta» [11].<br />
Ci passo davanti senza fermarmi: è l’ora <strong>di</strong> pranzo e mi sono promesso una sosta da<br />
Cicciotto a Marechiaro, giusto per alimentare il senso <strong>di</strong> colpa d’aver abbandonato i<br />
miei doveri <strong>di</strong> lavoratore e <strong>di</strong> padre <strong>di</strong> famiglia. E così, mentre mi godo lo spettacolo<br />
del Vesuvio dalla terrazza del ristorante e sorseggio un bicchiere <strong>di</strong> Fiano d’Avellino e<br />
lavoro il polpo col coltello e con un triplo carpiato trasfiguro il villoso figlio <strong>di</strong> Cicciotto<br />
che mi porta qualche frutto <strong>di</strong> mare al guazzetto nella cameriera che proprio qui,<br />
centoventi anni fa, fece perdere la testa a Di Giacomo, tiro il filo delle mie intenzioni e<br />
le perle rotolano sull’acciottolato.
E canto sottovoce a Marchiare ce sta ‘na funesta, la passione mia ce tuzzuléa… con<br />
accento improbabile. Pare che Salvatore Di Giacomo sia stato per la prima volta a<br />
Marechiaro molti anni dopo aver scritto la celebre canzone. Si sedette a una trattoria e<br />
fu servito dalla bella Carolina. Al caffè, l’oste si avvicinò allo sconosciuto avventore e<br />
gli raccontò che un giorno il poeta Di Giacomo arrivò per colazione, vide la cameriera<br />
e scrisse il brano. Al che, Di Giacomo esplose in una fragorosa risata.<br />
Ecco un bell’esempio <strong>di</strong> canzone che <strong>di</strong>venta «una sbarra della prigione della<br />
napoletanità» [12]. Secondo La Capria, il manierismo napoletano deriva dalla<br />
malinconia per un’Armonia Perduta e dalla certezza che è impossibile ricostruirla.<br />
«Quando si perde la grazia spontanea dell’esistenza (l’Armonia), si tende a<br />
conservarla artificialmente, in mo<strong>di</strong> impropri e illusori, a imitarne per nostalgia o altro<br />
la forma esteriore, senza veramente possederla. E questo accadde ai napoletani.<br />
Quando si accorsero che quell’Armonia gli era comunque necessaria per sopravvivere,<br />
necessaria come l’aria che respiravano, i napoletani si misero a “fare in napoletani”.<br />
Fu così che essi furono spinti per istinto <strong>di</strong> conservazione e <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> conoscenza a<br />
fingersi quell’Armonia Perduta; e la inscenarono e sceneggiarono, la enfatizzarono e<br />
proclamarono, finché non <strong>di</strong>venne una Recita Collettiva, capillare e pervasiva» [13].<br />
3.<br />
Parcheggio <strong>di</strong> fronte all’ingresso del <strong>Palazzo</strong>, sull’altro lato della strada. Da una friggitoria escono<br />
esalazioni croccanti e le note dell’ultimo successo <strong>di</strong> Robbie Williams. Al Café Tropical, due<br />
africani devono succo d’arancia. La boutique Marie Louise sta chiudendo.<br />
Credevo che <strong>Palazzo</strong> Donn’Anna fosse in rovina. E mi sbagliavo. È stato tinteggiato <strong>di</strong> fresco e un<br />
cancello elettrico mi separa dal cortile in cui sono parcheggiate le automobili degli attuali inquilini.<br />
Allungo il collo tra le inferriate del cancello – chiuso – e vedo che il gabbiotto della portineria è<br />
vuoto; come rischia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare il mio viaggio.<br />
Sul muro <strong>di</strong> cinta, a sinistra dell’entrata, si apre la bottega <strong>di</strong> un ferramenta; davanti al negozio, un<br />
paio <strong>di</strong> espositori su cui stanno arrotolate delle pezzature <strong>di</strong> moquette. Mi ci nascondo <strong>di</strong>etro,<br />
aspettando che da un momento all’altro il cancello si apra. Dieci minuti dopo, quando le ante si<br />
schiudono per fare uscire una BMW, mi infilo come un ladro e subito mi chiedo come farò ad<br />
uscire: vagherò, qui dentro, nei secoli, come l’ennesimo fantasma <strong>di</strong> <strong>Palazzo</strong> Donn’Anna? osserverò<br />
il mare <strong>di</strong> ceramica, lisciato dalla bafogna, assieme ai pescatori uccisi da una regina dei tempi che<br />
furono?<br />
Attraverso il cortile, passo sotto l’arcata centrale e mi sporgo dalla balaustra, sul mare. Ho con me il<br />
romanzo, nell’e<strong>di</strong>zione Oscar Mondadori con Il pesce d’oro <strong>di</strong> Klee in copertina. Con il terrore <strong>di</strong><br />
essere scoperto e buttato fuori da un momento all’altro – «ma non capite? il palazzo è mio, finché<br />
ho in mano questo libro!» – inizio a leggere.<br />
Vedo Massimo De Luca e Carla Boursier, insieme nella notte <strong>di</strong> Capodanno del 1949, quando sulla<br />
spiaggia <strong>di</strong> Positano lui le <strong>di</strong>ce <strong>di</strong> amarla sin dal giorno in cui, sei anni prima, assistettero mano<br />
nella mano ad un bombardamento su Napoli. Poi mi siedo al Bar Moccia e ascolto Massimo e il suo<br />
amico Gaetano <strong>di</strong>scutere <strong>di</strong> politica, mentre Ninì De Luca è al Middleton a <strong>di</strong>scettare <strong>di</strong> Pommerì e<br />
Veuve Cliquò assieme a Sasà e a Gui<strong>di</strong>no Cacciapuoti; tra un Negroni e un altro, parlano <strong>di</strong><br />
fuoriserie, <strong>di</strong> attricette, del «piede plebeo» che è inutile cercare <strong>di</strong> ingentilire «con lo scarpino<br />
sfilato perché il cuoio deformato del piedacchione rivela subito che non sei un vero signore» [14].<br />
Nessuno, ancora, s’è fatto vivo: <strong>Palazzo</strong> Donn’Anna affonda silenziosamente i suoi tentacoli<br />
nell’acqua immobile. Osservo la scala che porta giù, verso i piani al livello del mare. Conosco a<br />
memoria, senza esserci mai stato, cosa c’è là sotto: «un chiaro e scuro <strong>di</strong> corridoi dalle alte volte<br />
ricurve, interrotto da improvvisi abbaglianti riquadri d’azzurro, e una scomposta scenografia <strong>di</strong><br />
nicchie e archi e quinte <strong>di</strong> pareti semi<strong>di</strong>roccate, e lunghe file <strong>di</strong> sale dai soffitti barocchi attraversate
da drammatici tagli <strong>di</strong> luce e dal volo obliquo dei pipistrelli» [15]. È il percorso da fare per giungere<br />
a casa La Capria, lo stesso che spaventa Mira in una “bella giornata” del 1950 descritta nel romanzo<br />
d’esor<strong>di</strong>o, <strong>Un</strong> giorno d’impazienza.<br />
Alla fine <strong>di</strong> quei corridoi c’è una porta, un ingresso buio e poi una sala ottagonale con un soffitto a<br />
volta <strong>di</strong>pinto <strong>di</strong> grigio screziato. Casa La Capria. Chissà chi ci abita, adesso. E chissà chi ha preso il<br />
posto <strong>di</strong> Gemma Bellincioni, la soprano che occupava l’altra metà del grande appartamento e dava<br />
lezioni <strong>di</strong> arpeggio a un nugolo <strong>di</strong> allieve che il giovane Duddù sentiva gorgheggiare… do, dododò,<br />
doddododdodododdò… E i Genevois, i Murcell, i Twist e i Marinelli, e i principi Colonna e le<br />
ragazze Morelli e i marchesi Bugnano… Ci si può immalinconire al ricordo <strong>di</strong> persone sconosciute?<br />
Si può provare nostalgia per un tempo mai vissuto, per un luogo mai visto prima?<br />
… Come il Circolo Nautico, dove finalmente approdano Glauco e i fratelli De Luca (ma anche qui,<br />
La Capria bluffa col tempo: li avevamo lasciati in barca, i tre, a remare verso il Circolo, nel 1951.<br />
Ed ora che ci arrivano, però, è il 1952). La verità è che io ci sono stato in quel Circolo – senza<br />
averci messo mai piede – e li ho conosciuti l’avvocato Lo Sardo che continua a <strong>di</strong>re «cose-da-pazzicose-dell’altro-mondo»,<br />
e il cameriere Filuccio, e Cocò Cutolo che sbarca assieme alla bellissima<br />
Betty Borgstrom, e quelli che giocano a pallone sulla spiaggia e tirano certe cannonate, coi soci<br />
anziani che azzardano «certi tiri acrobatici, certe finezze e che si rialzano neri <strong>di</strong> sabbia e <strong>di</strong> sudore,<br />
con l’occhio che corre in cerca dell’applauso della terrazza, gridano atletici hop-hop-hop! e soffrono<br />
per tutto il tempo che non gli passano il pallone» [16]. E poi Mariella che arriva col bassotto al<br />
braccio, e Giggino Cannavacciuolo che segna un gol <strong>di</strong> testa, con quella pelata, e Gargiulo che si<br />
presenta vestito tutto <strong>di</strong> bianco e viene deriso per la sua ineleganza, e il Marchese D’Onofrio, in<br />
shorts, a torso nudo, col cappellino <strong>di</strong> picchè da marinaio… Basta essere stati in qualche Circolo<br />
Canottieri sul Tevere, a Roma, e queste persone, questi tic, li ritrovi subito. Come la partita <strong>di</strong> poker<br />
che va avanti da due giorni e due notti nella club house; o come lo spettacolo degli spogliatoi:<br />
«capi, notabili, decani <strong>di</strong> questo e <strong>di</strong> quello, si stanno spogliando in fretta e in furia, paroliandosi<br />
allegramente, manata, colpetti sulle pance, urlati commenti sui reciproci corpaccioni che sono<br />
veramente uno schifo. (…) Si lasciano andare al rutto, al peto, girano tutti nu<strong>di</strong> con quei pie<strong>di</strong><br />
unghiogialluti, li senti euforici sotto le docce che raccontano storie <strong>di</strong> casino, che parlano <strong>di</strong> troie<br />
con competenza, rispondono cor<strong>di</strong>almente ad un insulto, e sempre esagerati nelle parole e nei<br />
movimenti, con quelle facce segnate, come <strong>di</strong>ce Massimo, dalle rughe degli infiniti sorrisi servili<br />
rivolti ai potenti, e degli austeri cipigli rivolti agli inferiori. Poi te li ritrovi nelle sale del Circolo, in<br />
doppio petto, al tavolo <strong>di</strong> ramino o <strong>di</strong> baccarà a <strong>di</strong>scutere <strong>di</strong> questioni <strong>di</strong> precedenza e <strong>di</strong> procedura,<br />
ti fanno la lezione…» [17].<br />
E Massimo è lì, in mezzo a tutto questo – e tutto questo, per un miracolo <strong>di</strong> evocazione e <strong>di</strong> stile, è<br />
bellissimo: è un’altra bella giornata. Sarà lei, finalmente, dopo tanti falsi riconoscimenti, “la” bella<br />
giornata? Sembrerebbe <strong>di</strong> sì; eppure a Massimo fa male un orecchio e soffre – un’altra Occasione<br />
perduta!<br />
Ciclicamente, andando avanti nella lettura, si ripresenta la stessa scena: Glauco e Ninì sulla barca,<br />
Massimo sugli scogli a prendere il sole. Ma non è mai chiaro se questa scena in realtà si svolga in<br />
un’unica estate, oppure in tre estati <strong>di</strong>verse, quelle del ’51, del ’52 e del ’54. «Possibile che tutto sia<br />
uguale e tutto sia cambiato? (…) Possibile che tutto avviene come in un film, che tu lo ve<strong>di</strong> e pare<br />
che sta succedendo qualche cosa proprio in quel momento, e invece il film è stato già girato in un<br />
or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong>verso, e tutto è fermo nel rotolo del tempo?» [18]. Questo si chiede Massimo, mentre inizia<br />
a ripensare all’estate <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci anni prima, quando incontrò Carla. «Sì, è possibile, è possibile. (…)<br />
Salta fuori impreve<strong>di</strong>bile dal tempo che è tutt’un’estate, lo spazio bianco <strong>di</strong> un mattino» [19].<br />
Quando Massimo si tuffa in acqua e avviene lo stesso miracolo che Proust sperimenta quando<br />
ritorna con la memoria alla sua infanzia trascorsa a Combray, non appena riconosce «il gusto del<br />
pezzetto <strong>di</strong> madeleine che la zia inzuppava nel tiglio (…). Come in quel gioco, che piace ai<br />
giapponesi, <strong>di</strong> buttare in una ciotola <strong>di</strong> porcellana piena d’acqua dei pezzettini <strong>di</strong> carta a tutta prima<br />
indefinibili che, non appena immersi, si stirano, assumono contorni e colori, si <strong>di</strong>fferenziano<br />
<strong>di</strong>ventando fiori, cose, figure consistenti e riconoscibili, così, ora (…) tutto questo che sta
prendendo forma e soli<strong>di</strong>tà è uscito, città e giar<strong>di</strong>ni, dalla mia tazza <strong>di</strong> tè» [20].<br />
La tazza <strong>di</strong> tè <strong>di</strong> Massimo è il mare davanti a casa sua – <strong>Palazzo</strong> Donn’Anna – nel quale s’immerge<br />
pure nell’estate del ’42 e vede «un’ombra grigia, solitaria, che veniva come un or<strong>di</strong>gno metallico<br />
verso <strong>di</strong> me. La spigola» [21]. Contrariamente al sogno che farà do<strong>di</strong>ci anni dopo, questa volta<br />
Massimo riesce a catturarla: «Sentii che l’asta entrava in quel corpo. Trafitta si rovesciò <strong>di</strong> fianco,<br />
splen<strong>di</strong>da tutta d’argento, con le pinne irte sul dorso, la bocca aperta nello spasimo, il corpo a<br />
mezzaluna e come paralizzato» [22].<br />
Questa è una sorpresa per il lettore: credevamo che la spigola gli sarebbe sfuggita. E invece, ora che<br />
il pesce è tirato in secco sulla barca, capiamo qual è la sua funzione all’interno del romanzo. In un<br />
racconto tutto giocato sulla sincronizzazione in un unico tempo <strong>di</strong> tre-quattro <strong>di</strong>verse “belle<br />
giornate”, la spigola è la lancetta dell’orologio <strong>di</strong> La Capria: nel 1942 è catturata, nel 1954 è (in<br />
sogno) mancata, e nel 1960 viene servita a tavola; laddove il “primo tempo” è quello eroico della<br />
vera bella giornata, il “secondo tempo” è quello del rimpianto, e il terzo è quello della malinconica<br />
in<strong>di</strong>fferenza.<br />
Appena Massimo riemerge dall’acqua con la sua preda, iniziano i bombardamenti; con Glauco e<br />
Ninì, decide <strong>di</strong> rifugiarsi nella Grotta della Monaca <strong>di</strong> Mare, e lì si affiancano ad un’altra barca su<br />
cui sta una bion<strong>di</strong>na che <strong>di</strong>ce: «Ieri un aeroplano quasi toccava l’albero del cutter, si vedeva il<br />
pilota! Avrà pensato: io a fare la guerra e loro i bagni» [23]. È Carla, che «pretendeva, cinque anni<br />
dopo, quando la rivi<strong>di</strong> a Positano con Roger, che quel giorno lei ed io ci eravamo trovati sopra un<br />
cutter in mezzo al mare, e che Roger, proprio lui, aveva volato sulle nostre teste incerto se sganciare<br />
la sua bomba. Non era venuto tante volte a bombardare Napoli? Only twice, <strong>di</strong>sse Roger» [24].<br />
Finalmente ci è così spiegato la strano <strong>di</strong>alogo tra Massimo e Carla, nel primo capitolo, quando<br />
escono dalla Buca <strong>di</strong> Bacco dopo avere festeggiato il Capodanno:<br />
«Ma che ti prende ora?<br />
Povero Rogerino. Stavo pensando a lui.<br />
Non lo chiamare così. Si chiama Roger.<br />
Chissà che sta facendo.<br />
Ti sembra il momento <strong>di</strong> pensare a lui?<br />
Quest’estate l’amavo, adesso non me ne importa più niente. (…) Tu mi amavi già quest’estate?<br />
Anche prima se è per questo – dal giorno del bombardamento.<br />
Stavamo sul cutter e passò un aeroplano.<br />
Come te lo debbo <strong>di</strong>re? Non siamo mai stati in quel cutter. Te lo sei inventato.<br />
Lo ve<strong>di</strong> che sei antipatico?» [25]<br />
Questa fantasticheria <strong>di</strong> Carla è rivelatrice: retrospettivamente, mette Massimo e Roger nella stessa<br />
scena – con lei nel mezzo – durante una battaglia, come due rivali. A prima vista, può sembrare un<br />
sintomo della superficialità <strong>di</strong> Carla, sempre in bilico tra l’in<strong>di</strong>fferenza e un romanticismo da<br />
feuilleton. Ma, procedendo nella lettura, quando ci viene finalmente svelata la Grande Occasione<br />
Mancata <strong>di</strong> Massimo, il “sogno” <strong>di</strong> Carla acquisterà un significato molto più profondo e<br />
contrad<strong>di</strong>ttorio.<br />
Ed eccola, infine, la Grande Occasione Mancata <strong>di</strong> Massimo. Con nostra sorpresa, a metà del libro<br />
ci accorgiamo che ci è già stata raccontata nelle prime pagine. <strong>Un</strong>a manciata <strong>di</strong> righe nel primo<br />
capitolo. 1949:<br />
«Eccola la Scena. Si ripresenta sempre identica: lo sguardo <strong>di</strong> Carla che splende come un mattino<br />
tutto luce in fondo al mare, e lei così vicina – anche il battito del cuore! – vicina, con l’occhio<br />
marino, aspettando. E poi offesa? Stupita? Incredula? Prontamente <strong>di</strong>sinvolta comunque (…), per<br />
sempre lontanissima, che tenta <strong>di</strong> superare l’imbarazzo. Lui la guarda mentre lei si pettina i capelli<br />
raccolti sulla nuca, bionda coda <strong>di</strong> cavallo oscillante (…) e un sorriso umiliato che copre il desiderio
<strong>di</strong> morire. E i ragazzi, t’immagini le facce? Le risate? Le chiacchiere, se sapessero. Lui, solo, con la<br />
Grande occasione Mancata, e tutti i loro occhi aperti sulla Scena» [26].<br />
4.<br />
I raggi del sole grattano la volta dell’arcata e si sfilacciano. Per continuare a leggere<br />
devo dare la schiena al mare.<br />
Dovrebbe essere tutto chiaro. Eppure, c’è un <strong>di</strong>sagio. Tutto è sfuggente in Ferito a<br />
morte; come la spigola; e ogni svolta ci ritroviamo contemporaneamente, ancora e sempre in quel<br />
mattino del 1954 in cui Massimo De Luca s’è attardato sotto le lenzuola, e su una barca nel mare <strong>di</strong><br />
Posillipo, in una lunghissima estate che inizia nel 1951 e finisce un anno dopo. Ed ogni volta ci<br />
doman<strong>di</strong>amo: che sia questa, finalmente, la Bella Giornata? E poi, che <strong>di</strong>avolo è una Bella<br />
Giornata?<br />
«La mia bella giornata doveva essere una giornata qualunque, una <strong>di</strong> quelle lunghe tranquille<br />
giornate estive simili al trascorrere <strong>di</strong> una nuvola sull’azzurro in<strong>di</strong>fferente del cielo, dove non<br />
accade proprio nulla <strong>di</strong> rilevante, ma nella mia descrizione doveva corrispondere a tutte le belle<br />
giornate qualunque, e dunque contenerle tutte, catturarne il tempo» [27].<br />
È, dunque, la Bella Giornata, una serie <strong>di</strong> belle giornate? Quella del ’54, quella del ’52, quella del<br />
’51, quella del ’49, quella del ’42?<br />
Scrive La Capria:<br />
«Il mio libro comincia con un raggio <strong>di</strong> sole che, penetrando attraverso le imposte socchiuse, brilla<br />
come un geroglifico luminoso sulla parete della stanza dove Massimo si sta svegliando dai suoi<br />
sogni inquieti. Quel raggio gli porta l’annuncio della bella giornata. (…) Ma l’annuncio non fa più<br />
sobbalzare il cuore <strong>di</strong> Massimo. Ormai lo sa che da una bella giornata non c’è da aspettarsi più<br />
niente. (…) Ma perché Massimo non si aspetta più niente da una bella giornata? Cosa si aspettava?<br />
Cosa gli è accaduto? Ciò che gli è accaduto lo sapevo solo vagamente mentre iniziavo il mio libro.<br />
Sapevo che era il senso <strong>di</strong> una Grande Occasione Mancata (la sua stessa giovinezza? la felicità? la<br />
vita?), <strong>di</strong> una profonda <strong>di</strong>sillusione, che non riguardava soltanto lui, ma tutta la città e tutti i suoi<br />
miti. Dunque Massimo si sveglia, e dal suo risveglio fino al momento della partenza, in questo<br />
breve spazio che è lo spazio <strong>di</strong> un mattino del 1954, il tempo si <strong>di</strong>lata e le varie ore corrispondono<br />
ad anni <strong>di</strong>versi, senza soluzione <strong>di</strong> continuità. Dove nulla può accadere perché tutto sembra già<br />
accaduto una volta per sempre, <strong>di</strong>eci anni o un giorno – avrebbe dovuto suggerirlo la struttura del<br />
libro – sono esattamente la stessa cosa» [28].<br />
Che sia un romanzo in cui il corso del tempo è perlomeno irregolare, lo si desume pure dal sesto<br />
capitolo, quando Gaetano va a pranzo a casa De Luca. Dovrebbe essere il 1954, perché nel secondo<br />
capitolo – appunto, nel ‘54 – sentiamo la signora De Luca gridare a Massimo: «Non tornate tar<strong>di</strong>!<br />
Ricordati che oggi viene Gaetano a pranzo!» [29]. E invece è il 1953, visto che a tavola si accenna a<br />
Pippotto Alvini che morì al Circolo «un anno fa», dopo l’estenuante partita <strong>di</strong> poker (avvenuta<br />
nell’estate del 1952).<br />
Durante il pranzo, Massimo viene a sapere che Gaetano sta per partire per Milano, dove ha trovato<br />
un posto al giornale. Lo lascia a Napoli, da solo.<br />
Massimo abbandonerà la Foresta Vergine un anno dopo, nel 1954. Nel <strong>pomeriggio</strong> prima <strong>di</strong> quel<br />
suo ultimo giorno napoletano, iniziato con il sogno della spigola che gli sfugge, rivedrà per un<br />
attimo Carla in via dei Mille: «sempre elegante, bellissima, senza vedermi, è passata. Ad<strong>di</strong>o» [30] e<br />
rievoca il suo amore mentre passeggia con un conoscente che non perde occasione <strong>di</strong> malignare sul
conto <strong>di</strong> lei. «Tutta la vita proteggi un segreto, poi, il primo che passa <strong>di</strong>venta un recipiente <strong>di</strong><br />
confidenze intime» [31]. Ecco un’altra sincronizzazione: già nel primo capitolo avevamo visto<br />
Massimo raccontare «<strong>di</strong> Carla a uno qualunque, suo simile, ipocrita e fratello, un tale incontrato<br />
nella strada: Quella, la ve<strong>di</strong> quella? – e man mano che racconta, qualcosa dentro <strong>di</strong> lui si deforma, si<br />
corrompe» [32]. Così, <strong>di</strong> nuovo, adesso, nel settimo capitolo, leggiamo: «Quella, la ve<strong>di</strong> quella?<br />
Viviamo in una città che ti ferisce a morte o t’addormenta, o tutt’e due le cose insieme» [33].<br />
Mezzo addormentato, e ferito a morte, a poche ore dal suo allontanamento definitivo da Napoli,<br />
Massimo De Luca torna ancora una volta a quella notte in cui «una stupida e troppo forte giovanile<br />
emozione» rovinò il momento decisivo: «<strong>Un</strong>o <strong>di</strong>rebbe, a quale ragazzo un po’ nervoso non può<br />
capitare la prima volta per troppo amore… Quel tremito, morte che non potevo controllare, è niente<br />
non ci badare, non rassomigliava all’amore, e allora perché per troppo amore ti puoi stranire a tutto<br />
per sempre?» [34].<br />
5.<br />
Leggo le ultime parole del settimo capitolo: «Non io più sarò qua». Chiudo il libro, sollevo lo<br />
sguardo, giusto in tempo per notare un’auto che esce dal cancello. Esco anch’io, per la prima volta,<br />
per l’ultima, da <strong>Palazzo</strong> Donn’Anna. Non io più sarò qua.<br />
Durante il viaggio <strong>di</strong> ritorno penso a Carla e al suo “sogno pietoso”; la trasfigurazione epica del suo<br />
incontro con Massimo sotto le bombe è una bugia detta a Massimo perché egli, con<strong>di</strong>videndola,<br />
possa davvero pensare a quel <strong>pomeriggio</strong> del 1942 come ad una Bella Giornata – e riesca a salvare<br />
questa, piuttosto che il momento della Grande Occasione Mancata. Per la prima volta mi viene in<br />
mente che Carla, in questo senso, è il vero eroe <strong>di</strong> Ferito a morte.<br />
Il fatto che, letta in questo modo, la Bella Giornata sia una giornata effettivamente mai vissuta, è<br />
corroborato da un’altra singolarità. In realtà, nel libro non è detto che quell’incontro sotto le bombe<br />
è avvenuto nel 1942, bensì nel 1943. Se si vuole spingere fino in fondo l’identificazione <strong>di</strong> La<br />
Capria con il suo personaggio, ciò è impossibile. Nell’estate del ’43 La Capria è nel brin<strong>di</strong>sino col<br />
52° Battaglione e farà ritorno a Napoli solo nel <strong>di</strong>cembre del 1944. Tra l’altro, nell’evocazione del<br />
bombardamento, si parla <strong>di</strong> piloti inglesi (che fecero incursioni su Napoli nel ’42) e non <strong>di</strong> piloti<br />
americani, che attaccarono nel ’43. Insomma, La Capria descrive una giornata cui lui non ha mai<br />
assistito, e lo fa servendosi dei ricor<strong>di</strong> che ha <strong>di</strong> un’altra giornata: un giorno <strong>di</strong> un anno prima.<br />
«Quella del 1942», <strong>di</strong>rà in seguito, «fu l’estate più straor<strong>di</strong>naria della mia vita, la più intensa, quella<br />
che mi lasciò un segno indelebile nella memoria e nell’immaginazione. Fu straor<strong>di</strong>naria perché,<br />
date le circostanze, io sentivo che quell’estate era l’ultima estate felice, e fu straor<strong>di</strong>nario il fatto che<br />
la vivessi sapendolo . (…) Da quell’estate, il mondo è per me <strong>di</strong>viso in due: quello <strong>di</strong> prima del ’42<br />
e quello <strong>di</strong> dopo il ’42» [36].<br />
Mentre «infuria una orribile guerra alla quale partecipo mio malgrado» [37], nella sua Napoli vanno<br />
<strong>di</strong>strutti il Corso Garibal<strong>di</strong>, San Giovanni in Porta, via Depretis, il Parco Margherita, l’albergo<br />
Russia in Santa Lucia e il Caffè Vacca della Villa Comunale. «In questo completo isolamento, in<br />
questa vita totalmente involontaria che sono costretto a vivere», scrive sotto la tenda del suo<br />
accampamento, «ho avuto paura <strong>di</strong> non esistere più, proprio <strong>di</strong> non esserci» [38]<br />
In questo stato <strong>di</strong> sospensione metafisica, quando La Capria lesse le prime parole de La<br />
metamorfosi, gli sembrarono «scritte sulla porta <strong>di</strong> un mondo sconosciuto» [39]. Nello scarafaggio<br />
<strong>di</strong> Kafka, lui e i suoi giovani amici «ritrovarono raffigurate le immagini delle loro introversioni,<br />
della loro solitu<strong>di</strong>ne storica. E trovarono ancora, anche se sembra paradossale, un altro e più sottile<br />
fascino in Kafka: l’anonimo signor K. e Gregor Samsa erano vittime <strong>di</strong> un destino inesorabile su cui<br />
nulla potevano; erano colpevoli “per legge <strong>di</strong> natura”, come aveva detto l’Uomo del Sottosuolo»<br />
[40].<br />
La Bella Giornata (come ha istintivamente capito Carla), allora, non esiste?<br />
È questa <strong>di</strong>sillusione che traspare dal comportamento <strong>di</strong> Massimo, allorché torna a Napoli, per un
paio <strong>di</strong> giorni, nel 1960. Ormai sta a Roma, e viene a trovare la famiglia sempre più <strong>di</strong> rado. «A<br />
pranzo, la spigola, bollita, con maionese, fa bella figura intera nel piatto» [41].Ritrova i vecchi<br />
compagni, vinti e invecchiati; un fratello che resiste a tutto e <strong>di</strong>venta “eccezionale” e una città che<br />
non riesce più a riconoscere.<br />
E poi… «là, in fondo alla strada, qualcosa-che-passa-e-sembra, bionda coda <strong>di</strong> cavallo oscillante, ha<br />
svoltato l’angolo. Cerco lei, cerco Ninì… e mi pare sempre <strong>di</strong> camminare <strong>di</strong>etro qualcuno <strong>di</strong> cui<br />
sento ancora, vicini, i passi sopra queste pietre» [42].