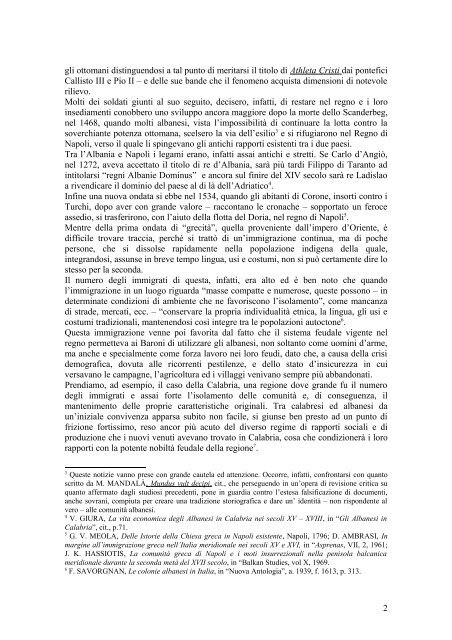Note sugli Albanesi d'Italia nel Mezzogiorno - Sides
Note sugli Albanesi d'Italia nel Mezzogiorno - Sides
Note sugli Albanesi d'Italia nel Mezzogiorno - Sides
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
gli ottomani distinguendosi a tal punto di meritarsi il titolo di Athleta Cristi dai pontefici<br />
Callisto III e Pio II – e delle sue bande che il fenomeno acquista dimensioni di notevole<br />
rilievo.<br />
Molti dei soldati giunti al suo seguito, decisero, infatti, di restare <strong>nel</strong> regno e i loro<br />
insediamenti conobbero uno sviluppo ancora maggiore dopo la morte dello Scanderbeg,<br />
<strong>nel</strong> 1468, quando molti albanesi, vista l’impossibilità di continuare la lotta contro la<br />
soverchiante potenza ottomana, scelsero la via dell’esilio3 e si rifugiarono <strong>nel</strong> Regno di<br />
Napoli, verso il quale li spingevano gli antichi rapporti esistenti tra i due paesi.<br />
Tra l’Albania e Napoli i legami erano, infatti assai antichi e stretti. Se Carlo d’Angiò,<br />
<strong>nel</strong> 1272, aveva accettato il titolo di re d’Albania, sarà più tardi Filippo di Taranto ad<br />
intitolarsi “regni Albanie Dominus” e ancora sul finire del XIV secolo sarà re Ladislao<br />
a rivendicare il dominio del paese al di là dell’Adriatico4 .<br />
Infine una nuova ondata si ebbe <strong>nel</strong> 1534, quando gli abitanti di Corone, insorti contro i<br />
Turchi, dopo aver con grande valore – raccontano le cronache – sopportato un feroce<br />
assedio, si trasferirono, con l’aiuto della flotta del Doria, <strong>nel</strong> regno di Napoli5 .<br />
Mentre della prima ondata di “grecità”, quella proveniente dall’impero d’Oriente, è<br />
difficile trovare traccia, perché si trattò di un’immigrazione continua, ma di poche<br />
persone, che si dissolse rapidamente <strong>nel</strong>la popolazione indigena della quale,<br />
integrandosi, assunse in breve tempo lingua, usi e costumi, non si può certamente dire lo<br />
stesso per la seconda.<br />
Il numero degli immigrati di questa, infatti, era alto ed è ben noto che quando<br />
l’immigrazione in un luogo riguarda “masse compatte e numerose, queste possono – in<br />
determinate condizioni di ambiente che ne favoriscono l’isolamento”, come mancanza<br />
di strade, mercati, ecc. – “conservare la propria individualità etnica, la lingua, gli usi e<br />
costumi tradizionali, mantenendosi così integre tra le popolazioni autoctone6 .<br />
Questa immigrazione venne poi favorita dal fatto che il sistema feudale vigente <strong>nel</strong><br />
regno permetteva ai Baroni di utilizzare gli albanesi, non soltanto come uomini d’arme,<br />
ma anche e specialmente come forza lavoro nei loro feudi, dato che, a causa della crisi<br />
demografica, dovuta alle ricorrenti pestilenze, e dello stato d’insicurezza in cui<br />
versavano le campagne, l’agricoltura ed i villaggi venivano sempre più abbandonati.<br />
Prendiamo, ad esempio, il caso della Calabria, una regione dove grande fu il numero<br />
degli immigrati e assai forte l’isolamento delle comunità e, di conseguenza, il<br />
mantenimento delle proprie caratteristiche originali. Tra calabresi ed albanesi da<br />
un’iniziale convivenza apparsa subito non facile, si giunse ben presto ad un punto di<br />
frizione fortissimo, reso ancor più acuto del diverso regime di rapporti sociali e di<br />
produzione che i nuovi venuti avevano trovato in Calabria, cosa che condizionerà i loro<br />
rapporti con la potente nobiltà feudale della regione7 .<br />
3 Queste notizie vanno prese con grande cautela ed attenzione. Occorre, infatti, confrontarsi con quanto<br />
scritto da M. MANDALÀ,<br />
Mundus vult decipi,<br />
cit., che perseguendo in un’opera di revisione critica su<br />
quanto affermato dagli studiosi precedenti, pone in guardia contro l’estesa falsificazione di documenti,<br />
anche sovrani, compiuta per creare una tradizione storiografica e dare un’ identità – non rispondente al<br />
vero – alle comunità albanesi.<br />
4 V. GIURA, La vita economica degli <strong>Albanesi</strong> in Calabria nei secoli XV – XVIII, in “Gli <strong>Albanesi</strong> in<br />
Calabria”, cit., p.71.<br />
5 G. V. MEOLA, Delle Istorie della Chiesa greca in Napoli esistente, Napoli, 1796; D. AMBRASI, In<br />
margine all’immigrazione greca <strong>nel</strong>l’Italia meridionale nei secoli XV e XVI, in “Asprenas, VII, 2, 1961;<br />
J. K. HASSIOTIS, La comunità greca di Napoli e i moti insurrezionali <strong>nel</strong>la penisola balcanica<br />
meridionale durante la seconda metà del XVII secolo, in “Balkan Studies, vol X, 1969.<br />
6 F. SAVORGNAN, Le colonie albanesi in Italia, in “Nuova Antologia”, a. 1939, f. 1613, p. 313.<br />
2