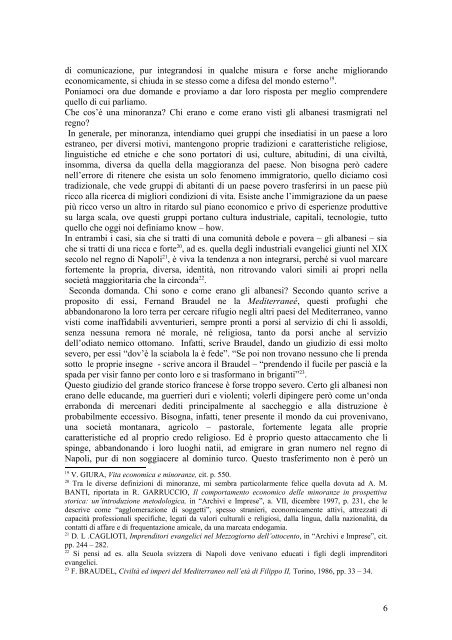Note sugli Albanesi d'Italia nel Mezzogiorno - Sides
Note sugli Albanesi d'Italia nel Mezzogiorno - Sides
Note sugli Albanesi d'Italia nel Mezzogiorno - Sides
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
di comunicazione, pur integrandosi in qualche misura e forse anche migliorando<br />
economicamente, si chiuda in se stesso come a difesa del mondo esterno 19 .<br />
Poniamoci ora due domande e proviamo a dar loro risposta per meglio comprendere<br />
quello di cui parliamo.<br />
Che cos’è una minoranza? Chi erano e come erano visti gli albanesi trasmigrati <strong>nel</strong><br />
regno?<br />
In generale, per minoranza, intendiamo quei gruppi che insediatisi in un paese a loro<br />
estraneo, per diversi motivi, mantengono proprie tradizioni e caratteristiche religiose,<br />
linguistiche ed etniche e che sono portatori di usi, culture, abitudini, di una civiltà,<br />
insomma, diversa da quella della maggioranza del paese. Non bisogna però cadere<br />
<strong>nel</strong>l’errore di ritenere che esista un solo fenomeno immigratorio, quello diciamo così<br />
tradizionale, che vede gruppi di abitanti di un paese povero trasferirsi in un paese più<br />
ricco alla ricerca di migliori condizioni di vita. Esiste anche l’immigrazione da un paese<br />
più ricco verso un altro in ritardo sul piano economico e privo di esperienze produttive<br />
su larga scala, ove questi gruppi portano cultura industriale, capitali, tecnologie, tutto<br />
quello che oggi noi definiamo know – how.<br />
In entrambi i casi, sia che si tratti di una comunità debole e povera – gli albanesi – sia<br />
che si tratti di una ricca e forte 20 , ad es. quella degli industriali evangelici giunti <strong>nel</strong> XIX<br />
secolo <strong>nel</strong> regno di Napoli 21 , è viva la tendenza a non integrarsi, perché si vuol marcare<br />
fortemente la propria, diversa, identità, non ritrovando valori simili ai propri <strong>nel</strong>la<br />
società maggioritaria che la circonda 22 .<br />
Seconda domanda. Chi sono e come erano gli albanesi? Secondo quanto scrive a<br />
proposito di essi, Fernand Braudel ne la Mediterraneé, questi profughi che<br />
abbandonarono la loro terra per cercare rifugio negli altri paesi del Mediterraneo, vanno<br />
visti come inaffidabili avventurieri, sempre pronti a porsi al servizio di chi li assoldi,<br />
senza nessuna remora né morale, né religiosa, tanto da porsi anche al servizio<br />
dell’odiato nemico ottomano. Infatti, scrive Braudel, dando un giudizio di essi molto<br />
severo, per essi “dov’è la sciabola la è fede”. “Se poi non trovano nessuno che li prenda<br />
sotto le proprie insegne - scrive ancora il Braudel – “prendendo il fucile per pascià e la<br />
spada per visir fanno per conto loro e si trasformano in briganti” 23 .<br />
Questo giudizio del grande storico francese è forse troppo severo. Certo gli albanesi non<br />
erano delle educande, ma guerrieri duri e violenti; volerli dipingere però come un‘onda<br />
errabonda di mercenari dediti principalmente al saccheggio e alla distruzione è<br />
probabilmente eccessivo. Bisogna, infatti, tener presente il mondo da cui provenivano,<br />
una società montanara, agricolo – pastorale, fortemente legata alle proprie<br />
caratteristiche ed al proprio credo religioso. Ed è proprio questo attaccamento che li<br />
spinge, abbandonando i loro luoghi natii, ad emigrare in gran numero <strong>nel</strong> regno di<br />
Napoli, pur di non soggiacere al dominio turco. Questo trasferimento non è però un<br />
19 V. GIURA, Vita economica e minoranze, cit. p. 550.<br />
20 Tra le diverse definizioni di minoranze, mi sembra particolarmente felice quella dovuta ad A. M.<br />
BANTI, riportata in R. GARRUCCIO, Il comportamento economico delle minoranze in prospettiva<br />
storica: un’introduzione metodologica, in “Archivi e Imprese”, a. VII, dicembre 1997, p. 231, che le<br />
descrive come “agglomerazione di soggetti”, spesso stranieri, economicamente attivi, attrezzati di<br />
capacità professionali specifiche, legati da valori culturali e religiosi, dalla lingua, dalla nazionalità, da<br />
contatti di affare e di frequentazione amicale, da una marcata endogamia.<br />
21 D. L .CAGLIOTI, Imprenditori evangelici <strong>nel</strong> <strong>Mezzogiorno</strong> dell’ottocento, in “Archivi e Imprese”, cit.<br />
pp. 244 – 282.<br />
22 Si pensi ad es. alla Scuola svizzera di Napoli dove venivano educati i figli degli imprenditori<br />
evangelici.<br />
23 F. BRAUDEL, Civiltà ed imperi del Mediterraneo <strong>nel</strong>l’età di Filippo II, Torino, 1986, pp. 33 – 34.<br />
6