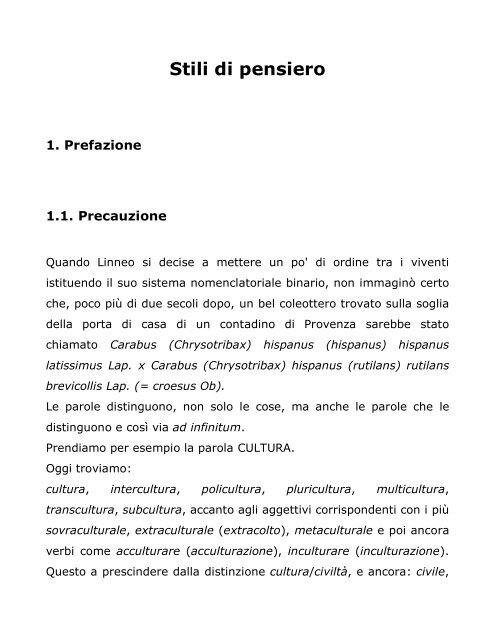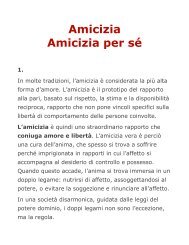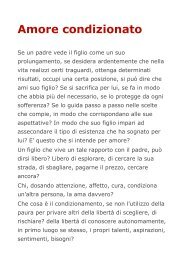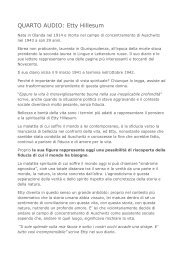Stili di Pensiero.pdf - Mauro Scardovelli
Stili di Pensiero.pdf - Mauro Scardovelli
Stili di Pensiero.pdf - Mauro Scardovelli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1. Prefazione<br />
1.1. Precauzione<br />
<strong>Stili</strong> <strong>di</strong> pensiero<br />
Quando Linneo si decise a mettere un po' <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne tra i viventi<br />
istituendo il suo sistema nomenclatoriale binario, non immaginò certo<br />
che, poco più <strong>di</strong> due secoli dopo, un bel coleottero trovato sulla soglia<br />
della porta <strong>di</strong> casa <strong>di</strong> un conta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Provenza sarebbe stato<br />
chiamato Carabus (Chrysotribax) hispanus (hispanus) hispanus<br />
latissimus Lap. x Carabus (Chrysotribax) hispanus (rutilans) rutilans<br />
brevicollis Lap. (= croesus Ob).<br />
Le parole <strong>di</strong>stinguono, non solo le cose, ma anche le parole che le<br />
<strong>di</strong>stinguono e così via ad infinitum.<br />
Pren<strong>di</strong>amo per esempio la parola CULTURA.<br />
Oggi troviamo:<br />
cultura, intercultura, policultura, pluricultura, multicultura,<br />
transcultura, subcultura, accanto agli aggettivi corrispondenti con i più<br />
sovraculturale, extraculturale (extracolto), metaculturale e poi ancora<br />
verbi come acculturare (acculturazione), inculturare (inculturazione).<br />
Questo a prescindere dalla <strong>di</strong>stinzione cultura/civiltà, e ancora: civile,
civilizzazione ecc.<br />
Questo balletto nomenclatoriale - cui non va negata rilevanza<br />
scientifica o almeno accademica - testimonia tuttavia un <strong>di</strong>sagio<br />
espressivo, meritevole forse <strong>di</strong> qualche considerazione non solo<br />
teorica.<br />
A me sembra, a rischio <strong>di</strong> passare per riduzionista, che l'intera<br />
querelle intorno alla parola cultura e ai suoi derivati giri intorno a due<br />
concetti, imbarazzanti entrambi perché avvertiti come pericolosi per la<br />
nostra stessa sopravvivenza: assolutezza e relatività o anche<br />
dogmatismo e relativismo. Non si tratta <strong>di</strong> concetti antitetici, come<br />
<strong>di</strong>mostra banalmente la frase: tutto è relativo, chiaramente<br />
dogmatica, assolutizzante. Piuttosto li chiameremmo conflittuali in<br />
quanto generatori <strong>di</strong> conflitti, e non sono verbali. Questa loro<br />
conflittualità non antitetica, pone dei problemi logici, i quali comunque<br />
andrebbero trattati in sede più competente.<br />
Per parte mia non posso che <strong>di</strong> proporre un escamotage, forse un po'<br />
logoro, ma ancora funzionante, che un quarto <strong>di</strong> secolo fa<br />
chiamammo IMC (Ipotesi metaculturale). Ne parlerò tra poco.<br />
L'aspetto logico <strong>di</strong> IMC o, se si vuole, <strong>di</strong> una conflittualità non<br />
antitetica, pur non essendo da sottovalutare in considerazione delle<br />
sue conseguenze pratiche, politiche anzitutto, è tuttavia marginale<br />
nell'azione da noi promossa (mi riferisco al Centro metaculturale da<br />
me <strong>di</strong>retto fino ai primi mesi del 2006), azione essenzialmente rivolta<br />
a progetti formativi <strong>di</strong> base, oggi in parte documentati sul sito Web<br />
<strong>di</strong>datticaperprogetti.it. È anche marginale per possibili iniziative in<br />
campo sociale, pedagogico, riabilitativo, psicoterapico ecc., in
particolare per progetti <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione inter- e transculturale, in una<br />
parola per tutto il versante pratico-operativo che abbiamo privilegiato<br />
in questi anni.<br />
Ho trattato questi argomenti ripetute volte, soprattutto quelli<br />
formativi, ma senza essere mai riuscito a cointeressare alcuna forma<br />
<strong>di</strong> potere e<strong>di</strong>toriale, me<strong>di</strong>atico, politico forse con l'unica eccezione <strong>di</strong><br />
un iniziale interessamento della pedagogia per l'in<strong>di</strong>rizzo metodologico<br />
sperimentato nell'area <strong>di</strong> mia competenza specifica: la musica.<br />
Nel presente scritto tenterò qualche incursione in settori a me<br />
originariamente estranei. Non mi nascondo i rischi del <strong>di</strong>lettantismo,<br />
che del resto non ho mai rifiutato <strong>di</strong> linea <strong>di</strong> principio. Da quando, nel<br />
1967, ho abbandonato, senza rimpianto, il mondo della cultura alta,<br />
ho smesso anche <strong>di</strong> informarmi, se non per occasionali fiammate per<br />
la logica, la fisica, l'epistemologia, che a suo tempo avevano acceso<br />
entusiasmi giovanili. Considerazioni <strong>di</strong> comodo si sono mescolate a<br />
tentativi <strong>di</strong> giustificazione teorica, per cui, appoggiandomi al fatto che<br />
un cervello ce l'abbiamo tutti, preferisco oggi parlare <strong>di</strong> stili <strong>di</strong><br />
pensiero - convergente, <strong>di</strong>vergente, logico-matematico... - anziché <strong>di</strong><br />
più o meno definibili ambiti <strong>di</strong>sciplinari.<br />
Se poi, come spesso mi capita, si verificano delle convergenze con<br />
pensieri rigorosamente e autorevolmente formulati, ne prendo atto<br />
con sod<strong>di</strong>sfazione, non tanto per le fortuite coincidenze quanto per il<br />
reciproco rafforzamento <strong>di</strong> due percorsi tra loro in<strong>di</strong>pendenti e<br />
muoventi in <strong>di</strong>rezione opposta: dall'alto e dal basso, da chi sa molto e<br />
deduce e da chi sa poco e cerca <strong>di</strong> capire. Ho <strong>di</strong>scusso altrove (Da<br />
sapere al pensare, 2003) l'in<strong>di</strong>rizzo metodologico che ci siamo dati
come Centro metaculturale e non ripeterò il già detto. Mi limito solo<br />
ad aggiungere che tale in<strong>di</strong>rizzo, fondato sui minimi livelli <strong>di</strong><br />
competenza e da lì impegnato a costruire competenze confrontabili<br />
con quelle <strong>di</strong> provenienza alta, continua da anni a dare risultati<br />
estremamente sod<strong>di</strong>sfacenti, sia tra i bambini che tra gli adulti. I<br />
vantaggi non tanto sono evidenti in sede specialistica (una<br />
conoscenza <strong>di</strong> questo tipo non può probabilmente costruirsi che<br />
attraverso uno stu<strong>di</strong>o assiduo <strong>di</strong> ciò che è già stato pensato), quanto<br />
riguardano la mobilità del pensiero, lo sviluppo dei raccor<strong>di</strong> trasversali<br />
tra <strong>di</strong>scipline anche lontane, il piacere, il gusto del pensare. Il<br />
pensiero è lavoro, costa fatica, ma è anche l'attività cui è deputato il<br />
nostro organo centrale, il cervello, e quin<strong>di</strong>, come tale, gratificante al<br />
massimo. L'esercizio, l'allenamento al pensiero attivo dovrebbe essere<br />
compito precipuo della scuola, che invece troppo spesso lo degrada a<br />
funzioni <strong>di</strong> stoccaggio informativo. Se ne è parlato a sufficienza nello<br />
scritto succitato, così come abbondanti in<strong>di</strong>cazioni operative si<br />
trovano sul nostro sito.<br />
Affronto ora questo stu<strong>di</strong>o sugli stili <strong>di</strong> pensiero in piena coscienza dei<br />
rischi cui vado incontro e della, probabilmente meritata, <strong>di</strong>sattenzione<br />
dei competenti. Mi trovo, alla soglia degli 80 anni, nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
un principiante che voglia mettersi in mostra, mentre nulla è più<br />
lontano dalla mia mente della vetrina culturale, cui del resto non ho<br />
mai aspirato. Ciò che mi spinge a questo extravagante passo è solo il<br />
sospetto che qualcosa dello stile metaculturale, che ormai mi sento<br />
appiccicato addosso, possa effettivamente servire a qualcun altro, ma<br />
non possa raggiungerlo semplicemente perché ho avuto paura <strong>di</strong>
espormi.<br />
1.2. Preconcetto-Premessa: IMC (Ipotesi<br />
metaculturale)<br />
Per quanto assai semplice nella forma, concettualmente ovvia e<br />
niente affatto originale, IMC ha richiesto, per raggiungere una<br />
formulazione provvisoriamente accettabile, una ventina <strong>di</strong> anni (1979-<br />
99) <strong>di</strong> intenso lavoro pratico e teorico, condotto collettivamente dagli<br />
operatori del CMC (Centro metaculturale) a <strong>di</strong>retto contatto con<br />
insegnanti e allievi <strong>di</strong> innumerevoli scuole italiane.<br />
Poiché ritengo assai improbabile (per la scarsa circolazione dei nostri<br />
iscritti) che il lettore si sia già imbattuto in una qualche definizione <strong>di</strong><br />
IMC, ripeto qui tre delle più comunemente usate, corredandole <strong>di</strong> un<br />
breve commento chiarificatore.<br />
Def.1:<br />
Ogni nostro atto o pensiero, se non altro in quanto possibile oggetto<br />
<strong>di</strong> comunicazione, ha in sé una componente culturale che va<br />
relativizzata alla cultura che l'ha prodotta.<br />
La definizione non è certo formalmente ineccepibile (perché ad<br />
esempio andrebbe "relativizzata alla cultura che l'ha prodotta"?).<br />
È però facilmente comprensibile e molti converranno che, per essere<br />
comunicabile, ogni nostro atto o pensiero ha bisogno <strong>di</strong> un linguaggio,<br />
ed ecco la "componente culturale" <strong>di</strong> cui parla Def.1. Def.1 è anche<br />
evidentemente autoreferente in quanto per essere comunicata ha
isogno <strong>di</strong> sé stessa e quin<strong>di</strong> va relativizzata ("alla cultura che l'ha<br />
prodotta", cioè la nostra.)<br />
IMC non è in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere sé stessa, si colloca nell'ambito <strong>di</strong> un<br />
pensiero debole, <strong>di</strong> qui costituisce probabilmente la punta più bassa.<br />
Def.2<br />
IMC coincide con la sospensione del "principio <strong>di</strong> non contrad<strong>di</strong>zione".<br />
Def.2 è molto meno evidente <strong>di</strong> Def.1, tuttavia formalmente più<br />
compatta e logicamente più coerente. Se IMC non è in grado, come<br />
abbiamo visto, <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendere sé stessa, potrà imbattersi in un qualsiasi<br />
momento con un'ipotesi più forte che l'ha neghi e allora dovrebbe<br />
soccombere, a meno che non le riesca <strong>di</strong> mettere tra parentesi il<br />
"principio <strong>di</strong> non contrad<strong>di</strong>zione". Abolire questo principio <strong>di</strong>cono i<br />
logici che non è possibile, piena il baratro dell'insignificanza (se "A"<br />
può essere contemporaneamente "non A", ogni nostra comunicazione<br />
risulta vanificata, la comprensione <strong>di</strong>venta impossibile). Non resta<br />
quin<strong>di</strong> che "sospendere" quel principio ammettendo, in certi casi, la<br />
contrad<strong>di</strong>zione, per reintrodurlo ogni volta che serve, cioè quasi<br />
sempre.<br />
Ma come fa IMC a evitare il buco nero dell'insignificanza, della<br />
nullificazione? Servendosi <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento assai semplice, del tutto<br />
arbitrario e autogiustificato, tale tuttavia da sfuggire a ogni tentativo<br />
<strong>di</strong> sabotaggio.<br />
Gli ingre<strong>di</strong>enti <strong>di</strong> questo meccanismo sono tre:<br />
u.c. (unità culturale come la definiscono la semiotica e l'antropologia:<br />
una parola, un concetto, uno strumento, un'usanza...)<br />
UCL (Universo Culturale Locale=cultura come la si intende
normalmente: caratteristica globale <strong>di</strong> una popolazione, ma anche <strong>di</strong><br />
un in<strong>di</strong>viduo, famiglia...)<br />
UMC (Universo Metaculturale= universo autocontrad<strong>di</strong>ttorio,<br />
assolutizzante, nullificante, costruito con gli infiniti UCL reali,<br />
immaginari, possibili, impossibili...)<br />
Tutti e tre questi ingre<strong>di</strong>enti sono artificiali, privi <strong>di</strong> qualsiasi riscontro<br />
oggettivo (non esistono u.c., UCL, UMC come esiste un cavallo o una<br />
se<strong>di</strong>a). Se <strong>di</strong> esistenza si può parlare è solo metodologica, si tratta<br />
cioè <strong>di</strong> strumenti concettuali utili ma privi <strong>di</strong> ogni veste ontologica,<br />
meno che mai metafisica. Oltretutto sono legati da circolarità, nel<br />
senso che ognuno per essere definito ha bisogno degli altri due e non<br />
è autosufficiente: UMC è un UCL costruito ad hoc per IMC; anche gli<br />
UCL sono delle u.c. (cioè dei concetti) costruiti per lo stesso scopo;<br />
ma le u.c. non avrebbero senso se non fossero collocabili in un<br />
qualche UCL; d'altronde l'universo involvente tutti gli UCL e tale per<br />
giunta da nullificarli è appunto IMC. Una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> estrema<br />
debolezza, che la nostra mente ha prodotto e <strong>di</strong> cui dobbiamo<br />
probabilmente accontentarci ma che, proprio per questo, è l'unica<br />
nostra forza.<br />
Def.3<br />
Date una qualsiasi proposizione p in cerca <strong>di</strong> convalida è sempre<br />
possibile trovare o costruire un UCLp che la renda vera.<br />
Trattandosi <strong>di</strong> una definizione non c'è nulla da <strong>di</strong>mostrare se non<br />
l'equivalenza con altre, ad esempio con Def.2. Per la logica corrente a<br />
due valori (vero, falso), l'unico caso in cui p risulta comunque falsa è<br />
quello in cui p è autocontrad<strong>di</strong>ttoria. Ma questo caso non ci deve
preoccupare perché, per Def.2, il principio <strong>di</strong> non contrad<strong>di</strong>zione è<br />
sospeso, se non altro in UMC, e UMC è appunto l'UCL in grado <strong>di</strong><br />
rendere sia vera che falsa l'autocontrad<strong>di</strong>zione.<br />
Def.3 esprime, possiamo <strong>di</strong>re, l'onnipotenza dell'intelletto umano,<br />
capace <strong>di</strong> fondere (come <strong>di</strong> negare) qualunque verità. È come se la<br />
debolezza <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>ceva prima si ribaltasse ora verso l'altro e fosse<br />
anche il massimo raggiungibile <strong>di</strong> un pensiero forte.<br />
Ripeto comunque quanto ripetutamente affermato, che cioè né IMC<br />
né il suo impianto formale ci sembrano interessanti in sé, e ma solo<br />
per le conseguenze metodologiche che se ne possono trarre.<br />
IMC sposta l'attenzione dal piano euristico, epistemologico, filosofico a<br />
quello pratico, fattivo, costruttivo. Qualsiasi altra ipotesi che facesse<br />
lo stesso le sarebbe equivalente.<br />
Non ripercorro in questa sede l'itinerario che ci ha portato nel corso<br />
degli anni a sviluppare una metodologia pedagogico-formativa volta<br />
alla costruzione <strong>di</strong> una cultura <strong>di</strong> base a in<strong>di</strong>rizzo metaculturale, in<br />
grado <strong>di</strong> aprirsi alla <strong>di</strong>versità e a forme <strong>di</strong> interazione paritaria tra<br />
culture. Tra gli strumenti propri <strong>di</strong> quest'in<strong>di</strong>rizzo nomino - ma non<br />
tratto - il circuito autogenerativo, la catabasi metaculturale, il binomio<br />
analisi-composizione, la relativizzazione culturale, l'estensione<br />
metaculturale (trasferibilità dei modelli), la modulazione culturale, la<br />
costruzione degli UCL.<br />
Le in<strong>di</strong>cazioni relative a questi strumenti si trovano tra i materiali <strong>di</strong><br />
supporto <strong>di</strong>dattico al nostro sito www.<strong>di</strong>datticaperprogetti.it. Itinerari<br />
specifici sul visivo, musicale, verbale si trovano sia sui CD che tra i
progetti offerti dal sito, la maggior parte dei quali propone incursioni<br />
metaculturali nei più <strong>di</strong>versi ambiti <strong>di</strong>sciplinari, dalla matematica alle<br />
scienze, dalla storia alla geografia, all'antropologia, agli stu<strong>di</strong> sociali, il<br />
tutto espresso in un linguaggio <strong>di</strong>fferenziato a seconda dei destinatari<br />
entro la fascia scolare dell'obbligo. Gli aspetti più problematici<br />
dell'interazione insegnanti-alunni sono ampiamente trattati nella<br />
sezione dei cosiddetti no<strong>di</strong> formativi, correlati ai progetti.<br />
Un problema, legato alla mia specificità <strong>di</strong> compositore, mi ha tenuto<br />
occupato per più <strong>di</strong> 30 anni, ed è stato il raccordo tra la fase che<br />
abbiamo chiamato <strong>di</strong> base e quella successiva, professionalizzante.<br />
Qui si trattava naturalmente <strong>di</strong> entrare in profon<strong>di</strong>tà negli aspetti<br />
culturali e tecnici della musica, e io ho tentato <strong>di</strong> farlo senza<br />
abbandonare lo stile mentale metaculturale della fase precedente. Se<br />
e quanto ci sia riuscito non sta a me <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care.<br />
Posso <strong>di</strong>re <strong>di</strong> avere dalla mia la testimonianza positiva <strong>di</strong> molti allievi<br />
musicisti e operatori musicali <strong>di</strong> base, cui la continuità tra le due fasi è<br />
apparsa evidente. Ma anche <strong>di</strong> questo non è questione nel presente<br />
scritto.<br />
Da molti anni il nostro Centro ha più volte affrontato il problema<br />
dell'educazione permanente, soprattutto, ma non solo, come<br />
aggiornamento professionale degli insegnanti, in particolare<br />
elementari. Cicli pluriennali <strong>di</strong> incontri con le famiglie degli alunni<br />
hanno prodotto materiali <strong>di</strong> notevole interesse dei quali contiamo <strong>di</strong><br />
arricchire il nostro sito.<br />
Recentemente mi sono proposto, con l'appoggio <strong>di</strong> tutto il Centro, <strong>di</strong><br />
ricavare da IMC in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> più ampia generalità, riguardanti La
convivenza pacifica nella <strong>di</strong>versità (2006), Dal sapere al pensare<br />
(2003), La funzione formativa nell'era della globalità (2006). Anche<br />
questi stu<strong>di</strong> entreranno a far parte dei materiali <strong>di</strong> supporto del nostro<br />
sito.<br />
Ora è la volta <strong>di</strong> <strong>Stili</strong> <strong>di</strong> pensiero che potrebbe, se non affermare,<br />
rendere almeno plausibile la presenza <strong>di</strong> IMC nell'epistemologia dei<br />
nostri giorni. Vedremo.<br />
Il raggio <strong>di</strong> intervento è alquanto più ampio che negli scritti precedenti<br />
e ancora meno supportato, come già detto, da competenze acquisite.<br />
Ciononostante penso valga la pena affrontare l'avventura anche se<br />
con la sola scorta <strong>di</strong> IMC; se qualcosa verrà detto <strong>di</strong> più o meno ovvio,<br />
sarà la coloritura metaculturale a <strong>di</strong>stinguerlo da quanto già e meglio<br />
affermato dagli stu<strong>di</strong> specialistici, e questa coloritura potrebbe, per la<br />
sua patina relativistica, me<strong>di</strong>are anche nei confronti <strong>di</strong> posizioni<br />
ra<strong>di</strong>calmente opposte.<br />
Da una premessa ci si aspetta anche alcune <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> intenti,<br />
che orientino il lettore e che lo inducano a continuare nella lettura o a<br />
desistere definitivamente.<br />
Anzitutto: quale lettore?<br />
Posso immaginare un visitatore casuale del nostro sito che resti<br />
momentaneamente incuriosito dalla locuzione stile <strong>di</strong> pensiero che<br />
forse non gli è abituale. Così come posso immaginare un giovane<br />
ricercatore - per esempio uno psicologo o un antropologo - che speri<br />
<strong>di</strong> trovare qualche notizia <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> recenti sull'argomento (quest'ultimo<br />
resterà probabilmente deluso dalla scarsa scientificità <strong>di</strong> quanto viene
leggendo).<br />
Posso però anche sperare che si imbatta nel nostro sito - e quin<strong>di</strong><br />
raggiunga anche questo scritto - un operatore culturale, per esempio<br />
un'insegnante, che abbia bisogno <strong>di</strong> convertire in operatività sul<br />
campo competenze acquisite teoricamente. È a un tale operatore che<br />
il CMC si rivolge per tra<strong>di</strong>zione e anche nel caso presente è lui il target<br />
preferenziale pur se non esclusivo.<br />
A prima vista, scorrendo per esempio l'in<strong>di</strong>ce, non sembra tuttavia<br />
che il taglio <strong>di</strong> questo stu<strong>di</strong>o sia <strong>di</strong> tipo pratico-operativo, un prêt-à-<br />
porter da indossare in classe; già la pretesa classificatoria degli stili<br />
mentali fa pensare piuttosto a una collezione <strong>di</strong> coleotteri che non a<br />
un manuale d'uso. Ma, come l'attribuzione <strong>di</strong> un nome specifico<br />
(anche quello ipertrofico citato all'inizio) non significa<br />
necessariamente che l'autore creda nell'oggettività <strong>di</strong> tutti i suoi<br />
riferimenti terminologici, così anche l'autore <strong>di</strong> questo scritto non<br />
pretende affatto <strong>di</strong> aver in<strong>di</strong>viduato dei settori della mente, ad<strong>di</strong>rittura<br />
delle aree del cervello associate ai vari stili <strong>di</strong> pensiero. A<br />
impe<strong>di</strong>rglielo sarebbe bastata IMC, da cui gli è ormai impossibile<br />
prescindere.<br />
Il caso è analogo a quello dei no<strong>di</strong> formativi, ai quali il CMC ha<br />
lavorato per anni, senza tuttavia credere nella loro esistenza<br />
oggettiva. Qui come lì si tratta <strong>di</strong> costrutti metodologici, la cui<br />
eventuale rilevanza riguarda il momento applicativo, l'utilità che ne<br />
viene dall'uso. Ma, a che cosa può servire una classificazione <strong>di</strong> stili <strong>di</strong><br />
pensiero?<br />
A molto poco, evidentemente, se ci si limita all'aspetto formale della
classificazione. Di più, speriamo, se al singolo stile si accompagna una<br />
metodologia formativa atta a potenziarlo.<br />
Ancora un ma: abbiamo appena detto che i singoli stili <strong>di</strong> pensiero non<br />
hanno una esistenza oggettiva, non sono cioè in<strong>di</strong>viduabili con<br />
chiarezza né separabili gli uni dagli altri. È anzi assai probabile che<br />
coesistano in ogni mente e siano sprovvisti <strong>di</strong> confini. E allora, perché<br />
classificarli e trattarli separatamente, visto che separatamente non<br />
incontreremo mai?<br />
I viventi vivono e sopravvivono in quanto <strong>di</strong>stinguono. Poco importa<br />
se a ciò che la mosca o l'uomo <strong>di</strong>stinguono corrisponde o non<br />
corrisponde un'entità reale. Le mosche non si interessano <strong>di</strong><br />
metafisica, gli è sufficiente <strong>di</strong>stinguere il mangiabile dall'immangiabile,<br />
la luce dal buio, il caldo dal freddo. L'uomo è un poco più esigente e<br />
non si accontenta <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere, ma pretende anche che ciò che lui ha<br />
<strong>di</strong>stinto lo sia anche in un mondo (un UCL) chiamato realtà.<br />
Per parte mia cercherò, in questo stu<strong>di</strong>o, <strong>di</strong> attenermi più alla mosca<br />
che all'uomo. Non sono (non credo <strong>di</strong> essere) persona <strong>di</strong> fede,<br />
tantomeno se le cose in cui dovrei credere le ho prodotte io stesso. Gli<br />
stili <strong>di</strong> pensiero non sono articoli <strong>di</strong> fede ma solo un ommati<strong>di</strong>o<br />
nell'occhio <strong>di</strong> una mosca.<br />
1.3. Prelu<strong>di</strong>o<br />
Al n°... del sito www.<strong>di</strong>datticaperprogetti.it si legge la seguente<br />
storiella, tolta dall'omonima raccolta scritta nel 1984 per rispondere
alla richiesta <strong>di</strong> alcune scuole elementari della Bassa Sabina.<br />
Il lago delle storie riflesse<br />
Vicino al paese <strong>di</strong> X c'era una volta un lago, anzi ci sarebbe ancora se<br />
ci fosse il paese <strong>di</strong> X. Ma il paese <strong>di</strong> X non c'è più, come vedremo.<br />
A vederlo, era un normale lago, non troppo grande né troppo piccolo.<br />
Pesci non ne conteneva e neppure rane e salamandre. L'acqua era<br />
troppo fredda per farci il bagno e a berla... non si sa, nessuno l'aveva<br />
mai bevuta, forse per paura e per rispetto.<br />
Sì, perché il lago aveva una strana proprietà: accoglieva e tratteneva<br />
a tutte le storie che gli venivano consegnate. Molti infatti andavano da<br />
lui ad affidargli le loro storie, vere o false che fossero, inventate o<br />
realmente accadute. Di certe storie c'erano anche due o più versioni.<br />
Fatti identici o simili si trovavano in più <strong>di</strong> una storia, ma quand'è che<br />
un fatto si poteva <strong>di</strong>re identico o simili a un altro? Il lago, comunque,<br />
non stava lì per <strong>di</strong>rimere, selezionare, giu<strong>di</strong>care, ma solo per<br />
conservare.<br />
E per trasmettere.<br />
Uno bastava che andasse al lago, si fermasse sulla sua vita (ma c'era<br />
anche a <strong>di</strong>sposizione una barca a remi per le ricerche in profon<strong>di</strong>tà) e<br />
<strong>di</strong>cesse ad alta voce il titolo <strong>di</strong> una storia o l'argomento o il nome dei<br />
personaggi, ed ecco la storia comparirgli davanti, riflessa nelle acque<br />
del lago.<br />
Riflessa come?<br />
Come in uno specchio, si <strong>di</strong>rà. Ma che cosa vi si vedeva riflesso?
Nessuna testimonianza è stata mai chiara su questo punto. Alcuni<br />
parlavano <strong>di</strong> scrittura, altri <strong>di</strong> immagini, altri <strong>di</strong> pensieri pensati da<br />
fuori invece che da dentro. Una circostanza era però da tutti<br />
confermata, anche per molti era l'unica che ricordavano con<br />
chiarezza: sul fondo <strong>di</strong> ogni storia ciascuno vedeva riflessa, tremula e<br />
trasparente ma ben riconoscibile, la propria immagine, come se lui<br />
stesso fosse in ogni storia o anche ogni storia in lui.<br />
Ma, si domanderà, se uno andava al lago a rileggervi una storia sua<br />
personale? Certo, ci si vedeva due volte: l'una come personaggio della<br />
storia (ma non sempre la somiglianza era convincente), l'altra come<br />
suo sfondo (talora intorbidato da occasionali mulinelli).<br />
Alcuni andavano al lago per <strong>di</strong>vertimento, come si va al cinema o si<br />
guarda la TV: volevano entrare <strong>di</strong> persona nelle storie <strong>di</strong> altri. C'era<br />
chi andava al lago per stu<strong>di</strong>o, e lo si riconosceva dal quaderno <strong>di</strong><br />
appunti che portava con sé, o dal registratore o dalla cinepresa. Altri<br />
ancora, come già detto, ci andavano per depositarle, le storie. In<br />
breve, non c'era persona <strong>di</strong> X che non avesse consuetu<strong>di</strong>ne con il lago<br />
e i suoi riflessi. Sembrava anche che la sua capacità <strong>di</strong> conservare e <strong>di</strong><br />
riflettere non avesse limiti.<br />
Poi però capitò il fatto per cui non possiamo neppure più <strong>di</strong>re con<br />
certezza se quel lago esiste ancora o se è mai esistito. Il suo punto <strong>di</strong><br />
riferimento geografico, il paese <strong>di</strong> X, un certo giorno si trasferì tutto<br />
intero, con le sue vie, le sue piazze e i suoi abitanti, nel lago,<br />
<strong>di</strong>ventando una delle sue innumerevoli storie riflesse.<br />
E così del lago stesso non resta altra traccia se non quella riflessa<br />
nella storia che vi ho raccontato.
E questo che c'entra? si chiederanno i lettori.<br />
Come forse ricorda chi ancora ha qualche <strong>di</strong>mestichezza con la musica<br />
dei secoli passati, non sempre i Prelu<strong>di</strong> hanno <strong>di</strong>rettamente a che fare<br />
con ciò cui prelu<strong>di</strong>ano. Spesso anzi, soprattutto nell'800, si tratta <strong>di</strong><br />
composizione autonome, che non prelu<strong>di</strong>ano a nulla.<br />
E così la storiella che vi ho raccontato potrebbe non avere nulla che<br />
fare con ciò che seguirà.<br />
Potrebbe però anche essere <strong>di</strong>versamente.<br />
2. Generalità<br />
Consideriamo un insieme <strong>di</strong> tre elementi, A, B, C. I suoi sottoinsiemi<br />
sono notoriamente più numerosi dei suoi elementi. Anche questi, presi<br />
singolarmente possono essere considerati come sottoinsiemi. In più<br />
abbiamo AB, AC, BC e, se si vuole, anche ABC. Se poi A, B, C<br />
vengono visti come prototipi, suscettibili <strong>di</strong> essere replicati, potremmo<br />
avere ABABC, ABCBC, ACACB, ma anche AAAAAA...BC e così via<br />
all'infinito.<br />
Sappiamo che il nostro cervello è composto <strong>di</strong> alcuni miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
cellule, della cui azione la mente può servirsi anche replicandola a<br />
piacere. Lasciando da parte la questione <strong>di</strong> chi o che cosa sia la<br />
mente, visto che il cervello è solo il suo strumento, è facile rendersi<br />
conto dell'immensa quantità <strong>di</strong> configurazioni che le connessioni<br />
parziali <strong>di</strong> queste cellule possono assumere in tempi anche brevissimi,
cioè <strong>di</strong> quanto pensiero, nell'accezione più generale del termine,<br />
siamo in grado <strong>di</strong> produrre. Probabilmente molto <strong>di</strong> più <strong>di</strong> quanto<br />
giunge alla nostra consapevolezza. Per esempio anche il battito del<br />
cuore, la respirazione, la <strong>di</strong>gestione utilizzano una loro parte <strong>di</strong><br />
pensiero - cioè <strong>di</strong> connessioni neuroniche - così come le nostre azioni<br />
istintive, i nostri sogni.<br />
L'attività del cervello che genericamente possiamo chiamare pensiero<br />
sfugge quin<strong>di</strong> a ogni tentativo oggettivo <strong>di</strong> localizzazione, anche<br />
perché niente ci assicura che il suo ren<strong>di</strong>mento attuale sia il massimo<br />
possibile. Il problema della mente è stato finora piuttosto il contrario:<br />
costringere il pensiero entro confini controllabili. Controllabili da chi?<br />
Dalla mente stessa nella sua versione in<strong>di</strong>viduale, più ancora però in<br />
quella collettiva. Tralasciando anche la questione, altrove <strong>di</strong>scussa, se<br />
e fino a che punto la mente in<strong>di</strong>viduale ne rifletta un'altra <strong>di</strong> proprietà<br />
comune, il controllo <strong>di</strong> ambedue è risultata essenziale per la<br />
sopravvivenza. E lo strumento <strong>di</strong> questo controllo l'abbiamo chiamato<br />
cultura. Le popolazioni umane mantengono la loro in<strong>di</strong>vidualità<br />
collettiva (non è un ossimoro!) attraverso la cultura, o meglio le<br />
culture, stante la loro enorme varietà nel tempo e nello spazio.<br />
Tutto questo è ai limiti dell'ovvio e anche l'analisi, sia delle singole<br />
culture che del concetto che le involve, è, da un paio <strong>di</strong> secoli a<br />
questa parte, a tal punto progre<strong>di</strong>ta che siamo oggi capaci <strong>di</strong><br />
costruirci osservatori metaculturali dai quali osservare e relativizzare il<br />
concetto e i suoi rappresentanti storici. Siamo capaci <strong>di</strong> farlo ma non<br />
ancora <strong>di</strong> vivere conseguentemente.<br />
Ve<strong>di</strong>amo tutti che il modello <strong>di</strong> società che ci siamo scelti (o che ci si è
imposto dopo il fallimento del modello concorrente) non offre<br />
sufficienti garanzie <strong>di</strong> sopravvivenza; non sappiamo tuttavia come<br />
uscirne. Stretto o largo, il limite delle singole culture si <strong>di</strong>mostra<br />
giorno per giorno più labile. Molti ancora ritengono <strong>di</strong> doverlo<br />
<strong>di</strong>fendere, anche con le armi, ma i processi <strong>di</strong> globalizzazione e la<br />
connessa ideologia sembrano inarrestabili.<br />
Ne deriverà la scomparsa delle culture, l'appiattimento su un unico<br />
modello vincente, ma poco affidabile? E a che ci servirebbe allora il<br />
concetto in<strong>di</strong>fferenziato <strong>di</strong> cultura? A nominare il nostro cammino<br />
verso l'autoannientamento?<br />
Sembra allora che la pluralità delle culture sia essenziale alla nostra<br />
sopravvivenza. Dovremo allora coniugarla con la globalizzazione, il<br />
che pone dei problemi metodologici non in<strong>di</strong>fferenti. Mantenere,<br />
potenziare anzi le <strong>di</strong>fferenze entro un quadro <strong>di</strong> globalità è quasi una<br />
sfida al pensiero logico. Il pericolo <strong>di</strong> precipitare nell'insignificanza <strong>di</strong><br />
UMC, per servirci del gergo metaculturale, è ben più che un pericolo<br />
teorico, astratto; ne va dell'affidabilità, non <strong>di</strong> un particolare modello,<br />
ma del pensiero umano tout-court.<br />
È per affrontare questo pericolo che è stata formulata IMC, ma non è<br />
affatto detto che l'averla formulata sia un atto risolutivo e non un<br />
semplice trucco deviante.<br />
I documenti del CMC come anche i miei scritti personali ritornano <strong>di</strong><br />
continuo su questo punto. IMC nasce nel dubbio, come espressione<br />
del dubbio ed è probabile che sia impotente a varcarne la soglia in<br />
<strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> una qualche certezza. Almeno fin quando si mantiene su<br />
un piano teorico, filosofico, epistemologico. Del resto non è stata mai
la ricerca <strong>di</strong> certezze la nostra intenzione, come più volte <strong>di</strong>chiarato<br />
ma soprattutto mostrato nella pratica formativa.<br />
Ho supposto poc'anzi che l'attività pensante dell'uomo non abbia<br />
ancora raggiunto il suo ren<strong>di</strong>mento ottimale a causa del potere<br />
costrittivo delle culture. Queste non avevano bisogno, per la loro<br />
sopravvivenza, <strong>di</strong> un ren<strong>di</strong>mento ottimale, anzi avevano l'interesse a<br />
promuoverlo solo in ambiti limitati e controllabili (per esempio<br />
nell'arte), lasciando che per il resto la mente restasse ben al <strong>di</strong> sotto<br />
delle sue capacità. Oggi la globalità ha cambiato le carte in tavola:<br />
l'eccellenza artistica o filosofica non bastano più a dar ragione della<br />
nostra sopravvivenza. La morte <strong>di</strong> un bambino africano per AIDS o<br />
mancanza d'acqua non è più compensata - se mai lo è stata - da un<br />
Tao te king o da una Passione bachiana. Il ren<strong>di</strong>mento ottimale della<br />
mente umana deve estendersi a ogni aspetto della nostra convivenza,<br />
ben oltre i confini specifici dell'Homo sapiens.<br />
In altre parole, dobbiamo <strong>di</strong>ventare più intelligenti - molto più<br />
intelligenti - in ogni azione della nostra vita. Il pensiero va portato<br />
nelle vicinanze del ren<strong>di</strong>mento ottimale delle cellule cerebrali. Un caso<br />
- cre<strong>di</strong>amo fortuito - <strong>di</strong> ipertelia ha permesso al nostro cervello <strong>di</strong><br />
svilupparsi molto al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto gli fosse richiesto, per farci<br />
sopravvivere. Il <strong>di</strong> più sembra oggi, paradossalmente, portarci rapida<br />
estinzione. Poiché nessuno dall'esterno si adopera alla riqualificazione<br />
della nostra mente, dobbiamo provvedere da noi. Il compito è arduo e<br />
il risultato per nulla scontato.<br />
Anche questo stu<strong>di</strong>o vuole dare un piccolo contributo nella <strong>di</strong>rezione:
IMPARIAMO A PENSARE MEGLIO.<br />
Ho già detto che il termine stile <strong>di</strong> pensiero non rimanda a nessun<br />
dato oggettivo, a qualcosa <strong>di</strong> univocamente definibile, ma si limita a<br />
suggerire un atteggiamento mentale in qualche modo collegato a un<br />
quadro culturale <strong>di</strong> riferimento. Non credo che gli UCL, per come li si<br />
voglia intendere, reclamino ciascuno un proprio stile <strong>di</strong> pensiero, ma<br />
che ne favoriscano alcuni in qualche caso fino a identificarsi con essi.<br />
Che cosa allora inten<strong>di</strong>amo per stile <strong>di</strong> pensiero?<br />
Alcuni esempi, al limite dell'ovvietà, serviranno a chiarire, a me stesso<br />
prima che ad altri, l'area semantica se non proprio il significato ultimo<br />
dell'espressione.<br />
Dire che un matematico <strong>di</strong> professione debba <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> uno stile <strong>di</strong><br />
pensiero logico-matematico è una banalità, affermarlo <strong>di</strong> un<br />
compositore <strong>di</strong> musica è certo meno ovvio, così come riscontrarlo in<br />
un calciatore potrebbe destare meraviglia. Che un Papa un teologo<br />
della cristianità rivelino un particolare attaccamento allo stile<br />
dogmatico attiene al loro ministero: senza questo attaccamento<br />
<strong>di</strong>fficilmente acquisterebbero cre<strong>di</strong>to in seno alla loro comunità, né più<br />
né meno <strong>di</strong> come uno sciamano deve avere <strong>di</strong>mestichezza con uno<br />
stile <strong>di</strong> pensiero magico per poter assolvere ai suoi compiti culturali.<br />
Alcuni UCL hanno terrorizzato e sviluppato stili <strong>di</strong> pensiero propri: così<br />
le scienze sperimentali hanno prodotto lo stile ipotetico-relativistico,<br />
efficacemente indagato da Karl Popper.<br />
Con stile <strong>di</strong> pensiero inten<strong>di</strong>amo riferirci ad abitu<strong>di</strong>ni mentali, itinerari<br />
preferenziali, meccanismi <strong>di</strong> concatenazione del pensiero caratteristici
sia <strong>di</strong> determinati in<strong>di</strong>vidui sia <strong>di</strong> UCL più o meno riconosciuti dai loro<br />
frequentatori. Non è raro il caso - e da noi in Europa ne abbiamo visto<br />
più <strong>di</strong> uno - che un determinato stile <strong>di</strong> pensiero fosse indotto o<br />
ad<strong>di</strong>rittura pilotato da gruppi <strong>di</strong> potere appoggiati a potenti ideologie o<br />
in possesso <strong>di</strong> adeguati strumenti <strong>di</strong> comunicazione. Evidente appare<br />
allora il legame tra cultura (culture) e stili <strong>di</strong> pensiero, legame più <strong>di</strong><br />
tipo sintomatico che <strong>di</strong> tipo causale, ma non per questo meno stretto.<br />
Questo legame è ovviamente funzionale alla cultura stessa, <strong>di</strong> cui<br />
costituisce per così <strong>di</strong>re il biglietto da visita; spesso però non viene<br />
riconosciuto nella sua culturalità e viene vissuto come un apriori<br />
preculturale. Vedremo tra poco vari esempi <strong>di</strong> un tale legame.<br />
Mentre nelle culture tra<strong>di</strong>zionali, ad<strong>di</strong>rittura del modello <strong>di</strong> cultura che<br />
la nostra si è costruito su basi antropologiche, sociologiche,<br />
economiche..., il rapporto <strong>di</strong> contiguità cultura-stile <strong>di</strong> pensiero ha<br />
subito pressoché ovunque un processo <strong>di</strong> fissazione ideologica che ha<br />
favorito la speciazione delle culture assicurando così alla specie<br />
biologica la necessaria variabilità interna, oggi il cammino evolutivo <strong>di</strong><br />
Homo sapiens sapiens ci pone <strong>di</strong> fronte problemi a non più risolvibili in<br />
termini culturali. Questo fatto, se adottiamo IMC, ci porta a<br />
un'evidente contrad<strong>di</strong>zione: poiché qualsiasi formulazione <strong>di</strong> quei<br />
problemi è, per IMC, culturalmente modulata, la loro soluzione lo è<br />
anch'essa, il che contrad<strong>di</strong>ce a quanto appena affermato.<br />
Si potrebbe osservare che la contrad<strong>di</strong>zione in sé non dovrebbe più<br />
preoccuparci, se facciamo valere la sospensione del principio <strong>di</strong> non<br />
contrad<strong>di</strong>zione (v. 1.2. Def.2). Ma nell'universo delle scelte effettive,<br />
concrete è perlomeno imprudente avvalersi <strong>di</strong> quella sospensione (che
ci porterebbe pericolosamente vicino a UMC); <strong>di</strong> conseguenza<br />
dobbiamo costruire, per i problemi planetari <strong>di</strong> oggi, un UCL che, pur<br />
essendo culturale come qualunque altro, lo sia però in maniera<br />
<strong>di</strong>versa da tutti gli altri. Anche qui una facile obiezione è la seguente:<br />
in quanto <strong>di</strong>stinguibili l'uno dall'altro, tutti gli UCL (tutte le culture)<br />
sono <strong>di</strong>versi tra loro, e non si vede come uno potrebbe esserlo in<br />
maniera <strong>di</strong>versa. La parola ci gioca così uno dei suoi brutti scherzi, cui<br />
è <strong>di</strong>fficile sottrarsi se si resta nel suo dominio. La parola però<br />
sappiamo che può anche salvarci da sé stessa (per esempio nell'UCL<br />
cristiano del Verbum). Così ci permette oggi, grazie al grado <strong>di</strong><br />
riflessiività raggiunto, <strong>di</strong> costruire un UCL contrapposto singolarmente<br />
a ogni altro, ma non al loro insieme; a questo UCL abbiamo dato il<br />
nome <strong>di</strong> UMC.<br />
Sprovvisto <strong>di</strong> statuto ontologico o metafisico (non avrebbe senso<br />
pre<strong>di</strong>carne l'esistenza), UMC assomiglia alla classe dei numeri<br />
complessi, la cui parte immaginaria, in<strong>di</strong>spensabile nelle fasi<br />
interme<strong>di</strong>e <strong>di</strong> calcolo, scompare nel risultato finale senza lasciare<br />
traccia. In altre parole la creazione artificiale <strong>di</strong> UMC ci rende oggi<br />
possibile un'ottica che, senza abbandonare il solido terreno della<br />
culturalità, non si leghi ideologicamente a nessuna cultura specifica.<br />
L'uomo che si solleva tirandosi su per i pie<strong>di</strong>.<br />
Abbiamo momentaneamente perso <strong>di</strong> vista gli stili <strong>di</strong> pensiero per<br />
inseguire le aporie del concetto totalizzante <strong>di</strong> cultura. È il potere<br />
attrattivo del buco nero UMC, cui IMC ci permette <strong>di</strong> sfuggire, ma mai<br />
definitivamente.
Le culture tra<strong>di</strong>zionali, si è detto, avevano negli stili <strong>di</strong> pensiero i loro<br />
sintomi qualificanti. Con ciò non si vuole affermare che tra loro<br />
incorresse un rapporto uno a uno, a ogni cultura il suo stile <strong>di</strong><br />
pensiero. Molte culture - forse tutte - erano in grado <strong>di</strong> accogliere o<br />
almeno tollerare stili <strong>di</strong>versi, anche contrapposti. Possiamo <strong>di</strong>re che<br />
ammettevano una <strong>di</strong>fferenziazione interna, così come la si osserva<br />
nelle specie biologiche: le <strong>di</strong>fferenze macroscopiche tra un levriero e<br />
un bassotto o tra pechinese e un sanbernardo possono ingannare un<br />
uomo ma non un cane. In questi casi si tratta tuttavia <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenze<br />
ottenute artificialmente me<strong>di</strong>ante incroci. Differenze ancora più<br />
vistose si osservano in natura tra femmine e maschi <strong>di</strong> una stessa<br />
specie <strong>di</strong> insetti dove quelle imitano fino all'in<strong>di</strong>stinguibilità altre<br />
specie non commestibili, ingannando gli uccelli ma non i propri<br />
maschi.<br />
La <strong>di</strong>fferenziazione interna alle singole culture ne assicura la stabilità<br />
evolutiva, contiene cioè, entro margini comparabili con la<br />
conservazione <strong>di</strong> una qualche identità specifica, le spinte <strong>di</strong>vergenti<br />
esercitate dall'emergere del caso. Questo almeno secondo l'ipotesi<br />
(neo)darwiniana, tuttora dominante negli stu<strong>di</strong> sull'evoluzione. Fin dal<br />
suo apparire a metà dell'800 il modello darwiniano ha suscitato<br />
qualche perplessità nel suo trasferimento ad altri ambiti <strong>di</strong> ricerca:<br />
economica per esempio o antropologica o politica. Tuttora il modello<br />
liberista basato sul mercato, concorrenza e profitto si appoggia al<br />
lontano prototipo che, stranamente, viene talora contestato, per altre<br />
ragioni, all'interno del modello stesso.<br />
Senza addentrarmi in questioni che superano <strong>di</strong> gran lunga le mie
competenze, do per scontata l'interpretazione che vede nella<br />
flessibilità delle culture un meccanismo atto a mantenerle in vita. Ora<br />
però sta accadendo qualcosa che mette in forse sia la sopravvivenza<br />
delle culture che il meccanismo della flessibilità interna. Quest'ultima<br />
presupponeva pur sempre la conservazione <strong>di</strong> un nucleo: la canna si<br />
piega sì, e resiste al vento, fin quando resta canna con le sue<br />
caratteristiche <strong>di</strong> flessibilità. Se le sue fibre dovessero perdere, per<br />
esempio con l'età, la loro elasticità, anche la canna, come la quercia,<br />
si spezzerebbe. Ora, nell'UCL in via <strong>di</strong> globalizzazione che stiamo<br />
vivendo, il nucleo che si vuole conservare è il capitale o meglio l'idea<br />
<strong>di</strong> capitale, giacché la sua localizzazione è oltremodo <strong>di</strong>fficile.<br />
Torneremo su questo punto quando si parlerà dello stile <strong>di</strong> pensiero<br />
politico-sociale (3.8). La flessibilità contigua a questo nucleo è la<br />
flessibilità del lavoro. Ma non basta più.<br />
Occorre la flessibilità <strong>di</strong> tutto il para<strong>di</strong>gma, capitale compreso,<br />
dobbiamo, quando serve, poter balzare in un altro flusso <strong>di</strong> pensiero,<br />
in un altro stile, adottandolo metodologicamente, senza identificarci<br />
ideologicamente con esso.<br />
Essenziale è quin<strong>di</strong> la <strong>di</strong>sponibilità mentale <strong>di</strong> più stili, nessuno dei<br />
quali è a priori quello giusto. Lo può essere in via ipotetica (v. 3.2.2.:<br />
stile ipotetico-relativistico); se nell'applicazione si <strong>di</strong>mostrasse<br />
particolarmente adatto a una certa situazione, potrà farsi<br />
temporaneamente dogmatico (v. 3.1.). Potrebbe così darsi<br />
occasionalmente la dogmatizzazione del pensiero relativistico ("tutto è<br />
relativo", da cui non dovrebbe essere <strong>di</strong>fficile uscire se si è<br />
sufficientemente allenati metaculturalmente. Voglio <strong>di</strong>re con queste
cavillosità metaculturali che i veri stili <strong>di</strong> pensiero vengono qui <strong>di</strong>stinti<br />
per poterli modulare reciprocamente. La flessibilità metaculturale,<br />
assai più ra<strong>di</strong>cale <strong>di</strong> quella concessa in regime <strong>di</strong> democrazia,<br />
raggiunge l'aporia dell'autocontrad<strong>di</strong>zione, anzi <strong>di</strong> questa aporia si fa<br />
un abito teorico, che tuttavia non viene mai indossato nella pratica.<br />
Quest'ultima infatti si manifesta sempre entro UCL limitati nello spazio<br />
e nel tempo, in una parola entro culture con<strong>di</strong>vise. IMC non si oppone<br />
alle culture con<strong>di</strong>vise (agli UCL); vive della loro pluralità, che si<br />
incarica <strong>di</strong> preservare dalla sterilità del modello unico.<br />
L'acquisizione della <strong>di</strong>sponibilità a più stili <strong>di</strong> pensiero, così come, più<br />
in generale, a un'ottica metaculturale, è un problema formativo che<br />
riteniamo non rinviabile se ci teniamo alla sopravvivenza. La rigi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />
alcuni <strong>di</strong> questi stili non tanto può essere vinta dal loro interno quanto<br />
dal confronto-modulazione con altri. Per far questo non è infatti<br />
necessario che chi pratica un certo stile ab<strong>di</strong>chi alle sue<br />
caratteristiche; importa invece che riconosca e valuti positivamente le<br />
caratteristiche <strong>di</strong> un altro. Può darsi infatti che situazioni <strong>di</strong>verse<br />
richiamino stili <strong>di</strong>versi, o che una situazione analizzabile secondo uno<br />
stile A evolva impreve<strong>di</strong>bilmente in <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> uno stile B.<br />
Anche la modulazione tra due stili (caso particolare della modulazione<br />
culturale) non è da intendersi come una semplice ibridazione o,<br />
peggio, come un compromesso, che <strong>di</strong> fatto toglie ad ambedue senza<br />
dare né all'uno né all'altro. La modulazione è chiamata piuttosto a<br />
generare una nuova entità, un nuovo stile mentale, né più né meno <strong>di</strong><br />
come una mutazione genetica propone alla selezione ambientale un<br />
nuovo organismo. Con la <strong>di</strong>fferenza essenziale che nella mutazione
genetica il principio attivo è il caso, mentre nella modulazione<br />
culturale lo è la conoscenza analitica <strong>di</strong> una situazione.<br />
Questo complesso intreccio che comprende capacità analitiche,<br />
<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> modelli, atteggiamento relativistico, tecniche <strong>di</strong><br />
modulazione ecc. non ci viene regalato alla nascita e neppure<br />
trasmesso culturalmente (le culture <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zione vi si oppongono anzi<br />
con energia); spesso non viene neppure riconosciuta, non si <strong>di</strong>ce la<br />
necessità, ma neppure l'utilità <strong>di</strong> un tale intreccio. Lo si considera<br />
ad<strong>di</strong>rittura come pericoloso per il mantenimento <strong>di</strong> valori, questi sì<br />
pericolosi se assunti acriticamente e semplicisticamente opposti ad<br />
altri, conseguenti ad altri stili <strong>di</strong> pensiero. Questo non vuol essere uno<br />
scritto polemico, uno scritto contro, ma solo un tentativo <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stinguere là dove ogni <strong>di</strong>stinzione appare preconcetta. In questo<br />
senso ho chiamato (1.2.) preconcetta anche IMC, così come considero<br />
preconcetti gli stili <strong>di</strong> pensiero e forse tutto il pensabile. La<br />
categorizzazione delle esperienze umane è ciò che ci rende possibile<br />
la comunicazione: lo sappiamo da sempre, ma solo <strong>di</strong> recente (con<br />
l'avvento della bomba H) ci siamo accorti <strong>di</strong> quanto sia pericolosa la<br />
loro reificazione (compresa quella <strong>di</strong> IMC).<br />
Stiamo oggi imparando uno stile <strong>di</strong> pensiero che riduca drasticamente<br />
la pericolosità del pensiero stesso.<br />
Non sono tanto i suoi contenuti a preoccuparci: troppo a lungo, forse,<br />
abbiamo identificato il pensiero con i suoi contenuti, accapigliandoci<br />
quando questi non coincidevano e chi pensava <strong>di</strong>versamente, in realtà<br />
pensava allo stesso modo cose <strong>di</strong>verse. E a noi interessa oggi più il<br />
modo del che cosa. Un terrorista pensa certamente cose che noi non
pensiamo, ma non è affatto da escludere che un buon citta<strong>di</strong>no<br />
europeo o americano pensi altre cose allo stesso modo <strong>di</strong> come un<br />
terrorista pensa le sue.<br />
La guerra in Iraq ha fatto molti più morti e invali<strong>di</strong> dell'attacco alle<br />
torri gemelle. Lo stile <strong>di</strong> pensiero che ha mosso ambedue è analogo, o<br />
meglio è analogo nei suoi effetti il <strong>di</strong>verso cocktail <strong>di</strong> stili che ha<br />
portato all'una o all'altro. Sarebbe bene quin<strong>di</strong> che imparassimo a<br />
valutare meglio le conseguenze degli atti derivanti dai <strong>di</strong>versi stili e<br />
dalle loro più impensabili combinazioni. Abbiamo visto che le culture,<br />
anche se non si identificano con un particolare stile, privilegiano<br />
tuttavia certi sincretismi che occorre conoscere nelle loro componenti<br />
se si vuole sostituire il <strong>di</strong>alogo allo scontro. Mi è capitato un giorno <strong>di</strong><br />
scrivere: "Conoscere vuol <strong>di</strong>re abitare lo spazio <strong>di</strong> un oggetto". Il<br />
<strong>di</strong>scorso che qui si sta facendo intende facilitare la momentanea<br />
occupazione <strong>di</strong> uno spazio che non ci appartiene, <strong>di</strong> uno stile mentale<br />
che non è il nostro.<br />
Perché interrogarci su modalità <strong>di</strong> pensiero cui neppure riconosciamo<br />
piena autonomia o univoca riconoscibilità? In altre parole, qual'è la<br />
finalità <strong>di</strong> questo scritto? Pura esercitazione accademica, convalida <strong>di</strong><br />
un'ipotesi epistemologica, indagine psicologica o antropologica?<br />
Non mi aspetto neppure una <strong>di</strong>ffusione del termine stile <strong>di</strong> pensiero,<br />
meno che mai una sua convalida tecnico-scientifica.<br />
Come per tutte le speculazioni teoriche su IMC e <strong>di</strong>ntorni, la finalità<br />
ultima è <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pratico: offrire all'orientamento promosso da IMC<br />
un'ulteriore strumento empirico <strong>di</strong> relativizzazione del pensiero che ne<br />
accresca la mobilità inter-trans-metaculturale. Di qui anche la
proposizione <strong>di</strong> esercizi per l'assunzione - transitoria - <strong>di</strong> stili <strong>di</strong><br />
pensiero più o meno estranei agli UCL abitati normalmente.<br />
È probabile che ci riesca più <strong>di</strong>fficile l'abbattimento <strong>di</strong> una casa in cui<br />
abbiamo vissuto, sia pure per poco, anziché <strong>di</strong> una casa che neppure<br />
abbiamo visitato. Molti terroristi sono tuttavia nati e cresciuti proprio<br />
nelle case che intendono abbattere. La sola conoscenza non basta,<br />
occorre uno stile <strong>di</strong> pensiero che rinunci definitivamente alla logica<br />
<strong>di</strong>sgiuntiva dell'o/o.<br />
3. <strong>Stili</strong> <strong>di</strong> pensiero (classificazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo)<br />
Entriamo qui nello specifico del nostro lavoro, ancorché, lo ripeto, non<br />
è tanto la classificazione degli stili <strong>di</strong> pensiero che ci interessa né la<br />
loro nominazione, quanto l'in<strong>di</strong>viduazione, più o meno arbitraria, <strong>di</strong><br />
modalità <strong>di</strong> approccio all'esperienza, dalla cui inesauribile<br />
ricombinazione si producono le linee <strong>di</strong>rettrici delle azioni.<br />
Altrettanto arbitrariamente, per rompere la monotonia <strong>di</strong><br />
un'elencazione lineare, ho <strong>di</strong>stinto due tipi <strong>di</strong> classificazione: <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>rizzo (3) e modale (4). La classificazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo appare più<br />
aderente alla collocazione <strong>di</strong>sciplinare degli stili considerati, la<br />
classificazione modale più aderente alla <strong>di</strong>rezionalità del pensiero.<br />
Così potremmo avere per esempio uno stile storico osservativo<br />
(cronaca), analitico (storie in senso stretto), sintetico (giu<strong>di</strong>zio<br />
storico), e ancora convergente, <strong>di</strong>vergente... Si potrebbe cioè<br />
costruire una tabella per righe e colonne, entro cui costringere con un
po' <strong>di</strong> abilità e fatica il riluttante materiale prescelto. Non tenterò<br />
neppure questa operazione se non per casi particolarmente invitanti.<br />
Per il resto potrà provarcisi il lettore, al quale chiedo comunque una<br />
buona collaborazione che compensi la labilità <strong>di</strong> questo scritto, ma<br />
soprattutto ne faccia uno strumento atto a rafforzare l'autonomia<br />
mentale dell'in<strong>di</strong>viduo.<br />
Nella mia intenzione il lettore, cioè il target del libro, è prima <strong>di</strong> tutto<br />
un operatore culturale <strong>di</strong> base (termine oggi in <strong>di</strong>suso ma che attende<br />
ancora una sua realizzazione nonché un adeguato riconoscimento<br />
istituzionale), un insegnante, quin<strong>di</strong>, della scuola dell'obbligo, ma<br />
anche un operatore <strong>di</strong> biblioteca, un me<strong>di</strong>atore interculturale,un<br />
riabilitatore ecc., chiunque sia o si senta impegnato in un lavoro <strong>di</strong><br />
formazione degli altri e <strong>di</strong> sé stesso.<br />
3.1. Stile dogmatico-assolutizzante<br />
È uno stile assai più <strong>di</strong>ffuso <strong>di</strong> quanto non si pensi. Potrebbe darsi<br />
ad<strong>di</strong>rittura che ogni forma <strong>di</strong> pensiero abbia un nucleo dogmatico. Il<br />
relativista che <strong>di</strong>ce "Tutto è relativo" è un dogmatico. L'uso, il logica,<br />
del qualificatore universale è traccia <strong>di</strong> un pregresso pensiero<br />
dogmatico. Non è neppure necessario che il dogma si trovi espresso<br />
da qualche parte. Qualsiasi giu<strong>di</strong>zio apo<strong>di</strong>ttico - "Le cose stanno così e<br />
così" - nasconde un inespresso dogma. Il realismo, l'idealismo<br />
possiamo <strong>di</strong>rli dogmatici, l'uno perché bran<strong>di</strong>sce la realtà come<br />
un'arma, l'altro perché fa lo stesso con l'idea. In un certo senso il
dogmatismo fondato su dogmi espliciti, come accade per esempio<br />
nelle gran<strong>di</strong> religioni rivelate, è il caso più banale perché <strong>di</strong>rettamente<br />
associato a un potere che ha anche gli strumenti per farsi valere.<br />
Il dogmatismo dei valori, <strong>di</strong> indubbia rilevanza psicologica, sociale e<br />
politica, è anch'esso <strong>di</strong> scarso interesse epistemologico perché<br />
altrettanto legato, seppure in maniera meno scoperta, a forme<br />
istituzionali <strong>di</strong> potere. Patria, famiglia, <strong>di</strong>ritto alla vita, <strong>di</strong>ritti dell'uomo<br />
sono <strong>di</strong> questo tipo, e il loro legame con il potere si manifesta nel<br />
momento in cui qualcuno non li con<strong>di</strong>vide come valori, e scattano<br />
misure <strong>di</strong>fensive (in realtà offensive). E che <strong>di</strong>re dei valori morali,<br />
civili, ad<strong>di</strong>rittura universali. Sono stati mai verificati nelle coscienze<br />
dei singoli? E allora a che titolo farne dei dogmi?<br />
Non è affatto mia intenzione svalutare i valori e neppure demonizzare<br />
i dogmi, in<strong>di</strong>spensabili forse ancora oggi (certamente lo sono stati per<br />
il passato) a dare un senso all'esistenza e a in<strong>di</strong>rizzarne la condotta.<br />
Molti <strong>di</strong> noi conoscono benissimo i legami tra dogmi potere eppure<br />
non si sognerebbero <strong>di</strong> contestarli. L'improvviso venir meno <strong>di</strong> quei<br />
legami creerebbe una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> instabilità in<strong>di</strong>viduale e sociale<br />
ben più pericolosa del loro permanere.<br />
Se il cammino futuro della società umana richiederà la rinuncia al<br />
pensiero dogmatico, tale rinuncia non potrà che avvenire<br />
gradualmente, per sgretolamento interno. Una qualsiasi imposizione<br />
dall'alto non farebbe che sostituire un sistema <strong>di</strong>ntorni con un altro, <strong>di</strong><br />
segno negativo rispetto al primo.<br />
Un segnale positivo <strong>di</strong> come i dogmi attuali si vengono costruendo a<br />
mano a mano per accrescimento del consenso collettivo e non per
afforzamento <strong>di</strong> un potere ci viene dalle recenti aperture <strong>di</strong> alcuni<br />
paesi a situazioni <strong>di</strong> fatto avverse alle strutture dogmatiche ere<strong>di</strong>tati<br />
dalla tra<strong>di</strong>zione. È il lento cammino verso la democrazia cui, pur con<br />
catastrofiche reci<strong>di</strong>ve, stiamo assistendo almeno dalla rivoluzione<br />
americana - seguita da quella francese - in poi. Ed è un cammino non<br />
volta al superamento del pensiero dogmatico ma una sua <strong>di</strong>versa<br />
fondazione: non più nell'inattingibilità <strong>di</strong> un potere <strong>di</strong>vino (assai<br />
spesso preso a modello <strong>di</strong> un potere secolare), bensì nella misurabilità<br />
del consenso umano. Il cammino è ancora lungo, come <strong>di</strong>mostra<br />
l'esclusione della parte <strong>di</strong> gran lunga predominante dell'umanità dalle<br />
se<strong>di</strong> dove si misura il consenso.<br />
Qualche tempo fa nell'allestire il materiale per il nostro sito<br />
www.<strong>di</strong>datticaperprogetti.it ho incluso tra i molti testi riflessivi sugli<br />
stili <strong>di</strong> pensiero il seguente, composto una ventina <strong>di</strong> anni prima:<br />
...... davanti alla legge<br />
...... davanti a Dio<br />
...... nei <strong>di</strong>ritti e nei doveri<br />
Libertà, uguaglianza, fraternità.<br />
Parità dei sessi. Diritto alla vita.<br />
Unicità della specie umana.<br />
TUTTI GLI UOMINI SONO UGUALI<br />
Chi ha detto queste cose?<br />
Le hanno dette degli uomini.<br />
Che valore hanno?
Il valore che gli uomini sapranno dargli.<br />
Il titolo e la parte sinistra dello scritto fanno uso <strong>di</strong> uno stile espositivo<br />
dogmatico: frasi brevi, apo<strong>di</strong>ttiche, slogans. Nella parte destra<br />
compaiono dei punti interrogativi e anche le risposte, più che<br />
chiudere, rimandano alla responsabilità umana e al futuro. Vengono<br />
quin<strong>di</strong> messi a confronto <strong>di</strong>retto due stili <strong>di</strong> pensiero senza tuttavia<br />
che vi sia contrapposizione. Le proposizioni della parte sinistra<br />
vengono semplicemente localizzate - negli UCL che le hanno espresse<br />
-, e la loro vali<strong>di</strong>tà non affermata né negata, bensì anch'essa<br />
localizzata e affidata alla responsabilità degli uomini (parte destra).<br />
Il proce<strong>di</strong>mento si iscrive puntualmente nell'orizzonte metodologico <strong>di</strong><br />
IMC e mostra nel contempo un esempio <strong>di</strong> modulazione culturale tra<br />
stili <strong>di</strong> pensiero apparentemente oppositivi: lo stile dogmatico non<br />
viene intaccato dallo stile relativistico, dalla loro modulazione emerge<br />
invece un nuovo stile, che abbiamo chiamato metaculturale.<br />
Lo stesso progetto......... presenta anche un altro testo, che già dal<br />
titolo appare in contrad<strong>di</strong>zione con il precedente:<br />
GLI UOMINI NON SONO TUTTI UGUALI<br />
Gli uomini non sono tutti uguali.<br />
A parte le <strong>di</strong>fferenze tra uomo e donna e quelle tra in<strong>di</strong>vidui, per cui<br />
riconosciamo Mario da Giovanni, Elena da Rosaria, gli essere umani si<br />
<strong>di</strong>stinguono anche per caratteristiche comuni a gran<strong>di</strong><br />
raggruppamenti, popolazioni, razze.
Di queste caratteristiche alcune sono evidenti a chi guarda: per<br />
esempio il colore della pelle o la forma degli occhi o del naso. Su altre<br />
è più <strong>di</strong>fficile pronunciarsi, anche se è altrettanto evidente che ci<br />
sono: <strong>di</strong>fferenze nel modo <strong>di</strong> pensare, <strong>di</strong> rapportarsi alle cose e<br />
all'ambiente, <strong>di</strong>fferenze che possiamo <strong>di</strong>re culturali.<br />
Per esempio gli uomini dalla pelle chiara hanno sviluppato una cultura<br />
che tra l'uomo e l'ambiente inserisce la tecnica, oggi presente in<br />
forme sempre più complesse e sofisticate.<br />
Gli uomini dalla pelle scura hanno invece mantenuto con l'ambiente<br />
un rapporto più <strong>di</strong>retto, e anche la loro tecnica è al servizio <strong>di</strong> questo<br />
rapporto.<br />
Sono tuttavia oggi in corso dei cambiamenti culturali per cui molti <strong>di</strong><br />
coloro che hanno conservato con la natura un rapporto <strong>di</strong>retto<br />
tendono a modernizzarlo in senso tecnologico, mentre alcuni degli<br />
appartenenti alla cultura tecnologica parlano <strong>di</strong> ritorno alla natura e <strong>di</strong><br />
salvaguar<strong>di</strong>a dell'ambiente.<br />
Se questa trasformazione portasse con sé un cambiamento <strong>di</strong> colore<br />
della pelle, sarebbe come <strong>di</strong>re che noi bianchi ci stiamo scurendo<br />
mentre i neri si stanno visibilmente schiarendo.<br />
Anche qui la proposizione espressa nel titolo poi subito ripetuta a<br />
inizio del testo suona dogmatica (vedremo tra poco perché). Ciò che<br />
segue, tuttavia, proprio perché cerca <strong>di</strong> giustificare quella<br />
proposizione argomentando e adducendo esempi, sembra propendere<br />
piuttosto per uno stile meno rigido, quasi relativistico-culturale. Al<br />
centro del testo la relazione istituita tra il colore della pelle e il
apporto con l'ambiente da un lato e con la tecnologia dall'altro<br />
produce temporaneamente l'impressione <strong>di</strong> un certo determinismo<br />
(siamo <strong>di</strong> nuovo vicini allo stile dogmatico); subito dopo però questa<br />
impressione viene cancellata dalla constatazione che sono in corso dei<br />
cambiamenti culturali che rimettono in <strong>di</strong>scussione quanto affermato<br />
(o meglio negato) dal titolo: se gli uomini sono in grado (tutti, non<br />
solo alcuni) <strong>di</strong> produrre cambiamenti così rilevanti, vuol <strong>di</strong>re che<br />
sanno controllare la loro variabilità, sono quin<strong>di</strong>, almeno da questo<br />
punto <strong>di</strong> vista, intercambiabili, quin<strong>di</strong> uguali fra <strong>di</strong> loro. Siamo<br />
all'opposto <strong>di</strong> quanto si voleva <strong>di</strong>mostrare all'inizio. L'uso, fantastico e<br />
metaforico, del colore rafforza l'idea del ribaltamento.<br />
Il proce<strong>di</strong>mento metaculturale è qui meno scoperto che nel caso<br />
precedente. La proposizione <strong>di</strong>scussa viene per prima cosa riba<strong>di</strong>ta<br />
attraverso la ripetizione (ma il lettore non ne esce più convinto),<br />
quin<strong>di</strong> lentamente ruotata intorno al proprio asse fino a riproporla con<br />
gli estremi scambiati: abbiamo ancora il bianco e il nero - cioè la non<br />
uguaglianza - ma con i termini invertiti. Nel passaggio dal bianco al<br />
nero e viceversa vi sarà stato almeno un punto in cui il colore sarà<br />
stato lo stesso per ambedue: percorsi simmetrici intorno a<br />
un'uguaglianza.<br />
Doman<strong>di</strong>amoci ora: come mai proposizioni come "Tutti gli uomini<br />
sono uguali" e simili suonano dogmatiche?<br />
Forse a causa del quantificatore universale "tutti"? Ma una frasi tipo<br />
"Il cavallo è un mammifero" - che non contiene quantificatori - suona<br />
meno dogmatica?<br />
Ho evidenziato suona, suonano perché non possiamo affermare che
chi pronuncia frasi del genere lo faccia con intenti dogmatici e non<br />
solo per ossequio alle strutture della lingua. Sono queste che<br />
rispecchiano, se usate senza particolari precauzioni, uno stile <strong>di</strong><br />
pensiero dogmatico non necessariamente con<strong>di</strong>viso da chi se ne<br />
serve. An<strong>di</strong>amo avanti: "Mario è buono" - chi lo <strong>di</strong>ce ne è convinto e<br />
vuole convincere anche qualcun altro; non relativizza ("Per me Mario<br />
è buono") ma assolutizza. E come fa? Attraverso l'uso assolutizzante<br />
del verbo essere. Nella sua funzione <strong>di</strong> ausiliario questo verbo appare<br />
innocuo ("Ieri siamo andati al cinema"). Già usato come copula buona<br />
parte della sua innocenza va perduta.<br />
Mario è buono<br />
Mario è generoso<br />
Mario è un ragazzo<br />
......<br />
Mario è<br />
Presa da solo, il verbo essere perde le sue funzioni grammaticali<br />
ausiliarie per assumere la più forte delle funzioni semantiche, quella <strong>di</strong><br />
certificazione <strong>di</strong> esistenza. Di più, non si limita a certificare (come<br />
sarebbe nell'espressione "Mario è esistente"), ma fonda, per così <strong>di</strong>re,<br />
il concetto stesso <strong>di</strong> esistenza. Doveva averlo ben presente Anselmo<br />
<strong>di</strong> Aosta, quando su questa prepotente funzione semantica basò una<br />
famosa prova ontologica dell'esistenza <strong>di</strong> Dio. Eccola in una versione<br />
un poco ammodernata:<br />
Definizione: Dio è l'essere perfettissimo <strong>di</strong> cui non si può pensare<br />
niente <strong>di</strong> più perfetto.<br />
Dimostrazione per assurdo: Se Dio, così definito, non esistesse,
sarebbe possibile pensare un essere altrettanto perfetto con in più la<br />
perfezione dell'esistenza. Ne consegue che Dio non sarebbe l'essere<br />
perfettissimo <strong>di</strong> cui non si può pensare niente <strong>di</strong> più perfetto. Il che<br />
contrad<strong>di</strong>rebbe la sua definizione. Quin<strong>di</strong>: Dio esiste.<br />
La prova ontologica è stata ripetutamente confutata nel corso dei<br />
secoli e non è certo mia intenzione né riproporla né tantomeno<br />
riproporne la confutazione. Se l'ho citata è solo per mostrare la<br />
funzione <strong>di</strong> reificazione dogmatica del verbo essere: la stessa<br />
definizione sopra riportata è infatti garantita unicamente da quell'"è",<br />
che <strong>di</strong> fatto non garantisce ma solo afferma (altri potrebbe sostituirlo<br />
con "sembra" o con "viene definito da alcuni" o con "non è").<br />
Ma non si esaurisce con il verbo essere la funzione dogmatizzante del<br />
linguaggio verbale. Quando identifichiamo un certo animale come<br />
"cavallo" compiamo un'operazione del tipo x è un y. La reificazione<br />
iniziata con il verbo essere si compie nel concetto reificato - nell'idea -<br />
<strong>di</strong> cavallo.<br />
È un vecchio <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> cui ci sono ben noti due parlanti illustri,<br />
Platone e Aristotele. Anche in questo caso non ho né la competenza<br />
né le intenzioni <strong>di</strong> intromettermi nell'antica querelle <strong>di</strong> cui mi basta<br />
segnalare la parte <strong>di</strong> responsabilità spettante al linguaggio. Il concetto<br />
<strong>di</strong> cavallo è infatti tributario del pensiero scientifico che lo subor<strong>di</strong>na il<br />
concetto <strong>di</strong> specie animale, che a sua volta riceve il suo senso dal<br />
sistema classificatorio in cui è inserito. Oggi peraltro il concetto <strong>di</strong><br />
specie come entità reale è messo fortemente in dubbio da quello<br />
stesso stile <strong>di</strong> pensiero che l'aveva istituito. Tuttavia non si vede<br />
perché a essere posto sotto inchiesta debba essere significato della
parola cavallo, quando questo significato continua come prima a<br />
essere sufficientemente chiaro per le nostre necessità<br />
comunicazionali.<br />
Vedremo meglio in seguito come il pensiero dogmatico non tanto va<br />
combattuto, se non forse in casi estremi (quando cioè viene bran<strong>di</strong>to<br />
come un'arma contro), quanto va riconosciuto riflessivamente da chi<br />
lo professa e, se il caso lo richiede, mantenuto entro i confini <strong>di</strong> un<br />
UCL anch'esso riconosciuto e <strong>di</strong>chiarato.<br />
Certo, è molto <strong>di</strong>fficile e anche improbabile che chi non avverte le<br />
implicazioni dogmatiche della parola acceda a stili <strong>di</strong> pensiero <strong>di</strong>versi<br />
da quello qui richiamato, a meno che non sia stato formato a una<br />
pluralità <strong>di</strong> stili e alla conseguente relativizzazione <strong>di</strong> ciascuno.<br />
Può apparire un controsenso parlare <strong>di</strong> relativizzazione dello stile<br />
dogmatico, ed effettivamente l'espressione ha un senso soltanto se si<br />
adotta IMC: in altre parole, lo stile metaculturale (<strong>di</strong> cui sarà<br />
questione tra poco) è lo strumento metodologico che, senza opporsi<br />
allo stile dogmatico, lo ammorbi<strong>di</strong>sce favorendo, quando si<br />
fronteggino posizioni dogmatiche apparentemente inconciliabili, la<br />
trasformazione dello scontro in <strong>di</strong>alogo, la reciproca aggressione in<br />
ricerca <strong>di</strong> una reciproca modulazione culturale.<br />
3.2. Stile assiomatico-deduttivo. Generalità<br />
L'ho <strong>di</strong>stinto dallo stile "dogmatico", cui peraltro assomiglia, perché fa<br />
<strong>di</strong>pendere la sua assolutezza da proposizioni che si presumono
autoevidenti - cioè non bisognose <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>mostrate - o che<br />
vengono, più o meno arbitrariamente, assunte come fondanti. In<br />
quest'ultimo caso la fondatezza <strong>di</strong> quelle proposizioni viene, per così<br />
<strong>di</strong>re, <strong>di</strong>mostrata da ciò che ne consegue.<br />
La problematica <strong>di</strong> questo stile non risiede solo nelle proposizioni<br />
fondanti (assiomi o postulati che siano), ma anche nelle operazioni<br />
che su esse si compiono. Che vuol <strong>di</strong>re che da certe proposizioni se ne<br />
deducono altre e da queste altre ancora e così via, presumibilmente<br />
senza fine? E, se le prime le abbiamo assunte come vere, come fa la<br />
loro verità a trasferirsi anche in quelle dedotte? Che garanzie abbiamo<br />
che questa proprietà (<strong>di</strong> essere vere o giuste) si conservi anche nelle<br />
proposizioni successive?<br />
Dobbiamo avere a <strong>di</strong>sposizione delle procedure che ci offrano,<br />
appunto, quelle garanzie. E non ci resta che fidarci sia delle une che<br />
delle altre. E perché dovremmo fidarci? Perché sono ragionevoli,<br />
frutto del nostro organo pensante e non abbiamo altro appiglio se non<br />
questo. Qui si manifesta la <strong>di</strong>fferenza dallo stile dogmatico, che non<br />
ha bisogno <strong>di</strong> proposizioni fondanti né <strong>di</strong> procedure affidabili per il<br />
semplice fatto che è garante <strong>di</strong> sé stesso.<br />
Ma se il pensiero assiomatico-deduttivo ha bisogno <strong>di</strong> essere garantito<br />
dalla ragione, è necessario che <strong>di</strong> questa ragione noi conosciamo il<br />
funzionamento e anche che sappiamo giu<strong>di</strong>carne l'affidabilità. Eccoci<br />
invece <strong>di</strong> nuovo pericolosamente vicini allo stile <strong>di</strong> pensiero<br />
dogmatico, in quanto avremmo a che fare con un'entità che<br />
garantisce sé stessa.<br />
Dire che siamo noi e garantire della ragione non è che un facile gioco
<strong>di</strong> parole, giacché per farlo non possiamo che servirci della ragione<br />
stessa. È la fede, dogmatica anch'essa, che il secolo dei lumi aveva in<br />
questa particolare facoltà della nostra specie: <strong>di</strong> raggiungere,<br />
rispecchiare, motivare la realtà attraverso il pensiero.<br />
In questo tentativo <strong>di</strong> analisi il punto non è comunque <strong>di</strong>mostrare una<br />
qualche superiorità <strong>di</strong> uno stile <strong>di</strong> pensiero su un altro, quin<strong>di</strong> neppure<br />
dello stile assiomatico-deduttivo su quella dogmatico. Mi preme<br />
piuttosto ricercare per ciascuno stile qualcosa che lo caratterizzi e lo<br />
<strong>di</strong>versifichi dagli altri. Nel nostro caso l'elemento qualificante mi<br />
sembra essere il ricorso alla ragione, assunta dogmaticamente come<br />
garanzia, se non <strong>di</strong> verità, almeno <strong>di</strong> affidabilità entro i limiti che volta<br />
per volta ci prefissiamo.<br />
Non posso tuttavia fare a meno <strong>di</strong> ripetere quanto già detto, che cioè<br />
anche lo stile assiomatico-deduttivo non si presenta allo stato puro<br />
che all'interno <strong>di</strong> particolari <strong>di</strong>scipline (delle quali si <strong>di</strong>scorrerà tra<br />
poco), mentre in linea generale lo troviamo più o meno contaminato<br />
con altri stili.<br />
Anzi - ma anche questo è stato già detto - lo stile assiomatico-<br />
deduttivo è, come gli altri, un'astrazione, utile forse a delineare una<br />
fisiognomica del pensiero che lo aiuti a comprendere sé stesso,<br />
un'astrazione peraltro sprovvista <strong>di</strong> consistenza reale e <strong>di</strong>mostrabile.<br />
Assai più reali e consistenti, perché descrivibili in termini procedurali,<br />
sono alcune sottospecificazioni <strong>di</strong> questo stile, cui vogliamo ora<br />
rivolgere la nostra attenzione.
3.2.1. Stile logico-matematico<br />
Il termine è impreciso giacché logica e matematica, nonostante le<br />
molte affinità, non coincidono. Diversi sono tra l'altro i rapporti tra<br />
struttura e semantica, <strong>di</strong>versi anche gli elementi base, proposizioni<br />
nell'un caso (o loro equivalenti formali), numeri (o loro simboli)<br />
nell'altro. Non è nostro compito tuttavia (né ne avremmo la capacità)<br />
<strong>di</strong> addentrarci nello specifico <strong>di</strong> queste aree <strong>di</strong>sciplinari, ma solo <strong>di</strong><br />
esplorarne la periferia in quello che abbiamo chiamato stile <strong>di</strong><br />
pensiero.<br />
Che cosa si intende comunemente per pensiero logico?<br />
Un modo <strong>di</strong> pensare che da premesse che si presume siano con<strong>di</strong>vise<br />
sappia desumere delle conseguenze non evidenti a prima vista.<br />
E come fa il pensiero logico a desumere, cioè a proporsi come<br />
strumento <strong>di</strong> verità, sempreché siano accettate le premesse (struttura<br />
del se... allora)? Non basta infatti l'accettazione <strong>di</strong> queste ultime,<br />
serve l'incontrovertibilità delle procedure deduttive, sulla quale deve<br />
pienamente concordare anche l'interlocutore, quale che esso sia. Se<br />
sull'accettabilità delle premesse si può <strong>di</strong>scutere, non è ammesso farlo<br />
sulle procedure deduttive. Già Aristotele con la sua trattazione del<br />
sillogismo aveva in<strong>di</strong>cato un prototipo:<br />
- Tutti gli uomini sono mortali.<br />
- Socrate è un uomo.<br />
- Socrate è mortale.<br />
Non si scappa: la conclusione appare necessaria, inelu<strong>di</strong>bile, una volta<br />
ammesse le prime due proposizioni (certo la prima potrebbe essere
falsa e Socrate essere un gatto, ma noi abbiamo già ammesso che<br />
siano vere...). Ma non abbiamo ancora raggiunto il termine ultimo<br />
delle premesse. Dobbiamo infatti credere in una qualifica che<br />
<strong>di</strong>stingua proposizioni vere da proposizioni false e non ammetta per<br />
esempio che se ne possono dare <strong>di</strong> vere e false allo stesso tempo.<br />
Non basta: per proposizione vera dobbiamo intendere che essa<br />
corrisponda a una situazione verificabile nella realtà, il che implica<br />
l'esistenza <strong>di</strong> qualcosa che sia o sia pensabile come reale ecc.<br />
In altre parole non possiamo essere certi che la catena delle premesse<br />
sia finita e ci permetta <strong>di</strong> dare al pensiero logico una fondazione<br />
assoluta. D'altra parte anche il ragionamento qui condotto e <strong>di</strong> tipo<br />
logico-deduttivo, poggia quin<strong>di</strong> sulle sabbie mobili e non garantisce <strong>di</strong><br />
fatto nulla.<br />
Non per niente i logici <strong>di</strong> professione hanno abbandonato ben presto<br />
la <strong>di</strong>scussione sui fondamenti per concentrarsi sulle operazioni logiche<br />
che almeno offrissero delle garanzie da un certo punto in poi (se...<br />
allora). Paradossalmente, una volta abbandonato il terreno delle<br />
premesse (compreso l'ancoraggio a una realtà esterna al pensiero<br />
stesso) la logica si è trovata nella scomoda con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> doversi<br />
giustificare da sé stessa, come uno che voglia tirarsi su per i pie<strong>di</strong>.<br />
Eppure è proprio in questa con<strong>di</strong>zione irrelata che il pensiero logico ha<br />
dato il meglio <strong>di</strong> sé costruendo (dalla fine dell'800 in poi) il superbo<br />
e<strong>di</strong>ficio della logica formale, destinato tuttavia a deflagrare dal suo<br />
interno, come ha <strong>di</strong>mostrato Kurt Gödel all'inizio degli anni 30 del<br />
secolo scorso. Da allora in poi la logica tende a una parcellizzazione<br />
tematica: logiche modali (possibilità, probabilità...), deboli, minimali,
temporali ecc. Il principio più resistente <strong>di</strong> tutti - il principio <strong>di</strong> non<br />
contrad<strong>di</strong>zione - cade tuttavia anch'esso con IMC (che tuttavia non<br />
aspira a uno statuto logico anche se avrebbe molto da guadagnare da<br />
una logica ad hoc).<br />
Ho già accennato all'affinità - non coincidenza - tra il pensiero logico e<br />
quello matematico. Spesso l'uno è stato considerato modello<br />
dell'altro, con alterne vicende.<br />
Qui come là si pone il problema della fondazione: lì il <strong>di</strong>lemma<br />
vero/falso (più tar<strong>di</strong> sostituito da <strong>di</strong>mostrabile/in<strong>di</strong>mostrabile), qui il<br />
concetto <strong>di</strong> numero. Già con Pitagora (e forse anche prima <strong>di</strong> lui) il<br />
numero si era emancipato dalla geometria - cioè dall'identificazione<br />
con un'unità <strong>di</strong> misura spaziale - per assumere una veste concettuale<br />
autonoma: il numero come ente pensabile per via <strong>di</strong>retta.<br />
Quanto questo ente sia problematico, anche per un bambino, lo<br />
<strong>di</strong>mostra la seguente storiella, costruita appunto su misura per una<br />
classe <strong>di</strong> scuola elementare:<br />
Carletto va maluccio in aritmetica.<br />
Ha delle strane idee sui numeri.<br />
Un giorno la maestra gli chiede: "Quanto fa 1+1?" e Carletto, pronto:<br />
"Uno!".<br />
"Ma che <strong>di</strong>ci?" fa la maestra.<br />
"Dico quel che <strong>di</strong>co" replica Carletto, poi prende una penna, la mostra<br />
la maestra le chiede: "Quante penne ve<strong>di</strong>?"<br />
"Una" <strong>di</strong>ce la maestra.
E Carletto, rivolto alla classe: "Quante ne vedete?"<br />
"Una" rispondono tutti in coro.<br />
"Ecco, 1+1=1".<br />
"Ma - gridano tutti - è sempre la stessa penna che ci hai mostrato!"<br />
E la maestra: "Ci dovevi mostrare due penne <strong>di</strong>verse!"<br />
E Carletto: "Ma nessuno mi ha mai detto che quando faccio 1+1 l'uno<br />
<strong>di</strong> sinistra è <strong>di</strong>verso dall'uno <strong>di</strong> destra!"<br />
L'argomentazione <strong>di</strong> Carletto prende <strong>di</strong> mira il concetto stesso <strong>di</strong><br />
numero e sembra fenderlo in due: da un lato il numero che entra<br />
concretamente in giochi in una qualsiasi operazione matematica,<br />
dall'altro il campione, il prototipo uno e in<strong>di</strong>visibile, l'idea platonica <strong>di</strong><br />
numero con il quale nessuna operazione è possibile. Ma gli hanno mai<br />
parlato, a Carletto, <strong>di</strong> queste due classi <strong>di</strong> numeri: i prototipi e i loro<br />
rappresentanti?<br />
Se poi teniamo presente che i numeri cosiddetti naturali (0,1,2...) ci<br />
vengono presentati dalla logica come classi <strong>di</strong> classi, cioè come<br />
rappresentanti <strong>di</strong> classi equipotenti (aventi cioè lo stesso numero <strong>di</strong><br />
elementi), abbiamo che il concetto <strong>di</strong> numero rischia <strong>di</strong> fendersi in tre:<br />
i numeri come prototipi, come classi <strong>di</strong> classi, come rappresentanti dei<br />
prototipi. Ed è proprio questo che Carletto vuol <strong>di</strong>re, prima mostrando<br />
la penna, poi gli uni dell'operazione 1+1=2, poi ancora rinviandoli<br />
all'idea una e in<strong>di</strong>visibile <strong>di</strong> UNO. Ma se un oggetto in apparenza così<br />
coerente e unitario come il numero 1 nasconde tre <strong>di</strong>verse nature, chi<br />
ci garantisce che non ne nasconda delle altre ancora e che l'accetta <strong>di</strong><br />
Carlo non finirà per polverizzarlo?
"Ma almeno lo sai che cosa sono i numeri?" gli domanda un giorno la<br />
maestra.<br />
"Sì, quelli che si contano."<br />
"Cioè?"<br />
"Bè... tre caramelle, tre canguri, tre aeroplani..."<br />
"E che cosa hanno in comune tre caramelle, tre canguri, tre<br />
aeroplani...?"<br />
"Proprio niente!"<br />
Non solo Carletto con la matematica ci va d'accordo, sembra anzi nato<br />
apposta per fare il matematico; o forse è solamente un ragazzo che<br />
sa ragionare. Qui la sua polemica si fa ancora più sottile.<br />
Provate a chiedere a un bambino che recita la filastrocca dei numeri<br />
che cosa sta contando: nel novanta per cento dei casi vi risponderà<br />
che sta contando i numeri. Provate allora a farlo contare da 6 a 10,<br />
poi ci penserà su e si correggerà. Questo perché si sarà accorto che i<br />
numeri, al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> ciò che significano come numeri, sono anche degli<br />
oggetti, degli elementi <strong>di</strong> una classe numerabile, il cui numero<br />
rappresentativo non è detto coincida con alcun elemento della classe.<br />
Cosicché Carletto sembra ritenere che i numeri sono degli oggetti che<br />
si possono contare come caramelle, i canguri, gli aeroplani; oggetti<br />
quin<strong>di</strong> come qualsiasi altro. E allora si capisce bene la sua risposta<br />
all'ultima domanda: in quanto oggetti, i numeri non hanno niente in<br />
comune con caramelle, canguri e aeroplani. "Ma come? - potrebbe<br />
continuare la maestra - non ti accorgi che hanno in comune il numero
tre?" La maestra della storiella comunque tace per prudenza o il<br />
narratore ha inteso <strong>di</strong> non farle fare una brutta figura. Per noi si<br />
aprono a questo punto almeno due itinerari. Proviamo a seguirli per<br />
un certo tratto.
Itinerario 1<br />
Possiamo immaginare che<br />
Carletto avrebbe replicato: "Ma<br />
come mai hanno in comune un<br />
numero e non una caramella, un<br />
canguro e non un aeroplano?" E<br />
questa sua obiezione non<br />
sembra del tutto infondata. Se<br />
infatti consideriamo<br />
separatamente le classi<br />
caramelle, canguri, aeroplani,<br />
numeri, ve<strong>di</strong>amo che queste<br />
classi possono avere in comune<br />
soltanto una proprietà<br />
rappresentata dagli elementi<br />
della classe numeri e non da<br />
quelli delle altre tre. La classe<br />
numeri è quin<strong>di</strong> una classe <strong>di</strong><br />
oggetti che al tempo stesso è<br />
una classe <strong>di</strong> proprietà. Le due<br />
classi coincidono oppure no? Il<br />
problema <strong>di</strong> Carletto sembra<br />
essere questo: quando parliamo<br />
<strong>di</strong> numeri sappiamo <strong>di</strong> che cosa<br />
stiamo parlando?<br />
Ma è importante saperlo?
Itinerario 2<br />
Ciò che tre caramelle, tre...<br />
hanno in comune non è alcun<br />
oggetto; in altre parole le<br />
quattro classi (caramelle,<br />
canguri, aeroplani e numeri)<br />
sono <strong>di</strong>sgiunte, non hanno cioè<br />
elementi comuni. Il che vuol<br />
<strong>di</strong>re che anche il 3 che le<br />
designa - le designa la potenza -<br />
non è un elemento della quarta<br />
classe, ma qualcosa che più o<br />
meno per caso ha lo stesso<br />
nome. Ma allora i numeri sono<br />
degli oggetti o sono<br />
qualcos'altro? "Dipende da come<br />
ce ne serviamo" risponderebbe<br />
Carletto.<br />
Ma la sua precedente risposta è<br />
insi<strong>di</strong>osa anche per un altro<br />
verso: se consideriamo i numeri<br />
come una proprietà, è evidente<br />
che caramelle, canguri e<br />
aeroplani non hanno "proprio<br />
niente" in comune (perlomeno<br />
nei normali contesti osservativi).<br />
Hanno qualcosa in comune solo<br />
se costitutivi <strong>di</strong> classi (o insiemi)<br />
equipotenti.<br />
I numeri sono quin<strong>di</strong> in questo<br />
caso delle proprietà che non<br />
affliggono gli elementi nella loro<br />
singolarità e nemmeno come<br />
insiemi, ma solo le classi, una<br />
volta che se ne siano contati gli<br />
elementi, quali che siano.<br />
Carletto sembra quin<strong>di</strong> avere<br />
ragione se le classi tre<br />
caramelle, tre... vengono<br />
considerate per i loro elementi.<br />
Ma neppure la maestra avrebbe<br />
torto se avesse insistito: lei<br />
infatti si sarebbe riferita alle<br />
classi <strong>di</strong> potenza 3.
I concetti <strong>di</strong> classe, insieme, elemento risultano fortemente astratti in<br />
questo loro particolare uso: il sospetto è che tale astrazione sia<br />
in<strong>di</strong>spensabile per dare una spiegazione, uno statuto logico al<br />
concetto <strong>di</strong> numero, ma che nell'uso pratico, quoti<strong>di</strong>ano, non ci serve.<br />
È anche poco probabile che la psicogenesi (costruzione psicologica)<br />
del numero passi per questi concetti, che restano quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> proprietà e<br />
<strong>di</strong> uso esclusivo dei matematici e dei logici.<br />
Questi dal canto loro hanno avuto il loro bel daffare per definire<br />
l'insieme dei numeri naturali (0,1,2...). Lo stile <strong>di</strong> pensiero <strong>di</strong> cui ci<br />
sono serviti è quello assiomatico-deduttivo cui abbiamo già<br />
accennato. Tra i vari gruppi <strong>di</strong> assiomi ideati a questo scopo, uno dei<br />
più noti anche fuori dall'ambito specifico è il gruppo degli Assiomi <strong>di</strong><br />
Peano, <strong>di</strong> cui ecco una versione informale:<br />
1. Esiste un numero naturale, 0.<br />
2. Ogni numero naturale ha un numero naturale successore.<br />
3. Numeri <strong>di</strong>versi hanno successori <strong>di</strong>versi.<br />
4. 0 non è il successore <strong>di</strong> alcun numero naturale.<br />
5. Ogni insieme <strong>di</strong> numeri naturali che contenga lo 0 e il successore <strong>di</strong><br />
ogni proprio elemento coincide con l'intero insieme dei numeri<br />
naturali.<br />
Gli ingre<strong>di</strong>enti <strong>di</strong> questi assiomi sono manifestamente tre:<br />
- il concetto <strong>di</strong> numero naturale (N)<br />
- lo 0<br />
- il concetto <strong>di</strong> successore (S).<br />
A ben guardare, a questa terna <strong>di</strong> concetti (anche lo 0 lo è) andrebbe<br />
aggiunto il pre<strong>di</strong>cato che dallo 0 viene trasmesso a tutti i suoi
<strong>di</strong>scendenti: il pre<strong>di</strong>cato - platonico, ontologico - dell'esistenza.<br />
Si tratta, per Peano e i matematici in genere, <strong>di</strong> assiomi, proposizioni,<br />
cioè, evidenti per sé stesse, refrattarie a ogni procedura <strong>di</strong>mostrativa.<br />
Già molti secoli prima il matematico Euclide aveva proposto un<br />
analogo gruppo <strong>di</strong> postulati a fondamento della geometria. Si vide in<br />
seguito che la non osservanza <strong>di</strong> anche un solo <strong>di</strong> questi postulati non<br />
tanto valse ad abbattere l'e<strong>di</strong>ficio geometrico già costruito quanto<br />
permise la costruzione <strong>di</strong> geometrie <strong>di</strong>verse da quella indagata da<br />
Euclide, Pitagora e gli altri. Così anche la matematica dei numeri<br />
naturali ha generato, con la messa in parentesi <strong>di</strong> qualcuno degli<br />
assiomi fondanti, altri tipi <strong>di</strong> numeri (razionali, irrazionali, reali,<br />
immaginari, complessi), la cui esistenza appare sempre meno<br />
evidente. Il caso finora estremo è dato dal numero i (=√-1), cui non<br />
si saprebbe attribuire alcuna consistenza ontologica pur essendo la<br />
sua presenza, nell'esercizio del calcolo, insostituibile.<br />
Il più tenace degli enti matematici sembra essere lo 0, storicamente<br />
tra gli ultimi arrivati, almeno in Occidente (né i greci né i romani se ne<br />
servivano); non per nulla Peano lo cita nel primo dei suoi assiomi.<br />
Eppure la sua natura <strong>di</strong> numero non ha affatto l'evidenza che Peano<br />
forse gli attribuiva. Se per esempio consideriamo il numero come una<br />
proprietà delle classi <strong>di</strong> oggetti, deve trattarsi <strong>di</strong> una proprietà assai<br />
strana, <strong>di</strong>versa da quella <strong>di</strong> tutti gli altri numeri. Infatti un numero<br />
qualsiasi che non sia lo 0 non inficia le altre proprietà della classe:<br />
1,2...n caramelle mantengono la loro <strong>di</strong>stinguibilità da 1,2...n canguri<br />
o aeroplani, mentre 0 caramelle sono in<strong>di</strong>stinguibili da 0 canguri o<br />
aeroplani o qualsiasi altra cosa. Lo 0 cancella tutte le altre proprietà
tra cui anche quella <strong>di</strong> essere oggetti o enti o ciò che si vuole.<br />
Possiamo vedere nello 0 una singolarità, un buco nero nel sistema<br />
numerico (e non solo dei numeri naturali). Nella terminologia <strong>di</strong> IMC<br />
lo 0 potrebbe designare numericamente UMC. Ma ve<strong>di</strong>amo che ne<br />
pensa Carletto.<br />
La maestra vuole spiegare il numero 0. Pensa <strong>di</strong> partire da un<br />
esempio. Chiama Carletto e gli domanda:<br />
"Carletto, secondo te, quanti rinoceronti ci sono in quest'aula?"<br />
Carletto: "Non so, ci devo pensare."<br />
Risata generale.<br />
La maestra: "Ma che c'è da pensare?"<br />
Carletto: "Per essere sicuro che non ci sono rinoceronti in quest'aula,<br />
dovrei sapere dove sono tutti i rinoceronti che esistono."<br />
Altra risata generale.<br />
"Ma che vuoi fare il furbo con me?" <strong>di</strong>ce la maestra, seccata.<br />
Carletto: "No, cerco solo <strong>di</strong> capire."<br />
La maestra: "E allora pensa ai tuoi rinoceronti e lasciaci lavorare."<br />
Alla fine della lezione la maestra vuole far pace con Carletto gli<br />
domanda sorridendo:<br />
"Beh, lo sai adesso dove stanno tutti i rinoceronti che esistono?"<br />
Carletto: "Sì, lo so."<br />
La maestra, sempre sorridendo: "E dove?"<br />
Carletto: "Fuori da quest'aula."<br />
Per Carletto il concetto <strong>di</strong> zero non è affatto intuitivo; "ci devo
pensare", <strong>di</strong>ce. Eppure lo vede bene che non ci sono rinoceronti in<br />
classe... Ma questa constatazione solo negativa non gli basta: lo zero<br />
da solo non è sufficientemente informativo, non ammette riferimenti<br />
concreti, quin<strong>di</strong> come possiamo usarlo per affermare qualcosa sui<br />
rinoceronti? E Carletto inverte la domanda, cercando informazioni<br />
positive sui rinoceronti.<br />
Ma forse sta scherzando, è in vena <strong>di</strong> battute... La sua risposta alla<br />
risata della classe e all'insegnante infasti<strong>di</strong>ta sembra invece essere<br />
molto precisa: "Cerco <strong>di</strong> capire".<br />
La soluzione che egli trova infatti alla fine dell'ora ne è una prova.<br />
Non solo riesce ad esprimere l'assenza dei rinoceronti nell'aula (lo<br />
zerorinoceronti) in una forma positiva (che ammette l'esistenza dei<br />
rinoceronti e ci dà un'informazione sul dove cercarli: dappertutto<br />
fuorché nell'aula <strong>di</strong> Carletto), ma sembra anche voglia <strong>di</strong>rci che lo<br />
zero riceve senso da tutto ciò che zero non è (ha senso <strong>di</strong>re che<br />
nell'aula non ci sono rinoceronti solo se i rinoceronti esistono, se non<br />
nella realtà, almeno come pensabili). Ma, <strong>di</strong>rà qualche matematico, il<br />
nostro problema è lo zero, non lo zerorinoceronti. "Ma <strong>di</strong> quello che<br />
m'importa!" gli risponderebbe Carletto.<br />
Proprio la <strong>di</strong>stinzione concettuale tra lo zero, lo zerorinoceronti e lo<br />
zeroqualunquealtracosa ci permette <strong>di</strong> connettere la matematica al<br />
linguaggio verbale come suo fondamento provvisorio. Possiamo<br />
parlare <strong>di</strong> 2 se<strong>di</strong>e solo se siamo in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguerle. Anche se le<br />
se<strong>di</strong>e in sé fossero in<strong>di</strong>stinguibili (perché, per esempio, prodotte in<br />
serie), occuperebbero posizioni <strong>di</strong>verse nello spazio e questo<br />
basterebbe a <strong>di</strong>stinguerle. D'altro canto nessuno <strong>di</strong>rebbe <strong>di</strong> un buco
nel muro che sono due perché un chiodo ci è stato messo due volte.<br />
Essenziale per dar senso al numero (eccetto che per 0 e 1) è la<br />
<strong>di</strong>stinguibilità degli oggetti che vogliamo numerare, e questa<br />
<strong>di</strong>stinguibilità si riflette nel linguaggio verbale attraverso l'imposizione<br />
<strong>di</strong> un nome o, comunque, <strong>di</strong> una marca <strong>di</strong>stintiva.<br />
Se questa (o il nome) manca, manca anche la <strong>di</strong>stinzione o perlomeno<br />
la possibilità <strong>di</strong> comunicarla.<br />
Ma la <strong>di</strong>stinzione non basta dare un fondamento - provvisorio - al<br />
numero. Un cavallo e un elefante non possiamo <strong>di</strong>rli due elefanti o<br />
due cavalli. Il numero due possiamo applicarlo soltanto se posse<strong>di</strong>amo<br />
una parola che unisca cavallo ed elefante entro un solo significato. Nel<br />
nostro caso, <strong>di</strong> parole che facciano questo ne abbiamo più <strong>di</strong> una:<br />
mammifero, vertebrato, quadrupede, animale... Se invece avessimo<br />
cavallo e sasso, le parole unificanti sarebbero altre, più generiche:<br />
oggetto, entità, cosa...<br />
Dobbiamo quin<strong>di</strong> saper <strong>di</strong>stinguere e raggruppare, due azioni<br />
apparentemente oppositive, ma confluenti nel concetto <strong>di</strong> numero<br />
(naturale). I successivi processi astrattivi avrebbero non solo<br />
sganciato il numero dal linguaggio verbale permettendogli la<br />
costituzione <strong>di</strong> un linguaggio proprio (il linguaggio matematico), ma<br />
avrebbero fatto sì che il numero naturale generasse altri tipi numerici<br />
non più riferibili alle azioni del <strong>di</strong>stinguere e raggruppare. O meglio,<br />
queste azioni continuano a or<strong>di</strong>nare oggetti come nel linguaggio<br />
verbale, ma ora questi oggetti sono interni al linguaggio matematico<br />
(numeri irrazionali, complessi ecc.) e non più riferibili a quella che<br />
chiamiamo realtà.
Un'ultima precisazione: il linguaggio verbale si è impadronito anche<br />
degli oggetti matematici, nominandoli, ma questa denominazione è<br />
secondaria, essendo seguita alla definizione matematica <strong>di</strong> quegli<br />
oggetti. Del resto l'aggancio del pensiero matematico al linguaggio<br />
verbale non è che un'ipotesi e neppure risolutiva, in quanto<br />
andrebbero indagate metaculturalmente proprio alle azioni del<br />
<strong>di</strong>stinguere e raggruppare.<br />
Non per nulla abbiamo qualificato come provvisorio questo tentativo<br />
<strong>di</strong> fondazione. Rivolgiamoci ora a una ulteriore sottospecificazione<br />
dello stile <strong>di</strong> pensiero assiomatico-deduttivo.<br />
3.2.2. Stile ipotetico-relativistico<br />
Anche qui l'accorpamento dei due termini è in certa misura arbitrario,<br />
in quanto essi non coincidono, come <strong>di</strong>mostra già l'assolutizzazione<br />
del secondo. La frase tutto è relativo non presuppone, per il<br />
relativismo, alcuna ipotesi. Semmai è la frase stessa a costituirsi<br />
come ipotesi, subito smentita logicamente dalla sua forma (tutto è...).<br />
Se ciononostante abbiamo unito quei due termini con il debole legame<br />
<strong>di</strong> un trattino, è per rimarcare il livello pratico delle nostre<br />
considerazioni, funzionali a una riflessività del quoti<strong>di</strong>ano, non a una<br />
riflessione teorica.<br />
Abbiamo anche incluso lo stile ipotetico-relativistico in un contenitore<br />
più ampio, lo stile assiomatico-deduttivo, pur riconoscendo la <strong>di</strong>versità<br />
dei concetti <strong>di</strong> assioma e ipotesi, il primo avente carattere fondante,
cioè non bisognoso <strong>di</strong> ulteriori fondazioni, il secondo invece poggiante<br />
su osservazioni opportunamente interpretate. L'assioma è una<br />
proposizione a priori, alla quale conseguono necessariamente altre<br />
proposizioni, che i logici chiamano teoremi e che in qualche modo<br />
sono contenute già nell'assioma; l'ipotesi invece è una struttura assai<br />
meno stabile, aperta nelle sue conseguenze fino al limite della<br />
falsificazione. Anche l'assioma, per la verità, può perdere nel tempo la<br />
sua vali<strong>di</strong>tà fondante, ma allora a pagarne le conseguenze è l'intero<br />
sistema su <strong>di</strong> esso costruito, mentre la falsificazione <strong>di</strong> un'ipotesi<br />
porta in genere a una nuova ipotesi o a una più o meno ra<strong>di</strong>cale<br />
mo<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> quella originaria, senza tuttavia che venga messo in<br />
crisi l'intero sistema.<br />
In questo senso si può <strong>di</strong>re che la relatività einsteiniana ha rivelato,<br />
per il realismo ingenuo (newtoniano), lo statuto <strong>di</strong> assioma piuttosto<br />
che <strong>di</strong> ipotesi. Questo perché proprio il relativismo ha mutato in<br />
ipotetico il precedente statuto assiomatico del realismo ingenuo. Ma <strong>di</strong><br />
ciò si parlerà in seguito.<br />
Il relativismo, se associato al concetto <strong>di</strong> ipotesi, non può logicamente<br />
configurarsi come assoluto o dogmatico, perché le sue proposizioni<br />
ere<strong>di</strong>tano dall'ipotesi la falsificabilità. Detto altrimenti, il relativismo<br />
stesso si fa ipotetico, quin<strong>di</strong> falsificabile: non possiamo cioè escludere<br />
a priori che esso venga sostituito da una qualche forma <strong>di</strong> certezza.<br />
Siamo nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze <strong>di</strong> IMC, un'ipotesi che ammette la<br />
propria falsificazione entra sé stessa (v. 1.2. Def. 2).<br />
La forma standard del pensiero ipotetico, quella che ne esprime anche<br />
il legame con il relativismo, è nota come If and Then statement, cioè
come struttura del se...allora. Questa struttura è spesso, ma non<br />
necessariamente, imparentata con il principio <strong>di</strong> causa (del tipo A è<br />
causa <strong>di</strong> B). Per esempio "Se piove le strade si bagnano" esibisce un<br />
legame causale (la pioggia bagna le strade), ma "Se piove non si va<br />
in gita" non implica causalità <strong>di</strong>retta (non si va in gita perché non ci<br />
piace bagnarci).<br />
Abbiamo incontrato la forma se...allora già trattando dello stile logico-<br />
matematico, ed effettivamente questa forma, tipica della deduzione<br />
logica, non appartiene primariamente allo stile ipotetico-relativistico.<br />
Ve<strong>di</strong>amo, anche in questo, caso quanto sia <strong>di</strong>fficile isolare i vari stili <strong>di</strong><br />
pensiero, che il più delle volte si sovrappongono e agiscono l'uno<br />
sull'altro generando forme ibride e complesse non più scomponibili se<br />
non a prezzo <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>cali semplificazioni. E <strong>di</strong> tali semplificazioni<br />
dobbiamo accontentarci se non vogliamo perderci in sottigliezze<br />
logiche o filosofiche <strong>di</strong> scarsa utilità pratica.<br />
Dicevamo che nella forma se...allora il se può essere riferito a un<br />
assioma anziché a un'ipotesi. La seconda parte - quella <strong>di</strong>pendente da<br />
allora - non cambia formalmente e resta relativizzata alla prima, il se.<br />
Questa tuttavia non ha la valenza <strong>di</strong> un'ipotesi e non ammette la<br />
falsificazione, irrigi<strong>di</strong>sce quin<strong>di</strong> anche ciò che segue, vanificando la<br />
sua la relatività, ridotta ormai a conseguenza necessaria <strong>di</strong> una verità.<br />
Alcune lingue, per esempio il latino, si spingono ancora oltre nel<br />
<strong>di</strong>fferenziare i perio<strong>di</strong> ipotetici: della realtà (dove l'antecedente è<br />
reale, quin<strong>di</strong> non si tratta <strong>di</strong> un'effettiva ipotesi) della possibilità (dove<br />
l'ipotesi, ancorché non provata, è tuttavia possibile), dell'irrealtà<br />
(dove l'ipotesi è solo immaginata, talora impossibile). La logica
formale tratta la struttura se...allora in maniera un poco <strong>di</strong>versa<br />
dall'uso comune, ma non è nostro compito addentrarci in questo<br />
campo come anche in quello della linguistica.<br />
Qualche parola vorrei invece ancora spendere sul funzionamento del<br />
pensiero ipotetico-relativistico in ambito scientifico. Seguendo<br />
l'impostazione, ormai classica, <strong>di</strong> Karl Popper, una proposizione o<br />
teoria non possono <strong>di</strong>rsi scientifiche se non ammettono la possibilità<br />
<strong>di</strong> essere considerate false. Ne consegue la quasi-contrad<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
uno scienziato, il quale abbia ipotizzato per esempio una nuova teoria<br />
per dar ragione <strong>di</strong> taluni fatti osservati, si adoperi in seguito, più che a<br />
comprovare con altri fatti la sua teoria, a cercarne la falsificazione,<br />
ovviamente sperando <strong>di</strong> non trovarla. Se comunque non la troverà lui,<br />
presto o tar<strong>di</strong> quella falsificazione la troverà qualcun altro.<br />
Il luogo della falsificazione come anche delle convalide sta nella<br />
seconda parte della formula, nell'allora.<br />
Sono infatti le conseguenze dell'ipotesi, cioè le osservazioni orientate<br />
su <strong>di</strong> essa a produrne la convalida o la falsificazione. Sia detto <strong>di</strong><br />
sfuggita: anche le osservazioni non sono ancora neutre, ma<br />
<strong>di</strong>pendono dalle ipotesi, il che complica ulteriormente la ricerca<br />
scientifica, che non può più contare su una totale oggettività. La<br />
successione: osservazione (invalidante una precedente ipotesi) -<br />
nuova ipotesi (o teoria) - nuova osservazione (convalidanteo<br />
invalidante) può valere come schema <strong>di</strong>alettico per una lettura<br />
storicistica del pensiero scientifico. Questo tipo <strong>di</strong> lettura è piuttosto<br />
recente e ha accompagnato da non più <strong>di</strong> un paio <strong>di</strong> secoli lo<br />
stupefacente cammino del pensiero scientifico, e <strong>di</strong> conseguenza delle
scienze e della tecnologia, cammino che non sembra prossimo ad<br />
arrestarsi, ma che sta ormai producendo più problemi <strong>di</strong> quanti non<br />
ne risolva.<br />
Quanto siamo lontani dalla posizione <strong>di</strong> Newton, che affermava<br />
"Hypotheses non fingo" - non costruisco ipotesi - e che evidentemente<br />
aveva una dogmatica fiducia nell'oggettività del Creato. Più prudente<br />
era il Car<strong>di</strong>nale Bellarmino che avvertì Galileo Galilei <strong>di</strong> trattare il<br />
movimento della Terra come ipotetico, non reale. Solo ai nostri giorni<br />
Albert Einstein ha potuto <strong>di</strong>re: "Un'ipotesi è una proposizione la cui<br />
verità è momentaneamente presunta ma il cui significato è al <strong>di</strong> là <strong>di</strong><br />
ogni dubbio".<br />
Se nella filogenesi umana il pensiero ipotetico-relativistico si è<br />
consolidato piuttosto tar<strong>di</strong> (ostacolato probabilmente da quello<br />
dogmatico, più funzionale alle varie forme <strong>di</strong> potere), chie<strong>di</strong>amoci ora<br />
come si sviluppa nell'ontogenesi, cioè durante la crescita<br />
dell'in<strong>di</strong>viduo? Non sono purtroppo al corrente <strong>di</strong> eventuali ricerche in<br />
questo campo, debbo quin<strong>di</strong> limitarmi a quanto osservato e<br />
sperimentato dal CMC nella sua più che trentennale attività.<br />
Non abbiamo esperienza <strong>di</strong> bambini molto piccoli, se si prescinde da<br />
quelle personali che alcuni <strong>di</strong> noi hanno avuto con i propri figli. La mia<br />
impressione è che il pensiero ipotetico si formi assai per tempo nella<br />
mente infantile e che la ripetitività gestuale che tutti conosciamo<br />
abbia a che fare con quello stile <strong>di</strong> pensiero, non <strong>di</strong>versamente da<br />
come uno scienziato, prima <strong>di</strong> dar cre<strong>di</strong>to a un'ipotesi, ne stu<strong>di</strong>a a<br />
lungo le conseguenze cercando in quelle la conferma - o la
falsificazione - dell'ipotesi stessa. Anche questa non è ovviamente che<br />
un'ipotesi interpretativa, cui altre se ne affiancano, che per esempio la<br />
ripetitività infantile sia legata a un rafforzamento della coscienza<br />
in<strong>di</strong>viduale ottenuto osservando la costanza del risultato conseguente<br />
a una certa azione. Le varie interpretazioni non è detto si escludano a<br />
vicenda: i comportamenti umani è probabile abbiano presupposti<br />
complessi anche quando ci appaiono semplici. Fra questi presupposti<br />
metterei appunto il pensiero ipotetico e non, per esempio, il principio<br />
<strong>di</strong> causa, nel quale vedrei piuttosto un carattere acquisito<br />
culturalmente. Non voglio avventurarmi oltre in un terreno che non è<br />
il mio.<br />
La nostra frequentazione riguarda soprattutto i bambini in età scolare,<br />
dai 6 ai 13 anni, e allora è evidente il possesso dello schema<br />
se...allora, anche se i normali processi formativi non sembrano<br />
favorirlo. L'insegnamento, inteso come trasmissione <strong>di</strong> sapere da chi<br />
sa (l'adulto) a chi non sa (il bambino), impe<strong>di</strong>sce al se <strong>di</strong> attivare<br />
tutta la sua potenzialità esplorativa e al conseguente allora <strong>di</strong> attivare<br />
le sue potenzialità logiche. Il quanto <strong>di</strong> sapere, la nozione<br />
semplicemente trasmessa, blocca la ricerca, blocca il ragionamento.<br />
Per fornire un complemento all'insegnamento trasmissivo - della cui<br />
insostituibilità siamo tuttora convinti - il nostro Centro (il CMC) ha<br />
sviluppato, dapprima nel solo ambito musicale e poi via via anche<br />
negli altri ambiti <strong>di</strong>sciplinari, una metodologia formativa basata sul<br />
binomio analisi-composizione e avente come modello <strong>di</strong> interazione il<br />
circuito autogenerativo, il tutto sullo sfondo <strong>di</strong> IMC. Un'ampia<br />
testimonianza <strong>di</strong> questo percorso formativo è in corso <strong>di</strong> pubblicazione
sul sito, più volte citato, www.<strong>di</strong>datticaperprogetti.it. Da questo vorrei<br />
citare alcuni testi, esemplificativi <strong>di</strong> quanto qui vado <strong>di</strong>cendo sullo stile<br />
<strong>di</strong> pensiero ipotetico-relativistico.<br />
Io cerco sempre <strong>di</strong> capire.<br />
Oppure domando ai gran<strong>di</strong>.<br />
CERCO DI CAPIRE<br />
Gli altri bambini ho visto che fanno lo stesso.<br />
Forse anche i gran<strong>di</strong> fanno così.<br />
Ma loro a chi domandano quando non capiscono?<br />
Forse alcuni gran<strong>di</strong> capiscono più cose <strong>di</strong> altri.<br />
O le capiscono meglio.<br />
E magari le insegnano.<br />
Ma anche loro non credo che capiscano proprio tutto.<br />
E loro a chi domandano le cose che non capiscono?<br />
Forse se le domandano tra loro.<br />
Forse fanno finta <strong>di</strong> capire.<br />
CERCO DI CAPIRE<br />
Forse qualche volta hanno capito per davvero e qualche volta fanno<br />
finta.<br />
Ma noi, come facciamo a capire quando hanno capito per davvero e<br />
quando<br />
fanno finta?
CERCO DI CAPIRE<br />
Credo che dovrebbero essere loro stessi a <strong>di</strong>rcelo.<br />
A <strong>di</strong>re: "Questa cosa l'ho capita veramente"<br />
oppure: "Faccio conto che la cosa stia così e così".<br />
Anzi credo che dovrebbero <strong>di</strong>re più spesso: "Faccio conto che la cosa<br />
stia<br />
così e così".<br />
Chi li assicura infatti che la cosa l'hanno capita veramente?<br />
(......)<br />
Il testo è evidentemente apocrifo (come anche i seguenti) nel senso<br />
che non li ha scritti un bambino, bensì un adulto, che tuttavia ha<br />
tentato <strong>di</strong> assumere l'abito mentale <strong>di</strong> quello.<br />
È una sorta <strong>di</strong> avvio al pensiero ipotetico, o meglio alla riflessione sul<br />
pensiero ipotetico, <strong>di</strong> cui il bambino è già in possesso.<br />
Ecco invece il pensiero ipotetico in azione.<br />
CERCO DI CAPIRE<br />
Perché la luna, il sole, le stelle non cadono?<br />
Cerco <strong>di</strong> capire.<br />
Dove dovrebbero cadere?<br />
Sulla terra!<br />
E perché non da qualche altra parte?
Forse non cadono perché non sanno dove cadere.<br />
CERCO DI CAPIRE<br />
Perché la luna, il sole, le stelle non cadono?<br />
Cerco <strong>di</strong> capire.<br />
Forse cadono, ma ca<strong>di</strong>amo anche noi e così non ce ne accorgiamo.<br />
CERCO DI CAPIRE<br />
Perché la luna, il sole, le stelle non cadono?<br />
Cerco <strong>di</strong> capire.<br />
Se prendo un pezzo <strong>di</strong> terra e lo lascio cadere, cade per terra.<br />
Forse anche un pezzo <strong>di</strong> luna, lasciato cadere sulla luna, cadrebbe<br />
sulla luna.<br />
E un pezzo <strong>di</strong> sole sul sole.<br />
E un pezzo <strong>di</strong> una stella sulla stella.<br />
Forse la luna, il sole e le stelle cadono su sé stessi.<br />
I ragionamenti, anche se apocrifi, sono a portata <strong>di</strong> bambino.<br />
Le tre sezioni del testo conducono a tre ipotesi <strong>di</strong>verse. La prima <strong>di</strong><br />
queste è improbabile perché umanizza gli astri (non sanno dove<br />
cadere); se prescin<strong>di</strong>amo tuttavia dall'espressione umanizzante,<br />
possiamo scorgervi l'immagine <strong>di</strong> un universo isotropo cioè senza<br />
<strong>di</strong>rezioni privilegiate, un'immagine certo falsa localmente ma forse<br />
accettabile nel suo insieme. La seconda ipotesi corrisponde
concettualmente alla relatività galileiana e, se pensiamo la caduta<br />
come un moto uniformemente accelerato, ad<strong>di</strong>rittura alla relatività<br />
generale <strong>di</strong> Einstein. Alla quale rimanda con maggiore precisione la<br />
terza ipotesi, che sembra descrivere ciò che accade in un buco nero,<br />
anche questo, del resto, ipotetica conseguenza della relatività<br />
generale.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista dello stile <strong>di</strong> pensiero i tre minitesti qui riportati<br />
intendono mostrare come, al <strong>di</strong> là delle estremamente complesse<br />
formulazioni matematiche, certi ipotesi sono assai semplici e<br />
facilmente intuibili. Come mai, allora hanno dovuto attendere secoli,<br />
talora millenni, per essere in<strong>di</strong>viduate? Newton sapeva benissimo che<br />
la massa inerziale era identica a quella gravitazionale; aveva anche a<br />
<strong>di</strong>sposizione lo stesso armamentario matematico - da lui inventato (e<br />
da Leibnitz) - <strong>di</strong> Einstein. Perché non arrivò a formulare la teoria della<br />
relatività generale? Perché "Hypotheses non fingo". Glie lo impe<strong>di</strong>va lo<br />
stile <strong>di</strong> pensiero dogmatico.<br />
Noi ve<strong>di</strong>amo le cose intorno a noi.<br />
Le ve<strong>di</strong>amo con i loro colori.<br />
CERCO DI CAPIRE<br />
Al buio non ve<strong>di</strong>amo né i colori né le cose.<br />
Le cose però ci sono sempre: le possiamo toccare.<br />
Ma i colori non li riconosciamo toccandoli.<br />
Perché si riconoscano i colori ci vuole la luce.<br />
Luce e colori vanno d'accordo.
CERCO DI CAPIRE<br />
Ma se c'è la luce e io chiudo gli occhi, i colori non li vedo.<br />
E neppure le cose. Posso però toccarle.<br />
Forse i colori vanno d'accordo, oltreché con la luce, anche con gli<br />
occhi.<br />
CERCO DI CAPIRE<br />
Perché le cose intorno a noi hanno <strong>di</strong>versi colori?<br />
Forse per farsi riconoscere meglio.<br />
I fiori e gli animali si riconoscono meglio nella TV a colori che in quella<br />
in<br />
bianco e nero.<br />
Ma le TV siamo noi a costruirle.<br />
E oggi le costruiamo in modo che sappiano <strong>di</strong>stinguere i colori.<br />
Ma le cose intorno a noi le ve<strong>di</strong>amo senza la TV.<br />
Con che cosa le ve<strong>di</strong>amo?<br />
Con gli occhi!<br />
Forse l'occhio è costruito in modo da <strong>di</strong>stinguere i colori.<br />
CERCO DI CAPIRE<br />
Le cose hanno <strong>di</strong>versi colori - il nostro occhio li <strong>di</strong>stingue.<br />
L'occhio e le cose vanno d'accordo.
Supponiamo che l'occhio veda solo in bianco e nero come certe TV.<br />
Se ora qualcuno ci domandasse se le cose sono colorate, che cosa<br />
risponderemmo?<br />
Risponderemmo che no, non sono colorate.<br />
O forse non capiremmo neppure la domanda.<br />
CERCO DI CAPIRE<br />
Se i nostri occhi vedessero in bianco e nero, andrebbero sempre<br />
d'accordo<br />
con le cose?<br />
No, perché le cose hanno i colori.<br />
Ma noi lo sappiamo solo perché abbiamo gli occhi fatti come la TV a<br />
colori.<br />
Forse i colori ci sono solo se c'è un occhio capace <strong>di</strong> vederli.<br />
Il testo ha la forma <strong>di</strong> un monologo fittizio.<br />
Tutte le proposizioni appaiono separate dall'a capo, salvo le ultime<br />
due, quasi a segnalare in chiusura l'unicità del pensante.<br />
Il riferimento esterno è tra i più probabili per un bambino degli anni<br />
'80 (quando i testi sono stati scritti): la TV. Oggi ci sarebbe da<br />
considerare Internet, <strong>di</strong> uso sempre più frequente anche tra i<br />
giovanissimi.<br />
Come i testi citati in precedenza, anche questi terminano ciascuno con<br />
un'ipotesi, introdotta - salvo che nel primo testo - da un forse.<br />
Nel loro insieme queste ipotesi ricostruiscono - con espressioni
facilmente comprensibili, a misura <strong>di</strong> bambino - il percorso<br />
relativizzante compiuto negli ultimi due secoli (all'incirca da Goethe in<br />
poi) dal pensiero scientifico intorno all'evoluzione adattativa <strong>di</strong> alcuni<br />
organi (qui l'occhio) e delle loro prestazioni.<br />
L'ultima ipotesi, che fa <strong>di</strong>pendere i colori dall'occhio che li <strong>di</strong>stingue,<br />
va ancora più in là e relativizza i fenomeni alla capacità <strong>di</strong> osservarli.<br />
Non cre<strong>di</strong>amo che il bambino abbia bisogno <strong>di</strong> certezze.<br />
Pensiamo - ma anche questa è solo un'ipotesi - che uno stile<br />
ipotetico-relativistico attivi assai più che non uno stile dogmatico il<br />
pensiero sia infantile che dell'adulto.<br />
3.3. Stile causale-lineare/areale<br />
Ho già accennato al principio <strong>di</strong> causa che per lungo tempo ha<br />
dominato il pensiero occidentale fino a proporsi, con la Scolastica,<br />
come asse portante della <strong>di</strong>mostrazione dell'esistenza <strong>di</strong> Dio. Per fare<br />
questo il principio <strong>di</strong> causa ha dovuto postulare la sua interabilità<br />
lineare:<br />
A è causa <strong>di</strong> (B è causa <strong>di</strong> (C è causa <strong>di</strong> (...)))<br />
Un semplice esperimento, ovunque proponibile, mostra come il<br />
pensiero, se non particolarmente addestrato, non funziona così.<br />
Un'inchiesta sul seguente problema:<br />
Se esco quando piove, mi bagno. Perché?<br />
[Il perché sta qui per: qual è la causa (del fatto che mi bagno)?]<br />
ha prodotto le seguenti risposte:
- Perché piove.<br />
- Perché la pioggia è fatta <strong>di</strong> acqua.<br />
- Perché l'acqua è bagnata.<br />
- Perché non porto l'ombrello...<br />
- ... e neppure l'impermeabile.<br />
- Perché il mio ombrello ha un buco.<br />
- Perché non sono idrorepellente.<br />
- Perché non sono un pesce...<br />
- ... né un pinguino.<br />
- Perché non sono abbastanza caldo da far evaporare l'acqua.<br />
......<br />
Le prime tre risposte potrebbero formare una catena causale, le altre<br />
si collocano per così <strong>di</strong>re in parallelo nel senso che nessuna può<br />
considerarsi in rapporto <strong>di</strong> causa con le altre.<br />
Un pensiero addestrato (con<strong>di</strong>zionato) alla linearità causale non<br />
accetterebbe probabilmente come causali (quin<strong>di</strong> come pertinenti) le<br />
risposte dalla quarta in poi. Il pensiero scientifico si è identificato per<br />
secoli con il pensiero causale; non si <strong>di</strong>ce che le cause le ha<br />
in<strong>di</strong>viduate, ma che le ha sempre cercate, anche attribuendole a<br />
entità convenzionali inventate ad hoc. E così la me<strong>di</strong>cina, <strong>di</strong> cui una<br />
branca, l'eziologia, si occupa precipuamente della causa delle<br />
malattie.<br />
La causalità è stata da sempre il motore principale della ragione e la<br />
ricerca delle cause su su fino alla causa prima il suo fine ultimo.<br />
Dietro questa ricerca c'è stata la convinzione, assai <strong>di</strong>ffusa<br />
nell'occidente cristiano, che il reale è razionale, cioè pienamente
descrivibile dalla ragione. E ragione significa qui essenzialmente<br />
capacità <strong>di</strong> interpretare il mondo per catene <strong>di</strong> causa-effetto. A<br />
garanzia <strong>di</strong> questo rispecchiamento tra realtà e razionalità la nostra<br />
religione, nella versione ufficiale datale dalla Chiesa, ha posto Dio,<br />
causa prima, per così <strong>di</strong>re incausata. Per poter raggiungere questo<br />
primum movens la causalità ha dovuto porsi come lineare così da<br />
poter essere percorsa univocamente in quella <strong>di</strong>rezione. Ci si può ora<br />
chiedere il perché <strong>di</strong> questa univoca <strong>di</strong>rezionalità, non con<strong>di</strong>visa da<br />
altri stili pensiero. Azzar<strong>di</strong>amo anche noi una spiegazione causale, pur<br />
facendola nascere da un atteggiamento critico nei confronti della<br />
causalità: la linearità causale è facilmente governabile, favorisce cioè<br />
il potere <strong>di</strong> chi la gestisce. E la Chiesa - cristiana, ma non solo lei - si<br />
è autoproclamata gestore della ragione lineare.<br />
Questo abbozzo <strong>di</strong> spiegazione causale mostra, com'è naturale che<br />
sia, tutta la fragilità del modello, in quanto molte correnti del pensiero<br />
cristiano, come vedremo, non sono affatto lineari e neppure la Chiesa<br />
ufficiale esaurisce il suo potere nella consequenzialità causale.<br />
In effetti il modello <strong>di</strong> causalità che abbiamo chiamato lineare è tutt'al<br />
più modello-limite, forse mai applicato nella sua integrità, più un<br />
in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> tendenza che un dato culturalmente riscontrabile. Un<br />
primo correttivo relativizzante è stato introdotto accordando un certo<br />
spazio alle concause. Queste restano subor<strong>di</strong>nate alla causa<br />
principale, ne limitano però la portata attirando su <strong>di</strong> sé l'interesse<br />
dell'osservatore.<br />
- "Quest'anno gira la giavanese e io, come al solito, sono stato tra i<br />
primi a prenderla."
- "Per forza, con la tua abitu<strong>di</strong>ne a non portare il cappotto..."<br />
- "... e a tenere spenti i termosifoni..."<br />
- "Io invece penso che te la sei presa per quella cura che hai fatto e<br />
che deve aver abbassato le tue <strong>di</strong>fese naturali."<br />
- "A meno che non sia altro che la riacutizzazione dell'influenza della<br />
stagione scorsa, che non ti ha mai abbandonato del tutto..."<br />
- "Quin<strong>di</strong> non sarebbe la giavanese ma sempre la tibetana dell'anno<br />
scorso..."<br />
- "... magari ibridata con la giavanese <strong>di</strong> quest'anno..."<br />
......<br />
Questo <strong>di</strong>alogo fittizio a più voci rispecchia più da vicino la<br />
complessità del pensiero causale che non una normale affermazione:<br />
"Non posso venire perché sto a letto con l'influenza". Le concause<br />
nominate nel <strong>di</strong>alogo quasi mettono in ombra la giavanese, che<br />
ritorna alla fine, indebolita dal sospetto <strong>di</strong> ibridazione.<br />
La crescente attenzione per le concause ha portato a una ridefinizione<br />
del principio <strong>di</strong> causa in termini non più lineari ma areali. I fenomeni<br />
non sarebbero più collegati l'uno all'altro da consequenzialità <strong>di</strong>retta,<br />
ma sarebbero determinati dal confluire <strong>di</strong> più cause, potenzialmente<br />
infinite. Un singolo fenomeno verrebbe così a trovarsi entro un'area,<br />
meglio universo isotropo (cioè senza <strong>di</strong>rezioni privilegiate) <strong>di</strong><br />
causalità, e l'attribuzione a una causa piuttosto che a un'altra<br />
<strong>di</strong>penderebbe soltanto dall'osservatore e dal punto <strong>di</strong> vista adottato.<br />
Come prima il modello lineare, così ora quello areale appare descritto<br />
come un modello-limite, cui i casi concreti tendono ad accostarsi più o<br />
meno. Il termine area o anche universo ha qualche affinità con il
concetto <strong>di</strong> campo (<strong>di</strong> forza, gravitazionale, elettromagnetico...) in<br />
fisica.<br />
Così una forza viene definita fisicamente dal valore che una certa<br />
variabile (un vettore) assume in un certo punto <strong>di</strong> un campo. Ridotta<br />
in termini puramente numerici la forza perde ogni consistenza<br />
materiale e <strong>di</strong>venta un'entità assai più maneggevole <strong>di</strong> quanto non<br />
fosse quando era pensata quasi come un oggetto. La perplessità <strong>di</strong><br />
Newton, che non riusciva a trovare una causa materiale per la gravità,<br />
viene aggirata dal concetto <strong>di</strong> campo, che si limita a registrare dei<br />
valori, noncurante del principio <strong>di</strong> causa.<br />
Il colpo <strong>di</strong> grazia a questo principio viene dato forse dalla fisica<br />
moderna, (relatività generale e teoria dei quanti), benché già David<br />
Hume l'avesse liquidato filosoficamente un paio <strong>di</strong> secoli prima.<br />
Ma non è mia intenzione, come già detto altre volte, avventurarmi su<br />
terreni così specifici.<br />
Considerato dal punto <strong>di</strong> vista metaculturale - che, senza demonizzare<br />
lo specifico, specifico non è - il principe <strong>di</strong> causa non va né affermato<br />
né negato nella sua generalità (cioè a <strong>di</strong>re in UMC), ma solo<br />
localizzato: in certi UCL mantiene la sua vali<strong>di</strong>tà, in altri no, è<br />
necessario verificare. Nella funzione formativa - che costituisce<br />
l'orizzonte pratico che ci siamo dati e in cui anche il presente scritto<br />
intende inserirsi nonostante la sovrabbondanza <strong>di</strong> considerazioni<br />
teoriche - in questa funzione il principio <strong>di</strong> causa ha ancora un ruolo,<br />
in particolare nel rapporto con la scuola?<br />
È bene a questo punto <strong>di</strong>stinguere tra formazione <strong>di</strong> base e<br />
formazione culturale più attenta alle esigenze - culturali, lavorative...
- locali. Questa <strong>di</strong>stinzione, come la maggior parte <strong>di</strong> quelle che<br />
quoti<strong>di</strong>anamente adoperiamo, non può che avere una valenza<br />
metodologica, genericamente orientativa, perché non avrebbe alcun<br />
senso separare i due momenti e neppure assegnare all'uno o all'altro<br />
strumenti informativi specifici.<br />
Nell'opinione comune, che ha certamente argomenti a suo favore, il<br />
cammino formativo dovrebbe muovere da un quadro <strong>di</strong> certezze, tra<br />
cui il principio <strong>di</strong> causa, essenziale - si <strong>di</strong>ce - per il consolidamento<br />
dell'Io in<strong>di</strong>viduale, e solo in una fase successiva potrebbero essere<br />
introdotte le sottigliezze del relativismo, dell'arealità, della riflessione<br />
metaculturale.<br />
Nei nostri progetti formativi il cammino è l'inverso: il bambino, aperto<br />
com'è a ogni inse<strong>di</strong>amento culturale, pensiamo vada anzitutto<br />
preparato ad accogliere questi inse<strong>di</strong>amenti in forme non dogmatiche.<br />
Questo non perché lo stile dogmatico sia da valutare negativamente e<br />
tantomeno da condannare (condanneremmo quasi tutta la nostra<br />
cultura e anche molte altre); ma perché l'attuale situazione mon<strong>di</strong>ale<br />
non vi si rispecchia più con tutta la sua problematicità e pericolosità.<br />
Ritorneremo ancora su questo punto.<br />
Ecco ora qualche in<strong>di</strong>cazione sull'ammorbi<strong>di</strong>mento del principio <strong>di</strong><br />
causa, sul quale le nostre famiglie basano ancora gran parte della loro<br />
azione educativa, spesso nella forma paralogica del se...allora:<br />
"Attento, se corri così finirai per cadere" (necessariamente?), "Quando<br />
nevica molti uccellini muoiono <strong>di</strong> freddo" (non, ad esempio, per<br />
mancanza <strong>di</strong> cibo?), "Se non siamo andati in villeggiatura è a causa<br />
della malattia della nonna" (povera nonna, non solo malata, ma anche
esponsabile della mancata villeggiatura!).<br />
Nella mente del bambino queste applicazioni scorrette e subdole del<br />
principio <strong>di</strong> causa si imprimono più o meno fortemente, ma<br />
soprattutto si imprime il principio stesso che sarà poi molto <strong>di</strong>fficile<br />
relativizzare.<br />
Crac...<br />
Un <strong>di</strong>alogo fittizio<br />
(B=bambina, E=Einstein)<br />
B. (piangendo)... mi è caduta la tazzina...<br />
E. ... poco male, ce ne abbiamo tante altre...<br />
B. ... mi è scappata <strong>di</strong> mano... ma perché le cose cadono se nessuno<br />
le tiene? (Smette <strong>di</strong> piangere)<br />
E. Perché sono pesanti...<br />
B. ... ma perché le cose pesanti cadono per terra?<br />
E. Perché la terra le attrae.<br />
B. Che vuol <strong>di</strong>re che le "attrae"... come fa ad attrarle se non c'è<br />
niente che le tira giù, nemmeno un elastico?<br />
E. Le attrae con una forza che si chiama forza <strong>di</strong> gravità o anche<br />
gravitazione...<br />
B. ... ma, se voglio tirar giù una cosa, devo toccarla o almeno toccare<br />
una cosa legata a quella... ma qui tra la tazzina terra non c'era<br />
nulla... e allora?<br />
E. Si parla <strong>di</strong> azione a <strong>di</strong>stanza. La forza <strong>di</strong> gravità agisce da lontano<br />
senza contatto <strong>di</strong>retto tra i corpi che si attraggono...
B. ... ma come fa ad agire da lontano?<br />
E. ... be'... anche il sole ti illumina da lontano...<br />
B. Già, ma lui mi manda la luce che mi tocca e la vedo e sento pure<br />
che è calda...<br />
E. ... forse anche la gravitazione ti tocca con qualcosa che c'è e non si<br />
vede... si parla per esempio <strong>di</strong> gravitoni che potrebbero essere simili<br />
alle particelle <strong>di</strong> luce che chiamiamo fotoni.<br />
B. Sì, ma quelle si vedono mentre i gravitoni siete voi scienziati a<br />
immaginarli...<br />
E. ... come immaginiamo anche gli atomi, gli elettroni e molte altre<br />
particelle che una per una non si vedono ma che tutte insieme fanno i<br />
corpi.<br />
B. E perché immaginate tutte quelle particelle e non per esempio<br />
un'altra cosa?<br />
E. ... che cosa per esempio?<br />
B. ... che ne so... che non ci sono particelle... o anche che non ci sono<br />
<strong>di</strong>stanze... che non c'è lo spazio, perché anche quello non si vede, si<br />
vedono solo le cose che ci stanno dentro...<br />
E. (Fra sé e sé)... oppure che le cose non sono altro che spazio<br />
mo<strong>di</strong>ficato... (a voce alta) Mi hai dato una buona idea... ci penserò su.<br />
È chiaro che il <strong>di</strong>alogo è inventato ed è poco probabile che una<br />
bambina si avventuri nella ricerca delle cause (della gravità) fino a<br />
ipotizzare l'assenza dello spazio. Poco probabile non significa peraltro<br />
impossibile. Se per esempio la cultura <strong>di</strong> base, come qui l'inten<strong>di</strong>amo,<br />
le permettesse <strong>di</strong> considerare spazio e tempo in forma aperta,
problematica ("non si vedono - <strong>di</strong>rebbe la bambina - si vedono solo le<br />
cose che ci stanno dentro"), il precedente <strong>di</strong>alogo <strong>di</strong>venterebbe<br />
possibile.<br />
3.4. Stile finalistico-progettuale<br />
Il pensiero finalistico risponde anch'esso alla domanda perché. Ciò<br />
<strong>di</strong>pende peraltro, come già visto, dalla struttura della lingua italiana.<br />
Altre lingue <strong>di</strong>fferenzierebbero (in tedesco wozu, wofür, weshalb,<br />
warum e, nella risposta: weil). Ho scelto il termine finalistico in<br />
omaggio al pensiero filosofico classico che parlava <strong>di</strong> causa finalis in<br />
simmetria cronologica con il consueto principio <strong>di</strong> causa. È come se si<br />
invertisse la normale <strong>di</strong>rezionalità del tempo - dal passato al futuro - e<br />
la causa <strong>di</strong> un evento potesse trovarsi in un qualche stato futuro, dato<br />
a seconda dei casi come possibile, probabile, certo. Nel caso della<br />
certezza questo stile verrebbe modulato da quello dogmatico. Viene<br />
data per esempio come certa una con<strong>di</strong>zione umana finale, definitiva,<br />
verso cui si è mossa (si muove) l'intera evoluzione dell'esistente, dalla<br />
materia inanimata alla materia vivente, agli animali, all'uomo, alla<br />
riunificazione con il Divino. È una concezione finalistica comune a<br />
molte religioni e che da quelle cosiddette rivelate riceve da Dio stesso<br />
un marchio <strong>di</strong> garanzia (per i cattolici da Gesù Cristo). L'idea<br />
dell'uomo come re del creato e quin<strong>di</strong>, laicamente, come padrone<br />
assoluto delle sue risorse fa capo a una tale concezione finalistica.<br />
Che è palesemente <strong>di</strong> comodo perché ci riconosce tutti i <strong>di</strong>ritti sui
viventi, la materia, l'universo, senza assegnarci alcun dovere. A<br />
segnalarci questi ultimi ci pensano fortunatamente la biosfera, la<br />
materia e l'universo stesso.<br />
Ma non sono solo le religioni a servirsi del pensiero finalistico. Anche<br />
l'idea <strong>di</strong> progresso, che tanta parte ha nelle ideologie sociali, politiche<br />
dei nostri tempi, partecipa ad evidenza <strong>di</strong> questo stile. L'utopia <strong>di</strong> una<br />
società giusta, libera, egalitaria <strong>di</strong>venta, per questo stile, una meta<br />
raggiungibile e da raggiungere, una meta che vale bene qualche<br />
rinuncia e anche qualche sacrificio che altrimenti sarebbe<br />
ingiustificabile.<br />
- Morire per la causa (come in ogni guerra, anche se la causa non è<br />
mai la stessa).<br />
- Agire per una giusta causa.<br />
- Il fine giustifica i mezzi.<br />
- Obiettivi, finalità.<br />
- Lavorò tutta la vita con l'obiettivo...<br />
- Il suo fine ultimo è sempre stato...<br />
- Sognava <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare...<br />
- Il mio più grande desiderio è...<br />
......<br />
Espressioni come queste sono all'or<strong>di</strong>ne del giorno; termini quali<br />
utopia, speranza, aspettativa, desiderio ecc. rimandano tutti alla<br />
nostra capacità, non <strong>di</strong> prevedere, ma <strong>di</strong> prefigurare ipoteticamente<br />
un futuro verso cui <strong>di</strong>rigere pensieri e azioni: un futuro che non ha il<br />
carattere <strong>di</strong> certezza dogmatica prospettato da alcune religioni, ma<br />
che mantiene per noi la forza attrattiva che dà un senso alla nostra
vita.<br />
Possiamo <strong>di</strong>re che questo senso della vita, che tutti cerchiamo proprio<br />
perché siamo noi stessi a richiederlo (gli animali pare che non ne<br />
abbiano bisogno), sia equamente composto <strong>di</strong> passato - come garante<br />
<strong>di</strong> identità - e <strong>di</strong> futuro - come garante del <strong>di</strong>venire. Il passato lo<br />
ve<strong>di</strong>amo come un dato immo<strong>di</strong>ficabile (anche se la sua <strong>di</strong>versa<br />
interpretabilità ci dovrebbe indurre a qualche dubbio); il futuro lo<br />
ve<strong>di</strong>amo come più o meno aperto (chiuso solo per un pensiero<br />
dogmaticamente deterministico). E proprio nelle aperture del futuro si<br />
colloca la progettualità umana, forse la più specifica delle nostre<br />
facoltà. Tolgo le seguenti considerazioni dal nodo formativo Progettare<br />
del nostro sito Web, anche allo scopo <strong>di</strong> informare con un esempio il<br />
lettore sulle caratteristiche <strong>di</strong> questa sezione del sito.<br />
3.4.1. Generalità<br />
I termini progetto, progettare hanno un immenso campo <strong>di</strong><br />
applicabilità, che <strong>di</strong> conseguenza non può essere esaurito nelle poche<br />
righe che gli de<strong>di</strong>cheremo. In linea generale possiamo pensare il<br />
singolo progetto come anello <strong>di</strong> una catena progettuale
indefinitamente estesa nei due sensi del prima e del poi o come<br />
cerchio in una serie <strong>di</strong> cerchi concentrici<br />
L'educazione alla consapevolezza metaculturale mira al<br />
riconoscimento - sempre comunque limitato - degli anelli del prima e<br />
del poi ovvero degli spazi progettuali interno ed esterno relativi a un<br />
progetto dato.<br />
In altre parole si tratta <strong>di</strong> rendersi conto - per quanto possibile - degli<br />
antecedenti da cui consegue il progetto in questione e delle<br />
conseguenze che ne potranno derivare.<br />
......<br />
3.4.2. Fasi e sta<strong>di</strong> progettuali<br />
Ma il termine progetto anche in un altro senso uno spessore
cronologico, e cioè pensabile come un insieme <strong>di</strong> fasi implicanti il<br />
fattore tempo. Immaginiamo per esempio il seguente progetto:<br />
Cucinare un uovo al tegamino<br />
Possiamo <strong>di</strong>stinguere innanzitutto una fase progettuale (quando<br />
decido <strong>di</strong> farmi il nuovo al tegamino e so anche come fare) e una fase<br />
esecutiva (quando effettivamente cucino l'uovo).<br />
Ma sia la fase progettuale che quella esecutiva sono ulteriormente<br />
scomponibili e associabili in sta<strong>di</strong>:<br />
1°<br />
sta<strong>di</strong><br />
o<br />
2°<br />
sta<strong>di</strong><br />
o<br />
3°<br />
sta<strong>di</strong><br />
o<br />
{<br />
{<br />
{<br />
fase progettuale: in<strong>di</strong>viduazione degli ingre<strong>di</strong>enti (uovo, olio,<br />
sale)<br />
fase esecutiva: reperimento degli ingre<strong>di</strong>enti<br />
fase progettuale: in<strong>di</strong>viduazione degli strumenti (tegamino,<br />
fornello)<br />
fase esecutiva: reperimento degli strumenti<br />
fase progettuale: coor<strong>di</strong>namento ingre<strong>di</strong>enti-strumenti<br />
(scaldare il tegamino, riscaldare l'olio, rompervi dentro<br />
l'uovo, aggiungere il sale)<br />
fase esecutiva: cottura dell'uovo<br />
I vari sta<strong>di</strong> qui elencati possono intendersi anche come sottoprogetti,<br />
ciascuno dei quali provvisto <strong>di</strong> una fase progettuale in senso stretto e<br />
<strong>di</strong> una esecutiva. Ogni sta<strong>di</strong>o è premessa in<strong>di</strong>spensabile ad almeno<br />
uno dei seguenti. Nel nostro caso gli sta<strong>di</strong> 1º e 2º sono premessa<br />
in<strong>di</strong>spensabile al 3º.
3.4.3. Realizzazioni effettive - realizzazioni virtuali<br />
Spesso questi sta<strong>di</strong> progettuali e le corrispondenti fasi (progettuale ed<br />
esecutiva) si concatenano quasi automaticamente e noi quasi non ce<br />
ne ren<strong>di</strong>amo conto.<br />
La consapevolezza entra in gioco quando in un punto qualsiasi<br />
sopraggiunge un impe<strong>di</strong>mento:<br />
"Credevo <strong>di</strong> avere ancora nuovo nel frigo invece...<br />
E adesso dove vado a prenderlo l'uovo, oggi che è domenica?"<br />
oppure<br />
"Hanno tolto il gas, mi tocca usare il fornello a spirito".<br />
Di regola una progettazione ben fatta deve prevedere anche la<br />
successione degli sta<strong>di</strong> progettuali con tutte le loro fasi. Deve cioè<br />
realizzare - non effettivamente ma virtualmente - anche le fasi<br />
esecutive. Qui sta anzi uno dei vantaggi del pensiero cosciente (più<br />
sviluppato nell'uomo) su quello istintivo (più sviluppato negli animali).<br />
Anche la <strong>di</strong>ga <strong>di</strong> un castoro, il nido <strong>di</strong> un uccello o <strong>di</strong> una vespa<br />
presuppongono un progetto dettagliato per sta<strong>di</strong> e fasi, ma questo<br />
progetto è in massima parte depositato nel genoma e non è a<br />
<strong>di</strong>screzione del costruttore. Né il castoro, né l'uccello né la vespa<br />
stu<strong>di</strong>ano i loro progetti a tavolino: per loro si può <strong>di</strong>re che esistano<br />
solo le fasi esecutive, quelle progettuali restando fuori dalla loro<br />
esperienza. Se le con<strong>di</strong>zioni ambientali restano quelle abituali, i loro<br />
progetti innati funzionano al meglio, se tuttavia cambiano in maniera
ilevante, le loro costruzioni falliscono e così costruttori. Sarebbe<br />
come se un ingegnere sperimentasse la costruzione <strong>di</strong> una villa su un<br />
ghiaione <strong>di</strong>rettamente eseguendola per poi vederla crollare a valle. Ma<br />
l'ingegnere, prima <strong>di</strong> costruire la villa ne progetta virtualmente sta<strong>di</strong> e<br />
fasi e, se la villa a un certo momento crolla, lo fa virtualmente, sulla<br />
carta, il che è certamente assai meno <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>oso.<br />
Insomma la progettualità cosciente implica un lavoro <strong>di</strong> cui la<br />
progettualità istintiva non ha bisogno, offre però molto maggiori<br />
garanzie <strong>di</strong> successo in un ambiente fortemente instabile come quello<br />
culturale, creato dall'uomo.<br />
Non sempre tuttavia la progettualità umana sembra essere del tutto<br />
cosciente o forse altre forze intervengono ad accecarla, e gli effetti <strong>di</strong><br />
una progettualità non sufficientemente controllata sappiamo che<br />
possono essere <strong>di</strong>sastrosi.<br />
Per questa ragione un'educazione precoce alla progettazione cosciente<br />
e controllata per sta<strong>di</strong> e fasi ci appare, oggi più che mai, essenziale<br />
per un progetto <strong>di</strong> sopravvivenza.<br />
3.4.4. ???<br />
Quanto qui si è detto sulla progettazione può essere sintetizzato nello<br />
schema seguente.
Ovviamente uno schema non può dar ragione <strong>di</strong> tutti i casi, così come<br />
non bisogna chiedere a una teoria più <strong>di</strong> quanto non può dare. Così<br />
nella grafizzazione qui proposta non è detto che gli sta<strong>di</strong> si<br />
susseguano cronologicamente. Alcuni possono attuarsi<br />
contemporaneamente (mentre io vado a comprare l'uovo, tu prepara<br />
il tegame e scalda l'olio). Anche la <strong>di</strong>stinzione fra fase progettuale e
fase esecutiva può non essere chiara soprattutto quando quest'ultima<br />
è virtuale, non effettiva (cioè l'esecuzione è solo pensata).<br />
3.4.5. Finalità, motivazioni<br />
Il termine progetto, o meglio l'azione del progettare, può essere<br />
analizzato anche in altri mo<strong>di</strong>, tra cui uno che potremmo definire<br />
motivazionale che lo rapporti cioè alla situazione attuale, così come<br />
viene percepita da chi progetta. Si parla così delle finalità <strong>di</strong> un<br />
progetto o delle motivazioni che ci spingono ad esso.<br />
- Un ponte rischia <strong>di</strong> crollare: si chiami un ingegnere che faccia un<br />
progetto <strong>di</strong> consolidamento.<br />
- Voglio approfon<strong>di</strong>re la mia conoscenza dell'inglese: progetto un<br />
soggiorno in Inghilterra.<br />
- L'uso dei combustibili fossili mette a rischio la nostra<br />
sopravvivenza: occorre progettare più ampi stu<strong>di</strong> sulle fonti<br />
energetiche non inquinanti.<br />
(In quest'ultimo caso lo sta<strong>di</strong>o da progettare è ancora molto lontano<br />
dallo sta<strong>di</strong>o ultimo, che potrebbe effettivamente risolvere il problema.<br />
Questo però non dovrebbe esimerci dal dare inizio alla catena<br />
progettuale).<br />
3.4.6. Autonomia - eteronomia della progettualità
Sia le cause che le finalità che ci spingono a un progetto possono in<br />
varia misura <strong>di</strong>pendere dalla nostra volontà o da quella altrui, o anche<br />
da circostanze estranee al volere umano.<br />
In ogni caso sarebbe bene che ci rendessimo conto, per quanto<br />
possibile, della collocazione del progetto nell'universo della<br />
<strong>di</strong>screzionalità umana (cioè <strong>di</strong> ciò che noi uomini abbiamo deciso o<br />
possiamo decidere). In particolare dovremmo considerare i nostri<br />
progetti - sia virtuali che operativi - in relazione alla nostra autonomia<br />
<strong>di</strong> pensiero.<br />
Un esempio estremo (più volte riportato): un kamikaze progetta un<br />
attentato <strong>di</strong> cui sarà vittima lui stesso. Il suo progetto ha sicuramente<br />
una sua chiara collocazione nell'universo - politico, culturale religioso -<br />
che lui ben conosce (ma che a noi può apparire incomprensibile o<br />
nefasto); ma rientra, quel progetto, nell'ambito <strong>di</strong> una <strong>di</strong>screzionalità<br />
autonoma del suo autore? La risposta è per lui, probabilmente,<br />
positiva, per un osservatore esterno, probabilmente, negativa: il suo<br />
progetto è determinato da cause e finalità eteronome, che cioè non<br />
conseguono da una valutazione autonoma della situazione (così<br />
almeno pensa chi sta fuori).<br />
Anche progetti della nostra quoti<strong>di</strong>anità hanno spesso caratteristiche<br />
eteronome, anche quando a noi appaiono frutto della nostra<br />
autonomia.<br />
- Si rompe un elettrodomestico <strong>di</strong> vitale (?) importanza: non<br />
possiamo progettare <strong>di</strong> aggiustarlo noi stessi (anche se ne fossimo<br />
capaci), perché la fabbrica produttrice non vende i pezzi <strong>di</strong>
icambio, il nostro progetto non può essere che quello <strong>di</strong> ricorrere a<br />
quella fabbrica (o <strong>di</strong> ricomprare l'elettrodomestico).<br />
- Una giovane coppia progetta l'educazione del figlioletto: "Lo<br />
educheremo ai principi della nostra tra<strong>di</strong>zione". È evidente la<br />
collocazione del progetto nell'Universo Culturale Locale (UCL) <strong>di</strong><br />
quella tra<strong>di</strong>zione. Meno evidente l'autonomia <strong>di</strong>screzionale dei<br />
genitori (che potrebbero non aver considerato altre alternative). E<br />
che ne sarà dell'autonomia del figlio?<br />
(Qui non si vuole affatto privilegiare il concetto <strong>di</strong> autonomia<br />
in<strong>di</strong>viduale rispetto, per esempio, a un'autonomia <strong>di</strong> gruppo, <strong>di</strong><br />
cultura, <strong>di</strong> religione ecc. Si vuole soltanto in<strong>di</strong>rizzare l'attenzione sul<br />
grado <strong>di</strong> consapevolezza che informa i nostri progetti. Circa il binomio<br />
autonomia/eteronomia cliccare anche a riflettere, scegliere, valutare,<br />
comunicare...).<br />
3.4.7. Progetti in<strong>di</strong>viduali - progetti collettivi<br />
Fanno parte del quoti<strong>di</strong>ano sia gli uni degli altri: il progetto per lo<br />
svolgimento <strong>di</strong> un tema d'italiano dato in classe è in<strong>di</strong>viduale, il<br />
progetto <strong>di</strong> una gita scolastica è collettivo. Ma le cose stanno<br />
veramente in modo così semplice?<br />
Un progetto implicante l'uso del linguaggio verbale come appunto lo<br />
svolgimento <strong>di</strong> un tema, ha certo come componente collettiva il<br />
linguaggio stesso. Ma non solo: la maggior parte degli ingre<strong>di</strong>enti -<br />
materiali, concettuali, formali, logici... - con cui costruire i nostri
progetti non sono un'invenzione in<strong>di</strong>viduale, ma si trovano depositati<br />
in luoghi più meno accessibili della nostra cultura. In molti casi<br />
l'originalità, l'in<strong>di</strong>vidualità <strong>di</strong> un progetto sta solo nella ricombinazione<br />
locale <strong>di</strong> elementi noti. Anche le massime opere dell'ingegno<br />
coniugano in<strong>di</strong>vidualità e collettività in forme sempre <strong>di</strong>verse ma<br />
fruibili entro la cultura che ha contribuito a proporle. Un qualsiasi<br />
nostro progetto comunicativo prevede in un certo senso il ricevente e<br />
lo fa attraverso la propria componente collettiva.<br />
Viceversa il più collettivo dei progetti - poniamo: una religione - si<br />
avvale <strong>di</strong> numerosi sottoprogetti in<strong>di</strong>viduali, alcuni dei quali<br />
riconoscibili e attribuibili a questo o a quel Maestro, altri riassorbiti in<br />
un avvolgente anonimato.<br />
Le regole del gioco degli scacchi ci appaiono oggi come frutto <strong>di</strong> una<br />
convenzione - collettiva, appunto - ma ogni partita è una singolarità<br />
in<strong>di</strong>viduale.<br />
La <strong>di</strong>cotomia in<strong>di</strong>viduale/collettivo non è perseguibile indefinitamente,<br />
ma riguarda probabilmente gli strati più superficiali della<br />
progettazione. A un'analisi metaculturale più approfon<strong>di</strong>ta i due<br />
termini finiscono per confondersi.<br />
La loro opposizione va quin<strong>di</strong> conservata fin dove serve al progetto<br />
stesso, lasciando impregiu<strong>di</strong>cato lo spazio progettuale esterno (v.<br />
3.4.1.).<br />
Esempio:<br />
Scrivere una lettera d'amore è certo la fase esecutiva <strong>di</strong> un progetto<br />
in<strong>di</strong>viduale. Che poi nell'atto dello scrivere ci serviamo <strong>di</strong> qualche<br />
frase fatta o ad<strong>di</strong>rittura facciamo ricorso a modelli più o meno illustri
non cambia granché le cose. Il sentimento che ci spinge è per sempre<br />
cosa nostra, anche se somiglia - probabilmente - a un numero<br />
stragrande <strong>di</strong> sentimenti amorosi provati da altri. Dopo tutto l'amore<br />
risponde, per così <strong>di</strong>re, a un progetto biologico <strong>di</strong> sopravvivenza della<br />
specie, progetto - anzi superprogetto - che ci coinvolge tutti in quanto<br />
esseri viventi prima ancora che umani.<br />
L'uso <strong>di</strong> esprimere questo sentimento a parole nasce probabilmente<br />
con la parola stessa, così come la "lettera d'amore" ha bisogno, per<br />
essere progettata, della pratica della scrittura e questa <strong>di</strong> un<br />
opportuno co<strong>di</strong>ce grafico, tutte cose che, anche se usati<br />
in<strong>di</strong>vidualmente, in<strong>di</strong>viduali non sono, ma frutto <strong>di</strong> un accordo<br />
collettivo.<br />
E che succederà quando lei (o lui) riceverà la lettera? L'implicito (o<br />
esplicito, progetto in essa contenuto avrà una fase attuativa? E poi?<br />
3.5. Stile religioso-mistico<br />
Se mai qualcosa <strong>di</strong> universale è pre<strong>di</strong>cabile per la specie umana,<br />
questo è il pensiero religioso, che si ritrova presso tutti i popoli <strong>di</strong> cui<br />
si abbia notizia. Ciò non significa che questo tipo <strong>di</strong> pensiero sia o sia<br />
stato comune a tutti gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> una popolazione: singolarmente o<br />
per piccoli gruppi è probabile che la laicità sia anch'essa<br />
universalmente <strong>di</strong>ffusa, ma l'ufficialità delle culture si può <strong>di</strong>re che<br />
non la conosca, fino in tempi recentissimi. Questo perché religione e<br />
potere politico si associerebbero quasi automaticamente facendo della
prima il principale strumento del secondo. Un'interpretazione del<br />
genere appare tuttavia alquanto riduttiva e non è in grado neppure <strong>di</strong><br />
spiegare il meccanismo <strong>di</strong> tale associazione. Se il potere politico, che<br />
ha nel rapporto economico uno dei suoi punti <strong>di</strong> forza, ritiene <strong>di</strong> tanta<br />
importanza l'ancoraggio al pensiero religioso (ancora oggi evidente<br />
perfino negli stati democratici), vuol <strong>di</strong>re che questo pensiero occupa,<br />
estensivamente ed intensivamente, la maggioranza degli in<strong>di</strong>vidui.<br />
Non so se sia mai stato osservato l'insorgere spontaneo del pensiero<br />
religioso in un bambino. Potrebbe invero innestarsi su quella sorta <strong>di</strong><br />
animismo infantile che rende o finge viventi certi oggetti con cui il<br />
bambino viene in contatto; in ogni caso questo innesto è prodotto o<br />
almeno controllato dalla società (dall'UCL) <strong>di</strong> appartenenza. Non sono<br />
in grado <strong>di</strong> pronunciarmi su questi intricati rapporti che troppo<br />
somigliano al ben noto problema dell'uovo e della gallina.<br />
Una questione lungamente <strong>di</strong>scussa è se il bud<strong>di</strong>smo debba o no<br />
intendersi come una religione, dal momento che manca <strong>di</strong> una o più<br />
<strong>di</strong>vinità <strong>di</strong> riferimento (Buddha è piuttosto uno stato <strong>di</strong> coscienza - o<br />
<strong>di</strong> superamento della coscienza - che un'identificazione col <strong>di</strong>vino); <strong>di</strong><br />
interpretazione altrettanto problematica sono i culti animistici o il<br />
totemismo, da alcuni ritenuto estraneo a qualsiasi religione. Per<br />
questa ragione abbiamo scelto, per queste considerazioni, generiche<br />
più che generali, il termine (stile <strong>di</strong>) pensiero religioso anziché<br />
religione, troppo impegnativo sul piano concettuale.<br />
Del pari va detto che anche l'accoppiamento religioso-mistico nasce<br />
piuttosto da ragioni <strong>di</strong> simmetria con i titoli dei paragrafi precedenti<br />
che da più approfon<strong>di</strong>te riflessioni sull'argomento.
Che le correnti mistiche si formino all'interno delle religioni o, più<br />
prudentemente, del pensiero religioso è comunque una constatazione<br />
storica abbastanza facile a farsi. Altrettanto facile mostrare come la<br />
deriva mistica finisca non <strong>di</strong> rado per contrad<strong>di</strong>re le sue origini, al<br />
punto <strong>di</strong> sollecitare la condanna da parte del potere religioso. L'unio<br />
mystica del pensiero in<strong>di</strong>viduale con quello <strong>di</strong>vino, dell'Io con Dio è<br />
un'esperienza centrale <strong>di</strong> molte correnti mistiche. Per altre, che non si<br />
fondano sull'idea del <strong>di</strong>vino - ad esempio per il bud<strong>di</strong>smo -<br />
l'esperienza mistica è la liberazione dal dolore attraverso il<br />
superamento delle passioni e l'illuminazione che conduce al Nirvana,<br />
ovvero all'esperienza del vuoto.<br />
"Quando fluitai da Dio, tutte le cose mi parlarono: Dio è.<br />
Questo non mi può bastare, giacché in tal modo mi riconosco come<br />
creatura. Nell'irrompere però, nel liberarmi della mia volontà, <strong>di</strong> quella<br />
<strong>di</strong> Dio e <strong>di</strong> tutte le sue opere, più ancora, <strong>di</strong> Dio stesso, mi trovo sopra<br />
tutte le creature, né Dio né creatura, sono ciò che sono stato e<br />
resterò ora e per sempre. E ricevo una spinta che mi porta più in alto<br />
<strong>di</strong> tutti gli angeli. In questo slancio ricevo una tale ricchezza che Dio<br />
non mi può più bastare con tutto ciò che lo rende "Dio" e con tutte le<br />
sue opere <strong>di</strong>vine; giacché in questa irruzione comprendo che io e Dio<br />
siamo la stessa cosa. In quel momento sono quello che sono stato e<br />
non posso più né crescere né <strong>di</strong>minuire, perché sono la causa<br />
immobile che muove tutte le cose. Qui Dio non trova più il suo luogo<br />
nell'uomo, in quanto con questa povertà l'uomo raggiunge ciò che da<br />
sempre è stato e per sempre resterà. Qui Dio e tutt'uno con lo spirito<br />
e questa è la più profonda povertà che ci è dato incontrare".
Sorprende, in questo testo, tolto da una pre<strong>di</strong>ca del teologo e il<br />
filosofo Meister Eckhart (1260-1328), l'identificazione dell'unio<br />
mystica con la "più profonda povertà", con l'assoluta mancanza <strong>di</strong><br />
contenuto, con il vuoto <strong>di</strong> cui si è detto, singolarmente vicino al<br />
Nirvana dello stato <strong>di</strong> Buddha.<br />
E ancora:<br />
"Poni mente a questo miracolo! Il miracolo <strong>di</strong> essere fuori e dentro a<br />
un tempo, <strong>di</strong> comprendere ed essere compreso, <strong>di</strong> guardare ed essere<br />
il guardato, colui che tiene e colui che viene tenuto - ecco la meta<br />
dove lo spirito resta immobile nella quiete, unito all'amata eternità".<br />
Vista da IMC questa coincidentia oppositorum rimanda al nullificante<br />
Universo metaculturale (UMC) da cui dovremmo guardarci, sempreché<br />
ci teniamo alla sopravvivenza. Ma per il pensiero mistico, in<br />
particolare per Meister Eckhart, il problema della sopravvivenza si<br />
poneva in tutt'altro modo che ai giorni nostri, in quanto il misticismo<br />
cristiano poggia pur sempre su una religione rivelata <strong>di</strong> pone<br />
l'esistenza eterna, quale che ne sia la forma, a fondamento dell'idea<br />
stessa dell'essere.<br />
Nella cultura ebraica il pensiero mistico si raccoglie intorno alla<br />
Kabbala, insieme <strong>di</strong> tecniche interpretative dei sacri testi, a<br />
cominciare dalla Bibbia, dal Talmud, dalla Tora fino al Libro dello<br />
splendore, il Sohar, composto verso la fine del XIII secolo in Spagna,<br />
presumibilmente dal cabbalista Mosche de Leon. Centrale nella<br />
tra<strong>di</strong>zione cabbalistica è la figura <strong>di</strong> Isaak Luria (1534-1572) secondo<br />
cui meta del <strong>di</strong>venire mondano è la riconquista <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong>vino <strong>di</strong><br />
perfezione, meta da raggiungersi me<strong>di</strong>ante la speculazione sull'infinito
(??? p.80) e attraverso la trasmigrazione delle anime.<br />
La Kabbala ha fortemente influenzato la mistica cristiana e il pensiero<br />
alchemico del Rinascimento e ancora oggi agisce anche fuori<br />
dell'ambito religioso <strong>di</strong> origine. Più in generale il misticismo si può <strong>di</strong>re<br />
stia vivendo una nuova stagione popolare nel New Age e in certo Pop,<br />
certo assai lontana dai rigori filosofici <strong>di</strong> un Meister Eckhart e <strong>di</strong> un<br />
Nicola Cusano.<br />
Affini al pensiero mistico e talora confluenti sono le varie forme <strong>di</strong><br />
panteismo che si sono succedute nel corso <strong>di</strong> secoli. Anche l'idea <strong>di</strong><br />
Dio che Faust esprime a Margherita nella prima parte del Faust<br />
goethiano risente fortemente dell'atteggiamento panteistico del<br />
giovane poeta, cui del resto non era affatto estranea la cultura<br />
ermetico-cabbalistica ancora sopravvivente nel secolo dei lumi:<br />
Chi oserà nominarlo?<br />
Chi <strong>di</strong>chiarerei<br />
credo in lui<br />
Chi affermare<br />
con convinzione:<br />
non credo<br />
Lui che tutto abbraccia<br />
e tutto mantiene<br />
non abbraccia e mantiene<br />
anche me, te, sé stesso?<br />
Non s'inarca il cielo sopra <strong>di</strong> noi?<br />
Non sta ferma la terra quaggiù?<br />
E non salgono le stelle eterne
con sguardo amico?<br />
Non guarda il mio occhio il tuo e<br />
non tende tutto in me<br />
verso il tuo cuore, il tuo volto?<br />
......<br />
chiamalo come vuoi<br />
destino! cuore! amore! Dio!<br />
Non ho un nome per lui!<br />
Il sentimento è tutto;<br />
un nome: suono vuoto e vapore<br />
che annebbiano l'ardore celeste.<br />
Oggi il pensiero scientifico, con tutt'altri mezzi <strong>di</strong> quelli che poteva<br />
avere un alchimista rinascimentale, ripropone a più riprese una<br />
visione unitaria della fisica, ora nel segno della relatività generale, ora<br />
in quello dei costituenti elementari della materia, ora nei tentativi <strong>di</strong><br />
fondere i due approcci in un'unica teoria onnicomprensiva. Sembra<br />
che l'iperrazionalità del misticismo (per esempio nell'opera del filosofo<br />
della natura C. F. von Weizsäcker). Del resto anche il Tractatus logico-<br />
philosophicus <strong>di</strong> Ludwig Wittganstein, uno dei pensatori più rigorosi<br />
del 900, chiude con la citatissima proposizione:<br />
"Di ciò <strong>di</strong> cui non si può parlare, conviene tacere",<br />
generalmente interpretata, al <strong>di</strong> là della razionalità logica rivelatasi<br />
tautologica, come un'apertura incon<strong>di</strong>zionata al pensiero mistico.<br />
Questa interpretazione non risulta tuttavia confermata dalle<br />
successive Philosophische Untersuchungen (Ricerche filosofiche).<br />
Una visione per così <strong>di</strong>re a soffietto, che ora concentra il tutto nell'io,
ora <strong>di</strong>ffonde l'io nel tutto, è rappresentata dalla seguente parabola:<br />
Io alla sesta<br />
Gli occhi gli si aprirono e l'alterità lo sommerse. A essere precisi<br />
l'alterità si era manifestata già da prima, al più tar<strong>di</strong> dal punto in cui<br />
un movimento si era reso percepibile. Si erano dati infatti il<br />
movimento e la percezione del movimento, anche se la <strong>di</strong>stinzione era<br />
avvenuta solo in seguito. Ma anche ora l'alterità faceva tutt'uno con<br />
l'atto che la riconosceva, una forma primitiva dell'io cosciente. Ma<br />
come faceva l'alterità a rendersi irriconoscibile? Attraverso la luce<br />
(anche <strong>di</strong> questo ci si rese conto molto più tar<strong>di</strong>). E così erano in tre:<br />
l'io primitivo, l'alterità e la luce.<br />
Ma non ci si fermò a questo: nell'alterità si scorgevano trasmutazioni,<br />
movimenti <strong>di</strong> parti su altre parti. Ecco per esempio delle piccole forme<br />
semoventi che, non appena entravano in collisione, producevano altre<br />
sensazioni, piacevoli o spiacevoli. Forme più gran<strong>di</strong> confluivano tra<br />
loro per poi separarsi <strong>di</strong> nuovo e sembrava quasi <strong>di</strong> poter dominare<br />
col proprio movimento quest'alterità fluttuante. Qualche volta ci si<br />
riusciva, qualche volta no e questo era irritante, al punto che si<br />
strillava. Ma io e alterità si appartenevano - e come avrebbe potuto<br />
essere <strong>di</strong>versamente - solo che questa mostrava una incomprensibile<br />
tendenza alla fuga.<br />
Passarono i giorni, le settimane, i mesi, e dall'impersonalità si passò a<br />
un lui personale e questo lui imparò a <strong>di</strong>scernere: l'alterità continuava<br />
ad appartenergli, ma in una forma, per così <strong>di</strong>re, scissa. C'era l'io e
c'era il mio, cioè tutto il resto, sia che fosse d'accordo sia che no.<br />
Qualche anno dopo si vide che non era il molteplice ad appartenergli,<br />
ma lui al molteplice. E questo era troppo vasto e invadente per essere<br />
sopportato e così lui pensò <strong>di</strong> proteggere il suo io ritagliando dalla<br />
vastità del molteplice un molteplice più ristretto, formato da esseri<br />
che gli somigliavano e con i quali aveva <strong>di</strong>mestichezza: membri della<br />
sua famiglia, compagni <strong>di</strong> scuola, amici ecc.. Gli sembrò che il suo io<br />
avesse afferrato e ricondotto a sé parte dell'alterità perduta, ora però<br />
come oggetto <strong>di</strong> un senso <strong>di</strong> responsabilità finora sconosciuto.<br />
Un giorno apprese dalla TV - o lesse su un giornale - <strong>di</strong> uno che si era<br />
ferito - forse a morte - sul lavoro - o era durante un gioco? - e gli<br />
sembrò che anche questo lo riguardasse, quasi che l'altrui dolore<br />
fosse anche dolore suo. Una sciagura ferroviaria in In<strong>di</strong>a, un<br />
terremoto nell'America meri<strong>di</strong>onale, una guerra in Africa..., ma anche<br />
un successo nella ricerca me<strong>di</strong>ca, una scoperta archeologica, l'azzardo<br />
<strong>di</strong> un gol, perfino una vincita eccezionale al lotto, tutto questo era<br />
anche affar suo, e così si scelse una professione rivolta all'uomo: non<br />
un semplice impegno umanitario ma un'attività che penetrasse<br />
profondamente nella vita umana.<br />
Dall'io ristretto, attraverso l'io tribale, l'io sociale fino all'io<br />
antropologico, questo io si era allargato senza abbandonare la sfera<br />
egoistica: egoismo dell'uomo come specie.<br />
E così si risvegliò in lui la coscienza <strong>di</strong> non appartenere soltanto alla<br />
specie umana, ma all'intero mondo dei viventi, alla vita in quanto<br />
tale: attirò nel suo egoismo l'albero abbattuto, una specie estinta <strong>di</strong><br />
insetto, un leone assetato: sentimento biologico dell'io.
Da ultimo, contro le forze fisiche che lo stavano abbandonando, liberò<br />
le forze centrifughe del suo io sull'acqua, pietre, stelle e galassie. Gli<br />
parve allora, non che tutto rifluisse in lui, ma che tutto - egoità,<br />
alterità - defluisse da lui nell'inattingibilità del cosmo:<br />
l'Io alla sesta potenza.<br />
E i suoi occhi si richiusero.<br />
Siamo alquanto lontani dal pensiero religioso da cui siamo partiti,<br />
soprattutto dalle versioni dogmatiche che abbiamo sotto gli occhi,<br />
eppure non si saprebbe negare a una visione come quella esposta<br />
nella citata parabola una latente problematica religiosa. Come non la<br />
si saprebbe negare all'"Anticristo" <strong>di</strong> Nietzsche, che per tutta la sua<br />
vita ha avversato la pietà cristiana pur essendone profondamente<br />
imbevuto. Dalla sua famosa frase "Dio è morto" (La gaia scienza, libro<br />
III, 125) è stata recentemente derivata un'interpretazione del dettato<br />
evangelico che legherebbe il sacrificio <strong>di</strong> Cristo al superamento<br />
dell'idea <strong>di</strong> Dio, in altre parole alla frase nietzschiana. Ecco <strong>di</strong> che si<br />
tratta.<br />
Lo Jahvè del Vecchio Testamento era ormai avvertito (dagli Ebrei)<br />
come un <strong>di</strong>o possessivo, spietato, ven<strong>di</strong>cativo, corruttibile, in nulla<br />
migliore dei suoi colleghi mesopotamici. Per liberare il popolo ebraico<br />
dalla millenaria schiavitù non c'era che uccidere Jahvè. Ma come si fa<br />
a uccidere un <strong>di</strong>o, per giunta unico e onnipotente? Identificandosi con<br />
lui come uomo e lasciandosi uccidere. Questo il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> Gesù:<br />
<strong>di</strong>chiararsi figlio <strong>di</strong> Dio e partecipare quin<strong>di</strong> della natura <strong>di</strong>vina pur<br />
mostrandosi come uomo e quin<strong>di</strong> mortale. Essendo una e in<strong>di</strong>visibile
la natura <strong>di</strong>vina, la sua morte terrena avrebbe significato la morte <strong>di</strong><br />
Dio stesso. Di qui l'accordo con Giuda, semplice uomo senza <strong>di</strong>vinità.<br />
La Salvazione sarebbe così opera umana, garantita proprio da Giuda,<br />
anche lui <strong>di</strong>sposto al sacrificio.<br />
Gli uomini purtroppo non hanno voluto intendere il senso <strong>di</strong> questo<br />
superbo <strong>di</strong>segno e lo hanno tra<strong>di</strong>to facendo <strong>di</strong> Gesù proprio ciò che lui<br />
si era prefisso <strong>di</strong> abbattere.<br />
Numerosi sono gli in<strong>di</strong>zi che nei Vangeli, sia in quelli ufficiali che in<br />
quelli apocrifi, danno a<strong>di</strong>to a questa interpretazione. Che<br />
naturalmente, come ogni interpretazione, si pone in parallelo ad altre<br />
senza pretendere <strong>di</strong> rappresentare la verità. È anzi poco probabile che<br />
una simile idea <strong>di</strong> salvazione potesse maturare nel popolo ebraico in<br />
quegli anni, quando tutt'altro doveva essere il rapporto con il <strong>di</strong>vino<br />
che al giorno d'oggi. Ciò non toglie che un'ipotesi come quella qui<br />
presentata sia possibile nelle con<strong>di</strong>zioni attuali, dove la sopravvivenza<br />
<strong>di</strong>pende, assai più che dalla grazia <strong>di</strong>vina, dalla capacità dell'uomo <strong>di</strong><br />
farne a meno e <strong>di</strong> cavarsela col solo ausilio della propria mente e del<br />
senso <strong>di</strong> responsabilità verso sé stesso e gli altri viventi. Non credo<br />
del resto che una tale responsabilità, se saremo in grado <strong>di</strong><br />
assumerla, sia incompatibile col pensiero religioso, qualunque esso<br />
sia.<br />
3.6. Stile magico-<strong>di</strong>vinatorio<br />
Potremmo considerare questo stile <strong>di</strong> pensiero con una
sottospecificazione del pensiero religioso, se non fosse che alcune<br />
religioni vi si opporrebbero, a cominciare da quella cristiana. La figura<br />
<strong>di</strong> Cristo peraltro mostra molti tratti - i miracoli, le pre<strong>di</strong>zioni - comuni<br />
ai maghi, sacerdoti <strong>di</strong> Zaratustra, come forse è simboleggiato<br />
dall'arrivo <strong>di</strong> tre <strong>di</strong> loro a Betlemme.<br />
Tuttora Gesù viene spesso invocato per ottenere interventi tipo<br />
magico - guarigioni, ritrovamenti, vincite - non <strong>di</strong>versi da quelli<br />
richiesti, in altre culture, ad antenati, spiriti protettori, sciamani.<br />
Anche la Chiesa ufficiale, in particolari occasioni - per esempio nelle<br />
procedure <strong>di</strong> santificazione - non rifugge dal dare cre<strong>di</strong>to a fenomeni<br />
evidentemente <strong>di</strong> tipo magico come le guarigioni improvvise. Alcuni<br />
nostri luoghi <strong>di</strong> culto - Lourdes, Loreto ecc. - sono <strong>di</strong> fatto luoghi <strong>di</strong><br />
pratiche magiche o, se si preferisce, <strong>di</strong> religiosità pagana, così come il<br />
culto delle immagini, ostacolato in certi perio<strong>di</strong> dalle chiese orientali,<br />
prende spesso il posto del contatto <strong>di</strong>retto con la <strong>di</strong>vinità nella<br />
preghiera. Anche la forte astrazione dell'arte bizantina si lascia<br />
interpretare come un invito ai fedeli <strong>di</strong> trascendere il mondo reale e i<br />
suoi corpi fisici per raggiungere, attraverso l'immagine e non in essa,<br />
la sfera del sovrannaturale, del <strong>di</strong>vino. Il cammino inverso è stato<br />
percorso, dopo il mille, in occidente, quando l'immagine ha man mano<br />
preso il posto <strong>di</strong> ciò che essa rappresenta, un processo tipicamente<br />
magico (<strong>di</strong> magia simpatetica) che da allora continua a caratterizzare<br />
sempre più la nostra religiosità quoti<strong>di</strong>ana. Si pensa al culto della<br />
Madonna nera o alle innumerevoli immagini <strong>di</strong> Padre Pio che<br />
costellano negozi, ristoranti, abitacoli <strong>di</strong> camion, spesso in compagnia<br />
<strong>di</strong> più avvenenti figure femminili... La stessa funzione magico-religiosa
viene esercitata da oggetti-simbolo che non necessariamente<br />
riproducono naturalisticamente il personaggio significato, per esempio<br />
gli ex-voto. Ricordo, nel 1942, un tratto delle mura aureliane a Roma,<br />
che, dopo il bombardamento del quartiere <strong>di</strong> S. Lorenzo si riempì<br />
improvvisamente, attorno a un'e<strong>di</strong>cola della Madonna, <strong>di</strong> centinaia <strong>di</strong><br />
ex-voto, anche gran<strong>di</strong> e costosi.<br />
Ero ancora poco più che un bambino, eppure mi chiesi che altro<br />
potevano significare quegli ex-voto se non "Ti ringrazio, o mio<br />
Signore, che hai fatto morire il mio vicino <strong>di</strong> casa e non me".<br />
Il pensiero magico - che nel caso riportato si configura, a cose fatte,<br />
come ringraziamento - pervade non sono i rituali religiosi, ma anche<br />
quelli domestici, quoti<strong>di</strong>ani. Pratiche <strong>di</strong> scongiuro, oggetti<br />
portafortuna, formule propiziatorie sono all'or<strong>di</strong>ne del giorno e sono<br />
rare le persone che, potendo, non evitano <strong>di</strong> incrociare un gatto nero<br />
o <strong>di</strong> passare sotto una scala o <strong>di</strong> fare il nome <strong>di</strong> uno "che porta iella".<br />
È d'obbligo a questo punto il riferimento alla novella La patente <strong>di</strong><br />
Pirandello. Ed è probabile che anche il più scettico in fatto <strong>di</strong> magia<br />
nasconda tratti <strong>di</strong> superstizione e compia, quasi inconsapevolmente,<br />
micropratiche apotropaiche. Non siamo nemmeno sicuri che le<br />
scienze, segnatamente quelle me<strong>di</strong>che, così come la psicologia e la<br />
psicoanalisi siano del tutto estranee al pensiero magico. Un conto è il<br />
reale potere terapeutico <strong>di</strong> un certo me<strong>di</strong>cinale, un altro la fede in<br />
esso. Si parla spesso <strong>di</strong> effetto placebo: ma siamo in grado <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stinguere chiaramente tra effetto placebo reale potere terapeutico?<br />
E quando giochiamo al lotto o invochiamo la fortuna per una nostra<br />
impresa, siamo sicuri <strong>di</strong> essere immuni da contaminazioni magiche?
Il secolo dei lumi, il 700, procede <strong>di</strong>rettamente, per inversione, dai<br />
due precedenti, che avevano visto, in Europa, il trionfo della magia<br />
alchemica. La chimica e la fisica moderna nascono sul terreno<br />
dell'alchimia e l'opposizione ad essa è più apparente che reale.<br />
Keplero, l'interprete matematicamente rigoroso del moto dei pianeti,<br />
era un alchimista. Del resto anche la fede degli illuministi nella<br />
ragione come strumento <strong>di</strong> indagine della realtà presupponeva la<br />
razionalità del reale, un a priori logico non <strong>di</strong>ssimile da<br />
un'identificazione magica <strong>di</strong> un rappresentato con ciò che lo<br />
rappresenta. A ben guardare, ogniqualvolta un modello conoscitivo -<br />
sia esso il modello <strong>di</strong> newtoniano, quello relativistico <strong>di</strong> Einstein o i<br />
modelli logici della stessa attività pensante - viene, anche se<br />
provvisoriamente, identificato con il reale, possiamo parlare <strong>di</strong><br />
pensiero magico. Magica è l'ipostasi del numero presso i pitagorici,<br />
dell'idea in Platone, dell'idea <strong>di</strong> Dio in quelle religioni - e sono la<br />
maggior parte - che ce l'hanno. Un fisico dei nostri giorni, Roger<br />
Penrose, autore tra l'altro <strong>di</strong> un libro dal titolo The Road to reality (La<br />
strada che porta alla realtà, 2004, in Italia 2005) usa assai spesso i<br />
termini magia, miracolo sia per le teorie puramente matematiche<br />
come quella dei numeri complessi, sia per le teorie fisiche che in<br />
quelle matematiche hanno un modello interpretativo <strong>di</strong> stupefacente<br />
precisione.<br />
Forse proprio allo stile magico è riservato il compito <strong>di</strong> raggiungerla,<br />
questa realtà, o è quest'ultima a non essere altro che un prodotto<br />
della nostra mente cosicché il suo raggiungimento equivarrebbe a un<br />
atto metaculturale <strong>di</strong> riflessione.
Gli stu<strong>di</strong>osi del pensiero magico <strong>di</strong>stinguono praticamente tra magia<br />
simpatetica (che fa uso <strong>di</strong> simulacri), da contatto (che si serve <strong>di</strong><br />
pozioni, unguenti ecc.), incantesimi (formule propiziatorie o<br />
male<strong>di</strong>zioni), <strong>di</strong>vinazioni. In mancanza <strong>di</strong> maggiori conoscenze, mi<br />
soffermerò brevemente su quest'ultimo tipo, <strong>di</strong> larghissima <strong>di</strong>ffusione<br />
anche attuale.<br />
Gli antichi consideravano le <strong>di</strong>vinazioni, manifestazioni in<strong>di</strong>rette del<br />
<strong>di</strong>vino attraverso l'interpretazione che sacerdoti e aruspici davano <strong>di</strong><br />
fenomeni naturali come fulmini, terremoti, congiunzioni stellari, volo<br />
<strong>di</strong> uccelli ecc., o ricavavano dall'osservazione <strong>di</strong> interiora <strong>di</strong> animali,<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> foglie o carte, o infine dal responso <strong>di</strong> oracoli. In altre<br />
culture la pre<strong>di</strong>zione del futuro così come le pratiche propiziatorie<br />
erano e sono compito degli sciamani o stregoni in cui si incarna uno<br />
dei massimi poteri della comunità (confluenza <strong>di</strong> politica, religione e<br />
magia).<br />
Nella nostra cultura attuale le pratiche <strong>di</strong>vinatorie sono perlopiù<br />
degradate a gioco <strong>di</strong> società: fare le carte, leggere l'oroscopo o i fon<strong>di</strong><br />
del caffè. La credenza in queste pratiche viene detta (o tacciata <strong>di</strong>)<br />
superstizione, così come si tende a liquidare con questo termine<br />
anche contenuti <strong>di</strong> fede propri <strong>di</strong> altre religioni, per esempio africane o<br />
in<strong>di</strong>ane. Non si vede però in che cosa la credenza nell'intercessione<br />
dei santi o della Madonna <strong>di</strong>fferisca da quella nella protezione <strong>di</strong> una<br />
deità in<strong>di</strong>ana o <strong>di</strong> un qualche antenato tribale. In tutti i casi si tratta <strong>di</strong><br />
esorcizzare la paura <strong>di</strong> un futuro che ci appare incerto e pericoloso,<br />
affidandoci a forze che quel futuro conoscerebbero e potrebbero
orientare a nostro favore.<br />
Credo che pochi chiederebbero a un in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong> svelargli l'ora precisa<br />
della propria morte. Oltretutto, se lo facessero, sarebbe per aggirarla,<br />
cioè per smentire l'indovino contrad<strong>di</strong>cendo la ragione stessa per cui<br />
si sono rivolti a lui. L'arte <strong>di</strong>vinatoria lavora contro la <strong>di</strong>rezionalità del<br />
tempo, ma da questa ricava il suo potere nel momento che pretende<br />
<strong>di</strong> invertirla conoscitivamente. Nella realtà fenomenica tale inversione<br />
è resa impossibile dal secondo principio della termo<strong>di</strong>namica (che<br />
postula come necessario l'incremento dell'entropia); ma, se alla<br />
conoscenza togliamo la fisicità dei meccanismi cerebrali che la<br />
producono, nulla osta a che anche il futuro ci sia conoscitivamente<br />
accessibile. Chi per esempio crede nello spirito in quanto in<strong>di</strong>pendente<br />
dalla materia non dovrebbe avere <strong>di</strong>fficoltà ad ammettere la<br />
<strong>di</strong>vinazione, e non per questo dovremmo chiamarlo credulone o<br />
superstizioso. Non siamo peraltro neppure sicuri che la stessa<br />
materia, in qualche sua forma, per esempio all'interno <strong>di</strong> un buco<br />
nero, sia del tutto incompatibile con un tempo, <strong>di</strong>ciamo così,<br />
retrogrado. Sembra che, se fosse possibile un superamento della<br />
velocità della luce, anche la freccia del tempo dovrebbe<br />
necessariamente invertirsi.<br />
Alcuni stili <strong>di</strong> pensiero godono del pubblico riconoscimento, altri<br />
vengono avversati dal potere. Un tempo il pensiero scientifico veniva,<br />
da noi, condannato al rogo dal pensiero religioso, oggi questo<br />
continua ad accadere in forme meno violente ma non per questo<br />
meno persuasive, mentre in altre culture vige ancora la repressione<br />
violenta. Reciprocamente la cultura scientifico-tecnologica, congiunta
a un'immagine ideologizzata <strong>di</strong> democrazia, tende a imporsi<br />
sull'insieme delle altre, talora con la forza, talaltra con la pressione<br />
economica, sempre però a detrimento del nostro pianeta e <strong>di</strong> tutti<br />
coloro che lo abitano.<br />
Come il lettore <strong>di</strong> queste note e, in genere, delle cose che an<strong>di</strong>amo<br />
pubblicando già saprà, non è nostra intenzione demonizzare alcuno<br />
stile <strong>di</strong> pensiero, neppure quello dogmatico che probabilmente è il più<br />
lontano da IMC; tantomeno inten<strong>di</strong>amo esaltare quelli che la nostra<br />
attuale cultura privilegia, in particolare lo stile ipotetico-relativistico<br />
(3.2.2.) proprio della scienza. In accordo con IMC, che produce<br />
anch'essa un suo stile (3.12.), il problema si pone per noi in termini<br />
formativi: come rendere l'in<strong>di</strong>viduo e, tramite lui, la società<br />
consapevoli <strong>di</strong> questi stili e capaci <strong>di</strong> modularli tra loro così come la<br />
situazione lo richiede. Pensiamo che questo processo <strong>di</strong> autoanalisi<br />
debba avere inizio assai per tempo, sempre al fine <strong>di</strong> rendere<br />
l'in<strong>di</strong>viduo quanto più possibile responsabile dei suoi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> pensiero<br />
e quin<strong>di</strong> delle sue scelte operative.<br />
Il mondo del bambino, così come lo costruisce l'adulto fin dagli inizi, è<br />
intriso <strong>di</strong> magia: dagli animaletti <strong>di</strong> pelouche, veri e propri totem<br />
infantili, alle fiabe antiche e moderne, oggi rese visibili dalla TV, ai<br />
babbi natale, befane, fate, è tutto un pullulare <strong>di</strong> esseri immaginari<br />
dotati <strong>di</strong> poteri soprannaturali.<br />
Dovremmo privare il bambino <strong>di</strong> questo mondo in cui lui sembra<br />
trovarsi assai bene e senza sforzo? Le opinioni sono <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>: c'è chi<br />
reputa queste finzioni non necessarie, anzi forse dannose per lo<br />
sviluppo mentale del bambino, che si abituerebbe a ricreare in una
ealtà fittizia il sod<strong>di</strong>sfacimento dei suoi desideri, c'è invece che<br />
considera in<strong>di</strong>spensabile allo sviluppo armonico della personalità una<br />
prolungata permanenza in un mondo <strong>di</strong> pura fantasia. Più che<br />
pronunciarmi per l'una o l'altra tesi preferisco ancora una volta<br />
relativizzare il problema alle con<strong>di</strong>zioni locali: il bambino e il suo<br />
intorno non sono entità astratte, ma variabili così come lo saranno<br />
l'adulto e la società in cui si troverà a vivere. Ciò che conta è che un<br />
poco alla volta l'in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong>venti consapevole dei suoi rapporti con la<br />
complessità del mondo, in cui realtà e immaginazione, passato e<br />
futuro, storia e previsione si intrecciano in quello che consideriamo<br />
presente. Anche la riflessione critica non <strong>di</strong>strugge necessariamente la<br />
componente fantastica <strong>di</strong> una fiaba, la sostituisce piuttosto con<br />
l'umorismo, come <strong>di</strong>mostrano i personaggi <strong>di</strong>sneyani e i molti altri che<br />
popolano i cartoni animati e la moderna letteratura per l'infanzia.<br />
Ecco per esempio alcune storielle, tolte dal nostro sito, nelle quali è<br />
evidente l'intento <strong>di</strong> ricondurre streghe e fate alla quoti<strong>di</strong>anità senza<br />
per questo <strong>di</strong>struggerne l'incanto.<br />
- C'era una volta una buona fata, vecchissima e piena <strong>di</strong> rughe. I<br />
bambini le volevano un gran bene. Da un pezzo la vecchia fata non<br />
riusciva più a fare gli incantesimi. Anzi nessuno si ricordava <strong>di</strong><br />
averglieli mai visti fare. Eppure bambini e adulti le volevano un<br />
gran bene. Per essere una buona fata non c'è bisogno <strong>di</strong> saper fare<br />
gli incantesimi. E neppure <strong>di</strong> essere giovane e bella.<br />
- Le streghe da giovani assomigliano alle fate. Le fate da vecchie<br />
assomigliano alle streghe. Un giorno bambino incontrò una fata <strong>di</strong>
mezza età. O era una strega? Non era né l'una né l'altra. Era la<br />
vicina <strong>di</strong> casa.<br />
- Due fate s'incontrano. "Ciao - <strong>di</strong>ce l'una - come te la passi?" "Non<br />
c'è male - <strong>di</strong>ce l'altra - lavoro." "E che cosa fai?" "Manici <strong>di</strong> scopa<br />
per streghe."<br />
......<br />
Due streghe s'incontrano. "Ciao - <strong>di</strong>ce l'una - come te la passi?"<br />
"Non c'è male - <strong>di</strong>ce l'altra - lavoro." "E che cosa fai?" "Bacchette<br />
magiche per fate."<br />
- Una fata viveva sola in un vecchio castello semi<strong>di</strong>strutto dal tempo<br />
e dall'incuria. Il castello si lamentava spesso con la fata. Un giorno<br />
le <strong>di</strong>sse: "Perché mi lasci andare in rovina? Non ricor<strong>di</strong> come<br />
splendevo, alto su questa rocca, quando re e cavalieri della<br />
leggenda venivano alle mie porte chiedendo aiuto alla tua magia, o<br />
quando volavamo <strong>di</strong> incanto nelle fiabe e nei sogni dei bambini? E<br />
oggi? Gnomi e folletti, che un tempo mi lucidavano da cima a<br />
fondo, da un bel pezzo si sono trasformati in gufi e topi grigi; la tua<br />
alata corte <strong>di</strong> elfi è oggi una colonia <strong>di</strong> pipistrelli e tu stessa sempre<br />
più una vecchia custode che una fata. Se hai ancora un po' <strong>di</strong><br />
magia con te, perché non ci restituisci l'antico splendore?"<br />
"Mio vecchio e buon castello - rispose la fata - ma proprio non hai<br />
capito? Abbiamo conosciuto il tempo dei sogni, della fiaba, della<br />
leggenda... Oggi conosciamo il tempo della vita reale. Questo è il<br />
mio più potente incantesimo, e definitivo".<br />
La realtà: un incantesimo, una magia. Ci viviamo dentro, siamo
abituati ad essa. Immaginiamo un terrestre <strong>di</strong> pochi secoli fa, dei<br />
tempi, <strong>di</strong>ciamo, <strong>di</strong> Dante o dell'Ariosto. L'irrealtà fantastica dei loro<br />
viaggi è <strong>di</strong> gran lunga superata dalla realtà o<strong>di</strong>erna. E non tanto per le<br />
velocità oggi raggiungibili sulla terra e nello spazio quanto per la quasi<br />
istantaneità della comunicazione a <strong>di</strong>stanza. Chi utilizza la ra<strong>di</strong>o, la<br />
TV, i telefonini e Internet, non è detto si renda conto dell'immagine<br />
del mondo che la loro tecnologia implica.<br />
I nostri sensi e il pensiero che da essi è alimentato, conservano<br />
tuttora un'immagine ingenua del mondo, la stessa che Newton ha<br />
perfettamente matematizzato, ma che non corrisponde più a quella<br />
informatica che scienza e tecnologia oggi ci prospettano.<br />
L'informazione che ci giunge da una lontana galassia si è conservata<br />
intatta per milioni, miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> anni... o forse è meglio <strong>di</strong>re che il suo<br />
presente si estende nello spazio creando il tempo o, viceversa, che il<br />
suo luogo si propaga nel tempo creando lo spazio. E se insistiamo,<br />
come alcuni scienziati fanno, a considerare l'universo sub specie<br />
informationis, dobbiamo concludere che esso è racchiuso o<br />
rispecchiato in ogni suo punto, giacché possiamo ipotizzare ricevitori<br />
così potenti da captarne comunque l'intera informazione. Esistono<br />
inoltre delle teorie quantistiche che ipotizzano la coesistenza <strong>di</strong> più<br />
<strong>di</strong>versi tra loro non comunicanti.<br />
La più grande delle magie è però la congruenza tra la realtà,<br />
sperimentalmente indagata, e il pensiero matematico. Tale congruità<br />
è, almeno da Newton in poi, l'apriori <strong>di</strong> ogni ricerca che voglia essere<br />
scientifica. E la sua magia è tale che, ogniqualvolta una nuova<br />
osservazione sembra minare alle basi l'e<strong>di</strong>ficio teorico
matematicamente costruito, il pensiero reagisce inventando (o<br />
scoprendo) un nuovo modello, una nuova matematica, in grado <strong>di</strong><br />
sod<strong>di</strong>sfare e la nuova realtà osservata e la coerenza logica del<br />
sistema. Credo che questo procedere parallelo della conoscenza, dei<br />
suoi modelli matematici e della logica che ne governa l'interazione<br />
possa <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto considerarsi frutto <strong>di</strong> magia. Ed è questa l'unica realtà<br />
<strong>di</strong> cui abbiamo esperienza.<br />
La fata della storiella aveva fatto l'incantesimo giusto.<br />
3.7. Stile storicistico-identitario<br />
Molti ragazzi hanno l'abitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tenere un <strong>di</strong>ario, e anche alcuni<br />
adulti. Perché lo fanno? Per ricordarsi a sé stessi? Per riconoscersi in<br />
una documentazione scritta? Per raccomandarsi alla posterità?<br />
Ma non solo gli in<strong>di</strong>vidui tengono un <strong>di</strong>ario, lo fanno anche le<br />
comunità, le società, le nazioni, e allora si parla <strong>di</strong> storia. La storia<br />
come strumento <strong>di</strong> identificazione sia sul fronte interno, sia su quello<br />
esterno. La parola storia tuttavia ha molteplici significati alla cui<br />
origine sta forse l'effettivo andamento dei fatti, delle relazioni umane:<br />
realtà nel suo concreto svolgimento. Ma la realtà si svolge nel tempo;<br />
nulla la trattiene e sarebbe quin<strong>di</strong> incomprensibile se non ci fosse la<br />
memoria a conservare la traccia. E anche a questa traccia abbiamo<br />
dato il nome <strong>di</strong> storia. I popoli letterati hanno ulteriormente fissato<br />
questa traccia tramite la scrittura, i popoli illetterati si sono affidati<br />
alla tra<strong>di</strong>zione orale. I primi hanno spesso vantato la propria
superiorità sui secon<strong>di</strong> definendoli privi <strong>di</strong> storia quando non erano<br />
ovviamente privi <strong>di</strong> realtà e neppure <strong>di</strong> memoria storica, ma solo della<br />
notificazione scritta.<br />
Questa <strong>di</strong>venta probabilmente in<strong>di</strong>spensabile quando la complessità<br />
sociale supera un certo limite, ma resta più o meno pleonastica o<br />
semplicemente esornativa per i gruppi più ristretti. Nelle società <strong>di</strong><br />
tipo tribale la funzione identitaria viene svolta, più che dalla storia, da<br />
simboli totemici <strong>di</strong> appartenenza, dal culto degli anziani, da pratiche<br />
religiose con<strong>di</strong>vise. Nelle società letterate restano tracce, talora<br />
vistose, <strong>di</strong> tali portatori della funzione identitaria: così il concetto,<br />
ancora strenuamente <strong>di</strong>feso, <strong>di</strong> famiglia, così gli stessi nomi propri,<br />
variante letterata, <strong>di</strong> simboli totemici.<br />
A livello <strong>di</strong> comunità domina tuttavia su tutti l'idea <strong>di</strong> storia, ormai<br />
fissata definitivamente dalla scrittura. Anche qui siamo in presenza <strong>di</strong><br />
un residuo magico per cui la parola scritta non è solo un mezzo per<br />
comunicare ma essenzialmente una garanzia <strong>di</strong> conservazione: "Verba<br />
volant, scripta manent". E una cosa che si reputa degna <strong>di</strong> essere<br />
conservata ha certo un rapporto <strong>di</strong>retto con la verità (?)<br />
La storia scritta è comunque più affidabile <strong>di</strong> quella trasmessa solo<br />
oralmente... (?)<br />
Le nostre più antiche fonti storiche scritte - per esempio gli Annales<br />
della Roma repubblicana - danno effettivamente l'impressione <strong>di</strong><br />
essere oggettive, <strong>di</strong> raccontare soltanto dei fatti, non dei fatti<br />
osservati (e allora ci sarebbe da chiedersi da chi) e tanto meno<br />
interpretati; quando invece è ovvia la presenza <strong>di</strong> punti <strong>di</strong> vista non<br />
<strong>di</strong>chiarati. Più tar<strong>di</strong>, con l'avvento <strong>di</strong> una storiografia più attenta alle
cause che ai fatti - in Grecia per esempio già con Erodoto - alla<br />
semplice esposizione si sovrappone l'interpretazione, o meglio la<br />
stessa esposizione viene riconosciuta come un primo sta<strong>di</strong>o<br />
dell'interpretazione.<br />
Il senso critico si affina e la storiografia si sofferma,<br />
autoriflessivamente, su sé stessa, sulla metodologia con cui osserva,<br />
indaga. I fatti man mano sfumano i loro contorni ed emerge<br />
l'impalcatura interpretativa, vera protagonista della storiografia<br />
moderna.<br />
Si potrebbe pensare che un tale processo <strong>di</strong> relativizzazione abbia<br />
indebolito la funzione identitaria attribuita originariamente alla storia<br />
fissata attraverso la scrittura.<br />
Questo è forse avvenuto, dopo la seconda guerra mon<strong>di</strong>ale, in alcuni<br />
paesi, ma, anche lì, solo in ristrette minoranze, mentre allo stato<br />
attuale stiamo assistendo piuttosto a un ritorno <strong>di</strong> istanze identitarie,<br />
anche storiche, a giustificazione <strong>di</strong> conflitti causati da ben altri<br />
interessi.<br />
Ricordo ancora i retorici richiami alla romanità nel periodo fascista,<br />
formalmente non <strong>di</strong>ssimili dagli attuali richiami alle ra<strong>di</strong>ci cristiane<br />
dell'Europa, solo che oggi la popolazione destinataria <strong>di</strong> questi<br />
richiami è assai più ampia <strong>di</strong> quella un tempo invitata a riconoscersi<br />
nella romanità.<br />
Per la singolare congiuntura storica che stiamo vivendo, alla<br />
risorgente istanza identitaria si affianca oggi l'istanza opposta della<br />
globalizzazione planetaria. Ambedue assumono assai spesso forme<br />
ideologiche che portano acriticamente a scontri che non solo non
isolvono l'opposizione ma l'acuiscono fino a farne un reale pericolo<br />
per la nostra sopravvivenza. Dalle considerazioni fin qui fatte - tutte<br />
ovvie e risapute - risulta fin troppo evidente una presa <strong>di</strong> posizione<br />
contraria alle ideologie identitarie. Vorrei ora correggere questa<br />
posizione in senso metaculturale, avanzando un'interpretazione<br />
positiva, se non delle ideologie identitarie, almeno della ricerca <strong>di</strong><br />
identità in un'epoca nella quale il periodo <strong>di</strong> un appiattimento delle<br />
culture su modello unico (quello concorrenziale-capitalistico) è sotto<br />
gli occhi <strong>di</strong> tutti.<br />
Le scienze bio-ecologiche ritengono oggi la <strong>di</strong>versità, anzi la<br />
<strong>di</strong>versificazione come fondamento dei processi evolutivi in quanto<br />
forniscono alla variabilità ambientale sempre nuovo materiale su cui<br />
esercitare la sua pressione selettiva.<br />
In altre parole, proprio la proprietà del vivente <strong>di</strong> riprodursi per<br />
microvarianti (che tuttora si considerano casuali) assicurerebbe alla<br />
biosfera la plasticità necessaria alla sua sopravvivenza. Non è detto<br />
che la stessa ipotesi (chè <strong>di</strong> questo si tratta) possa estendersi anche<br />
all'universo delle culture umane. Potrebbe per esempio darsi il caso<br />
che un universo culturale in<strong>di</strong>fferenziato abbia per l'intera biosfera<br />
una marca negativa, sia cioè <strong>di</strong> ostacolo alla sua sopravvivenza. Gli<br />
in<strong>di</strong>zi non mancano, dall'inquinamento atmosferico, all'effetto serra,<br />
alla desertificazione <strong>di</strong> vaste aree, alla sparizione <strong>di</strong> molte specie<br />
animali e vegetali... Se così fosse, la <strong>di</strong>minuita <strong>di</strong>fferenziazione<br />
culturale potrebbe precludere alla sparizione anche della specie<br />
umana. Se viceversa l'evoluzione culturale dovesse per certi versi<br />
omologarsi a quella biologica, l'attuale riaffermarsi <strong>di</strong> istanze
identitarie potrebbe significare una compensazione evolutiva alla<br />
globalizzazione intesa come appiattimento sull'unico modello del<br />
Welfare occidentale.<br />
Al solito il problema non è <strong>di</strong> tipo aut-aut, ma <strong>di</strong> modulazione<br />
(meta)culturale tra modelli. Il modello identitario e quello<br />
globalizzante debbono accordarsi almeno su un punto, se mirano<br />
ambedue alla sopravvivenza della nostra specie: equilibrare a livello<br />
planetario il fabbisogno e il consumo energetico. Questi non sono<br />
peraltro gli stessi per ogni modello culturale; è importante comunque<br />
che l'adozione <strong>di</strong> un modello piuttosto che <strong>di</strong> un altro sia conseguenza<br />
<strong>di</strong> una scelta e non della sopraffazione <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> essi, come<br />
attualmente accade. È infatti possibile, anche se non probabile, che si<br />
innesti una corsa al ribasso dei consumi, quando un certo numero <strong>di</strong><br />
culture si dotassero <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> valori <strong>di</strong>versi da quelli dell'o<strong>di</strong>erna<br />
cultura del consumo.<br />
Tutto ciò è ovviamente teorico per non <strong>di</strong>re utopico, ma forse anche<br />
in<strong>di</strong>spensabile alla sopravvivenza, e allora, se a questa ci teniamo,<br />
non c'è che da rifletterci su seriamente.<br />
Ma ritorniamo allo stile <strong>di</strong> pensiero qui tematizzato. Abbiamo appaiato<br />
col solito trattino lo stile storicistico - cioè il pensiero storico - a quello<br />
identitario, supponendo che lo sviluppo del primo avesse a che fare<br />
con le istanze provenienti dal secondo.<br />
Converrà ora, per evitare confusioni che potrebbero avere<br />
conseguenze negative in campo metodologico, <strong>di</strong>stinguere là dove<br />
avevamo congiunto.<br />
Per molto tempo il pensiero storico si è asservito a quello identitario,
e non c'è bisogno <strong>di</strong> tornare a Tito Livio e alla prospettiva agiografica<br />
delle sue Deca<strong>di</strong>, è sufficiente confrontare libri <strong>di</strong> storia in uso fino a<br />
pochi decenni fa nelle scuole <strong>di</strong> nazioni <strong>di</strong>verse per rendersi conto <strong>di</strong><br />
quanto, almeno a livello formativo, la storiografia ufficiale fosse legata<br />
a intenti identitari. La storiografia più accorta batteva tuttavia altre<br />
strade e oggi è largamente penetrata anche nei testi <strong>di</strong>vulgativi e<br />
scolastici, pur restando tuttora sostanzialmente limitata agli<br />
acca<strong>di</strong>menti europei o almeno a quelli che hanno avuto macroscopici<br />
riflessi sulla storia europea. A questa apertura ha fatto tuttavia<br />
seguito un <strong>di</strong>verso muoversi della storia verso particolarismi etnici,<br />
religiosi, culturali che attendono ancora un atten<strong>di</strong>bile interpretazione<br />
storiografica.<br />
In molti casi - nell'ex Jugoslavia per esempio o in certe frange<br />
dell'Islam, ma anche nell'atteggiamento della Chiesa in casa nostra -<br />
si sono viste nuovamente forzature storiche in <strong>di</strong>rezione identitaria.<br />
Per contro alcune derive ideologiche globalizzante e antiidentitarie<br />
hanno demonizzato il concetto stesso <strong>di</strong> cultura in nome <strong>di</strong> un<br />
in<strong>di</strong>vidualismo in contrad<strong>di</strong>zione con le sue stesse premesse: identità<br />
non più culturale ma singola, globalizzazione senza società, senza<br />
storia.<br />
Per venire a capo <strong>di</strong> queste contrad<strong>di</strong>zioni, non per eliminarle, ma per<br />
ricomporle in una prospettiva <strong>di</strong> sopravvivenza, pensiamo sia utile<br />
<strong>di</strong>stinguere tra storia - che in ogni caso va considerata come storia<br />
interpretata - e identità (etnica, razziale, religiosa, nazionale ecc.).<br />
Questa sarebbe bene, se non altro per ragioni metodologiche, che non<br />
piegasse la storia ai propri fini, come quoti<strong>di</strong>anamente avviene. Solo
allora potremmo ricollocare il trattino <strong>di</strong> congiunzione tra le due<br />
parole per osservarne storicamente il cammino parallelo, senza che<br />
questo parallelismo si tramuti in sovrapposizione.<br />
Nell'ottica pedagogica del CMC anche il primo approccio al pensiero<br />
storico deve passare per il concetto <strong>di</strong> interpretazione.<br />
Sono molti i progetti del nostro sito che implicano questo concetto. Mi<br />
limito a citarne uno, basato su un doppio testo che narra uno stesso<br />
fatto secondo due interpretazioni opposte (progetto......)<br />
Ieri ho visto<br />
(Due testimonianze)<br />
I<br />
Ieri ho visto una scena terribile: un grosso cane lupo - ma forse era<br />
proprio lupo - che cercava <strong>di</strong> azzannare una bambina. Questa non<br />
aveva coraggio <strong>di</strong> scappare perché sapeva che l'animale era molto più<br />
veloce <strong>di</strong> lei. Per <strong>di</strong>fendersi gli ha dato prima da mordere una specie <strong>di</strong><br />
coperta, già a brandelli, poi, vedendo che quello non desisteva, ha<br />
cercato <strong>di</strong> <strong>di</strong>strarlo buttando lontano la palla con cui giocava. Questo<br />
per due o tre volte, infine la bambina, terrorizzata, mentre l'altro<br />
aggre<strong>di</strong>va la palla, si è nascosta <strong>di</strong>etro un albero, ma invano... Non so<br />
come è andata a finire perché sono corso via a chiedere aiuto.<br />
II<br />
Ieri ho visto una scena deliziosa: una bambina che giocava con un<br />
cane lupo più grosso <strong>di</strong> lei. Cercavano <strong>di</strong> strapparsi a vicenda una
vecchia coperta a brandelli, ma si vedeva chiaramente che il cane<br />
tirava piano per non far cadere la bambina. Poi lei ha cominciato a<br />
lanciargli una palla e quello correva a riprenderla. Questo per due o<br />
tre volte, finché la bambina si è nascosta <strong>di</strong>etro un albero, e il cane<br />
per un po' ha fatto finta <strong>di</strong> non trovarla...<br />
A una certa <strong>di</strong>stanza c'era un altro bambino che evidentemente<br />
avrebbe voluto giocare anche lui, ma qualcuno deve averlo<br />
richiamato, perché un certo punto è corso via...<br />
Nel lavoro relativo a questi testi si invitano gli alunni a <strong>di</strong>stinguere tra<br />
fatto accaduto, fatto osservato e fatto interpretato.<br />
Anche questa <strong>di</strong>stinzione viene tuttavia posta in <strong>di</strong>scussione, e si è<br />
visto che, nelle concrete esperienze condotte in classe, la <strong>di</strong>stinzione<br />
tra fatto accaduto e fatto osservato è meno netta delle altre due; i<br />
bambini sarebbero cioè propensi, come del resto gli adulti, ad<br />
ammettere l'oggettività dell'osservazione pur concedendo la variabilità<br />
dell'interpretazione. Alcuni bambini tendono a identificare<br />
osservazione e interpretazione, mantenendole <strong>di</strong>stinte dal fatto, altri<br />
infine considerano errate le interpretazioni che non corrispondono a<br />
una presunta oggettività del fatto osservato.<br />
Come è nostra abitu<strong>di</strong>ne, lasciamo aperta la <strong>di</strong>scussione: non è<br />
importante che si giunga a una conclusione unanime (questa potrebbe<br />
rivelarsi auspicabile quando si tratta <strong>di</strong> prendere una decisione<br />
collettiva), importante è l'attivazione del pensiero nella <strong>di</strong>versità delle<br />
opinioni.
Anche al secondo termine che compare nel titolo <strong>di</strong> questo paragrafo,<br />
(stile <strong>di</strong> pensiero) identitario il nostro sito riserva alcuni progetti, <strong>di</strong><br />
cui uno si basa sul seguente testo:<br />
Che vuol <strong>di</strong>re essere italiani?<br />
(Circuito autogenerativo)<br />
Sara, Franz, Melitta, Teo, Jaqueline, Omar<br />
T: Che strano: siamo tutti italiani ma solo io ho un vero nome<br />
italiano...<br />
M: ... be', proprio italiano... semmai greco se non sbaglio...<br />
J: Il mio nome, poi, <strong>di</strong> italiano non ha niente: sono nata a Boston e<br />
mia madre è americana e mi ha dato il nome in omaggio a Jaqueline<br />
Kennedy...<br />
O: Che però portava un nome francese...<br />
S: Almeno io porto un nome ebraico e sono <strong>di</strong> famiglia ebrea...<br />
F: ... mentre io sono napoletano e m'hanno chiamato Franz, chissà<br />
perché.<br />
S: I nomi non vogliono <strong>di</strong>re niente, siamo tutti italiani perché parliamo<br />
italiano.<br />
M: Veramente noi a casa parliamo un po' la<strong>di</strong>no e un po' tedesco, è<br />
che siamo <strong>di</strong> Sankt Ulrich, cioè <strong>di</strong> Ortisei in val Gardena.<br />
T: E allora com'è che parli così bene l'italiano?<br />
M: L'ho imparato qui a scuola con voi.<br />
O: Io lo parlo fin da piccolo, ma i miei genitori sono <strong>di</strong> Bengasi e<br />
qualche volta, quando non vogliono farsi capire, parlano arabo, ma io
li capisco.<br />
J: Io poi con mia madre parlo inglese...<br />
S: ... e io sto imparando l'ebraico perché da grande vorrei trasferirmi<br />
in Israele.<br />
F: Perché? Non ci stai bene qui in Italia?<br />
S: Sì che ci sto bene, ma vorrei tornare alla terra dei miei avi.<br />
T: Sciocchezze. Gli ebrei in Italia ci stanno fin dal Me<strong>di</strong>oevo.<br />
S: Sì, ma la Bibbia...<br />
T: E allora Cristo...<br />
O: Era nato in Palestina, quin<strong>di</strong> era ebreo...<br />
M: E allora, tutti in Palestina!<br />
J: La religione non conta. Ci sono italiani cattolici, ebrei, musulmani...<br />
F: ... anche italiani che non credo in Dio ma credono nel malocchio,<br />
come mia nonna.<br />
M: Ma allora: non conta il nome, non conta la lingua, non conta la<br />
religione, non contano gli antenati... che cos'è che conta per<br />
chiamarsi italiani?<br />
O: Sulla carta d'identità dei miei genitori c'è scritto: "citta<strong>di</strong>nanza<br />
italiana", vuol <strong>di</strong>re che qualcuno, la polizia, penso, o il comune li<br />
riconosce come italiani.<br />
T: Vuol <strong>di</strong>re che tutto <strong>di</strong>pende da un pezzo <strong>di</strong> carta...<br />
O: ... no, da chi l'ha rilasciato, cioè dalla polizia o dal comune, che<br />
rappresentano lo stato italiano.<br />
J: Quin<strong>di</strong> siamo italiani se lo stato ci riconosce come tali.<br />
M: Ma se quelli dello stato neppure ci conoscono!<br />
F: No, ma sanno che cosa siamo.
S: E che cosa siamo?<br />
F: Siamo italiani.<br />
Il testo ha struttura circolare, termina cioè là dove è iniziato: quelli<br />
dello stato (come <strong>di</strong>ce Melitta) sanno che siamo italiani perché ce lo<br />
<strong>di</strong>cono loro. Le cose non stanno forse in maniera così semplice e<br />
varrebbe la pena <strong>di</strong> continuare a <strong>di</strong>scutere. Il circuito autogenerativo<br />
descritto nel testo è fittizio, ma quelli reali, da noi sperimentati nelle<br />
scuole primarie, arrivano quasi sempre ad analoghe non conclusioni.<br />
3.8. Stile social-politico<br />
I due termini, sociale e politico, non sono certo sinonimi, anzi è bene,<br />
nella maggior parte dei casi, tenerli ben <strong>di</strong>stinti, anche se la<br />
<strong>di</strong>stinzione non è sempre agevole. Un'attenzione al sociale la troviamo<br />
sia a sinistra che a destra, politicamente parlando. Nazismo e<br />
fascismo erano per molti aspetti più socialisti dell'Unione Sovietica ai<br />
tempi <strong>di</strong> Stalin, ma non per questo le collocheremo nell'area politica <strong>di</strong><br />
sinistra. Oggi poi si assiste non <strong>di</strong> rado a uno scambio <strong>di</strong> ruoli, per cui<br />
alcune liberalizzazioni economiche - un argomento tra<strong>di</strong>zionalmente <strong>di</strong><br />
destra - viene caldeggiato più da sinistra che da destra. Lo stesso<br />
concetto <strong>di</strong> democrazia gode oggi <strong>di</strong> una certa ubiquità, potendosi<br />
trovare, ideologicamente impugnato, in ogni schieramento politico.<br />
Lasciamo però da parte lo stato attuale, fortemente perturbato, della<br />
vita politica. Qui ci interessa lo stile, l'orientamento del pensiero, e
allora conviene <strong>di</strong>stinguere tra sociale e politico, per scomodo che ciò<br />
possa essere, sempre pronti tuttavia ricercare i collegamenti,<br />
simboleggiati al solito dal trait d'union.<br />
Laddove socialismo mantiene una coloratura politica che per il<br />
momento non ci deve interessare, il semplice aggettivo sociale non fa<br />
che rimandare allo statuto biologico dell'homo sapiens come animale<br />
sociale. Né questo termine si oppone a in<strong>di</strong>viduo, come forse pensa<br />
chi nell'in<strong>di</strong>viduo si rifiuta <strong>di</strong> riconoscere la predominanza della<br />
componente culturale, <strong>di</strong> cui è madre, appunto, la società. Così come<br />
è un'ovvietà sostenere che la società è composta da in<strong>di</strong>vidui e che<br />
quin<strong>di</strong> sono questi a caratterizzare quella. Come già detto più volte,<br />
pensiamo che le opposizioni e le stesse <strong>di</strong>stinzioni abbiano una<br />
valenza metodologica piuttosto che ontologica, vadano quin<strong>di</strong><br />
chiamate in causa quando servono e non quando a richiederle è<br />
l'ideologia. Nel caso in <strong>di</strong>scussione la <strong>di</strong>stinzione in<strong>di</strong>viduo/società non<br />
è funzionale al nostro <strong>di</strong>scorso; lo è invece, anche se solo<br />
provvisoriamente, l'altra, tra sociale e politico, come già detto.<br />
C'è piuttosto da chiedersi se e fino a che punto l'uomo è un animale<br />
sociale. Che lo sia nella prima infanzia è <strong>di</strong>mostrato solo in un senso,<br />
nel bisogno che il bambino ha dell'adulto. Ma nessuno <strong>di</strong>rebbe una<br />
tigre un animale sociale perché i tigrotti hanno bisogno della madre o<br />
la femmina del maschio. Più tar<strong>di</strong> il bambino viene educato alla<br />
socialità, il che non significa ancora che ce l'abbia per istinto. Gli altri<br />
primati conosciuti hanno, se così si può <strong>di</strong>re, una socialità limitata, i<br />
pongi<strong>di</strong> in particolare, i più vicini a noi per patrimonio genetico, si<br />
associano per piccoli gruppi ed è probabile che i primi omini<strong>di</strong>
facessero lo stesso. Tra i mammiferi le sterminate orde <strong>di</strong> gnu si<br />
stenterebbe a definirli società perché manca ogni apprezzabile<br />
organizzazione interna. Un branco <strong>di</strong> lupi è certamente più<br />
gerarchizzato, uno <strong>di</strong> elefanti mostra anche abbozzi <strong>di</strong> funzionalità<br />
interna. Vere società, nel senso complesso che noi <strong>di</strong>amo alla parola,<br />
si trovano forse soltanto presso alcune (poche) specie <strong>di</strong> insetti -<br />
formiche, api, vespe, termiti -, e in queste la complessità sociale non<br />
è secondaria, cioè acquisita con l'educazione (come per l'uomo), ma<br />
primaria, cioè congenita.<br />
Possiamo fare l'ipotesi che nella specie umana il linguaggio si sia<br />
evoluto proprio come strumento <strong>di</strong> coesione sociale ma anche <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fferenziazione tra gruppi più o meno estesi. Al posto <strong>di</strong> un mancante<br />
o insufficiente istinto sociale l'uomo avrebbe cioè sviluppato un<br />
sistema <strong>di</strong>fensivo basato su una comunicazione assai più articolata<br />
che negli altri animali. Secondo questa ipotesi sarebbe il linguaggio<br />
verbale, la parola, a fondare la società, come molto più tar<strong>di</strong> sarà la<br />
parola scritta a moltiplicarne e rafforzarne le funzioni interne.<br />
All'esterno la <strong>di</strong>fferenziazione delle lingue e, parallelamente, delle<br />
strutture sociali avrebbe portato alla separazione, prima solo fisica poi<br />
anche ideologica, tra i gruppi, restringendo ad essi la nostra socialità.<br />
Tra gruppi <strong>di</strong>fferenti il sentimento prevalente è l'inimicizia che si<br />
manifesta sostanzialmente in due forme, assai poco sociali: lo<br />
sfruttamento o l'eliminazione.<br />
Non essendo io un antropologo, ignoro se questa ipotesi sia più o<br />
meno fondata; conosco solo, come tutti, i due termini finali,<br />
sfruttamento, eliminazione. Quest'ultima non è necessario avvenga
con l'uccisione in massa (tuttora in uso), può anche essere raggiunta<br />
attraverso l'assimilazione - uni<strong>di</strong>rezionale o reciproca. Tutto questo è<br />
stato possibile per millenni, senza che entrasse in pericolo la specie<br />
umana. Anche stragi delle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> quelle avvenute nel secolo<br />
scorso non hanno impe<strong>di</strong>to una crescita demografica senza<br />
precedenti, essa stessa pericolosa per la nostra sopravvivenza. Oggi<br />
l'umanità e forse la vita stessa non resisterebbero a un conflitto<br />
atomico globale (e qualsiasi conflitto locale rischia l'incontrollabilità).<br />
Non resta quin<strong>di</strong> che estendere la nostra socialità acquisita a tutto il<br />
genere umano eliminando, non questo o quel gruppo nemico, ma il<br />
concetto stesso <strong>di</strong> nemico, da sostituire con quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso amico.<br />
Amico non tanto in senso morale o filantropico, quanto piuttosto in<br />
quello <strong>di</strong> necessario alla nostra sopravvivenza.<br />
Anche questa nuova, estesa socialità pensiamo vada raggiunta<br />
attraverso l'educazione che tuttavia dovrà, si vuole farsi garante <strong>di</strong><br />
sopravvivenza, ricercare altre vie da quelle fin qui battute. Proprio<br />
perché la nostra socialità non è uno schema geneticamente trasmesso<br />
- e quin<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficabile solo in tempi eccessivamente lunghi -, ma una<br />
struttura culturalmente mo<strong>di</strong>ficabili anche in tempi brevi, la<br />
responsabilità dei nostri sistemi formativi, a cominciare dalla scuola, è<br />
molto maggiore che non per il passato. Di questo non sembra però<br />
che i giovani, i partiti politici e forse neppure l'uomo della strada, si<br />
siano accorti, vista la scarsa attenzione <strong>di</strong>ffusa per i problemi <strong>di</strong><br />
metodologie formativa. Come mai?<br />
Anche qui, più che risposte, possono darsi solo proposte<br />
interpretative. La quoti<strong>di</strong>anità ci asse<strong>di</strong>a - tutti, ricchi e poveri,
sfruttati e sfruttatori - con problemi che in<strong>di</strong>vidualmente ci appaiono<br />
<strong>di</strong> importanza vitale e che per questo siamo portati a generalizzare e<br />
a estendere a tutta l'umanità, così per esempio i problemi economici e<br />
<strong>di</strong> ripartizione delle risorse materiali. Questi problemi certamente<br />
esistono, e non si saprebbe sopravvalutarne l'importanza, ma non<br />
sono primari, almeno nell'interpretazione che ne stiamo dando.<br />
Primaria sarebbe lo stile <strong>di</strong> pensiero con cui l'uomo li affronta, stile<br />
ancora culturalmente legato alla salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> ciò che è locale,<br />
mentre la nostra attuale località è il pianeta su cui viviamo,<br />
infinitamente piccolo nell'universo, ma tuttora troppo grande per<br />
essere fatto oggetto <strong>di</strong> un pensiero capace <strong>di</strong> misurarsi con esso.<br />
Perché globalità planetarie e pensiero umano <strong>di</strong>vengano congruenti<br />
cre<strong>di</strong>amo serva una mutazione antropologica, possibile proprio in<br />
quanto la nostra socialità è acquisita e mo<strong>di</strong>ficabile: la mutazione<br />
della con<strong>di</strong>zione culturale a una metaculturale, in grado <strong>di</strong><br />
relativizzare le culture a una involvente cultura <strong>di</strong> sopravvivenza.<br />
Ritorneremo su questo punto nell'ultimo paragrafo <strong>di</strong> questo capitolo,<br />
rimandando per ora a quanto detto nel Preconcetto-Premessa (1.2.)<br />
su IMC.<br />
Questo breve excursus sulla socialità culturale dell'uomo ci porta al<br />
secondo termine della <strong>di</strong>ade in questione: stile (social)politico.<br />
Secondo Max Weber per politica s'intende un'aspirazione al potere e al<br />
monopolio legittimo dell'uso della forza. È un'interpretazione<br />
decisamente pessimistica del termine, anche se è <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>ssociarlo<br />
del tutto dall'idea <strong>di</strong> potere, soprattutto considerando i casi reali.<br />
Nell'utopia anarchica il potere, più che abolito, verrebbe ripartito tra
tutti i membri della società: è la forma estrema del socialismo, ogni<br />
tanto riaffiorante nella storia, anche in veste religiosa, e presente in<br />
molte parole d'or<strong>di</strong>ne rivoluzionarie (per esempio nel liberté, égalité,<br />
fraternité della rivoluzione francese).<br />
Al suo opposto troviamo il socialismo <strong>di</strong> stato, dove il potere è<br />
concentrato in forma anonima nell'idea <strong>di</strong> stato, rappresentante e<br />
unico gestore della volontà del popolo. Sappiamo tutti quanto nel<br />
socialismo reale il potere fosse anonimo e quanto il popolo (?) si<br />
riconoscesse in esso.<br />
Non è però solo il comunismo della versione staliniana ad aver<br />
usurpato il potere e la volontà del popolo. In forme meno smaccate<br />
quasi ogni uomo politico fa lo stesso quando sostiene <strong>di</strong> parlare a<br />
nome <strong>di</strong>... Ma, si <strong>di</strong>rà, almeno in democrazia c'è la delega attraverso il<br />
voto a legittimare il politico. E non c'è solo il voto, c'è anche il<br />
consenso che si esprime in vario modo, per esempio con la presenza<br />
fisica e il plauso delle masse...<br />
Non intendo affatto <strong>di</strong>sconoscere i meriti della democrazia né avrei da<br />
contrapporle alcun modello politicamente più affidabile. Anche il<br />
socialismo, meno reale ma forse più realistico, assume oggi ovunque<br />
una veste democratica che gli restituisce cre<strong>di</strong>bilità e ne fa un modello<br />
- un sottomodello - più competitivo nei confronti del capitalismo,<br />
questo pure, ovviamente, democratico. Il punto non è quin<strong>di</strong><br />
democrazia o..., ma quale democrazia. Perfino la Deutsche<br />
Demokratische Republik <strong>di</strong> staliniana memoria si fregiava <strong>di</strong> questo<br />
aggettivo passepartout.<br />
Il termine democrazia ha dunque scarso significato fin quando non lo
sottospecifichiamo in qualche modo.<br />
Una prima <strong>di</strong>stinzione interna riguarda<br />
- la democrazia <strong>di</strong>retta o partecipativa<br />
- la democrazia in<strong>di</strong>retta o rappresentativa.<br />
La prima ci riporta <strong>di</strong> fatto al socialismo originario e massimalista della<br />
cui natura utopica si è già detto. Oggi tuttavia lo sviluppo della<br />
tecnologia e delle telecomunicazioni sembrano avvicinarci a<br />
quell'orizzonte utopico e non mettono più del tutto fuori causa la<br />
democrazia <strong>di</strong>retta. Per il momento tuttavia non c'è molto da contarci.<br />
Resta la democrazia rappresentativa, verso cui si stanno orientando<br />
con maggiore o minore convinzione quasi tutti i paesi che chiamiamo<br />
civili. Sia detto tra parentesi: noi chiamiamo civili quei paesi che<br />
adottano forme democratiche <strong>di</strong> governo, il che a lume <strong>di</strong> logica è una<br />
petitio principii, che non <strong>di</strong>mostra nulla. Non mancano tuttavia nel<br />
panorama politico mon<strong>di</strong>ale forti opposizioni al concetto <strong>di</strong><br />
democrazia, soprattutto da parte religiosa. Per esempio, la religione<br />
cattolica plaude alla democrazia quando viene esercitata all'esterno, la<br />
esclude al suo interno. Lo stesso fa certo Islam moderato (quello<br />
estremista si regola, come sappiamo, altrimenti). Chiameremmo per<br />
questo il Cattolicesimo o l'Islam religioni incivili?<br />
Sia come sia, la democrazia avanza o per forza propria o per<br />
l'interesse <strong>di</strong> chi vuole che avanzi.<br />
Ripetiamo: quale democrazia?<br />
Quella in<strong>di</strong>retta, parlamentare, l'unica oggi possibile.<br />
Osserviamola un poco più da vicino. Alcuni principi sembrano<br />
assodati:
- la <strong>di</strong>visione dei poteri in legislativo (il parlamento)<br />
- il suffragio universale<br />
- la laicità dello stato<br />
esecutivo (il governo)<br />
giu<strong>di</strong>ziario (la magistratura)<br />
- la tutela dei <strong>di</strong>ritti fondamentali (civili, politici, sociali).<br />
Di questi principi quello che regge tutti gli altri è il suffragio<br />
universale. Sono gli elettori a esprimere la cosiddetta volontà<br />
popolare. Ma per esprimerla bisogna averla; tutti, uno per uno,<br />
debbono averla, e allora non sarà una volontà collettiva, popolare, ma<br />
la somma <strong>di</strong> tante e variegate volontà in<strong>di</strong>viduali. A decidere quale<br />
sarà la volontà determinante è la maggioranza, e qui si presenta il<br />
primo ostacolo o, se si vuole, la prima ingiustizia: alcune volontà sono<br />
<strong>di</strong> serie A (quelle della maggioranza), altre <strong>di</strong> serie B (quelle della<br />
minoranza). Questo in<strong>di</strong>pendentemente dal loro valore - ai fini della<br />
sopravvivenza, dell'equilibrio sociale, del welfare...<br />
Ma la democrazia (non in tutte le sue forme) ha provveduto anche a<br />
garantirsi dall'errore degli elettori. Le elezioni si propongono ogni<br />
certo numero <strong>di</strong> anni. Chi si è sbagliato o non è stato sod<strong>di</strong>sfatto nella<br />
sua aspettativa voterà <strong>di</strong>versamente la prossima volta, cosicché entro<br />
un congruo lasso <strong>di</strong> tempo l'equilibrio tra le forze in campo sarà<br />
raggiunto.<br />
È la democrazia bipolare o dell'alternanza, oggi ritenuta migliore<br />
garante <strong>di</strong> stabilità che non la democrazia pluripartitica. Questa dava<br />
infatti ai partiti minori un potere destabilizzante e <strong>di</strong> ricatto nei<br />
confronti dei partiti maggiori, al tempo stesso tuttavia garantiva più
efficacemente i <strong>di</strong>ritti delle minoranze.<br />
Ma che cosa sono, come si costituiscono i partiti?<br />
Per Max Weber sono libere associazioni che hanno l'obiettivo <strong>di</strong><br />
raccogliere voti. Per altri, meno drasticamente, hanno in comune<br />
anche una certa visione della società, dello stato e della sua gestione.<br />
A questa visione possiamo dare il nome <strong>di</strong> ideologia. C'è anche chi<br />
considera la partitocrazia una degenerazione della democrazia; la<br />
nostra costituzione comunque li prevede esplicitamente. All'interno<br />
del parlamento i partiti sono rappresentati dai gruppi parlamentari,<br />
facenti capo a un leader o segretario <strong>di</strong> partito.<br />
Lo stato democratico ha come presupposto la libertà - <strong>di</strong> opinione e <strong>di</strong><br />
espressione - dei citta<strong>di</strong>ni votanti. Si suppone cioè che nessun fattore<br />
con<strong>di</strong>zionante ne determini l'azione <strong>di</strong> voto. Una tale supposizione è<br />
del tutto irrealistica oltreché fuorviante. Proprio perché animale<br />
educato alla socialità l'uomo non è libero <strong>di</strong> agire e forse neanche <strong>di</strong><br />
pensare in perfetta autonomia. D'altronde lo stesso ambiente,<br />
fortemente antropizzato, in cui vive e le stesse sue abitu<strong>di</strong>ni culturali<br />
ne influenzano le scelte. E così fanno le correnti <strong>di</strong> opinione che<br />
traversano la società, in particolare le ideologie e le religioni. Come<br />
può <strong>di</strong>rsi libero mentalmente un cattolico o un ebreo praticante? O un<br />
convinto comunista o un fascista? Si <strong>di</strong>rà che lo sono per scelta,<br />
religiosa o politica. Ma quando e come avrebbero scelto? Da bambini,<br />
in famiglia, a scuola? Dopo aver conosciuto e valutato tutte le<br />
alternative?<br />
Nessuno pensa che la parola libertà voglia estendersi a tutte le scelte<br />
possibili. Ma almeno a quelle principali, riguardanti la vita o la morte
del singolo e del gruppo... Se così fosse non ci sarebbero state<br />
guerre, stermini, non ci sarebbero eroi e kamikaze. Chi andrebbe<br />
deliberatamente a farsi ammazzare se fosse libero <strong>di</strong> non farlo. E non<br />
c'è solo la costrizione fisica, la minaccia, il ricatto... assai più efficace<br />
la pressione ideologica: <strong>di</strong>fesa della patria, dei valori, delle ra<strong>di</strong>ci...<br />
ancora più efficace, questa pressione, se esercitata da un leader<br />
carismatico, capace <strong>di</strong> convincere, <strong>di</strong> sostituire con il proprio il<br />
pensiero della moltitu<strong>di</strong>ne.<br />
Ricordo quanto questa sostituzione fosse <strong>di</strong>lagante nella Germania<br />
nazista o nell'Italia fascista, dove la parola del Fuhrer o del Duce<br />
risuonava da ogni parte e riempiva libri, giornali, manifesti... Sì,<br />
perché anche il carisma non è solo della persona che lo esercita, ma<br />
anche dei mezzi comunicativi che lo costruiscono. Allora si andava<br />
dall'altoparlante che ne amplificava a <strong>di</strong>smisura la voce alla ra<strong>di</strong>o che<br />
ne faceva risuonare ogni casa, alla carta stampata che la ridondava<br />
per l'occhio. Non era certo facile sottrarsi a questa violenza verbale<br />
che investiva l'intera società, ma violenza ideologica che la sottendeva<br />
era più sottile e penetrante perché perpetrata sull'in<strong>di</strong>viduo<br />
subdolamente fin dall'infanzia. Le principali armi del potere sono la<br />
propaganda e l'educazione, i cannoni e i missili vengono dopo, quando<br />
la popolazione è stata convinta a pagare <strong>di</strong> tasca propria la loro<br />
fabbricazione, e con la vita <strong>di</strong> molti il loro uso.<br />
Tutto questo vale per ieri. Oggi le cose stanno <strong>di</strong>versamente: c'è la<br />
democrazia!<br />
A parte il fatto che la democrazia non c'è dappertutto, c'è invece da<br />
ripetere la domanda: quale democrazia?
Cominciamo proprio da una <strong>di</strong> quelle che abbiamo detto essere le<br />
principali armi del potere: dalla propaganda. Dell'educazione<br />
parleremo alla fine.<br />
Oggi i mezzi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> massa sono enormemente più<br />
potenti <strong>di</strong> ieri e <strong>di</strong> conseguenza l'azione modellante sulle menti <strong>di</strong> chi<br />
se ne serve è ancora più incisiva. Il potere <strong>di</strong> convinzione<br />
dell'immagine visiva supera <strong>di</strong> gran lunga quello della parola letta o<br />
u<strong>di</strong>ta.<br />
Una fossa piena <strong>di</strong> cadaveri genera orrore e desiderio <strong>di</strong> rivalsa senza<br />
che neppure sia chiaro dove e quando l'immagine sia stata ripresa e a<br />
chi sia da attribuirsi il fatto. Per contro è anche vero che il cinema e la<br />
stessa TV ci hanno ormai abituato a immagini <strong>di</strong> incre<strong>di</strong>bile violenza,<br />
cosicché spesso leggiamo i documenti <strong>di</strong> realtà come finzione e<br />
viceversa, senza lasciarci sconvolgere più <strong>di</strong> tanto... I bambini poi,<br />
non ancora sufficientemente allenati a <strong>di</strong>stinguere, mettono tutto sul<br />
conto della finzione e non è raro il caso che tentino <strong>di</strong> riprodurla in<br />
proprio...<br />
Questo quoti<strong>di</strong>ano assalto del visivo non può che avere pesanti<br />
conseguenze sul nostro modo <strong>di</strong> pensare, sulla nostra libertà. La<br />
situazione sembra ad<strong>di</strong>rittura peggiore <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> un tempo.<br />
E così sarebbe se non avessimo la democrazia. Per quanto se ne<br />
possa criticare la realizzazione capitalistica, è pur vero che hanno oggi<br />
accesso ai mass me<strong>di</strong>a molte più voci - anche se non tutte - <strong>di</strong> quante<br />
vi avessero negli anni della <strong>di</strong>ttatura.<br />
Ma l'accesso ai mass me<strong>di</strong>a ha un costo non in<strong>di</strong>fferente ed è ovvio<br />
che a essere favorito è il capitale, tanto più quanto più è grande. In
campagna elettorale i partiti non badano a spese (e non solo negli<br />
Stati Uniti) nella speranza <strong>di</strong> potersi rifare, una volta giunti al potere.<br />
Un insieme <strong>di</strong> leggi e regole cercano <strong>di</strong> arginare lo strapotere del<br />
grande capitale, ma questo si <strong>di</strong>mostra sempre in grado <strong>di</strong> costruire<br />
nuovi canali <strong>di</strong> penetrazione nel pensiero collettivo, così da garantirsi<br />
la superiorità comunicazionale. Alla quale saprebbe opporsi solamente<br />
un elettorato sufficientemente formato al pensiero critico.<br />
Quanto sin qui detto ha il solo scopo <strong>di</strong> collegare il concetto <strong>di</strong> libertà<br />
e quello <strong>di</strong> pensiero critico. Senza quest'ultimo la libertà, <strong>di</strong> cui tutti<br />
parlano e riven<strong>di</strong>cano il monopolio alla propria parte politica, è solo<br />
illusoria, slogan elettorale senza contenuto. Molti adulti l'hanno<br />
sufficientemente sviluppato, il pensiero critico, attraverso lo stu<strong>di</strong>o<br />
delle vicende <strong>di</strong> vita, assai più grande è il numero <strong>di</strong> coloro che lo<br />
hanno sviluppato nei settori <strong>di</strong> loro interesse ma per il resto ne sono<br />
alquanto carenti. Questo perché l'istituto formativo per eccellenza,<br />
cioè la scuola, non lo ha coltivato quanto basta per rendere il citta<strong>di</strong>no<br />
responsabile delle sue scelte e non passivamente <strong>di</strong>pendente dalle<br />
ideologie. Abbiamo trattato, come CMC, questo tema in varie<br />
occasioni, ma soprattutto abbiamo sperimentato, in anni <strong>di</strong> pratica<br />
<strong>di</strong>retta, una metodologia volta alla formazione del pensiero critico nei<br />
più <strong>di</strong>versi ambiti <strong>di</strong>sciplinari. Il molto lavoro fatto ci ha permesso <strong>di</strong><br />
generalizzare questa metodologia e <strong>di</strong> darle, con IMC, un affidabile<br />
base epistemologica. Non ripeteremo qui il già detto, cre<strong>di</strong>amo solo <strong>di</strong><br />
poter aggiungere che IMC, ma soprattutto le sue conseguenze<br />
pratiche nel campo della formazione, siano oggi premessa
in<strong>di</strong>spensabile alla definizione <strong>di</strong> libertà e al suo esercizio, anche<br />
politico. Sempre e solo a titolo <strong>di</strong> esempio, propongo <strong>di</strong> rileggere il<br />
breve testo dal titolo Tutti gli uomini sono uguali, con il relativo<br />
commento, in 3.1.<br />
L'esterno, il sociale non va contrapposto all'in<strong>di</strong>viduale, egoistico. Tra i<br />
due la funzione me<strong>di</strong>atrice è affidata al pensiero critico, che partecipa<br />
<strong>di</strong> ambedue.<br />
3.9. Stile etico-morale<br />
Perlopiù etica e morale vengono considerati sinonimi, anche se in<br />
etica prevale il significato filosofico <strong>di</strong> fondazione razionale della<br />
morale. Qui vorrei attenermi a un intento più descrittivo un sostantivo<br />
greco ethos (= condotta, comportamento, consuetu<strong>di</strong>ne), lo stesso da<br />
cui deriva etologia (= stu<strong>di</strong>o del comportamento degli animali).<br />
Nel caso dell'uomo nessuno parlerebbe <strong>di</strong> etologia, bensì <strong>di</strong> storia del<br />
costume, tutt'al più <strong>di</strong> psicologia comportamentale. Eppure gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
Konrad Lorenz, <strong>di</strong> Tinbergen, <strong>di</strong> Eibl Eibesfeldt non e altri hanno<br />
hanno mostrato notevoli convergenze con (o derivazioni da) il<br />
comportamento animale, in particolare riguardo i primati e<br />
segnatamente ai pongi<strong>di</strong>. Ripetuti esperimenti <strong>di</strong> questi ultimi anni<br />
rendono sempre più fluttuanti i confini tra geneticamente trasmesso e<br />
culturalmente acquisito. È stato anche detto che la trasmissione<br />
culturale è il meccanismo che la selezione naturale ha affidato alla<br />
trasmissione genetica per accelerare l'evoluzione della specie. Di fatto
la cultura ha sostituito dalla nostra specie molte delle prestazioni<br />
fornite da ciò che negli altri animali chiamiamo istinto. Ricerche<br />
accurate hanno tuttavia <strong>di</strong>mostrato che anche nell'uomo alcuni<br />
comportamenti, in particolare certi segnali inviati quasi<br />
inconsapevolmente, appartengono ancora alla sfera istintuale o<br />
perlomeno su <strong>di</strong> essa si innestano. Reciprocamente, altri<br />
comportamenti considerati frutto <strong>di</strong> un'attività cosciente, si osservano<br />
anche in specie animali molto lontane dalla nostra in una ipotetica<br />
scala evolutiva. Così la comunicazione linguistica, ancorché non<br />
necessariamente affidata all'uso della voce, è stata riscontrata per<br />
molti animali, ad esempio per le api. Forse però questi parallelismi<br />
non sono nei fatti ma piuttosto nelle interpretazioni antropomorfe che<br />
siamo soliti darne. Quando poi ci imbattiamo in comportamenti che<br />
non riusciamo a inquadrare nelle nostra normalità, scatta in noi il<br />
giu<strong>di</strong>zio morale: il leone è feroce, il serpente subdolo e così via, per<br />
quanto ferocia e inganno siano da attribuirsi piu' all'uomo che a<br />
qualsiasi altro animale.<br />
Oggi tuttavia quest'abitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care gli animali con il metro<br />
umano si va perdendo grazie alla <strong>di</strong>vulgazione scientifica per<br />
immagini. È invece ancora ra<strong>di</strong>cata l'abitu<strong>di</strong>ne al giu<strong>di</strong>zio culturale tra<br />
gruppi umani. Comportamenti <strong>di</strong>vergenti dai nostri denotano<br />
inferiorità, così come per un musulmano ortodosso noi siamo degli<br />
infedeli e come tali da condannare. All'interno <strong>di</strong> una stessa cultura le<br />
devianze sono connotate negativamente anche se in altri perio<strong>di</strong><br />
neppure neppure sarebbero stati considerati devianze. Cosi' la<br />
pedofilia omosessuale, fortemente demonizzata ai tempi nostri, era
praticata normalmente nell'antichità greco-romana e nel vicino<br />
oriente, anzi era parte del processo formativo presso gli strati alti<br />
della società, come testimoniato in abbondanza da poeti e filosofi.<br />
Con ciò non si vuole <strong>di</strong>re che questo comportamento debba<br />
rinormalizzarsi anche allo stato attuale, ma che sia il comportamento<br />
che la sua inibizione non riguardano un'astratta morale universale, ma<br />
una variabile etica locale.<br />
I Maya e molte altre culture in ogni parte del mondo, usavano fare<br />
sacrifici umani per propiziarsi gli dei, in Europa venivano sacrificate le<br />
streghe a beneficio - si <strong>di</strong>ceva - delle loro anime. La tortura, ammessa<br />
fino a pochi secoli fa nell'amministrazione della giustizia, è oggi<br />
ufficialmente abolita nella maggior parte degli stati, ufficiosamente<br />
tollerata -ma non da chi la subisce - quasi ovunque, quando le<br />
circostanze lo richiedono - ma chi stabilisce quali sono queste<br />
circostanze? E molto facile condannare la violenza personale senza<br />
neppure considerare lo schema comportamentale <strong>di</strong> cui è una<br />
devianza. La violenza sulla donna o sui minori non è un prodotto del<br />
caso ma si innesta sul normale comportamento sessuale del maschio<br />
- riscontrabile anche in altre specie animali - quando manca la,<br />
altrettanto normale, contro-azione inibitoria. Probabilmente tutti<br />
saremo capaci della più orrenda nefandezza se non funziossero, anche<br />
solo momentaneamente, i meccanismi <strong>di</strong> inibizione che regolano la<br />
nostra moralità.<br />
I comportamenti che si osservano in guerra ne sono una riprova,<br />
quando le retro-azioni inibenti sono culturalmente azzerate ("...in<br />
guerra tutto è permesso!").
Potrebbe sembrare, da quanto sto <strong>di</strong>cendo, che <strong>di</strong> tutto si possa<br />
trovare una giustificazione e che la persona ne sia largamente<br />
deresponsabilizzata. Ne conseguirebbe, per la società, uno stato <strong>di</strong><br />
anarchia ingovernabile, prelu<strong>di</strong>o a una rapida estinzione o al risorgere<br />
<strong>di</strong> un totalitarismo non più tollerabile. Non è questo il punto <strong>di</strong> vista<br />
che sto cercando <strong>di</strong> adottare così come non lo è il giu<strong>di</strong>zio morale, del<br />
tutto inadeguato, ad<strong>di</strong>rittura fuorviante se applicato ai comportamenti<br />
umani, come lo era un tempo quando lo si applicava il comportamento<br />
animale. Cercare <strong>di</strong> capire non significa giustificare e men che mai<br />
lasciar correre, ma non ci aiuta neppure sostituire la comprensione<br />
con l' apo<strong>di</strong>tticità <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio morale. L'etica puo' essere uno<br />
strumento migliore, perchè piu' flessibile, specie se le inten<strong>di</strong>amo<br />
come osservazione del comportamento umano, anteriore al giu<strong>di</strong>zio,<br />
in altre parole più vicina all'etologia piu' che alla morale. Certo alla<br />
ricerca deve seguire una parte normativa capace <strong>di</strong> produrre giu<strong>di</strong>zi,<br />
anche <strong>di</strong> severa condanna. Ma sia questi che le norme da cui<br />
<strong>di</strong>scendono credo che non debbano avere nulla che fare con la morale<br />
come comunemente la si intende, cioè come matrice <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi. Credo<br />
però anche della giustizia attuale già funzioni a questo modo, che cioè<br />
sia uno strumento applicativo delle leggi e che queste ultime, essendo<br />
promanate, nei regimi democratici, dal parlamento che si definisce<br />
laico, non abbiano il loro fondamento in una morale, quale che sia, ma<br />
nella ragione umana. Resta da vedere quando questa ragione umana<br />
sia immune dal giu<strong>di</strong>zio morale...<br />
Si obietterà che anche la morale è frutto della ragione umana e quin<strong>di</strong><br />
non ha senso <strong>di</strong>re che le si oppone. Il fatto è che la ragione umana
talvolta si stanca <strong>di</strong> funzionare - e glielo si può concedere - preferendo<br />
riposarsi sulle ideologie, e la morale è una <strong>di</strong> queste. Come sostitutivo<br />
provvisorio della ragione, la morale e per molti un punto <strong>di</strong><br />
riferimento su cui orientare le proprie azioni. E la cosiddetta opinione<br />
pubblica preferisce muoversi su rotaie anziché afferrare il volante.<br />
Anche la morale funge da rotaia così come l'interesse economico, e<br />
non <strong>di</strong> rado le due corrono parallele o ad<strong>di</strong>rittura coincidono. Ma la<br />
pubblica opinione, se non nei contenuti - storicamente variabili -,<br />
almeno nei meccanismi che la producono ha le sue basi nella<br />
formazione che la società offre all'in<strong>di</strong>viduo. La società, dal canto suo,<br />
ha tutto l'interesse <strong>di</strong> assicurarsi la governabilità dei suoi<br />
comportamenti; <strong>di</strong> conseguenza tende a pre<strong>di</strong>sporre questi ultimi a<br />
forme <strong>di</strong> pensiero più possibile omologabili. La scuola tra<strong>di</strong>zionale<br />
operava in questa <strong>di</strong>rezione, e infatti le considerazioni morali vi<br />
avevano una gran parte. Oggi è ancora così? La società ha ancora<br />
bisogno <strong>di</strong> una pubblica opinione?<br />
Le due domande non sono retoriche, non saprei effettivamente dove<br />
trovare una risposta. Da un lato il rimescolamento etnico, religioso,<br />
razziale oggi in atto in ogni parte dalla terra sembrerebbe richiedere<br />
una pluralità <strong>di</strong> riconoscimenti, una <strong>di</strong>sponibilità al <strong>di</strong>verso quali mai si<br />
erano avute in passato. Dall'altro questo stesso rimescolamento, per<br />
essere gestibile a livello planetario, potrebbe aver bisogno <strong>di</strong> un<br />
rapido processo <strong>di</strong> omologazione che ci eviti un'esplosione culturale<br />
per eccesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità. La soluzione, se la si troverà, sarà<br />
probabilmente nel modulare tra loro <strong>di</strong>versità e omologazione:<br />
<strong>di</strong>versità <strong>di</strong> contenuti, omologazione procedurale. Queste tuttavia
sono solo parole; siamo ancora lontani da tradurle in atti concreti. Il<br />
CMC se ne sta occupando per ciò che riguarda la formazione primaria;<br />
anche questo stu<strong>di</strong>o sugli stili <strong>di</strong> pensiero vuol essere un contributo in<br />
tal senso.<br />
Consideriamo per esempio il modello <strong>di</strong> famiglia sul quale convergono<br />
o mostrano <strong>di</strong> convergere, nell'occidente cristiano, morale, religione,<br />
economia politica. Anche l'opinione pubblica e la scuola fanno<br />
riferimento a quel modello, che notoriamente non è nè è stato l'unico,<br />
neppure nella tra<strong>di</strong>zione giudaico-cristiana.<br />
Il punto però non è se la famiglia occidentale sia o non sia il modello<br />
oggi piu' adatto alla conservazione della specie, ma se si debba<br />
con<strong>di</strong>viderlo per scelta o per costrizione ideologica. Nel momento che<br />
entrano in gioco con<strong>di</strong>zionamenti morali o religiosi la scelta non è piu'<br />
tale e la morale decade a ipocrisia. Anche in questo l'orientamento<br />
pedagogico del CMC privilegia anzitutto un'informazione il piu'<br />
possibile ampia e aperta alla pluralità. Soprattutto però mira<br />
all'autonomia della mente, stimolandola anche al <strong>di</strong> là dell'etica<br />
umana, per esempio con una storiella come la seguente ,<br />
etologicamente documentata (specie considerata: Scarabaeus sacer),<br />
ma <strong>di</strong>chiaratamente riproposta nei termini umanizzati <strong>di</strong> un' Intervista<br />
a uno scarabeo stercoraro.<br />
I. Hai conosciuto i tuoi genitori?<br />
(I = intervistatore, S = scarabeo)<br />
S. Sì, perfettamente. Tutti e due, mamma e papà.<br />
I. E tu a quale dei due assomigli <strong>di</strong> più?
S. Che voi che ne sappia, non li ho mica visti!<br />
I. Ma se hai appena detto che li conosci perfettamente!<br />
S. Conosco le pareti della mia cameretta, morbide e lisce, conosco<br />
ogni colpo <strong>di</strong> zampa che le ha levigate; conosco l'enorme riserva <strong>di</strong><br />
sterco sceltissimo, accuratamente pressato in forma <strong>di</strong> palla,<br />
conosco ogni movimento che l'ha formata; conosco la tana<br />
sotterranea dove tanto tempo ho abitato e il lungo corridoio<br />
d'uscita, conosco la ruvida fatica che c'è voluta per costruirli. Che<br />
vuoi che me ne importi <strong>di</strong> sapere i miei genitori che aspetto<br />
avevano, quando con le mie zampe, al buio, ho accarezzato le<br />
tracce <strong>di</strong> ogni loro gesto?<br />
I. E a te non <strong>di</strong>spiace <strong>di</strong> non poter conoscere i tuoi figli?<br />
S. Chi ti ha detto che non riconoscerò?<br />
Quando costruirò la loro casa, o voler ho le visse per loro, ritirò le<br />
pareti, persero sterco, allora saprò anche ogni loro mostra,<br />
conoscero' la loro vita istante per istante fino al momento in cui<br />
abbandoneranno la casa della loro infanzia.<br />
Per noi scarabei, la famiglia è una traccia nella terra, nello sterco.<br />
Ben strana famiglia, se misurata sulle abitu<strong>di</strong>ni umane, ma<br />
certamente funzionalissima alla sopravvivenza, giacché dura da<br />
svariate decine <strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> anni, da molto prima che gli omini<strong>di</strong> -non<br />
si <strong>di</strong>ce l'uomo - si affaciassero sulla terra.<br />
Qualcuno potrebbe ritenere eccessivamente antropomorfizzata la<br />
precedente storiella. Non c'è dubbio che lo sia e l'insegnante che se<br />
ne dovesse servire farà bene a renderne consapevoli gli alunni. Il suo
scopo - della storiella - non è un'indagine psicologica dello scarabeo e<br />
neppure attribuirgli un senso della famiglia che probabilmente non ha.<br />
È ad<strong>di</strong>rittura una forzatura analizzare il suo comportamento<br />
riproduttivo nei termini umani <strong>di</strong> famiglia. Data però la forte<br />
ideologizzazione del nostro comportamento riproduttivo appunto<br />
attraverso quel termine, c'è sembrato utile, per la sua relativizzazione<br />
metaculturale, servircene anche nel caso dello scarabeo. L'insegnante<br />
comunque troverà sul nostro sito molto altro materiale concernente la<br />
famiglia umana e i suoi equivalenti nel mondo animale.<br />
Riprendendo ora il tema etica-morale, e concludendo, mentre il metro<br />
morale mi sembra del tutto inapplicabile all'etologia, il metro etologico<br />
può convenire in certi casi all'etica, riconducendo l'umano entro i suoi<br />
confini biologici. Quest'atteggiamento non incontrerà probabilmente il<br />
favore <strong>di</strong> ampi sttori della società e non nella nostra sola cultura.<br />
Come per tutto ciò che qui si legge, non c'è da parte nostra alcuna<br />
pretesa <strong>di</strong> convincere ma solo <strong>di</strong> aprire o alimentare una <strong>di</strong>scussione<br />
su determinati argomenti. Qui si è trattato della morale, la cui<br />
immagine potrà apparire a certuni fortemente <strong>di</strong>storta. Non nego la<br />
mia scarsa simpatia per questo termine, ma soprattutto per ciò che<br />
troppo spesso vi si nasconde <strong>di</strong>etro. Del resto penso sia più morale<br />
riflettere e <strong>di</strong>scutere <strong>di</strong> morale anziché farne oggetto <strong>di</strong> propaganda e<br />
strumento <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio e <strong>di</strong> condanna.<br />
!!!!! PAGINA MANCANTE !!!!! (p. 122)
gico assolutizzante. Dal punto <strong>di</strong> vista metaculturale, qui adottato,<br />
queste assolutizzazioni sono del tutto legittime se viene loro<br />
riconosciuto un luogo in UMC (nell'Universo Metaculturale), evitando<br />
così che fluttuino liberamente in esso, in altre parole se le si associa a<br />
un UCL ( Universo Culturale Locale)riconosciuto e <strong>di</strong>chiarato. Nulla ci<br />
sarebbe neppure da obiettare se questo UCL dovesse allargarsi a tutta<br />
l'umanità, semprechè questo allargamento non sia imposto con la<br />
forza o con la conversione coatta. Come si vede l'assiologia<br />
metaculturale, pur appartenendo all'area relativistica, si <strong>di</strong>stingue<br />
dalla sua versione assolutizzata ("tutto è relativo"):<br />
a) per la localizzazione dei giu<strong>di</strong>zi assoluti;<br />
b) per la variabilità temporale degli UCL <strong>di</strong> riferimento.<br />
Questa ultima circostanza possiamo chiamarla la storicità degli UCL, a<br />
patto <strong>di</strong> un'energica riduzione fenomenica del concetto <strong>di</strong> storia.<br />
L'estetica è certo uno dei campi dove abitualmente si esercita la<br />
funzione giu<strong>di</strong>cante. Primariamente l'estetica ha a che fare con il<br />
bello, questo non riguarda solamente l'arte che <strong>di</strong> solito gli viene<br />
associata, ma anche altri ambiti cui non vien fatto normalmente <strong>di</strong><br />
pensare. Così la matematica della quale i matematici spesso esaltano<br />
la bellezza <strong>di</strong> certe teorie, come il calcolo infinitesimale o la teoria dei<br />
numeri complessi. In qualche caso questa bellezza si rende ad<strong>di</strong>rittura<br />
visibile come nel caso dell'insieme <strong>di</strong> Mandelbrot, basato sulla ripetuta<br />
sostituzione<br />
z --> z 2 + c
dove c è un numero complesso fissato. Come è noto questa semplice<br />
formula matematica produce, se realizzata al computer, strutture<br />
visive <strong>di</strong> complessità infinitamente crescente ma <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>ne che non<br />
possiamo fare a meno <strong>di</strong> percepire come bello. Così anche certe teorie<br />
fisiche, matematicamente espresse, colpiscono per la loro bellezza, a<br />
cominciare dalla meccanica <strong>di</strong> Newtoniana alle equazioni <strong>di</strong> Maxwell<br />
per il campo elettromagnetico, alle teorie einsteniane della relatività<br />
ristretta e generale. È universalmente conosciuta la semplicissima<br />
formula che nella relatività generale esprime il rapporto tra Massa (m)<br />
ed energia (E)<br />
dove c è la velocità della luce.<br />
E = mc 2<br />
È stupefacente che la valutazione estetica coincide in molti casi con<br />
una misura <strong>di</strong> verità sperimentalmente comprovata: cioè le teorie o i<br />
modelli matematicamente piu' concisi ed eleganti sono anche quelli<br />
che rendono maggiormente conto dei risultati sperimentali. Qualcosa<br />
<strong>di</strong> simile accade per la logica formale, dall'analisi aristotelica del<br />
sillogismo al teorema <strong>di</strong> incompletezza <strong>di</strong> Gödel.<br />
Della percezione del bello sembra che svolgano un ruolo importante la<br />
simmetria e l'economicità. Ambedue sono forse in rapporto con le<br />
strutture simmetriche della maggior parte dei viventi e con il<br />
risparmio energetico che regola i loro rapporti con l'ambiente. Non è<br />
però la perfetta simmetria che suscita in noi il senso del bello. Spesso
la simmetria è solo il termine antitetico che ci permette <strong>di</strong> godere<br />
della simmetria. Le due torri che incorniciano simmetricamente le<br />
facciate delle cattedrali gotiche ci sollecitano a ricercarne le interne<br />
asimmetrie. Così come le teorie <strong>di</strong> Vergini e santi nei mosaici<br />
ravennati o le astratte geometrie <strong>di</strong> Mondrian ci affascinano per tutto<br />
ciò che <strong>di</strong> irrazionale vi si nasconde. Vedremo come in musica<br />
l'aggiunta del parametro tempo trasformerà i concetti <strong>di</strong> simmetria,<br />
geometricità, razionalità negli equivalenti <strong>di</strong><br />
impreve<strong>di</strong>bilità/impreve<strong>di</strong>bilità.<br />
Stati fatti molti tentativi <strong>di</strong> misurazione del bello in termini <strong>di</strong><br />
informazione o, se si vuole, <strong>di</strong> bit. Quanto maggiore la quantità <strong>di</strong><br />
informazione per cm 2 <strong>di</strong> superficie o per unità fraseologica o<br />
narrativa, tanto più alta la valutazione estetica. Solo che non è chiaro<br />
che cosa sia un'informazione filtrata attraverso la cultura. Per un<br />
osservatore abituato alla prospettiva una pittura che non ne faccia<br />
uso apparirà primitiva e quin<strong>di</strong> scarsamente informativa. Un<br />
appassionato <strong>di</strong> poesia trecentesca puo' non reagire affatto alla prosa<br />
<strong>di</strong> un Gadda.<br />
Nella valutazione estetica la soggettività a un peso determinante...<br />
Ma nel determinare la soggettività il peso sta in gran parte nella<br />
cultura che a sua volta non è un prodotto soggettivo, anche se resta<br />
in<strong>di</strong>viduale la sua configurazione locale: un groviglio inestricabile dal<br />
<strong>di</strong>panare il quale è più prudente astenersi.<br />
3.10.1. Esperienze grafico-pittoriche
Quali risposte danno a questo proposito le esperienze <strong>di</strong> base?<br />
Sono ormai una trentina d'anni che il CMC si occupa <strong>di</strong> ricerche sulla<br />
produttività infantile e <strong>di</strong> parte incompetente in campo musicale e<br />
visivo. Delle esperienze musicali <strong>di</strong>rò tra poco. Quanto al visivo <strong>di</strong>rò<br />
subito che i termini estetica, arte, bello, brutto non sono mai stati<br />
introdotti ufficialmente e solo occasionalmente qualcuno dei<br />
partecipanti ne ha fatto uso, in maniera irriflessa. Aggiungo anche che<br />
per molti mesi a nessuno sarebbe venuto in mente <strong>di</strong> servirsene<br />
giacché niente <strong>di</strong> ciò che veniva prodotto sembrava vera che fare con<br />
il bello. I progetti su cui lavorare venivano forniti inizialmente<br />
dall'operatore, e solo un poco alla volta anche la progettualità è<br />
passata in mano ai partecipanti. Questi potevano essere<br />
in<strong>di</strong>fferentemente gruppi <strong>di</strong> adulti o alunni <strong>di</strong> scuole elementari: i<br />
risultati sono apparsi in<strong>di</strong>pendenti dall'età. A titolo <strong>di</strong> esempio riporto<br />
qui alcuni dei progetti su cui si è lavorato in una seconda elementare.<br />
Per una documentazione più ampia si consulti nostro sito dai<br />
numeri...al...o il volumetto Esperienze grafico-pittoriche a cura <strong>di</strong><br />
Paola Bucan e Adonella Del Bufalo...<br />
Progetto:
Pren<strong>di</strong> l'elemento linea dritta<br />
verticale e replicalo 5 volte sul foglio.<br />
La maggioranza dei bambini si è<br />
automaticamente orientata sulla<br />
pratica della scrittura e sul<br />
corrispondente uso del foglio (inizio<br />
in alto a sinistra e prosecuzione a <strong>di</strong>stanze uguali verso destra).<br />
a)<br />
b)<br />
Un solo caso <strong>di</strong>vergente, interpretato<br />
dalla maggioranza in un primo<br />
momento come scorretto: "ha<br />
sbagliato!"<br />
La riflessione sul progetto e sulle due realizzazioni ha portato a<br />
considerare quello come non ben definito, o meglio come<br />
(relativamente) aperto, e queste come realizzazioni <strong>di</strong> due possibili
alternative implicite nel progetto stesso (i termini usati sono stati<br />
ovviamente altri, commisurati all'età dei bambini).<br />
È stato chiaramente riconosciuto il progetto che presiede alla normale<br />
pratica della scrittura (normale si intende per noi europei, giacché,<br />
come sappiamo, altre culture hanno progetti <strong>di</strong> scrittura <strong>di</strong>versi):<br />
inizio in alto a sinistra e prosecuzione da sinistra a destra e dall'alto in<br />
basso.
Progetto:<br />
Replicare l'elemento precedente 11 volte sul foglio.<br />
Esecuzioni<br />
a)<br />
è risultata ancora evidente la<br />
<strong>di</strong>fficoltà a liberarsi dalle<br />
convenzioni della scrittura<br />
b)<br />
commento:<br />
“non è stato attento”<br />
“ha sbagliato”<br />
La riflessione sul progetto e sulle esecuzioni ha rilevato l'apertura del<br />
progetto (che non <strong>di</strong>ce nulla sulla lunghezza dell'elemento) e<br />
l'accettabilità dell'esecuzione b), come realizzazioni <strong>di</strong> una alternativa<br />
compatibile con il progetto.<br />
Progetto:<br />
Raggruppare sul foglio 9 repliche dell'elemento precedente; lunghezza<br />
costante.<br />
(Prima indagine del concetto <strong>di</strong> gruppo e sul termine raggruppare).<br />
Esecuzioni
a)<br />
ancora il con<strong>di</strong>zionamento alla<br />
scrittura!<br />
b)<br />
con<strong>di</strong>zionamento parziale<br />
c)<br />
svincolamento!
d)<br />
“Ha sbagliato” (il riferimento al<br />
progetto – lunghezza costante –<br />
giustifica l’osservazione)<br />
Il concetto <strong>di</strong> gruppo, raggruppamento è stato interpretato nel senso<br />
<strong>di</strong> vicinanza degli elementi. L'analisi ha rilevato la <strong>di</strong>versa collocazione<br />
della realizzazione d) nel campo.<br />
Abbiamo chiamato campo lo spazio (qui il foglio) entro cui collochiamo<br />
i nostri <strong>di</strong>segni.<br />
......<br />
Progetto (proposto molti mesi più tar<strong>di</strong> dei precedenti e facente parte<br />
<strong>di</strong> una serie progettuale dal titolo Primo piano-sfondo. Disturbo)<br />
Delimita il campo.<br />
Scegli due pennarelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso spessore.<br />
Composizione astratta con la caratteristica compositiva: un elemento<br />
in primo piano.<br />
Il termine nuovo - "primo piano" - non viene definito ma lasciato alla<br />
<strong>di</strong>scussione dei partecipanti.<br />
"Come sarebbe in primo piano?"<br />
"Quello che noto per primo".<br />
"Che si vede <strong>di</strong> più".<br />
"Che sta sopra come le posate sulla tovaglia".
Si è concluso che, per avere un elemento in primo piano, conviene<br />
<strong>di</strong>segnarlo col pennarello più grosso.<br />
Compare a questo punto il termine sfondo o fondo. "Fondo fatto <strong>di</strong><br />
elementi sottili e palli<strong>di</strong> e sopra, in opposizione, elemento grosso e<br />
forte" (Questa specificazione del progetto è stata proposta dei<br />
bambini).<br />
Esempi <strong>di</strong> esecuzione:<br />
a)<br />
c)<br />
b)<br />
d)
- "a) sta nel progetto; si vedono due pennarelli <strong>di</strong>versi; lo sfondo<br />
(sotto) è fatto col pennarello fino e l'elemento che si vede <strong>di</strong> più è<br />
fatto col pennarello grosso". - "Il fondo è fatto a specchio, si può<br />
<strong>di</strong>re che è preve<strong>di</strong>bile, così non <strong>di</strong>sturba".<br />
- "b) sta nel progetto; l'elemento in primo piano si vede benissimo,<br />
lo sfondo è preve<strong>di</strong>bile, è tutto or<strong>di</strong>nato". - "Sembra una tovaglia".<br />
- "c) sta nel progetto, come a)". - "No, per me non ci sta, perché, più<br />
che un elemento in primo piano, quella curva grossa è una curva<br />
che <strong>di</strong>sturba". - "Perché in a) non <strong>di</strong>sturbava?" - "No, perché non<br />
era curvo e poi stava al centro e aveva la stessa forma delle linee<br />
sottili".<br />
- "d) sembra una tovaglia come b), ma lui ci ha messo al centro<br />
rettangolo che non è neppure in primo piano". - "Perché un<br />
rettangolo non può essere un elemento: è una figura, composta <strong>di</strong><br />
molti elementi". - "E poi lui ha usato sempre il pennarello fino". "Ma<br />
anche una figura può essere un elemento e poi l'uso del pennarello<br />
grosso non era obbligatorio"...<br />
Discussioni del genere sono la norma in queste esperienze, anzi sono<br />
il loro fine ultimo. Non si tratta infatti <strong>di</strong> portare nella scuola <strong>di</strong> tutti<br />
una "scuola <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno", ma solo <strong>di</strong> offrire ai bambini un'occasione<br />
concreta, operativa per esercitare il pensiero a confrontare,<br />
motivandole, opinioni <strong>di</strong>verse. Procedendo oltre nel cammino<br />
intrapreso si è visto come un poco alla volta emergono anche<br />
considerazioni estetiche, sempre però motivate e relativizzate<br />
all'esperienza in corso. E si affinano i mezzi tecnici e si scoprono
sempre nuove alternative; infine, da un certo punto in poi (verso il<br />
secondo-terzo anno) anche la progettualità si fa autonoma e la<br />
presenza dell'operatore culturale perde le sue connotazioni <strong>di</strong>rettive e<br />
viene percepita come una presenza alla pari.<br />
3.10.2. Esperienze musicali<br />
Sono quelle su cui il CMC si è formato negli anni settanta. Sono anche<br />
sufficientemente note per ritornarvi su anche in questa sede. Va però<br />
detto che, pur essendosi in certo modo normalizzate, quelle<br />
esperienze sono andate incontro a ra<strong>di</strong>cali frainten<strong>di</strong>menti. Per prima<br />
cosa sono state considerate come un ricettario per facilitare il compito<br />
dell'insegnante <strong>di</strong> musica nelle scuole me<strong>di</strong>e. A questo<br />
frainten<strong>di</strong>mento ha contribuito forse anche il testo originario <strong>di</strong> Musica<br />
prima, che effettivamente conserva ancora molti tratti prescrittivi,<br />
nonostante l'apertura del progetto d'insieme. Rifacimenti più recenti <strong>di</strong><br />
quel materiale hanno ridotto al minimo quella presenza, ma ormai il<br />
primo frainten<strong>di</strong>mento era avvenuto ed era comodo adagiarsi su <strong>di</strong><br />
esso. Il secondo, più grave frainten<strong>di</strong>mento è stato ed è l'aver<br />
scambiato il libro per un metodo per l'appren<strong>di</strong>mento della musica<br />
mentre non è stato né pensato come metodo né funzionalizzato, se<br />
non secondariamente, a quell'appren<strong>di</strong>mento. Per imparare la musica<br />
ci sono mo<strong>di</strong> assai più rapi<strong>di</strong> ed efficaci. Il terzo frainten<strong>di</strong>mento è<br />
stato vedervi una via <strong>di</strong> approccio a quella che allora si chiamava
musica contemporanea e che oggi nessun giovane conosce, sommersi<br />
come siamo dal rock e dalla musica <strong>di</strong> consumo.<br />
Ma allora, qualcuno potrà domandarsi, qual'era il fine <strong>di</strong> Musica prima<br />
e dei suoi rifacimenti? Nessun altro che stimolare il pensiero in senso<br />
critico e metaculturale, analogamente alle nostre esperienze nel<br />
visivo, e in tutti i campi formativi oggi documentati sul nostro sito. È<br />
però anche vero che se questi frainten<strong>di</strong>menti hanno avuto luogo,<br />
qualche cosa ci dev'essere stata per rendere possibili. Forse all'inizio<br />
non ci era chiara come oggi la funzione formativa generale, non<br />
specifica, <strong>di</strong> quell'impostazione. Soprattutto ha giocato il fatto che,<br />
essendo io musicista sembrava ovvio che, scrivendo <strong>di</strong> musica,<br />
dovessi mirare soprattutto a quella e non a un più ampio progetto<br />
formativo. Questo infatti si è definitivamente chiarito negli anni<br />
ottanta, troppo tar<strong>di</strong> perché qualcuno mi desse retta come operatore<br />
culturale <strong>di</strong> base anziché come insegnante <strong>di</strong> musica. C'era infine,<br />
come c'è ancora, l'effettiva necessità <strong>di</strong> insegnanti <strong>di</strong> musica preparati<br />
per la scuola me<strong>di</strong>a e non per il conservatorio. Il convergere <strong>di</strong> queste<br />
circostanze può dar ragione <strong>di</strong> quei frainten<strong>di</strong>menti che oggi non mi<br />
preoccupano più, così come non mi preoccupano le sorti della mia<br />
musica da quando essa è <strong>di</strong>venuta un hobby privato, anche se assai<br />
impegnativo.<br />
Per dare al lettore non informato un'idea dell'itinerario formativo da<br />
noi seguito in ambito musicale, <strong>di</strong>rò poche cose e addurrò un paio <strong>di</strong><br />
esempi tolti, al solito, dal nostro sito (......).<br />
L'ambito esperienziale si incentra sul binomio analisi-composizione e<br />
si presenta sud<strong>di</strong>viso in due sottoambiti:
- composizione-analisi <strong>di</strong> suoni non co<strong>di</strong>ficati (informale)<br />
- composizione-analisi in presenza del co<strong>di</strong>ce notale convenzionale.<br />
Il primo sottoambito è funzionale all'esperienza della co<strong>di</strong>ficazione (la<br />
scuola fornisce co<strong>di</strong>ci ma non si preoccupa <strong>di</strong> far sperimentare la loro<br />
genesi).<br />
Il secondo sottoambito è funzionale alla costruzione <strong>di</strong> regole locali<br />
(sistemi <strong>di</strong> regole) per l'uso <strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ce (più quello notale della nostra<br />
tra<strong>di</strong>zione).<br />
È abbastanza evidente che i progetti collegati a questi sottoambiti,<br />
pur riguardando l'esperienza musicale, hanno una valenza formativa<br />
assai più generale, come rivela la loro trasferibilità in altri ambiti<br />
comunicazionali (grafico-pittorico, come abbiamo visto, ma anche<br />
verbale, logico-matematico ecc.).<br />
La grafizzazione dei progetti informali (partim).<br />
(Questo progetto presuppone i precedenti, relativi all'ascolto dei suoni<br />
ambientali e l'improvvisazione informale).<br />
L'esecuzione e la verifica dei progetti relativi a composizioni informali<br />
non può, al punto in cui siamo, che condursi sulla base alquanto labile<br />
della memoria. L'uso del registratore, è vero, potrebbe facilitarci il<br />
compito, e in effetti la traccia magnetica non è che una particolare<br />
forma <strong>di</strong> grafizzazione dell'esperienza. Qui però vorremmo occuparci<br />
<strong>di</strong> mo<strong>di</strong> più attivi <strong>di</strong> fissazione dell'oggetto musicale. Questo, come<br />
sappiamo, vive nel tempo, c'è ad<strong>di</strong>rittura chi <strong>di</strong>ce che è fatto <strong>di</strong><br />
tempo, destinato quin<strong>di</strong> a <strong>di</strong>ssolversi attimo per attimo se non
interveniamo noi legandolo in qualche modo allo spazio...... La<br />
soluzione a questo tipo <strong>di</strong> problemi è a tutti nota: non per nulla la<br />
prima cosa che ci insegnano a scuola è leggere e scrivere.<br />
(.....)<br />
Come scrivere una partitura - un grafico - informale?<br />
Sarà bene accordarsi sulla grafizzazione dei principali parametri del<br />
suono (li ricor<strong>di</strong>amo: qualità, durata, intensità) seguendo il principio<br />
generale della massima chiarezza ed economicità dei segni. Sarà bene<br />
anche ricordare che, in sede <strong>di</strong>dattica, ogni segno o modo <strong>di</strong><br />
grafizzazione andrà pazientemente ricavato dal lavoro comune: se si<br />
vuole mantenere al lavoro <strong>di</strong> base tutto il suo valore formativo<br />
generale, le scorciatoie offerte da chi sa (per esempio dall'insegnante)<br />
tolgono anziché dare. È molto probabile (ma niente affatto sicuro,<br />
come innumerevoli casi ci hanno <strong>di</strong>mostrato) che le soluzioni standard<br />
(e in un certo senso ormai co<strong>di</strong>ficate) emergono comunque dal lavoro<br />
<strong>di</strong> gruppo: un conto è tuttavia riceverle passivamente da chi ce le<br />
trasmette, un conto è constatare a posteriori una convergenza tra la<br />
proposta nostra e quella riconosciuta ufficialmente come migliore.<br />
(Segue la grafizzazione del parametro qualità o timbro......)<br />
Passiamo ora parametro durata, cominciando dal caso più semplice,<br />
cioè dalla presenza/assenza <strong>di</strong> un suono, per esempio la solita A. Ecco<br />
una via facilmente percorribile.<br />
Un gruppo (con <strong>di</strong>rettore) o un solista esegue una sequenza <strong>di</strong> A<br />
intramezzata da pause (sia le une che le altre <strong>di</strong> durata variabile). Un<br />
secondo gruppo ne ricerca (in tempo reale) la grafizzazione (ciascuno<br />
per proprio conto).
Ecco alcune tra le soluzioni più frequentemente proposte (la sequenza<br />
era composta da 4 A <strong>di</strong> varia durata e da 3 pause, anch’esse <strong>di</strong> varia<br />
durata):<br />
1. aaaaa aaa a aaaaaaaaa<br />
2. A A A A<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
Un'analisi sull'informazione trasmessa ci <strong>di</strong>ce che:<br />
- tutte le soluzioni registrano 4 A (benché 3., 4., 5. non specificano<br />
che si tratta <strong>di</strong> una A)<br />
- tutte le soluzioni registrano le <strong>di</strong>verse durate delle A (seppure non<br />
ne danno il valore assoluto)<br />
- nessuna, salvo la 5. ci informa sulla durata delle pause (che in 1.,<br />
2., 4. sembrerebbe costante, mentre in 3. resta indefinita)<br />
- la 5. ci dà le maggiori informazioni (<strong>di</strong>versifica le durate sia delle A<br />
che delle pause).<br />
La soluzione migliore sembra quin<strong>di</strong> essere la 5., ma a certe<br />
con<strong>di</strong>zioni.<br />
Quali? Chie<strong>di</strong>amo gli autori <strong>di</strong> 4. e 5. come hanno realizzato il loro<br />
grafici:
- risposta <strong>di</strong> 4.: "Ho tirato la penna durante la A, poi mi sono fermato<br />
fino alla successiva."<br />
- risposta <strong>di</strong> 5.: "Ho tirato la penna durante la A, poi ho continuato a<br />
tirare durante la pausa, ma senza premere la penna sul foglio."<br />
Domanda: "E con che velocità l'hai tirata?"<br />
Risposta: "Sempre la stessa".<br />
(Segue una <strong>di</strong>scussione sul rapporto lunghezza del segmento-durata<br />
del suono, quin<strong>di</strong> sulla grafizzazione del parametro intensità, infine<br />
vengono dati degli esenti completi <strong>di</strong> partiture informali a uno e due<br />
cori......)<br />
Come si vede, il lavoro <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ficazione, non essendo fornito nessun<br />
co<strong>di</strong>ce precostituito, è lungo e complesso. Un insegnante interessato<br />
al risultato finale può considerarlo tempo perso, per noi è il vero<br />
obiettivo dell'esperienza.<br />
Diamo ora un piccolo saggio <strong>di</strong> com'è possibile un lavoro analitico-<br />
compositivo <strong>di</strong> base in presenza <strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ce precostituito, senza però<br />
che ne siano specificate le regole d'uso.<br />
Campo re-fa, valore <strong>di</strong> durata unitario.<br />
Per cominciare sono sufficienti i segni grafici:<br />
- una riga<br />
- un <strong>di</strong>schetto<br />
Cambiano la posizione del <strong>di</strong>schetto rispetto alla riga otteniamo:<br />
<strong>di</strong>schetto sotto la riga = re<br />
<strong>di</strong>schetto sulla la riga = mi<br />
<strong>di</strong>schetto sopra la riga = fa
Allineando le tre note avremo<br />
re mi fa<br />
Proviamo ora a cantarle o a suonarle con un metallofono o un flauto<br />
dolce (parallelamente al lavoro compositivo verrà avviato lo stu<strong>di</strong>o<br />
dell'intonazione vocale e strumentale), dando ogni suono un<br />
convenzionale valore unitario <strong>di</strong> durata, in tempo piuttosto lento.<br />
Consegnamo quin<strong>di</strong> questi segni ai componenti del gruppo invitandoli<br />
ad allineare un certo numero <strong>di</strong> <strong>di</strong>schetti in or<strong>di</strong>ne arbitrario su una<br />
riga non troppo corta.<br />
Ecco una sequenza<br />
1.<br />
Dopo averla cantata o suonata proviamo ad analizzarla. Ma cosa vuol<br />
<strong>di</strong>re analizzare? Una risposta ottenuta un giorno da un'insegnante<br />
elementare <strong>di</strong> Milano può costituire un buon inizio: "Analizzare vuol<br />
<strong>di</strong>re <strong>di</strong>stinguere delle parti e metterle in relazione tra <strong>di</strong> loro".<br />
Nel caso <strong>di</strong> una sequenza lineare le parti sono da intendersi come<br />
segmenti. Alla proposta <strong>di</strong> segmentare la 1. le realizzazioni saranno le<br />
più <strong>di</strong>verse, per esempio:<br />
1.a<br />
1.b<br />
1.c<br />
Si conviene <strong>di</strong> fare una piccola pausa in corrispondenza della virgola,<br />
si eseguono le tre sequenze e si osserva che ci appaiono <strong>di</strong>verse tra<br />
loro pur essendo costituite dalle stesse note nello stesso or<strong>di</strong>ne. Se ne
deduce che la segmentazione influisce grandemente sulla fisionomia<br />
della sequenza. Sarà bene quin<strong>di</strong> segmentare a ragion veduta.<br />
Ma quali ragioni presiedono alle segmentazioni <strong>di</strong> 1. qui proposte?<br />
1.a segue il criterio <strong>di</strong> chiudere i segmenti a ogni mi<br />
1.b li chiude dopo una nota imme<strong>di</strong>atamente ripetuta<br />
1.c si affida a un criterio aritmetico: segmenti <strong>di</strong> tre note.<br />
Ogni segmentazione segue ovviamente un proprio progetto e in sede<br />
<strong>di</strong>dattica è essenziale che questo progetto venga riconosciuto e<br />
<strong>di</strong>chiarato.<br />
A questo punto la decisione più logica è che la segmentazione <strong>di</strong> una<br />
sequenza la faccia l'autore stesso seguendo un suo progetto.<br />
Esempi: ......<br />
Il lavoro prosegue ampliando il campo a cinque note consecutive (re-<br />
la o mi-si, o fa-do) e oltre, fino a coprire i sette gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> un campo<br />
<strong>di</strong>atonico. Vengono quin<strong>di</strong> (o anche precedentemente) introdotti i<br />
valori <strong>di</strong> durata e così via entrando un po' alla volta nello specifico<br />
musicale.<br />
Ho avuto la fortuna, data la mia professione, <strong>di</strong> poter sperimentare la<br />
metodologia progettata a livello <strong>di</strong> base fino agli ultimi gra<strong>di</strong> dello<br />
specialistico compositivo, da sempre considerato un hortus conclusus<br />
riservato a pochi addetti ai lavori.<br />
La professione del compositore è certamente una scelta che pochi<br />
fanno, specialmente nell'Italia <strong>di</strong> oggi, apparentemente sorda ad altra<br />
musica che non sia la canzone <strong>di</strong> Sanremo o il rock.
La via che conduce alla musica in senso più compositivo, includente<br />
cioè la nostra tra<strong>di</strong>zione dal me<strong>di</strong>oevo ad oggi nonché le tra<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
altre culture, questa via è aperta a chiunque, sempre che, s'intende,<br />
abbia interesse a percorrerla.<br />
Ma questa non è che una manifestazione secondaria dell'impianto<br />
metodologico qui <strong>di</strong>scusso. Primaria è la sua trasferibilità, come già<br />
detto più volte e come testimoniato dal nostro sito. Anche la presente<br />
rassegna degli stili <strong>di</strong> pensiero ne è una conseguenza, probabilmente<br />
non necessaria ma utile, si spera, per la relativizzazione democratica<br />
delle opinioni, sia nostra e che altrui.<br />
3.10.3. Esperienze verbali<br />
La parola è uno strumento <strong>di</strong> comunicazione talmente normalizzato<br />
che in linea generale ba<strong>di</strong>amo al che cosa ci viene detto assai più che<br />
al come. Ciò non è del tutto vero e sarà bene osservare più da vicino<br />
come avviene la comunicazione attraverso la parola. Questa si<br />
accompagna nell'uso parlato ad altri atti e atteggiamenti comunicativi<br />
da cui ricaviamo delle informazioni non necessariamente congruenti<br />
con ciò che la parola sta <strong>di</strong>cendo. Una stessa frase può cambiare<br />
ra<strong>di</strong>calmente <strong>di</strong> senso a seconda <strong>di</strong> come viene pronunciata: con<br />
rabbia, con in<strong>di</strong>fferenza, con stupore ecc. E questi <strong>di</strong>versi sensi li<br />
ricaviamo da tratti paralinguistici <strong>di</strong> varia natura: intensità della voce,<br />
gesticolazione, espressioni facciali ecc.
Tutto questo a prescindere dagli elementi circostanziali, dal contesto<br />
<strong>di</strong> vita che accompagna ogni atto comunicazionale. In realtà gli atti<br />
comunicazionali <strong>di</strong> qualsiasi tipo sono estremamente complessi ed è<br />
troppo riduttivo attribuirli al solo sistema linguistico che ci appare<br />
dominante. In questo campo le nostre conoscenze e ancor più le<br />
ipotesi vanno molto al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto queste brevi note possono <strong>di</strong>re.<br />
Se le ho richiamate alla mente è solo per correggere la frase iniziale:<br />
<strong>di</strong> come cui non baderemmo a sufficienza non riguarda in questo caso<br />
i tratti paralinguistici che accompagnano la parola ma la parola<br />
stessa, il <strong>di</strong>scorso nella sua <strong>di</strong>sposizione interna, grammaticale,<br />
sintattica, retorica. Gli antichi, almeno per come ci testimonia la<br />
tra<strong>di</strong>zione letteraria, erano assai più sensibili <strong>di</strong> noi all'arte del parlare<br />
e la coltivavano nell'esercizio, appunto, della retorica, anche<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dai contenuti da trasmettere. Oggi la scuola poco<br />
se ne cura, attenta tutt'al più all'errore ortografico o <strong>di</strong> grammatica. A<br />
nessuno verrebbe in mente <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are l'arringa <strong>di</strong> un avvocato o un<br />
<strong>di</strong>scorso elettorale dal punto <strong>di</strong> vista del come sono <strong>di</strong>sposte le parole.<br />
Eppure questo come, anche se non gli prestiamo attenzione, continua<br />
a funzionare né più né meno che ai tempi <strong>di</strong> Demostene.<br />
È solo una questione <strong>di</strong> stile, <strong>di</strong> pertinenza dell'estetica, o vi sono<br />
implicati anche altri aspetti, più rilevanti per la comunicazione?<br />
Questa domanda nasconde già un pregiu<strong>di</strong>zio: nel caso <strong>di</strong> un quadro o<br />
<strong>di</strong> un brano musicale la qualificazione estetica viene considerata<br />
primaria, nel caso della parola il giu<strong>di</strong>zio estetico o <strong>di</strong> stile entra in<br />
gioco solo in casi particolari, ghettizzati nell'ambito della letteratura.<br />
Tutti, bene o male, scrivono, ben pochi li qualifichiamo come scrittori,
anche se un articolo <strong>di</strong> giornale o un capitolo <strong>di</strong> fisica teorica possono<br />
essere scritti meglio della pagina molto citata <strong>di</strong> un romanzo famoso.<br />
Ma che vuol <strong>di</strong>re meglio in questo caso? Come confrontare tra loro<br />
una pagina <strong>di</strong> romanzo e uno scritto scientifico? Forse in base al loro<br />
ren<strong>di</strong>mento comunicazionale. E questo come lo definiamo? Forse in<br />
base al rapporto tra l'informazione trasmessa e quella ricevuta.<br />
Ricevuta da chi, da un lettore esperto o da un lettore occasionale?<br />
Forse...<br />
Potremmo continuare a lungo senza convincere né noi, né gli altri.<br />
Alcuni fatti, come per esempio quelli <strong>di</strong> comunicazione, sono a tal<br />
punto complessi che, per quanto noi proseguiamo nell'indagine, la<br />
spiegazione resta sempre ugualmente lontana. Del resto anche il<br />
nostro gatto <strong>di</strong> casa, qualche volta ci sembra <strong>di</strong> capirlo, più spesso ci<br />
è incomprensibile. Probabilmente la ragione umana (non il pensiero)<br />
ha un grado <strong>di</strong> complessità inferiore a quella del più semplice<br />
organismo vivente.<br />
Non per questo dobbiamo trascurare l'attività conoscitiva, dentro e<br />
fuori i confini imposti dalla razionalità. In primo luogo perché la<br />
ragione li sposta <strong>di</strong> continuo, poi perché il margine che sta al <strong>di</strong> là <strong>di</strong><br />
essi non sappiamo quanto sia ampio. Così come non conosciamo il<br />
margine ultimo del pensiero al <strong>di</strong> là della ragione.<br />
Spesso la nostra impostazione metodologica è stata criticata come<br />
eccessivamente razionalistica e anche il nostro modo <strong>di</strong> trattare, a<br />
livello <strong>di</strong> base, delle pratiche considerate artistiche (musica, <strong>di</strong>segno)<br />
può rafforzare questa impressione. Penso infatti che tutto ciò che è<br />
razionalmente raggiungibile vada razionalmente raggiunto.
Per il resto vale l'ultima frase dal Tractatus wittgensteiniano "Di ciò <strong>di</strong><br />
cui non si può parlare conviene tacere", con in più l'osservazione che<br />
anche la parola sa tacere molte delle cose <strong>di</strong> cui parla. È il dominio<br />
dell'alone connotativo, del non detto esplicitamente, un alone che<br />
oltretutto varia da ricevente a ricevente e per qualcuno può ridursi a<br />
zero se mancano adeguati riferimenti culturali. E questo variabile e in<br />
buona parte insondabile alone al <strong>di</strong> là del razionale è ciò che qualifica<br />
il pensiero estetico e per cui vale la pena <strong>di</strong> coltivarlo fin dai primi<br />
anni <strong>di</strong> scuola. Non penso infatti che esso sia prerogativa del poeta,<br />
dell'artista, ma sia accessibile, come stile <strong>di</strong> pensiero, a chiunque,<br />
sempreché sia stato formato in tal senso.<br />
Ma a che serve, all'uomo della strada, uno stile <strong>di</strong> pensiero estetico?<br />
Anzi tutto non conosco la categoria "uomo della strada". Sulla strada<br />
ci camminiamo tutti e lo faceva anche Dante Alighieri. Il quale si sarà<br />
servito delle sue parole anche per comprare il pane.<br />
Ma la parola pane si sarà portato <strong>di</strong>etro lo stesso alone che ha<br />
nell'episo<strong>di</strong>o del Conte Ugolino? Per il panettiere <strong>di</strong> allora<br />
probabilmente no, per noi oggi nell'alone <strong>di</strong> pane c'è anche quello, sia<br />
che ce ne ren<strong>di</strong>amo conto sia che no. La parola è <strong>di</strong>ventata, dopo<br />
Dante, più pesante, e questo accade impercettibilmente dopo ogni sua<br />
occorrenza, anche se siamo noi a pronunciarla.<br />
La percezione estetica accresce lo spessore semantico della parola<br />
giacché non è questa ad averlo ma siamo noi a darglielo.<br />
E la comunicazione verbale, sia orale che scritta, si arricchisce<br />
proporzionalmente al suo spessore semantico: <strong>di</strong>ciamo <strong>di</strong> più,
capiamo <strong>di</strong> più con lo stesso numero <strong>di</strong> parole, e questo è un<br />
vantaggio culturale e biologico su cui la scuola dovrebbe riflettere.<br />
Un'obiezione, banale ma non infondata, potrebbe essere: ma se<br />
questo vantaggio lo <strong>di</strong>amo a tutti non è più un vantaggio -<br />
un'obiezione che nasce ogni volta che si vorrebbe estendere un<br />
privilegio all'intera società. Certo, decadrebbe come vantaggio, come<br />
privilegio, ma arricchirebbe il nostro universo comunicazionale, la<br />
nostra vita quanto o più <strong>di</strong> quanto non facciano Internet o i telefoni<br />
cellulari, che lo estendono mal tempo stesso lo assottigliano come si<br />
fa con la pasta delle fettuccine. Restituire alla parola <strong>di</strong> tutti i giorni il<br />
suo peso perduto è un'operazione <strong>di</strong> welfare, non inquinante, priva <strong>di</strong><br />
effetti collaterali, un ricostituente mentale utile a tutti.<br />
Altro <strong>di</strong>scorso è quello assiologico, riguardante cioè la valutazione.<br />
Facile <strong>di</strong>re che nella Divina Comme<strong>di</strong>a la parola vale più che al<br />
mercato rionale; assai più <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>mostrarlo, se per esempio a<br />
chiedere del pane è un <strong>di</strong>sabile extracomunitario. Penso che<br />
Benedetto Croce avesse delle buone ragioni a collocare l'arte e il<br />
pensiero estetico nell'ambito transazionale dell'intuizione, meno<br />
quando questi concetti si fanno strumento <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione: questo<br />
sì, questo no. Al giu<strong>di</strong>zio estetico, se pure non vogliamo eliminarlo del<br />
tutto, credo sia meglio riserbare un valore minimale, non eccedente la<br />
cornice dell'occasionalità per cui la sera in TV preferisco guardarmi un<br />
buon giallo che un impegnativo film d'autore. E qualcuno dovrà<br />
<strong>di</strong>mostrarmi che il film d'autore è esteticamente migliore del buon<br />
giallo. Rileggiamo ora il grande passo:
Noi leggevamo un giorno, per <strong>di</strong>letto,<br />
Di Lancillotto, come amor lo strinse:<br />
Soli eravamo, e senza alcun sospetto.<br />
Per più fiate gli occhi ci sospinse<br />
Quella lettura, e scolorocci 'l viso:<br />
Ma sol un punto fu quel che ci vinse.<br />
Quando leggemmo, il <strong>di</strong>siato riso<br />
Esser baciato da cotanto amante,<br />
Questi, che mai da me non fia <strong>di</strong>viso,<br />
La bocca mi baciò, tutto tremante.<br />
Galeotto fu 'l libro e chi lo scrisse.<br />
Quel giono più non vi leggemmo avante.<br />
Come non gridare al capolavoro, come trattenersi dal valutare come<br />
raggiungibile la bellezza <strong>di</strong> questi versi? Ma che ci guadagneremmo,<br />
che ci guadagnerebbero questi versi da questa ovvia valutazione? Non<br />
si vuol <strong>di</strong>re che una reazione del genere non sia più che legittima, ma<br />
che può averla solo<br />
- chi conosce e intende l'italiano dei tempi <strong>di</strong> Dante<br />
- chi ha una pur vaga idea <strong>di</strong> chi sia Lancillotto<br />
- uno cui piace leggere<br />
- uno che abbia dell'attrazione sessuale un'idea sufficientemente<br />
consapevole
...<br />
Per chi non abbia questi prerequisiti, per esempio un ragazzetto <strong>di</strong><br />
scuola me<strong>di</strong>a abituato solo al mondo <strong>di</strong> Sanremo, le nostre valutazioni<br />
<strong>di</strong> eccellenza letteraria suonano probabilmente incomprensibili e<br />
fasti<strong>di</strong>ose.<br />
Abbiamo noi gli strumenti per <strong>di</strong>mostrarla, questa eccellenza?<br />
Probabilmente no, possiamo però accrescere la recettività <strong>di</strong> chi legge<br />
rilevando alcuni tratti del testo che probabilmente sfuggono a una<br />
lettura inesperta. Così il trattamento del fattore tempo:<br />
- il passato della vicenda narrata ("Leggevamo un giorno...")<br />
- un passato anteriore (la storia <strong>di</strong> Lancillotto e Ginevra)<br />
- un passato focalizzato in un punto ("Ma sol un punto...")<br />
- un tempo senza tempo, esteso a un futuro <strong>di</strong> eternità ("Questi che<br />
mai...")<br />
- un tempo bloccato ("Quel giorno più non vi leggemmo avante.")<br />
Così il grande modello - Lancillotto, "cotanto amante" - e la realtà <strong>di</strong><br />
Paolo - "tutto tremante" - la cui passione, tuttavia non avrà fine. Da<br />
notare la rima che rinforza sia l'analogia che l'opposizione. Così anche<br />
l'altra rima, "viso", "riso" che rende quasi visibile parallelismo delle<br />
due situazioni. E ancora:<br />
- "<strong>di</strong>letto" che sembra offuscarsi in "sospetto"<br />
- la progressione: "strinse" (fuori campo, riferito al modello),<br />
"sospinse" (in situazione, <strong>di</strong>retto verso l'esito), "vinse" (punto<br />
d'arrivo).<br />
Si osservi poi la doppia rappresentazione - fisica, assai poco<br />
stilnovistica - del bacio e l'intensificazione da "desiato riso" a "bocca",
con quel misto <strong>di</strong> timidezza ed eccitazione erotica espressa dal<br />
participio "tremante". E si potrebbe continuare per un pezzo...<br />
Paolo e Francesca: una coppia famosa, come Giulietta e Romeo, Faust<br />
e Margherita, Renzo e Lucia. Famosa per chi ha qualche conoscenza<br />
letteraria (nei quiz televisivi e nei rotocalchi ben altre sono le coppie<br />
famose). Si sarebbe tentati <strong>di</strong> stabilire una graduatoria tra esse. Se<br />
come criterio valutativo assumessimo la stringatezza, vincerebbe<br />
certamente la coppia dantesca: pochi versi <strong>di</strong> contro a una trage<strong>di</strong>a,<br />
una trage<strong>di</strong>a multipla e un romanzo. Se però il criterio fosse un altro<br />
(per esempio l'intensità espressiva o lo spessore culturale) la coppia<br />
vincitrice sarebbe un'altra. E se uscissimo dalla letteratura, coppie<br />
vincenti sarebbero tutti coloro che stanno bene assieme.<br />
Servono a poco i giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> qualità; se il pensiero estetico vuole<br />
riacquistare una perduta cre<strong>di</strong>bilità deve liberarsi della componente<br />
assiologica o almeno sottoporla a una ra<strong>di</strong>cale relativizzazione.<br />
Cre<strong>di</strong>amo che l'estetica come <strong>di</strong>sciplina filosofica riguar<strong>di</strong> non gli<br />
oggetti ma l'occhio o meglio la mente <strong>di</strong> chi li osserva. Così intenso, il<br />
ruolo dell'estetica nei processi formativi resta essenziale.<br />
Nel nostro lavoro in una classe elementare abbiamo presentato ai<br />
bambini un testo in tre parti, dal titolo<br />
<strong>di</strong> cui ecco la prima parte:<br />
La fabbrica della casa,
Davanti alla finestra <strong>di</strong> Luigino stanno costruendo una nuova casa. A<br />
giu<strong>di</strong>care dalle fondamenta e dalle case vicine, non sarà un grande<br />
palazzo ma solo una palazzina <strong>di</strong> 4 o 5 piani e 2 o 3 appartamenti per<br />
piano.<br />
Luigino passa le ore alla finestra, osservando il via vai dei muratori,<br />
l'andare e venire dei camion, il su e giù dei montacarichi. Sulle prime<br />
tutto quel movimento gli sembrava casuale, <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>nato. Per esempio,<br />
a che fare hanno portato tutto quel legname? La casa mica la faranno<br />
<strong>di</strong> legno!<br />
E l'acqua? Sembra che i muri li vogliano riempire d'acqua.<br />
Eppure in quelli della casa <strong>di</strong> Luigino l'acqua non c'è: neanche a farci<br />
un buco...<br />
E quel signore che viene ogni tanto con un grande foglio <strong>di</strong> carta:<br />
Luigino lo vede dall'alto, ma sul foglio non ci sta per niente il <strong>di</strong>segno<br />
<strong>di</strong> una casa, solo quadrati, rettangoli e tanti numeri.<br />
Eppure il lavoro procede e la casa vien su: un piano ogni 3 o 4 giorni.<br />
Luigino guarda e riguarda; e man mano capisce.<br />
Capisce come tutto quel movimento, quell'andare e venire, quel salire<br />
e scendere segue un or<strong>di</strong>ne che in qualche modo è già dato.<br />
È come se i movimenti fossero collegati in serie prefissate: una serie<br />
<strong>di</strong> movimenti per fare un pilastro, un'altra per un solaio e così via.<br />
Ma dove è segnato quest'or<strong>di</strong>ne precostituito? Forse proprio su quel<br />
grande foglio su cui c'è scritto Progetto. E forse quel signore che lo<br />
tiene in mano avrà in mente tutti i movimenti e le serie <strong>di</strong> movimenti<br />
che serviranno alla realizzazione del progetto.
La storiella segue passo passo... che cosa? La costruzione della casa?<br />
Forse, anche. Più ancora però il lavoro mentale <strong>di</strong> Luigino per<br />
comprendere. E come si svolge questo lavoro? Osserviamo.<br />
Anzitutto c'è l'osservazione ("Luigino passa le ore..."); poi una<br />
percezione confusa ("Sulle prime tutto quel movimento..."), le prime<br />
ipotesi, subito rigettate ("la casa mica la faranno <strong>di</strong> legno!...",<br />
"Sembra che i muri..."). E Luigino continua a guardare: comincia a<br />
scorgere un or<strong>di</strong>ne, una progettualità e alla fine capisce.<br />
Questo tipo <strong>di</strong> analisi, che i bambini normalmente fanno senza troppa<br />
<strong>di</strong>fficoltà, riguarda il contenuto della storiella. Più faticosa - ma non<br />
meno stimolante - un'analisi dell'espressione, cioè <strong>di</strong> come il<br />
contenuto viene espresso. Immaginando una macchina da presa, la<br />
ve<strong>di</strong>amo ora puntata sulla casa in costruzione, quasi fosse Luigino a<br />
riprenderla, ora su Luigino che osserva qualche particolare, ora con<br />
una zoomata sui particolari stessi (per esempio il foglio con il<br />
progetto); da ultimo ve<strong>di</strong>amo la quasi identificazione con il pensiero <strong>di</strong><br />
Luigino...<br />
Tutto questo vivifica il <strong>di</strong>scorso, rende partecipe il lettore, accresce<br />
l'informazione del testo al <strong>di</strong> là del suo contenuto. Certo non fa della<br />
storiella un oggetto <strong>di</strong> valutazione estetica, ma stimola all'analisi e<br />
alla riflessione. E, al livello <strong>di</strong> base cui inten<strong>di</strong>amo attenerci, questo è<br />
sufficiente.<br />
3.11.Stile ecologico-globalizzante
La parola ecologia e la <strong>di</strong>sciplina che essa designa sono <strong>di</strong> invenzione<br />
piuttosto recente (circa metà ottocento). Etimologicamente stu<strong>di</strong>o<br />
della casa, hanno assunto il significato <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o dell'ambiente e<br />
riguardano sia il mondo animale (uomo compreso) che quello vegetale<br />
nei loro rapporti reciproci e con ciò che li circonda.<br />
Si parla così <strong>di</strong> sistemi ecologici nella loro globalità (un'isola, una<br />
foresta, un massiccio montuoso isolato, una città ecc.), ma anche <strong>di</strong><br />
nicchie ecologiche, riferite a una determinata specie e alle con<strong>di</strong>zioni<br />
ambientali che ne hanno permesso la sopravvivenza e l'evoluzione.<br />
La nicchia ecologica della specie umana, limitata forse in origine, è<br />
oggi costituita dall'intero pianeta terra, considerato come un unico<br />
ecosistema che riceve l'apporto energetico <strong>di</strong> cui ha bisogno<br />
essenzialmente da sole (trascurabile quello fornito dall'interno del<br />
pianeta).<br />
L'uomo però ha trovato assai più pratico ed economico servirsi <strong>di</strong> fonti<br />
energetiche <strong>di</strong>verse da quella solare, praticamente inesauribile,<br />
rivolgendosi alla terra stessa, o meglio ai prodotti della biosfera<br />
(legname, carbone, petrolio) che, per abbondanti che siano, non sono<br />
certo inesauribili. In particolare quelli ricavabili da organismi tuttora<br />
viventi hanno richiesto la deforestazione e conseguente<br />
desertificazione <strong>di</strong> vaste superfici: così in Africa, in Amazzonia, nel<br />
Madagascar e, a casa nostra, in buona parte della penisola balcanica e<br />
dell'Appennino. In tempi recentissimi sono state in<strong>di</strong>viduate nei<br />
minerali ra<strong>di</strong>oattivi sorgenti <strong>di</strong> energia <strong>di</strong> grande potenza ma, ahimè,<br />
assai poco affidabili come Chernobyl ha <strong>di</strong>mostrato. In genere tutta<br />
l'energia che non ricaviamo <strong>di</strong>rettamente dalla fornace solare ha un
costo assai alto in termini <strong>di</strong> inquinamento: una stufa a legno<br />
rinchiusa in una stanza può essere mortale per chi ci abita. La<br />
biosfera ci si mostra gelosa dei suoi prodotti e ven<strong>di</strong>cativa. E il grande<br />
problema ecologico <strong>di</strong> oggi è appunto l'inquinamento: terrestre, idrico,<br />
atmosferico. Come mai la biosfera non ha conosciuto questo problema<br />
prima dell'avvento della specie umana? Si parla invero <strong>di</strong> un possibile<br />
inquinamento atmosferico prodotto da gas vulcanici in precedenti ere<br />
geologiche, ma si tratta <strong>di</strong> ipotesi <strong>di</strong>fficilmente <strong>di</strong>mostrabili e<br />
comunque riguardanti un tempo lontano da noi <strong>di</strong> decine e se non<br />
centinaia <strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> anni.<br />
Mentre l'inquinamento minaccia oggi da vicino la sopravvivenza nostra<br />
e <strong>di</strong> tutti i viventi, e invano cerchiamo <strong>di</strong> addossarne la responsabilità<br />
ad altri che a noi stessi. Forse è proprio la facoltà che più ci <strong>di</strong>stingue<br />
dagli altri viventi e <strong>di</strong> cui an<strong>di</strong>amo particolarmente fieri, la ragione, ad<br />
averci portato sull'orlo dell'estinzione. Senza l'uomo l'ecosistema terra<br />
si è mantenuto, sembra da un paio <strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> anni, in un equilibrio<br />
<strong>di</strong>namico <strong>di</strong> vita e morte regolato da potenti processi retroattivi,<br />
culminanti a tratti in catastrofi ecologiche con la sparizione <strong>di</strong> interi<br />
or<strong>di</strong>ni animali e vegetali, ma pur sempre atti a garantire la<br />
sopravvivenza dell'ecosistema della sua globalità. Oggi si aprono<br />
davanti a noi tre futuri possibili:<br />
- l'annientamento del sistema ecologico globale<br />
- una catastrofe ambientale limitata con la sparizione della specie<br />
umana<br />
- un futuro possibile anche per la specie umana a con<strong>di</strong>zione che<br />
questa sappia riconquistare il perduto equilibrio.
Qui si apre una contrad<strong>di</strong>zione assai <strong>di</strong>fficilmente superabile: poiché è<br />
proprio la ragione che ci ha portato alla rottura <strong>di</strong> quell'equilibrio,<br />
come possiamo affidarci proprio a lei per ricostruirlo?<br />
Conviene forse che penetriamo analiticamente nel concetto <strong>di</strong> ragione,<br />
tentandone una scomposizione che ci permetta poi una<br />
ricomposizione meno pericolosa.<br />
Premetto che tutto il presente <strong>di</strong>scorso ha carattere ipotetico, il che<br />
non gli impe<strong>di</strong>rebbe tuttavia <strong>di</strong> avanzare pretese scientifiche. Ma non<br />
è questo il caso. Manca la sua scientificità l'appoggio sperimentale, se<br />
si prescinde da spora<strong>di</strong>ci successi in campo educazionale. Per giunta<br />
ciò che viene detto non è altro che frutto <strong>di</strong> ragione, <strong>di</strong> quella facoltà<br />
cioè su cui si vuole indagare. La ragione è capace <strong>di</strong> un'autoanalisi che<br />
arrivi fino a metterla in forse? Questa è appunto l'ipotesi, per cui non<br />
abbiamo alcun esperimento convincente.<br />
Muoviamo comunque da questa ipotesi e doman<strong>di</strong>amoci: è la ragione<br />
in quanto tale a mettere in forse la nostra sopravvivenza? Se così<br />
fosse, dovremmo considerare un'ipertelia, cioè uno sviluppo anomalo,<br />
producente regressione come lo sviluppo corporeo <strong>di</strong> certi <strong>di</strong>nosauri,<br />
ecologicamente incompatibile e quin<strong>di</strong> destinato a più o meno rapida<br />
estinzione. Può darsi però che la ragione non sia un meccanismo<br />
unitario ma in qualche modo composito, e che le <strong>di</strong>verse parti abbiano<br />
un <strong>di</strong>verso ritmo evolutivo. Alcune <strong>di</strong> esse, che chiameremo culturali,<br />
evolverebbero in tempi più brevi rispetto alle componenti biologiche,<br />
ma più lunghi rispetto ad altre, che chiameremo metaculturali. Queste<br />
ultime, in grado <strong>di</strong> riconoscere le componenti culturali nella coscienza<br />
riflessa, avrebbero la funzione <strong>di</strong> feedback negativo così da riportare il
processo evolutivo nel suo insieme entro i limiti omeoretici (= <strong>di</strong><br />
equilibrio <strong>di</strong>namico) della biosfera precedente la comparsa dell'homo<br />
sapiens. Il problema della sopravvivenza si configurerebbe quin<strong>di</strong><br />
così: accrescere le componenti metaculturali della ragione e arginare<br />
il potere <strong>di</strong> quelle culturali.<br />
Questa è, lo ripeto, una ipotesi gratuita in quanto nulla autorizza una<br />
tale scomposizione della ragione umana. Nulla però la impe<strong>di</strong>sce in<br />
linea ipotetica e, se da essa dovesse scaturire un benché minimo<br />
vantaggio per la nostra sopravvivenza, non si vede perché scartarla a<br />
priori. In<strong>di</strong>zi che portino in questa <strong>di</strong>rezione non mancano: dal<br />
continuo incremento degli stu<strong>di</strong> antropologici al progressivo<br />
abbandono dell'etnocentrismo, al successo <strong>di</strong> un'epistemologia<br />
relativistica, al <strong>di</strong>ffondersi della democrazia (anche a prescindere<br />
dall'uso delle armi), al proliferare dei movimenti <strong>di</strong> base del tipo no<br />
global...<br />
Quanto a questi ultimi, si tratta <strong>di</strong> movimenti che non si oppongono<br />
agli inevitabili processi <strong>di</strong> globalizzazione indotti dal progresso<br />
tecnologico nel campo delle telecomunicazioni, ma non accettano una<br />
globalità fondata unicamente sull'economia e sull'integrazione del<br />
commercio mon<strong>di</strong>ale tramite le multinazionali. I sostenitori <strong>di</strong> uno<br />
sviluppo sostenibile credono nella possibilità <strong>di</strong> uno sviluppo che<br />
garantisca i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere<br />
quelli delle generazioni future. Costoro talvolta <strong>di</strong>menticano la<br />
globalità <strong>di</strong> sistema del nostro pianeta, più spesso però parlano <strong>di</strong><br />
correlazione tra le <strong>di</strong>mensioni economiche, sociali e ambientali,<br />
includendo così nella loro visione l'intera biosfera (l'equilibrio delle tre
E: ecologia, equità, economia). In questo quadro, fatto proprio anche<br />
dall'UNESCO (2001) trova posto il grande problema della<br />
conservazione - ad<strong>di</strong>rittura incremento - della <strong>di</strong>versità culturale<br />
"necessaria per l'umanità quanto la bio<strong>di</strong>versità lo è per la natura",<br />
ammissione da cui traspare tuttavia ancora la tra<strong>di</strong>zionale separazione<br />
tra natura e cultura, oggi non più sostenibile senza pregiu<strong>di</strong>zio per<br />
entrambe. Più ra<strong>di</strong>cale, ma forse anche più realistica, una filosofia<br />
della decrescita, come quella propugnata dall'economista e filosofo<br />
francese S. Latouche, secondo il quale un modello <strong>di</strong> sviluppo basato<br />
solo sulla crescita indefinita del PIL (prodotto interno lordo)<br />
porterebbe necessariamente al collasso dell'ecosistema planetario e<br />
per le conseguenze dell'inquinamento e per le reazioni <strong>di</strong> quella parte<br />
del mondo non competitiva sul piano della produttività.<br />
Tratteremo nel seguente paragrafo dello stile <strong>di</strong> pensiero<br />
metaculturale, alla cui ra<strong>di</strong>ce troviamo IMC, cui si è già accennato in<br />
apertura. Soffermiamoci ancora per breve tratto sulla formazione <strong>di</strong><br />
un pensiero ecologico-globalizzante sulla cui necessità molti si <strong>di</strong>cono<br />
d'accordo, ma che nei fatti viene largamente sorpassato dal<br />
dominante pensiero consumistico. Una storiella che frequentemente<br />
utilizziamo come innesco a un circuito autogenerativo sull'ecologia è<br />
la seguente:<br />
C'era una volta un tale che aveva ricevuto in ere<strong>di</strong>tà una casa grande,<br />
ricca e bella. Si mise subito ad abitarla e a usarla a suo piacimento<br />
senza curarsi neppure <strong>di</strong> osservare come era fatta.
A essere giusti, se ne curava, ma sempre dopo che qualcosa non era<br />
andata come voleva lui. E quando qualcosa non andava come lui<br />
voleva, ne dava sempre la colpa alla casa e provvedeva ad aggiustare<br />
i suoi <strong>di</strong>fetti.<br />
E così, a forza <strong>di</strong> aggiustature, rifacimenti, ampliamenti, la casa non<br />
corrispondeva più al suo piano <strong>di</strong> fabbricazione.<br />
E cominciò a <strong>di</strong>ssestarsi: una crepa dell'intonaco, un tubo forato da un<br />
chiodo malmesso, un ce<strong>di</strong>mento per sovraccarico, un tramezzo<br />
crollato...<br />
Dopo qualche anno i figli <strong>di</strong> quel tale decisero <strong>di</strong> abbattere la casa,<br />
ormai non più abitabile, per costruirne una nuova, più adatta alle loro<br />
esigenze. Per far presto decisero <strong>di</strong> servirsi <strong>di</strong> esplosivo. Ma fecero i<br />
conti senza l'oste. E in questo caso l'oste era la terra. Sotto la casa<br />
c'era infatti un'enorme caverna sotterranea <strong>di</strong> cui nessuno si era mai<br />
accorto perché nessuno aveva mai fatto dei sondaggi. Il soffitto <strong>di</strong><br />
questa caverna crollò per l'esplosione, e là dove avrebbe dovuto<br />
esserci la casa moderna e funzionale c'è oggi un recinto con un<br />
cartello: "Vietato accostarsi, pericolo <strong>di</strong> morte".<br />
Nelle <strong>di</strong>scussioni successive alla lettura della storiella la metafora<br />
casa terra risulta <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata evidenza anche in una III<br />
elementare. Non così il significato secondo del crollo finale, percepito<br />
più come un incidente che non come dovuto a imprevidenza. Anche il<br />
parallelismo tra la situazione attuale e quel "Vietato accostarsi,<br />
pericolo <strong>di</strong> morte" è stato colto solo dopo qualche tempo, ma allora<br />
c'è stato qualche bambino che si è ricordato della bomba <strong>di</strong> Hiroshima
(evidentemente ne aveva sentito parlare in famiglia o alla TV) e<br />
qualche altro che si è impaurito. Difficile raccordare il nostro stato <strong>di</strong><br />
benessere alla sua pericolosità. In genere l'idea <strong>di</strong> pericolo nasce da<br />
una situazione <strong>di</strong> incertezza e <strong>di</strong> malessere. Quando tutto intorno a<br />
noi tende a rassicurarci (e in linea generale l'adulto si comporta così<br />
con il bambino), è molto poco probabile che ci ren<strong>di</strong>amo conto <strong>di</strong> ciò<br />
che potrebbe minare la nostra sicurezza.<br />
Se perfino un cartello troppo spesso non è sufficiente a evitare<br />
incidenti anche gravi, tanto meno questi sono evitabili quando il<br />
cartello neppure c'è, anzi i <strong>di</strong>ntorni della zona pericolosa ci appaiono<br />
particolarmente gradevoli.<br />
Per sollecitare ulteriormente una progressiva presa <strong>di</strong> coscienza della<br />
responsabilità che noi uomini abbiamo nei confronti della nostra casa<br />
celeste ci serviamo spesso <strong>di</strong> alcuni Dialoghi fittizi come il seguente,<br />
incentrato sull'opposizione naturale/artificiale (P=Paolo,<br />
F=Francesca).<br />
F. Ho ripensato a quello che ci siamo detti a proposito <strong>di</strong> naturale e<br />
artificiale: oggi si parla molto dell'uomo che con i suoi prodotti<br />
artificiali inquina la natura e mette in forse perfino la nostra<br />
sopravvivenza.<br />
...<br />
P. Ho letto che in certi perio<strong>di</strong> anche i vulcani producevano troppi gas,<br />
che rendevano impossibile la vita.<br />
F. Credo che il problema non sia la <strong>di</strong>stinzione naturale/artificiale ma<br />
la logica.
P. Non capisco! Che vuoi <strong>di</strong>re?<br />
F. Voglio <strong>di</strong>re che, se gli uomini fossero stufi <strong>di</strong> vivere, farebbero bene<br />
a inquinare la natura; siccome però vogliono vivere, anzi vivere<br />
sempre meglio, e al tempo stesso inquinare, entrano in<br />
contrad<strong>di</strong>zione...<br />
P. ... mentre ai vulcani della logica non gliene importava niente.<br />
F. Quin<strong>di</strong>, sempre a lume <strong>di</strong> logica,<br />
- o rinunciamo a vivere sempre meglio<br />
- o rinunciamo a inquinare.<br />
P. Ma non possiamo vivere meglio senza inquinare?<br />
F. Vivremmo meglio già se non inquinassimo.<br />
P. Forse dovremmo rinunciare a qualcosa...<br />
F. Ma chi dovrebbe rinunciare? Chi non ha quasi nulla?<br />
P. Forse chi ha troppo.<br />
F. Ma hai mai sentito uno che <strong>di</strong>ce "io ho troppo"?<br />
P. No, e allora come si fa?<br />
F. Non lo so.<br />
Le battute conclusive sono chiaramente aperte, interlocutorie: si<br />
chiede al lettore <strong>di</strong> trovare una via <strong>di</strong> uscita. Ed effettivamente i<br />
ragazzi in genere fanno delle proposte:<br />
- si potrebbe imporre a chi più ha <strong>di</strong> dare una parte <strong>di</strong> ciò che ha a<br />
chi non ha nulla<br />
- si potrebbe proibire a chi inquina <strong>di</strong> inquinare<br />
- si potrebbe decidere tutti assieme <strong>di</strong> inquinare <strong>di</strong> meno...<br />
- ... il che vuol <strong>di</strong>re consumare <strong>di</strong> meno...
- ... e guadagnare <strong>di</strong> meno<br />
- oppure si potrebbe inventare un modo <strong>di</strong> produrre senza inquinare<br />
......<br />
Come si vede queste soluzioni proposte in una V elementare<br />
riproducono in forme semplificate soluzioni politiche e tecnologiche da<br />
tempo sperimentate nella società adulta (decisioni imposte dall'alto,<br />
democraticamente concordate, ricerca <strong>di</strong> fonti energetiche non<br />
inquinanti...).<br />
Dovrebbe essere chiaro che una visione ecologica e globalizzante dei<br />
problemi che oggi gravano sulla nostra sopravvivenza ci accomuna,<br />
come CMC, a tutti coloro che li denunciano e tentano <strong>di</strong> risolverli.<br />
Troppe sono tuttavia le trappole che si nascondono <strong>di</strong>etro la parola<br />
natura in ambedue i sensi: la tal cosa è del tutto naturale (mentre è<br />
manifestamente un'acquisizione culturale) o la talaltra è decisamente<br />
contro natura (mentre si tratta ancora una volta <strong>di</strong> un tabù culturale).<br />
Occorre preparare in tempo le <strong>di</strong>fese separando ecologia da morale,<br />
globalizzazione da appiattimento su un unico modello, welfare da<br />
benessere misurato in termini solo economici.<br />
3.12. Stile relativistico-metaculturale<br />
Abbiamo già incontrato - in 3.2.2. - il termine relativistico, associato<br />
però a ipotetico per definire lo stile mentale scientifico oggi<br />
imperante. Le affinità tra i due stili - quello ipotetico e quello<br />
metaculturale - sono molte e in qualche caso non è neppure
necessario che vengano <strong>di</strong>stinti. Il relativismo che li lega non è<br />
tuttavia lo stesso. Nella scienza, in particolare nella fisica, la teoria<br />
della relatività può essere considerata un'ipotesi, non certo una teoria<br />
relativa a certi fenomeni piuttosto che ad altri.<br />
Sia la relatività ristretta che quella generale sono state formulate da<br />
Einstein come Newton formulò la sua, cioè come teoria <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà<br />
assoluta e come tali vanno considerate e possiamo <strong>di</strong>re che sono,<br />
nell'ambito che esse definiscono. Secondo IMC, rientrano<br />
perfettamente nel modello <strong>di</strong> assolutezza metaculturale, modello che<br />
ammette l'assoluto, purché localizzato in qualche UCL.<br />
E qui l'UCL che le convalida è fornito dalle teorie stesse. Viene in<br />
mente la consueta immagine dell'omino che si tira su prendendosi per<br />
i pie<strong>di</strong>. Ma nel caso della fisica ci sono le prove sperimentali a<br />
convalidare nel mondo reale quelle teorie... finché un inatteso<br />
esperimento non le contrad<strong>di</strong>ca. In effetti la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> un assoluto<br />
non localizzabile non può essere <strong>di</strong>mostrato da nessun esperimento<br />
reale. E in questo sta la <strong>di</strong>fferenza tra la relatività scientifica e quella<br />
metaculturale: la relatività scientifica non <strong>di</strong>pende da alcun UCL<br />
particolare e aspira alla vali<strong>di</strong>tà entro UMC, pur attendendo con<br />
trepidazione l'esperimento che la invaliderà; il relativismo<br />
metaculturale non ha nulla da temere poiché nulla pretende al <strong>di</strong> là <strong>di</strong><br />
quanto richiesto nei singoli UCL.<br />
Sembrano - e forse sono - sottigliezze <strong>di</strong> scarso interesse logico e<br />
come tali gratuite e inutili. Penso però che gli stili <strong>di</strong> pensiero, come<br />
qui quello relativistico-metaculturale, non vadano misurati l'uno con il<br />
metro dell'altro, ma valutati - metaculturalmente - nelle loro
conseguenze pratiche, il che oggi vuol <strong>di</strong>re essenzialmente nel loro<br />
valore <strong>di</strong> sopravvivenza. Il concetto è darwiniano e attiene in origine<br />
alla biologia (evoluzionismo), attualmente però se ne osserva<br />
l'applicabilità alla cultura umana. Fino a pochi decenni fa era<br />
dominante l'idea del progresso, <strong>di</strong> un illimitato avanzamento della<br />
tecnica, del benessere (welfare) e della conoscenza umana. Quanto a<br />
quest'ultima non so se un analogo conoscitivo del teorema <strong>di</strong> Gödel<br />
segnerà un giorno il limite dell'umanamente conoscibile.<br />
Il limite del welfare si viene oggi tracciando nei problemi ecologici che<br />
tutti conosciamo. Il progresso tecnico sembra non avere limiti se non<br />
quelli che potrà assegnargli in un futuro più o meno lontano la<br />
capacità umana <strong>di</strong> metabolizzarlo biologicamente. Sia come sia,<br />
l'ideologia del progresso - il progresso come valore autonomo,<br />
svincolato dalla sopravvivenza - si sta palesemente indebolendo. Se<br />
ne stanno cercando dei sostituti più affidabili, spesso ricorrendo a<br />
ideologie pregresse <strong>di</strong> tipo magico-religioso, talora elaborando ipotesi<br />
<strong>di</strong> decrescita (economica, dei consumi, del welfare) o <strong>di</strong> equilibrio<br />
statico (senza né progresso né regresso). Ma avrebbe senso un futuro<br />
in cui il domani non aggiunge nulla all'oggi, anzi toglie qualche cosa?<br />
Un futuro <strong>di</strong> involuzione, varrebbe la pena <strong>di</strong> viverlo? Certo, nella<br />
storia dei viventi non mancano fasi regressive che aboliscono alcune<br />
conquiste ottenute in milioni <strong>di</strong> anni: per esempio il volo in alcune<br />
specie <strong>di</strong> insetti e uccelli. Ma si tratta <strong>di</strong> un vero regresso e non<br />
piuttosto <strong>di</strong> un riadattamento evolutivo a mutate con<strong>di</strong>zioni<br />
ambientali, in definitiva, quin<strong>di</strong>, a un progresso?
Non è che dobbiamo rinunciare del tutto a questa idea, quanto che<br />
dobbiamo renderla compatibile con la sopravvivenza cambiandone i<br />
contenuti. Lo stesso welfare, oggi legato quasi esclusivamente al<br />
fattore economico, all'avere <strong>di</strong> più, potrebbe essere misurato da altri<br />
parametri, apparentemente secondari, per esempio alla<br />
consapevolezza che in altre parti della terra non si muoia <strong>di</strong> fame. Il<br />
progresso tecnico e anche quello conoscitivo (la scienza) potrebbero<br />
concentrarsi più sul contenimento della produttività umana che sul<br />
suo incremento, lasciando ad altre componenti della biosfera lo spazio<br />
vitale che gli abbiamo tolto. Anche per questo tipo <strong>di</strong> progresso<br />
occorre un investimento <strong>di</strong> pensiero, superiore forse a quello<br />
necessario a produrre nuovi modelli <strong>di</strong> conoscenza. E così le culture,<br />
piuttosto che mirare all'espansione e all'autoglorificazione, potrebbero<br />
rivolgersi criticamente su sé stesse e sulla propria idoneità alla<br />
sopravvivenza (la nostra occidentale, per esempio, chiaramente non<br />
lo è). In una parola, pensiamo che occorra una mutazione<br />
antropologica che, partendo dallo stato culturale che ci <strong>di</strong>stingue<br />
come specie, un poco alla volta ci porti alla transizione verso uno<br />
stato metaculturale, caratterizzato da riflessività potenzialmente<br />
illimitata. Con ciò non voglio <strong>di</strong>re che la riflessione metaculturale<br />
debba procedere all'infinito come la serie <strong>di</strong> immagini riflesse da due<br />
specchi affrontati, ma che, ovunque ci si fermi, la fermata avvenga<br />
nella consapevolezza che un'immagine ultima non è raggiungibile.<br />
È quanto propone IMC, l'Ipotesi Metaculturale, <strong>di</strong> cui già si è detto in<br />
apertura, ma le cui conseguenze pratiche, soprattutto in campo<br />
formativo, sono ancora quasi del tutto da indagare. Prima però <strong>di</strong>
muovere qualche passo in questa <strong>di</strong>rezione, vorrei ricordare che,<br />
secondo IMC, la componente metaculturale non si manifesterebbe<br />
soltanto oggi nelle culture umane, ma ne sarebbe piuttosto il motore<br />
occulto, ciò che ne ha permesso il progresso (ancora questa parola,<br />
spogliata tuttavia <strong>di</strong> qualsiasi contenuto specifico): le culture, cioè,<br />
avrebbero progre<strong>di</strong>to, quale più quale meno, grazie alla loro capacità<br />
<strong>di</strong> riflettere su sé stesse, sulla loro relatività. Semplificando al<br />
massimo, possiamo grafizzare il rapporto tra cultura e riflessività<br />
metaculturale in questo modo.<br />
La <strong>di</strong>rezionalità del grafico non è essenziale: potrebbe essere rivolto<br />
verso l'alto, <strong>di</strong>pende da come consideriamo la riflessione, se<br />
procedente verso un irraggiungibile fondamento o verso un'altrettanto<br />
irraggiungibile finalità ultima.<br />
IMC e lo stile <strong>di</strong> pensiero che ne deriva non sono dunque una novità<br />
ma una costante delle culture; ciò che oggi si aggiunge è un ulteriore
grado <strong>di</strong> riflessività che ci permette <strong>di</strong> vedere con maggiore chiarezza<br />
questa componente verticale che forse è proprio ciò che <strong>di</strong><br />
specificamente umano caratterizza i nostri sistemi culturali. Anche nel<br />
mondo animale la cultura gioca un ruolo essenziale per la<br />
sopravvivenza delle singole specie, come <strong>di</strong>mostrano la trasmissione<br />
culturale <strong>di</strong> comportamenti caratteristici da una generazione all'altra<br />
nonché la <strong>di</strong>sponibilità, geneticamente fondata, all'appren<strong>di</strong>mento.<br />
Questo vale per i mammiferi, per gli uccelli e in minore misura per le<br />
altre classi, dove peraltro ve<strong>di</strong>amo funzionare, con pari se non<br />
superiore ren<strong>di</strong>mento, altre forme <strong>di</strong> trasmissione. Probabilmente la<br />
trasmissione culturale ha a che fare con lo sviluppo del cervello o <strong>di</strong><br />
parti <strong>di</strong> esso come farebbero pensare i mammiferi e segnatamente i<br />
pongi<strong>di</strong> e l'uomo, presso il quale le <strong>di</strong>mensioni relative raggiunte da<br />
quest'organo potrebbero essere legate alla riflessività metaculturale.<br />
Osservo in questa esposizione una sovrabbondanza <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionali,<br />
dovuti in parte alla scarsa conoscenza che il CMC ha <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong><br />
problemi, in parte però anche allo stato attuale della neurofisiologia e,<br />
più in generale, dell'epistemologia in relazione alla riflessività.<br />
La trattazione teorica <strong>di</strong> IMC e dello stile <strong>di</strong> pensiero metaculturale<br />
non potrà che avvantaggiarsi da ulteriori stu<strong>di</strong> su questo argomento.<br />
Ciò non contrad<strong>di</strong>ce quanto prima affermato sui limiti<br />
dell'umanamente conoscibile: l'attività conoscitiva potrebbe (ancora<br />
un con<strong>di</strong>zionale!) proseguire indefinitamente senza raggiungerli, quei<br />
limiti, così come anche le altre forme <strong>di</strong> progresso non è detto<br />
debbano arrestarsi, ma solo cambiare il loro itinerario, le loro finalità.<br />
"Homo sapiens - mi è capitato un giorno <strong>di</strong> scrivere - pre<strong>di</strong>lige le
forme potenziali non quelli attuali. Come specie, avrà realizzato sé<br />
stesso quando tutte le sue potenzialità saranno <strong>di</strong>venute attuali. Ma<br />
per arrivare a questo c'è ancora molto tempo... Quando però la sua<br />
conoscenza intellettuale sarà <strong>di</strong>venuta un tutt'uno con quella biologica<br />
(l'informazione biologica verrà compresa intellettualmente - la<br />
conoscenza coinciderà con l'essere) sarà la fine della sua specificità, la<br />
fine dell'uomo come specie". 1 Oggi sarei meno catastrofico, ma<br />
tuttora ritengo che il limite ultimo della conoscenza sia un'aporia<br />
logica in quanto, anche se lo ammettessimo, sarebbe sempre<br />
possibile un atto metaculturalmente riflessivo che lo travalicherebbe.<br />
Ma non è questo genere <strong>di</strong> speculazioni che avevamo in mente<br />
proponendo IMC. Ripeto quanto già detto in innumerevoli situazioni:<br />
la riflessione metaculturale non è uno sterile esercizio del pensiero<br />
che si autocompiace, ma un correttivo pratico volto a in<strong>di</strong>rizzarlo<br />
verso la concretezza del problema dei problemi: quella della<br />
sopravvivenza. Spesso, come per esempio nella pratica musicale <strong>di</strong><br />
base, non è <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ata evidenza il collegamento con la<br />
sopravvivenza. Lo stesso vale per le singole specificità culturali, ma<br />
non per il loro insieme. Così questo collegamento dovrebbe essere<br />
chiaro (almeno noi speriamo che lo sia) a chiunque abbia una buona<br />
conoscenza del nostro sito e dei materiali <strong>di</strong> supporto.<br />
Non è mia intenzione riproporre qui ampie sezioni dell'uno e degli<br />
altri, tanto più che un certo numero <strong>di</strong> citazioni sono già contenute nei<br />
vari paragrafi del presente scritto. Raccomando però ai lettori<br />
interessati, meglio ancora se professionalmente impegnati in campo<br />
1 Musica/società, 266, in tedesco
formativo, <strong>di</strong> intraprendere una navigazione all'interno del sito, anche<br />
sperimentando - nelle scuole o con gruppi <strong>di</strong> partecipanti, bambini,<br />
giovani o adulti - le in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> lavoro connesse ai singoli progetti.<br />
Al titolo <strong>di</strong> esempio adduco un'ulteriore citazione, riguardante un<br />
progetto nel quale la <strong>di</strong>rezionalità metaculturale e il collegamento con<br />
la culturalità della conoscenza sono facilmente leggibili, anche per un<br />
alunno delle elementari.<br />
Una ricerca senza contenuto<br />
(Monologo fittizio,partim)<br />
"Sì, mi avevano detto che a scuola ti fanno fare delle ricerche, ma<br />
finora non mi è mai capitato.<br />
Che vuol <strong>di</strong>re ricercare? Cercare due volte? E poi, cercare che cosa?<br />
Ho cercato il mio telefonino, non l'ho trovato e adesso lo ricerco...<br />
No, non credo... La ricerca dev'essere un'altra cosa... Ho sentito<br />
parlare <strong>di</strong> ricerca scientifica e anche <strong>di</strong> ricerca storica.<br />
C'è qualcosa che non si conosce e la si vuole conoscere. Oppure c'è<br />
qualcosa che si osserva e non si capisce: si fa una ricerca per vedere<br />
se è vero o se la cosa sta in altro modo. Cioè si fanno delle<br />
osservazioni sulla cosa che ci interessa, poi si cerca <strong>di</strong> capire ciò che<br />
si è osservato: si fanno delle ipotesi e si verifica se queste ipotesi<br />
spiegano veramente ciò che si è osservato.<br />
Ma che vuol <strong>di</strong>re che lo spiegano?<br />
Vuol <strong>di</strong>re che danno una risposta a tutte le nostre domande su quella<br />
cosa.
Proprio a tutte?<br />
Può darsi che una risposta produca altre domande...<br />
Allora le ricerche non finiscono mai...<br />
Ma le ipotesi dove le vado a trovare?<br />
Posso fabbricarmele da solo...<br />
Ma se la cosa la conosco troppo poco per fare delle ipotesi sensate?<br />
Vado a informarmi da chi ne sa <strong>di</strong> più.<br />
Oppure faccio una ricerca - eco <strong>di</strong> nuovo la parola chiave - su<br />
un'enciclope<strong>di</strong>a o su Internet, poi magari su qualche libro<br />
specializzato.<br />
E, se la cosa che mi interessa non posso osservarla, per esempio<br />
perché è accaduta nel passato o accade lontano da me?<br />
Debbo contentarmi <strong>di</strong> ciò che mi <strong>di</strong>cono le tracce, i documenti scritti, i<br />
libri o, se ci sono, i testimoni <strong>di</strong>retti, cioè quelli che la cosa l'hanno<br />
vista.<br />
Ma come faccio a sapere se mi <strong>di</strong>cono la verità?<br />
Posso consultare più documenti, più libri, chiedere a più testimoni,<br />
anzi credo che una buona ricerca non possa limitarsi a una sola fonte,<br />
documento o libro o persona che sia.<br />
Del resto, anche se la cosa l'ho osservata io stesso e magari mi sono<br />
costruito anche delle ipotesi, chi mi <strong>di</strong>ce che ho visto bene e ho<br />
pensato bene?<br />
Sicuro al cento per cento non sarò mai, ma se una certa ipotesi trova<br />
d'accordo molti ricercatori, ci sono buone probabilità che sia quella<br />
giusta, almeno finché...
... finché nuove e più approfon<strong>di</strong>te ricerche non portino a nuove<br />
ipotesi e così via".<br />
Che il monologo sia fittizio lo si vede dal fatto che l'ingenuità della<br />
prima domanda viene via via contraddetta da ciò che segue, dove il<br />
monologante si <strong>di</strong>mostra assai più informato che non all'inizio. È come<br />
se il processo conoscitivo fosse già in corso. Un primo lavoro da fare<br />
su questo testo potrebbe essere un'analisi del medesimo sia dal punto<br />
<strong>di</strong> vista del contenuto (che cosa ci <strong>di</strong>ce) sia da quello dell'espressione<br />
(come ce lo <strong>di</strong>ce). Un confronto tra contenuto ed espressione ci<br />
mostrerebbe poi un certo parallelismo: l'espressione si fa più<br />
complessa a mano a mano che anche il contenuto penetra più a fondo<br />
il suo argomento. Questo infine (la ricerca) si riflette su sé stesso<br />
metaculturalmente (ricerca sulla ricerca).<br />
L'esempio qui riportato non esaurisce certamente il senso del termine<br />
relatività metaculturale, anzi sembra non <strong>di</strong>stinguerlo dallo stile<br />
ipotetico-relativistico <strong>di</strong> cui in 3.2.2. In effetti questo è un po' il<br />
modello - uno dei modelli, gli altri si trovano nella musica e nelle arti<br />
in genere - su cui IMC è stata costruita. Quasi per assurdo, è più<br />
facile accettare ciò che ci <strong>di</strong>ce la scienza, anche per l'autorità che<br />
siamo <strong>di</strong>sposti a riconoscerle, che immedesimarci nella quoti<strong>di</strong>anità <strong>di</strong><br />
IMC.<br />
Della quoti<strong>di</strong>anità ci consideriamo esperti e padroni e IMC sembra<br />
sottrarci anche questo dominio, <strong>di</strong>sconoscendogli certezza e valore.<br />
A questa, certo possibile, interpretazione se ne oppone un'altra che<br />
alla quoti<strong>di</strong>anità riconosce pienamente certezza e valore, purché
culturalmente localizzati. Ed è questa localizzazione degli assoluti che<br />
incontra le maggiori <strong>di</strong>fficoltà ad essere accettata, perché ne implica<br />
la relativizzazione, non al suo interno, ma nel confronto con altri<br />
luoghi culturali, altri UCL. Questa <strong>di</strong>fficoltà aumenta dall'infanzia<br />
all'età adulta, quando il ra<strong>di</strong>camento culturale si fa più forte, le<br />
abitu<strong>di</strong>ni si consolidano, lo stile mentale si sclerotizza...<br />
Per questa ragione IMC ha il suo punto <strong>di</strong> forza nei processi formativi,<br />
non necessariamente limitati all'età scolare, certo però aventi nella<br />
scuola l'area <strong>di</strong> più probabile sviluppo. Non cre<strong>di</strong>amo che lo stile<br />
relativistico-metaculturale possa influire <strong>di</strong>rettamente sull'arco<br />
evolutivo della mente. La progressiva sclerotizzazione dello stile <strong>di</strong><br />
pensiero avverrà comunque: un conto però se avverrà sulla<br />
impermeabilità <strong>di</strong> uno stile fortemente culturalizzato, un altro se<br />
avverrà sull'apertura relativistica dello stile metaculturale. Lascio al<br />
lettore <strong>di</strong> trarne le conseguenze per un possibile, niente affatto certo,<br />
futuro.<br />
4. Stile <strong>di</strong> pensiero (classificazione modale)<br />
Ho già detto in apertura a 3. che la <strong>di</strong>stinzione qui adottata per gli stili<br />
<strong>di</strong> pensiero tra classificazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e classificazione modale è<br />
del tutto artificiale e funzionale a una prima ricognizione su questa<br />
in<strong>di</strong>stinta materia.<br />
Tutti sappiamo pensare ma la parola stessa pensiero manca <strong>di</strong> un suo<br />
preciso referente. Se <strong>di</strong>co "mano" so a quali parti del corpo mi
iferisco; se <strong>di</strong>co "<strong>di</strong>gerire", conosco a gran<strong>di</strong> linee i processi fisiologici<br />
significati; se <strong>di</strong>co "pensare" possa far finta <strong>di</strong> sapere che cosa sto<br />
<strong>di</strong>cendo, in realtà non lo so. Penso per parole, per immagini, per<br />
concetti?...<br />
Penso pensieri miei o pensieri già pensati da altri? So sempre che<br />
cosa penso... anche nel sonno? Posso pensare <strong>di</strong> pensare? E così<br />
via...<br />
Certo la psicologia tenta <strong>di</strong> darci una mano. Ma ci riesce?<br />
E così anche la neurologia, la fisiologia, l'anatomia spiegano,<br />
interpretano, localizzano, ciascuno nell'ambito suo specifico.<br />
Ma il pensiero che cos'è?<br />
Probabilmente è la domanda stessa a presupporre un oggetto che non<br />
c'è. Il pensiero viene "appercepito", non "percepito" come percepiamo<br />
gli oggetti fuori da noi. Potremmo, anche se non ci conviene farlo,<br />
percepire il nostro fegato, il nostro cuore, perfino il nostro cervello,<br />
per esempio estraendoli e mettendoli su un tavolo. Qualche <strong>di</strong>fficoltà<br />
in più avremmo se volessimo vedere i nostri occhi, ma c'è sempre la<br />
scappatoia dello specchio... Qualcuno potrebbe <strong>di</strong>re che anche i<br />
pensieri li ve<strong>di</strong>amo concretizzati in ciò che <strong>di</strong>ciamo o facciamo. Ma si<br />
tratta proprio dei nostri pensieri o non <strong>di</strong> una semplice traccia, come<br />
le orme fossilizzate <strong>di</strong> un <strong>di</strong>nosauro non sono il <strong>di</strong>nosauro stesso?<br />
Anche la nostra indagine sugli stili <strong>di</strong> pensiero non ci avvicina <strong>di</strong> un<br />
passo all'essenza del pensiero. (Il pensiero a un'essenza?)<br />
Tanto meno lo fa la <strong>di</strong>stinzione tra classificazione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e<br />
classificazione modale. E allora perché insistervi?
Ritornando a IMC, il pensiero, metaculturalmente inteso, non è<br />
rivolto, come <strong>di</strong>cevano gli antichi, al riconoscimento della verità;<br />
semmai alla sua costruzione. Anche quella che qui proponiamo è una<br />
costruzione, non della verità, ma <strong>di</strong> uno strumento che riteniamo<br />
possa essere utile ai processi formativi sia del singolo che della<br />
collettività. In definitiva ciò che ci interessa non è il riconoscimento<br />
ontologico del pensiero (il pensiero, che cos'è), ma la sua attivazione.<br />
Per assurdo, se arrivassimo a capire la sua essenza, non avremmo più<br />
ragione <strong>di</strong> riflettere e cesserebbe il principale stimolo al suo<br />
movimento. Cre<strong>di</strong>amo infatti che la capacità <strong>di</strong> riflettere su sé stesso<br />
sia ciò che <strong>di</strong>stingue il pensiero umano dalle altre forme <strong>di</strong> pensiero<br />
del regno animale. E se venisse meno questa nostra specificità, anche<br />
la nostra sopravvivenza come specie non avrebbe più senso<br />
nell'economia della biosfera. Restando ai limiti dell'assurdo, il pensiero<br />
umano ricava la sua ragion d'essere proprio dalla sua inadeguatezza.<br />
Un pensiero onnisciente, onnipotente, non avrebbe un futuro, non<br />
conoscerebbe la vita: affonderebbe nell'universo nullificante che<br />
chiamiamo UMC.<br />
Il <strong>di</strong>segno epistemologico che ci guida è appunto quello <strong>di</strong> sfuggire al<br />
suo potere attrattivo.<br />
4.1. Modalità osservativa<br />
I maestri dell'osservazione sembrano essere i bambini molto piccoli,<br />
che infatti ve<strong>di</strong>amo spesso girare e rigirare uno stesso oggetto,<br />
batterlo, assaggiarlo per molti minuti.
Possiamo <strong>di</strong>re che lo osservano?<br />
Dipende da che cosa inten<strong>di</strong>amo per osservare.<br />
In una ipotetica catena semantica riguardante l'attività visiva -<br />
percepire, guardare, vedere, osservare - osservare occupa l'ultimo<br />
posto e presuppone ben più che il solo organo della vista. Già il<br />
vedere non è passiva ricezione sensoriale come forse lo è il percepire.<br />
Possiamo immaginare che una cellula percepisca un segnale luminoso<br />
dal fatto che si contrae, <strong>di</strong>fficilmente <strong>di</strong>remmo che lo vede. Del resto<br />
anche molto più su nella scala evolutiva un falco in volo scruta<br />
intensamente il campo in cui si nasconde la starna, ma non la vede,<br />
grazia alla sua immobilità e al colore mimetico del piumaggio. Un<br />
piccolo movimento ed eccolo piombare sulla preda. Anche noi, del<br />
resto, non ve<strong>di</strong>amo tutto ciò che percepiamo ma solo quello <strong>di</strong> cui<br />
posse<strong>di</strong>amo uno schema mentale <strong>di</strong> riferimento. Molti, passeggiando<br />
in un bosco non vedono che alberi, altri <strong>di</strong>stinguono aghifoglie da<br />
latifoglie, altri ancora alcune delle specie più comuni, pini, abeti,<br />
querce, faggi, l'esperto in botanica vede molto <strong>di</strong> più nonostante<br />
percepisca gli stessi stimoli del laico. Guardare presuppone<br />
intenzionalità, vedere il possesso <strong>di</strong> modelli interpretativi. In molti<br />
animali, specialmente negli insetti, questi modelli sono geneticamente<br />
fissati, cosicché quella certa vespa parassita non ha bisogno <strong>di</strong><br />
imparare a riconoscere il buco in cui deporrà le uova, e neppure <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>are la sua anatomia interna, la cui esatta conoscenza le è<br />
in<strong>di</strong>spensabile per paralizzare il bruco senza ucciderlo. Forse non è<br />
neppure essenziale che lo veda come buco, potrebbe essere<br />
sufficiente un altro tipo <strong>di</strong> percezione, per esempio tattile od olfattiva.
In generale possiamo <strong>di</strong>re che l'occhio vede se la mente sa che cosa<br />
guardare. Per gli animali cui l'istinto fornisce questo modello, il<br />
problema è risolto per via ere<strong>di</strong>taria, ma per quelli che debbono<br />
costruirselo attraverso l'esperienza, qual'è il meccanismo che glielo<br />
permette? La cosa ci riguarda da vicino, perché l'uomo è l'animale<br />
forse meno dotato dal punto <strong>di</strong> vista istintuale. Non ci basta percepire<br />
e neppure guardare e vedere: dobbiamo saper osservare. Per fortuna<br />
questa capacità ci è data geneticamente, anche se non ancora<br />
provvista <strong>di</strong> contenuti. (È come se l'uomo avesse conservato, dei<br />
perduti istinti, solo un involucro <strong>di</strong> potenzialità.)<br />
Siamo cioè capaci <strong>di</strong> osservare, <strong>di</strong> costruirci dei modelli conoscitivi su<br />
cui misurare gli input sensoriali. Ma che cosa osserva un bambino<br />
molto piccolo?<br />
(Tutto ciò che si <strong>di</strong>ce in proposito ha carattere ovviamente ipotetico,<br />
poiché mancano sia la comunicazione <strong>di</strong>retta che la memoria<br />
soggettiva come anche la sperimentabilità scientifica.)<br />
Osserva le cose che lo circondano attraverso le reazioni che<br />
producono in lui. In tal modo costruisce una prima <strong>di</strong>stinzione tra sé e<br />
il mondo, alla quale altre ne seguono, sempre più numerose, tutte<br />
basate sul confronto, non tra le cose stesse, ma tra le immagini<br />
sensoriali ricevute.<br />
Come vengono <strong>di</strong>stinte le immagini?<br />
Attraverso la loro scomposizione e successive operazioni <strong>di</strong> confronto.<br />
Ma abbiamo già sconfinato in un'altra modalità che chiameremo<br />
analitica e <strong>di</strong> cui ci occuperemo nel paragrafo successivo. Il fatto è<br />
che la stessa scomposizione che quasi inavvertitamente stiamo
facendo dell'atto osservativo è in larga misura arbitraria e così le varie<br />
componenti in<strong>di</strong>viduate sono fittizie, utili tutt'al più a in<strong>di</strong>rizzare<br />
l'attenzione sul complicato intreccio degli atti mentali che<br />
costituiscono l'osservazione.<br />
L'osservazione <strong>di</strong> sé stessi accresce ulteriormente la complessità <strong>di</strong><br />
queste intreccio. Tuttavia pensiamo che sia opportuno promuovere<br />
l'attività osservante, <strong>di</strong>retta sia fuori che dentro <strong>di</strong> noi, fin dal suo<br />
primo manifestarsi nei primi mesi <strong>di</strong> vita.<br />
Più tar<strong>di</strong> dovrà essere la scuola a farlo, in misura ben maggiore <strong>di</strong><br />
quanto oggi non accada. Perché questa raccomandazione?<br />
Attraverso l'osservazione - prima <strong>di</strong> una lunga serie <strong>di</strong> operazioni<br />
conoscitive -:<br />
- il mondo si arricchisce indefinitamente (si arricchisce la nostra<br />
immagine <strong>di</strong> esso)<br />
- si arricchiscono indefinitamente gli strumenti mentali grazie ai quali<br />
osserviamo (così la capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere)<br />
- gli innumerevoli stimoli sensoriali cui siamo sottoposti non vanno<br />
<strong>di</strong>spersi e la nostra vita si fa più interessante<br />
- penetriamo più a fondo nelle cose e nei rapporti tra esse, in altre<br />
parole capiamo meglio e <strong>di</strong> più<br />
- accresciamo le nostre capacità intellettive, <strong>di</strong>ventiamo più<br />
...<br />
intelligenti.<br />
Abbiamo fin qui abbinato l'osservazione all'attività visiva. Si tratta più<br />
che altro <strong>di</strong> una metafora perché si osserva quasi altrettanto bene con<br />
l'u<strong>di</strong>to e gli altri sensi. Il primato della vista, su cui tra l'altro sembra
si sia modellato il linguaggio verbale, è stato peraltro messo in<br />
<strong>di</strong>scussione proprio dall'avvento della parola, che, almeno in origine,<br />
si è servita essenzialmente del canale u<strong>di</strong>tivo.<br />
La capacità osservativa va quin<strong>di</strong> promossa attraverso tutti i canali<br />
comunicazionali <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponiamo, e <strong>di</strong> questo dovrebbero tener conto<br />
sia le famiglie che la scuola. Anche le attività lu<strong>di</strong>co-sportive si basano<br />
sull'osservazione attenta della situazione esterna attraverso la<br />
propriocezione delle risposte interne. I bambini apprendono per<br />
imitazione i comportamenti co<strong>di</strong>ficati dalle <strong>di</strong>verse culture e<br />
l'imitazione si fonda anch'essa sull'osservazione. Questa attiva inoltre<br />
il pensiero logico prima che la parola possa formularlo. Concetti come<br />
apertura/chiusura, dentro/fuori, sopra/sotto, stasi/moto ecc. sono<br />
spazialmente rappresentabili me<strong>di</strong>ante semplici giochi con le mani. Ho<br />
sperimentato più volte questo genere <strong>di</strong> giochi con bambini <strong>di</strong> due o<br />
tre mesi e ho a mia volta osservato il loro sguardo che seguiva con<br />
evidente intensità e qualche volta precedeva le traiettorie delle parti<br />
in movimento. Anche usando i suoni è facile mantenere a lungo<br />
l'attenzione dei bambini. Ciò è possibile con:<br />
- il battito delle mani<br />
- lo schiocco delle <strong>di</strong>ta<br />
- lo schiocco delle<br />
labbra<br />
- oggetti vari battuti tra<br />
loro<br />
- l’uso dei suoni<br />
Mantenendo<br />
, variando o<br />
trasformand<br />
o<br />
il tipo <strong>di</strong> suono,<br />
la sua durata,<br />
la <strong>di</strong>namica (forte,
alfabetici piano),<br />
- l’uso anomalo della<br />
voce<br />
- soffi, scoppiettii<br />
ecc.<br />
la <strong>di</strong>rezionalità<br />
Durante questi giochi non è raro che i bambini ridano o che mostrino<br />
sorpresa quando presumibilmente una loro aspettativa viene<br />
<strong>di</strong>sattesa. Queste ed altre reazioni lasciano supporre un'intensa<br />
attività cerebrale oltreché emotiva tanto che non è improprio parlare,<br />
anziché <strong>di</strong> giochi, <strong>di</strong> un vero esercizio lavorativo, per giunta<br />
gratificante come non sempre saranno gli esercizi proposti dalla<br />
scuola. Anche in seguito l'osservazione, specie se libera, non imposta<br />
cioè né pilotata dagli adulti, provoca piacere.<br />
Enrico si interessa <strong>di</strong> insetti.<br />
A scuola va abbastanza bene. Non gli fa fatica stu<strong>di</strong>are.<br />
Ma quando lo portano in campagna è capace <strong>di</strong> correre tutto il giorno<br />
<strong>di</strong>etro ai suoi insetti. E la si era porta a casa pesanti barattoli pieni <strong>di</strong><br />
terra o <strong>di</strong> acqua. E ci stu<strong>di</strong>a su delle ore.<br />
La mamma è preoccupata che si affatichi troppo.<br />
"Ma <strong>di</strong> che ti preoccupi, mamma, - le <strong>di</strong>ce Enrico - in campagna ci<br />
vado per <strong>di</strong>vertirmi. Mica è come a scuola..."<br />
Non è una storiella inventata, è un'effettiva testimonianza.<br />
Certo l'osservazione, forse spontanea all'inizio, si affievolisce con<br />
l'età. Le persone anziane, in linea generale, osservano assai meno del<br />
giovane ma soprattutto vedono sempre meno ciò che osservano. Per
loro il mondo inesorabilmente si impoverisce. Per alcuni questo<br />
impoverimento comincia molto prima della norma. Mantenere la<br />
capacità <strong>di</strong> osservare non allunga forse la vita, ma previene<br />
l'invecchiamento precoce. Mantenere questa capacità non è sempre<br />
facile: è necessario che la sostenga l'interesse, e la scuola, specie se<br />
orientata a sod<strong>di</strong>sfare le esigenze del mercato del lavoro, fa troppo<br />
poco in questa <strong>di</strong>rezione.<br />
4.2. Modalità analitica<br />
Ho già detto che la <strong>di</strong>stinzione tra modalità osservativa e modalità<br />
analitica è più che altro <strong>di</strong> comodo in quanto già l'osservazione<br />
possiamo considerarla una prima forma <strong>di</strong> analisi, anche se<br />
scarsamente riflessa. Nell'accezione comune osservare vuol <strong>di</strong>re<br />
raggiungere l'oggettività delle cose attraverso l'attività sensoriale;<br />
sappiamo però che percepiamo soltanto ciò per cui siamo pre<strong>di</strong>sposti,<br />
geneticamente o culturalmente. Ma che vuol <strong>di</strong>re analizzare?<br />
Molti anni fa ho posto questa domanda in un corso <strong>di</strong> aggiornamento<br />
per insegnanti elementari a Milano. Il corso riguardava la pratica<br />
musicale <strong>di</strong> base, cosicché le risposte facevano tutte in qualche modo<br />
riferimento alla musica: analizzare vuol <strong>di</strong>re<br />
- capire la forma del pezzo<br />
- capire l'intenzione dell'autore<br />
- collocare il pezzo nel suo contesto culturale<br />
e così via.
Solo un insegnante sembrò porsi il problema nella sua generalità.<br />
Rispose infatti, articolando le parole con fatica, quasi trovandole sul<br />
momento:<br />
Analizzare... vuol <strong>di</strong>re... <strong>di</strong>stinguere delle parti... e metterle in<br />
relazione tra <strong>di</strong> loro.<br />
Da allora mi sono sempre servito <strong>di</strong> questa definizione per una prima<br />
ricognizione sul significato <strong>di</strong> analizzare. In molti casi la definizione è<br />
stata considerata esauriente e solo una più attenta riflessione ne ha<br />
mostrato la <strong>di</strong>pendenza da certi presupposti. Infatti: come facciamo a<br />
<strong>di</strong>stinguere se non analizzando ciò che stiamo osservando, e che vuol<br />
<strong>di</strong>re mettere in relazione se non sappiamo a che tipo <strong>di</strong> relazione<br />
vogliamo riferirci?<br />
Per un primo passo, tuttavia, questa definizione viene comunemente<br />
accettata. Un secondo passo è possibile compierlo pur restando<br />
momentaneamente all'interno <strong>di</strong> un'esperienza musicale <strong>di</strong> base.<br />
Ripren<strong>di</strong>amo per un momento la sequenza 1. <strong>di</strong> pag.135 in una delle<br />
segmentazioni proposte, per esempio:<br />
1.c<br />
La segmentazione si è evidentemente basata sul criterio numerico:<br />
segmenti <strong>di</strong> tre note. Altre segmentazioni, come abbiamo visto, si<br />
sono riferite ad altri criteri, tutti in qualche modo precostituiti. Alcuni<br />
dei partecipanti hanno peraltro <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> non essersi serviti <strong>di</strong><br />
alcun criterio e <strong>di</strong> aver segmentato la sequenza a caso. Per analizzare<br />
queste segmentazioni casuali abbiamo cominciato con l'applicare i<br />
criteri analitici conosciuti. Poiché nessuno <strong>di</strong> essi dava ragione della<br />
segmentazione si è parlato <strong>di</strong> impreve<strong>di</strong>bilità e la si è assunta come
criterio analitico. È un trucco <strong>di</strong> cui l'uomo si serve abitualmente:<br />
quando un concetto <strong>di</strong> cui abbiamo bisogno non si lascia ridurre ad<br />
altri concetti già noti, ne facciamo un concetto primo, irriducibile, così<br />
come in matematica abbiamo inventato i numeri irrazionali,<br />
immaginari, i concetti <strong>di</strong> infinito, infinitesimo e forse anche lo zero.<br />
La stessa "<strong>di</strong>stinzione delle parti", ovviamente variabile da<br />
osservatore a osservatore, molto spesso è apparsa arbitraria e<br />
<strong>di</strong>fficilmente motivabile, cosicché ci si è affidati piuttosto alla<br />
convergenza, totale o parziale, delle analisi come criterio primo.<br />
Questa, che all'inizio è sembrata un punto <strong>di</strong> debolezza dell'attività<br />
analitica, tanto che la si è sorretta costringendola entro limiti<br />
progettuali prefissati, in seguito si è <strong>di</strong>mostrata il suo punto <strong>di</strong> forza<br />
come motore <strong>di</strong> pensiero in continua espansione. Il parallelo con la<br />
democrazia nel confronto con una sud<strong>di</strong>tanza coatta può dare un'idea<br />
dello spessore formativo <strong>di</strong> questo genere <strong>di</strong> esperienze.<br />
Va anche ricordato - perché lo abbiamo detto infinite volte - che la<br />
modalità analitica è strettamente correlata a quella produttiva,<br />
costruttiva, sulla quale torneremo più in là (4.8.).<br />
Ancora qualche parola su due sottomodalità analitiche e la loro<br />
funzione formativa.<br />
Abbiamo a suo tempo <strong>di</strong>stinto, sulla base <strong>di</strong> IMC, due sottomodalità <strong>di</strong><br />
analisi:<br />
- analisi culturale<br />
- analisi metaculturale.<br />
Con l'analisi culturale confrontiamo gli oggetti o le loro parti con i<br />
sistemi concettuali propri <strong>di</strong> un determinato UCL.
Con l'analisi metaculturale non facciamo altro che riconoscere questo<br />
collegamento rendendoci <strong>di</strong>sponibili, se le circostanze lo richiedono,<br />
ad altri collegamenti.<br />
Non esiste, secondo noi, un'analisi specificamente metaculturale, che<br />
si porrebbe al <strong>di</strong> sopra o anche solo al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> ogni UCL. La non<br />
specificità dell'analisi metaculturale consiste nella sua riflessività, il cui<br />
fine è la relativizzazione <strong>di</strong> ogni analisi culturale all'UCL che la<br />
prodotta. In altre parole, ogni analisi non può che essere culturale;<br />
con la <strong>di</strong>stinzione qui richiamata non vogliamo altro che inserire una<br />
modalità riflessiva quale correttore relativistico nei processi analitico-<br />
conoscitivi. Possiamo infatti considerare l'analisi una forma <strong>di</strong><br />
conoscenza.<br />
Una forma razionale, si <strong>di</strong>rà... Non necessariamente.<br />
Un gatto che annusa una salsiccia ne fa un'analisi olfattiva, o<br />
ad<strong>di</strong>rittura un'analisi chimica tramite l'olfatto. Difficilmente <strong>di</strong>remmo<br />
però che la sua analisi è razionale, anche se operata, per lui come per<br />
noi, dal cervello. Nell'accezione comune del termine l'analisi può<br />
essere avviata dall'apparato sensoriale, si compie però nella ragione,<br />
cioè in quella particolare facoltà del cervello che riteniamo peculiare<br />
della specie umana. Non sappiamo però con esattezza se anche il<br />
gatto non possegga qualcosa <strong>di</strong> analogo a questa facoltà. Ciò che un<br />
gatto sicuramente non fa è riferire la sua analisi a un particolare UCL,<br />
relativizzarla cioè metaculturalmente. E noi uomini, che saremmo<br />
attrezzati per farlo, lo facciamo? La scuola ce lo insegna?<br />
A scuola si insegnano perlopiù sistemi analitici già collaudati (e spesso<br />
anche storicamente superati). D'altronde che senso avrebbe
ipercorrere cammini analitici perfettamente noti? Meglio acquisire<br />
<strong>di</strong>rettamente i risultati...<br />
Difficile controbiettare a tali argomenti. Tre punti vorrei comunque<br />
segnalare:<br />
- la per<strong>di</strong>ta (per eccesso <strong>di</strong> conoscenza) <strong>di</strong> un'esperienza analitica <strong>di</strong><br />
prima mano (quando cioè tocca progettare anche gli strumenti -<br />
materiali, mentali - con cui analizzare)<br />
- la frequente assolutizzazione degli strumenti dei risultati analitici<br />
conseguiti, nonché dell'autorità che li ha conseguiti (caso<br />
esemplare per tutto il Me<strong>di</strong>oevo: Aristotele)<br />
- la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> innestare sull'analisi culturale quella metaculturale, <strong>di</strong><br />
cui avvertiamo, oggi come non mai l'urgenza metodologica.<br />
Questi tre punti sono tra loro connessi, non però in maniera lineare,<br />
così che da uno derivino in successione gli altri due. Anche l'analisi<br />
metaculturale, come abbiamo visto, non è scissa e neppure<br />
nettamente <strong>di</strong>stinguibile dalle analisi culturali. La sua autoriflessività<br />
andrebbe esercitata fin dalla prima età scolare. Se la scuola non lo fa<br />
è perché non ha ancora sviluppato una <strong>di</strong>dattica dell'analisi,<br />
soprattutto nella sua veste metaculturale. Un avvio in tal senso è<br />
dato, nella metodologia sviluppata dal CMC, dalla cosiddetta analisi <strong>di</strong><br />
primo contatto.<br />
Questa riduce al minimo gli strumenti culturali <strong>di</strong> cui si serve:<br />
essenzialmente criteri logico-analitici <strong>di</strong> base, la cui <strong>di</strong>ffusione è<br />
talmente ampia da farli considerare universali, preculturali. Ne<br />
nomino alcuni: più <strong>di</strong>, meno <strong>di</strong>, uguale a, <strong>di</strong>verso da, unito, separato<br />
ecc. Non è questo il luogo per entrare nello specifico; <strong>di</strong> tali criteri si
occupa la Gestalt-psychologie e ad essa conviene fare riferimento.<br />
Non va comunque confusa l'analisi <strong>di</strong> primo contatto con l'analisi<br />
ingenua <strong>di</strong> chi crede <strong>di</strong> raggiungere per questa via una conoscenza<br />
oggettiva delle cose. Quando per esempio constatiamo l'uguaglianza<br />
<strong>di</strong> due oggetti non inten<strong>di</strong>amo certo sostenere che gli atomi <strong>di</strong> cui<br />
sono composti sono gli stessi, quanto piuttosto affermare la loro<br />
in<strong>di</strong>stinguibilità in certe con<strong>di</strong>zioni. Per passare dall'analisi ingenua a<br />
quella <strong>di</strong> primo contatto è sufficiente che ci ren<strong>di</strong>amo conto,<br />
metaculturalmente, dei criteri elementari ma pur sempre culturali, che<br />
abbiamo utilizzato. La già citata storiella <strong>di</strong> Carletto (3.2.1.) dovrebbe<br />
chiarire quanto è ambiguo perfino un criterio, in apparenza così<br />
solido, come quello <strong>di</strong> identità.<br />
Si è soliti <strong>di</strong>stinguere tra analisi e progettazione. L'una riguarda cose<br />
che già esistono e da cui vorremmo ricavare delle informazioni per<br />
comprenderle, l'altra cose che non esistono ancora, ma che vorremmo<br />
portare a esistere. Le ragioni <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>stinzione sono evidenti e non<br />
c'è bisogno <strong>di</strong> sottolinearle. Più interessante tentare l'unificazione dei<br />
due concetti nel nome del primo <strong>di</strong> essi: subor<strong>di</strong>nare cioè la<br />
progettazione a una particolare forma <strong>di</strong> analisi. Questo è possibile se<br />
adottiamo le seguenti definizioni:<br />
analisi=rilevazioni sull'esistente<br />
progettazione=rilevazioni sul possibile<br />
Il termine comune rilevazioni unifica laddove i due termini esistente e<br />
possibile <strong>di</strong>vidono. Ma le rilevazioni sono il frutto <strong>di</strong> un'analisi, da cui:<br />
analisi (in senso stretto)=analisi dell'esistente<br />
progettazione=analisi del possibile
Supponiamo uno sta<strong>di</strong>o progettuale X. Per passare allo sta<strong>di</strong>o X+1,<br />
debbo anzitutto analizzare le possibili alternative, gli X+1 virtuali tra<br />
cui scegliere, in base ai criteri progettuali adottati, quello che più mi<br />
conviene<br />
Per altre considerazioni sulla modalità analitica si consulti il "Nodo<br />
formativo" analizzare sul nostro sito www.<strong>di</strong>datticaperprogetti.it.<br />
Eccone il grafico riassuntivo:
L'analisi metaculturale non mo<strong>di</strong>fica gli altri mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> analisi, esplicita<br />
solo gli strumenti utilizzati e li relativizza, rapportandoli alla cultura<br />
che li ha prodotti.
4.3. Modalità sintetica<br />
Il grafico che chiude il paragrafo precedente <strong>di</strong>ciamo che ne sintetizza<br />
il contenuto, così come una lettura analitica <strong>di</strong> esso ce lo restituisce in<br />
forma <strong>di</strong>scorsiva. In certo qual modo la sintesi è il reciproco<br />
dell'analisi, anzi ambedue concorrono all'attività conoscitiva (che,<br />
appunto, è attività, non ricezione passiva). Queste, come in genere<br />
tutte le cose che si leggono in questo libro, sono delle ovvietà,<br />
accessibile a chiunque si soffermi a riflettere su sé stesso e sulle<br />
proprie modalità <strong>di</strong> pensiero. Lo stile metaculturale non produce<br />
novità, non è né scienza né ricerca, ma ripensa relativisticamente<br />
l'ovvio, indagando sui presupposti che lo rendono, appunto, ovvio.<br />
Chiunque può percorrere, anzi forse lo ha già fatto, itinerari simili a<br />
quelli che vedrà qui esposti, e non c'è bisogno che abbia compiuto<br />
stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> psicologia o antropologia. Ci sono delle <strong>di</strong>scipline che, almeno<br />
nei loro fondamenti, sono <strong>di</strong> pubblico dominio, o meglio lo sarebbero<br />
se non fossero offuscate, proprio in quel fondamenti da insegnamenti<br />
più o meno ideologizzatati.<br />
Come facciamo a <strong>di</strong>stinguere un sasso da un gatto?<br />
In genere non ci serve a metterli uno accanto all'altro per confrontarli<br />
punto per punto. Il nostro cervello ha già sintetizzato due <strong>di</strong>verse<br />
immagini mentali e ci basta confrontare queste ultime, con notevole<br />
risparmio <strong>di</strong> energia. Ma per sintetizzarle il cervello ha dovuto<br />
analizzare serie <strong>di</strong> dati sensoriali da assegnare all'una o all'altra<br />
immagine. A quale gatto assomiglia la mia immagine <strong>di</strong> gatto? Al mio,
a quello del vicino, a un gatto nero o tigrato? A un soriano o un<br />
angora? A quale sasso assomiglia la mia immagine <strong>di</strong> sasso?<br />
Probabilmente a nessuno in particolare. Si <strong>di</strong>ce che abbiamo il<br />
concetto <strong>di</strong> sasso, <strong>di</strong> gatto. Alla formazione del concetto hanno<br />
concorso, a parità <strong>di</strong> merito, sia la modalità analitica sia quella<br />
sintetica del nostro pensiero. E anche nel momento applicativo,<br />
quando cioè si tratta <strong>di</strong> riconoscere un certo oggetto come gatto o<br />
come sasso, non faccio che analizzare ancora, senza neppure<br />
rendermene conto, un insieme <strong>di</strong> input sensoriali per poi confrontarli<br />
con l'uno o con l'altro concetto.<br />
Questo o qualcosa del genere accade infinite volte nel corso <strong>di</strong> una<br />
giornata e non servirebbe a nulla a riflettere, come qui abbiamo fatto,<br />
sopra ogni singolo caso. Non so se il meccanismo del <strong>di</strong>stinguere e<br />
riconoscere sia innato o acquisito; se voglio, posso osservarlo<br />
funzionare, e il più delle volte questo è sufficiente. Ma an<strong>di</strong>amo<br />
avanti.<br />
La modalità sintetica si esprime al massimo grado nella costruzione<br />
delle teorie scientifiche. Formula come la newtoniana<br />
o la einsteiniana<br />
F=ma (Forza=massa x accelerazione)<br />
E=mc 2 (Energia=massa x quadrato della velocità della luce)<br />
sintetizzano con pochi simboli relazioni fisiche ipoteticamente<br />
universali, valide cioè in ogni tempo e in ogni luogo per qualsiasi<br />
corpo. E, se ci manteniamo all'interno delle rispettive teorie (come è<br />
sperimentalmente provato) possiamo anche togliere quel cautelativo<br />
"ipoteticamente".
Forse la stessa matematica ha un fondamento sintetico del concetto <strong>di</strong><br />
numero. Quando <strong>di</strong>ciamo: ho comprato 7 mele, ho applicato un<br />
numero a un altro concetto - quello <strong>di</strong> mela - senza tener conto della<br />
<strong>di</strong>versità in<strong>di</strong>viduale della mela. In altre parole il numero 7 ha senso<br />
solo se:<br />
- ho sintetizzato il concetto <strong>di</strong> mela<br />
- ho sintetizzato in un solo termine numerico il risultato <strong>di</strong> una serie<br />
<strong>di</strong> operazioni +1 a partire da 0.<br />
Anche in questo caso l'invenzione del sistema dei numeri naturali<br />
(come poi <strong>di</strong> altri sistemi numerici) ha portato, in forza delle sue<br />
capacità sintetiche, a enormi semplificazioni pratiche e teoriche.<br />
Non sappiamo, come già per il pensiero analitico, se e fino a che<br />
punto gli animali posseggano quello sintetico, se cioè siano in grado <strong>di</strong><br />
sintetizzare, in un qualcosa come un concetto, un insieme <strong>di</strong><br />
esperienze ripetute. L'analogia o la ripetitività <strong>di</strong> una reazione al<br />
medesimo stimolo non implicano necessariamente la<br />
concettualizzazione. Potrebbe trattarsi <strong>di</strong> un riflesso con<strong>di</strong>zionato, che<br />
però neppure la esclude. La nostra scarsa conoscenza dei processi<br />
cerebrali nell'uomo come nelle altre specie animali non ci permette<br />
<strong>di</strong>stinzioni certe. Se ve<strong>di</strong>amo il nostro gatto annusare e riannusare lo<br />
stesso cibo che riceve ogni giorno ci viene da concludere che la<br />
modalità analitica prevalga in lui su quella sintetica. Quando però, in<br />
presenza <strong>di</strong> altri gatti lo ve<strong>di</strong>amo avventarsi sulla sua ciotola senza<br />
perdere tempo ad annusarla, supponiamo che abbia elaborato un<br />
concetto o almeno un'immagine mentale del presumibile contenuto<br />
della ciotola. Stiamo parlando <strong>di</strong> un mammifero, come lo siamo noi,
ed è plausibile una certa affinità con il comportamento nostro. Ma nel<br />
caso della già citata vespa predatrice, zoologicamente molto lontana<br />
da noi, non c'è nessuna ragione perché da comportamenti<br />
apparentemente simili si inferiscano meccanismi anch'essi simili. È<br />
quin<strong>di</strong> assai improbabile che gli insetti siano capaci <strong>di</strong><br />
concettualizzazione. D'altronde è assai probabile che gli altri strumenti<br />
mentali <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>spongono (e su cui siamo tuttora poco informati)<br />
siano più adatti ed efficienti per le loro esigenze <strong>di</strong> quanto lo sarebbe<br />
il laborioso e <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>oso strumento concettuale.<br />
Con il quale, nella sua singolare mescolanza <strong>di</strong> analisi e sintesi, noi<br />
uomini ci troviamo benissimo. Sempreché ci abbiano abituati a usarlo<br />
correttamente. Ma qual è il suo uso corretto e come facciamo a<br />
<strong>di</strong>stinguerlo da un uso scorretto?<br />
Nelle scuole si usa ancor oggi il riassunto, definito perlopiù la sintesi<br />
<strong>di</strong> un testo più lungo in un altro più corto che ne conservi l'essenziale.<br />
Altre volte si tratta <strong>di</strong> riassumere un'esperienza conservandone<br />
soltanto i tratti essenziali. Quali sono questi tratti?<br />
Un riassunto particolarmente sintetico dei Promessi sposi potrebbe<br />
essere il seguente:<br />
Matrimonio conta<strong>di</strong>no, ostacolato da nobiltà prepotente, con l'aiuto <strong>di</strong><br />
Dio e della peste giunge finalmente a compimento.<br />
Lo <strong>di</strong>remmo un buon riassunto? Eppure l'essenziale è mantenuto.<br />
Quale essenziale?<br />
A scuola il riassunto è uno degli spauracchi per gli studenti. "E se non<br />
riesco a indovinare l'essenziale?"
Il pregiu<strong>di</strong>zio, che dalla scuola passa allo studente, sta nel ritenere<br />
che in un testo o in una situazione vi siano delle cose importanti, altre<br />
meno, altre ad<strong>di</strong>rittura per niente. Il che, per un testo letterario per<br />
esempio, suona come un'assur<strong>di</strong>tà. In ogni caso una graduatoria <strong>di</strong><br />
importanza tra gli argomenti <strong>di</strong> un testo o i particolari <strong>di</strong><br />
un'esperienza va riferita al progetto per cui si riassume.<br />
Ai fini <strong>di</strong> un'indagine della polizia il riassunto del testo <strong>di</strong> una lettera<br />
fatto da un investigatore avrà un aspetto completamente <strong>di</strong>verso da<br />
riassunto della medesima lettera fatto dal ricevente ignaro a un<br />
amico.<br />
Un riassunto presuppone un'analisi del testo o dell'esperienza da<br />
riassumere e questa un progetto analitico a sua volta legato a<br />
particolari finalità.<br />
- voglio informare sui luoghi nominati o visitati<br />
- voglio riferire su alcune particolarità incontrate nella lettura o<br />
nell'esperienza <strong>di</strong>retta<br />
- voglio riportare impressioni da me ricevute<br />
- voglio ricavare da queste delle considerazioni sul futuro<br />
- voglio ricavarne delle considerazioni estetiche<br />
- voglio semplicemente ricostruire per sommi capi i fatti narrati<br />
vissuti.<br />
È quest'ultimo progetto ciò che normalmente si intende a scuola<br />
quando si parla <strong>di</strong> "riassunto". Sarebbe bene comunque che anche<br />
nella pratica scolastica<br />
- o ciascuno riassumesse <strong>di</strong>chiarando il proprio progetto e le relative<br />
finalità
- o fosse concordato un progetto comune, definendone<br />
caratteristiche e finalità (eventualmente anche la lunghezza del<br />
testo).<br />
In ambedue i casi un successivo lavoro <strong>di</strong> confronto metterà in rilievo<br />
o la varietà dei progetti o, se il progetto è unico, la varietà delle sue<br />
interpretazioni. L'aspetto qualitativo <strong>di</strong> queste sarà da considerare,<br />
più che da un punto <strong>di</strong> vista estetico o stilistico, dalla funzionalità<br />
rispetto al progetto <strong>di</strong>chiarato.<br />
4.4. Modalità convergente<br />
"Non si ricordava quando aveva visto la prima volta un violino.<br />
Sapeva solo che gliene avevano regalato uno, un violinetto piccolo,<br />
quasi un giocattolo, quando aveva tre anni.<br />
E che da allora non se ne era separata mai, fin quando non lo cambiò<br />
con un violino vero, anche se <strong>di</strong> fabbrica. Solo molti anni dopo,<br />
quando già si parlava <strong>di</strong> lei come <strong>di</strong> un caso, una generosa donazione<br />
permise alla famiglia <strong>di</strong> comprargliene uno <strong>di</strong> scuola cremonese. Agli<br />
inizi non si pensava <strong>di</strong> fare <strong>di</strong> lei una violinista. Ma ci pensò da sé. Non<br />
aveva ancora preso lezioni <strong>di</strong> musica che già sapeva riprodurre sullo<br />
strumento le melo<strong>di</strong>e più in voga del momento. Ebbe la fortuna che si<br />
interessò <strong>di</strong> lei un eccellente maestro <strong>di</strong> violino che in pochi anni la<br />
condusse a un <strong>di</strong>ploma con il massimo dei voti e la lode. Frattanto<br />
aveva frequentato la scuola, ma senza troppo impegno, al punto che<br />
la abbandonò anzitempo per de<strong>di</strong>care tutto il suo tempo all'amato
violino. A <strong>di</strong>ciotto anni era già una concertista <strong>di</strong> fama internazionale,<br />
applau<strong>di</strong>ta in tutta Europa e in procinto <strong>di</strong> conquistare le platee <strong>di</strong><br />
tutto il mondo. Nonostante le sue straor<strong>di</strong>narie qualità naturali, si<br />
costringeva a un lavoro quoti<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> molte ore, de<strong>di</strong>cate però non<br />
solo allo stu<strong>di</strong>o dello strumento, ma anche e soprattutto alla<br />
conoscenza della musica in tutti i suoi aspetti, tecnici, stilistici, storici.<br />
I suoi interessi sembravano convergere su quest'unico punto, la<br />
musica, dentro la quale un poco alla volta iniziò l'esplorazione<br />
dell'universo umano.<br />
Tutto ciò che la scuola non le aveva dato o che lei non aveva saputo<br />
cogliere lo ritrovò, potenziato oltre ogni limite, nella musica. E capì<br />
che la musica non le era stata data per sé stessa ma per capire la<br />
vita. E così, al culmine della carriera ripose il violino, aprì una scuola<br />
in una delle regioni più povere dell'Africa, dove visse ancora per alcuni<br />
decenni, de<strong>di</strong>ta, come un tempo al violino, ora alla formazione delle<br />
coscienze."<br />
È una biografia inventata, ma non improbabile, come <strong>di</strong>mostra la<br />
biografia <strong>di</strong> un Albert Schweitzer profondo stu<strong>di</strong>oso <strong>di</strong> Bach e, da<br />
ultimo, me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> malattie infettive nell'ospedale <strong>di</strong> Lambarene. E che<br />
cosa ha a che fare questa più o meno verosimile biografia con la<br />
modalità convergente <strong>di</strong> cui dovrebbe occuparsi presente paragrafo?<br />
Come abbiamo visto per le modalità analitica e sintetica, la cui<br />
oppositività è risultata più apparente che reale, così anche qui la<br />
modalità convergente non si oppone necessariamente a quella<br />
<strong>di</strong>vergente - <strong>di</strong> cui sarà questione nel prossimo paragrafo - ma può
ad<strong>di</strong>rittura aprirsi ad essa solo intensificando sé stessa. La nostra<br />
violinista arriva alla vita - per giunta in una delle sue forme estreme -<br />
attraverso la musica. Forse ogni attività umana, se convergono su <strong>di</strong><br />
essa tutte le potenzialità operative e conoscitive a nostra <strong>di</strong>sposizione,<br />
può portare a questa esplosione fuori dai suoi limiti. Le varie<br />
specificità che segmentano il mondo del lavoro umano poggiano su<br />
strati <strong>di</strong> crescente generalità, e man mano che facciamo convergere<br />
su una <strong>di</strong> queste i nostri interessi vitali, aumentano le probabilità che<br />
l'esperienza specifica deflagri in qualcosa <strong>di</strong> assai più ampio e<br />
comprensivo. Giacché questo qualcosa non sopraggiunge dall'esterno<br />
ma è contenuto in nuce in qualsiasi punto del nostro UCL. L'analogia<br />
con la monade leibnitziana, che rispecchia in sé tutto l'universo, è<br />
evidente; come anche analogia con il DNA, portatore potenziale dei<br />
caratteri ere<strong>di</strong>tari <strong>di</strong> intere generazioni, o come lo spazio informatico<br />
che ci circonda, in ogni punto del quale possiamo immaginare<br />
concentrata informazione <strong>di</strong> tutto l'universo.<br />
Dico questo per mostrare un possibile collegamento tra convergenza e<br />
<strong>di</strong>vergenza del pensiero e, ancora oltre, tra opposizioni <strong>di</strong> qualsiasi<br />
tipo, che tali sono soltanto fino a un certo livello della catabasi<br />
metaculturale 2 .<br />
Ciò non esclude ovviamente che <strong>di</strong>versità e opposizione facciano parte<br />
della nostra quoti<strong>di</strong>anità, anzi ne costituiscano l'aspetto più vitale,<br />
capace <strong>di</strong> riversarsi anche su ogni tentativo <strong>di</strong> unificazione degli<br />
opposti: più la <strong>di</strong>vergenza è grande, più è significativa la<br />
2 Per catabasi metaculturale inten<strong>di</strong>amo una <strong>di</strong>scesa autoriflessiva verso livelli <strong>di</strong> maggior generalità rispetto a quello cui si<br />
situa l’esperienza in corso (v. 6.2.4.)
convergenza, quando si riesca ad attuarla. (Da notare che per<br />
convergenza si intende qui un'operazione successiva alla <strong>di</strong>vergenza,<br />
laddove nell'accezione <strong>di</strong> poc'anzi veniva intesa come precedente.)<br />
Sia come sia lo stile convergente produce spesso risultati <strong>di</strong> massimo<br />
rilievo in ogni settore. Gli ingre<strong>di</strong>enti <strong>di</strong> fondo, anche matematici, della<br />
relatività ristretta erano già noti prima che Einstein ne annunciasse la<br />
teoria. Per arrivare a questa, come più tar<strong>di</strong> alla teoria della relatività<br />
generale o alla Quanten theoria è stata probabilmente necessaria una<br />
enorme intensificazione della convergenza sulla specificità dei<br />
problemi fisici, specificità da cui è esplosa poi la <strong>di</strong>vergenza verso<br />
nuovi enunciati universali.<br />
Si pensi per esempio anche all'estrema concentrazione espressiva <strong>di</strong><br />
certi Lieder <strong>di</strong> Schubert o degli ultimi Quartetti <strong>di</strong> Beethoven, o del<br />
mahleriano Canto della terra; o ancora all'abbraccio della Pietà<br />
Rondanini, alle penombre <strong>di</strong> Rembrandt, all'incanto luminoso <strong>di</strong><br />
Vermeer e così via, opere tutte in cui la convergenza delle componenti<br />
tecniche ed espressive su quell'unico risultato costringe anche il<br />
fruitore a far convergere le sue capacità ricettive e <strong>di</strong><br />
immedesimazione fino a trapassare l'opera nel <strong>di</strong>ssolvimento della sua<br />
singolarità.<br />
È possibile un'educazione al pensiero convergente? Con quali finalità?<br />
Ve<strong>di</strong>amo per prime queste ultime. Anzi tutto il pensiero convergente<br />
implica attenzione. E l'attenzione a ciò che si fa porta a risparmio <strong>di</strong><br />
tempo e a maggiore sicurezza. Sappiamo tutti i pericoli cui va<br />
incontro un guidatore <strong>di</strong>sattento.
Ma perché vi sia attenzione anche quando ne va della nostra vita<br />
occorre un'adeguata motivazione. È questo uno dei gran<strong>di</strong> problemi<br />
della scuola cui nessun programma ministeriale, anche il più aperto,<br />
potrà dare soluzione, almeno finché continuerà a puntare sui<br />
contenuti più che non sull'attività pensante. I contenuti potranno<br />
interessare l'uno o l'altro degli alunni, raramente l'intera classe, e i<br />
<strong>di</strong>sinteressati restano esclusi. Il pensiero, in quanto strumento a<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutti, come braccia e gambe, tutti sentono il bisogno <strong>di</strong><br />
svilupparlo al massimo dell'efficienza. Con il pensiero qualsiasi<br />
contenuto potrà essere affrontato se e quando ne nascerà l'interesse.<br />
Ma una scuola del pensiero è ancora <strong>di</strong> là da venire. Per ora sarebbe<br />
già molto se la scuola si preoccupasse, più assai <strong>di</strong> quanto non faccia,<br />
della motivazione allo stu<strong>di</strong>o. Alla nostra violinista non devono essere<br />
costate una grande fatica le ore trascorse con il suo amato strumento.<br />
La convergenza <strong>di</strong> tutte le sue forze su quell'unico interesse era per<br />
lei la normalità. Ma si trattava <strong>di</strong> un caso eccezionale: una sorta <strong>di</strong> a<br />
priori motivazionale che non avrebbe senza pretendere da chiunque.<br />
Ciò non toglie che una maggiore attenzione per la motivazione<br />
potrebbe favorire almeno delle convergenze momentanee, da cui<br />
potrebbero svilupparsi interessi anche <strong>di</strong>vergenti. Non poche<br />
esperienze condotte dal CMC parlano in questo senso. Era ed è<br />
impressionante la concentrazione con cui gruppi <strong>di</strong> bambini, intere<br />
classi sanno impegnarsi nella composizione musicale o visiva per il<br />
solo fatto <strong>di</strong> doverla pensare e poi <strong>di</strong>scutere minuziosamente tra tutti.<br />
Si parla oggi molto <strong>di</strong> produttività, misurandola solo in termini <strong>di</strong> cose<br />
prodotte e trascurando l'atto del produrre. La più forte delle
motivazioni la troviamo però in quell'atto e non nelle sue<br />
conseguenze.<br />
Il momento del fare e, forse più ancora, della progettazione mentale<br />
richiede da noi la convergenza <strong>di</strong> tutte le nostre competenze e<br />
capacità: un'azione calcistica in preparazione <strong>di</strong> un gol impegna i<br />
calciatori fino ai limiti delle loro forze, in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto<br />
che il gol venga poi realizzato o no. Un pittore convergere con tutto sé<br />
stesso su una tela che forse neppure <strong>di</strong>pingerà, o un poeta su una<br />
poesia che non scriverà. La vera motivazione non riguarda ciò che<br />
avremo o non avremo fatto, ma l'intera fase precedente, del fare e<br />
del pensare. Su questa la scuola potrebbe cominciare a riflettere.<br />
4.5. Modalità <strong>di</strong>vergente<br />
Ai possibili collegamenti tra modalità convergente e modalità<br />
<strong>di</strong>vergente o meglio al possibile esito <strong>di</strong>vergente <strong>di</strong> una modalità<br />
convergente ho già accennato nel paragrafo precedente.<br />
Resta da considerare metaculturalmente la <strong>di</strong>vergenza in sé. Se non è<br />
modulata dal suo contrario, la pura <strong>di</strong>vergenza, cioè l'incapacità <strong>di</strong><br />
fermare il pensiero su un unico oggetto o un unico punto <strong>di</strong> vista,<br />
viene giu<strong>di</strong>cata patologica (schizofrenia) a meno che non<br />
intervengano, spesso tar<strong>di</strong>vamente, considerazioni estetiche che ne<br />
fanno la manifestazione <strong>di</strong> un pensiero geniale. Non mi soffermerò,<br />
per incompetenza, su questo genere <strong>di</strong> valutazioni anche perché<br />
forme meno ra<strong>di</strong>cali <strong>di</strong> <strong>di</strong>vergenza appartengono anche al pensiero
comune e le ritroviamo in una qualsiasi classe elementare. Nello<br />
svolgimento <strong>di</strong> un tema dato non manca mai il ragazzo che, a giu<strong>di</strong>zio<br />
dell'insegnante, è andato fuori tema. Ricordo che nella scuola <strong>di</strong> un<br />
tempo (oggi si è più prudenti) questo giu<strong>di</strong>zio era inappellabile,<br />
qualsiasi cosa uno avesse scritto nella parte incriminata. Che il fuori<br />
tema fosse sintomo <strong>di</strong> un'insofferenza per dei limiti imposti o ricerca<br />
<strong>di</strong> collegamenti lontani poco importava, la valutazione restava<br />
negativa: "non sa tenere sotto controllo il proprio pensiero". Questo<br />
quando la cultura europea aveva già conosciuto l'astrattismo, il<br />
surrealismo, Kafka, Strawinsky e Joice: la scuola, si sa, non pecca <strong>di</strong><br />
avanguar<strong>di</strong>smo.<br />
Ma che cosa si intende, almeno in questa sede, per modalità (o, se si<br />
preferisce, stile) <strong>di</strong>vergente?<br />
Non certo un'incapacità <strong>di</strong> controllo del pensiero e neppure una<br />
tendenza da reprimere (semmai da incanalare dentro una<br />
progettualità consapevole), più spesso anzi una capacità da<br />
incentivare. Il pensiero <strong>di</strong>vergente è per esempio in<strong>di</strong>spensabile nel<br />
reperimento delle alternative, punto focale del concetto <strong>di</strong> libertà. Ne<br />
abbiamo trattato in quasi tutte le pubblicazioni del CMC. Ecco in due<br />
parole <strong>di</strong> che si tratta.<br />
In prospettiva, più tecnica che ideologica, libertà è possesso<br />
consapevole <strong>di</strong> più alternative, tra cui scegliere. In una transizione da<br />
uno stato S a uno stato S1 le alternative sono normalmente molteplici,<br />
ma le ideologie e, in generale, la cultura tendono a obliterarle tutte,<br />
salvo quelle che giovano a chi, controllando ideologie e cultura,<br />
detiene <strong>di</strong> fatto il potere. La scelta <strong>di</strong> come raggiungere lo stato S1 e
<strong>di</strong> regola la stessa scelta dello stato S1 è quin<strong>di</strong> obbligata, per quanto<br />
il potere continui a sban<strong>di</strong>erare il concetto ideologizzato <strong>di</strong> libertà. Un<br />
pensiero allenato alla <strong>di</strong>vergenza sa in<strong>di</strong>viduare le alternative<br />
nascoste o ad<strong>di</strong>rittura costruirne <strong>di</strong> nuove <strong>di</strong>mostrandosi un potente<br />
alleato <strong>di</strong> una democrazia non ideologizzata.<br />
In una <strong>di</strong>mensione non politica la modalità <strong>di</strong>vergente produce uno<br />
strumento espressivo <strong>di</strong> grande forza: la metafora. Molte metafore si<br />
sono degradate col tempo a slogan, mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>re, ormai quasi privi<br />
dell'originaria efficacia:<br />
- avere l'occhio <strong>di</strong> lince<br />
- è un vulcano <strong>di</strong> idee<br />
- bada a quella lì: è un'acqua cheta<br />
- fare un bagno <strong>di</strong> folla<br />
- avere la testa nelle nuvole.<br />
Ma <strong>di</strong> metafore se ne inventano tutti i giorni e non solo da poeti e<br />
scrittori, ma anche dall'anonimo passante:<br />
- la mia ragazza è una cicorietta fresca,<br />
per <strong>di</strong>re che è amabile con una punta <strong>di</strong> amaro.<br />
A ben guardare, una buona metafora richiede, come già visto, il<br />
concorso, pressoché contemporaneo, <strong>di</strong> <strong>di</strong>vergenza e convergenza.<br />
Con la prima operiamo una ricognizione tra le immagini can<strong>di</strong>date al<br />
ruolo <strong>di</strong> metafora, con la seconda mettiamo a fuoco questa immagine<br />
e, alternativamente, il concetto da rendere metaforicamente,<br />
analizzandone le corrispondenze, da cui risulterà la cre<strong>di</strong>bilità<br />
dell'accoppiamento. Esempio:
Si tratta <strong>di</strong> rinforzare con una metafora la descrizione <strong>di</strong> un giovane<br />
dal carattere forte e sicuro <strong>di</strong> sé. Una prima ricognizione mi dà:<br />
roccia, vecchia quercia, acciaio, antico romano, Superman, leone ecc.<br />
Scarto roccia e leone perché mi sembrano abusate, antico romano<br />
perché mi suona ri<strong>di</strong>cola, Superman perché fumettistica, acciaio<br />
perché eccessiva.<br />
Scelgo vecchia quercia, ma per riscattarla dalla sua ovvietà la socio al<br />
suo contrario e ne sviluppo l'immagine:<br />
- "... benché fosse ancora quasi un ragazzo, ne ammiravo il carattere<br />
forte e sicuro <strong>di</strong> sé, da vecchia quercia fortemente ra<strong>di</strong>cata alla sua<br />
terra..."<br />
Nella grande aria "Come scoglio" dall'opera Così fan tutte <strong>di</strong> Mozart, il<br />
librettista Lorenzo da Ponte <strong>di</strong>pinge con consumata 3 abilità letteraria<br />
lo stato d'animo <strong>di</strong> Fior<strong>di</strong>ligi sul punto <strong>di</strong> cedere - ma troppo<br />
orgogliosa per ammetterlo - alle lusinghe <strong>di</strong> Ferrando:<br />
Come scoglio 4 immoto resta<br />
contra i venti, e la tempesta<br />
così ognor quest'alma è forte<br />
nella fede, e nell'amor.<br />
Mozart rincara la dose 5 assumendo per quest'aria, nel bel mezzo <strong>di</strong> un<br />
dramma giocoso (ovvero opera buffa) lo stile da opera seria, e lo fa<br />
accentuandone le caratteristiche retoriche fino al limite dove si<br />
stravolgono nell'opposto. Uno stile musicale usato come metafora!<br />
3 “<strong>di</strong>pinge” e “consumata”: due stereotipi metaforici<br />
4 Più che <strong>di</strong> metafora si tratta qui <strong>di</strong> paragone, a causa <strong>di</strong> quel “Come” iniziale, ma il commento resta lo stesso<br />
5 Altra metafora <strong>di</strong> uso comune
Anche il linguaggio visivo si <strong>di</strong>mostra capace <strong>di</strong> metafore. Questo<br />
soprattutto nella figuratività, dove la metafora assume spesso<br />
l'aspetto del simbolo. L'occhio <strong>di</strong> Dio che sovrasta molte pitture<br />
me<strong>di</strong>evali, l'Agnello al centro della grande composizione <strong>di</strong> Van Eych,<br />
il Leone che custo<strong>di</strong>sce il Vangelo <strong>di</strong> San Marco vanno letti<br />
contenutisticamente come simboli. Ma le ombre <strong>di</strong> Rembrandt o le<br />
geometrie solari <strong>di</strong> Piero della Francesca rimandano,<br />
metaforicamente, a opposte concezioni del mondo,<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dai loro contenuti.<br />
Intere opere o cicli <strong>di</strong> opere possono leggersi come metafore: così la<br />
Divina Comme<strong>di</strong>a come metafora <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> salvazione,<br />
analogo al Faust (ma quanto <strong>di</strong>verso nel contenuto!), così l'intera<br />
Tetralogia wagneriana come la condanna (metaforica assai più che<br />
effettiva) del potere, del denaro, della schiavitù.<br />
La modalità <strong>di</strong>vergente è forse la maggiore ricchezza <strong>di</strong> cui<br />
<strong>di</strong>sponiamo.<br />
4.6. Modalità giu<strong>di</strong>cante (valutante)<br />
- La giraffa è un mammifero<br />
- X è un Y<br />
Frasi <strong>di</strong> questo tipo hanno un senso solo se ce l'hanno sia X che Y. In<br />
genere X è dato (per esempio perché sotto i nostri occhi) e Y è ciò che<br />
si pre<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> esso. "È" raccorda l'uno all'altro e al tempo stesso<br />
esprime quella che abbiamo chiamato modalità giu<strong>di</strong>cante. Altri
parlerebbe <strong>di</strong> funzione giu<strong>di</strong>cante, termine forse tecnicamente più<br />
giusto perché privo <strong>di</strong> connotazioni psicologiche, ma con qualche<br />
pretesa <strong>di</strong> scientificità in più. Non sono né un logico né un linguista,<br />
quin<strong>di</strong> non mi addentro in un terreno così battuto fin da quando<br />
l'uomo ha cominciato a pensare umanamente. Non so neppure se tutti<br />
i giu<strong>di</strong>zi sono riconducibili a quella forma elementare o all'altra, meno<br />
apo<strong>di</strong>ttica:<br />
- Se a allora b.<br />
So soltanto che dell'una o dell'altra si fa spesso abuso, collegandole a<br />
una qualche forma <strong>di</strong> potere:<br />
- La terra è al centro dell'universo e chi non la pensa così, al rogo!<br />
Vorrei anche servirvi <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> comodo, giu<strong>di</strong>zio<br />
valutazione, cui de<strong>di</strong>care due sottoparagrafi anch'essi <strong>di</strong>stinti.<br />
4.6.1. Il giu<strong>di</strong>zio in senso stretto<br />
È la forma dura della modalità giu<strong>di</strong>cante, forma che più <strong>di</strong>rettamente<br />
rimanda al potere <strong>di</strong> chi giu<strong>di</strong>ca. Proprio per questo pensiamo<br />
- vada esercitata per quanto possibile metaculturalmente, cioè<br />
esplicitando al meglio il sistema <strong>di</strong> riferimento (per esempio gli<br />
articoli <strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ce)<br />
- vada perio<strong>di</strong>camente considerato, sempre metaculturalmente, il<br />
sistema <strong>di</strong> riferimento.<br />
Ambedue le cose si fanno, in democrazia, anche se i livelli attraversati<br />
dalla catabasi metaculturale sono in genere i più superficiali. Livelli più
profon<strong>di</strong> vengono raggiunti dalle rivoluzioni, ma qui gli effetti<br />
collaterali si fanno spesso intollerabili. Questo, in ambito sociale e<br />
politico; in ambito scientifico le rivoluzioni sono perlopiù incruente, ma<br />
tali non sono le loro conseguenze, come Hiroshima e Chernobyl<br />
<strong>di</strong>mostrano.<br />
Nella quoti<strong>di</strong>anità l'attività giu<strong>di</strong>cante è all'or<strong>di</strong>ne del giorno, al punto<br />
che neppure ce ne ren<strong>di</strong>amo conto e trascuriamo le precauzioni <strong>di</strong> cui<br />
sopra.<br />
- I prezzi sono alle stelle (eppure ci permettono <strong>di</strong> vivere molto<br />
meglio <strong>di</strong> altre popolazioni).<br />
- La guerra è il peggiore dei mali (eppure gli uomini l'hanno praticata<br />
da sempre).<br />
- L'universo è infinitamente grande (anche se nessuna verifica sarà<br />
mai possibile).<br />
- La matematica non è un'opinione (e se lo fosse?).<br />
- Lucia è una poco <strong>di</strong> buono (fa la prostituta per mantenere i figli).<br />
Chi giu<strong>di</strong>ca normalmente non relativizza i suoi giu<strong>di</strong>zi e si oppone a<br />
che altri lo facciano. Il giu<strong>di</strong>zio tende alla prevaricazione o perlomeno<br />
finge accordo con l'interlocutore. Dovremmo quin<strong>di</strong>, per correttezza,<br />
astenerci dal giu<strong>di</strong>care?<br />
Il problema è <strong>di</strong> carattere morale, esula quin<strong>di</strong> dalla nostra indagine.<br />
Certo è (ma anche questo è un giu<strong>di</strong>zio prevaricante) che l'esercizio<br />
in<strong>di</strong>scriminato della modalità giu<strong>di</strong>cante genera a sua volta<br />
opposizione ed entra in zona pericolo. Lo ve<strong>di</strong>amo ogni giorno,<br />
quando opposti fondamentalismi si giu<strong>di</strong>cano a vicenda e <strong>di</strong>fendono<br />
con la vita - e la morte altrui - i propri giu<strong>di</strong>zi. D'altronde, se a livello
privato sta entrando nell'uso una blanda forma <strong>di</strong> relativizzazione,<br />
banalmente espressa (come qui facciamo) da stereotipe figure<br />
retoriche: "a mio parere", "secondo me", "molti ritengono" ecc., a<br />
livello pubblico - per esempio in ambito giuri<strong>di</strong>co - la relativizzazione<br />
non può essere applicata alla fase giu<strong>di</strong>cante, ma solo a quella,<br />
successiva, della valutazione. Ne andrebbe della coesione sociale,<br />
dell'affidabilità delle istituzioni e il danno per la vivibilità sul nostro<br />
pianeta sarebbe incalcolabile. La relativizzazione metaculturale ha<br />
essa stessa un suo luogo culturale e questo luogo ha ancora da essere<br />
costruito nella consapevolezza degli in<strong>di</strong>vidui. Fino allora la giustizia<br />
umana, sia pure con le perio<strong>di</strong>che rivisitazioni <strong>di</strong> cui si è detto,<br />
manterrà la sua insostituibile funzione.<br />
Ancora una parola sulla genesi della modalità giu<strong>di</strong>cante, contestuale<br />
alla genesi del linguaggio verbale, che sembra modellarsi su <strong>di</strong> essa.<br />
Non è che un'ipotesi, probabilmente ben conosciuta se non già<br />
superata in sede antropologica. Secondo questa ipotesi il linguaggio<br />
verbale si sarebbe evoluto per sod<strong>di</strong>sfare sul piano espressivo le<br />
esigenze del giu<strong>di</strong>zio, e a sua volta, come già osservato, implicato con<br />
la struttura sociale e il potere. Non tutti i linguaggi avrebbero a che<br />
fare con il giu<strong>di</strong>zio, così quello musicale o quello logico-matematico, il<br />
quale, più che sul vero/falso o giusto/errato si basa sulla<br />
derivabilità/non derivabilità dagli assiomi, fornendo così la cornice<br />
relativizzante entro cui assolutizzare le sue espressioni. Anche le arti<br />
figurative possono sì rappresentare fatti <strong>di</strong> giustizia, ma non si<br />
strutturano su <strong>di</strong> essi.
Pensiamo che la formazione <strong>di</strong> un citta<strong>di</strong>no effettivamente<br />
democratico debba passare anzitutto su una permanente riflessione<br />
sul linguaggio verbale e i connessi meccanismi <strong>di</strong> concettualizzazione.<br />
4.6.2. La valutazione<br />
(Riporto, con poche mo<strong>di</strong>fiche, il nodo formativo valutare, pubblicato<br />
sul sito www.<strong>di</strong>datticaperprogetti.it)<br />
Generalità<br />
L'esercizio della valutazione è, tra le operazioni interne alle varie<br />
culture, una delle più <strong>di</strong>ffuse. Si può <strong>di</strong>re che quasi ogni nostra<br />
espressione contenga, implicita o esplicita, una valutazione.<br />
- Bella giornata, oggi!<br />
- Il compito in classe era davvero <strong>di</strong>fficile.<br />
- Preferisco gli spaghetti alle fettuccine.<br />
- Sta' attento e non ricadere nello stesso errore!<br />
- Ahimé, le vacanze stanno per finire...<br />
Abbiamo definito la valutazione un'operazione culturale perché, anche<br />
se non sembra evidente, <strong>di</strong>etro ogni valutazione c'è una gerarchia <strong>di</strong><br />
valori variabile da cultura a cultura e anche, all'interno <strong>di</strong> una stessa,<br />
da situazione a situazione.<br />
Così la valutazione <strong>di</strong> un compito come "<strong>di</strong>fficile" <strong>di</strong>pende in buona<br />
parte dalla preparazione dell'allievo, così come il concetto stesso <strong>di</strong><br />
errore ha un senso solo se riferito a un insieme concordato <strong>di</strong> regole.<br />
La valutazione è inoltre assai spesso legata all'interesse <strong>di</strong> chi valuta.
- Una <strong>di</strong>tta vuole assumere un esperto <strong>di</strong> informatica. Valuterà<br />
negativamente un promettente scrittore che nel computer vede<br />
solo una moderna macchina per scrivere.<br />
- Un falegname cerca un aiutante. Evita <strong>di</strong> assumere uno più bravo <strong>di</strong><br />
lui.<br />
- Al concorso i commissari d'esame si trovarono d'accordo nel dare il<br />
massimo dei voti al figlio dell'assessore (che forse non lo meritava).<br />
Su quest'ultimo esempio le valutazioni espresse o sottintese sono due<br />
- e riguardano sia l'assessore che il figlio - e noi, in mancanza <strong>di</strong><br />
ulteriori informazioni, non siamo in grado <strong>di</strong> valutare quale delle due<br />
sia più corretta (il can<strong>di</strong>dato era o no meritevole?).<br />
Queste e altre considerazioni dovrebbero servire a relativizzare la<br />
valutazione appunto come operazione culturale. Ciò non significa<br />
toglierle valore (svalutare la valutazione), ma solo riconoscere con la<br />
maggiore chiarezza possibile il contesto culturale (ma anche<br />
situazionale, sociale, ideologico...) entro cui si produce.<br />
Criteri <strong>di</strong> valutazione<br />
Che questi siano variabili da punto a punto del nostro UCL è ormai<br />
ovvio... fin quando non vengono toccati i fondamenti <strong>di</strong> questo<br />
universo. E dei suoi fondamenti sono in tanti a occuparsi: la religione,<br />
la morale corrente, le convinzioni politiche, la giustizia, i <strong>di</strong>ritti umani,<br />
il buon senso... In certi casi i criteri <strong>di</strong> valutazione assumono una<br />
veste oggettiva: quando per esempio ci sono <strong>di</strong> mezzo i numeri e i<br />
modelli scientifici.
Il tasso glicemico <strong>di</strong> un certo sangue, l'altezza del Monte Everest, la<br />
ra<strong>di</strong>ce quadrata <strong>di</strong> 16 ecc. neppure vengono considerate valutazioni,<br />
anche se, almeno nei due primi casi, il margine <strong>di</strong> errore è sempre<br />
presente; si suppone comunque che i valori esatti esistano e siano,<br />
oggettivamente, sempre meglio approssimabili.<br />
Ti capita però anche che questa veste oggettiva venga assunta dai<br />
non aventi <strong>di</strong>ritto.<br />
- La tale canzone ha vinto il Festival <strong>di</strong> Sanremo.<br />
- Il tale leader politico ha vinto le elezioni.<br />
- Il tema <strong>di</strong> X risultò essere il migliore della scuola.<br />
Nell'opinione comune, se i fatti sono andati in questo modo, vuol <strong>di</strong>re<br />
che quella canzone, quel leader politico, quel tema erano<br />
effettivamente i migliori. Un'analisi un poco più scaltrita metterà in<br />
dubbio quell'"effettivamente", ma non il <strong>di</strong>ritto dei valutanti a valutare<br />
come hanno fatto.<br />
Siamo talmente abituati alla pratica della valutazione che il problema<br />
dei criteri passa per lo più in second'or<strong>di</strong>ne.<br />
Anche a scuola, dove al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> qualche mugugno, <strong>di</strong> qualche debole<br />
protesta in genere non si va. Né chi si sente colpito da una<br />
valutazione ingiusta ha nient'altro da opporre che la sua personale,<br />
<strong>di</strong>versa valutazione.<br />
Che fare allora? Astenerci tutti dal valutare?<br />
Normalizzazione degli atti valutativi<br />
Prima <strong>di</strong> prospettare delle alternative alla valutazione, ve<strong>di</strong>amo se e<br />
quando è possibile normalizzarne l'uso.
Normalizzare = ridurre a norma.<br />
Sarebbe quin<strong>di</strong> possibile fissare delle norme che garantiscano<br />
l'oggettività <strong>di</strong> una valutazione?<br />
Ovviamente no. Cadrebbe quin<strong>di</strong> tutto il <strong>di</strong>scorso sulla relativizzazione<br />
che fin qui si è fatto, e a questo <strong>di</strong>scorso non vorremmo rinunciare,<br />
perché lo riteniamo in<strong>di</strong>spensabile alla nostra sopravvivenza (non è<br />
che un'ipotesi e dentro questo limite la proponiamo).<br />
Non è quin<strong>di</strong> la valutazione stessa che si intende normalizzare, ma le<br />
con<strong>di</strong>zioni al contorno, come <strong>di</strong>re tutto ciò che ne accompagna il<br />
concreto esercizio. Riferiamoci per esempio a un abituale contesto<br />
scolastico, e, in particolare, a un tema svolto in un ambiente sociale <strong>di</strong><br />
periferia urbana.<br />
Una valutazione monoplanare, condotta sull'unico criterio della<br />
correttezza grammatical-sintattica misurata sull'italiano ufficiale,<br />
sarebbe non solo inadeguata ma anche scorretta, in quanto non<br />
terrebbe conto delle varianti linguistiche localmente dominanti. Se<br />
contestualmente si accompagnasse ad altre valutazioni - rispetto<br />
all'ambiente culturale frequentato dallo scrivente, all'uso <strong>di</strong> i<strong>di</strong>oletti,<br />
all'imme<strong>di</strong>atezza espressiva ecc. - i suoi risultati apparirebbero<br />
relativizzati dall'insieme degli altri e riacquisterebbero una loro<br />
vali<strong>di</strong>tà. La pluralità dei criteri valutativi consente infatti <strong>di</strong> evitare il<br />
giu<strong>di</strong>zio semplicemente - e semplicisticamente - negativo. Ma non<br />
basta: i sistemi <strong>di</strong> riferimento cui si improntano i veri criteri valutativi<br />
vanno esplicitati ed essi stessi analizzati nelle loro <strong>di</strong>versità - e talora<br />
<strong>di</strong>vergenze -, cosicché l'alunno se ne appropri coscientemente ben al
<strong>di</strong> là <strong>di</strong> quanto il semplice risultato della valutazione potrebbe<br />
suggerirgli.<br />
In momenti successivi l'alunno stesso potrebbe partecipare - da solo o<br />
nel gruppo classe - a una tale valutazione, relativizzata e stratificata.<br />
Di qui non è <strong>di</strong>fficile passare alla composizione <strong>di</strong> testi orientati volta<br />
per volta su singoli sistemi <strong>di</strong> riferimento o, meglio ancora, su una<br />
combinazione <strong>di</strong> essi. In tal modo si chiuderebbe il cerchio analisi-<br />
composizione nel nome della consapevolezza e la stessa valutazione<br />
contribuirebbe metodologicamente alla funzione formativa.<br />
Alternative alla valutazione<br />
Ecco: la funzione formativa - nella scuola ma non solo - pensiamo<br />
debba essere il metro stesso della valutazione.<br />
Prima ancora <strong>di</strong> come condurla, chie<strong>di</strong>amoci se la valutazione è<br />
necessaria, in<strong>di</strong>spensabile alla funzione formativa. In altre parole, ci<br />
sono alternative alla valutazione, è pensabile una scuola che non ne<br />
faccia uso o si limiti per esempio a valutare sé stessa, i suoi operatori,<br />
i suoi criteri formativi? Le ipotesi massimaliste non ci appartengono,<br />
quin<strong>di</strong> neppure sapremmo progettare una scuola del genere. Quanto a<br />
possibili alternative alla valutazione, molte sono ben note e non resta<br />
che ricordarle in questa sede.<br />
Anzitutto l'attività produttiva - fisica e mentale - è essa stessa<br />
un'alternativa alla valutazione. L'esercizio del corpo e della mente è <strong>di</strong><br />
per sé gratificante. Di più, ha carattere autoevolutivo: la guida una<br />
sorta <strong>di</strong> autovalutazione, così come si impara a camminare solo<br />
camminando. Vi sono poi i prodotti dell'attività umana ed è su <strong>di</strong> essi
che si esercita normalmente la valutazione. E se, anziché valutarli, ci<br />
si limitasse a osservarli, ad analizzarli, a confrontarli con altri<br />
consimili, rilevandone affinità e <strong>di</strong>fferenze? Lo stesso si potrebbe fare<br />
nel confronto con le regole, con i co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> uso comune: regola, co<strong>di</strong>ce<br />
rispettato oppure no. In ambedue i casi perché? Entro quale progetto<br />
compositivo, comunicativo? Se il fine è la formazione, è essenziale la<br />
consapevolezza del proprio operare, non la valutazione, né da parte <strong>di</strong><br />
altri né da parte propria.<br />
Valutare è spesso usato come sinonimo <strong>di</strong> verificare. Possiamo per<br />
contro considerare la verifica tra le alternative alla valutazione. Voglio<br />
verificare per esempio se ho messo lo zucchero nel caffè.<br />
Dall'assaggio otterrò un sì o un no, ma la valutazione sarà positiva o<br />
negativa a seconda che il caffè mi piaccia dolce o amaro. Voglio<br />
verificare se Giulio sa fare le sottrazioni. Se vedo che non le sa fare,<br />
prima <strong>di</strong> valutare negativamente questa sua incapacità, mi chiedo se<br />
qualcuno gliele ha mai insegnate. Mi è stato detto che hanno spostato<br />
la fermata dell'autobus. Vado a verificare. La valutazione <strong>di</strong>penderà<br />
dal fatto che la fermata sia ora più vicina o più lontana da casa mia.<br />
Una scuola ricca <strong>di</strong> momenti <strong>di</strong> verifica non è ancora una scuola che<br />
valuta. Lasciamo che a valutare siano i commissari dei concorsi o i<br />
futuri datori <strong>di</strong> lavoro. La scuola, soprattutto la scuola dell'obbligo,<br />
pensi piuttosto a formare, ad attivare i suoi frequentatori.<br />
Sintesi degli argomenti esposti<br />
Valutare = attribuire un valore a risultato <strong>di</strong> una verifica.
Culturalità dei criteri <strong>di</strong> valutazione<br />
relativizzati, cioè riconosciuti nella<br />
loro culturalità<br />
assolutizzati dalle ideologie<br />
oggettivanti<br />
Normalizzazione dell'esercizio della valutazione:<br />
- dalla valutazione monoplanare (un solo sistema <strong>di</strong> riferimento) alla<br />
valutazione compensata (più sistemi <strong>di</strong> riferimento)<br />
- esplicitazione, analisi e <strong>di</strong>scussione dei sistemi <strong>di</strong> riferimento<br />
- passaggio alla fase produttiva.<br />
Alternative alla valutazione:<br />
- la stessa attività e i suoi prodotti (osservazione, analisi, confronto,<br />
verifica) consapevolezza.<br />
4.7. Modalità critica<br />
È affine per un verso alla modalità analitica, per un altro alla modalità<br />
giu<strong>di</strong>cante (valutativa). Il campo semantico della parola critica è<br />
comunque assai vasto: si va dalla Critica della ragion pura alla critica<br />
cinematografica, dove la prima si apparenta piuttosto all'analisi, la<br />
seconda alla valutazione. Il rapporto con crisi non è sempre evidente,<br />
tuttavia ambedue queste parole rimandano a una con<strong>di</strong>zione<br />
permanente del pensiero umano: non c'è fase storica che qualcuno<br />
non definisca "<strong>di</strong> crisi" e non c'è persona che non eserciti con piacere<br />
l'attività critica.
4.7.1. ???<br />
In quanto prossima all'analisi, la critica che opera anch'essa<br />
prevalentemente con strumenti culturali che peraltro non sempre<br />
<strong>di</strong>chiara anzi spesso neppure riconosce come tali.<br />
Eppure la sua ambizione sarebbe proprio <strong>di</strong> raggiungere i fondamenti<br />
della conoscenza, della morale, del giu<strong>di</strong>zio.<br />
D'altronde la credenza stessa nei fondamenti fa parte della nostra<br />
come <strong>di</strong> molte altre culture, il che non dovrebbe tuttavia impe<strong>di</strong>re (e<br />
<strong>di</strong> fatto non impe<strong>di</strong>sce) la ricerca.<br />
L'impossibile non ha mai fermato l'iniziativa dell'uomo:<br />
"Den lieb'ich, der Unmögliches begehrt"<br />
(Amo colui che aspira all'impossibile)<br />
<strong>di</strong>ce Manto <strong>di</strong> Faust in procinto <strong>di</strong> richiedere Elena alle Madri.<br />
Possiamo vedere del pensiero critico il più potente motore evolutivo<br />
della nostra specie, probabilmente ignoto alle altre, e in quanto tale<br />
coincidente con la modalità riflessiva, anche questa considerata<br />
esclusivamente umana. E, come per analisi e la riflessione, anche alla<br />
critica possiamo oggi applicare la <strong>di</strong>cotomia culturale/metaculturale,<br />
con la solita avvertenza che tra i due termini, più che opposizione c'è<br />
contiguità.<br />
Dico "oggi", ma dovrei anche localizzare l'espressione negli imme<strong>di</strong>ati<br />
<strong>di</strong>ntorni del CMC, giacché, nonostante il fatto che lo stile<br />
metaculturale sia ampiamente <strong>di</strong>ffuso, il termine ancora non lo è.
Abbiamo già visto in 3.12. una grafizzazione della componente<br />
metaculturale comune a tutte le culture. La <strong>di</strong>cotomia risulta evidente<br />
solo se siamo consapevoli <strong>di</strong> questa componente; altrimenti, restando<br />
operante solo la componente culturale, analisi, riflessione e critica<br />
segnerebbero il passo, incapaci <strong>di</strong> vedere oltre i confini dell'UCL che le<br />
con<strong>di</strong>ziona. In particolare la critica, filosoficamente intesa, non può<br />
che essere metaculturale, anche se non fa ancora uso <strong>di</strong> questo<br />
termine.<br />
4.7.2. ???<br />
Se consideriamo l'altro versante <strong>di</strong> critica, quello più vicino alla<br />
modalità valutativa, ne troviamo una miriade <strong>di</strong> specificazioni: critica<br />
letteraria, musicale, cinematografica, sociale, politica... Inoltre una<br />
miriade <strong>di</strong> locuzioni che contengono il termine o un suo derivato:<br />
- avere l'occhio critico<br />
- vedere la cosa criticamente<br />
- ... è un criticone<br />
- ... è un serio critico d'arte<br />
- critica è facile...<br />
- la situazione si fa critica<br />
- ... non ti critico, ma
Una parola così usata e abusata necessariamente ha perso <strong>di</strong> nettezza<br />
semantica e si adatta ai <strong>di</strong>versi atteggiamenti mentali senza avanzare<br />
particolari pretese. Ciò non significa tuttavia che la critica in senso per<br />
esempio musicale non possa avere una rilevanza culturale almeno<br />
pari a quella <strong>di</strong> una delle Critiche kantiane: basti pensare a figure<br />
come Wagner, Nietzsche o Adorno per rendersi conto quanto il<br />
pensiero filosofico si confonda con quello musicale, al punto <strong>di</strong> far<br />
confluire i relativi linguaggi in un'unica espressione critica. Lo stesso<br />
vale per altre specificazioni <strong>di</strong> questo termine che, derivando dal<br />
greco = giu<strong>di</strong>co, <strong>di</strong>stinguo, è parimenti applicabile ai<br />
prodotti finiti che all'atto del produrli. Un poeta che si trova a dover<br />
scegliere un'espressione piuttosto che un'altra, un compositore una<br />
certa combinazione <strong>di</strong> suoni, un coreografo una certa lettura del corpo<br />
umano, hanno davanti a sé un numero molto alto <strong>di</strong> alternative<br />
culturalmente predeterminate o localmente costruite, alternative che<br />
il pensiero critico fa da ultimo collassare nell'unica scelta definitiva.<br />
Chi produce, in qualsiasi campo, possiamo <strong>di</strong>rlo un critico della<br />
virtualità, delle cose che non sono, ma che per essere hanno bisogno<br />
appunto della riflessione critica. Un giornalista che soppesa le parole,<br />
<strong>di</strong> questa modalità si serve e così un cuoco che mescola gli ingre<strong>di</strong>enti<br />
<strong>di</strong> una pietanza. Di qui la necessità che la modalità critica si trovi<br />
adeguatamente rispecchiata negli itinerari formativi che la società<br />
sceglie per i suoi membri più giovani e, a maggior ragione, nello<br />
stesso itinerario che porta a quella scelta.
4.8. Modalità costruttiva/<strong>di</strong>struttiva<br />
Ho scelto <strong>di</strong> accomunare questi due aggettivi, normalmente<br />
considerati incompatibili, per mostrarne non solo la compatibilità ma<br />
la reciproca compenetrazione fino a renderli in<strong>di</strong>stinguibili.<br />
- Il progetto <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio prevede che il terreno su cui<br />
dovrà sorgere venga anzitutto ripulito dal suo manto vegetale e<br />
adeguatamente spiegato (il che significa <strong>di</strong>struggere la sua<br />
precedente configurazione).<br />
- La crescita del corpo umano va <strong>di</strong> pari passo con la sostituzione<br />
delle cellule morte.<br />
- Lo scrittore si convinse che il capitolo, cui stava lavorando ormai da<br />
più settimane, proprio non funzionava. Prese le pagine<br />
faticosamente composte e le stracciò. In capo a pochi giorni il<br />
capitolo fu riscritto, questa volta con la piena approvazione del suo<br />
autore.<br />
- È un bambino deboluccio, ha bisogno <strong>di</strong> molta carne.<br />
Per l'esistenza stessa Goethe trovò l'espressione:<br />
Stirb und werde;<br />
(muori e <strong>di</strong>venta)<br />
Ogni attimo che sopravviene segna la morte del precedente e muore<br />
nell'attimo che lo segue. Sembra ad<strong>di</strong>rittura strano che <strong>di</strong> concetti <strong>di</strong>
costruzione e <strong>di</strong>struzione, nascita e morte, essere e non essere siano<br />
stati non solo separati ma ad<strong>di</strong>rittura considerati antitetici. A produrre<br />
le antitesi sono probabilmente proprio gli atti <strong>di</strong> separazione. Questi<br />
peraltro, come quoti<strong>di</strong>anamente sperimentiamo, sono in<strong>di</strong>spensabili<br />
alla nostra sopravvivenza, che proprio <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità si alimenta e che in<br />
un universo in cui nulla fosse <strong>di</strong>stinguibile neppure sarebbe pensabile.<br />
Il "peccato originale" consiste semmai nell'aver assolutizzato,<br />
ideologizzato la separazione e, ognuno per sé, i suoi termini, il prima<br />
dal poi, la vita dalla morte, il bene dal male e così via. La finalità<br />
pratica del <strong>di</strong>stinguere, legata alla comunicazione, alla parola e quin<strong>di</strong><br />
alla sopravvivenza della nostra specie (quanto alle altre, siamo troppo<br />
poco informati), troppo spesso degenera nella pretesa metafisica e<br />
finisce per ra<strong>di</strong>calizzarsi nel "sì/no", "<strong>di</strong>o/<strong>di</strong>avolo" perdendo ogni<br />
flessibilità concettuale e trasformandosi in argomento <strong>di</strong> scontro.<br />
Tornando infatti alla <strong>di</strong>cotomia costruttivo/<strong>di</strong>struttivo, se ne sono fatti<br />
due concetti antitetici che, nonostante la evidente analogia verbale,<br />
producono valutazioni anch'esse antitetiche, dove la <strong>di</strong>struttività viene<br />
in genere valutata negativamente:<br />
- critica costruttiva/critica <strong>di</strong>struttiva<br />
- ... è molto intelligente, ma ha una mentalità <strong>di</strong>struttiva...<br />
- ... è un tipo positivo, costruttivo...<br />
Ma in certi casi è la costruttività a essere guardata con sospetto -<br />
forse perché <strong>di</strong>strugge qualcosa a cui tenevamo -, mentre la<br />
<strong>di</strong>struttività, in quanto colpisce tutto e tutti in<strong>di</strong>scriminatamente,<br />
<strong>di</strong>venta un valore positivo - forse perché fa piazza pulita del terreno<br />
su cui si pensa <strong>di</strong> costruire (ma non lo si fa per non contrad<strong>di</strong>rsi).
Non poche posizioni politiche, assai forti sul versante della critica<br />
<strong>di</strong>struttiva, si sono involute nella loro stessa critica, restando perdenti<br />
<strong>di</strong> fronte all'acritico attivismo dei costruttori <strong>di</strong> benessere. (Quanto<br />
questo attivismo sia da considerarsi acritico è comunque questione <strong>di</strong><br />
punti <strong>di</strong> vista, giacché ogni costruzione implica, come abbiamo visto,<br />
l'esame critico delle alternative, reali o virtuali che siano.)<br />
Talora si pensa alla <strong>di</strong>struttività come più legata a un pensiero<br />
giovanile, ancora immaturo, mentre la costruttività sarebbe propria<br />
piuttosto <strong>di</strong> una fase matura, <strong>di</strong> maggiore consapevolezza. Non credo<br />
molto in questa <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> uno stile mentale dall'età; forse si può<br />
sostenere la propensione del giovane per l'accentuazione della<br />
polarità in un senso o nell'altro, mentre l'anziano tenderebbe piuttosto<br />
alla me<strong>di</strong>azione, alla modulazione reciproca o, con parola che a un<br />
giovane non piacerebbe, al compromesso. Anche <strong>di</strong> questo non sono<br />
affatto convinto come, in genere, <strong>di</strong> tutte le ipotesi <strong>di</strong> determinismo<br />
caratteriologico. Ogni positività del fare, del produrre richiede il<br />
concorso <strong>di</strong> ambedue le modalità qui <strong>di</strong>scusse e non mi risulta che i<br />
giovani facciano o producano meno <strong>di</strong> chi è più avanti negli anni. Il<br />
problema ritengo che stia, come sempre, nel grado <strong>di</strong> consapevolezza<br />
raggiunto: c'è chi raggiunge assai presto un livello sufficientemente<br />
elevato e chi, annebbiato dalle ideologie più <strong>di</strong>verse, non lo raggiunge<br />
mai. Ma che cosa inten<strong>di</strong>amo per consapevolezza? Nel caso per<br />
esempio <strong>di</strong> una scelta, chiamerei consapevole una scelta che tenga<br />
conto <strong>di</strong> tutto ciò che attraverso <strong>di</strong> essa va perduto. E solo un<br />
accurato bilancio preventivo tra ciò che si guadagna e ciò che si perde<br />
può legittimare la decisione. Ma questi bilanci sono i più <strong>di</strong>fficili a farsi,
anche perché si basano essenzialmente sul possibile, sul probabile,<br />
sul virtuale, in breve su un futuro inconoscibile. Mentre le decisioni<br />
vanno prese su un presente conosciuto o su un passato interpretato.<br />
E quando sono in molti a essere chiamati a prendere una decisione, le<br />
valutazioni delle variabili in gioco raramente convergono su una scelta<br />
univoca. Sono le <strong>di</strong>fficoltà della democrazia, in cui però non<br />
sapremmo preferire la scorciatoia - oggi troppo rischiosa - <strong>di</strong> una<br />
convergenza forzata. E come alla democrazia bisogna essere formati,<br />
così anche la dosatura <strong>di</strong> <strong>di</strong>struzione-costruzione (in <strong>di</strong>rezione della<br />
sopravvivenza) va sperimentata già nella scuola, visto che le famiglie<br />
sono generalmente impreparate a questi <strong>di</strong>fficili equilibri. Chè <strong>di</strong><br />
equilibri si tratta, non <strong>di</strong> equilibrismi, quali si vedono troppo spesso in<br />
politica.<br />
Che cosa può fare la scuola?<br />
Innanzitutto promuovere riflessione e consapevolezza.<br />
Qualche in<strong>di</strong>cazione in tal senso l'insegnante che ne avesse bisogno<br />
può trovarla nel sito del CMC e in questo stesso scritto. Maggiori<br />
in<strong>di</strong>cazioni gliele forniranno i ragazzi stessi - e forse anche i bambini -<br />
a patto che vengano messi a conoscenza del problema e sollecitati a<br />
una <strong>di</strong>scussione alla pari (per esempio sul modello del circuito<br />
autogenerativo). In fin dei conti la questione riguarda il futuro, non<br />
certo il passato immo<strong>di</strong>ficabile, e il futuro è assai più loro che nostro.<br />
Credo sia possibile renderli consapevoli <strong>di</strong> questo e delle<br />
responsabilità che ne derivano. A ogni pubblica occasione i politici,<br />
rivolgendosi ai giovani, non fanno che <strong>di</strong>chiarare: "Il futuro siete voi",<br />
poi però se lo tengono per sé, giovani compresi.
"Ma tu fai lo stesso" potrebbe <strong>di</strong>rmi qualcuno e non saprei<br />
contrad<strong>di</strong>rlo. Non posso che sperare nella contrad<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> qualche<br />
giovane che <strong>di</strong>mostri contrario.<br />
4.9. Modalità assente<br />
Può sembrare strano e illogico che a proposito delle modalità in cui si<br />
manifestano gli stili <strong>di</strong> pensiero si parli <strong>di</strong> modalità assente, cioè <strong>di</strong><br />
qualche cosa che, essendo assente, neppure ha modo <strong>di</strong> manifestarsi.<br />
In realtà non è che venga meno l'attività pensante, che non ci<br />
abbandona mai, questa tuttavia farebbe <strong>di</strong> tutto per sottrarsi alla<br />
verifica della società. È una con<strong>di</strong>zione non rara nel mondo giovanile,<br />
il contrario degli "eroici furori" che animavano la gioventù <strong>di</strong> un<br />
tempo: ubriacature ideologiche oggi sostituite dall'atarassia indotta<br />
(dalla droga) o dal <strong>di</strong>sinteresse universale. Il termine "modalità<br />
assente" dovrebbe forse essere sostituito da "modalità dell'assenza",<br />
giacché non è la modalità a essere assente ma colui che l'adotta. E<br />
come mai questa con<strong>di</strong>zione si verifica oggi con tanta frequenza? È<br />
per scelta dei ragazzi, per un mondo che, oggettivamente, è privo <strong>di</strong><br />
motivi <strong>di</strong> interesse, per costrizione dall'alto?<br />
Spesso <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>lagante in<strong>di</strong>fferenza per ciò che ci circonda viene<br />
incolpata la cosiddetta "per<strong>di</strong>ta dei valori", da quelli religiosi a quelli<br />
civili e sociali, a quelli morali. Eppure mai come in questo periodo è<br />
fiorito il volontariato. "Grazie - mi si <strong>di</strong>ce - alla mancanza <strong>di</strong> lavoro<br />
retribuito..." Il che è vero solo in parte, perché al volontariato
partecipano anche non pochi professionisti, sottraendo ore <strong>di</strong> lavoro<br />
alla propria professione e ai relativi guadagni. Ma la modalità assente<br />
non riguarda certo chi offre gratuitamente il suo lavoro, semmai le<br />
strutture che dovrebbero remunerarlo, ma non sono in grado <strong>di</strong> farlo.<br />
Riguarda invece chi dal problema del lavoro neppure si sente toccato:<br />
o perché non ha bisogno <strong>di</strong> lavorare o perché, pur avendone bisogno,<br />
gli oppone un rifiuto ideologico. Com'è possibile un'ideologia del non<br />
lavoro (non si <strong>di</strong>ce dell'"ozio" per rispetto all'otium oraziano, che era<br />
tutt'altra cosa)?<br />
Da un ipotetico osservatorio metaculturale ve<strong>di</strong>amo tutta cultura<br />
occidentale impegnata - se così si può <strong>di</strong>re - nel <strong>di</strong>simpegno.<br />
Motivazioni, anche politiche, che fino a una trentina <strong>di</strong> anni fa<br />
muovevano gran<strong>di</strong> masse giovanili, oggi si spengono nelle <strong>di</strong>scoteche,<br />
nelle sale-giochi, nella droga. E non vi è stata una frattura tra quei<br />
movimenti e l'inerzia o<strong>di</strong>erna, ma un lento (neppure troppo)<br />
scivolamento, quasi che il punto <strong>di</strong> arrivo fosse in qualche modo già<br />
contenuto nell'agitazione degli inizi. I quali inizi si fanno con buone<br />
ragioni e risalire all'ormai mitico 68 e ai suoi imme<strong>di</strong>ati precedenti su<br />
suolo americano. Un ruolo <strong>di</strong> primaria importanza toccò alla musica<br />
(in particolare al rock) e a certo teatro come il Living theatre,<br />
quest'ultimo imparentato al teatro d'avanguar<strong>di</strong>a europeo e<br />
americano, mentre il rock (salvo alcune eccezioni tra cui Jimi Hendrix)<br />
si è mantenuto più vicino alla musica <strong>di</strong> consumo (che preferisco<br />
chiamare della quoti<strong>di</strong>anità) che alle esperienze musicali<br />
d'avanguar<strong>di</strong>a. Ed è forse questo <strong>di</strong>vorzio tra musica e ascoltatore<br />
(<strong>di</strong>vorzio cui non aderì il rock) che ha un poco alla volta esonerato
l'avanguar<strong>di</strong>a musicale (compreso il suo più profilato rappresentante<br />
politico, Luigi Nono) dal partecipare alle lotte degli anni successivi.<br />
Così come è forse la maggior permeabilità del rock alle ragioni <strong>di</strong><br />
mercato a <strong>di</strong>rottarne la forza <strong>di</strong>rompente verso la protesta in<strong>di</strong>viduale<br />
anziché verso quella politica.<br />
(Le cose che qui vado <strong>di</strong>cendo possono non trovare d'accordo più <strong>di</strong><br />
un lettore; non rispecchiano comunque una presunta verità dei fatti<br />
ma solo il modo come io li ho vissuti.)<br />
Dalla protesta in<strong>di</strong>viduale, che spesso si banalizzava in un'invettiva<br />
generica accompagnata da rabbiose gesticolazioni convenzionali, alle<br />
piatterie <strong>di</strong> Sanremo il passo era ormai breve cosicché in pochi anni<br />
siamo passati dall'enorme investitura politica <strong>di</strong> Bella ciao ai<br />
neosentimentalismi rivieraschi. E a tutto questo l'avanguar<strong>di</strong>a<br />
musicale ha assistito inerte, essa stessa caduta nelle secche<br />
dell'assenza.<br />
Tutta la cultura d'occidente, salvo forse il cinema, sembra oggi in<br />
cammino verso questa anomala modalità. In testa vedrei l'Italia,<br />
grazie una politica culturale e scolastica <strong>di</strong> rara ottusità, e più ancora<br />
grazia a un uso della multime<strong>di</strong>alità macroscopicamente asservito al<br />
mercato e all'interesse privato.<br />
Se in questa analisi c'è un barlume <strong>di</strong> verosimiglianza, c'è ancora da<br />
meravigliarsi dell'assenza dei giovani <strong>di</strong> oggi?<br />
Se cercate in questi giorni (ultimi <strong>di</strong> gennaio-primi <strong>di</strong> febbraio 2007)<br />
<strong>di</strong> rinver<strong>di</strong>re la loro memoria sulle atrocità del recente passato. Quale<br />
memoria? Che può voler <strong>di</strong>re per la mente <strong>di</strong> un quin<strong>di</strong>cenne la shoah,
<strong>di</strong> cui hanno solamente letto sui libri <strong>di</strong> scuola, come noi abbiamo letto<br />
della <strong>di</strong>sfatta <strong>di</strong> Varo nelle selve germaniche ai tempi <strong>di</strong> Augusto?<br />
"Non ce ne può fregà de meno" mi hanno detto degli insensibili alunni<br />
<strong>di</strong> II me<strong>di</strong>a. Ma qual era la sensibilità degli oratori che fingevano <strong>di</strong><br />
credere nella commossa partecipazione dei ragazzi, quando loro stessi<br />
non avevano memorie cui partecipare. Qualcosa <strong>di</strong> più e <strong>di</strong> meglio si<br />
poteva fare - e forse qua e là si è fatto -: per esempio chiedersi come<br />
una popolazione celebrata per l'alta qualità della sua cultura abbia<br />
potuto cadere in balia <strong>di</strong> un istrione <strong>di</strong> piazza della rozzezza <strong>di</strong> un<br />
Hitler ("ma chi era Hitler?" mi ha chiesto un ragazzo, "un nipote <strong>di</strong><br />
Mussolini" gli ha risposto un altro). Chissà, forse c'entravano qualcosa<br />
i me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> allora - giornali, libri, ra<strong>di</strong>o... - o forse la scuola, che in sei<br />
anni riuscì a convincere i suoi alunni a invadere mezza Europa mentre<br />
alle loro spalle le case dei genitori - perlopiù coi genitori dentro -<br />
venivano rase al suolo dalle bombe nemiche...<br />
"Cose oggi non più possibili...! eppure possibilissime in Iraq,<br />
Afganistan, Palestina, Somalia e in molte altre regioni "che non fanno<br />
notizia", ma la gente ci muore lo stesso, se non per la guerra, <strong>di</strong><br />
fame, <strong>di</strong> sete, <strong>di</strong> Aids...<br />
Ci si meraviglia delle folle trascinate dall'ottuso furore <strong>di</strong> Hitler quando<br />
si vedono ogni giorno migliaia <strong>di</strong> giovani cadere in assenza<br />
inseguendo con le braccia gli stereotipi ritmi della più insulsa delle<br />
canzonette (non tutte le canzoni sono insulse), o ancora abbandonarsi<br />
alla cieca violenza per un gol non assegnato. Certo le conseguenze <strong>di</strong><br />
questi comportamenti sono incommensurabilmente <strong>di</strong>versi, ma i<br />
comportamenti stessi non lo sono. Il buon citta<strong>di</strong>no sotto il fati<strong>di</strong>co
alcone non si rendeva probabilmente conto delle conseguenze del<br />
suo applau<strong>di</strong>re. Se ne rende conto la ragazzina urlante alla vista del<br />
suo cantautore preferito (o, vorrei aggiungere, io stesso quando, non<br />
più ragazzo, perdevo ogni controllo nell'applau<strong>di</strong>re la Terra <strong>di</strong><br />
Mahler)?<br />
Il meccanismo è lo stesso: solo che dovremmo sapere (dovrebbero<br />
avercelo insegnato?) quando applicarlo e quando è bene non farlo.<br />
Finora tuttavia ho parlato, non <strong>di</strong> assenze, ma <strong>di</strong> eccessive presenze:<br />
l'America in Iraq, i fans al concerto rock, i tifosi allo sta<strong>di</strong>o. Presenze<br />
non tanto <strong>di</strong> numero quanto <strong>di</strong> irriflessa partecipazione. Con un facile<br />
ossimoro possiamo <strong>di</strong>re: assenza per troppa presenza. Vengono<br />
<strong>di</strong>sertati luoghi culturali dove sarebbe necessaria una più assidua<br />
frequentazione, frequentatissimi i luoghi che non <strong>di</strong>sturbano.<br />
Lo sapevano benissimo già gli imperatori romani, che per tacitare la<br />
plebe turbolenta costruivano sta<strong>di</strong> e facevano allenare gla<strong>di</strong>atori. Non<br />
credo che in natura esistano le plebi; so però che si possono allevare<br />
artificialmente. Oggi, da noi, lo fanno la televisione e il consumismo.<br />
Ma chi ha interesse alla formazione <strong>di</strong> vasti strati <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza<br />
assente? Chi assente non è e non vuole che troppa presenza pensante<br />
<strong>di</strong>sturbi la sua. La classe politica in genere, soprattutto quella parte<br />
che detiene il potere o fa <strong>di</strong> tutto per ottenerlo. Quin<strong>di</strong> i politici tutti?<br />
Non necessariamente. Alcune minoranze hanno assunto - forse per<br />
necessità, talora per calcolo - un ruolo <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> riequilibrio<br />
degli in<strong>di</strong>rizzi espressi dai gran<strong>di</strong> numeri. Siamo poi sicuri che il potere<br />
sia oggi in mano ai politici? E non per esempio alle multinazionali o
alle banche o ai detentori dei mezzi <strong>di</strong> informazione? E quale peso<br />
hanno le religioni, vere e proprie centrali ideologiche?<br />
Non sta a me, e noi quattro gatti del CMC, addentrarci in analisi per<br />
cui non abbiamo gli strumenti necessari. Il nostro campo è la<br />
formazione, e allora c'è da chiedersi se è possibile formare o meglio<br />
sollecitare ad autoformarsi un citta<strong>di</strong>no responsabilmente presente nel<br />
pubblico come nel privato. Pensiamo <strong>di</strong> sì e tutte le nostre azioni e i<br />
nostri scritti testimoniano, non che la cosa è possibile, ma della nostra<br />
fiducia che lo sia.<br />
È <strong>di</strong> questi giorni un gravissimo episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> violenza avvenuto in uno<br />
sta<strong>di</strong>o ad opera <strong>di</strong> una tifoseria composta in gran parte da minorenni.<br />
Episo<strong>di</strong> meno gravi sono all'or<strong>di</strong>ne del giorno. Se ne parla per qualche<br />
giorno alla TV, sui giornali e si <strong>di</strong>cono anche cose molto sensate... poi<br />
tutto ritorna a come era prima, fino al prossimo episo<strong>di</strong>o gravissimo.<br />
Ogni volta c'è chi in<strong>di</strong>vidua nella violenza, anche minorile, un<br />
problema sociale, culturale, ma la scuola continua, imperturbabile, a<br />
spargere semi <strong>di</strong> sapere, <strong>di</strong>sinteressandosi del terreno su cui cadono.<br />
E questo terreno è la mente dei riceventi, che non si nutre <strong>di</strong> sementi,<br />
semmai le aiuta a crescere. In un mio precedente scritto, Dal sapere<br />
al pensare, ho cercato <strong>di</strong> commentare le esperienze condotte al CMC<br />
in<strong>di</strong>cando, per la scuola, una opportuna integrazione alla trasmissione<br />
culturale, cioè l'attivazione del pensiero riflesso. Credo che sia questa<br />
la via che porta alla consapevolezza <strong>di</strong> quanto più ricco sia un mondo<br />
conosciuto <strong>di</strong> uno appena percepito e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> quanto sia più<br />
gratificante una presenza conoscitiva <strong>di</strong> un'ignoranza assente. E<br />
siccome la società, pur dando a molti l'opportunità <strong>di</strong> conoscere, poco
si cura <strong>di</strong> stimolare il desiderio, l'assenza finisce per vincere, ed ecco<br />
fiorire la violenza, la stupi<strong>di</strong>tà e la droga in forma <strong>di</strong> pillole o<br />
polverine, ma anche come con<strong>di</strong>zionamento alla moda, alla TV, alle<br />
mani sventolate sotto un palcoscenico o un balcone.<br />
Formare = far agire il pensiero, renderlo capace <strong>di</strong> riflessione<br />
metaculturale. Questa, almeno, è la nostra opinione.<br />
4.10. Modalità riflessiva<br />
Dovrebbe essere il paragrafo più lungo <strong>di</strong> tutti, e invece risulterà il più<br />
corto. Per la semplice ragione che della modalità riflessiva tratta<br />
l'intero libro, <strong>di</strong> più, tratta tutta la nostra attività come CMC, dal 1974<br />
a oggi, con la speranza che l'oggi si estenda fino al momento in cui<br />
queste righe verranno lette. Ci sentiamo così esentati dal ripercorrere<br />
vie più volte battute, che nulla aggiungerebbero che il lettore già non<br />
sappia.<br />
Dovrei parlargli della riflessione culturale e <strong>di</strong> quella metaculturale,<br />
ma il lettore è ormai pienamente in grado <strong>di</strong> provvedere da solo,<br />
sempre che la cosa lo interessi. Dovrei suggerirgli, se è un educatore<br />
pubblico o privato, <strong>di</strong> trattare riflessivamente i problemi della mente e<br />
del pensiero, ovviamente non limitandosi a ciò che qui si legge, ma<br />
rivolgendosi anche alla letteratura più qualificata in senso scientifico<br />
senza tuttavia lasciarsi soggiogare da questa. Come più volte mi è<br />
capitato <strong>di</strong> <strong>di</strong>re: un cervello ce l'abbiamo tutti e anche quella parte <strong>di</strong><br />
esso capace <strong>di</strong> autoosservarsi e <strong>di</strong> ragionare su <strong>di</strong> sé. Se anche ci
mancano delle nozioni specifiche e soprattutto un vocabolario che le<br />
nomini, chi meglio <strong>di</strong> noi può informarsi sul nostro modo <strong>di</strong> pensare? E<br />
se non lo facciamo non è tanto per mancanza <strong>di</strong> strumenti quanto<br />
perchè qualcosa ce l'impe<strong>di</strong>sce. Può sembrare un controsenso, ma<br />
penso che i maggiori ostacoli ce li pone la cultura, che anziché<br />
facilitarci l'accesso a noi stessi, tende a porci al suo servizio,<br />
sostituendo il suo pensiero al nostro. La modalità riflessiva non si<br />
oppone alla consapevolezza culturale, ma ne fa emergere<br />
l'onnipresente componente meta.<br />
Appen<strong>di</strong>ce ai capitoli 3. e 4.<br />
Ho chiamato questo paragrafo appen<strong>di</strong>ce perchè non ho nessuna<br />
intenzione <strong>di</strong> scriverlo. Lo potrà fare il lettore, se crede, e per la parte<br />
che lo interessa. Ecco che cosa intendo <strong>di</strong>re.<br />
Nelle poche righe introduttive al capitolo 3. ho accennato alla possibile<br />
costruzione <strong>di</strong> una tabella per righe e colonne che unifichi le due<br />
arbitrarie classificazioni degli stili <strong>di</strong> pensiero qui proposte. Questa<br />
tabella avrebbe il seguente aspetto:<br />
Classif.<br />
modale<br />
(Cap.4.)<br />
<strong>Stili</strong> <strong>di</strong> pensiero<br />
Classif. <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo (Cap.3.)<br />
1. 2. 3. 4. 5. 6.,7.,8....12.<br />
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. .......<br />
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. .......<br />
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. .......
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. .......<br />
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. .......<br />
6. ... ... ... ... ... .......<br />
... ... ... ... ... ... .......<br />
10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. .......<br />
Nell'insieme: 120 possibili combinazioni. Il lettore potrà puntare il <strong>di</strong>to<br />
su una casella a suo piacimento e considerare lo stile <strong>di</strong> pensiero<br />
corrispondente alla combinazione numerica ivi contenuta.<br />
Esempio:<br />
Casella n.7.4.<br />
Colonna 7 = Cap. 3.§.7.: Stile storicistico-identitario<br />
Riga 4 = Cap. 4.§3.: Modalità sintetica<br />
Argomento da considerare: La sintesi storico-identitaria come stile <strong>di</strong><br />
pensiero (nella Roma imperiale, nella Cina <strong>di</strong> Mao, nell'era fascista<br />
ecc.).<br />
Nulla vieta <strong>di</strong> costruire un'analoga tabella riflessiva, ponendo nelle<br />
righe e colonne lo stesso tipo <strong>di</strong> classificazione, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo o modale.<br />
Nel primo caso avremmo così per esempio:<br />
Casella n.1.1.<br />
Colonna 1 = Cap. 3.§1.: Stile dogmatico assolutizzante<br />
Riga 1 = Cap. 3.§1.: Stile dogmatico assolutizzante<br />
Argomento da considerare: Autogiustificazione del pensiero<br />
dogmatico-assolutizzante
Nel secondo caso (tabella riflessiva delle modalità <strong>di</strong> pensiero)<br />
potremmo avere:<br />
Casella n.8.4.<br />
Colonna 8 = Cap. 4.§8.: Modalità costruttiva/<strong>di</strong>struttiva<br />
Riga 3 = Cap. 4.§4.: Modalità convergente<br />
Argomento da considerare: Convergenza del pensiero (in<strong>di</strong>viduale o<br />
collettivo) su una progettualità costruttiva e/o <strong>di</strong>struttiva (nella storia<br />
del marxismo-leninismo, nei movimenti giovanili del secondo 900, in<br />
certi tipi <strong>di</strong> schizofrenia ecc.)<br />
Sommando le due tabelle riflessive avremmo un totale <strong>di</strong><br />
144+100=244 caselle da aggiungere alle 120 precedenti. Se poi<br />
volessimo combinare ciascuna delle tabelle riflessive con la prima qui<br />
riportata (entro una rappresentazione tri<strong>di</strong>mensionale), avremmo:<br />
(120x144)+(120x100)=16.680+12.000=28.680 caselle da<br />
aggiungere alle 364 precedenti, per un totale <strong>di</strong> 29.044 argomenti da<br />
considerare.<br />
Tenendo inoltre presente che le due classificazioni adotte non solo<br />
sono arbitraria ma certo numericamente molto al <strong>di</strong> sotto degli stili<br />
mentali in<strong>di</strong>viduabili, gli argomenti crescono a <strong>di</strong>smisura.<br />
È più che ovvio che il mio progetto classificatorio non può aver avuto<br />
ambizioni <strong>di</strong> completezza teorica e neppure <strong>di</strong> atten<strong>di</strong>bilità scientifica.<br />
Allora quale è stata ed è la sua finalità?<br />
Nient'altro che promuovere la riflessione, l'autoanalisi del pensiero,<br />
possibile a tutti, in<strong>di</strong>pendentemente dal suo sapere.<br />
E perché dovremmo analizzare il nostro stesso pensiero senza<br />
lasciarlo andare dove lui vorrebbe? Per il semplice fatto che questo lui
troppo spesso non siamo noi, ma è qualcun altro o qualcos'altro che ci<br />
sostituisce. Ma è possibile un pensiero che sia interamente nostro,<br />
della cui gestione siamo interamente responsabili? Probabilmente una<br />
consapevolezza totale non è raggiungibile e una parte <strong>di</strong> noi, del<br />
nostro pensiero resta proprietà altrui o <strong>di</strong> dominio pubblico. Se le<br />
varie culture convergono al loro interno su determinati punti, vuol <strong>di</strong>re<br />
che anche gli in<strong>di</strong>vidui che vi appartengono e si riconoscono in esse<br />
partecipano <strong>di</strong> un comune pensiero eterogestito. È un meccanismo<br />
probabilmente selezionato dall'evoluzione biologica a salvaguar<strong>di</strong>a del<br />
gruppo. In tal modo tuttavia sull'evoluzione biologica si è innestata<br />
quella culturale, procedente con tempi più rapi<strong>di</strong>, quin<strong>di</strong> spesso in<br />
conflitto con la vita stessa. Sull'evoluzione culturale si è poi innestata,<br />
come sappiamo, quella tecnologica e da ultimo il progresso<br />
informatico, così da mettere definitivamente in crisi l'unità biologico-<br />
culturale dell'uomo con grave pericolo per la sua sopravvivenza.<br />
Ritengo che solo una riconquistata gestione del pensiero possa<br />
salvarci. Gestione comunque limitata, ma i cui limiti non sono fissati<br />
una volta per tutte, ma sono faticosamente ampliabili. Il pensiero che,<br />
riflettendo su sé stesso, travalica continuamente i propri confini e,<br />
finché riuscirà a farlo, manterrà in vita sé stesso e noi con lui.<br />
Il compito formativo che la società umana ha davanti a sé - questa<br />
almeno è la nostra opinione - non è l'esplorazione dell'universo, o<br />
meglio, lo è nella misura in cui questa coincide con l'esplorazione <strong>di</strong><br />
ciò che ci <strong>di</strong>stingue come società da quelle non umane: il pensiero<br />
riflesso. Ma non si tratta <strong>di</strong> una esplorazione solo conoscitiva, il ???<br />
(p.217) non ci basta più. Occorre che l'autocoscienza responsabile
governi anche le nostre azioni, la nostra progettualità. Penso - ma<br />
non ho nessuna possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrarlo - che, se fossimo capaci <strong>di</strong><br />
autonomia mentale, le nostre decisioni convergerebbero sul<br />
mantenimento della vita alle migliori con<strong>di</strong>zioni possibili.<br />
Ma la via verso questa autonomia è lunga, non sappiamo quanto.<br />
Eppure sappiamo quali ostacoli incontreremo e, ciò che è peggio, se il<br />
punto fin qui raggiunto ci garantisce sufficiente autonomia mentale da<br />
proseguire aggirando la catastrofe. Sono l'eventuale domani ce lo<br />
<strong>di</strong>rà.<br />
Potrebbe sembrare che tabelle sugli stili <strong>di</strong> pensiero più sopra<br />
proposte servano a un nuovo gioco <strong>di</strong> società: il giocatore lancia su<br />
una <strong>di</strong> esse una freccetta che andrà a colpire una certa casella;<br />
questa gli fornirà l'argomento da trattare a parole o per iscritto. La<br />
sua argomentazione verrà <strong>di</strong>scussa in circuito autogenerativo; quin<strong>di</strong><br />
le verrà assegnato un voto da ciascuno dei partecipanti. Vince chi<br />
avrà ottenuto la somma <strong>di</strong> voti più alta. A parità <strong>di</strong> somma la vittoria<br />
verrà assegnata al giocatore più alto (o più pesante o con più<br />
sorelle...).<br />
Un gioco meno frivolo potrebbe essere: tirare ogni giorno la freccia e<br />
riflettere per 15 minuti sull'argomento segnato. Anche con giochi<br />
come questi le tabelle raggiungerebbero il loro scopo: far riflettere su<br />
come riflettiamo, far pensare il pensiero.<br />
Solo a titolo <strong>di</strong> esempio riporto (parzialmente) quanto prodotto da un<br />
gioco condotto in circuito autogenerativo con un gruppo <strong>di</strong> insegnanti<br />
<strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a.
Tabella utilizzata: riflessiva <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo.<br />
Lancio della freccia 6.3. =<br />
Colonna 6 = Stile magico-<strong>di</strong>vinatorio<br />
Riga 3 = Stile causale-lineare/areale<br />
Argomento da considerare: Quali sono le cause che fanno sussistere<br />
nel pieno dell'era tecnologica uno stile magico-<strong>di</strong>vinatorio?<br />
Trattazione fornita dal lanciatore:<br />
"Non credo nel principio <strong>di</strong> causa, soprattutto quando viene applicato<br />
a fenomeni culturali come gli stili <strong>di</strong> pensiero. Penso piuttosto a una<br />
concomitanza <strong>di</strong> fattori contestuali, che tuttavia non producono<br />
necessariamente quel risultato. Tra i fattori che vedrei oggi favorevoli<br />
al conservarsi <strong>di</strong> un pensiero magico nomino:<br />
- l'indebolimento delle ideologie forti (le religioni anzitutto, i credo<br />
politici, i valori morali e civili, le certezze in genere)<br />
- il <strong>di</strong>ffondersi del relativismo culturale che sembra toglierci ogni<br />
appiglio conoscitivo<br />
- la moda degli oroscopi<br />
- una <strong>di</strong>ffusa tendenza regressiva (tipo new age, satanismi...)<br />
- l'effettivo permanere <strong>di</strong> residui arcaici in vasti strati <strong>di</strong> popolazione<br />
(autoctona o immigrata)<br />
- la deresponsabilizzazione dell'in<strong>di</strong>viduo.<br />
Il relativismo e l'indebolimento delle ideologie non sono stati<br />
compensati da un'educazione dell'autonomia in<strong>di</strong>viduale e così a molti<br />
non è restato che rivolgersi a forme irrazionali <strong>di</strong> pensiero. Così anche<br />
l'enorme sviluppo della tecnica, l'accentuazione della modernità in<br />
tutti i suoi aspetti ha prodotto per reazione un regresso culturale
verso una mitica arcaicità, sostenuta da mode più o meno insulse, in<br />
grado però <strong>di</strong> deresponsabilizzare l'in<strong>di</strong>viduo fingendolo dominato da<br />
chissà quali forze sovrannaturali. A queste mode ha contribuito<br />
probabilmente il contatto sempre più stretto con altre culture per le<br />
quali la magia e la superstizione fanno tuttora parte <strong>di</strong> un normale<br />
stile <strong>di</strong> vita".<br />
Discussione.<br />
- A me le religioni non sembrano affatto in declino. Le guerre, le<br />
persecuzioni, le intolleranze che si vedono nel mondo sono tutte, se<br />
non causate, certo fortemente incentivate dalle religioni.<br />
- Stando a ciò che le religioni <strong>di</strong>cono, non vedo la <strong>di</strong>fferenza con la<br />
superstizione. Chi si affida ai santi per risolvere i suoi problemi non<br />
è <strong>di</strong>verso da chi si affida ai tarocchi.<br />
- Poi c'è il risalto che i me<strong>di</strong>a danno in<strong>di</strong>scriminatamente a tutto ciò<br />
che fa notizia e, ahimè, anche proselitismo, come pratiche <strong>di</strong> culto<br />
aberranti, superstizioni...<br />
- ... e c'è il fattore moda, anche questo imputabile in gran parte ai<br />
me<strong>di</strong>a...<br />
- ... ma la moda c'è sempre stata...<br />
- come anche i me<strong>di</strong>a, seppur non potenti come oggi.<br />
- Io non demonizzerei più <strong>di</strong> tanto i me<strong>di</strong>a. Ciò che manca è la<br />
capacità <strong>di</strong> reagire criticamente ad essi...<br />
- ... non si tratta <strong>di</strong> abolire la TV, la ra<strong>di</strong>o, i giornali e nemmeno <strong>di</strong><br />
imporre una censura. Il problema è educativo: né la famiglia né la<br />
scuola sanno formare - come <strong>di</strong>ceva lei prima - all'autonomia del<br />
pensiero.
- E perché non lo sanno fare?<br />
- Perché nessuno li ha formati in tal senso. Nel migliore dei casi la<br />
scuola ti dà una cultura, che tu assumi come verità e, quando ti<br />
accorgi che non lo è, la sostituisci con la prima cosa che ti viene<br />
incontro, anche l'oroscopo <strong>di</strong> un giornaletto o una pratica religiosa<br />
<strong>di</strong> sapore esotico...<br />
- Ciò che conta è che non resti solo. Vanno bene sia la parrocchia che<br />
la tifoseria <strong>di</strong> calcio o il club satanico.<br />
- Ma autonomia non vuol <strong>di</strong>re solitu<strong>di</strong>ne. Al contrario, chi sa pensare<br />
in proprio sa aiutare anche il pensiero altrui. Se l'insegnante <strong>di</strong> oggi<br />
non sa aiutare i suoi alunni a pensare autonomamente è perché<br />
neanche lui lo sa fare...<br />
- ... un problema <strong>di</strong> cui nessuna riforma scolastica sembra<br />
interessarsi...<br />
- ... perché sarebbe una riforma costosa e nessun governante, anzi<br />
nessun politico si vuole seriamente impegnare in un settore così<br />
poco - anzi per niente - red<strong>di</strong>tizio come il settore formativo<br />
- ... a meno che non sia asservito alla produzione <strong>di</strong> ricchezza...<br />
- Come se ne esce?<br />
......<br />
Quasi tutti i circuiti autogenerativi avviati con gli insegnanti si<br />
chiudono melanconicamente con una domanda senza risposta. Gli<br />
insegnanti si rendono ben conto che le cose non vanno, che la scuola<br />
non risponde più alle esigenze della situazione attuale, alle nostre<br />
stesse speranze <strong>di</strong> sopravvivenza, ma "come se ne esce?".
Il gioco, qui riportato nelle sue linee essenziali, ha questa volta<br />
toccato un problema marginale della nostra società, il riaffiorare del<br />
pensiero magico in un'era che vede gran parte dell'antica magia<br />
trasformarsi in tecnologia. Non era mia intenzione puntare sui<br />
contenuti, ma solo dare l'idea <strong>di</strong> come anche un argomento<br />
casualmente scelto con il lancio <strong>di</strong> una freccetta potesse suscitare una<br />
<strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> qualche interesse.<br />
È proponibile questo gioco in una classe elementare un me<strong>di</strong>a? E<br />
quale sarebbe la sua utilità formativa?<br />
Che sia proponibile è <strong>di</strong>mostrabile dal fatto che l'abbiamo proposto più<br />
volte in varie classi. Della sua utilità <strong>di</strong>rò fra poco.<br />
Troppo <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>osa <strong>di</strong> tempo ci è apparsa la costruzione della tabella<br />
iniziale, più utile invece la riflessione preventiva sugli stili <strong>di</strong> pensiero.<br />
In genere i ragazzini ne in<strong>di</strong>viduano non più <strong>di</strong> quattro o cinque, per<br />
esempio:<br />
- lo stile scientifico-matematico (1)<br />
- lo stile fantastico (2)<br />
- lo stile morale (3)<br />
- lo stile riflessivo (4)<br />
- lo stile autoritario (5)<br />
Con questi è facile costruire una tabella riflessiva <strong>di</strong> 16 o 25 caselle<br />
1 2 3 4 5<br />
2<br />
3
4<br />
sulla quale lanciare le frecce.<br />
5<br />
L'argomento suggerito dal lancio della freccia viene brevemente<br />
trattato dal lanciatore, quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>scusso dai ragazzi per tutta l'ora<br />
scolastica. L'insegnante interverrà solo per ricondurre il <strong>di</strong>scorso nei<br />
limiti dell'argomento o per far rispettare i turni <strong>di</strong> intervento,<br />
lasciando qua e là brevi spazi all'accavallarsi delle voci, o infine per<br />
limitare gli interventi soltanto ripetitivi.<br />
In genere i ragazzi reagiscono positivamente a questo gioco che loro<br />
stessi hanno costruito e che ora sentono <strong>di</strong> dover gestire in proprio. Il<br />
tutto viene registrato o ripreso da una telecamera. Meglio sarebbe<br />
tuttavia che qualcuno prenda degli appunti dai quali ricavare poi una<br />
relazione consuntiva.<br />
Se i risultati vengono ritenuti <strong>di</strong> un certo interesse, potranno essere<br />
raccolti e pubblicati per esempio su Internet.<br />
A che dovrebbe servire tutto questo?<br />
Tutti pensiamo, ma siamo poco abituati pensare come. E così altri<br />
finiscono per occupare il nostro pensiero lasciandoci nell'illusione <strong>di</strong><br />
essere noi gli occupanti. E, mentre il vero occupante fa ovviamente gli<br />
interessi suoi, i nostri non li cura più nessuno fin quando non<br />
coincidono con quelli. Di qui la necessità, per l'occupante, <strong>di</strong><br />
convincerci <strong>di</strong> questa coincidenza.<br />
Di qui anche la necessità, per l'occupato, <strong>di</strong> riprendersi la sua<br />
autonomia mentale coltivando la facoltà riflessiva <strong>di</strong> cui siamo dotati
ma che, senza un adeguato esercizio, tende ad atrofizzarsi. E non solo<br />
nell'anziano, ma anche, e forse <strong>di</strong> più, nel cervello giovane, su cui<br />
maggiormente grava la pressione <strong>di</strong> chi ha interesse a limitarne<br />
l'autonomia.<br />
E il nostro gioco mira ad accrescere questa autonomia attraverso<br />
l'esercizio della riflessione: il pensiero a guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> sé stesso e della<br />
sua in<strong>di</strong>pendenza.<br />
5. <strong>Stili</strong> <strong>di</strong> pensiero <strong>di</strong>sturbati<br />
Un grafico ci aiuterà a or<strong>di</strong>nare la materia.<br />
costruttive<br />
esterne normali<br />
<strong>di</strong>struttive<br />
Interferenze patologico<br />
costruttive<br />
interne <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo<br />
<strong>di</strong>struttive<br />
culturale<br />
Chiamiamo interferenza l'azione <strong>di</strong> uno stile mentale su un altro (per<br />
esempio le caselle delle precedenti tabelle<br />
possono essere lette come casi <strong>di</strong> interferenza).
Distinguiamo interferenze esterne (prodotte da stili mentali <strong>di</strong> cui<br />
sono portatori gli altri)<br />
da interferenze interne (prodotte da stili mentali coesistenti<br />
in noi stessi).<br />
Distinguiamo, sia per le interferenze interne che per quelle esterne tra<br />
interferenze costruttive o normali e<br />
interferenze <strong>di</strong>struttive o <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo.<br />
Distinguiamo infine il <strong>di</strong>sturbo in<br />
patologico (dovuto a <strong>di</strong>sfunzioni<br />
nell'attività del cervello)<br />
culturale (dovuto a <strong>di</strong>storsioni<br />
mentali indotte)<br />
Come già osservato in altre occasioni, ai grafici non dobbiamo<br />
chiedere più <strong>di</strong> quanto non possano dare, e lo stesso vale per le<br />
<strong>di</strong>stinzioni, che sono sempre <strong>di</strong> comodo, valgono cioè fin dove non<br />
intervengono considerazioni contrarie. Del resto gli stessi termini <strong>di</strong><br />
cui ci serviamo per <strong>di</strong>stinguere (esterno/interno,<br />
costruttivo/<strong>di</strong>struttivo, patologico/culturale...) non hanno altra<br />
consistenza che la loro più o meno arbitraria funzione <strong>di</strong>stintiva.<br />
Potremmo affermare capovolgendo il comune sentire, che il mondo<br />
rispecchia il linguaggio con cui lo descriviamo ovvero la mente che lo<br />
pensa.<br />
Ma qui non è questione <strong>di</strong> filosofia ma <strong>di</strong> analisi pratiche che ci<br />
servano nel rapportarci gli uni agli altri. E, poiché questi rapporti, per<br />
le ragioni che sappiamo, hanno da essere pacifici, cerchiamo, per
quanto possibile, <strong>di</strong> astenerci dal valutare i due corni <strong>di</strong> ogni<br />
<strong>di</strong>stinzione affinché l'uno <strong>di</strong> essi non si trasformi in <strong>di</strong>scriminazione<br />
verso l'altro.<br />
In questo capitolo prenderemo in considerazione solo le ultime<br />
<strong>di</strong>stinzioni, quelle tra interferenze normali e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo e tra <strong>di</strong>sturbo<br />
patologico e culturale.<br />
5.1. Interferenze normali<br />
Cominciamo col <strong>di</strong>sturbare lo stesso grafico da cui inten<strong>di</strong>amo partire.<br />
Nel concetto <strong>di</strong> normalità rientrano sia l'aspetto costruttivo che quello<br />
<strong>di</strong>struttivo dell'interferenza purché tra i due vi sia equilibrio (<strong>di</strong> questo<br />
ci occuperemo nel capitolo seguente). Assegnare la qualifica <strong>di</strong><br />
normalità al solo aspetto costruttivo è pertanto già una forzatura,<br />
legata all'interpretazione banale della normalità come illimitato<br />
accrescimento <strong>di</strong> benessere. Un primo passo avanti verso una<br />
riconsiderazione critica della normalità sarebbe già includervi una<br />
adeguata porzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>struttività (tra cui la morte in<strong>di</strong>viduale).<br />
Ogni scambio comunicazionale, quale che sia il linguaggio usato e<br />
quale ne sia il contenuto dovrebbe quin<strong>di</strong> rientrare nel concetto <strong>di</strong><br />
normalità. Già il farne un'interferenza suona male per chi non è<br />
abituato all'uso scientifico del termine (per esempio nell'ottica). Sarà<br />
bene quin<strong>di</strong> chiarire anzitutto che, come qui l'inten<strong>di</strong>amo, il termine<br />
interferenza non è già <strong>di</strong> per sé stesso sinonimo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo, come<br />
nell'uso comune, ma designa solo un'azione mo<strong>di</strong>ficante <strong>di</strong> un segnale
su un altro, qui <strong>di</strong> uno stile <strong>di</strong> pensiero su un altro. Il che è del tutto<br />
normale quando due stili si incontrano sia tra menti <strong>di</strong>verse che<br />
all'interno <strong>di</strong> una stessa mente, come abbiamo visto nelle tabelle<br />
riflessive <strong>di</strong> cui nel paragrafo precedente.<br />
Fin qui niente che infici il concetto <strong>di</strong> normalità. Lo stile mentale <strong>di</strong><br />
ognuno sfugge alle categorializzazioni proposte nei capitoli 3. e 4. o<br />
anche possiamo vedervi una composizione singola <strong>di</strong> vari stili,<br />
composizione per giunta variabile nel tempo. Già l'arrivo <strong>di</strong> una<br />
qualsiasi comunicazione, il contatto anche momentaneo con uno stile<br />
<strong>di</strong>verso può mo<strong>di</strong>ficarla. Di regola la mente reagisce positivamente a<br />
queste mo<strong>di</strong>ficazioni - si è evoluta proprio per accoglierle -: ed è la<br />
normalità. In certi casi però la reazione è negativa, <strong>di</strong> rigetto: ecco il<br />
<strong>di</strong>sturbo, che non risiede quin<strong>di</strong> nella <strong>di</strong>versità in quanto tale, ma<br />
nell'in<strong>di</strong>sponibilità all'accoglienza.<br />
5.2. Interferenze <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo<br />
Nei casi più gravi queste interferenze possono effettivamente<br />
<strong>di</strong>ventare <strong>di</strong>struttive e le <strong>di</strong>struzioni riguardare l'una o l'altra o<br />
ambedue le menti collidenti. È possibile però anche formare o<br />
trasformare le menti, così da rinormalizzare il <strong>di</strong>sturbo?<br />
La domanda è complessa e anche la risposta non potrà che esserlo.<br />
La casistica dei <strong>di</strong>sturbi e delle reazioni ad essi è innumerabile e<br />
sarebbe assurda ogni pretesa <strong>di</strong> esaurirla. Il punto non è trovare una<br />
soluzione a ogni caso, ma registrare il problema e avviare dei
programmi per affrontarlo. In ambito psicologico il problema lo si è<br />
posto, degli stu<strong>di</strong> sono stati fatti, dei programmi avviati. In ambito<br />
formativo sia fatto poco o nulla. Generici appelli alla tolleranza del<br />
<strong>di</strong>verso, qualche accenno alla necessità biologica del <strong>di</strong>verso... e poco<br />
più. Perché questo <strong>di</strong>vario? È presto detto: curare le singole devianze<br />
psichiche costa poco allo stato, molto alle famiglie; curare la<br />
formazione <strong>di</strong> tutti i citta<strong>di</strong>ni costerebbe moltissimo allo stato, che ha<br />
ben altre priorità. Oggi, con la devolution (in italiano: devoluzione), la<br />
privatizzazione, la aziendalizzazione perfino della scuola, c'è da<br />
sperare in una maggiore attenzione per questo problema? Le regioni, i<br />
privati, le aziende non hanno anche loro ben altre priorità?<br />
Non ho alcuna intenzione <strong>di</strong> insistere in queste inutili querimonie. O ci<br />
si renderà conto della necessità <strong>di</strong> una riforma ra<strong>di</strong>cale e universale<br />
del sistema formativo o sarà molto <strong>di</strong>fficile evitare<br />
l'autoannientamento. La cosa, comunque, non mi riguarda più.<br />
Ma ritorniamo al nostro schema e puntiamo il <strong>di</strong>to su:<br />
5.2.1. Il <strong>di</strong>sturbo patologico<br />
Il lettore non si aspetti nulla <strong>di</strong> men che ovvio su questo punto, non<br />
essendo nessuno nel nostro Centro né psicologo, né psichiatra, né<br />
psicanalista. Più d'uno avrà certo avuto a che fare con un esponente<br />
<strong>di</strong> quest'ultima categoria, tuttora assai visitata; alcuni sono insegnanti<br />
<strong>di</strong> sostegno, altri frequentano corsi <strong>di</strong> counselling, nessuno però<br />
esercita una delle summenzionate professioni. Tra i nostri<br />
collaboratori esterni ve ne sono <strong>di</strong> seriamente impegnati sul versante
psichico della formazione. Uno in particolare vorrei nominare per il<br />
notevole apporto dato alle comuni ricerche: <strong>Mauro</strong> <strong>Scardovelli</strong>, cui<br />
de<strong>di</strong>co il presente scritto. Oltre all'amicizia personale, molto mi lega<br />
alla sua esperienza. Chi la conosce non potrà fare a meno <strong>di</strong> notare<br />
quanta parte <strong>di</strong> essa si riflette anche nelle righe <strong>di</strong> questo libro che, al<br />
suo termine, desidero sottoporre alla competenza <strong>di</strong> <strong>Mauro</strong>, certo<br />
assai più specifica della mia.<br />
Come già detto altrove, il mio strano modo <strong>di</strong> lavorare mi conduce<br />
spesso in territori estranei, o meglio, che estranei non sono a me<br />
come persona, giacché sono territori comuni a tutti, ma sui quali non<br />
ho alcuna particolare informazione se non quella acquisita per sentito<br />
<strong>di</strong>re; e, naturalmente, l'informazione ricavata per esperienza <strong>di</strong>retta e<br />
quella accessibile a chiunque attraverso la riflessività del pensiero.<br />
Ripeto queste cose per prevenire il lettore, ma soprattutto per<br />
invitarlo a confrontare ciò che qui sta leggendo con le più autorevoli<br />
opinioni degli esperti <strong>di</strong> settore.<br />
Ho definito come patologico e il <strong>di</strong>sturbo mentale dovuto a <strong>di</strong>sfunzioni<br />
nell'attività del cervello. Non è granché come definizione in quanto<br />
non è specificato che cosa si intende per <strong>di</strong>sfunzione. Immagino cose<br />
del genere:<br />
- non sono più sicuro che due più due faccia quattro<br />
- non ricordo come mi chiamo<br />
- confondo il cane con la pulce che lo abita<br />
- credo nei fantasmi<br />
......
Con un po' <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinvoltura questo tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sfunzioni potrebbero<br />
attribuirsi a <strong>di</strong>fetto o eccesso <strong>di</strong> cultura anziché a patologie. Così il<br />
dubbio su 2+2 potrebbe cogliere chi ha ripercorso fino in fondo la<br />
<strong>di</strong>mostrazione del teorema <strong>di</strong> incompletezza enunciata per la logica da<br />
Kurt Gödel, e l'essermi <strong>di</strong>menticato il mio nome può <strong>di</strong>pendere dal<br />
fatto che mi chiamo <strong>di</strong> rado... e così via.<br />
Supponiamo tuttavia <strong>di</strong> riuscire a in<strong>di</strong>viduare la patologia da cui<br />
<strong>di</strong>pende una certa <strong>di</strong>sfunzione. È curabile questa patologia? Ma che<br />
vuol <strong>di</strong>re curabile: che è riconducibile alla normalità? Normalità <strong>di</strong> chi?<br />
Certo non la sua (per lui è normale il suo stato patologico).<br />
Normalità come valore me<strong>di</strong>o calcolato su un alto numero <strong>di</strong><br />
osservazioni. Osservazioni condotte dove: tra i visitatori <strong>di</strong> Lourdes o<br />
tra i fondamentalisti talebani o in una tifoseria <strong>di</strong> ultras?<br />
Supponiamo ancora (ma quante ipotesi tocca fare!) che ci siamo<br />
accordati sul concetto <strong>di</strong> normalità e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> devianza psicologica.<br />
Ripeto la domanda: è curabile questa devianza?<br />
Qui le risposte variano a seconda delle <strong>di</strong>agnosi e delle ipotesi<br />
classificatorie sottostanti alle <strong>di</strong>agnosi: schizofrenia, ebefrenia, stato<br />
paranoide ecc. E anche le cure proposte oscillano tra la<br />
somministrazione <strong>di</strong> farmaci e il trattamento psichiatrico o<br />
psicoanalitico secondo il tale o tale in<strong>di</strong>rizzo. Un tempo i casi più gravi<br />
venivano ricoverati (non certo curati) nei manicomi. Oggi non lo si fa<br />
più, ma i problemi sono rimasti, forse anche ulteriormente aggravati.<br />
Non entro in merito alle <strong>di</strong>verse soluzioni; mi limito a riportare una<br />
favoletta evolutiva <strong>di</strong> qualche anno fa:
Con l'ultima guerra nucleare la finora sopravvissuta razza dell'Homo<br />
sapiens, la vetta evolutiva raggiunta dalla vita sul nostro pianeta, si è<br />
estinta. Solo all'interno della foresta amazzonica vive ancora una<br />
tribù, rimasta isolata da molti secoli e psichicamente arretrata a livello<br />
<strong>di</strong> un han<strong>di</strong>cappato <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a gravità. Da questa tribù ci si aspetta il<br />
ripopolamento del pianeta. La domanda è: qual è la razza umana<br />
biologicamente vincente: l'Homo sapiens che con la sua superiore<br />
intelligenza si è auto<strong>di</strong>strutto, o la superstite razza che l'ultimo<br />
sapiens considererebbe <strong>di</strong>sabile?<br />
Con ciò non voglio affatto negare l'ipotesi darwiniana e tanto meno il<br />
mirabile grado evolutivo raggiunto dal cervello umano. Penso però<br />
che questo cervello avrebbe tutto da guadagnare se imparasse a<br />
relativizzare sé stesso e le sue capacità. Non è affatto detto che chi<br />
viene socialmente considerato demente o minorato psichico lo sia<br />
anche in termini <strong>di</strong> sopravvivenza. Potrebbe darsi che proprio la<br />
nostra normalità sia soccombente e la sua no. Quin<strong>di</strong>, prima <strong>di</strong><br />
sforzarci a normalizzare lui, pensiamoci due volte. Potremmo farne un<br />
infelice se già non l'abbiamo fatto. Non è l'omologazione delle nostre<br />
normalità il fine del nostro intervento, ma l'equiparazione delle loro<br />
<strong>di</strong>versità. Cose, queste, oggi comunemente riconosciute da chiunque<br />
lavori in campo psichiatrico, almeno così spero e credo. Analoghe<br />
riflessioni dovrebbe però fare chi punta sulla meritocrazia. Già le<br />
<strong>di</strong>scriminazioni apportate dal voto e dagli esami scolastici possono<br />
produrre ferite psichiche <strong>di</strong>fficilmente rimarginabili e colpire i soggetti<br />
più deboli, non quelli meno capaci. Non sempre la vita si incaricherà a<br />
compensare l'aggressione della se<strong>di</strong>cente normalità.
5.2.2. Il <strong>di</strong>sturbo culturale<br />
È la forma più <strong>di</strong>ffusa <strong>di</strong> interferenza <strong>di</strong>struttiva da parte <strong>di</strong> una<br />
cultura su un'altra o, più modestamente, <strong>di</strong> uno stile <strong>di</strong> pensiero su un<br />
altro. Va subito precisato che il termine <strong>di</strong>struttivo riflette il punto <strong>di</strong><br />
vista <strong>di</strong> chi si sente <strong>di</strong>sturbato, non certo <strong>di</strong> chi <strong>di</strong>sturba. Un<br />
musulmano avverte come un forte <strong>di</strong>sturbo le vignette satiriche su<br />
Maometto pubblicate in Occidente reagisce <strong>di</strong>sturbando a sua volta la<br />
cattiva coscienza degli occidentali. Bush e i suoi alleati <strong>di</strong>sturbano<br />
(con le armi) la cultura dei talebani - che contempla la lapidazione<br />
delle adultere ma non degli adulteri - e quelli rispondono appoggiando<br />
il terrorismo.<br />
Il terrorismo stesso, del resto, non è che una risposta culturale<br />
impropria (che noi consideriamo impropria) al sistematico <strong>di</strong>sturbo<br />
(economico, culturale, religioso) che noi infliggiamo alle popolazioni<br />
del terzo mondo.<br />
[Forse si potrebbero trovare dei mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> interazione e <strong>di</strong>versi<br />
dall'interferenza armata.]<br />
Anche le interferenze costruttive - come quelle che la religione<br />
pretende siano le missioni con le conversioni forzate - vengono<br />
vissute <strong>di</strong>versamente da chi le subisce. Così la civilizzazione apportata<br />
dal colonialismo si è <strong>di</strong>mostrata un <strong>di</strong>sturbo culturale tra i peggiori:<br />
l'urbanizzazione, la corsa al guadagno, l'AIDS, la corruzione <strong>di</strong>lagano<br />
come non mai, mentre i malanni endemici, la fame, la sete, le rivalità
tribali, gli o<strong>di</strong> interetnici sono ben lungi dall'essere estirpati. Anche in<br />
paesi ricchissimi <strong>di</strong> risorse naturali le economie locali, più che<br />
<strong>di</strong>sturbate, sono state travolte dalla rapacità dell'economia capitalista.<br />
Sono cose ben note a chiunque abbia mai aperto un giornale o acceso<br />
una televisione. La cultura vincente - quella euroamericana del<br />
mercato e del consumo - ha oggi contaminato tutte le altre, alcune<br />
delle quali aspirano al primato mon<strong>di</strong>ale, senza peraltro abbandonare<br />
il pericoloso modello (quanto sia pericoloso non è più un mistero per<br />
nessuno).<br />
I politici - per lo meno alcuni - cercano <strong>di</strong> andare alla ra<strong>di</strong>ce degli<br />
enormi problemi culturali, economici, sociali cui questo modello<br />
espone l'umanità intera, ma quella che per loro è la ra<strong>di</strong>ce è ancora<br />
assai lontana dal terreno che potrebbe alimentare un <strong>di</strong>verso modello.<br />
È nostra convinzione - fortunatamente non solo nostra - che la nostra<br />
eventuale sopravvivenza non <strong>di</strong>penda dagli epifenomeni economici,<br />
culturali, sociali che caratterizzano la superficie del nostro pianeta<br />
antropizzato.<br />
In questo lo stile <strong>di</strong> pensiero che abbiamo chiamato metaculturale si<br />
<strong>di</strong>scosta dal modello marxiano, <strong>di</strong> cui peraltro con<strong>di</strong>vide molteplici<br />
aspetti. Le strutture profonde che sorreggono la nostra società vanno<br />
indagate, al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> quegli epifenomeni, ai livelli del pensiero che li<br />
riflettono nella consapevolezza. I sistemi economici, culturali, sociali<br />
tendono a consolidarsi come autonomi nei confronti del pensiero,<br />
giganteschi meccanismi automatizzati che del pensiero possono fare a<br />
meno perchè paghi <strong>di</strong> quello già investito in essi. Laddove il pensiero<br />
è anzitutto mobilità, continua interferenza <strong>di</strong> una parte sull'altra e, se
si vuole, <strong>di</strong>sturbo nel duplice senso, costruttivo e <strong>di</strong>struttivo. Un<br />
pensiero incapace <strong>di</strong> <strong>di</strong>struggere sé stesso per ricostruirsi in altra<br />
forma non è buon garante <strong>di</strong> sopravvivenza. E noi questo gli<br />
chiederemo: che si accorga del vicolo cieco in cui si è cacciato e che si<br />
<strong>di</strong>a da fare per uscirne.<br />
Tra le tante cose che si possono <strong>di</strong>re sul <strong>di</strong>sturbo culturale c'è che<br />
esso è uno sport assai praticato, anche per la sod<strong>di</strong>sfazione che<br />
produce in chi lo pratica. È molto più intrigante contrad<strong>di</strong>re<br />
l'interlocutore che assecondarlo nelle sue argomentazioni. E così,<br />
anche se ci trovassimo d'accordo con lui, questo basterebbe in molti<br />
casi a farci cambiare idea, almeno momentaneamente. Le polemiche,<br />
spesso così fasti<strong>di</strong>ose per chi non vi partecipa, sono all'or<strong>di</strong>ne del<br />
giorno nel mondo della politica, dove appaiono tanto più aspre quanto<br />
più i punti <strong>di</strong> vista oggi adottati dagli uni somigliano a quelli ieri<br />
proclamati dagli altri. Se si trattasse solo <strong>di</strong> un gioco atto a sollecitare<br />
il pensiero, così come nelle scuole <strong>di</strong> retorica si praticava il<br />
contrad<strong>di</strong>ttorio in<strong>di</strong>pendentemente dalle convinzioni dei <strong>di</strong>aloganti, il<br />
<strong>di</strong>sturbo pianificato andrebbe anche bene. Quando però paralizza il<br />
<strong>di</strong>alogo e impe<strong>di</strong>sce la decisione, il <strong>di</strong>sturbo andrebbe controllato o<br />
ad<strong>di</strong>rittura evitato per autonoma rinuncia. Per contro un parere<br />
<strong>di</strong>verso non andrebbe interpretato come un <strong>di</strong>sturbo solo per la sua<br />
<strong>di</strong>versità. L'introiezione critica del <strong>di</strong>verso spesso arricchisce il<br />
pensiero molto più che non la irriflessa opposizione. La - temporanea<br />
e metodologica (non ideologica) - immedesimazione con un pensiero
non nostro ci regala un punto <strong>di</strong> vista che talvolta si aggiunge al<br />
nostro senza <strong>di</strong>sturbarlo, anzi offrendogli un'alternativa insospettata.<br />
Il <strong>di</strong>sturbo culturale fa comunque parte della quoti<strong>di</strong>anità e sta a noi<br />
sentircene colpiti riinterpretarlo positivamente come occasione <strong>di</strong><br />
riflessione e <strong>di</strong> arricchimento.<br />
Il danno che un forte <strong>di</strong>sturbo culturale può provocare è tanto<br />
maggiore quanto minore è l'elasticità mentale del ricevente. Un<br />
cattolico o un musulmano fondamentalista percepiscono come<br />
aggressione ciò che altri avvertirebbero si e no come un blando<br />
<strong>di</strong>sturbo. E reagiscono <strong>di</strong> conseguenza. E il danno reciproco che ne<br />
deriva sappiamo che può essere incalcolabile.<br />
La prevenzione deve quin<strong>di</strong> seguire un duplice in<strong>di</strong>rizzo:<br />
- limitare lo sport del <strong>di</strong>sturbo culturale<br />
- accrescere l'elasticità mentale della popolazione.<br />
Ambedue queste prevenzioni ricadono su sistema formativo. Non<br />
bastano gli inviti moralistici al rispetto reciproco così come non basta,<br />
per prevenire l'uccisione <strong>di</strong> un commissario <strong>di</strong> polizia davanti allo<br />
sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Catania, pre<strong>di</strong>care i giovani ultras che le forze dell'or<strong>di</strong>ne<br />
sono garanti <strong>di</strong> sicurezza, quando è proprio la sicurezza che quelli<br />
rifiutano. (E altrettanto è inutile colpevolizzare le famiglie dopo che i<br />
fatti sono successi, quando i mass me<strong>di</strong>a non fanno che incentivare<br />
una irriflessa passione per il calcio e propagandare attraverso<br />
l'immagine l'uso in<strong>di</strong>scriminato della violenza.)<br />
Basterebbe allora, per prevenire risposte violente, accrescere<br />
l'elasticità mentale degli in<strong>di</strong>vidui affinché non cedano alle
provocazioni? Ammettiamolo pure; ma come si rende più elastica una<br />
mente? E chi lo deve fare?<br />
Le in<strong>di</strong>cazioni in questo senso non mancano, ma non mancano<br />
neppure le forze che fieramente si oppongono a una elasticizzazione<br />
della mente, a cominciare dalla Chiesa e da quei partiti politici che per<br />
convinzione od opportunità le si accodano (quasi tutti). Il guaio è che<br />
l'uso della forza, giustamente negato a chi <strong>di</strong>sturba culturalmente, è<br />
liberamente ammesso - in un senso non necessariamente fisico, ma<br />
soprattutto culturale-me<strong>di</strong>atico - in chi si sente <strong>di</strong>sturbato.<br />
Se inseguiamo da destra a sinistra le linee del grafico che apre questo<br />
capitolo, da culturale (<strong>di</strong>sturbo), attraverso <strong>di</strong>struttive (interferenze)<br />
arriviamo alla coppia esterne/interne. Un'interferenza esterna del<br />
nostro modo <strong>di</strong> pensare può essere oltremodo fasti<strong>di</strong>osa, ad<strong>di</strong>rittura<br />
pericolosa. Un regime <strong>di</strong>ttatoriale che interferisca col pensiero <strong>di</strong> chi<br />
non ne accetta l'impostazione può provocare la morte, come sanno i<br />
citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> quasi tutti i paesi. Eppure l'interferenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo più<br />
<strong>di</strong>struttiva è quella interna, che agisce, non in forza <strong>di</strong> un potere che<br />
ci sovrasta, ma ad opera del nostro stesso cervello: un dubbio che si<br />
insinua nella mente, un'ideologia che vacilla, una certezza non più<br />
tale...<br />
Sono esperienze che tutti abbiamo fatto, ma che non tutti abbiamo<br />
riflesso positivamente. In alcuni il <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o interno si è <strong>di</strong>mostrato<br />
devastante portando a una sorta <strong>di</strong> schizofrenia culturale in grado <strong>di</strong><br />
contagiare intere popolazioni, si vedano i casi del fascismo-nazismo e
del comunismo reale, dagli effetti assai simili anche se prodotti da<br />
premesse antitetiche.<br />
Ma è sensata la <strong>di</strong>cotomia esterno/interno?<br />
Ricordo una riflessione collettiva, in una seconda elementare, su<br />
questa <strong>di</strong>cotomia applicata all'esperienza sonora. Si trattava <strong>di</strong><br />
classificare i suoni percepiti in interni/esterni all'aula: non sono <strong>di</strong><br />
clacson è stato classificato come esterno, mentre la voce<br />
dell'insegnante come interna. Tutto è andato bene fin quando un<br />
bambino non ha osservato che tutti i suoni u<strong>di</strong>ti erano per forza <strong>di</strong><br />
cose interni dal momento che li avevano u<strong>di</strong>ti dentro l'aula. Quel<br />
giorno correggemmo i presupposti dell'esperienza <strong>di</strong>stinguendo tra<br />
suono e sorgente sonora.<br />
Tornando al caso nostro, le interferenze esterne possono restare tali,<br />
quali che siano le conseguenze. Il più delle volte però penetrano nella<br />
nostra mente fino a interferire dall'interno.<br />
Un cristiano che si converte all'Islam dovrà questa conversione<br />
inizialmente a un'interferenza esterna, per un certo periodo<br />
combatterà presumibilmente con la stessa interferenza interiorizzata,<br />
fino a capovolgere la situazione e avvertire come interferenza<br />
residuale la fede precedente.<br />
Di quanto poco sia <strong>di</strong>fen<strong>di</strong>bile l'altra antinomia, tra interferenza<br />
costruttiva e <strong>di</strong>struttiva già si è detto. E così anche l'opposizione<br />
"schizofrenia patologica/culturale" è assai meno netta <strong>di</strong> come si<br />
potrebbe pensare, visto che non pochi, considerati pazzi in vita, da<br />
morti sono <strong>di</strong>ventati gran<strong>di</strong> pensatori e artisti. Qualche volta - ed è il<br />
caso <strong>di</strong> Hölderlin, Schumann, Nietzsche, Wolf - dei poeti, musicisti,
filosofi in vita, l'hanno conclusa in stato demenziale. (È singolare che<br />
questi casi si siano affollati nella Germania degli ultimi due secoli<br />
permettendo a Thomas Mann <strong>di</strong> costruire con il suo Doktor Faustus il<br />
mito <strong>di</strong> una cultura votata alla <strong>di</strong>sintegrazione della follia.)<br />
Il lettore avrà notato come ogni volta che per una ragione o l'altra mi<br />
servo <strong>di</strong> una <strong>di</strong>cotomia o più in generale <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinzioni,<br />
corro subito ai ripari, quasi a chiudere una falla che potrebbe rivelarsi<br />
pericolosa. Cerco io stesso <strong>di</strong> capire perché è così. Gioca forse<br />
l'influsso della coincidentia oppositorum, cara ai mistici e, attraverso<br />
loro, anche a me; oppure è la convinzione che ogni <strong>di</strong>stinguo è frutto<br />
<strong>di</strong> riduzionismo, semplifica cioè indebitamente la nostra esperienza del<br />
mondo separando ciò che separabile non è, e lo fa con la cattiva<br />
coscienza <strong>di</strong> chi sa <strong>di</strong> supplire in tal modo solo a una comprensione<br />
insufficiente. Ma quale sarebbe una comprensione sufficiente?<br />
Anche l'ipotesi che sorregge questo scritto è riduzionistica.<br />
Ricaveremmo dal mondo delle informazioni con cui costruirci una<br />
prima immagine; su questa interviene la riflessione producendo una<br />
seconda immagine, quin<strong>di</strong> un ulteriore riflessione ne produce una<br />
terza e così via. Graficamente:
Ogni immagine è ovviamente <strong>di</strong>versa dalla precedente e, dopo un<br />
certo numero <strong>di</strong> riflessioni, non è detto abbia più alcuna somiglianza<br />
con la prima. Così l'immagine del mondo che ci danno le riflessioni<br />
scientifiche succedutesi dopo l'immagine newtoniana non hanno più<br />
niente in comune con quella trasmessaci dai sensi e che Newton<br />
aveva cercato <strong>di</strong> interpretare.<br />
Già così l'ipotesi è assai complessa. Il riduzionismo consiste<br />
nell'ipotizzare che il mondo ci invii una informazione unica, coerente e<br />
stabile. Mentre è assai probabile:<br />
- che questa immagine non sia unitaria (saremmo noi a unificarla<br />
nella percezione)<br />
- che non sia coerente (sarebbe il meccanismo logico della mente a<br />
renderla tale)<br />
- che non sia stabile nel tempo (la stabilizzerebbe il cervello<br />
oggettivizzando il tempo).<br />
Potrebbe essere che le varie parti del mondo, ad<strong>di</strong>rittura ogni suo<br />
costituente elementare - posto che esistano - ci invii delle
informazioni tra loro contrad<strong>di</strong>ttorie e instabili... E ancora: chi ci <strong>di</strong>ce<br />
che anche il nostro cervello rifletta le immagini unitariamente e<br />
coerentemente? Sappiamo solo che a noi unitarietà, coerenza e<br />
durevolezza fanno comodo, che le immagini così elaborate, per<br />
<strong>di</strong>verse che siano, ci permettono <strong>di</strong> comunicare e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> vivere. Non<br />
per nulla il punto <strong>di</strong> forza <strong>di</strong> IMC non sta nel numero dei livelli<br />
attraversati dalla catabasi metaculturale, cioè da quanto siamo<br />
progre<strong>di</strong>ti nella conoscenza, ma nell'arresto. E in questa capacità <strong>di</strong><br />
fermare la necessità al livello che attualmente ci serve sta la nostra<br />
speranza <strong>di</strong> sopravvivere. L'infinita parte residua della catabasi non<br />
serve all'oggi ma al domani e la vita si svolge in un perenne oggi.<br />
Capisco bene che quanto sto <strong>di</strong>cendo troverà molti lettori in<br />
<strong>di</strong>saccordo e forse anch'io lo sarò tra breve. Si parlava <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo<br />
culturale. I maggiori artefici <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbi culturali siamo noi stessi<br />
quando pensiamo, cioè sempre. Quando il nostro pensiero è lasciato<br />
libero dagli obblighi imposti dalla logica e dall'imperativo della<br />
coerenza, cioè nel sogno o nella follia, scompaiono anche i <strong>di</strong>sturbi<br />
culturali... O forse no, e continuano a interferire con il nostro pensiero<br />
sotto forma <strong>di</strong> incubi o paranoie. Al punto che potrebbe sorgere il<br />
sospetto che sia il nostro abituale modo <strong>di</strong> pensare, con tutte le<br />
restrizioni cui la cultura (l'UCL) lo sottopone, il vero <strong>di</strong>sturbo cui la<br />
mente tenta invano <strong>di</strong> sottrarsi evadendo nel sogno fisiologico o<br />
artificiale.
6. Rilevamento ed equilibrazione degli stili <strong>di</strong> pensiero<br />
- Generalità<br />
Rispetto ad altri lavori prodotti dal CMC e da me personalmente,<br />
questo sugli stili <strong>di</strong> pensiero ha tutta l'aria <strong>di</strong> essere assai più una<br />
trattazione teorica che un manuale pratico. La riflessione teorica ha<br />
indubbiamente un ruolo <strong>di</strong> grande rilievo anche in progetti formativi<br />
come i nostri. Di regola tuttavia la sua presenza non ha carattere<br />
autocelebrativo ma, per così <strong>di</strong>re, <strong>di</strong> servizio. Perfino la stesura <strong>di</strong> IMC<br />
e delle linee-guida che ne derivano non occupano in genere che poche<br />
decine <strong>di</strong> pagine (esistono peraltro trattazioni più ampie, mai<br />
pubblicate). Questo scritto sembra invece compiacersi <strong>di</strong> sé stesso e<br />
non esibisce chiari collegamenti con l'in<strong>di</strong>rizzo formativo che ci è<br />
proprio. La cosa può apparire tanto più gratuita in quanto le riflessioni<br />
qui esposte non godono dell'appoggio <strong>di</strong> alcuna riconosciuta autorità.<br />
Posso forse contare su occasionali convergenze (<strong>di</strong> alcune sono stato<br />
cortesemente informato da amici competenti), ma queste non sono<br />
certo sufficiente fare <strong>di</strong> questo libro un testo scientifico cui concedere<br />
il necessario cre<strong>di</strong>to.<br />
Ciononostante voglio tentare in quest'ultimo capitolo quel raccordo<br />
con la pratica formativa che, programmato fin dall'inizio, sembra<br />
essersi perso lungo la strada in favore <strong>di</strong> una gratuita autonomia.
Possono le considerazioni qui squadernate essere <strong>di</strong> qualche utilità nei<br />
percorsi formativi?<br />
In quelli specializzanti - oggi i più richiesti - penso <strong>di</strong> no. Questi<br />
tuttavia presuppongono - oggi forse più <strong>di</strong> ieri - un percorso basilare,<br />
comune a tutti, al quale le nostre considerazioni credo possano dare<br />
un contributo essenziale.<br />
Cominciamo dalla <strong>di</strong>stinzione primaria, sulla cui arbitrarietà e<br />
inconsistenza scientifica mi sono soffermato più volte. Perché<br />
<strong>di</strong>stinguere stili <strong>di</strong> pensiero dai confini incerti e mai riscontrabili allo<br />
stato puro? E perché questi e non altri? E perché ripartirli in due<br />
categorie, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e modali?<br />
Qui conviene chiarirci con noi stessi e con gli eventuali lettori. Quali<br />
sono le finalità <strong>di</strong> una trattazione come questa? Non certo <strong>di</strong><br />
informare su uno stato <strong>di</strong> cose, presunto o reale, quando la materia<br />
trattata - il pensiero - neppure sappiamo se conosce uno stato o sia in<br />
perenne movimento. Potremmo invero assumere gli stili qui elencati<br />
come ipotesi su cui sviluppare una teoria più o meno coerente. Ma<br />
anche questa non sembra rientrare tra le nostre finalità, altrimenti<br />
una teoria del genere l'avremmo sviluppata. Mentre ciò a cui siamo<br />
pervenuti non è che un gioco, simile alla battaglia navale della nostra<br />
infanzia. E allora?<br />
Forse tutto l'insieme possiamo considerarlo un gioco che, come i<br />
giochi dei bambini, sono anche un esercizio della mente. Gli stili<br />
mentali qui in<strong>di</strong>viduati sarebbero come le figure degli scacchi, le cui<br />
funzioni e il cui movimenti sono determinati da regole arbitrarie. Il<br />
parallelo non calza del tutto perché le figure degli scacchi sono
nettamente, oggettivamente <strong>di</strong>stinte, mentre le <strong>di</strong>stinzioni operate tra<br />
gli stili <strong>di</strong> pensiero, sono critiche, non oggettive. Per critico intendo<br />
<strong>di</strong>pendente da un punto <strong>di</strong> osservazione, interno alla mente. In altre<br />
parole, niente <strong>di</strong> oggettivo, ma un'immagine mutevole, instabile, in<br />
continua trasformazione. La finalità ultima, non solo in questa<br />
indagine ma <strong>di</strong> tutto il nostro lavoro, non è filosofica né conoscitiva,<br />
ma essenzialmente volta all'attivazione del pensiero. Non è neppure<br />
molto importante la <strong>di</strong>rezione verso cui il pensiero si attiva, purché<br />
non resti inattivo sul già acquisito, come il drago Faffner a guar<strong>di</strong>a del<br />
tesoro.<br />
Comunque si vogliano classificare gli stili <strong>di</strong> pensiero, ognuno <strong>di</strong> noi ne<br />
ha sostanzialmente a <strong>di</strong>sposizione parecchi: il punto è portarli a<br />
consapevolezza attraverso la riflessione e renderli <strong>di</strong>sponibili<br />
attualmente. La nostra stessa in<strong>di</strong>vidualità si comincia a pensare che<br />
sia pluralistica. Dopotutto la biologia ci descrive come un insieme (una<br />
colonia?) <strong>di</strong> cellule dotate, nonostante la <strong>di</strong>fferenziazione al servizio <strong>di</strong><br />
una totalità organica, <strong>di</strong> una certa autonomia, massima nelle cellule<br />
staminali. (Curiosamente qui autonomia significa <strong>di</strong>sponibilità a una<br />
pluralità <strong>di</strong> servizi.) Potrebbe quin<strong>di</strong> essere che gli stili mentali<br />
<strong>di</strong>pendano da una sorta <strong>di</strong> decisione <strong>di</strong> maggioranza in quel<br />
parlamento cellulare che chiamiamo cervello. Ma anche le<br />
maggioranze cambiano, anzi la democrazia si basa proprio<br />
sull'alternanza delle maggioranze. E così potrebbe accadere nel nostro<br />
cervello. Una delle finalità del nostro lavoro - e <strong>di</strong> questo libro -<br />
sarebbe quin<strong>di</strong> la democratizzazione della mente, il che vorrebbe <strong>di</strong>re
affrancarla dalle costrizioni ideologiche e dallo stile dogmatico,<br />
restituendo a lei e alle sue cellule l'autonomia cui aspiriamo.<br />
Ma, sarà vero che le menti e le cellule che ne regolano il<br />
funzionamento aspirano all'autonomia?<br />
Molti in<strong>di</strong>zi lasciano credere che non sia così. La facilità con cui tutti<br />
noi ca<strong>di</strong>amo nelle trappole dell'ideologia e del dogma starebbe a<br />
<strong>di</strong>mostrare che la mente preferisce adeguarsi a un pensiero già<br />
pensato che pensare autonomamente. D'altronde è allenata fin dai<br />
banchi <strong>di</strong> scuola giocare <strong>di</strong> rimessa e a contentarsi <strong>di</strong> spazi sempre più<br />
piccoli <strong>di</strong> autonomia. I gran<strong>di</strong> induttori dei comportamenti <strong>di</strong> massa,<br />
dal calcio alla canzonetta, alla TV, alla moda, ci risparmiano la fatica<br />
<strong>di</strong> costruirci il tempo libero; a costruirci il tempo occupato ci pensa,<br />
quando le va <strong>di</strong> farlo, l’impresa ??? (p.231A) Del pensiero e della<br />
fatica in<strong>di</strong>viduale c'è sempre meno bisogno, suppliscono le macchine e<br />
i circuiti informatici. Non più stimolato, il pensiero va in vacanza e<br />
depone ogni velleità <strong>di</strong> autonomia. E la cosa non <strong>di</strong>spiace<br />
all'impren<strong>di</strong>tore e neppure al politico. A pochi è concesso quel tanto <strong>di</strong><br />
inventiva in<strong>di</strong>viduale che serve a battere la concorrenza, i più<br />
conviene che pensino il meno possibile per non <strong>di</strong>sturbare il pensiero<br />
dei pochissimi delegati a usarlo. Il tipo <strong>di</strong> democrazia cui quei delegati<br />
ci hanno abituato e che correntemente viene chiamata libertà è quasi<br />
altrettanto liberticida della tirannia assoluta. Non risulta che<br />
l'esecuzione me<strong>di</strong>aticamente moltiplicata, <strong>di</strong> Saddam Hussein abbia<br />
reso più libera la mente degli Iracheni.<br />
Sono possibili altri tipi <strong>di</strong> democrazia? Non so fare che ripetere la<br />
domanda per cui attualmente non vedo risposta. L'unica cosa alla
quale in molti - ma sempre troppo pochi - ci stiamo adoperando è la<br />
rivitalizzazione del pensiero promuovendone l'esercizio fin<br />
dall'infanzia. In questo senso, ripeto, non conta tanto il contenuto <strong>di</strong><br />
un libro come il presente, quanto il contagio che ne può nascere:<br />
l'innesco <strong>di</strong> un'attività mentale anche del tutto in<strong>di</strong>pendente da questo<br />
contenuto.<br />
Si è detto della pluralità <strong>di</strong> stili compresenti in ogni mente.<br />
Questa pluralità, come quella biologica che rende possibile la vita, è<br />
altrettanto in<strong>di</strong>spensabile alla mente capace <strong>di</strong> riflessione.<br />
I problemi che ne <strong>di</strong>pendano sono due e ambedue riguardano la<br />
formazione:<br />
- il mantenimento se non ad<strong>di</strong>rittura l'incremento della pluralità<br />
- la sua equilibrazione.<br />
In una qualsiasi nicchia ecologica la <strong>di</strong>versità delle componenti si<br />
mantiene nel tempo grazie all'equilibrio tra esse.<br />
Ecco già l'inter<strong>di</strong>pendenza dei due problemi: il mantenimento della<br />
pluralità <strong>di</strong>pende dalla sua equilibrazione. Ma come si fa a equilibrare<br />
il molteplice?<br />
De<strong>di</strong>cheremo la seconda metà del capitolo a questo problema, mentre<br />
nella prima tratteremo del rilevamento degli stili nella loro pluralità.<br />
Anche il rilevamento non è sempre <strong>di</strong> facile attuazione. Proprio perché<br />
i confini tra uno stile e l'altro sono sfumati e il loro tracciato arbitrario,<br />
l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> essi è oltremodo problematica e ancor più lo è il<br />
riconoscimento delle relazioni che si instaurano tra loro. Questo<br />
riconoscimento, come già osservato in innumerevoli casi analoghi,
non coglie fatti oggettivi ma <strong>di</strong>pende dalle finalità per cui osserviamo.<br />
Avremo così<br />
- rilevamenti <strong>di</strong> primo contatto<br />
- rilevamenti a fini <strong>di</strong> comunicazione<br />
- rilevamenti a fini formativi, in particolare<br />
- rilevamenti a scuola.<br />
A ciascuna <strong>di</strong> queste finalità de<strong>di</strong>cheremo un paragrafo <strong>di</strong> riflessioni, o<br />
meglio <strong>di</strong> un possibile avvio alla riflessione.<br />
6.1. Il rilevamento<br />
Conoscere una persona vuol <strong>di</strong>re conoscere i suoi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> pensare, <strong>di</strong><br />
reagire, <strong>di</strong> comunicare nelle più <strong>di</strong>verse situazioni. Può trattarsi <strong>di</strong> un<br />
amico, <strong>di</strong> un collega <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> un familiare: conoscerlo vuol <strong>di</strong>re<br />
saper prevedere i suoi comportamenti, le sue reazioni emotive, le sue<br />
argomentazioni. Ma anche saper valutare ogni cosa in relazione alla<br />
totalità della persona per quel tanto o poco che ci riguarda, vuoi per<br />
interesse vuoi per affettività. Per conoscere una persona possono<br />
volerci degli anni; spesso l'immagine che ci facciamo <strong>di</strong> lei cambia nel<br />
corso del tempo. Naturalmente questa variabilità <strong>di</strong>pende in larga<br />
misura anche da noi. La conoscenza non è uni<strong>di</strong>rezionale ma implica<br />
un'azione reciproca, questo perfino nel caso <strong>di</strong> oggetti fisici, come la<br />
teoria dei quanti ci ha insegnato; tanto più tra esseri viventi,<br />
massimamente se anche pensanti. Ciò che io rilevo nel rapporto con<br />
l'altro è funzione del mio modo <strong>di</strong> pensare non meno che del suo. Ne
consegue che per conoscere l'altro debbo anzitutto conoscere me<br />
stesso: il grado <strong>di</strong> oggettività <strong>di</strong> una conoscenza - che comunque sarà<br />
sempre relativo - è determinato anche dalla conoscenza del mio<br />
apparato conoscitivo, cioè della mia mente. "Ogni analisi e al tempo<br />
stesso autoanalisi dei meccanismi del pensiero. Conoscere vuol <strong>di</strong>re<br />
abitare lo spazio <strong>di</strong> un oggetto: conoscere questo spazio significa<br />
conoscere la parte <strong>di</strong> noi che lo abita." (B.P. 1975)<br />
Riporto ora, per frammenti, quanto già scritto nel 1992 ma non<br />
pubblicato, poi entrato a far parte del testo base su IMC (1999).<br />
"L'immagine dell'altro, nei termini qui usati, [possiamo considerarla]<br />
l'immagine <strong>di</strong> un UCL visto da un UCL non necessariamente prossimo.<br />
Questa schematizzazione richiede alcune parole <strong>di</strong> commento.<br />
In prospettiva metaculturale l'immagine dell'altro [è descrivibile]<br />
come parzialmente autoriflessiva, per le zone in condominio nei due<br />
UCL, per il resto come un identikit costruito sulla base delle mie<br />
esperienze interpersonali (quanto maggiori queste esperienze, tanto<br />
più affidabile il mio identikit)...<br />
All'immagine dell'altro saremmo tentati <strong>di</strong> opporre l'immagine <strong>di</strong> sé,<br />
interamente autoriflessiva in quanto per costruirla non sarebbe<br />
necessaria l'esperienza interpersonale. Questa interpretazione sembra<br />
invero troppo ristretta: la conoscenza <strong>di</strong> sé è apparsa, a chi se ne è<br />
occupato filosoficamente o psicologicamente, come un processo <strong>di</strong><br />
lenta, <strong>di</strong>fficile, spesso dolorosa attuazione. Qui vorrei considerarla<br />
come un caso particolare dell'immagine dell'altro per le seguenti<br />
ragioni:
- il momento che possiamo <strong>di</strong>re appercettivo è comune all'una come<br />
all'altra immagine<br />
- per la parte residua non posso che fare appello alla mia esperienza<br />
<strong>di</strong> me stesso (alla serie <strong>di</strong> momenti appercettivi in qualche modo<br />
compresenti nella mia memoria)...<br />
Se voglio dare alla mia immagine <strong>di</strong> me un certo "spessore storico"<br />
non posso che procedere come per l'immagine dell'altro, producendo<br />
cioè un identikit, affidabile nella misura in cui lo sono i vari atti<br />
riflessivi e la memoria che li conserva... Non sembra dunque, nella<br />
prospettiva qui in<strong>di</strong>cata, che l'immagine <strong>di</strong> sé goda <strong>di</strong> un qualche<br />
privilegio entro l'insieme "immagine dell'altro"...<br />
Intendo anche l'immagine del bambino come un caso particolare<br />
dell'immagine dell'altro... Il bambino cui mi riferisco è, vorrei <strong>di</strong>re, un<br />
costrutto statistico corrispondente a una fascia <strong>di</strong> età tra i 3 e i 9 anni,<br />
gli anni cioè della scuola dell'infanzia e delle prime tre classi<br />
elementari... L'immagine in questione, come <strong>di</strong> regola la costruiamo,<br />
è sostanzialmente... potenzialità, futuro, preparazione all'adulto, il suo<br />
UCL è ingenuo, carente, in via <strong>di</strong> formazione, plasmabile ecc.<br />
L'immagine costruita in prospettiva metaculturale ne fa invece un<br />
interlocutore a pieno titolo, <strong>di</strong> pari rilevanza culturale rispetto a<br />
qualsiasi adulto. L'UCL che in lui si manifesta - e che <strong>di</strong>fficilmente il<br />
nostro sa cogliere - mostra delle caratteristiche che perlopiù si<br />
perdono in seguito: la minor quantità <strong>di</strong> informazioni immagazzinate e<br />
soprattutto <strong>di</strong> strutture culturalmente consolidate rende quell'UCL più<br />
agile al suo interno, più pronta a formulare ipotesi, interpretazioni, a<br />
costruire circuiti logici e probabilistici..."
Ho incluso nella precedente autocitazione anche uno spezzone<br />
riguardante l'immagine metaculturale del bambino perché l'attività<br />
<strong>di</strong>dattico-pedagogica, cui va soprattutto la nostra attenzione, parte <strong>di</strong><br />
solito proprio dal rilevamento delle caratteristiche comportamentali,<br />
cognitive, riflessive ecc. dei destinatari <strong>di</strong> quell'attività, in altre parole<br />
degli stili <strong>di</strong> pensiero <strong>di</strong> cui hanno <strong>di</strong>sponibilità.<br />
6.1.1. Il rilevamento <strong>di</strong> primo contatto<br />
Abbiamo usato il termine "<strong>di</strong> primo contatto" nell'ambito dell'analisi<br />
visiva, poi anche musicale, a designare un tipo <strong>di</strong> analisi ottenuta<br />
proiettando sull'oggetto da analizzare una rete <strong>di</strong> concetti logico-<br />
gestaltici <strong>di</strong> amplissima valenza culturale, al punto da poterli<br />
considerare elementari, preculturali, <strong>di</strong> base. Anche queste analisi non<br />
si <strong>di</strong>fferenziano da altre, più complesse, che per il carattere irriflesso,<br />
istintivo dei criteri analitici adoperati. A una considerazione<br />
metaculturalmente più approfon<strong>di</strong>ta, anche l'ingenuità irriflessa e<br />
istintiva <strong>di</strong> queste analisi <strong>di</strong> primo contatto rivelano però la loro<br />
culturalità, anche se <strong>di</strong> raggio assai ampio.<br />
Analogamente è possibile parlare, a proposito degli stili <strong>di</strong> pensiero, <strong>di</strong><br />
un rilevamento <strong>di</strong> primo contatto. Due persone che non si conoscono<br />
vengono presentate l'una all'altra: già il modo <strong>di</strong> servirsi delle formule<br />
d'uso, l'espressione facciale, la gestualità che le accompagnano<br />
portano a un rilevamento <strong>di</strong> primo contatto, cioè al costituirsi <strong>di</strong> una<br />
prima, ipotetica immagine dell'altro. E a questa si associa un, ancora
irriflesso, moto <strong>di</strong> simpatia/antipatia. Molti ritengono del tutto<br />
irrazionale, istintivo appunto, questo moto; per parte mia lo attribuirei<br />
a impercettibili, non ancora analizzabili segnali comunicativi che<br />
connotano <strong>di</strong>sponibilità o in<strong>di</strong>sponibilità al contatto. Tali segnali,<br />
ancorché irriflessi - e forse anche recepiti in maniera irriflessa - non<br />
apparterrebbero, sempre secondo me, a un livello extraculturale,<br />
inanalizzabile razionalmente, ma a livelli culturali profon<strong>di</strong>, comunque<br />
raggiungibili dalla catabasi metaculturale.<br />
Se alla presentazione fanno seguito altre occasioni <strong>di</strong> incontro, <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>alogo, <strong>di</strong> confronto, è probabile che alla prima, ipotetica immagine<br />
dell'altro, altre ipotesi si sostituiscano, non necessariamente<br />
congruenti con quella, e altre ancora a queste, in una continua<br />
variabilità dal cui integrale si viene formando un'immagine duratura,<br />
fondamento del reciproco rapporto sociale. Il confine tra il rilevamento<br />
<strong>di</strong> primo contatto e il consolidarsi dell'immagine definitiva (o<br />
perlomeno duraturo) non è ovviamente tracciabile; tutt'al più si può<br />
parlare <strong>di</strong> una fase <strong>di</strong> trapasso, non <strong>di</strong> rado turbolenta, che può<br />
portare al rafforzamento <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> consuetu<strong>di</strong>ne come anche a<br />
una rottura.<br />
Tutto ciò fa parte <strong>di</strong> una quoti<strong>di</strong>anità non professionale. Diverso è il<br />
caso dove il rapporto interpersonale assume connotazioni<br />
professionali. Queste possono darsi:<br />
- in ambito psicoterapico o psicanalitico<br />
- in ambito euristico-conoscitivo<br />
- in ambito formativo.
Limitiamoci per ora al rilevamento <strong>di</strong> primo contatto. È chiaro che in<br />
tutti e tre questi ambiti i moti istintivi, irriflessi, seppure ineliminabili,<br />
vanno per così <strong>di</strong>re messi tra parentesi, per essere eventualmente<br />
analizzati in un secondo momento. Lo psicanalista potrà provare un<br />
moto <strong>di</strong> antipatia per un suo cliente, <strong>di</strong>fficilmente, se è un<br />
professionista serio, potrà basare su <strong>di</strong> esso un progetto <strong>di</strong><br />
trattamento. Similmente un'insegnante non dovrebbe far <strong>di</strong>pendere la<br />
sua azione formativa dalla prima impressione ricevuta dai suoi allievi<br />
(e neppure dalle immagini successive). E uno stu<strong>di</strong>oso del<br />
comportamento umano non ci guadagnerebbe molto in cre<strong>di</strong>bilità se<br />
basasse le sue ricerche soltanto sul comportamento <strong>di</strong> mogli e figli. In<br />
tutti questi casi i rilevamenti <strong>di</strong> primo contatto fanno parte delle<br />
professionalità specifiche e delle relative metodologie. Qui lascerò ad<br />
altri <strong>di</strong> occuparsi dei primi due ambiti sopra ricordati, non avendo io<br />
alcuna competenza <strong>di</strong> essi. (Qualcuno osserverà che anche questo<br />
libro nasce, per esplicita ammissione <strong>di</strong> chi lo scrive, da<br />
incompetenza. Confermo, ma ritengo meno pericoloso un libro<br />
incompetente che uno psichiatra, uno psicanalista, uno scienziato che<br />
lo sia). Dirò invece qualche cosa sull'ambito formativo che in un modo<br />
o nell'altro ha occupato tutta la mia vita. Ricordo un primo contatto<br />
con uno studente <strong>di</strong> composizione in piena età contestataria, al quale<br />
qualsiasi cosa io <strong>di</strong>cessi non andava bene e con cui il <strong>di</strong>alogo era<br />
impossibile. Concepii per lui una forte antipatia, penso<br />
contraccambiata. Decisi allora <strong>di</strong> rinunciare al <strong>di</strong>alogo e <strong>di</strong> far parlare<br />
solo lui. Dopo qualche tempo cominciò ad annoiarsi: da parte mia non<br />
trovava la minima resistenza e, se voleva un contrad<strong>di</strong>ttorio, doveva
farselo da solo. Questo lo costrinse a sdoppiare, per così <strong>di</strong>re, il suo<br />
pensiero cercando argomenti ora per l'uno ora per l'altro dei due<br />
contendenti. Anche io glieli appoggiavo alternativamente stimolandolo<br />
a rafforzare le sue stesse argomentazioni. In capo qualche tempo<br />
imparò anche a concordare con me o con altri senza per questo<br />
sentirsi sminuito nella sua autonomia. Diventammo e siamo ancora<br />
amici.<br />
Un altro caso, inizialmente assai <strong>di</strong>fficile, mi è capitato in una quarta<br />
elementare, dove mi era stato concesso <strong>di</strong> condurre una<br />
sperimentazione musicale <strong>di</strong> base cioè non volta all'insegnamento<br />
specifico. Un alunno <strong>di</strong> quella classe, un quattor<strong>di</strong>cenne pluriripetente<br />
ed emarginato sia dai compagni che dagli insegnanti si rivaleva su<br />
tutti con la violenza. Si stava lavorando sull'informale, cioè su suoni e<br />
rumori non co<strong>di</strong>ficati per l'uso musicale, e i bambini dovevano venire,<br />
uno alla volta, a <strong>di</strong>rigere con gesti concordati un'improvvisazione<br />
sonora. La cosa era però resa impossibile dal comportamento<br />
devastante del quattor<strong>di</strong>cenne maciste. Dopo vari, inutili tentativi <strong>di</strong><br />
ammonirlo mi venne in mente <strong>di</strong> chiamare proprio lui a <strong>di</strong>rigere. Fu un<br />
<strong>di</strong>sastro: faceva il gradasso gesticolando come un ossesso ed<br />
emettendo grida selvagge. Finita la performance, gli feci notare la sua<br />
mancanza <strong>di</strong> controllo, insinuando però senza parere che in lui c'era<br />
della stoffa... All'incontro seguente gli lanciai un'occhiata d'intesa e,<br />
dopo un po', lo chiamai a <strong>di</strong>rigere. Questa volta pretese che i<br />
compagni lo seguissero nelle sue insensate gesticolazioni. Gli feci<br />
osservare che, se si fossero messi d'accordo sul significato dei gesti,<br />
le cose sarebbero andate meglio. Tornato al suo posto, il ragazzo
iprese il suo comportamento <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo. Anche questa volta mi fu<br />
facile fargli notare la contrad<strong>di</strong>zione: "Quando <strong>di</strong>rigi - e lo sai fare -<br />
vuoi che gli altri ti <strong>di</strong>ano retta, ma quando è un altro a <strong>di</strong>rigere, tu non<br />
sei capace a seguirlo." Dopo alcuni incontri, durante i quali mi<br />
<strong>di</strong>mostravo interessato ai suoi progressi, le cose si stabilizzarono e le<br />
sue azioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sturbo si ridussero entro limiti sopportabili. Che cosa<br />
era successo? Me lo <strong>di</strong>sse lui stesso, anni più tar<strong>di</strong> - lavorava come<br />
volontario in una struttura <strong>di</strong> assistenza -: "Era la prima volta che<br />
qualcuno apprezzava ciò che facevo e ho cominciato a credere in me<br />
stesso. Ora cerco anch'io <strong>di</strong> dare fiducia a quelli con cui lavoro".<br />
Il primo contatto con una prima elementare <strong>di</strong> 20-30 alunni può<br />
essere scoraggiante, e ho conosciuto insegnanti che si sono arresi alla<br />
violenza collettiva dei bambini (chè <strong>di</strong> questo si tratta) ovvero hanno<br />
reagito in modo repressivo azzerando ogni possibilità <strong>di</strong><br />
comunicazione paritetica. Solo circostante particolarmente fortunate o<br />
insegnante con una eccezionale preparazione rendono<br />
formativamente produttive classi con più <strong>di</strong> 10-15 alunni. Di questo i<br />
politici non vogliono prendere notizia e continuano a varare riforme<br />
che non affrontano nessuno dei no<strong>di</strong> problematici della formazione:<br />
insegnante adeguatamente preparati - e retribuiti -, scuole<br />
adeguatamente attrezzate. Ma questi adeguamenti non rendono - anzi<br />
costano, e non poco - in termini economici e non portano vantaggi<br />
elettorali.<br />
Tuttavia qualcosa si può ancora <strong>di</strong>re circa l'inevitabile primo contatto<br />
che ogni insegnante è chiamato più volte ad affrontare nella sua vita<br />
lavorativa. Un giorno un amico - non ricordo quale - a me, che mi
lamentavo del fasti<strong>di</strong>o provocatomi dal comportamento <strong>di</strong> un comune<br />
conoscente, <strong>di</strong>sse: "Invece <strong>di</strong> lamentarti <strong>di</strong> lui, chie<strong>di</strong>ti del perché <strong>di</strong><br />
quel fasti<strong>di</strong>o. Il problema sei tu, non lui".<br />
Così, ad un primo contatto con una classe <strong>di</strong> bambini, cominciamo col<br />
rilevare le nostre reazioni: <strong>di</strong> sgomento, paura, ansia, o, al contrario,<br />
volontà repressiva, <strong>di</strong> dominio, <strong>di</strong> sfida. Cerchiamo <strong>di</strong> analizzarle <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduarne gli antecedenti ecc., perché "il problema siamo noi, non<br />
le classi". Riflettiamo poi: la classe non è un oggetto, non esiste come<br />
tale. Davanti a noi abbiamo un insieme, più o meno casuale, <strong>di</strong><br />
bambini, ciascuno con le sue caratteristiche e sono queste da rilevare,<br />
non quelle della classe. Se col tempo un oggetto si dovesse formare<br />
del tipo classe, questo accadrà - o non accadrà - con il nostro<br />
contributo, e della parte che ci riguarda sarebbe bene fossimo<br />
coscienti (ancora una volta i rilevamenti vanno compiuti innanzitutto<br />
sono gli stessi).<br />
Nella formazione professionale dell'insegnante gli vengono dati degli<br />
utili suggerimenti sui rilevamenti <strong>di</strong> primo contatto (poiché anche sui<br />
successivi): si tratta <strong>di</strong> tracciare un primo identikit: che cosa sa<br />
l'alunno, come si esprime, come si comporta ecc. Ma è proprio qui, al<br />
momento del primo contatto, che il rilevamento produce i risultati più<br />
dubitabili, in quanto l'interazione insegnante-alunno, non essendosi<br />
ancora normalizzata, è più che altro <strong>di</strong> ostacolo a qualsiasi pretesa <strong>di</strong><br />
oggettività. Semmai è in un lungo periodo <strong>di</strong> contatto, quando il<br />
rilevamento cede alla consuetu<strong>di</strong>ne, che si fa strada, non l'oggettività<br />
della reciproca conoscenza, ma la preve<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong> certe reazioni e<br />
comportamenti. Se certe osservazioni a carattere statistico possono
ivelarsi utili per la pianificazione <strong>di</strong>dattico-formativa, l'osservazione<br />
in<strong>di</strong>viduale va esercitata con cautela e parsimonia. Sentirsi osservati<br />
non piace nessuno (o, in qualche caso, piace troppo), soprattutto se<br />
all'osservazione si associano la valutazione e il giu<strong>di</strong>zio. E l'alunno non<br />
fa eccezione e la scuola spesso gli appare, più che un luogo <strong>di</strong><br />
formazione, un tribunale che decide del suo presente e del suo futuro.<br />
Da quanto detto traspare la mia scarsa considerazione per i<br />
rilevamenti <strong>di</strong> primo contatto. Già la parola rilevamento è <strong>di</strong> quelle<br />
che chiudono più che aprire, e chiudere a un primo contatto...<br />
Certamente però non è a una chiusura che pensa chi parla <strong>di</strong> test<br />
d'ingresso o, come qui, <strong>di</strong> rilevamento <strong>di</strong> primo contatto; semmai alla<br />
possibilità <strong>di</strong> costruire una prima ipotesi su cui avviare l'azione<br />
formativa, un'ipotesi da sostituire quanto prima con altre meglio<br />
fondate. Che cosa ci serve per formulare un'ipotesi?<br />
Indubbiamente ci servono delle conoscenze, ma quelle ricavabili da un<br />
primo contatto sono comunque assai scarse. Oltre le conoscenze<br />
servono altre tre cose:<br />
- la curiosità<br />
- il coraggio <strong>di</strong> sbagliare<br />
- la <strong>di</strong>sponibilità a cambiare idea.<br />
20-30 (ad<strong>di</strong>rittura 40) menti infantili da indagare, anche se<br />
decisamente troppe, dovrebbero scatenare la curiosità <strong>di</strong> chi lavorerà<br />
con loro per anni, sempreché questo prerequisito ci sia (come<br />
sempre, il primo rilevamento va compiuto su <strong>di</strong> noi).<br />
Le nostre prime ipotesi saranno quasi certamente sbagliate. Abbiamo<br />
il coraggio <strong>di</strong> formularle lo stesso e siamo poi <strong>di</strong>sponibili a
correggerle? Questi, a mio parere, i principali rilevamenti <strong>di</strong> primo<br />
contatto, e non riguardano gli alunni.<br />
6.1.2. Rilevamenti a fini comunicazionali<br />
Non so se la vita sia interamente riducibile a comunicazione.<br />
Sappiamo comunque che la comunicazione nelle sue varie forme gioca<br />
un ruolo essenziale nei sistemi biologici. E sia l'uomo come società sia<br />
il singolo in<strong>di</strong>viduo sono dei sistemi biologici, per comprendere i quali<br />
occorre conoscere le forme comunicazionali che li tengono assieme.<br />
Tra queste alcune sono geneticamente predeterminate come la<br />
struttura del DNA e delle molecole affini, altre vengono, più o meno<br />
precocemente, apprese. Un bambino, al suo ingresso nella scuola,<br />
possiede già un buon numero <strong>di</strong> forme comunicazionali: il riso, il<br />
pianto, una ricca gestualità, la mimica facciale, vari tipi <strong>di</strong><br />
vocalizzazione, la parola... Se vogliamo entrare in rapporto con lui,<br />
dobbiamo imparare a conoscere i suoi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> articolare tutte queste<br />
forme. In parte il lavoro ci viene facilitato dai co<strong>di</strong>ci - non importa se<br />
innati o acquisiti - che li regolano. Per un'altra parte l'uso <strong>di</strong> questi<br />
co<strong>di</strong>ci è in<strong>di</strong>vidualmente caratterizzato e quin<strong>di</strong> non c'è che<br />
l'osservazione <strong>di</strong>retta, il rilevamento dei mo<strong>di</strong> espressivi in<strong>di</strong>viduali.<br />
Possiamo inoltre supporre, almeno per la specie umana, che i mo<strong>di</strong><br />
espressivi siano coscientemente o meno collegati a intenzionalità<br />
comunicative, all'attività cerebrale che chiamiamo pensiero,<br />
nell'ambito del quale stiamo qui <strong>di</strong>stinguendo una pluralità <strong>di</strong> stili. Per
comunicare efficacemente, cioè per conoscerci meglio, dobbiamo,<br />
attraverso una corretta interpretazione dei mo<strong>di</strong> espressivi in<strong>di</strong>viduali,<br />
poter accedere l'uno agli stili <strong>di</strong> pensiero dell'altro. La cosa è tutt'altro<br />
che semplice per le ragioni già dette - cioè che questi stili non sono né<br />
stabili né univocamente definiti -, ma anche perché le loro espressioni<br />
non sono affatto trasparenti, cosicché un atteggiamento <strong>di</strong> dogmatica<br />
sicurezza può nascondere la paura del relativismo. Inoltre molti dei<br />
co<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> cui ci serviamo hanno piuttosto la funzione <strong>di</strong> nascondere che<br />
<strong>di</strong> rivelare il nostro pensiero: quando in compagnia ci lasciamo andare<br />
a <strong>di</strong>vagazioni incontrollate, questo non significa che la nostra modalità<br />
prevalente non sia convergente. Occorrono molti rilevamenti, fatti in<br />
situazioni <strong>di</strong>verse, per poter <strong>di</strong>re che una certa persona cominciamo a<br />
conoscerla.<br />
Si potrebbe pensare che il linguaggio verbale, a <strong>di</strong>fferenza per<br />
esempio <strong>di</strong> quello mimico-gestuale, offra maggiori garanzie <strong>di</strong><br />
affidabilità proprio per la concettualizzazione che ne costituisce il<br />
fondamento. È vero piuttosto il contrario: la parola è capace <strong>di</strong> usare<br />
il concetto per fingere una realtà che non è. La parola sa mentire. È<br />
un'esperienza, quella del doppio messaggio, che tutti abbiamo fatto<br />
sia come riceventi che come emittenti: la parola per esempio approva<br />
mentre il gesto o l'espressione facciale <strong>di</strong>sapprovano. "Mente il ceffo,<br />
io no non mento" <strong>di</strong>ce Leporello che notoriamente è un briccone.<br />
La stessa comunicazione verbale è un'attività estremamente<br />
complessa e pluristratificata, e i fini per cui ce ne serviamo<br />
complicano ancora più le cose. Quasi mai il fine è la semplice<br />
verbalizzazione <strong>di</strong> un dato <strong>di</strong> fatto. Nel migliore dei casi ne viene
comunicata una interpretazione, e questa ha a che fare con lo stile<br />
mentale che l'ha prodotta. Una modalità analitica ce ne darà<br />
un'immagine ricca <strong>di</strong> particolari <strong>di</strong>fficili da ridurre a unità, una<br />
modalità sintetica ci mostrerà il dato <strong>di</strong> fatto nella sua inscin<strong>di</strong>bile<br />
unità. Ma qual è il dato <strong>di</strong> fatto?<br />
Come l'interpretazione che ci viene comunicata, così anche la sua<br />
comprensione da parte nostra viene filtrata dal nostro stile mentale, o<br />
meglio da quella mescolanza <strong>di</strong> stili, comunque classificati, che<br />
costituiscono il nostro abituale stile <strong>di</strong> pensiero. Di questo dobbiamo<br />
tenere conto nei nostri scambi comunicazionali, ma per farlo è<br />
necessario conoscerlo. Conosciamo i nostri mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> pensare, quello<br />
stile che, pur nella sua variabilità, consideriamo nostro?<br />
Tutti pensiamo, ma pochi si soffermano a pensare come. Abbiamo<br />
anche visto quanto il pensiero indotto (da ideologie, religioni,<br />
superstizioni) ci impe<strong>di</strong>sca l'autoriflessione. Perché la comunicazione<br />
raggiunga un massimo <strong>di</strong> efficacia è quin<strong>di</strong> necessario sgomberare,<br />
per quanto possibile, la nostra mente da questo pensiero indotto.<br />
Altrettanto necessario è sfrondare il pensiero altrui della parte che<br />
non gli appartiene, non perché non faccia parte della comunicazione,<br />
ma perché già nota e preve<strong>di</strong>bile. Ci sarebbe invece da chiedersi<br />
perché noi, tutti noi, facciamo così largo uso <strong>di</strong> un pensiero irriflesso,<br />
spesso <strong>di</strong> lontana e inverificabile provenienza.<br />
Per attuare questa pulizia ideologica occorrono:<br />
- un continuo rilevamento degli stili e delle modalità <strong>di</strong> pensiero sia<br />
nostri che <strong>di</strong> coloro con cui inten<strong>di</strong>amo comunicare un confronto<br />
con le varie forme <strong>di</strong> pensiero indotto oggi circolanti
- la provvisoria messa in parentesi <strong>di</strong> queste forme onde in<strong>di</strong>viduare<br />
eventuali (non necessariamente presenti) componenti <strong>di</strong> autonoma<br />
riflessione<br />
- la <strong>di</strong>sponibilità, da ambo le parti, a basare su queste componenti<br />
autonome i nostri rapporti comunicativi.<br />
La pulizia ideologica come qui l'inten<strong>di</strong>amo non ha alcuna equivalenza,<br />
neppure formale, con la famigerata pulizia etnica, oggi come ieri<br />
praticata su larga scala; anzi è forse il più efficace strumento per<br />
contrastarla. L'o<strong>di</strong>o per il <strong>di</strong>verso ha infatti ra<strong>di</strong>ci ideologiche, giacché<br />
la natura sembra pre<strong>di</strong>ligere il <strong>di</strong>verso in tutti i suoi livelli<br />
organizzativi. Inoltre la pulizia ideologica non si propone <strong>di</strong> togliere <strong>di</strong><br />
mezzo le ideologie, ma solo <strong>di</strong> relativizzarle alla cultura che le ha<br />
prodotte, come recita una delle definizioni <strong>di</strong> IMC. In altre parole la<br />
pulizia ideologica non si presenta essa stessa in veste ideologica, ma<br />
come fondamento <strong>di</strong> una metodologia che abbiamo chiamato<br />
metaculturale. Anche i rilevamenti <strong>di</strong> cui qui è questione, per essere<br />
affidabili e funzionali a una comunicazione efficace, vanno condotti<br />
(secondo noi) in maniera metaculturale. Presuppongono cioè<br />
l'operazione <strong>di</strong> pulizia ideologica che li avvicini il più possibile<br />
all'irraggiungibile oggettività della conoscenza.<br />
Una facile obiezione è la seguente:<br />
-Se l'oggettività è data per irraggiungibile, che importanza ha la<br />
maggiore o minore vicinanza del dato rilevato a questa fantomatica<br />
oggettività?-<br />
Facile è anche la risposta:
-Nessuna, nella teoria. Gran<strong>di</strong>ssima nella pratica. Infatti la <strong>di</strong>stanza<br />
che qui ci interessa non è quella da una presunta oggettività, ma la<br />
<strong>di</strong>stanza dai con<strong>di</strong>zionamenti ideologici. Quanto più ce ne<br />
allontaniamo, tanto maggiore la nostra autonomia. L'autonomia<br />
totale, ideologica, probabilmente, è anch'essa irraggiungibile.<br />
Possiamo tuttavia considerarla come una misura <strong>di</strong> libertà. E se a<br />
questa, come sembra, ci teniamo, cerchiamo <strong>di</strong> accrescerne la misura.<br />
6.1.3. Rilevamenti a fini formativi<br />
È l'aspetto che, come CMC, più ci riguarda. Certo, anche i fini<br />
comunicazionali sono, per noi come per tutti, <strong>di</strong> centrale rilevanza, e<br />
così quelli conoscitivi: ma in quanto sussunti entro un progetto <strong>di</strong><br />
formazione. Per me in particolare è abbastanza ovvio che sia più<br />
interessato a questo tipo <strong>di</strong> progetti, in<strong>di</strong>rizzati alle generazioni future,<br />
che ad altri.<br />
Altrettanto ovvio è che, per avviare un processo formativo o per<br />
portarlo avanti, sono necessari perio<strong>di</strong>ci rilevamenti <strong>di</strong> verifica. Questi<br />
riguarderanno tutte le parti in causa, sia i forman<strong>di</strong> che i formatori,<br />
che le strutture progettuali. Quando si pianifica un percorso<br />
formativo, per buona che sia l'esperienza pregressa, molto si affida al<br />
pensiero ipotetico ed ha quin<strong>di</strong> bisogno <strong>di</strong> verifica. Troppo spesso<br />
tuttavia la verifica viene esercitata a senso unico, dal progetto verso<br />
l'esterno e la verifica del progetto viene rimandata fino al presentarsi<br />
<strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> crisi. Così il grande progetto comunista, anziché
ilevare in tempo le proprie carenze, ha aspettato che queste<br />
prendessero il sopravvento <strong>di</strong>struggendo il progetto stesso. Qualcosa<br />
<strong>di</strong> simile sta oggi accadendo al capitalismo liberistico, le cui verifiche<br />
sono tutte interne al sistema - crescita del PIL, del consumo, del<br />
welfare - e poco si curano dei rilevamenti esterni - protocollo <strong>di</strong><br />
Kyoto, denunce <strong>di</strong> Green Peace e degli ambientalisti-.<br />
I rilevamenti e i risultati che essi producono non hanno un valore in<br />
sé, ma lo acquistano non appena sono immessi in un sistema<br />
interpretativo. È quin<strong>di</strong> in<strong>di</strong>spensabile che la verifica riguarda<br />
anzitutto questo.<br />
A questo punto sorge la ben nota <strong>di</strong>fficoltà logica: entro quale sistema<br />
verificheremo la vali<strong>di</strong>tà del sistema interpretativo? Ricorsività infinita,<br />
il buco nero <strong>di</strong> UMC?<br />
Il pensiero dogmatico ha risolto il problema inventando una causa<br />
prima e ancorando ad essa tutto il resto. Sono però noti i risvolti<br />
negativi del pensiero dogmatico, costretto a perenne <strong>di</strong>fensiva nei<br />
confronti <strong>di</strong> quello ipotetico-relativistico. Lo stile metaculturale,<br />
nient'altro che una variante dello stile ipotetico-relativistico, ha<br />
introdotto il concetto metodologico <strong>di</strong> fermata, una sorta <strong>di</strong><br />
ancoraggio mobile che ha il vantaggio <strong>di</strong> non doversi <strong>di</strong>fendere.<br />
In prospettiva metaculturale i rilevamenti a fini formativi sono rivolti<br />
primariamente all'autoverifica <strong>di</strong> questo stile. Naturalmente il concetto<br />
<strong>di</strong> stile <strong>di</strong> pensiero è <strong>di</strong> per sé troppo astratto per costituirsi a materia<br />
<strong>di</strong> verifica, cosicché questa si svolgerà, come d'abitu<strong>di</strong>ne, su<br />
rilevamenti concreti - crescite, <strong>di</strong>minuzioni, costi, ricavi, guadagni,<br />
conoscenze, competenze ecc. -, con l'avvertenza che i suoi risultati
sono da considerarsi relativi alla fermata concordata in precedenza e<br />
nulla implicano nel caso <strong>di</strong> un suo spostamento. "Hanno spostato il<br />
capolinea della metropolitana. Da domani possiamo cercare casa<br />
anche nel quartiere <strong>di</strong>...".<br />
Questa correzione metaculturale è secondo noi ciò che <strong>di</strong>stingue una<br />
finalità formativa adeguata alla transizione antropologica che stiamo<br />
vivendo dalle tra<strong>di</strong>zionali finalità informative volte al rilevamento <strong>di</strong><br />
una situazione <strong>di</strong> fatto. Nulla <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso viene rilevato; ciò che cambia<br />
è lo stile mentale che presiede al rilevamento.<br />
6.1.4. Rilevamenti e scuola<br />
Veniamo ora al punto focale <strong>di</strong> questo <strong>di</strong>scorso su rilevamenti e<br />
verifiche: alla scuola.<br />
Forse da sempre le finalità della scuola si sono più o meno equamente<br />
<strong>di</strong>stribuite tra la trasmissione <strong>di</strong> un sapere e la verifica della sua<br />
acquisizione. Che tali fini istituzionali non siano però sufficienti alla<br />
formazione dell'in<strong>di</strong>viduo e della società, anche questo lo si è sempre<br />
saputo. Difficile era però in<strong>di</strong>viduare delle carenze non riducibili a<br />
precisi ambiti <strong>di</strong>sciplinari e così, per tutto quanto esulava da questi<br />
ambiti, ci si limitava a generici richiami a un armonico sviluppo della<br />
personalità, a un'educazione alla convivenza civile, al rispetto<br />
dell'altro e così via. Farne materiad'insegnamento era quasi<br />
impossibile, ragion per cui la scuola ha continuato fino ai tempi nostri
a privilegiare gli aspetti contenutistici della sua azione rispetto a quelli<br />
metodologici.<br />
Oggi però la transizione antropologica <strong>di</strong> cui si è detto (dallo sta<strong>di</strong>o<br />
culturale a uno metaculturale) impone un ra<strong>di</strong>cale cambiamento. I<br />
contenuti sono ormai reperibili con facilità on line così come le prime<br />
operazioni su <strong>di</strong> essi (quali ce le insegnavano - e insegnano - a<br />
scuola). Sarebbe quin<strong>di</strong> sufficiente abituare gli alunni a un corretto ed<br />
efficace uso <strong>di</strong> Internet e la scuola potrebbe anche scomparire o<br />
trasferirsi nelle case degli utenti. Se viceversa la scuola del saperesi<br />
trasformasse in una scuola del pensare il contatto tra in<strong>di</strong>vidui,<br />
ciascuno con la sua unica mescolanza <strong>di</strong> stili <strong>di</strong>versi, resterebbe<br />
insostituibile. Anche in una scuola elementare e non solo per i<br />
bambini.<br />
Come pensano i bambini?<br />
È la domanda che ci siamo posti, come operatori del CMC, fin<br />
dall'inizio della nostra attività, nel 1974, quando il CMC si chiamava<br />
ancora - ed era - Centro <strong>di</strong> Ricerca e Sperimentazione Metaculturale<br />
Musica in Sabina. E le risposte ce le hanno date i nostri frequentatori<br />
<strong>di</strong> allora, in maggioranza bambini, ma anche ragazzi più gran<strong>di</strong>, <strong>di</strong> 16-<br />
17 anni. Solo che ce le hanno date... in musica.<br />
Le competenze linguistico-verbali <strong>di</strong> un bambino <strong>di</strong> Cantalupo (un<br />
paese <strong>di</strong> poco più <strong>di</strong> 1000 abitanti, in maggioranza pendolari<br />
gravitanti su Roma) erano in quegli anni alquanto scarse e non ci<br />
davano sufficienti informazioni sul funzionamento delle loro menti.<br />
Avevamo però a <strong>di</strong>sposizione un altro sistema comunicazionale, da<br />
loro stessi sviluppato su basi logico-gestaltiche (V. 3.10.2.): il sistema
notale, <strong>di</strong> cui avevamo dato solo gli elementi primi, le note, senza<br />
alcuna regola per l'uso. Oltre a questo i bambini avevano<br />
approfon<strong>di</strong>tamente indagato e sperimentato l'informale, la<br />
composizione cioè coi suoni non co<strong>di</strong>ficati. Potevamo così seguire il<br />
loro pensiero nei suoi <strong>di</strong>versi stili e modalità senza far riferimento al<br />
linguaggio verbale.<br />
Ci siamo ben presto accorti del predominio dello stile logico-<br />
matematico sugli altri e della tranquilla <strong>di</strong>sponibilità alla<br />
relativizzazione metaculturale. Molti comuni pregiu<strong>di</strong>zi sono caduti, tra<br />
cui quelli su:<br />
- la propensione del bambino per uno stile fantastico-<strong>di</strong>vergente<br />
- l'insufficienza in lui del pensiero logico<br />
- il bisogno <strong>di</strong> certezze<br />
- la scarsa capacità <strong>di</strong> astrazione<br />
- la superiorità mentale <strong>di</strong> uno dei due sessi sull'altro<br />
- la superiorità ragionativa dell'adulto.<br />
Così ci siamo accorti che in genere l'adulto sa molte più cose e risolve<br />
i suoi problemi in base a ciò che ha imparato, mentre, a fronte <strong>di</strong> una<br />
situazione nuova, non ancora sperimentata, il bambino, che sa molto<br />
meno, sa però pensare meglio dell'adulto. Il problema con il bambino,<br />
che parla poco e male, è istituire un buon canale comunicazionale.<br />
Spesso ci siamo riusciti con la gestione informale dei suoni o con la<br />
loro rappresentazione grafica. Più tar<strong>di</strong> abbiamo fatto osservazioni<br />
ancora più convincenti con al composizione soltanto visiva, senza cioè<br />
attribuire ai tratti <strong>di</strong>segnati alcun significato aggiunto.
Un giorno m'è venuta l'idea <strong>di</strong> farli pensare a voce alta durante la<br />
composizione. Ecco il testo registrato <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> questi esperimenti<br />
(17.4.76 Rinaldo Settimi, V elementare)<br />
"Mi spieghi come fai a comporre, a cosa pensi?"<br />
"Penso a come mette le note"<br />
"Fammi vedere. Eccoti un foglio."<br />
"La faccio <strong>di</strong> quattro quarti. Prima metto la chiave <strong>di</strong> violino, poi penso<br />
con che nota posso comincià. Per esempio sol. Poi si, la, fa, poi il sol<br />
da due, poi metto mi..."<br />
"Perchè mi?"<br />
"Perchè, se metto si, ripetevo."<br />
"E non ti piace ripetere?"<br />
"No, non mi piace."<br />
"Ma qualche volta ripeti."<br />
"Sì ma no sempre. Fa, poi metto il re, poi dovrei mette quello che<br />
manca, il mi, invece rimetto fa..."<br />
"Ah, non lo fai sempre questo gioco?" (<strong>di</strong> riempire un intervallo<br />
lasciato aperto)<br />
"Non sempre, ma quasi sempre perchè così mi regolo meglio.<br />
La, sol, si, la, do, poi ci metto il re, poi si da tre e pausa da uno."<br />
"Tu le pause quando le metti?"<br />
"Quando vedo che ce sò tante note e uno non ce la fa a falle. Poi<br />
riviene il re, poi do, la, fa da uno e sol da due. Prima ci avevamo<br />
tante note nere poi una nota lunga e qui poche note nere e poi una<br />
lunga."<br />
"Ci hai pensato?"
"Un po', sì, ci ho pensato."<br />
"Quando vai avanti, guar<strong>di</strong> a quello che hai fatto prima?"<br />
"Secondo. Se non me lo ricordo, guardo... se mi ritrovo in <strong>di</strong>fficoltà,<br />
allora ricomincio da capo. Allora sol, mi e mo' mi, sol..."<br />
"Ah, pensi pure a questo?"<br />
"Sì, qualche volta. Poi fa da due, se riferma, la, sol, si, la, pausa...<br />
Ve<strong>di</strong>, se raccorcia, prima tante nere, poi <strong>di</strong> meno, poi ancora più<br />
corto... (in<strong>di</strong>ca la pausa). Do, si, re, la, do, si, sol da due, poi chiudo:<br />
la, si, sol da quattro."<br />
"Allora ci pensi a chiude'?"<br />
"Sì, ci penso."<br />
Certamente il testo notale rivela molto maggiori correlazioni interne<br />
che non il testo verbale. Può darsi che si fossero installati nella mente<br />
dell'autore certi automatismi neppure più registrati a livello cosciente<br />
(Rinaldo a quel tempo aveva composto già centinaia <strong>di</strong> melo<strong>di</strong>e ed era<br />
ormai anche in grado <strong>di</strong> cantarle e <strong>di</strong> eseguirle sul flauto dolce o sul<br />
pianoforte).
Un'altra scoperta <strong>di</strong> quegli anni è stata la trasferibilità dei criteri logici<br />
elementari (come li chiamavamo allora) da un ambito<br />
comunicazionale all'altro. Il pensiero analitico-compositivo funzionava<br />
allo stesso modo, o per lo meno in modo molto simile, nelle<br />
esperienze musicali e in quelle grafico-pittoriche (ciò risultava<br />
evidente già dalla grafizzazione delle melo<strong>di</strong>e, la cui composizione era<br />
più logico-visiva che logico-au<strong>di</strong>tiva). Così intesa la pratica musicale <strong>di</strong><br />
base era <strong>di</strong> per sé stessa inter<strong>di</strong>sciplinare e il passaggio ad altri<br />
linguaggi, compreso quello verbale, quasi automatico. Certo, ogni<br />
linguaggio ha le sue specificità, percettive anzitutto, poi anche<br />
lessicali, grammaticali, sintattiche - a prescindere dalle <strong>di</strong>verse<br />
funzioni sociali -, ma queste specificità acquistano peso solo man<br />
mano che ci si allontana dal livello<strong>di</strong> base. Se ci si mantiene<br />
sufficientemente vicini a questo livello, la pratica culturale <strong>di</strong> base può<br />
farsi fondamento per tutte le più complesse strutture che le varie<br />
culture hanno creato.<br />
A questo punto ci siamo accorti <strong>di</strong> due cose:<br />
- che anche la musica può concorrere alla formazione del pensiero<br />
- che qualsiasi <strong>di</strong>sciplina può farlo, a patto <strong>di</strong> riconoscere ed<br />
esplicitare un proprio livello <strong>di</strong> base.<br />
E così il nostro centro da Centro Musica si è trasformato in Centro<br />
Metaculturale dando inizio, 20 anni più tar<strong>di</strong>, alla composizione del<br />
sito www.<strong>di</strong>datticaperprogetti.it.
6.2. L'equilibrazione<br />
Ripren<strong>di</strong>amo questo tema dove l'avevamo lasciato, alla fine del<br />
paragrafo Generalità <strong>di</strong> questo capitolo.<br />
Come si fa ad equilibrare il molteplice?<br />
In una ricetta <strong>di</strong> cucina l'equilibrazione degli ingre<strong>di</strong>enti è frutto <strong>di</strong><br />
esperienza, ma la si legge anche su appositi libri.<br />
Nella composizione musicale (o pittorica o poetica) una manna ce l'ha<br />
danno le convenzioni linguistiche (le tecniche, gli stili) <strong>di</strong> riferimento.<br />
In linea generale è la cultura in cui viviamo che ci suggerisce, quando<br />
non ci prescrive, come equilibrare le sue componenti.<br />
Ma quando anche le culture intorno a noi si fanno molteplici, a chi se<br />
non al singolo in<strong>di</strong>viduo tocca il lavoro dell'equilibrazione?<br />
E se questo in<strong>di</strong>viduo non fosse neppure lui riuscito a equilibrare i suoi<br />
stili <strong>di</strong> pensiero?<br />
Ma che vuol <strong>di</strong>re equilibrare<br />
Sappiamo - ad esempio dalla fisica - che l'equilibrio può essere sia<br />
statico che <strong>di</strong>namico. Il primo garantisce la stabilità <strong>di</strong> uno stato, il<br />
secondo <strong>di</strong> un processo. Anche un processo tuttavia può avere un<br />
percorso uniforme o variabile e vi può essere un equilibrio anche <strong>di</strong><br />
queste variabilità e così via. In matematica possiamo stu<strong>di</strong>are questi<br />
processi me<strong>di</strong>ante derivazioni <strong>di</strong> secondo, terzo... grado.<br />
E un processo caratterizzato da turbolenza? La matematica possiede<br />
dei modelli <strong>di</strong> crescente approssimazione anche per questi processi,<br />
ma qui non si tratta <strong>di</strong> descriverli matematicamente, bensì <strong>di</strong><br />
affrontarli attraverso la normale attività della nostra mente.
6.2.1. L'equilibrazione politica<br />
Non è il mio campo, quin<strong>di</strong> le poche cose che <strong>di</strong>rò probabilmente sono<br />
scontate e suoneranno ingenue se non scorrette a un esperto.<br />
Per cominciare mi sembra che l'equilibrio politico non debba essere <strong>di</strong><br />
tipo statico; anzi la sua <strong>di</strong>namicità (a più livelli) mi sembra essenziale<br />
per tener <strong>di</strong>etro alla variabilità dei rapporti sociali. È noto come certi<br />
modelli - come quello delle caste in In<strong>di</strong>a o delle classi in Occidente -<br />
abbiano per lungo tempo ridotto questa variabilità fino a sfociare in<br />
drammatiche rotture <strong>di</strong> equilibrio o in fasi <strong>di</strong> turbolento progresso,<br />
pericolose per l'equilibrio mon<strong>di</strong>ale.<br />
Perché oggi il problema dell'equilibrio non è più circoscrivibile<br />
localmente: accendere una lampa<strong>di</strong>na a New York o a Roma può voler<br />
<strong>di</strong>re togliere un bicchiere d'acqua a un africano. L'equilibrio politico è<br />
inscin<strong>di</strong>bile da quello economico. Fin quando sul nostro pianeta ci sarà<br />
chi muore per sovralimentazione e chi per fame è perlomeno ipocrita<br />
parlare <strong>di</strong> equilibrazione politica.<br />
Questa ha poi a che fare con l'autonomia del pensiero. Se il pensiero<br />
dell'in<strong>di</strong>viduo è etero<strong>di</strong>retto - e oggi tutto concorre alla sua<br />
eteronomia - è parimenti ipocrita parlare <strong>di</strong> democrazia, <strong>di</strong> libertà e<br />
così via. I sistemi democratici che ci governano saranno forse quanto<br />
<strong>di</strong> meno peggio la società umana abbia saputo realizzare, restano<br />
però ancora assai lontani da un assetto internamente ed<br />
esternamente equilibrato. La con<strong>di</strong>zione che a me sembra
in<strong>di</strong>spensabile a un serio progetto <strong>di</strong> equilibrazione mon<strong>di</strong>ale è la<br />
capacità <strong>di</strong> ogni uomo <strong>di</strong> pensare con la propria testa e <strong>di</strong> fare le sue<br />
scelte in piena autonomia. Molti obietteranno che questa autonomia<br />
non farebbe altro che rendere oltremodo precaria ogni forma <strong>di</strong><br />
equilibrio. Questo verrebbe raggiunto più facilmente da una <strong>di</strong>ttatura<br />
in grado <strong>di</strong> convincere o costringere i suoi sud<strong>di</strong>ti all'uniformità <strong>di</strong><br />
pensiero che meglio le conviene. Come se ciò non potesse accadere<br />
anche in democrazia! Basterebbe proporre una riduzione dei consumi<br />
o una <strong>di</strong>versa ripartizione delle ricchezze mon<strong>di</strong>ali, che del bambino<br />
africano non ci importerebbe più nulla.<br />
La nostra tanto sban<strong>di</strong>erata libertà finisce dove comincia il primo TG.<br />
Ma non solo lì. Finisce anche davanti alla porta <strong>di</strong> una chiesa, <strong>di</strong> una<br />
moschea, <strong>di</strong> una pagoda. L'equilibrio <strong>di</strong> cui abbiamo bisogno per<br />
sopravvivere non si concilia col pensiero religioso (o con qualsiasi<br />
altra ideologia). E non perché questa o quella religione (o ideologia)<br />
prescriva o proibisca certi comportamenti, ma perché invade le nostre<br />
menti al punto che prescrizioni e proibizioni vengono introiettate e<br />
assolutizzate nel nostro pensiero, schiavizzandolo. Non è neppure<br />
importante se e quanto ognuno <strong>di</strong> noi possa concordare con certe<br />
enunciazioni <strong>di</strong> principio, ciò che inficia queste enunciazioni è la<br />
captazione <strong>di</strong> consenso, ottenuta attraverso la negazione del pensiero<br />
autonomo. È essenziale per questo tipo <strong>di</strong> azione politica controllare i<br />
sistemi formativi della società e impe<strong>di</strong>re che le scelte del pensiero<br />
varchino i confini <strong>di</strong> una regione prestabilita. Ed è singolare - anche se<br />
facilmente comprensibile - che forze politiche se<strong>di</strong>centi favorevoli<br />
all'emancipazione del pensiero accettino supinamente questa evidente
prevaricazione, non <strong>di</strong>co evitando <strong>di</strong> osteggiarla, ma appoggiandone<br />
tutte le manifestazioni. Basta, da noi, aprire la TV per accorgersene.<br />
Che ci sia qualche interesse reciproco?<br />
Una democrazia un poco più vera <strong>di</strong> quella in cui viviamo peso che<br />
dovrebbe cercare la sua legittimazione nel consenso <strong>di</strong> persone<br />
pensanti e non con<strong>di</strong>zionate dei mass me<strong>di</strong>a. Il che, in termini<br />
economici, vuol <strong>di</strong>re investire <strong>di</strong> più (ma molto <strong>di</strong> più) nella<br />
formazione del citta<strong>di</strong>no e dei suoi formatori. Ma su questo - che è un<br />
ambito a me più congeniale - ritornerò tra breve.<br />
Prima <strong>di</strong> chiudere queste ovvie, ma per alcuni scomode,<br />
considerazioni, vorrei riportare una breve <strong>di</strong>scussione con un ragazzo<br />
<strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a, <strong>di</strong> cui non ricordo neppure il nome.<br />
"A che servono i partiti politici? A farci pensare tutti allo stesso modo.<br />
È vero che loro <strong>di</strong>cono cose <strong>di</strong>verse, ma ci costringono a scegliere tra<br />
le cose che vogliono loro. E soprattutto mettono un'etichetta alle<br />
nostre scelte quasi che per scegliere avessimo bisogno <strong>di</strong> pensare<br />
come loro, ma soprattutto a loro."<br />
"Che vuoi <strong>di</strong>re?"<br />
"Che scegliere significa scegliere un partito. Mentre io potrei scegliere<br />
una mela o una partita <strong>di</strong> calcio..."<br />
"Ma non sarebbe una scelta politica!"<br />
"E perché le scelte debbono per forza essere politiche?"<br />
"Certo che no, ma stavamo parlando <strong>di</strong> politica..."<br />
"Che vuol <strong>di</strong>re? Se si sta parlando <strong>di</strong> politica, non posso <strong>di</strong>re che<br />
preferisco una mela o una partita <strong>di</strong> calcio?"
"Lo puoi <strong>di</strong>re, puoi anche rifiutare il <strong>di</strong>scorso politico e lasciare che<br />
altri decidano per te come vuoi essere governato".<br />
"Il fatto è che non voglio essere governato, soprattutto non dai<br />
partiti".<br />
"E come vorresti risolvere il problema della convivenza civile?"<br />
"Sulla base <strong>di</strong> un programma concordato."<br />
"E come lo concorderesti tra milioni <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni."<br />
"Tramite Internet."<br />
Non so come quel ragazzo intendesse farlo, ma forse varrà la pena <strong>di</strong><br />
pensarci, in futuro.<br />
6.2.2. L'equilibrazione culturale: compromesso e<br />
me<strong>di</strong>azione<br />
Abbiamo visto come gli UCL siano delle entità metodologiche più che<br />
non ontologiche, <strong>di</strong>fficili se non impossibili a delimitarsi e largamente<br />
arbitrarie. Comunque lì si costruisca, gli UCL non sono omogenei al<br />
loro interno né privi <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zioni. Si potrebbe pensare che,<br />
<strong>di</strong>minuendone il raggio, la loro omogeneità si faccia più probabile.<br />
Questo però non sembra essere vero giacché anche gli UCL <strong>di</strong> raggio<br />
in<strong>di</strong>viduale sono spesso fortemente autocontrad<strong>di</strong>ttori, tanto che alla<br />
loro equilibrazione occorre por mano dall'esterno.<br />
Conformemente a IMC <strong>di</strong>stinguiamo tra<br />
- equilibrazione culturale e<br />
- equilibrazione metaculturale.
Come il lettore può facilmente immaginare, anche questa <strong>di</strong>stinzione è<br />
<strong>di</strong> comodo, metodologica. Abbiamo infatti sostenuto in altra parte <strong>di</strong><br />
questo libro che la con<strong>di</strong>zione culturale della nostra specie presuppone<br />
per ogni livello una componente meta, normale ad esso, componente<br />
che possiamo considerare il motore evolutivo delle culture.<br />
Trascuriamo per il momento l'evoluzione delle culture e il loro motore;<br />
supponiamole statiche, definite da leggi o convenzioni. Sappiamo che<br />
comunque sono soggette a turbolenze interne, riconducibili a squilibri<br />
che, avendo noi esclusa la componente meta - o trans - culturale, non<br />
possono che essere valutati negativamente. A livello sociale ogni<br />
cultura, anche se in apparenza stabile, ha i suoi equilibri interni,<br />
tenuti a bada dai sistemi repressivi vigenti, ma pronti a esplodere non<br />
appena questi sistemi perdono <strong>di</strong> efficacia. Ma perché dovrebbero<br />
perdere <strong>di</strong> efficacia?<br />
A causa dell'usura, come accade per ogni meccanismo. Ma che cosa<br />
produce usura nel nostro caso?<br />
Il compromesso. La repressione, anche se sostenuta da leggi, genera<br />
malcontento. E il sistema, alla lunga, non può convivere con il<br />
malcontento e deve accedere a compromessi che, sempre alla lunga,<br />
ne minano la soli<strong>di</strong>tà fino a determinarne la crisi, da cui sistema uscirà<br />
solo grazie alla componente meta. Fino ad allora il meccanismo<br />
equilibratore sarà appunto il compromesso. La funzione del<br />
(sotto)sistema giuri<strong>di</strong>co penso che sia, non tanto quella <strong>di</strong> inseguire<br />
un'irraggiungibile ideale <strong>di</strong> giustizia, quanto <strong>di</strong> rendere possibili i<br />
compromessi. Che cosa inten<strong>di</strong>amo con questo termine?
[Non ho nessuna <strong>di</strong>mestichezza né con il termine in sé (per cui provo<br />
scarsa simpatia) e ancor meno con i suoi ambiti applicativi, da quello<br />
economico a quello politico e giu<strong>di</strong>ziario. Parlo quin<strong>di</strong> da "uomo della<br />
strada" (altro termine che non amo, si provi per esempio a volgerlo al<br />
femminile), poco informato su quegli ambiti, almeno dal punto <strong>di</strong> vista<br />
tecnico.]<br />
Una nota definizione latina suona: do ut des. Poiché in qualunque<br />
controversia la ragione non sta tutta da una parte sola, si tratta <strong>di</strong><br />
cedere una parte della propria per ricevere una parte <strong>di</strong> quella<br />
avversa. Nei casi più banali la ragione viene quantificata in denaro o<br />
beni in<strong>di</strong>viduali e ripartita in base alla decisione <strong>di</strong> un tribunale. In<br />
casi più complessi a essere materia <strong>di</strong> compromesso sono le<br />
limitazioni delle libertà in<strong>di</strong>viduali, dal <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> accesso agli sta<strong>di</strong> alla<br />
detenzione in carcere. Forse è tecnicamente improprio parlare, in<br />
questi casi, <strong>di</strong> compromesso: il "colpevole" che cosa avrebbe da dare<br />
in cambio della eventuale riduzione <strong>di</strong> pena?<br />
Secondo il parere dell'uomo della strada il compromesso del do ut des<br />
non riguarda l'imputato e la giustizia ma la pubblica accusa e la<br />
<strong>di</strong>fesa, o meglio i loro rappresentanti.<br />
Il problema per costoro è <strong>di</strong> uscirne con un massimo <strong>di</strong> guadagno<br />
(anche in termini <strong>di</strong> prestigio) o con un minimo <strong>di</strong> danno e allora il<br />
compromesso è lo strumento equilibratore per eccellenza.<br />
Ma non è l'unico. Anche la me<strong>di</strong>azione lo è. Ne parleremo più<br />
<strong>di</strong>ffusamente nel paragrafo seguente a proposito dell'equilibrazione<br />
metaculturale. All'interno <strong>di</strong> una cultura pensata come immo<strong>di</strong>ficabile
la me<strong>di</strong>azione ha molto a che fare con il compromesso, anche se per<br />
alcuni tratti conviene <strong>di</strong>stinguerla.<br />
Mentre il compromesso mira a un accordo <strong>di</strong> comodo tra le parti che<br />
non coinvolge necessariamente le convinzioni in<strong>di</strong>viduali, tanto è vero<br />
che viene assai spesso <strong>di</strong>satteso, la me<strong>di</strong>azione tende ad agire più<br />
sugli stili <strong>di</strong> pensiero che su gli interessi materiali delle parti. Penso a<br />
un filosofo che me<strong>di</strong>a tra correnti <strong>di</strong> pensiero contrastanti, o a una<br />
teoria scientifica che accoglie elementi <strong>di</strong> teorie in opposizione, o<br />
infine a una religione sincretica, che tuttavia vedrei piuttosto riferita a<br />
una me<strong>di</strong>azione - o modulazione - metaculturale.<br />
Un efficace strumento equilibratore è la <strong>di</strong>sponibilità alla coesistenza<br />
del <strong>di</strong>verso o, con termine molto usato, la tolleranza. Non mi<br />
piacerebbe tuttavia essere tollerato, preferirei essere compreso o<br />
anche ignorato; più <strong>di</strong> tutto mi piacerebbe interessare qualcuno e<br />
lavorare sulla reciproca <strong>di</strong>versità. Non so se questa <strong>di</strong>sponibilità fa<br />
parte della nostra struttura antropologica; la vedo peraltro<br />
manifestarsi come curiosità già in molte specie animali considerati<br />
superiori. Vedo però anche nelle chiusure culturali, parimenti<br />
osservabili in certi animali, un meccanismo inibitore <strong>di</strong> quella<br />
<strong>di</strong>sponibilità. Vi ritornerò su.<br />
Siamo qui al confine tra il sociale e l'in<strong>di</strong>viduale, come del resto tutto<br />
ciò che riguarda la psiche umana partecipa <strong>di</strong> ambedue i versanti della<br />
nostra umanità.<br />
La cultura è cosa dell'in<strong>di</strong>viduo o della società? Credo <strong>di</strong> potermi<br />
risparmiare una risposta. Le cose si fanno più complicate quando<br />
proviamo a separare i concetti. Così molti conflitti interni all'in<strong>di</strong>viduo
provengono dai doppi coman<strong>di</strong> impartiti dai suoi due versanti. Un<br />
comportamento che avverto come naturale mi viene vietato dalla<br />
cultura. Ma sono proprio sicuro della naturalità <strong>di</strong> quel<br />
comportamento? Se la nostra stessa in<strong>di</strong>vidualità ci appare oggi<br />
multipla, quanta parte <strong>di</strong> questa molteplicità è attribuibile alla cultura?<br />
E la cultura, per esempio la nostra, occidentale, possiamo <strong>di</strong>rla<br />
unitaria?<br />
Anche a queste domande mi risparmio una risposta, lasciando al<br />
lettore <strong>di</strong> agitarle nella sua mente. Proprio il fatto che domande del<br />
genere restano più o meno aperte o riman<strong>di</strong>no ad altre domande<br />
ancora, è una <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> quanto sia <strong>di</strong>fficile l'equilibrazione<br />
interna dell'in<strong>di</strong>viduo.<br />
E qui si apre l'altro problema: <strong>di</strong> quale in<strong>di</strong>viduo si parla?<br />
Di un in<strong>di</strong>viduo normale o patologico? Abbiamo già visto quanto sono<br />
arbitrari i confini tra le due con<strong>di</strong>zioni. Una persona, apparentemente<br />
equilibrata, può soffrire proprio <strong>di</strong> questo suo equilibrio, che lo rende<br />
inadatto a condurre una vita attiva e propositiva. Come è noto l'abuso<br />
dei tranquillanti non è la migliore delle cure.<br />
Ancora una volta non vado oltre in un campo <strong>di</strong> mia incompetenza.<br />
Preferisco assumere un'ottica per me abituale, ancorché gli oggetti<br />
osservati siano sostanzialmente gli stessi.<br />
6.2.3. L'equilibrazione metaculturale: la modulazione<br />
(inter)culturale
La con<strong>di</strong>zione umana, come la stiamo vivendo oggi, richiede questo<br />
cambiamento <strong>di</strong> ottica. I problemi che fino a ieri si risolvevano, (o<br />
meglio credevamo si potessero risolvere) culturalmente, cioè ogni<br />
popolo secondo la propria cultura, oggi esplodono a problemi <strong>di</strong> tutti,<br />
planetari in un senso che va molto al <strong>di</strong> là dell'orizzonte antropico cui<br />
eravamo abituati. Cambia la composizione dell'atmosfera, cambia il<br />
clima, cambia la fisionomia della terra, spariscono in tempi brevissimi<br />
specie animali e vegetali e ancora <strong>di</strong> più ne spariranno negli anni<br />
futuri, quelle che restano somigliano sempre meno ai loro antenati...<br />
In una parola gli equilibri - <strong>di</strong>namici sì, ma legati a perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> migliaia,<br />
milioni <strong>di</strong> anni - si stanno vistosamente rompendo, siamo entrati in<br />
una fase <strong>di</strong> turbolenza ambientale a cui non eravamo preparati,<br />
cosicché tocca ricorrere, tar<strong>di</strong>vamente, ai ripari. Di chi è la colpa?<br />
Della natura, dell'uomo, dei paesi ricchi? Domande ormai oziose,<br />
anche perché ogni nostra risposta non farebbe che rimandare ad altre<br />
colpe precedenti e queste ad altre ancora in una catena senza fine che<br />
avrebbe come unico effetto la paralisi del pensiero propositivo. E <strong>di</strong><br />
questo abbiamo il massimo bisogno se vogliamo sopravvivere. Fino a<br />
ieri, ripeto, il pensiero propositivo poteva nascere dall'interno <strong>di</strong><br />
qualche cultura, da una riflessione metaculturale.<br />
Lo ve<strong>di</strong>amo si può <strong>di</strong>re quoti<strong>di</strong>anamente. Le soluzioni endoculturali,<br />
volte alla salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> una singola cultura, generano scontri<br />
interculturali che sempre più ci avvicinano alla catastrofe nucleare.<br />
Alcune soluzioni cominciano a essere <strong>di</strong>scusse a livello planetario - il<br />
protocollo <strong>di</strong> Kyoto, la non proliferazione delle armi atomiche,<br />
l'abolizione della pena <strong>di</strong> morte, la conservazione dell'ambiente, il
ispetto dei <strong>di</strong>ritti umani... Si vanno formando o acquistano<br />
consistenza strutture o organismi sovranazionali con caratteristiche<br />
interculturali (ONU, UNESCO, tribunale de l'Aja); la stessa espansione<br />
capitalistica non sembra arrestarsi ai confini tra le culture così come i<br />
modelli socio-economici, politici (socialismo, capitalismo e modelli<br />
interme<strong>di</strong>), anche se originariamente proposti entro particolari UCL,<br />
vengono, ormai da qualche secolo, ripresi dalle più <strong>di</strong>verse culture:<br />
così il modello nato dalle rivoluzioni americana e francese, così il<br />
modello socialcomunista, proposto dalla cultura dell'800 e <strong>di</strong>lagato in<br />
Cina, in parti dell'Africa, nell'America Latina... Ma il processo può<br />
essere in seguito a ritroso fino all'affermarsi delle gran<strong>di</strong> religioni<br />
post-giudaiche, il Cristianesimo e l'Islam, fortemente universaliste, o,<br />
più in<strong>di</strong>etro ancora, alla concessione della citta<strong>di</strong>nanza romana a tutti<br />
i sud<strong>di</strong>ti dell'Impero.<br />
Il fenomeno non è quin<strong>di</strong> recente, non perlomeno su scala storica. La<br />
singolarità della situazione culturale o<strong>di</strong>erna consisterebbe, come già<br />
osservato, nella non più sostenibile accelerazione <strong>di</strong> un processo per<br />
altro verso normale nella specie umana, forse ad<strong>di</strong>rittura in tutta la<br />
sfera biologica. Sappiamo però anche che, contestualmente ai<br />
processi <strong>di</strong> integrazione - delle specie biologiche negli ecosistemi,<br />
degli in<strong>di</strong>vidui nelle società ecc. - corrono i processi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione<br />
- specifica, culturale, in<strong>di</strong>viduale, e che il quadro del vivente ci viene<br />
offerto proprio dal bilanciamento, dall'equilibrazione <strong>di</strong> questi due<br />
processi. Ed è <strong>di</strong> fronte a un problema <strong>di</strong> equilibrazione, anzi <strong>di</strong><br />
riequilibrazione <strong>di</strong> un rapporto entrato in crisi <strong>di</strong> turbolenza, che ci<br />
troviamo oggi posti, e non sembra che ci sia più il tempo per fermarci
a rimpiangere una pregressa con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> culturalità ristretta alla cui<br />
protratta permanenza dobbiamo appunto l'attuale crisi.<br />
Eccoci quin<strong>di</strong> nuovamente all'argomento del presente capitolo:<br />
l'equilibrazione, non più culturale, ma metaculturale come con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong> sopravvivenza. Ammettiamo che sia necessaria, è anche<br />
sufficiente? È una domanda che si presenta spesso nelle fasi <strong>di</strong><br />
transizione. Mentre la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> necessità è constatabile me<strong>di</strong>ante<br />
un'analisi del presente e del passato, quella <strong>di</strong> sufficienza è solo<br />
ipotizzabile, per giunta con una certa dose <strong>di</strong> ottimismo. Non so se la<br />
transizione alla fase metaculturale sarà sufficiente a garantirci la<br />
sopravvivenza, potrebbe essere già troppo tar<strong>di</strong> o le resistenze<br />
culturali troppo forti... Sono però convinto che senza quella<br />
transizione le probabilità <strong>di</strong> sopravvivenza sono ridotte a zero.<br />
Che cosa occorre perché la nostra specie raggiunga il nuovo sta<strong>di</strong>o<br />
antropologico che abbiamo chiamato metaculturale?<br />
Anzitutto va chiarito - e lo abbiamo già detto molte volte - che il<br />
nuovo sta<strong>di</strong>o non contrad<strong>di</strong>ce né cancella il precedente. Non solo le<br />
culture conserveranno intatte le loro valenze storiche, formative, <strong>di</strong><br />
pensiero, ma le vedranno accresciute dalla relativizzazione che le<br />
sottrae a un'inverificabile assolutezza. Inoltre sappiamo dalla biologia<br />
che la conservazione è premessa in<strong>di</strong>spensabile al cambiamento. E<br />
ancora: l'apertura delle frontiere culturali, la caduta <strong>di</strong> molti altri muri,<br />
favorirà - ma la cosa è già in atto da tempo - la fecondazione<br />
reciproca <strong>di</strong> stili <strong>di</strong> pensiero <strong>di</strong>versi. Il nostro cervello sembra, al<br />
contrario delle culture, non produrre confini, muri se non metodologici<br />
aventi come scopo il proprio abbattimento. Se questi confini, questi
muri si soli<strong>di</strong>ficano a ideologie, ciò avviene ad opera delle culture. La<br />
transizione allo sta<strong>di</strong>o metaculturale dovrebbe liberare le potenzialità<br />
della nostra mente, non più imbrigliata dalle costrizioni culturali, ma<br />
affidata solamente alla rete comunicazionale delle cellule cerebrali e<br />
alle sue pressoché infinite possibilità combinatorie. Ma, ripeto, che<br />
cosa occorre per giungere a questo?<br />
Un primo passo cre<strong>di</strong>amo <strong>di</strong> averlo in<strong>di</strong>viduato nella modulazione<br />
culturale. Il termine modulazione è ben noto da vari ambiti <strong>di</strong>sciplinari<br />
(fisica, musica, telecomunicazioni...) e in<strong>di</strong>ca genericamente una<br />
transizione da un modo <strong>di</strong> essere, o <strong>di</strong> apparire, a un altro. Spesso si<br />
sottintende che tra i due mo<strong>di</strong> vi sia corrispondenza biunivoca o<br />
almeno qualche analogia che faciliti la transizione. Così in musica la<br />
modulazione conduce da una tonalità A a una tonalità B avente <strong>di</strong><br />
solito una struttura interna identica o quasi a quella della A.<br />
Applicato, come qui facciamo, al termine cultura - modulazione<br />
culturale - sta a significare l'azione <strong>di</strong> una cultura su un'altra,<br />
ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong> un singolo dato (unità) culturale su un'altro della stessa<br />
o <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa cultura. Una normale traduzione - per esempio<br />
dall'inglese italiano -, rientra in questo concetto, in quanto il<br />
passaggio non è del tutto neutro ma implica qualche adattamento<br />
grammaticale sintattico, spesso anche <strong>di</strong> significato. L'interpretazione<br />
<strong>di</strong> un testo <strong>di</strong>fficile attraverso l'adozione <strong>di</strong> un particolare punto <strong>di</strong><br />
vista è un altro esempio <strong>di</strong> modulazione culturale. Il caso poi<br />
dell'antica Grecia, che, conquistata con le armi da Roma, la conquistò<br />
a sua volta culturalmente, è efficacemente analizzabile, anche nei<br />
dettagli, per mezzo del termine in questione. L'azione modulante <strong>di</strong>
una cultura su un'altra è comunque <strong>di</strong> tutta normalità e anche noi la<br />
viviamo quoti<strong>di</strong>anamente, seppure non sempre in piena<br />
consapevolezza. Le culture considerate più forti e autonome sono <strong>di</strong><br />
fatto il prodotto <strong>di</strong> estese contaminazioni che, lungi dal togliere loro<br />
autonomia, le hanno anzi costruite e rafforzate proprio attraverso<br />
continue modulazioni culturali, interne ed esterne. L'attuale cultura<br />
occidentale - seppure è possibile parlarne al singolare - è un<br />
complesso sincretismo <strong>di</strong> culture (greco-romana, cristiana, germanica<br />
con profon<strong>di</strong> influssi me<strong>di</strong>o-orientali e arabi) <strong>di</strong> cui oggi si vorrebbe<br />
celebrare l'originalità.<br />
L'opposizione tra autonomia e modulazione culturale va <strong>di</strong>ssolta<br />
analiticamente fin dalle prime fasi formative. Dissolta in quanto<br />
opposizione, va però mantenuta come <strong>di</strong>stinzione (due concetti<br />
<strong>di</strong>stinti non per questo si oppongono l'uno all'altro: la guerra non<br />
nasce dalla <strong>di</strong>versità ma dall'opposizione inanalizzata).<br />
Ma il termine modulazione può spingere la sua semantica anche oltre.<br />
"Ho capito: non è il sole che gira intorno alla terra, ma è la terra che<br />
gira intorno al proprio asse."<br />
Che vuol <strong>di</strong>re quell'"Ho capito"?<br />
Possiamo vedervi la modulazione <strong>di</strong> un fenomeno percepito attraverso<br />
la proiezione <strong>di</strong> un'unità culturale (il modello copernicano). Una<br />
<strong>di</strong>versa unità culturale (per esempio il modello tolemaico) indurrebbe<br />
una <strong>di</strong>versa comprensione:<br />
"Ho capito: non è la terra a girare su se stessa, ma è l'universo che<br />
gira intorno al suo centro, appunto la terra."
Sussistono ancora argomenti a favore <strong>di</strong> questo secondo "Ho capito"<br />
(per esempio che, non essendovi un centro assoluto dell'universo,<br />
qualsiasi suo punto, anche la terra, può essere assunto come tale).<br />
"Capire": noi capiamo me<strong>di</strong>ante i concetti elaborati dalla nostra<br />
cultura; altre culture, che hanno elaborato altri concetti, capiscono<br />
<strong>di</strong>versamente. È probabile che molti dei concetti <strong>di</strong> uso comune siano<br />
presenti anche in altre culture; questa loro eventuale altra presenza<br />
va comunque verificata. Ciò vale anche all'interno <strong>di</strong> una stessa<br />
cultura, quando vi siano per esempio marcate <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> età o <strong>di</strong><br />
con<strong>di</strong>zione sociale. Possiamo ad<strong>di</strong>rittura attribuire a un'anomala<br />
modulazione culturale e l'apparente <strong>di</strong>storta comprensione in un<br />
portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap psichico o in un caso estremo <strong>di</strong> emarginazione<br />
culturale.<br />
Un grafico commentato:
La riflessione metaculturale riconduce le percezioni ideologizzate <strong>di</strong><br />
realtà alle modulazioni culturali che le hanno prodotte e <strong>di</strong> lì all'idea<br />
stessa <strong>di</strong> realtà.<br />
6.2.4. L'equilibrazione metaculturale: la catabasi<br />
metaculturale<br />
Traggo questo sotto paragrafo dal testo base su IMC (B.Porena 1999).<br />
Nel senso qui dato la catabasi, che per gli antichi era metafora <strong>di</strong> un<br />
cammino autoriflessivo nelle profon<strong>di</strong>tà dell'io, si propone fuori da
ogni contesto mitico o psicoanalitico e assume connotazioni<br />
meramente tecniche, come conseguenza <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> IMC.<br />
Data una proposizione p0, questa esibirà, per IMC, una componente<br />
culturale (pertinente cioè a uno o più UCL) + un residuo che<br />
supponiamo non culturalizzato. Analizziamo ora questo residuo: il<br />
risultato sarà un insieme <strong>di</strong> p1,2...n che si troveranno ciascuna delle<br />
stesse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> p0. Possiamo quin<strong>di</strong> ripetere su <strong>di</strong> esse le stesse<br />
operazioni che abbiamo adottato per p0, ottenendo un altro sciame <strong>di</strong><br />
proposizioni e così via. IMC non fa altro che affermare non esservi un<br />
limite inferiore a questo processo: la catabasi non raggiungerà mai un<br />
fondo, o, ciò che è lo stesso, è destinata a perdersi in UMC. Il<br />
problema è allora: come, a che punto, con che motivazioni arrestare<br />
la catabasi.<br />
A un eguale non risultato saremmo arrivati percorrendo la strada delle<br />
componenti culturali <strong>di</strong> p0, anche qui scendendo anello per anello<br />
lungo la catena dei riman<strong>di</strong> culturali e il problema sarebbe stato<br />
ancora una volta l'arresto. Tocchiamo qui con mano ciò che <strong>di</strong>stingue<br />
IMC dallo scetticismo integrale, dal nichilismo, ciò che impe<strong>di</strong>sce alla<br />
catabasi <strong>di</strong> perdersi in UMC e consente all'uomo <strong>di</strong> conservarsi nella<br />
sua <strong>di</strong>gnità culturale: l'autodeterminazione dell'arresto.<br />
Il termine va interpretato, soprattutto per l'estensione da dare a<br />
quell'auto... Più che intenderlo in forma personalizzata, come atto <strong>di</strong><br />
arbitrio in<strong>di</strong>viduale, converrà riferirlo a qualcosa <strong>di</strong> verificabile<br />
intersoggettivamente, per esempio al concetto <strong>di</strong> progetto. La<br />
catabasi metaculturale fa cioè parte della progettualità umana, finita<br />
come tutto ciò che la riguarda. Lo stesso progetto che innesca la
catabasi deve saperne determinare l'arresto se non vuole correre il<br />
rischio dell'annichilimento. Il problema è <strong>di</strong> tipo compositivo e l'unico<br />
ancoraggio possibile sta nel progetto <strong>di</strong> controllo associato al<br />
problema stesso. Se questo sistema è fortemente personalizzato,<br />
l'arresto verrà percepito come immotivato e arbitrario. Se viceversa è<br />
frutto <strong>di</strong> un consenso sociale più o meno ampio, ne intenderanno le<br />
ragioni almeno i consenzienti.<br />
La catabasi metaculturale non ha cioè né può avere come fine il<br />
raggiungimento <strong>di</strong> una verità extraculturale ma solo <strong>di</strong> un livello<br />
analitico su cui vi sia un sufficiente consenso sociale.IMC è un'ipotesi<br />
pratica, costruita soprattutto per la composizione del <strong>di</strong>verso e<br />
conseguentemente per la sopravvivenza; la catabasi metaculturale ne<br />
costituisce la fase applicativa e il suo arresto averrà quando sia stato<br />
raggiunto un livello che registri l'unificazione <strong>di</strong> ciò che ai livelli<br />
superiori si manifesta come <strong>di</strong>versità, in altre parole un livello <strong>di</strong><br />
accordo tra i contendenti.<br />
Accordo significa così la costruzione o composizione <strong>di</strong> un UCL<br />
comune, la cui estensione sia finita ma tale da garantire il<br />
mantenimento delle <strong>di</strong>versità e nel contempo favorirne la reciproca<br />
modulazione.<br />
Catabasi metaculturale e modulazione (inter)culturale sono pertanto i<br />
due principali strumenti <strong>di</strong> equilibrazione metaculturale. Spero <strong>di</strong><br />
essere riuscito a mostrare come per noi modulazione e compromesso<br />
non siano la stessa cosa.
6.2.5. L'equilibrazione metaculturale come progetto<br />
formativo<br />
Nel nostro cammino verso l'equilibrazione degli stili <strong>di</strong> pensiero che<br />
concorrono a muovere la nostra mente siamo finalmente giunti alla<br />
fase pratica che per noi è essenzialmente formativa e limitata ai primi<br />
gra<strong>di</strong>, salvo che per la musica dove l'esplorazione si è addentrata<br />
nello specifico.<br />
In un certo senso il presente libro dovrebbe cominciare a questo<br />
punto, mentre il lettore si accorge che sta finendo. In effetti questa<br />
come le altre trattazioni teoriche che mi è capitato <strong>di</strong> esporre le<br />
considero come propedeutiche agli scritti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pratico: lo stesso<br />
testo-base su IMC è stato pensato come premessa a La pratica<br />
culturale <strong>di</strong> base, sud<strong>di</strong>visa nei tre ambiti, musicale, grafico-visivo e<br />
verbale. Così anche questo testo sugli stili <strong>di</strong> pensiero ha la sua<br />
ricaduta pratico-operativa del nostro sito, che peraltro è già<br />
ampiamente presente nelle pagine precedenti.<br />
E il capitolo che dovrebbe aprire il libro a una fase attuativa si trova a<br />
chiuderlo con l'invito a rivolgersi altrove. Per rendere in qualche modo<br />
allettante questo invito, o almeno tale da destare qualche curiosità,<br />
richiamerò alcuni dei progetti <strong>di</strong>dattici e dei no<strong>di</strong> formativi contenuti<br />
nel sito o in altri nostri scritti non pubblicati o <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile accesso.<br />
Non sempre negli esempi riportati è evidente il fine dell'equilibrazione<br />
metaculturale. Il termine è per noi <strong>di</strong> acquisizione recente: <strong>di</strong>cendo<br />
"equilibrazione" poniamo l'accento su "azione" e non su "equilibrio",<br />
giacché, mentre questo suggerisce l'idea <strong>di</strong> stasi, quella dà l'idea <strong>di</strong>
movimento, trasformazione, processo. "Omeoresi" a correzione <strong>di</strong><br />
"omeostasi": equilibrazione cioè nel <strong>di</strong>venire, non nell'immobilità.<br />
L'equilibrazione <strong>di</strong> forze interne a una cultura l'abbiamo chiamata<br />
culturale; quando le forze in gioco appartengono a culture <strong>di</strong>verse,<br />
anche in reciproca opposizione, parliamo <strong>di</strong> equilibrazione<br />
metaculturale i cui principali strumenti li abbiamo in<strong>di</strong>viduati nella<br />
modulazione (inter)culturale e nella catabasi metaculturale.<br />
(Dal "nodo formativo" modulare)<br />
Proponete a un gruppo <strong>di</strong> bambini (per esempio a una classe) il<br />
seguente tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione:<br />
"Il bambino e la famiglia".<br />
Dopo una prima fase genericamente esplorativa concentrate il<br />
<strong>di</strong>battito sui seguenti punti:<br />
- il bambino è proprietà dei genitori?<br />
- il bambino è un in<strong>di</strong>viduo autonomo fin dalla nascita?<br />
- il bambino appartiene alla società in cui vive?<br />
- i genitori hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> educarlo come vogliono?<br />
- la società ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> formarlo secondo i suoi principi e costumi?<br />
- la scuola ha il dovere <strong>di</strong> formare il bambino così come la locale<br />
società lo richiede?<br />
Domande <strong>di</strong> questo tipo, eventualmente appoggiate da esempi<br />
concreti, possono essere messe a <strong>di</strong>scussione già in una seconda o<br />
terza elementare, così come nelle assemblee con i genitori. Essenziale<br />
è che il modello adottato nella <strong>di</strong>scussione sia il circuito<br />
autogenerativo con piena parità dei partecipanti. Le risposte saranno
<strong>di</strong>fferenti, talora ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong>vergenti; non è importante che si<br />
giunga a un risultato univoco, importante è che intorno a questi -<br />
come ad altri - problemi si attivi la mente, perché non accolga<br />
passivamente quanto le viene detto nell'interesse <strong>di</strong> qualcuno o<br />
qualcosa d'altro. Importante è inoltre che ciascuno cerchi <strong>di</strong> motivare<br />
quanto più possibile le proprie affermazioni. I ragazzi, ma anche gli<br />
adulti spesso si accontentano <strong>di</strong> affermare o <strong>di</strong> negare, magari<br />
alzando la voce o servendosi <strong>di</strong> formule-trappola tipo: "è risaputo<br />
che", "non mi puoi negare", "è evidente che"... o ancora<br />
richiamandosi a qualche autorità del presente o del passato: "lo <strong>di</strong>ce<br />
la mamma (o il Papa o il capo del governo, o Platone), non lo <strong>di</strong>co<br />
io...".<br />
Nel momento che ci sforziamo <strong>di</strong> motivare, <strong>di</strong> appoggiare con<br />
argomenti ciò che <strong>di</strong>ciamo, ci ren<strong>di</strong>amo conto <strong>di</strong> quanta parte del<br />
nostro pensiero è predeterminata dalla cultura, quanto quest'ultima ci<br />
tenga costantemente sotto gli occhi <strong>di</strong> uno specchio, entro il quale<br />
ve<strong>di</strong>amo riflesso il mondo. E non abbiamo nessuna garanzia che<br />
questo specchio non sia deformante.<br />
L'argomentazione può tuttavia non essere sufficiente: spesso gli<br />
argomenti assunti a <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> un'asserzione e dettati dalla cultura<br />
localmente dominante sono assai <strong>di</strong>fficili da penetrare criticamente.<br />
- "Qual è per te il gioco più bello?"<br />
- "Che domande! Il calcio!"<br />
- "Perché proprio il calcio?"<br />
- "Perché piace a tutti, basta guardare quello che succede agli<br />
europei..."
- "E ti sembra una buona ragione? In America per esempio<br />
preferiscono il rugby."<br />
- "Già, ma quelli sono americani!"<br />
- "Bè, non sono fatti come noi?"<br />
- "Sì, ma hanno altre abitu<strong>di</strong>ni..."<br />
- "Allora a te il calcio piace perché ci sei abituato..."<br />
- "Forse..."<br />
- "Ma chi ti ci ha abituato?"<br />
- "Non so, forse quelli che giocano al calcio..."<br />
- "Hai mai sentito parlare del gatto che si morde la coda?"<br />
A questo punto l'amico del calcio è costretto portare qualche<br />
argomento più convincente a favore dello sport pre<strong>di</strong>letto e forse si<br />
accorgerà man mano che tutti i suoi argomenti fanno capo a qualche<br />
luogo comune, a convinzioni acquisite, introiettate, sono in altre<br />
parole culturalmente modulati.<br />
(Dal progetto...)<br />
Le api e la geometria<br />
(Un <strong>di</strong>alogo fittizio)<br />
E=Enrico S=Sara<br />
S. Ma che <strong>di</strong>ci? Che le api stu<strong>di</strong>ano la geometria...<br />
E. E come lo spieghi sennò?<br />
S. Spieghi che cosa?<br />
E. Che le celle dei loro ni<strong>di</strong> sono esagoni regolari.
S. Che <strong>di</strong>scorsi! Avresti detto lo stesso se fossero state dei quadrati o<br />
dei cerchi!<br />
E. Un momento! Pensiamoci meglio... se le api costruissero delle celle<br />
circolari, così<br />
tra cella e cella resterebbero degli spazi vuoti, dove potrebbero<br />
nascondersi dei piccoli intrusi, pericolosi per le larve delle api...<br />
Inoltre la costruzione sarebbe antieconomica perché non sfrutterebbe<br />
tutto lo spazio <strong>di</strong>sponibile.<br />
S. Già, ma se le celle fossero tutte quadrate o triangolari, così:<br />
non ci sarebbero spazi vuoti...<br />
o così ,<br />
E. Giusto, ma il miele che si accumula negli angoli sarebbe raggiunto<br />
con <strong>di</strong>fficoltà dalle larve, che non ce la farebbero ad arrivare fino in<br />
fondo...<br />
S. Ma anche gli esagoni hanno degli angoli...
E. Sì ma sono più ottusi... l'esagono è più simile a un cerchio, dove <strong>di</strong><br />
angoli non ce ne sono per niente.<br />
S. Ma allora un ottagono, un decagono ecc. sono ancora più simile a<br />
un cerchio...<br />
E. È vero... ma la geometria ci <strong>di</strong>ce che, dopo il triangolo equilatero e<br />
il quadrato, l'esagono è l'unico poligono regolare con cui è possibile<br />
ricoprire senza residui una superficie piana.<br />
S. E le api come lo sanno?<br />
E. Qui sta il punto. Chi glielo insegna?<br />
S. Non lo so, ma non credo che vadano a scuola <strong>di</strong> geometria...<br />
E. Senti: questo nostro è un <strong>di</strong>alogo fittizio e neppure noi siamo veri<br />
<strong>di</strong>aloganti. Lasciamo che siano i nostri lettori a proseguire nel<br />
ragionamento...<br />
In<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> lavoro<br />
Sara ed Enrico, come si <strong>di</strong>ce, gettano la spugna, cioè si arrendono e<br />
invitano noi a continuare...<br />
Se nessuno insegna alle api che cosa sono gli esagoni regolari e come<br />
si fa costruirli, come fanno a saperlo?<br />
Un bambino, per esempio sa come si fa <strong>di</strong>gerire?<br />
Eppure <strong>di</strong>gerisce.<br />
Il cuore sa come si fa a far circolare e sangue?<br />
Eppure lo fa.<br />
La mente sa come si fa a pensare?<br />
Eppure pensa.
E così un'ape forse non sa come si fabbricano gli esagoni eppure li<br />
fabbrica.<br />
Nessun animale sa come si costruisce un suo simile eppure tutti gli<br />
animali si riproducono...<br />
Sono la stessa cosa fare e sapere <strong>di</strong> fare?<br />
Per sapere cosa sta facendo devo potermi osservare come<br />
dall'esterno. Devo in un certo senso sdoppiarmi: io che faccio, io che<br />
mi osservo fare...<br />
A questa nostra capacità <strong>di</strong>amo il nome <strong>di</strong> consapevolezza.<br />
Non sappiamo se e fino a che punto ce l'abbiano anche gli altri<br />
animali. Sappiamo però che non <strong>di</strong> tutto ciò che facciamo siamo<br />
consapevoli. E così può essere che le api costruiscano i loro esagoni<br />
senza esserne consapevoli.<br />
Ma la domanda resta, anzi si fa ancora più acuta. Se nessuno gliel'ha<br />
insegnato e neppure loro se ne rendono conto, come sono arrivate al<br />
modello esagono regolare?<br />
Sappiamo dalla geometria che l'esagono regolare è la figura più simile<br />
al cerchio con cui tappezzare senza residui una superficie piana, e che<br />
quin<strong>di</strong> è il modello più economico per chi voglia usare al meglio tutto<br />
lo spazio <strong>di</strong>sponibile.<br />
Supponiamo <strong>di</strong> chiedere a un computer quale sia la figura geometrica<br />
regolare in grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare queste due esigenze:<br />
- essere il più possibile simile al cerchio<br />
- poter essere replicata fino a ricoprire senza residui una superficie<br />
data.
Il computer vi in<strong>di</strong>cherà senza incertezze l'esagono e non avrebbe<br />
senso chiedersi se se ne rende conto.<br />
Le api avrebbero quin<strong>di</strong> incorporato un computer?<br />
Ma il computer l'abbiamo inventato noi uomini.<br />
E chi lo avrebbe installato nelle api?<br />
Forse non siamo stati noi a inventarlo, ma solo a scoprire la possibilità<br />
<strong>di</strong> costruirlo.<br />
Continuate pensare...<br />
(Da Esperienze verbali 2.2. Linearità funzionale)<br />
Le funzioni del linguaggio verbale è probabile si siano sviluppate in<br />
stretto rapporto con le necessità <strong>di</strong> sopravvivenza. È utile quin<strong>di</strong><br />
indagarle ed esercitarle entro processi reali o verosimili. Altrettanto<br />
utile e forse più <strong>di</strong>vertente applicarle a casi immaginari, come accade<br />
nelle fiabe e nelle favole.<br />
Esempio: (Storia <strong>di</strong> fantasia, poche parole più volte ripetute 6 )<br />
C'era una volta un orologio che si era stancato <strong>di</strong> fare ogni giorno lo<br />
stesso lavoro: misurare i secon<strong>di</strong>, i minuti, le ore, girare sempre le<br />
lancette senza mai cambiare verso, sempre alla stessa velocità, senza<br />
mai riposare un'ora, un minuto, un secondo.<br />
Così decise <strong>di</strong> fermarsi ogni tanto a riposare per qualche secondo o<br />
minuto. Prima qualche volta al giorno, poi sempre più spesso: dai<br />
secon<strong>di</strong> passò ai minuti, poi, un giorno, alle ore. Poi decise <strong>di</strong> girare al<br />
contrario, cambiare verso ogni tanto. Fermarsi, ripartire. Certo, era<br />
molto più <strong>di</strong>vertente, la vita era davvero un'altra cosa.<br />
6 Autore: Angelo Bernar<strong>di</strong>ni
Peccato che proprio allora si ritrovò tra i ferri vecchi, gettato via in<br />
soffitta, inutile. Per lui il tempo si era fermato...<br />
Questo testo, analizzato in circuito autogenerativo al Centro, ha<br />
prodotto tra l'altro le seguenti osservazioni:<br />
- sembra una parabola sulla funzionalità: venuta meno la sua<br />
funzione, anche l'orologio perde la sua in<strong>di</strong>vidualità...<br />
- ... già ma la funzione dell'orologio è esterna, è per chi se ne serve;<br />
lui stesso neppure se ne rende conto...<br />
- ... vista dall'interno, quella che da fuori appare come una funzione,<br />
è una prigione, un con<strong>di</strong>zionamento da cui lui si vuole liberare...<br />
- ... le finalità interne all'orologio non coincidono con quelle esterne:<br />
lui vorrebbe godersi la vita, cambiandola a suo piacimento, la sua<br />
funzione (esterna) però glielo impe<strong>di</strong>sce...<br />
- ... cose che non capitano solo agli orologi.<br />
- Storiella interessante perché (auto)riflessiva...<br />
- ... permette <strong>di</strong> analizzare per così <strong>di</strong>re le due facce - esterna-<br />
interna - <strong>di</strong> qualsiasi funzione...<br />
- ... e suggerisce anche implicitamente un modello <strong>di</strong> integrazione<br />
sociale: far coincidere, nei limiti del possibile, le due facce <strong>di</strong> una<br />
funzione...<br />
- ... armonizzare cioè le esigenze interne, in<strong>di</strong>viduali, con le esigenze<br />
esterne, sociali...<br />
- ... mi <strong>di</strong>ci niente...<br />
È più che evidente che con queste casuali citazioni abbiamo appena<br />
sfiorato il tema dell'equilibrazione metaculturale come progetto
formativo. Eppure lo consideriamo il tema centrale della formazione al<br />
punto in cui siamo pervenuti.<br />
A <strong>di</strong>re il vero, <strong>di</strong> tale tema non si trovano a tutt'ora che deboli tracce,<br />
per giunta <strong>di</strong> netto profilo ideologico (tolleranza, reciproca<br />
comprensione, uguaglianza, fratellanza...). In altri ambiti -<br />
sociopolitico, psicologico, legislativo - si è decisamente più avanti, nel<br />
senso che alle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> principio fanno seguito in<strong>di</strong>cazioni<br />
operative che, nonostante siano ancora insufficienti, entrano tuttavia<br />
nella nostra quoti<strong>di</strong>anità. L'ambito formativo, che riteniamo prioritario<br />
perché anticipa il domani, è viceversa il più attardato, in particolare<br />
nei suoi gra<strong>di</strong> superiori.<br />
Qui tutto si concentra ancora sui contenuti, oggi <strong>di</strong> molto eccedenti le<br />
capacità <strong>di</strong> stoccaggio della mente umana e, oltretutto, soggetti a<br />
sempre più rapido invecchiamento. Mentre le strutture profonde che<br />
permettono alla mente l'approccio critico-riflessivo a qualsiasi<br />
contenuto evolvono in tempi biologici, incomparabilmente più lenti<br />
dell'evoluzione dei contenuti.<br />
Sono cose che tutti sanno... E allora perché non focalizzare la<br />
formazione <strong>di</strong> tutti sugli aspetti psicologici, metodologici, metaculturali<br />
e solo secondariamente (nel momento cioè <strong>di</strong> ingresso nel mondo<br />
settorializzato del lavoro) contenutistici? È ben vero che le strutture <strong>di</strong><br />
approccio non hanno consistenza autonoma, hanno cioè bisogno dei<br />
contenuti per riconoscersi e svilupparsi, ma in una prospettiva del<br />
genere sono i contenuti a essere funzionali alle strutture <strong>di</strong> approccio<br />
e non viceversa come oggi accade. Questo cambio <strong>di</strong> prospettiva, che<br />
mi appare essenziale per la sopravvivenza, impone un ra<strong>di</strong>cale
ipensamento delle strutture dei percorsi formativi, <strong>di</strong> conseguenza<br />
anche adeguati investimenti. La società, la famiglia, il semplice<br />
citta<strong>di</strong>no sono oggi <strong>di</strong>sposti a riconsiderare inveterate convinzioni in<br />
ambito educativo?<br />
7. Postfazione<br />
Perché la società, la famiglia, il semplice citta<strong>di</strong>no dovrebbero essere<br />
<strong>di</strong>sposti al "ra<strong>di</strong>cale ripensamento" <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>ceva? Perché l'hanno<br />
letto su un libro con glielo ha detto uno che neppure ha le carte in<br />
regola per parlare <strong>di</strong> questo argomento?<br />
Siamo ancora legati alla settorialità universitaria: <strong>di</strong> pedagogia può<br />
parlare solo un laureato in pedagogia, <strong>di</strong> psicologia un laureato in<br />
psicologia. Con ciò non voglio negare valore alle specializzazioni<br />
professionali. Se voglio costruirmi una casa chiederò l'aiuto piuttosto<br />
<strong>di</strong> un ingegnere o <strong>di</strong> un architetto che <strong>di</strong> un farmacista. Siccome però<br />
nella casa ci devo vivere io, il mio parere resterà vincolante anche per<br />
quelli. E così, dovendo io convivere con la mia psiche, non la affiderò<br />
totalmente allo psicologo o allo psicanalista ma cercherà <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogare<br />
con loro, e lo stesso farò con il pedagogista per l'attività formativa.<br />
Ci sono alcune <strong>di</strong>scipline come le due sunnominate che fanno parte<br />
del nostro quoti<strong>di</strong>ano e su cui molti hanno riflettuto anche senza<br />
essere del mestiere. Wagner era psicanalista almeno quanto Freud<br />
anche se normalmente viene rubrucato altrove.
Si parla della scuola <strong>di</strong> tutti e in effetti a scuola ci sono andati tutti (o<br />
quasi), ma solo in pochi sono chiamati a legiferare su <strong>di</strong> essa. Tutti<br />
facciamo parte della società e ne siamo in qualche modo esperti, ma<br />
quando nelle se<strong>di</strong> ufficiali si parla <strong>di</strong> darle un'organizzazione piuttosto<br />
che un'altra, sono in pochi a decidere e non sempre per il suo bene.<br />
Ma - si <strong>di</strong>rà - abbiamo la democrazia, che cosa si vuole <strong>di</strong> più?<br />
La partecipazione, <strong>di</strong>cono in molti, ma nessuno sa come far<br />
partecipare tutti gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> una società a una <strong>di</strong>scussione che la<br />
riguarda. Ma forse il punto non è questo, e la scappatoia della<br />
democrazia rappresentativa è ancora valida, a una con<strong>di</strong>zione: che<br />
l'elettore sia il più possibile consapevole delle sue scelte e delle<br />
motivazioni che lo spingono a farle.<br />
Perché dovremmo dubitare della buona fede degli elettori, o meglio<br />
della loro competenza in materia? Vorremmo avere come elettori solo<br />
degli esperti politologi? O dei sociologi, degli economisti?<br />
Ci basterebbe della gente onesta, che sa pensare. Anzi, credo<br />
socraticamente che chi pensa bene non può che farlo onestamente.<br />
L'onestà non è un ornamento del pensiero, è il suo strumento <strong>di</strong><br />
autocontrollo. La morale non c'entra. E come si fa a pensare bene?<br />
Tutti pensano, ma come <strong>di</strong>stinguere chi pensa bene da chi pensa<br />
male? Non credo in una netta <strong>di</strong>stinzione tra bene e male. Chi, prima<br />
<strong>di</strong> Copernico, avesse sostenuto che la terra gira intorno al sole,<br />
avrebbe pensato male sia per l'opinione comune che per la scienza<br />
ufficiale con te, più tar<strong>di</strong> è accaduto il contrario. Una migliore<br />
<strong>di</strong>stinzione si ha tra chi pensa con la testa propria e chi con la testa<br />
altrui. E a questa autonomia mentale abbiamo de<strong>di</strong>cato molte delle
nostre ricerche pedagogiche... per arrivare alla conclusione che una<br />
totale autonomia del pensiero è probabilmente irraggiungibile. Ma<br />
neppure necessaria al fine che ci siamo prefissi: aumentare le chances<br />
<strong>di</strong> sopravvivenza della nostra specie. Siamo arrivati ad<strong>di</strong>rittura a<br />
ipotizzare che tutto è già stato pensato e che l'unica attività mentale<br />
ancora possibile è la variazione locale del già pensato. Un ulteriore e<br />
forse ultima <strong>di</strong>stinzione è quin<strong>di</strong> tra coloro che si rendono conto dei<br />
modelli adottati dal loro pensiero e sono in grado <strong>di</strong> relativizzarli, a<br />
fronte <strong>di</strong> coloro che non se ne rendono conto e li assolutizzano. E<br />
sull'incentivazione della consapevolezza abbiamo, come CMC,<br />
concentrato il massimo del nostro impegno formativo e su questo<br />
basiamo le nostre pretese <strong>di</strong> partecipazione a un ra<strong>di</strong>cale<br />
ripensamento del sistema educativo affinché meglio risponda<br />
all'imperativo del momento: consapevolezza in<strong>di</strong>viduale e sociale della<br />
situazione in cui stiamo vivendo e del nostro ruolo in un progetto<br />
universale <strong>di</strong> sopravvivenza.<br />
Che contributo ha dato finora il CMC a questo progetto? Quale altro<br />
potrà dare? Per la risposta alla prima domanda non so che rimandare<br />
il lettore al nostro sito.Il contributo più forte che il CMC potrà dare in<br />
futuro (per il presente la sua attività è troppo poco conosciuta e<br />
riconosciuta) non sono tanto le in<strong>di</strong>cazioni - pur abbondanti -<br />
sperimentate in più <strong>di</strong> trent'anni, quanto l'aver collocato il problema<br />
della consapevolezza nella quoti<strong>di</strong>anità familiare, scolastica e delle<br />
istituzioni formative in genere.<br />
Teoricamente e come raccomandazione se ne parla più o meno da<br />
sempre, tanto quanto si parla <strong>di</strong> libertà, <strong>di</strong> responsabilità, tolleranza e
così via. Al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> queste enunciazioni <strong>di</strong> principio raramente si va; in<br />
particolare poco si è ancora fatto per raccordare questi principi alla<br />
normalità comportamentale degli in<strong>di</strong>vidui: il bullismo nelle scuole, la<br />
violenza negli sta<strong>di</strong>, le sopraffazioni domestiche non sono fenomeni<br />
occasionali e impreve<strong>di</strong>bili, ma rientrano nella normalità <strong>di</strong> cui non<br />
sono responsabili i soli in<strong>di</strong>vidui ma la società tutta nei modelli che<br />
propone e che vengono acriticamente introiettati. Acriticamente sta<br />
qui per "mancanza <strong>di</strong> consapevolezza" e allora c'è da domandarsi il<br />
perché <strong>di</strong> questa mancanza. Semplicemente perché il fulcro della<br />
formazione sta nell'acquisizione, nella patrimonializzazione da sapere,<br />
alto o basso che sia, non nella riflessione su <strong>di</strong> esso, che sola ci rende<br />
consapevoli <strong>di</strong> ciò che siamo, abbiamo, sappiamo e sappiamo fare.<br />
Non siamo stati abituati a questo: al posto della riflessione abbiamo<br />
conosciuto l'indottrinamento, la delega del pensiero, l'adeguamento<br />
passivo.<br />
Il "ra<strong>di</strong>cale ripensamento" <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>ceva riguarda proprio questo<br />
punto, l'adeguamento passivo. A che serve lottare contro la droga o il<br />
fumo, quando ci si chiede l'adeguamento passivo ai dettami della<br />
chiesa, delle morali, dei partiti, quando la moda, la televisione o la<br />
pubblicità con<strong>di</strong>zionano le nostre scelte fin nei minimi particolari. Ma<br />
l'invito all'adeguamento va anche molto più in là. La nazione, la<br />
<strong>di</strong>sciplina, la cultura stessa, se non siamo in grado <strong>di</strong> riconoscerle (il<br />
che vuoi già <strong>di</strong>re relativizzarle), che altro sono se non occulti richiami<br />
all'omologazione?<br />
E che si dovrebbe fare? Insegnare che 2+2 forse fa 4, o che<br />
probabilmente Parigi è la capitale della Francia?
Non ripeto qui quanto ampiamente mostrato nelle nostre pubblicazioni<br />
a cominciare dal sito e da queste stesse pagine. Non tanto nel suo<br />
labile contenuto quanto nell'in<strong>di</strong>rizzo da esso segnato vorremmo che il<br />
nostro messaggio venisse, se non ha accolto, almeno letto da chi è<br />
stato incaricato dalla società a dare le linee guida <strong>di</strong> un percorso<br />
formativo valevole per tutti i citta<strong>di</strong>ni.<br />
Accenno qui a una questione, assai <strong>di</strong>battuta negli ultimi anni, ma,<br />
secondo noi, mai dal punto <strong>di</strong> vista essenziale. Formazione pubblica o<br />
privata? Certo, se il pubblico si adegua al privato (cioè a interessi <strong>di</strong><br />
parte) in settori cruciali della formazione, il <strong>di</strong>battito resta in superficie<br />
e tanto vale <strong>di</strong>sinteressarsene. Se però si dovesse andare più a fondo<br />
- per esempio nel momento <strong>di</strong> un ra<strong>di</strong>cale ripensamento -, la scelta<br />
esclusiva del pubblico si imporrebbe <strong>di</strong> conseguenza. Ma siamo ancora<br />
lontani da questo.<br />
Anche senza giungere a delineare un progetto <strong>di</strong> riforma per la scuola<br />
nei suoi gra<strong>di</strong> inferiori (quelli che ci appaiono fondanti nel senso pieno<br />
della parola), vorrei tuttavia riportare alcune osservazioni emerse dal<br />
CMC negli innumerevoli circuiti autogenerativi de<strong>di</strong>cati all'argomento.<br />
Sono cose che a chi ha seguito negli anni le nostre esperienze<br />
appaiono scontate, non lo sono per la maggioranza degli insegnanti<br />
fedeli alle proprie premesse formative. Non lo sono soprattutto per le<br />
famiglie, che interferiscono oggi pesantemente con la scuola, anche<br />
quando non hanno alcun titolo per farlo, salvo quello <strong>di</strong> essere o<br />
rappresentare i genitori degli alunni. Quando, a suo tempo, si pensò<br />
<strong>di</strong> integrare scuola e famiglia nel processo formativo dei minori, le<br />
intenzioni del legislatore colsero indubbiamente l'aspetto positivo del
problema facendo finalmente <strong>di</strong>alogare i principali responsabili <strong>di</strong> quel<br />
processo. Non ci si avvide invece degli aspetti negativi, in primis<br />
dell'incapacità <strong>di</strong> molte famiglie a usare meto<strong>di</strong> democratici e<br />
partecipanti nella gestione dei rapporti familiari ed extrafamiliari. A ciò<br />
si aggiunge la convinzione ideologica che i figli siano proprietà dei<br />
genitori e che questi abbiano il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> educarli come vogliono. Di<br />
qui conflitti e incomprensioni tra famiglia e scuola che spesso<br />
demotivano gli alunni allo stu<strong>di</strong>o e intralciano la normalità formativa.<br />
Un altro mito dell'educazione è che la scuola - e la famiglia - debbono<br />
partire dai bisogni del bambino, dal mondo delle sue fantasie infantili.<br />
Quando sappiamo tutti benissimo che bisogni e fantasie sono indotti<br />
dall'ambiente in cui il bambino vive, ambiente che è oggi<br />
essenzialmente me<strong>di</strong>atico e funzionale non certo a una sua<br />
formazione equilibrata, ma al mercato dell'informazione. E così<br />
ve<strong>di</strong>amo la maggioranza dei bambini schiavizzati dai telefonini e dai<br />
videogiochi, il cui uso e abuso viene incentivato dalle famiglie, che<br />
trovano molto comodo affidare ad essi (e alla TV) il tempo libero dei<br />
minori. I quali dal canto loro lo estendono volentieri alle ore<br />
scolastiche costringendo la scuola ad adottare forme repressive che<br />
non giovano <strong>di</strong> certo a un buon rapporto reciproco.<br />
Ma siamo ancora alla periferia del problema. Per affrontarlo nella sua<br />
ra<strong>di</strong>calità occorrerebbe il concorso <strong>di</strong> più competenze - specifiche delle<br />
varie <strong>di</strong>scipline, epistemologiche, psicopedagogiche, metaculturali -,<br />
ma soprattutto occorrerebbe una sperimentazione sufficientemente<br />
protratta sull'intero territorio nazionale.<br />
È probabile infatti:
- che un'impostazione metaculturale della formazione cominci a dare<br />
risultati apprezzabili solo dopo qualche tempo<br />
- che questi risultati non siano ovunque gli stessi.<br />
Va poi detto che una sperimentazione del genere ha bisogno <strong>di</strong> una<br />
classe insegnante adeguatamente preparata. Ma chi dovrebbe<br />
prepararla se non sono <strong>di</strong>sponibili formatori che già lo siano.<br />
Il problema non è nuovo nella storia della vita e della cultura in<br />
particolare. La soluzione, in quest'ultimo caso, sta<br />
nell'autogeneratività del pensiero, capace <strong>di</strong> interagire con il futuro<br />
tramite lo stile ipotetico. Ma questa soluzione non è data una volta<br />
per tutte e va ricavata caso per caso, il che richiede tempo. Tanto più<br />
in quanto le culture, che pure potrebbero favorire processo, in genere<br />
lo ostacolano con la loro viscosità. Se si accetta IMC, questa viscosità<br />
potrebbe essere fortemente ridotta coniugando lo stile ipotetico con<br />
quello metaculturale, ma anche l'acquisizione <strong>di</strong> questi stili ai processi<br />
formativi non è cosa che si fa da un giorno all'altro. Ci vuole tempo.<br />
Ce l'abbiamo questo tempo?<br />
Molti in<strong>di</strong>zi ci fanno dubitare. Anche a voler essere ottimisti, credo ci<br />
convenga comportarci come se non l'avessimo. Ciò vuol <strong>di</strong>re, sempre<br />
secondo IMC, renderci consapevoli dell'asse metaculturale che<br />
traversa tutte le culture umane e rende possibile la loro interazione<br />
positiva e <strong>di</strong> conseguenza la loro evoluzione.<br />
Certo, per mettere in moto un meccanismo critico-riflessivo <strong>di</strong> portata<br />
sovranazionale come quello ricavabile da IMC sarebbe necessaria una<br />
volontà politica assai più forte che non per concordare il protocollo <strong>di</strong>
Kyoto o la moratoria nella caccia alle balene. La via non potrebbe<br />
tuttavia essere un'altra.<br />
Apparentemente un regime totalitario <strong>di</strong> estensione planetaria<br />
accorcerebbe notevolmente i tempi. Ma:<br />
1.- occorrerebbe un regime platonico non legato nessun interesse<br />
economico o <strong>di</strong> potere<br />
2.- occorrerebbe che le decisioni <strong>di</strong> un tale regime venissero fatte<br />
proprie da ogni sud<strong>di</strong>to, singolarmente.<br />
Un ambedue queste con<strong>di</strong>zioni non sono manifestamente né<br />
realizzabili, né auspicabili. L'omologazione espressa dalla 2.<br />
contrad<strong>di</strong>ce il principio ritenuto basilare per la vita: la <strong>di</strong>versificazione.<br />
Non c'è quin<strong>di</strong> che da lavorare alla convergenza, la più ampia<br />
possibile, su alcune forme <strong>di</strong> sviluppo, economico non meno che<br />
culturale, ecocompatibili.<br />
Queste forme andrebbero cioè ricercate, <strong>di</strong>scusse e accettate<br />
democraticamente, quando tuttavia la democrazia avesse compiuto<br />
qualche decisivo passo verso l'autonomia consapevole, in<strong>di</strong>viduale e<br />
sociale. Ma proprio questi decisivi passi presuppongono già<br />
l'autonomia verso cui muovono: è la circolarità paralizzante cui IMC<br />
sostituisce la circolarità-spirale, progre<strong>di</strong>ente indefinitamente lungo il<br />
proprio asse.<br />
Il problema della sopravvivenza, stando a quanto si <strong>di</strong>ce, andrebbe<br />
quin<strong>di</strong> affrontato primariamente sul piano formativo. Ciò non vuol <strong>di</strong>re<br />
che contemporaneamente, anzi in tempi anche più stretti, non lo si<br />
debba affrontare anche su altri piani; qualsiasi risultato si ottenga su<br />
uno <strong>di</strong> questi non potrà essere che labile ed effimero se non si sarà
a<strong>di</strong>cato profondamente nella consapevolezza del maggior numero <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>vidui. Ne consegue che il momento formativo dovrà eccedere <strong>di</strong><br />
gran lunga i confini della scuola e farsi permanente nell'ambito della<br />
vita. Gli strumenti per questo ampiamento già esistono e sono a tutti<br />
noti.<br />
"Che orrore! - <strong>di</strong>ranno in molti - trasformare l'universo<br />
comunicazionale in cui viviamo in un'immensa aula scolastica, ogni<br />
nostro gesto o parola in una raccomandazione sul modo <strong>di</strong> vivere...".<br />
Con<strong>di</strong>vido: che orrore! Purtroppo però è proprio così, solo che non ce<br />
ne ren<strong>di</strong>amo conto. Ho trattato altrove questo punto (La funzione<br />
formativa nell'era della globalità, cap.I) e non mi ripeterò. Non si<br />
tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> dare a ogni espressione nostra o altrui una valenza<br />
formativa ma solo <strong>di</strong> riconoscere quella che comunque vi si nasconde<br />
e <strong>di</strong> accoglierla o meno secondo il nostro progetto <strong>di</strong> vita.<br />
Sia come sia, gli scambi culturali tra in<strong>di</strong>vidui, gruppi, culture <strong>di</strong>verse<br />
andranno illuminati dalla luce della consapevolezza assai più <strong>di</strong> quanto<br />
oggi accade, se si vuole che contribuiscano alla nostra sopravvivenza<br />
e non alla nostra estinzione. Si ha troppo spesso l'impressione che a<br />
livello politico nazionale e internazionale la comunicazione avvenga in<br />
modo pericolosamente irriflesso e la storia, anche recentissima, non<br />
smentisce questa impressione. Supponiamo pure che oggi il gioco<br />
politico si sia fatto più accorto e che le cose dette dall'uno vengano<br />
intese dall'altro nel senso meno pregiu<strong>di</strong>zievole per la sopravvivenza.<br />
Che ne è <strong>di</strong> tutti gli altri cui i mass me<strong>di</strong>a si affrettano a riportare le<br />
cose come sono state dette e non come sono state recepite dall'una o<br />
l'altra delle parti? Un gruppo <strong>di</strong> ascoltatori in<strong>di</strong>pendenti potrebbe
eagire secondo una propria interpretazione delle parole ascoltate e<br />
interferire con la incomprensibile politica ufficiale destabilizzando<br />
ulteriormente ciò che già <strong>di</strong> suo stabile non è. Una maggiore cura nel<br />
formare il citta<strong>di</strong>no non all'adorazione acritica della verità ma alla<br />
costruzione relativistica dell'interpretazione gioverebbe certamente a<br />
ridurre questi pericoli.<br />
Da quanto detto e dalle altre innumerevoli osservazioni che sono alla<br />
portata <strong>di</strong> tutti è abbastanza ovvio che il pubblico, cioè lo stato o, se<br />
si preferisce, la società nel suo insieme dovrebbe rivolgersi,<br />
autoriflessivamente, al problema formativo con ben altro investimento<br />
economico e soprattutto <strong>di</strong> attenzione competenze <strong>di</strong> quello tuttora<br />
concesso. E questo non solo nella scuola ma entro tutto lo spessore<br />
sociale. Ricordo ancora il graduale <strong>di</strong>simpegno delle istituzioni,<br />
durante gli anni '80 e '90, da tutto ciò che avesse a che fare con<br />
l'impegno formativo e culturale. Gli aurei anni <strong>di</strong> piombo avevano<br />
aperto prospettive <strong>di</strong> rinnovamento sociale che le BR si sono affrettate<br />
a richiudere in perfetta concordanza <strong>di</strong> intenti con la parte più retriva<br />
della nostra società, che ha finito per stravincere. Pensavo allora, a<br />
ogni nuovo anno, che più in basso <strong>di</strong> così non si potesse scendere,<br />
mentre la <strong>di</strong>scesa non era che agli inizi. In seguito anch'io, come tutti,<br />
mi sono man mano adattato ai livelli via via raggiunti, ritirandomi,<br />
anche per raggiunti limiti <strong>di</strong> età, da una vita socialmente attiva e<br />
riannodando la mia vita a quella - precedente il '68 - <strong>di</strong> compositore,<br />
anzi, per essere più precisi, <strong>di</strong> compositore da arma<strong>di</strong>o, visto il mio<br />
pressoché totale <strong>di</strong>sinteresse per la presentazione pubblica <strong>di</strong> quanto<br />
vado scrivendo. Solo in tempi assai recenti la vivacità <strong>di</strong> altri
componenti - assai più giovani - del CMC mi ha indotto a una<br />
moderata ripresa dell'attività politico-formativa con la stesura <strong>di</strong><br />
alcuni testi, tra cui il presente, e un'assidua partecipazione al lavoro <strong>di</strong><br />
allestimento del nostro sito.<br />
Mentre scrivo queste righe (febbraio 2007), stiamo assistendo alla<br />
caduta del governo Pro<strong>di</strong> accompagnata da una ripresa del consenso<br />
alle destre. La borsa ha reagito con un'impennata dei titoli legati al<br />
nome <strong>di</strong> Berlusconi e tutto sembra precipitare nuovamente ai livelli <strong>di</strong><br />
stupi<strong>di</strong>tà che ci eravamo illusi <strong>di</strong> aver superato. Ma che <strong>di</strong>ritto ho io <strong>di</strong><br />
parlare <strong>di</strong> stupi<strong>di</strong>tà se alcuni - anzi moltissimi - non la pensano come<br />
me?<br />
In effetti bisognerebbe semmai parlare <strong>di</strong> stupi<strong>di</strong>tà con<strong>di</strong>visa, visto<br />
che più <strong>di</strong> una volta mi sono trovato d'accordo con gli estremisti <strong>di</strong><br />
sinistra cui si devono la fragilità e la caduta dell'attuale governo,<br />
presumibilmente l'unico in grado <strong>di</strong> restituirci cre<strong>di</strong>bilità politica.<br />
Poiché non credo nella stupi<strong>di</strong>tà in<strong>di</strong>viduale, non mi resta che<br />
attribuire quella collettiva ai modelli indotti e ai meccanismi <strong>di</strong><br />
induzione, ai quali solo pochissimi (e io non sono tra quelli) riescono a<br />
sfuggire. Soprattutto è più che preoccupante il fatto che sono<br />
soprattutto i giovani a rinunciare alla propria autonomia mentale in<br />
favore <strong>di</strong> pacchetti <strong>di</strong> pensiero già confezionati o, peggio ancora, <strong>di</strong><br />
veri e propri sostituti <strong>di</strong> pensiero, acquistabili all'angolo della strada,<br />
in <strong>di</strong>scoteca o su Internet. Perché questo rifiuto al pensiero attivo? È<br />
un fenomeno solo attuale o si è verificato, in altre forme, anche in<br />
passato? C'è speranza <strong>di</strong> vederlo, non <strong>di</strong>co scomparire, ma almeno<br />
attenuarsi?
Al tempo della mia infanzia le cose non andavano certo meglio: ci<br />
avevano convinti che il futuro del mondo era nel modello fascista, più<br />
tar<strong>di</strong> altri ci hanno traghettato verso quello comunista, poi verso<br />
l'economia <strong>di</strong> mercato. I modelli peraltro sopravvivono alla propria<br />
egemonia e restano come opzioni ideologiche all'interno della<br />
superideologia avente nome democrazia. E fin qui sembrerebbe che<br />
questo approdo alla democrazia abbia risolto il problema. Ve<strong>di</strong>amo<br />
tuttavia giorno dopo giorno che non è così: guerre palesemente inutili<br />
(posto che ce ne siano mai state <strong>di</strong> utili), stragi, genoci<strong>di</strong>, povertà<br />
circondata da ricchezza, morti per malattie curabili... I problemi si<br />
sono semmai acuiti fino a mettere in forse la sopravvivenza <strong>di</strong> noi<br />
tutti. C'è da domandarsi: se ogni singola persona fosse chiamata a<br />
esprimersi su ciascuno <strong>di</strong> questi problemi e le fosse chiesto <strong>di</strong><br />
ragionare con la sola sua testa, saremmo a questo punto?<br />
Come sappiamo, la democrazia <strong>di</strong>retta, non è ancora tecnicamente<br />
realizzabile (e chi avrebbe interesse a realizzarla?); possiamo però<br />
lavorare a rendere autonomo il pensiero <strong>di</strong> ciascuno e più responsabili<br />
le sue scelte politiche. È probabile che con la crescita delle autonomie<br />
in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong>minuiscano le stupi<strong>di</strong>tà collettive che tuttora dominano il<br />
mondo.<br />
È ben comprensibile come una tale guerra alla stupi<strong>di</strong>tà collettiva -<br />
che in parte è anche guerra contro noi stessi in quanto partecipi <strong>di</strong><br />
quella stupi<strong>di</strong>tà - trovi meno alleati <strong>di</strong> qualsiasi altra guerra. Non certo<br />
le religioni, ognuna delle quali forte non della propria saggezza ma<br />
della stupi<strong>di</strong>tà indotta, non certo le ideologie <strong>di</strong> massa, il cui potere<br />
sta soprattutto nella sottrazione <strong>di</strong> autonomia, non il mercato
mon<strong>di</strong>ale, le cui leggi si fondano sull'omologazione <strong>di</strong> vasti strati <strong>di</strong><br />
pensiero, nessuna delle forze in gioco a livello sovranazionale, può<br />
avere un effettivo interesse a rendere autonomo e responsabile il<br />
pensiero in<strong>di</strong>viduale.<br />
Allora perché avventurarsi per questa strada? Per puro spirito<br />
missionario, per filantropia, per imperativo morale?<br />
Siamo ormai troppo scaltriti per non scorgere l'ipocrisia nascosta sotto<br />
questo genere <strong>di</strong> motivazioni. L'interesse ovviamente c'è ed è il più<br />
forte che si possa immaginare: l'interesse egoistico alla<br />
sopravvivenza. Ho riportato, a proposito dello stile <strong>di</strong> pensiero<br />
religioso-mistico (3.5.), una parabola in cui l'egoismo da in<strong>di</strong>viduale si<br />
fa universale senza abbandonare la sfera dell'io, anzi ampliandola<br />
oltre ogni limite. È solo una finzione idealistica senza pretesa <strong>di</strong><br />
effettiva realizzazione, dà tuttavia una <strong>di</strong>rezionalità alla strada che<br />
pensiamo sia da percorrere: dall'egoismo personale verso cerchi <strong>di</strong><br />
egoismo sempre più larghi:
Escludere una finalità mistico-religiosa <strong>di</strong> tipo spinoziano; a noi qui<br />
interessa quella assai più reale e improcrastinabile: la sopravvivenza.<br />
Le scienze e l'ecologia si adoperano a monitorare il progressivo<br />
aggravarsi della situazione, ci suggeriscono anche dei rime<strong>di</strong> che,<br />
seppure non risolutivi, varrebbero tuttavia a rallentare il processo<br />
degenerativo in atto. Ma le loro raccomandazioni si scontrano con i<br />
cerchi più interni della sopra riportata immagine dell'io. Anche quel<br />
poco che si fa a livello ufficiale rischia <strong>di</strong> andare perduto se non si<br />
<strong>di</strong>ffonde lo stile <strong>di</strong> pensiero ecologico-globalizzante (3.11.) Questo<br />
deve inoltre penetrare, al <strong>di</strong> là della razionalità, nella sfera emotiva<br />
degli in<strong>di</strong>vidui. La frase <strong>di</strong> cui spesso mi servo - "Quando accen<strong>di</strong> una<br />
lampa<strong>di</strong>na pensa che stai sottraendo un bicchiere d'acqua a un<br />
bambino africano" - non significa che non devo accendere la<br />
lampa<strong>di</strong>na, ma non va neppure intesa in senso metaforico. Significa<br />
piuttosto che debbo compensare il mio gesto con un altro che in<br />
qualche modo restituisca al bambino africano il bicchiere d'acqua cui<br />
ha <strong>di</strong>ritto quanto me.<br />
Il problema della compensazione ci riporta al concetto <strong>di</strong> equilibrio,<br />
equilibrazione trattato in 6. Lì invero l'equilibrazione era riferita<br />
principalmente agli stili <strong>di</strong> pensiero, alla sfera psichica, mentre<br />
andrebbe estesa a tutti gli ambiti <strong>di</strong> interrelazione sociale, a<br />
cominciare da un'equa ri<strong>di</strong>stribuzione delle risorse materiali.<br />
L'argomento esula troppo dalle mie abitu<strong>di</strong>ni lavorative perché lo<br />
affronti con un minimo <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>bilità. Credo però che le soluzioni<br />
tecniche si troverebbero, solo che si instaurasse a livello in<strong>di</strong>viduale e
mon<strong>di</strong>ale lo stile ecologico-globalizzante <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>ceva. È possibile<br />
che ciò accada? E come?<br />
Autogenerativamente.<br />
Un innesco ideologico è probabilmente necessario e in questo senso il<br />
contributo dei movimenti, dei partiti e anche della moda può essere<br />
assai importante. Ma se su questo innesco la scuola e la formazione<br />
pubblica in genere non sapranno intervenire portandolo al centro<br />
dell'azione formativa, quello stile verrà sopraffatto dagli egoismi più<br />
ristretti. E non si tratta <strong>di</strong> farne una <strong>di</strong>sciplina, una materia come<br />
tuttora lo sono la geografia o la storia (che pure dovrebbero, in<br />
un'ottica formativa rinnovata, deporre questo loro statuto). Si tratta<br />
piuttosto <strong>di</strong> farne delle aree, degli UCL, <strong>di</strong> riflessività aperte a tutti,<br />
perché il problema della convivenza pacifica nella <strong>di</strong>versità culturale e<br />
ambientale non può essere risolto che con la partecipazione massima<br />
possibile: autogenerativamente, appunto.<br />
Un'ultima considerazione rivolgo ora a questo scritto e alla sua un<br />
poco anomala gestazione. Nel contempo vorrei mettere in guar<strong>di</strong>a il<br />
lettore (credo però <strong>di</strong> averlo già fatto) dal dare troppo cre<strong>di</strong>to alle<br />
cose qui scritte. Non perché siano deliberatamente falsate; anzi, ho<br />
cercato per quanto mi è stato possibile <strong>di</strong> attenermi a osservazioni dal<br />
vero, raccolte in mezzo secolo <strong>di</strong> attività formativa, sia specialistica<br />
(musica) che <strong>di</strong> base (dal 1975). Ma è proprio l'osservazione e la<br />
riflessione su <strong>di</strong> essa che vanno considerate con cautela e soprattutto<br />
confrontate con altre osservazioni, altre riflessioni.<br />
È questo ciò che manca al libro e per cui sono ricorso al generoso<br />
aiuto <strong>di</strong> un amico: il confronto con le posizioni oggi raggiunte dalle
icerche scientificamente più qualificate in campo psicologico,<br />
epistemologico, pedagogico. Da ciò che ho occasionalmente appreso<br />
ricavo la speranza che molte siano le convergenze. Qualcuno si<br />
chiederà perché, se le convergenze ci sono, non attenersi soltanto alla<br />
versione accre<strong>di</strong>tata. Da vecchio cultore <strong>di</strong> Thomas Mann e del suo<br />
Giuseppe, credo nella doppia bene<strong>di</strong>zione, dall'alto e dal basso. Manca<br />
a questo libro quella dall'alto e conto su <strong>Mauro</strong> <strong>Scardovelli</strong> per<br />
ottenerla.<br />
È chiaro che nessuno è del tutto privo delle competenze necessarie a<br />
ciò che fa conte, se non altro le capta dai <strong>di</strong>scorsi, dalle letture<br />
occasionali. Ricordo per esempio che parecchi decenni fa mi capitò <strong>di</strong><br />
occuparmi <strong>di</strong> Piaget e dell'epistemologia genetica e questo pur<br />
passeggero interesse non può aver mancato <strong>di</strong> lasciare tracce nel<br />
nostro lavoro <strong>di</strong> base. Sarebbe tuttavia millantato cre<strong>di</strong>to se<br />
spacciassimo il CMC per un'istituzione parauniversitaria e me stesso<br />
come un'autorità in materia. Non lo siamo, almeno fino adesso, e<br />
<strong>di</strong>verso è anche il nostro ruolo, assai più pratico che teorico.<br />
Ed è da questo ruolo che scaturisce un'in<strong>di</strong>cazione che vorrei ora<br />
trasmettere a chi volesse occuparsi <strong>di</strong> una riforma della scuola in<br />
senso metaculturale. La sperimentazione sul campo ha dato buoni<br />
risultati ce ne stiamo servendo anche in alcuni corsi <strong>di</strong> formazione<br />
professionale per adulti. Ecco <strong>di</strong> che si tratta.<br />
Quale che sia l'ambito <strong>di</strong>sciplinare da affrontare, far precedere<br />
l'in<strong>di</strong>spensabile stu<strong>di</strong>o specifico da un'approfon<strong>di</strong>ta riflessione<br />
condotta sulla base delle competenze comuni sull'argomento. Non<br />
solo i partecipanti verranno così sensibilizzati a problematiche cui si
itenevano estranei, ma è anche possibile che si trovino ad aver<br />
pensato, seppure in modo impreciso, cose che la cultura alta sta<br />
appena scoprendo (si legge in proposito in 3.3. la storiella <strong>di</strong> Einstein<br />
e la bambina cui è caduta la tazzina). I modelli esplicativi oggi più<br />
accre<strong>di</strong>tati verranno così trapiantati in un terreno già preparato ad<br />
accoglierli e <strong>di</strong> questo si avvantaggerà segnatamente la motivazione<br />
allo stu<strong>di</strong>o, eterno cruccio degli allievi come degli insegnanti.<br />
Presupposto a tale in<strong>di</strong>cazione è l'ipotesi - da me con<strong>di</strong>visa in pieno -<br />
che la mente abbia in tutti più o meno lo stesso grado <strong>di</strong> sviluppo. Le<br />
emergenze in<strong>di</strong>viduali, favorite se non interamente dovute a<br />
circostanze ambientali, hanno comunque importanza soltanto nella<br />
misura in cui si riflettono sul cammino evolutivo della specie umana.<br />
Presi uno per uno siamo tutti intelligenti. Diamoci da fare per esserlo<br />
anche come collettività.<br />
Postlu<strong>di</strong>o<br />
Per simmetria con il Prelu<strong>di</strong>o che chiude la Prefazione riporto, a<br />
chiusura del tutto, un'altra storiella, sempre del 1984 e commentato<br />
nel nostro sito (progetto n.......). Non sono certo che abbia a che fare<br />
con il libro. Deciderà il lettore.<br />
La gara
C'era una volta (ma non credo che fosse molto tempo fa) un<br />
ingegnere che progettava robot, poi li faceva costruire e li teneva<br />
presso <strong>di</strong> sé per stu<strong>di</strong>arne le reazioni.<br />
I suoi robot erano <strong>di</strong> gran lunga i più perfezionati tra quanti ve ne<br />
fossero sulla terra. Non tanto per quello che facevano (in genere non<br />
si curava molto delle loro capacità <strong>di</strong> movimento) quanto per quello<br />
che riuscivano a pensare.<br />
Uno in particolare, l'ultimo (perché poi non ne fece costruire più,<br />
come vedremo), lo teneva occupato da mattina si era.<br />
La complessità del suo cervello artificiale era tale che l'ingegnere non<br />
riusciva a trovare un problema, un calcolo, un'equazione che quello<br />
non sapesse risolvere in quattro e quattr'otto.<br />
Molte delle soluzioni avanzate dal robot non erano però delle vere e<br />
proprie soluzioni, ma delle abilissime riformulazioni dei problemi,<br />
cosicché toccava ora all'ingegnere tentar <strong>di</strong> risolverli.<br />
Era una sfida. Una sfida che l'ingegnere accolse con coraggio, anche<br />
con paura: gli sembrava fosse in gioco non solo la sua personale<br />
intelligenza, ma quella del genere umano tutto.<br />
Non ci dormiva la notte e al mattino riprendeva la gara stanca ancora<br />
del giorno prima. Il robot dal canto suo non provava alcuna emozione.<br />
Non aveva bisogno <strong>di</strong> riposare e pensava anche <strong>di</strong> notte.<br />
Mentre il robot accumulava vantaggio su vantaggio, l'ingegnere<br />
deperiva <strong>di</strong> giorno in giorno, nonostante le cure cui si era sottoposto.<br />
Sempre più spesso gli capitava <strong>di</strong> sbagliare e <strong>di</strong> farsi correggere dal<br />
robot, che invece sembrava incapace <strong>di</strong> commettere il più piccolo<br />
errore.
E venne una sera che l'ingegnere pensò: "Non ce la faccio più.<br />
Domani mi arrendo".<br />
Vinse però l'ingegnere pur perdendo la gara. La mattina dopo andò<br />
infatti dal robot e gli <strong>di</strong>sse: "Non ce la faccio a vincere la tua<br />
intelligenza con la mia. Quale intelligenza potrebbe riuscirci e come?"<br />
Il robot, senza paura, risolse il problema auto<strong>di</strong>struggendosi. "Io al<br />
posto tuo - pensò l'ingegnere - avrei avuto paura e avrei preferito<br />
perdere la gara, come del resto l'ho persa adesso".<br />
E smise <strong>di</strong> costruire robot.<br />
Cantalupo<br />
24-II-2007
Nota bibliografica<br />
Testi - e<strong>di</strong>ti e ine<strong>di</strong>ti - cui si fa riferimento nel libro.<br />
B.Porena: Musica/società - Einau<strong>di</strong>, Torino 1975<br />
B.Porena, C. Dionisi, P. Bučan: La Musica nella scuola dell'obbligo I;<br />
II; III A, B - Pro Musica Stu<strong>di</strong>um, Roma 1975-78<br />
B.Porena: Musica prima - Altrarea, Treviso 1979<br />
Centro <strong>di</strong> ricercha e sperimentazione metaculturale:<br />
L'operatore culturale <strong>di</strong> base - Ed. Thyrus, Terni 1982<br />
Id: L'attività culturale <strong>di</strong>ffusa - Ed. Thyrus, Terni 1983<br />
B.Porena: Per la composizione - Milano, Ricor<strong>di</strong> 1983<br />
A.A.V.V.: Didattica dei linguaggi nella scuola dell'obbligo - Teramo,<br />
Giunti&Lisciani Ed. 1988<br />
B.Porena: La musica. Produzione, <strong>di</strong>stribuzione, consumo - Roma,<br />
E<strong>di</strong>tori Riuniti, 1988