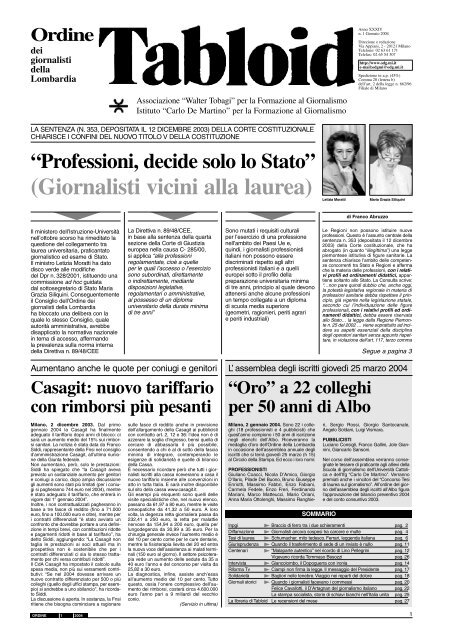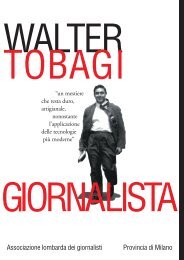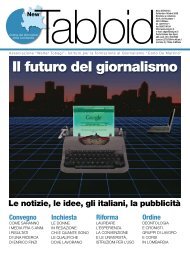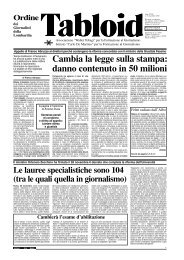Gennaio 2004 - Ordine dei Giornalisti
Gennaio 2004 - Ordine dei Giornalisti
Gennaio 2004 - Ordine dei Giornalisti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Ordine</strong><br />
<strong>dei</strong><br />
giornalisti<br />
della<br />
Lombardia<br />
Il ministero dell’Istruzione-Università<br />
nell’ottobre scorso ha rimeditato la<br />
questione del collegamento tra<br />
laurea universitaria, praticantato<br />
giornalistico ed esame di Stato.<br />
Il ministro Letizia Moratti ha dato<br />
disco verde alle modifiche<br />
del Dpr n. 328/2001, istituendo una<br />
commissione ad hoc guidata<br />
dal sottosegretario di Stato Maria<br />
Grazia Siliquini. Conseguentemente<br />
il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong><br />
giornalisti della Lombardia<br />
ha bloccato una delibera con la<br />
quale lo stesso Consiglio, quale<br />
autorità amministrativa, avrebbe<br />
disapplicato la normativa nazionale<br />
in tema di accesso, affermando<br />
la prevalenza sulla norma interna<br />
della Direttiva n. 89/48/CEE<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo<br />
Istituto “Carlo De Martino” per la Formazione al Giornalismo<br />
LA SENTENZA (N. 353, DEPOSITATA IL 12 DICEMBRE 2003) DELLA CORTE COSTITUZIONALE<br />
CHIARISCE I CONFINI DEL NUOVO TITOLO V DELLA COSTITUZIONE<br />
“Professioni, decide solo lo Stato”<br />
(<strong>Giornalisti</strong> vicini alla laurea)<br />
La Direttiva n. 89/48/CEE,<br />
in base alla sentenza della quarta<br />
sezione della Corte di Giustizia<br />
europea nella causa C- 285/00,<br />
si applica “alle professioni<br />
regolamentate, cioè a quelle<br />
per le quali l’accesso o l’esercizio<br />
sono subordinati, direttamente<br />
o indirettamente, mediante<br />
disposizioni legislative,<br />
regolamentari o amministrative,<br />
al possesso di un diploma<br />
universitario della durata minima<br />
di tre anni”<br />
Aumentano anche le quote per coniugi e genitori<br />
Casagit: nuovo tariffario<br />
con rimborsi più pesanti<br />
Milano, 2 dicembre 2003. Dal primo<br />
gennaio <strong>2004</strong> la Casagit ha finalmente<br />
adeguato il tariffario dopo anni di blocco: ci<br />
sarà un aumento medio del 15% sui rimborsi<br />
sanitari. La notizia è stata data da Franco<br />
Siddi, rappresentante della Fnsi nel consiglio<br />
d’amministrazione Casagit, all’ultima riunione<br />
della Giunta federale.<br />
Non aumentano, però, solo le prestazioni:<br />
Siddi ha spiegato che “la Casagit aveva<br />
previsto un sostanziale aumento per genitori<br />
e coniugi a carico, dopo ampia discussione<br />
gli aumenti sono stati più limitati (per i coniugi<br />
si pagheranno 744 euro nel <strong>2004</strong>), mentre<br />
è stato adeguato il tariffario, che entrerà in<br />
vigore dal 1° gennaio <strong>2004</strong>”.<br />
Inoltre, i non contrattualizzati pagheranno in<br />
base a tre fasce di reddito (fino a 71.000<br />
euro, fino a 100.000 euro e oltre), mentre per<br />
i contratti differenziati “è stato avviato un<br />
confronto che dovrebbe portare a una definizione<br />
in tempi brevi, con contribuzioni ridotte<br />
e pagamenti ridotti in base al tariffario”, ha<br />
detto Siddi, aggiungendo: “La Casagit non<br />
taglia le prestazioni ai soci attuali ma in<br />
prospettiva non è sostenibile che per i<br />
contratti differenziati ci sia lo stesso trattamento<br />
per chi versa contributi ridotti”.<br />
Il CdA Casagit ha impostato il calcolo sulla<br />
spesa media, non più sui versamenti contributivi:<br />
“Se nel <strong>2004</strong> dovesse arrivare un<br />
nuovo contratto differenziato per 500 o più<br />
colleghi (quello degli uffici stampa, per esempio)<br />
si andrebbe a uno sbilancio”, ha ricordato<br />
Siddi.<br />
La discussione è aperta. In sostanza, la Fnsi<br />
ritiene che bisogna cominciare a ragionare<br />
sulle fasce di reddito anche in previsione<br />
dell’allargamento della Casagit ai pubblicisti<br />
con contratto art. 2, 12 e 36: l’idea non è di<br />
azzerare la soglia d’ingresso, bensì quella di<br />
cercare di abbassarla il più possibile,<br />
consentendo a chi è al di sotto della fascia<br />
minima di integrare, contemperando le<br />
esigenze di solidarietà e quelle di bilancio<br />
della Cassa.<br />
È necessario ricordare però che tutti i giornalisti<br />
iscritti alla cassa riceveranno a casa il<br />
nuovo tariffario insieme alle convenzioni in<br />
atto in tutta Italia. E sarà inoltre disponibile<br />
sul sito della cassa www.casagit.it.<br />
Gli esempi più eloquenti sono quelli delle<br />
visite specialistiche che, nel nuovo elenco,<br />
passano da 61,97 a 80 euro, mentre le visite<br />
omeopatiche da 41,32 a 50 euro. A loro<br />
volta, la degenza retta giornaliera passa da<br />
232,41 a 250 euro, la retta per malattie<br />
nervose da 154,94 a 200 euro, quella per<br />
lungodegenza da 30,99 a 35 euro. Per la<br />
chirurgia generale invece l’aumento medio è<br />
del 10 per cento come per le cure dentarie,<br />
mentre la fisioterapia lievita del 20 ed entra<br />
la nuova voce dell’assistenza ai malati terminali<br />
(150 euro al giorno). Il settore psicoterapia<br />
vede un aumento delle sedute da 35 a<br />
40 euro l’anno e del concorso per visita da<br />
25,82 a 30 euro.<br />
La diagnostica, infine, assiste anch’essa<br />
all’aumento medio del 10 per cento. Tutto<br />
questo, ossia l’onere complessivo dell’aumento<br />
<strong>dei</strong> rimborsi, costerà circa 4.600.000<br />
euro l’anno pari a 9 miliardi del vecchio<br />
conio.<br />
(Servizio in ultima)<br />
Sono mutati i requisiti culturali<br />
per l’esercizio di una professione<br />
nell’ambito <strong>dei</strong> Paesi Ue e,<br />
quindi, i giornalisti professionisti<br />
italiani non possono essere<br />
discriminati rispetto agli altri<br />
professionisti italiani e a quelli<br />
europei sotto il profilo della<br />
preparazione universitaria minima<br />
di tre anni, principio al quale devono<br />
attenersi anche alcune professioni<br />
un tempo collegate a un diploma<br />
di scuola media superiore<br />
(geometri, ragionieri, periti agrari<br />
e periti industriali)<br />
Anno XXXIV<br />
n. 1 <strong>Gennaio</strong> <strong>2004</strong><br />
Direzione e redazione<br />
Via Appiani, 2 - 20121 Milano<br />
Telefono: 02 63 61 171<br />
Telefax: 02 65 54 307<br />
http://www.odg.mi.it<br />
e-mail:odgmi@odg.mi.it<br />
Spedizione in a.p. (45%)<br />
Comma 20 (lettera b)<br />
dell’art. 2 della legge n. 662/96<br />
Filiale di Milano<br />
di Franco Abruzzo<br />
Le Regioni non possono istituire nuove<br />
professioni. Questo è l’assunto centrale della<br />
sentenza n. 353 (depositata il 12 dicembre<br />
2003) della Corte costituzionale, che ha<br />
abrogato (in quanto “illegittima”) una legge<br />
piemontese istitutiva di figure sanitarie. La<br />
sentenza chiarisce l’ambito delle competenze<br />
concorrenti tra Stato e Regioni e afferma<br />
che la materia delle professioni, con i relativi<br />
profili ed ordinamenti didattici, appartiene<br />
soltanto allo Stato. La Consulta scrive:<br />
“…non pare quindi dubbio che, anche oggi,<br />
la potestà legislativa regionale in materia di<br />
professioni sanitarie debba rispettare il principio,<br />
già vigente nella legislazione statale,<br />
secondo cui l’individuazione delle figure<br />
professionali, con i relativi profili ed ordinamenti<br />
didattici, debba essere riservata<br />
allo Stato… la legge della Regione Piemonte<br />
n. 25 del 2002 … viene soprattutto ad incidere<br />
su aspetti essenziali della disciplina<br />
degli operatori sanitari senza appunto rispettare,<br />
in violazione dell’art. 117, terzo comma<br />
L’ assemblea degli iscritti giovedì 25 marzo <strong>2004</strong><br />
“Oro” a 22 colleghi<br />
per 50 anni di Albo<br />
Milano, 2 gennaio <strong>2004</strong>. Sono 22 i colleghi<br />
(18 professionisti e 4 pubblicisti) che<br />
quest’anno compiono i 50 anni di iscrizione<br />
negli elenchi dell’Albo. Riceveranno la<br />
medaglia d’oro dell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia<br />
in occasione dell’assemblea annuale degli<br />
iscritti che si terrà giovedì 25 marzo (h 15)<br />
al Circolo della Stampa. Ed ecco i loro nomi:<br />
PROFESSIONISTI<br />
Giuliano Coacci, Nicola D’Amico, Giorgio<br />
D’Ilario, Pilade Del Buono, Bruno Giuseppe<br />
Enriotti, Massimo Fabbri, Enzo Fabiani,<br />
Carmela Fedele, Enzo Freri, Ferdinando<br />
Mariani, Marco Matteucci, Mario Oriani,<br />
Anna Maria Ottolenghi, Massimo Ranghie-<br />
SOMMARIO<br />
Letizia Moratti Maria Grazia Siliquini<br />
Segue a pagina 3<br />
ri, Sergio Rossi, Giorgio Santocanale,<br />
Angelo Soldani, Luigi Vismara.<br />
PUBBLICISTI<br />
Luciano Consigli, Franco Gallini, Jole Giannini,<br />
Giancarlo Sansoni.<br />
Nel corso dell’assemblea verranno consegnate<br />
le tessere di praticante agli allievi della<br />
Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica<br />
e dell’Ifg “Carlo De Martino”. Verranno<br />
premiati anche i vincitori del “Concorso Tesi<br />
di laurea sul giornalismo”. All’ordine del giorno<br />
dell’assemblea degli iscritti all’Albo figura<br />
l’approvazione del bilancio preventivo <strong>2004</strong><br />
e del conto consuntivo 2003.<br />
Inpgi Braccio di ferro tra i due schieramenti pag. 2<br />
Diffamazione <strong>Giornalisti</strong> ancora sospesi tra carcere e multe pag. 4<br />
Tesi di laurea Schumacher, mito tedesco. Ferrari, leggenda italiana pag. 6<br />
Giurisprudenza Quando il trasferimento di sede di un inviato è nullo pag. 11<br />
Centenari “Malaparte autentico” nel ricordo di Lino Pellegrini pag. 12<br />
Vigevano ricorda Tommaso Besozzi pag. 26<br />
Intervista Giancolombo, il Dopoguerra con ironia pag. 14<br />
Riforma Tv Ciampi non firma la legge. Il messaggio del Presidente pag. 17<br />
Solidarietà Bagliori nelle tenebre. Viaggio nei reparti del dolore pag. 18<br />
Giornali storici Quando i giornalisti facevano i commessi pag. 20<br />
Felice Cavallotti, il D’Artagnan del giornalismo italiano pag. 22<br />
La stampa socialista, storie di schiavi bianchi nell’Italia unita pag. 25<br />
La libreria di Tabloid Le recensioni del mese pag. 27<br />
1
CRONACA DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO GENERALE DELL’ISTITUTO. RINVIO AL 14 GENNAIO <strong>2004</strong><br />
4 dicembre: subito<br />
braccio di ferro tra<br />
i due schieramenti<br />
(le nomine slittano)<br />
1. Comunicato di Autonomia e solidarietà/<strong>Giornalisti</strong> uniti<br />
“È ancora possibile un dialogo per evitare<br />
i rischi di un prolungato vuoto<br />
nella gestione dell’Istituto”<br />
Roma, 4 dicembre 2003. Le componenti di<br />
“Autonomia e Solidarietà” e “<strong>Giornalisti</strong> Uniti<br />
per un’informazione libera” esprimono<br />
rammarico per la mancata elezione del<br />
Consiglio di Amministrazione dell’Inpgi da<br />
parte del Consiglio generale riunito oggi.<br />
L’Istituto di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti non ha<br />
quindi ancora una guida stabile ed autorevole,<br />
a causa dell’atteggiamento ostruzionistico<br />
di 19 consiglieri che non hanno partecipato<br />
al voto facendo mancare il quorum di due<br />
terzi degli aventi diritto al voto previsto dallo<br />
2. Comunicato di Inpgi.Sicambia<br />
Roma, 4 dicembre 2003. La “maggioranza”<br />
dell’Inpgi che fa capo al presidente uscente<br />
Gabriele Cescutti non è riuscita ad eleggere<br />
il nuovo consiglio d’amministrazione.<br />
Lo annunciano i consiglieri generali di<br />
Inpgi.Sicambia (Puntoeacapo, Quarto Potere,<br />
Stampa Democratica, Stampa Romana)<br />
che, insieme al consigliere della Calabria,<br />
non hanno partecipato al voto facendo<br />
mancare il numero legale. In questo modo,<br />
Inpgi.Sicambia ha impedito l’arrogante blitz<br />
tentato dalla “maggioranza” (che comprende<br />
Cescutti e il segretario Fnsi Paolo Serventi<br />
Longhi) che aveva dichiarato di voler occupare<br />
9 posti su 10 in consiglio d’amministrazione.<br />
“L’istituto di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti deve<br />
essere rinnovato e gestito tenendo conto<br />
della volontà di oltre 2.300 colleghi che<br />
hanno votato per Inpgi.Sicambia in Lazio-<br />
Molise, Lombardia e Campania: in queste<br />
regioni, dove opera più del 63% <strong>dei</strong> giornalisti<br />
italiani, la coalizione di Inpgi.Sicambia ha<br />
ottenuto una netta vittoria. L’attuale statuto<br />
Inpgi assegna solo il 50% <strong>dei</strong> consiglieri alle<br />
regioni dove lavora la maggioranza <strong>dei</strong> gior-<br />
23 dicembre<br />
Trattative bloccate<br />
sul “nodo Cescutti”<br />
Roma, 23 dicembre 2003. L’alleanza inpgi.sicambia ha<br />
diffuso il seguente comunicato: “Una soluzione per il governo<br />
dell’Inpgi si potrà trovare se il Presidente uscente<br />
Gabriele Cescutti farà un passo indietro. È quanto hanno<br />
chiesto i portavoce di “Inpgi.Sicambia” durante il secondo<br />
incontro che si è tenuto oggi con i rappresentanti di “Autonomia<br />
e Solidarietà/<strong>Giornalisti</strong> Uniti”.<br />
A fronte di proposte tanto modeste da risultare irrispettose<br />
nei confronti dell’elettorato che a Milano, Roma e Napoli si<br />
è espresso con chiarezza per un radicale cambiamento<br />
nella gestione dell’Istituto, i rappresentanti di inpgi.sicambia,<br />
hanno ribadito la necessità di un effettivo rinnovamento<br />
dell’Inpgi, a partire dalla sostituzione del Presidente.<br />
Con questa pregiudiziale il confronto rimane comunque<br />
aperto. Il Consiglio Generale che dovrà nominare il CdA è<br />
fissato per il 14 gennaio prossimo: dunque c’è ancora<br />
tempo per trovare una soluzione adeguata. Chi vuole a tutti<br />
i costi e con qualsiasi compromesso imporre Gabriele<br />
Cescutti alla guida dell’Inpgi si assume la responsabilità di<br />
un percorso che contiene il rischio del Commissariamento<br />
dell’Istituto”.<br />
Statuto per l’elezione del Cda. Alla votazione<br />
hanno infatti partecipato 38 consiglieri su 58,<br />
quindi una maggioranza larga che intende<br />
confermare e rafforzare la linea di onestà,<br />
rigore ed efficienza seguita dai precedenti<br />
Consigli di amministrazione.<br />
Le componenti di maggioranza ritengono sia<br />
ancora possibile un dialogo tra tutte le aree<br />
presenti nel Consiglio generale dell’Inpgi per<br />
ricercare una soluzione condivisa che eviti i<br />
rischi di un prolungato vuoto nella gestione<br />
dell’Istituto.<br />
“Abbiamo impedito a una maggioranza<br />
di palazzo di sostituirsi<br />
alla vera maggioranza degli elettori”<br />
nalisti: oggi abbiamo impedito che una<br />
maggioranza di palazzo si sostituisse alla<br />
vera maggioranza degli elettori, ma siamo<br />
disponibili a lavorare insieme per un’effettiva<br />
collaborazione. Perciò avevamo proposto,<br />
prima di uscire dall’aula, il rinvio del voto per<br />
il consiglio d’amministrazione e siamo aperti<br />
a un confronto serio nei prossimi giorni”,<br />
hanno dichiarato i consiglieri di Inpgi.Sicambia<br />
Maurizio Andriolo, Enrico Castelli, Paolo<br />
Chiarelli, Marcella Ciarnelli, Stefania Conti,<br />
Carlo Ercole Gariboldi, Francesco Gerace,<br />
Giacomo Lombardi, Silvana Mazzocchi,<br />
Umberto Nardacchione, Giovanni Negri,<br />
Giuseppe Nicotri, Edmondo Rho, Pierluigi<br />
Roesler Franz, Marco Sassano, Claudio<br />
Scarinzi, Massimo Signoretti, Marcello Ugolini,<br />
Lino Zaccaria. A sua volta il consigliere<br />
Carlo Parisi, ha dichiarato: “Ho preso atto<br />
che il segretario aggiunto della Fnsi, Giovanni<br />
Rossi, ha ufficialmente affermato che non<br />
ci sono le condizioni politiche per un allargamento<br />
della maggioranza e quindi, pur non<br />
appartenendo alla coalizione Inpgi.Sicambia,<br />
la Calabria ha abbandonato l’aula non partecipando<br />
al voto”.<br />
Inpgi<br />
Lettera-proposta<br />
Presidente e consiglieri<br />
a casa dopo due mandati<br />
Ritengo che sia dovere di ogni giornalista partecipare al<br />
dibattito che sta infiammando l’Inpgi. Abilitato e fortificato da<br />
40 anni di iscrizione all’Albo, chiedo ospitalità a Tabloid ed<br />
entro subito in argomento prendendo spunto dall’articolo di<br />
Enzo Chiodini apparso sul numero di dicembre, articolo scritto<br />
con rabbia e amore, impastato di spirito caustico e di forti<br />
verità.<br />
Punti nodali della riforma sono quelli indicati con lucido vigore<br />
da Franco Abruzzo: la revisione dello statuto per abolire<br />
l’attuale iniquo sistema elettorale e l’abolizione del divieto di<br />
cumulo che tanti danni - in massima parte non rimediabili -<br />
ha combinato ai pensionati.<br />
Ma vorrei dire qualcosa di più a costo di attirarmi antipatie a<br />
ogni livello.<br />
Il nuovo auspicabile statuto dovrebbe contenere la norma<br />
che impedisce la rielezione di presidente, consiglieri e sindaci<br />
dopo due mandati consecutivi.<br />
Quante volte noi giornalisti accusiamo personaggi dell’industria,<br />
della finanza, della politica e dello sport di essere legati<br />
al classico, fatidico, compromettente cadreghino? Perché<br />
non dare prova che nell’alternanza crediamo davvero?<br />
11 dicembre: inizia<br />
il confronto serrato<br />
per scongiurare<br />
il commissariamento<br />
Roma, 11 dicembre 2003. Iniziato oggi il<br />
confronto per eleggere i nuovi vertici dell’Inpgi.<br />
“Inpgi.Sicambia” ha accettato di incontrare i<br />
vertici della Fnsi, guidati dal segretario Paolo<br />
Serventi Longhi, e il presidente uscente<br />
dell’Inpgi Gabriele Cescutti, per trovare una<br />
soluzione all’attuale impasse e per dare un<br />
futuro all’Istituto di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti’:<br />
“Dopo la fumata nera del 4 dicembre scorso,<br />
quando è fallito il tentato blitz della ‘maggioranza’<br />
che voleva occupare 9 posti su 10 in Consiglio<br />
d’Amministrazione, abbiamo ribadito oggi<br />
che il confronto deve garantire una effettiva<br />
rappresentanza della volontà di oltre 2.300<br />
colleghi che hanno votato per noi in Lazio-Molise,<br />
Lombardia e Campania”, hanno dichiarato i<br />
rappresentati di Inpgi.Sicambia. Durante l’incontro<br />
di oggi, i portavoce di Inpgi.Sicambia,<br />
Silvana Mazzocchi e Giovanni Negri hanno<br />
ribadito le posizioni dell’alleanza - cui hanno<br />
aderito Puntoeacapo, Professione Giornalista,<br />
Quarto Potere, Stampa Democratica e<br />
per la lista <strong>dei</strong> pensionati Stampa Romana -<br />
e il segretario della Fnsi ha garantito che senza<br />
un ulteriore passaggio con Inpgi.Sicambia<br />
non si riunirà il Consiglio generale dell’Istituto<br />
di previdenza per eleggere il nuovo Consiglio<br />
d’Amministrazione. Inpgi.Sicambia “considera<br />
positivo l’avvio di un confronto politicoprogrammatico<br />
per il funzionamento dell’Istituto<br />
di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti: l’elezione <strong>dei</strong><br />
nuovi vertici al momento appare improbabile<br />
possa avvenire prima delle prossime festività”.<br />
“In Lazio-Molise, Lombardia e Campania, dove<br />
opera più del 63% <strong>dei</strong> giornalisti italiani, la<br />
coalizione di Inpgi.Sicambia ha ottenuto una<br />
netta vittoria: noi siamo disponibili a lavorare<br />
insieme per un’effettiva collaborazione, ma<br />
chiediamo tra l’altro una riforma statutaria che<br />
dia maggiori garanzie all’intera categoria”,<br />
hanno concluso i rappresentanti di<br />
Inpgi.Sicambia.<br />
Riscontro di apertura per il momento, come si<br />
legge in una nota di “Autonomia e solidarieta e<br />
<strong>Giornalisti</strong> uniti, le componenti che sul piano<br />
nazionale hanno ottenuto la maggioranza degli<br />
eletti nel consiglio generale dell’Inpgi (oltre 34<br />
eletti), e che hanno avviato oggi il confronto<br />
con le liste di minoranza (19 eletti) in vista della<br />
formazione del consiglio di amministrazione<br />
dell’istituto”. La maggioranza “si è detta disponibile<br />
al dialogo, purché non si vogliano stravolgere<br />
o addirittura capovolgere con accordi<br />
di vertice i risultati delle urne, che sono stati<br />
chiari e netti, ottenuti su programmi e candidati<br />
ben identificati. Apertura al dialogo. Apertura<br />
al confronto. In modo da garantire all’Inpgi un<br />
governo efficiente, solido, capace di garantire<br />
il futuro e non solo di fare promesse”. (AGI)<br />
Abruzzo<br />
“Ora serve<br />
un presidente<br />
di garanzia”<br />
Milano, 11 dicembre 2003. Franco<br />
Abruzzo (Movimento Professione<br />
Giornalista) ha così commentato gli<br />
avvenimenti romani: “Rimango dell’idea<br />
che l’Inpgi abbia bisogno di un<br />
presidente di garanzia e di una giunta<br />
unitaria e paritetica che in 30 giorni<br />
prepari un nuovo Statuto dell’Istituto<br />
rispettoso delle regole democratiche.<br />
La maggioranza oggi è minoranza,<br />
mentre la minoranza è maggioranza.<br />
La Costituzione è stata violentata.<br />
Dopo il varo del nuovo Statuto, bisogna<br />
andare al voto per consegnare la<br />
gestione a una maggioranza che<br />
accetti questo programma minimo: a)<br />
aggancio delle pensioni agli aumenti<br />
contrattuali biennali; b) libertà di<br />
cumulo per i pensionati; c) libertà di<br />
iscrizione alla gestione separata per<br />
chi ha contratti di collaborazione regolati<br />
dalla cessione <strong>dei</strong> diritti oppure<br />
per chi guadagna fino a 5mila euro<br />
all’anno”.<br />
E ora, a costo di passare per un donchisciottesco risparmiatore,<br />
pongo alcune domande all’attenzione <strong>dei</strong> colleghi:<br />
1) Non è assurdo che a Roma dove l’Inpgi possiede fior di<br />
stabili, l’Istituto debba avere due sedi, una in piazza Apollodoro<br />
e l’altra in via Nizza con evidente raddoppio delle<br />
spese generali?<br />
2) Perché inviare ogni mese il “cedolino” della pensione<br />
quando la stessa non varia? Non sarebbe sufficiente<br />
spedirlo una volta all’anno risparmiando così spese di<br />
carta, stampa, imbustamento e posta?<br />
3) Qual è il rapporto (numerico) tra impiegati dell’Inpgi e giornalisti<br />
iscritti all’Inpgi?<br />
4) Che senso ha la pubblicazione del periodico “Inpgi - comunicazione”<br />
visto che il più delle volte giunge a destinazione<br />
già... obsoleto?<br />
5) Non sarebbe più utile e conveniente tenere aggiornato in<br />
tempo reale il sito Internet?<br />
Sono piccole cose? Può essere, ma di tanti granelli di sabbia<br />
è formato il deserto. Almeno su questo dovremmo essere<br />
tutti d’accordo. O no? Mario Bardi<br />
2 ORDINE 1 <strong>2004</strong>
I N T E R V E N T O<br />
Pensione giornalisti:<br />
ovvero quando la legge<br />
non è uguale per tutti<br />
Riforma delle pensioni: un tormentone che<br />
angoscia e contrappone. Sono soprattutto<br />
quelle di anzianità e la loro abolizione a tenere<br />
accesa la contrapposizione tra sindacati e<br />
opposizione da una parte, Governo dall’altra.<br />
Ci sono, però, alcune categorie indifferenti<br />
alla contesa perché escluse dalla possibilità<br />
di ottenere la pensione di anzianità<br />
anche con 40 anni di contributi e magari 64<br />
anni di età. Sono tutti quei professionisti che<br />
nell’arco della vita hanno cambiato lavoro e<br />
Istituto previdenziale. In questa casistica, pur<br />
essendo lavoratori dipendenti, rientrano i<br />
giornalisti della Rai o comunque tutti coloro<br />
che prima dell’Inpgi abbiano versato i contributi<br />
previdenziali ad un istituto diverso dall’Inps<br />
o Inpdap (poi vedremo i riferimenti a<br />
quest’ultimo Ente). Ma vediamo come stanno<br />
le cose.<br />
Per le pensioni di anzianità la regola da<br />
applicare ai giornalisti discende da una legge<br />
del ‘55, la n° 1122 così detta legge Vigorelli<br />
che all’art. 3 recita: “All’iscritto presso l’Istituto<br />
nazionale di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti<br />
italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento<br />
del diritto a pensione, il periodo di<br />
iscrizione e la contribuzione versata nell’Assicurazione<br />
Generale Obbligatoria per la<br />
invalidità, la vecchiaia e i superstiti” vale a<br />
dire l’Inps. La legge parla di vecchiaia e non<br />
di anzianità perché a quel tempo “l’anzianità”<br />
non esisteva. Quando poi questa è stata<br />
introdotta nel nostro sistema nessuno si è<br />
preoccupato di modificare quella legge. E<br />
quando ciò è stato suggerito si è fatto orecchie<br />
da mercante a causa, è stato detto,<br />
dell’aumento <strong>dei</strong> costi per gli istituti eroganti.<br />
In pratica cosa succede con la legge 1122?<br />
Ai fini della pensione di anzianità essa<br />
consente la totalizzazione <strong>dei</strong> contributi (ogni<br />
Ente paga “pro rata” per gli anni <strong>dei</strong> rispettivi<br />
versamenti) solo tra Inpgi e Inps escludendo<br />
tutte le altre “previdenze” nonostante le stesse<br />
siano sostitutive dell’Assicurazione obbligatoria<br />
di previdenza sociale.<br />
L’estensore di questo articolo ha iniziato ad<br />
occuparsi della questione all’indomani della<br />
sentenza n°61 del ‘99 emessa dalla Corte<br />
costituzionale su ricorso <strong>dei</strong> dipendenti della<br />
casse private o privatizzate ai quali non era<br />
consentito il pro quota nemmeno per la<br />
pensione di vecchiaia.<br />
Ebbene quella sentenza invitava il legislatore<br />
a provvedere senza però specificare per<br />
quali fattispecie. La totalizzazione è stata poi<br />
inserita, per le categorie escluse, nella finanziaria<br />
del 2001 (legge n. 388/2000) ma a<br />
valere solo per la pensione di vecchiaia.<br />
Da allora ci sono stati contatti con i presidenti<br />
pro tempore e alcuni componenti della<br />
Commissione lavoro della Camera e perfino<br />
con sottosegretari. Della questione era stato<br />
investito anche il presidente della Commissione<br />
parlamentare di controllo Enti gestori<br />
previdenza e assistenza sociale senatore<br />
Michele De Luca il quale in una relazione<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
di Marcello Paris<br />
riteneva giusta la totalizzazione anche per la<br />
pensione di anzianità. Purtroppo l’opposizione<br />
delle casse private, attraverso le loro<br />
associazioni e soprattutto l’AdEPP, hanno<br />
impedito una possibile soluzione nel senso<br />
richiesto.<br />
Non è dato conoscere che incidenza avrebbe<br />
la pensione di anzianità su le varie casse<br />
private. Sappiamo che per l’Inpgi l’esborso<br />
sarebbe molto limitato per l’esiguo numero<br />
delle persone coinvolte e ancor meno per<br />
quelle interessate ad abbandonare il lavoro<br />
prima <strong>dei</strong> 65 anni.<br />
Sollecitazioni e sensibilizzazioni al problema<br />
sono state fatte anche nei confronti dell’Inpgi,<br />
della Fnsi e dell’Usigrai. L’Inpgi, attraverso<br />
il presidente Gabriele Cescutti, si limitò a<br />
rispondere ciò che già si conosceva.<br />
La Fnsi, attraverso il direttore Giancarlo<br />
Tartaglia, nel settembre 1999 rispose che in<br />
occasione di una audizione la questione era<br />
stata sottoposta all’attenzione del presidente<br />
della Commissione lavoro della Camera, in<br />
quel momento l’onorevole Renzo Innocenti<br />
Ds, (peraltro da noi in precedenza contattato).<br />
Da allora silenzio. Insomma si protrae una<br />
situazione di grande discriminazione tra lavoratori<br />
della stessa categoria. Tanto per esemplificare:<br />
i colleghi della carta stampata se<br />
impiegati in precedenza all’interno dell’azienda<br />
editoriale con altra mansione e versamenti<br />
all’Inps possono ottenere la pensione<br />
di anzianità.<br />
Ma non è finita. La discriminazione in atto si<br />
trasformerà in beffa quando gli Enti Locali, e<br />
la Pubblica Amministrazione in genere,<br />
aderiranno alla richiesta dell’Inpgi che, interpretando<br />
una circolare ministeriale, chiede<br />
ai giornalisti degli uffici stampa e alle amministrazioni<br />
da cui dipendono di versare i<br />
contributi al nostro Istituto.<br />
Ebbene questi colleghi in virtù della legge<br />
322/58 possono “spostare”, a titolo gratuito, i<br />
contributi dal loro Istituto, l’Inpdap, all’Inps e<br />
ottenere, volendo, la pensione di anzianità.<br />
Allora, tutti coloro che hanno versato i contributi<br />
ad Enti diversi dall’Inps e Inpdap non<br />
potranno mai ottenere la pensione di anzianità?<br />
No, due possibilità ci sarebbero ma<br />
entrambe onerose.<br />
La prima consiste nello spostare “ricongiungere”<br />
tutti i contributi dentro l’Inps perdendo i<br />
benefici del maggior rendimento derivante<br />
dai versamenti all’Inpgi. In pratica contributi<br />
buttati al vento. L’altra possibilità è data dalla<br />
ricongiunzione di tutti i contributi con l’Inpgi,<br />
possibilità molto teorica per l’alto costo della<br />
stessa.<br />
Come si è detto all’inizio la riforma delle<br />
pensioni prevede il superamento della<br />
pensione di anzianità ma, finché questo istituto<br />
esiste, giustizia verrebbe che tutti i lavoratori,<br />
a parità di condizioni, ne potessero<br />
usufruire. Si tratta di una questione di uguaglianza.<br />
O no?<br />
Sentenza della Corte costituzionale<br />
La totalizzazione <strong>dei</strong> contributi versati<br />
a più gestioni accerta i requisiti<br />
per la pensione ma non l’importo<br />
Nella sentenza n. 325/2003, la Corte costituzionale<br />
ha ribadito un principio importante:<br />
“Questa Corte ha più volte affermato che il<br />
meccanismo della totalizzazione <strong>dei</strong> periodi<br />
versati in diverse gestioni previdenziali<br />
debba operare nel caso in cui l’assicurato<br />
non abbia maturato il diritto a un trattamento<br />
pensionistico in alcuna delle gestioni alle<br />
quali è o è stato iscritto (in particolare<br />
sentenze n. 198/2002 e n. 61/1999). Rientra,<br />
invece, nella discrezionalità del legislatore la<br />
scelta circa l’estensione del principio ai fini<br />
della misurazione della pensione (sentenza<br />
n. 198/2002”.<br />
Segue Abruzzo da pagina 1<br />
“Professioni, decide solo lo Stato”<br />
(<strong>Giornalisti</strong> vicini alla laurea)<br />
della Costituzione, il principio fondamentale<br />
che riserva allo Stato la individuazione e<br />
definizione delle varie figure professionali<br />
sanitarie”.<br />
Il principio affermato dalla Consulta non è<br />
nuovo. Nella sentenza n. 38/1997, la Corte<br />
aveva, infatti, affermato che “rientra nella<br />
discrezionalità del legislatore ordinario determinare<br />
le professioni intellettuali per l’esercizio<br />
delle quali è opportuna l’istituzione di<br />
ordini o collegi e la necessaria iscrizione in<br />
appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.)”.<br />
L’importanza della nuova pronuncia è tutta<br />
nelle date: la sentenza del 12 dicembre 2003<br />
è la prima dopo la riforma (legge costituzionale.<br />
18 ottobre 2001 n. 3) del Titolo V, che<br />
al terzo comma dell’articolo 117 afferma:<br />
“Nelle materie di legislazione concorrente<br />
spetta alle Regioni la potestà legislativa,<br />
salvo che per la determinazione <strong>dei</strong> princìpi<br />
fondamentali, riservata alla legislazione dello<br />
Stato”. Una sentenza della Corte costituzionale<br />
(la n. 271 del 22 luglio 1996), in tema di<br />
principi fondamentali, afferma che “nella<br />
materia di competenza concorrente, i principi<br />
fondamentali risultanti dalla legislazione<br />
statale esistente, assolvono alla funzione<br />
loro propria, che è quella di unificare il sistema<br />
delle autonomie ai livelli più alti, solo<br />
quando hanno il carattere di stabilità e univocità”.<br />
La sentenza n. 353/2003 ribadisce sul<br />
punto che “i relativi principi fondamentali,<br />
non essendone stati, fino ad ora, formulati<br />
<strong>dei</strong> nuovi, sono pertanto da considerare<br />
quelli, secondo la giurisprudenza di questa<br />
Corte (cfr. sentenze n. 201 del 2003 e n. 282<br />
del 2002), risultanti dalla legislazione statale<br />
già in vigore”.<br />
L’assetto attuale delle professioni<br />
Il Dlgs n. 300/1999 affida al ministero della<br />
Giustizia la vigilanza sugli Ordini professionali<br />
e al ministero dell’Istruzione-Università<br />
la “missione” di formare i nuovi professionisti.<br />
Il comma 18 dell’articolo 1 della legge n.<br />
4/1999 conferisce al ministero dell’Istruzione-Università,<br />
di concerto con quello della<br />
Giustizia, il compito di “integrare e modificare”<br />
con regolamento gli attuali ordinamenti<br />
sull’accesso alla professioni e di raccordarli<br />
con le lauree triennali e con le lauree specialistiche<br />
biennali. Il regolamento (Dpr n.<br />
328/2001) disciplina la maggioranza delle<br />
professioni intellettuali (dottore agronomo e<br />
dottore forestale, agrotecnico, architetto,<br />
assistente sociale, attuario, biologo, chimico,<br />
geologo, geometra, ingegnere, perito agrario,<br />
perito industriale, psicologo) e trascura<br />
quelle <strong>dei</strong> giornalisti, degli statistici e <strong>dei</strong><br />
consulenti del lavoro. Con parere 7 maggio<br />
2002 n. 2228 il Consiglio di Stato ha scritto<br />
che “non sussistono motivi ostativi alla riforma<br />
dell’ordinamento professionale <strong>dei</strong> giornalisti,<br />
come previsto dall’articolo 1 (comma<br />
18) della legge n. 4/1999”.<br />
L’<strong>Ordine</strong> di Milano pronto a disapplicare<br />
la normativa italiana sull’accesso<br />
a favore di quella comunitaria<br />
che prevede il possesso<br />
di una laurea minima triennale<br />
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione,<br />
si è ritenuto (erroneamente) che lo<br />
Stato avesse perso i suoi poteri regolamentari<br />
e che non potesse, quindi, riscrivere il<br />
Dpr n. 328/2001, allargandolo ai giornalisti,<br />
<strong>Ordine</strong>/Tabloid<br />
ORDINE - TABLOID<br />
periodico ufficiale del Consiglio<br />
dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia<br />
Mensile / Spedizione in a. p. (45%)<br />
Comma 20 (lettera B) art. 2 legge n. 662/96<br />
Filiale di Milano<br />
Anno XXXIV - Numero 1, gennaio <strong>2004</strong><br />
Direttore responsabile FRANCO ABRUZZO<br />
Condirettore BRUNO AMBROSI<br />
Direzione, redazione, amministrazione<br />
Via Appiani, 2 - 20121 Milano<br />
Tel. 02/ 63.61.171 - Telefax 02/ 65.54.307<br />
Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti<br />
della Lombardia<br />
Franco Abruzzo presidente;<br />
Brunello Tanzi vicepresidente;<br />
Sergio D’Asnasch consigliere segretario;<br />
Davide Colombo consigliere tesoriere.<br />
Consiglieri: Bruno Ambrosi,<br />
Letizia Gonzales, Liviana Nemes Fezzi,<br />
Cosma Damiano Nigro, Paola Pastacaldi<br />
agli statistici e ai consulenti del lavoro. Si può<br />
affermare, con Vincenzo Caianiello, che<br />
“tutto ciò che attiene allo status del professionista<br />
e delle libere professioni è riconducibile<br />
all’articolo 33 della Costituzione, il<br />
quale parla di esame di Stato” (Vincenzo<br />
Caianiello, “L’inserimento delle professioni<br />
nel titolo V della Costituzione” in Atti del<br />
Convegno nazionale “Quale federalismo per<br />
le professioni” del 18 marzo 2002 in Codroipo-Ud).<br />
Il ministero dell’Istruzione-Università nell’ottobre<br />
scorso ha rimeditato la questione del<br />
collegamento tra laurea universitaria, praticantato<br />
giornalistico ed esame di Stato. Il<br />
ministro Letizia Moratti ha dato disco verde<br />
alle modifiche del Dpr n. 328/2001, istituendo<br />
una commissione ad hoc guidata dal<br />
sottosegretario di Stato Maria Grazia Siliquini.<br />
Conseguentemente il Consiglio<br />
dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia<br />
ha bloccato una delibera con la quale lo<br />
stesso Consiglio, quale autorità amministrativa,<br />
avrebbe disapplicato (in forza delle<br />
sentenze n. causa 103/1988 della Corte di<br />
Giustizia Ce 22 luglio 1989 e n. 389/1989<br />
della Corte costituzionale) l’articolo 33<br />
(commi 4, 5, 6 e 7) della legge n. 69/1963,<br />
affermando la prevalenza (in base alla<br />
sentenza n. 389/1989 della Corte costituzionale)<br />
sulla norma interna della Direttiva<br />
n. 89/48/CEE. Questa direttiva, in base alla<br />
sentenza della quarta sezione della Corte<br />
di Giustizia europea nella causa C- 285/00,<br />
si applica “alle professioni regolamentate,<br />
cioè a quelle per le quali l’accesso o l’esercizio<br />
sono subordinati, direttamente o indirettamente,<br />
mediante disposizioni legislative,<br />
regolamentari o amministrative, al<br />
possesso di un diploma universitario della<br />
durata minima di tre anni”.<br />
Sono mutati i requisiti culturali per l’esercizio<br />
di una professione nell’ambito <strong>dei</strong> Paesi Ue<br />
e, quindi, i giornalisti professionisti italiani<br />
non possono essere discriminati rispetto agli<br />
altri professionisti italiani e a quelli europei<br />
sotto il profilo della preparazione universitaria<br />
minima di tre anni, principio al quale<br />
devono attenersi anche alcune professioni<br />
un tempo collegate a un diploma di scuola<br />
media superiore (geometri, ragionieri, periti<br />
agrari e periti industriali).<br />
Con l’iniziativa del ministro Moratti e del<br />
sottosegretario Siliquini, è prevedibile che<br />
nel giro di 4-6 mesi l’accesso al praticantato<br />
giornalistico e all’esame di Stato sia vincolato<br />
esclusivamente al possesso di una laurea<br />
(qualsiasi) conseguita al termine di un<br />
percorso minimo di tre anni. La pratica (di<br />
durata biennale) potrà essere svolta nelle<br />
redazioni; nelle scuole di giornalismo, nei<br />
master universitari e nei corsi di laurea<br />
specialistica in giornalismo (riconosciuti<br />
dall’<strong>Ordine</strong>). La modifica del Dpr n. 328/2001<br />
presuppone una prima approvazione del<br />
testo da parte del Consiglio <strong>dei</strong> ministri, l’acquisizione<br />
successiva di tre pareri (tra i quali<br />
quello del Consiglio di Stato) e, quindi, una<br />
seconda approvazione da parte del Consiglio<br />
<strong>dei</strong> ministri. Segue la pubblicazione del<br />
Dpr nella Gazzetta Ufficiale. Un Dpr, che,<br />
comunque, fotografa una situazione esistente:<br />
già oggi 8 praticanti su 10 sono laureati.<br />
Franco Abruzzo<br />
Collegio <strong>dei</strong> revisori <strong>dei</strong> conti<br />
Alberto Comuzzi (presidente),<br />
Maurizio Michelini e Giacinto Sarubbi<br />
Direttore dell’OgL Elisabetta Graziani<br />
Segretaria di redazione Teresa Risé<br />
Realizzazione grafica:<br />
Grafica Torri Srl (coordinamento<br />
Franco Malaguti, Marco Micci)<br />
Stampa Stem Editoriale S.p.A.<br />
Via Brescia, 22<br />
20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)<br />
Registrazione n. 213 del 26 maggio 1970<br />
presso il Tribunale di Milano.<br />
Testata iscritta al n. 6197 del Registro<br />
degli Operatori di Comunicazione (ROC)<br />
Comunicazione e Pubblicità<br />
Comunicazioni giornalistiche Advercoop<br />
Via G.C.Venini, 46 - 20127 Milano<br />
Tel. 02/ 261.49.005 - Fax 02/ 289.34.08<br />
La tiratura di questo numero<br />
è di 23.296 copie<br />
Chiuso in redazione il 23 dicembre 2003<br />
3
DIFFAMAZIONE<br />
<strong>Giornalisti</strong><br />
ancora<br />
di Francesca Romanelli<br />
Il tempo delle polemiche era scattato prima<br />
dell’estate. Quando la proposta di legge che<br />
aveva come relatore Gianfranco Anedda,<br />
parlamentare di An, si era vista approvare in<br />
Commissione giustizia alla Camera un<br />
emendamento che chiedeva da un minimo<br />
di sei mesi a un massimo di tre anni dietro le<br />
sbarre per i giornalisti colpevoli di diffamazione.<br />
Certo, limava a sua volta le vigenti<br />
quanto desuete prescrizioni della legge sulla<br />
stampa datate 1948 che volevano la reclusione<br />
da uno a sei anni. Ma tanto era bastato<br />
per scatenare la bufera su Montecitorio e<br />
provocare le dimissioni del relatore che<br />
denunciava di non riconoscersi più nelle<br />
modifiche apportate. Così il testo, che aboliva<br />
inoltre la responsabilità del direttore per<br />
omesso controllo, è stato fagocitato dalla<br />
proposta unificata che vede come relatrice<br />
Isabella Bertolini (Fi) e che è stata presentata<br />
il 4 novembre.<br />
Cuore del provvedimento è la cancellazione<br />
del carcere per i giornalisti. Rimane il processo<br />
penale che sfocia, però, soltanto in una<br />
multa variabile dai 1.500 ai 7.500 euro. Con<br />
il minimo che può lievitare a 2.000 se si attribuisce<br />
a qualcuno un fatto determinato, ma<br />
scende di nuovo a 1.500 se è stata pubblicata<br />
la rettifica. A bilanciare la pena, però,<br />
arrivano la pubblicazione obbligatoria della<br />
sentenza di condanna e la trasmissione<br />
degli atti all’<strong>Ordine</strong> professionale “per la<br />
determinazione delle sanzioni disciplinari”.<br />
Più vaghe le previsioni in tema di rettifica: si<br />
affronta la disciplina per la stampa non periodica<br />
(i libri) e per l’edicola si stabilisce che<br />
“nella determinazione del danno (...) il giudice<br />
tiene conto della pubblicazione della rettifica,<br />
se richiesta dalla persona offesa”. Altra<br />
novità è il freno pigiato sulla corsa <strong>dei</strong> risarcimenti:<br />
“il danno patrimoniale non può eccedere<br />
la somma di 25mila euro”. E l’azione<br />
civile si prescrive in un anno dal giorno in cui<br />
il giornale è uscito con la notizia. Torna invece<br />
a fare capolino la responsabilità del direttore<br />
per omesso controllo, anche se per il<br />
timoniere della testata “la pena è in ogni<br />
caso ridotta di un terzo”. Per la diffamazione<br />
semplice “arrecata con il mezzo della stampa”,<br />
infine, la multa va da 500 a 2.500 euro<br />
triplicati se si offendono istituzioni politiche o<br />
giudiziarie. Suona ora, dunque, il tempo del<br />
dibattito. Come quello ospitato il 28 novembre<br />
in sala Montanelli al Circolo della Stampa<br />
che ha visto presenti il presidente<br />
dell’Odg lombardo Franco Abruzzo, gli<br />
onorevoli Michele Saponara e Giuliano Pisapia,<br />
più un parterre di avvocati composto da<br />
Caterina Malavenda, Corso Bovio e Luca<br />
Boneschi. Assente invece l’ex direttore del<br />
Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli.<br />
L’occasione è la presentazione dell’Asdi,<br />
associazione fra gli studiosi di diritto<br />
dell’informazione che nasce in sinergia con<br />
le università e aperta ai cittadini. Insieme agli<br />
obiettivi di organizzare corsi di aggiornamento<br />
sul diritto dell’informazione e attivare una<br />
banca dati on line capace di raccogliere tutte<br />
le norme del settore.<br />
Dibattito sulla proposta Bertolini al Circolo della Stampa<br />
Giuliano Pisapia,<br />
parlamentare Rifondazione Comunista<br />
“Posso definire questa proposta con la<br />
classica formula «la montagna ha partorito<br />
il topolino». Il nuovo testo ha provocato<br />
effetti non voluti. Troppo spesso si confonde<br />
la libertà di stampa con il diritto di diffamare.<br />
La diffamazione, invece, può avere<br />
conseguenze gravissime e spesso irreversibili.<br />
Tutti abbiamo letto di persone suicidatesi in<br />
seguito a notizie diffamatorie lontane dalla<br />
realtà. Su 89 casi giudiziari esaminati<br />
dall’<strong>Ordine</strong> lombardo <strong>dei</strong> giornalisti, infatti,<br />
di 65 si è riscontrato che manca la veridicità<br />
della notizia. Il tema della diffamazione<br />
a mezzo stampa è oggetto di discussione<br />
da almeno due legislature. Prima si era<br />
andati in aula con testo ampiamente condiviso,<br />
ma è stato rimandato in Commissione<br />
giustizia per valutare la costituzionalità<br />
o meno di un limite ai danni patrimoniali.<br />
C’era stata una ridiscussione, ma non una<br />
conclusione.<br />
Abbiamo avuto il testo Anedda, con<br />
l’emendamento Mormino che ha portato in<br />
primo piano la misura del carcere per i giornalisti.<br />
Io avevo chiesto la permanenza<br />
domiciliare domenicale al posto della reclusione.<br />
Dopo le polemiche, il governo aveva<br />
dichiarato di aver preso in mano la situazione<br />
e aveva annunciato un nuovo testo in<br />
15 giorni: è stato presentato dopo tre mesi.<br />
L’attuale proposta non è risolutiva, ma finalizzata<br />
soltanto a eliminare la detenzione e<br />
ad avvicinare, per così dire, i giornalisti<br />
all’attività di governo.<br />
L’esecutivo ha fatto presentare dalla relatrice<br />
Bertolini un testo davvero minimale. È<br />
giusto abolire il carcere per i reati con pene<br />
minime, ma serve allora una riforma organica<br />
che elimini la disparità di trattamento<br />
con altre violazioni. Il vilipendio alla bandiera,<br />
ad esempio, prevede la reclusione da<br />
uno a tre anni.<br />
E così via per tanti piccoli reati, anche di<br />
opinione. Altro punto, la rettifica: può essere<br />
causa di non punibilità (in sede penale),<br />
ma non per il risarcimento <strong>dei</strong> danni (come<br />
invece previsto dalla proposta Anedda)<br />
TROPPE<br />
“SPARATE”,<br />
POCO<br />
CONTROLLO<br />
perché la rettifica limita, ma non elimina il<br />
danno. Inoltre, non si può non permettere<br />
al giornalista di dimostrare la verità di ciò<br />
che viene scritto o affermato avviando la<br />
causa molti anni dopo il fatto contestato. In<br />
più, serve una tutela forte del segreto<br />
professionale. È impensabile intercettare<br />
un giornalista per sei/otto mesi con lo<br />
scopo di capirne le fonti. Bisogna infine<br />
trovare una soluzione per impedire che<br />
querele infondate intimidiscano il giornalista<br />
che fa correttamente il proprio dovere.<br />
L’emendamento Pisapia prevede che, se la<br />
querela è temeraria e tale sia riconosciuta<br />
dal giudice, sia punita con una sanzione<br />
obbligatoria”.<br />
Malavenda: “Questa legge non serve<br />
concretamente quasi a nulla. I giornalisti<br />
condannati al carcere sono pochissimi e<br />
risarcimenti troppo consistenti hanno<br />
conseguenze letali sui piccoli giornali”.<br />
Michele Saponara,<br />
senatore Forza Italia<br />
“Di diffamazione si è cominciato a parlare<br />
nel 2000. Oggi è protagonista un testo<br />
unificato che prende in considerazione ben<br />
otto proposte di legge. Si vuole conciliare<br />
la libertà di stampa e l’onorabilità del cittadino.<br />
E in questo caso è il Parlamento ad essere<br />
imputato, perché non riesce a conciliare<br />
queste due esigenze. Si dice che siano<br />
stati i giornalisti a fare pressioni sul Parlamento,<br />
siamo stati accusati di questo. La<br />
relatrice Bertolini? È stata nominata dopo<br />
che Anedda è divenuto capogruppo di An.<br />
Bisogna dire, come prima cosa, che tutti i<br />
proponenti prevedevano il reclusione per i<br />
giornalisti: molti hanno pensato ad una<br />
riduzione da sei a tre anni di carcere al<br />
massimo. Ebbene, l’emendamento aveva<br />
una sua ratio nel proporre proprio la reclusione,<br />
perché vi sono casi in cui la diffamazione<br />
è grave e rasenta la calunnia. Ora la<br />
proposta è stata unificata agli altri testi: non<br />
si parla più di carcere, ma solo di una pena<br />
pecuniaria che alcuni suggeriscono di<br />
accrescere. Viene modificato così anche il<br />
di Francesca Romanelli<br />
L’inchiesta, questa volta, l’ha fatta l’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti lombardo. E a finire sotto<br />
accusa sono stati i giornalisti. Esito delle indagini: la scoperta che il palazzaccio<br />
di Porta Vittoria condanna spesso i giornalisti per un motivo che da quotidiani<br />
celebrati e professionisti declamati non ci si aspetterebbe di certo: la falsità della<br />
notizia. Tutto questo succede, con orrore dell’<strong>Ordine</strong> professionale, addirittura<br />
in 65 casi su 89. La ricerca è stata condotta su tutte e 157 le sentenze emesse<br />
dal Tribunale civile negli anni 2001 e 2002. Ha rilevato una lieve prevalenza<br />
delle pronunce di accoglimento delle domande di risarcimento danni (56%)<br />
rispetto a quelle di rigetto (44%).<br />
E proprio fra le 89 sentenze che sanciscono di rifondere il danno provocato da<br />
un determinato articolo, ben 65 sono state spiccate per “il difetto di verità della<br />
notizia pubblicata”. Con un ulteriore “difetto di verità putativa” riscontrato in 7<br />
dispositivi, la violazione del criterio di criterio di continenza (che suggerisce di<br />
scrivere il fatto e non un romanzo) in 28 casi e la carenza dell’interesse pubblico<br />
in almeno 8 casi.<br />
La durata media del processo di primo grado? Più o meno tre anni e mezzo.<br />
Le pubblicazioni maggiormente interessate? I quotidiani nazionali (60%) e i<br />
settimanali (29%). Mentre la contabilità delle testate coinvolte parla del Corriere<br />
della Sera (21%), Il Giornale (17%) e Panorama (10%) sui primi tre gradini<br />
di questo improbabile podio. I diffamati sono soprattutto privati (25%) e magistrati<br />
(18%). Mentre i pezzi più a rischio sono quelli di cronaca (53%), seguiti<br />
dagli editoriali (31%) e dalle interviste (16%). L’inchiesta, autorizzata dal presidente<br />
del Tribunale Vittorio Cardaci e resa possibile dall’ufficio statistiche al<br />
terzo piano del Palazzo di Giustizia, precisa anche che i danni patrimoniali e<br />
morali ammontano in genere a 14.816,94 euro.<br />
Necessario dunque che i giornalisti di giudiziaria ripassino ogni volta l’insegnamento<br />
(nientemeno) che della Suprema Corte di Cassazione: possibile<br />
scrivere notizie diffamatorie purché vere, di interesse pubblico, scritte civilmente<br />
e, soprattutto, nella loro essenzialità.<br />
sospesi tra carcere e multe<br />
regime giuridico dell’ingiuria: anche per<br />
questa, solo una pena pecuniaria. Ma<br />
procediamo per punti. Un altro problema è<br />
la rettifica. Si oscilla dall’esclusione della<br />
punibilità nel caso venga pubblicata<br />
adeguatamente al ritenerla un’attenuante<br />
della pena. Altro passaggio importante è<br />
quello del risarcimento: per evitare richieste<br />
esose, è stato fissato un tetto massimo<br />
al risarcimento del danno. Una misura che<br />
è rimasta nel testo unificato. La proposta<br />
Bertolini è dunque un punto di partenza su<br />
cui lavorare. Un deterrente per i giornalisti,<br />
invece, potrebbe essere l’ipotesi di una<br />
sanzione disciplinare o l’interdizione<br />
temporanea dalla professione. La responsabilità<br />
del direttore infine è trattata nell’articolo<br />
57. E alcune proposte escludono la<br />
responsabilità oggettiva”.<br />
Malavenda: “Più si va avanti in questo<br />
dibattito, più mi convinco della bontà del<br />
sistema attuale in cui i giudici applicano la<br />
regola del buon senso. Questa legge<br />
sembra specificare cose che già ci sono. I<br />
giornalisti, o sono vittime o sono carnefici.<br />
E vittime sono quelli di piccoli giornali non<br />
coperti da assicurazione”.<br />
Giovanni Negri,<br />
giornalista “Il Sole24Ore”<br />
“Non si tratta di una legge inutile. Il tetto <strong>dei</strong><br />
25mila euro come limite massimo al risarcimento<br />
è adatto. I veri problemi sono altri<br />
e riguardano chi fa parte della nostra categoria.<br />
Sono comportamenti dai quali ognuno<br />
dovrebbe tenersi in guardia: fidarsi troppo<br />
delle agenzie, non controllare personalmente<br />
le notizie, le fonti e così via. Le<br />
sanzioni disciplinari? Devono restare. È<br />
necessario invece evitare l’attuale incongruenza<br />
di tempi fra le sanzioni penali,<br />
quelle civili e quelle professionali”.<br />
Malavenda: “ L’argomento più interessante<br />
di questa legge è la rettifica. Oggi è libera,<br />
non ci sono vincoli. E invece bisogna distinguerne<br />
tre tipi: quella che lamenta fatti falsi,<br />
quella che contesta fatti veri e quella che<br />
prende di mira commenti e opinioni”.<br />
Luca Boneschi,<br />
avvocato<br />
“Il limite <strong>dei</strong> 25mila euro è, realisticamente,<br />
la media <strong>dei</strong> risarcimenti che oggi vengono<br />
comminati dai nostri giudici. La nostra<br />
legge sulla stampa è un’ottima legge. E<br />
dobbiamo ricordare che fu approvata in<br />
sede di assemblea costituente proprio per<br />
la particolarità e la delicatezza di questa<br />
disciplina.<br />
Mette al centro di tutte le sue previsioni la<br />
dignità della persona. E con essa i diritti<br />
alla reputazione, all’immagine... Certo la<br />
pena detentiva originariamente prevista,<br />
oggi va al di là della coscienza sociale. La<br />
direttissima per i casi di diffamazione a<br />
mezzo stampa, che pure era prevista, ora<br />
non si fa più. Ma era importante per l’immediatezza<br />
del giudizio e della riparazione.<br />
Bisogna dire poi che il diritto di rettifica, e il<br />
suo valore, è stato vanificato dal modo di<br />
agire <strong>dei</strong> giornalisti. Perché le rettifiche<br />
vengono relegate a lettere al direttore e<br />
sminuite. Non sono mai state pubblicate<br />
secondo le previsioni di legge che impongono<br />
la presenza sulla stessa pagina del<br />
pezzo contestato, con lo stesso rilievo, lo<br />
stesso richiamo grafico, nel termine di due<br />
giorni.<br />
Per tutto il resto, basterebbe togliere la<br />
pena detentiva e lasciare quella pecuniaria.<br />
Ma manteniamo la solennità della costituente.<br />
Oggi, l’attuale schema prevede di<br />
punire la diffamazione con multe da 5 euro<br />
in su. Nella proposta Anedda, la richiesta<br />
di rettifica è condizione di procedibilità per<br />
il giudizio e il risarcimento del danno. E se<br />
non viene pubblicata? L’azione per il risarcimento<br />
si prescrive poi in un anno rispetto<br />
ai cinque sanciti dal codice civile. Diversa è<br />
la previsione del testo Bertolini; fa diventare<br />
la rettifica un’attenuante lasciando intatto<br />
l’articolo 8 della legge sulla stampa e<br />
introducendo un articolo 8 bis per disciplinare<br />
gli altri mezzi di informazione. La<br />
pena, come abbiamo detto, è variabile. E<br />
va da 5 euro in su. Veniamo poi al tema del<br />
danno: la proposta Bertolini è un miglioramento<br />
rispetto a quella di Anedda, ma<br />
pone tutta una serie di problemi. Perché se<br />
4 ORDINE 1 <strong>2004</strong>
viene concretamente riconosciuto il danno<br />
patrimoniale, dove vanno a finire invece il<br />
danno biologico e quello esistenziale? Io<br />
rafforzerei la disciplina della rettifica nel<br />
sistema attuale”.<br />
Malavenda: “Così come la proposta di<br />
legge è scritta, sembra solo che l’<strong>Ordine</strong><br />
debba scegliere quali misure applicare nei<br />
confronti del giornalista...”<br />
Francesco Abruzzo, presidente dell’<strong>Ordine</strong><br />
<strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia<br />
“Non mi sento di chiedere nulla al Parlamento.<br />
I giornalisti infatti non meritano<br />
nulla. Secondo uno studio che abbiamo<br />
appena condotto, e che ha preso in esame<br />
89 cause civili arrivate al Palazzo di Giustizia<br />
di Milano, ben 65 sentenze hanno<br />
sancito che le notizie pubblicate non erano<br />
vere. Per il resto, l’<strong>Ordine</strong> lombardo ha una<br />
propria linea consolidata nel tempo.<br />
Il rispetto della dignità della persona e quello<br />
della verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti sono <strong>dei</strong><br />
paletti insuperabili e frenano il diritto di<br />
cronaca. Che è un diritto <strong>dei</strong> cittadini (e non<br />
<strong>dei</strong> giornalisti) ad essere informati correttamente<br />
e completamente. Detto ciò questa<br />
legge Bertolini non mi convince. Non<br />
possiamo mettere limiti, per di più pecuniari,<br />
all’onore, la credibilità e l’identità delle<br />
persone.<br />
Per quanto riguarda la rettifica, la pubblicazione<br />
è un obbligo di legge. È un dovere<br />
professionale anche alla luce delle nuove<br />
normative sulla privacy. L’articolo 8 della<br />
legge sulla stampa prevede infatti non<br />
soltanto il diritto alla rettifica ma anche la<br />
possibilità che, se il direttore non ottemperi<br />
a questo obbligo, si possa andare da un<br />
giudice capace di ordinarne la pubblicazione.<br />
Oppure c’è, in concreto, l’opportunità di<br />
rivolgersi al presidente del consiglio regionale<br />
dell’<strong>Ordine</strong> per farla pubblicare. Quali<br />
sono, allora, le richieste dall’osservatorio<br />
del nostro ordine professionale? Prima di<br />
modificare una legge scaturita in sede<br />
costituente pensiamoci bene.<br />
Anche se è urgente uniformare i tempi del<br />
giudizio penale e civile, oggi diversi ed<br />
enormemente distanti. Altro punto è il<br />
segreto professionale: il Parlamento si deve<br />
adeguare alle prescrizioni della sentenza<br />
Goodwin.<br />
I magistrati italiani non hanno sufficiente<br />
cultura sui pronunciamenti del Tribunale di<br />
Strasburgo. Nel settore civile, bisogna rifarsi<br />
all’articolo 1227 del codice, con l’obbligo<br />
che chi lamenta un danno presunto chieda<br />
subito la rettifica. In pratica, l’obbligo di<br />
muoversi subito per limitare il danno. Ma<br />
poi, perché la Procura non informa l’<strong>Ordine</strong><br />
di tutti i procedimenti a carico <strong>dei</strong> suoi giornalisti?<br />
Non parlo solo di casi di diffamazione.<br />
Infine, il direttore ha un compito di vigilanza<br />
e deve finire sotto processo insieme<br />
al giornalista. Quante volte ricevo chiamate<br />
di colleghi in lacrime che mi raccontano di<br />
essere stati spinti dal direttore ad occuparsi<br />
di una determinata vicenda! Ultima cosa,<br />
bisogna ricordare tutti la normativa sulla<br />
privacy. La nuova legge dal 1° gennaio<br />
<strong>2004</strong>”.<br />
Malavenda: “Un aspetto importante ancora<br />
da dibattere è la scomparsa dell’udienza<br />
preliminare che comporta l’assegnazione<br />
del procedimento a giudici onorari invece<br />
che togati, con tutto quanto comporta in<br />
termini di esperienza quotidiana di giudizio”.<br />
Corso Bovio, avvocato<br />
“Abbiamo voglia di ripetere che la rettifica<br />
va pubblicata, che è un obbligo di legge,<br />
che serve a definire l’eventuale quanto<br />
successivo giudizio. Ma seguendo la scuola<br />
giornalistica di Mario Missiroli, e la mia<br />
vocazione che ha preceduto anche quella<br />
di avvocato, ritengo comunque la rettifica<br />
una notizia data due volte. I 25mila euro di<br />
risarcimento massimo mi preoccupano:<br />
oggi esiste anche il danno da vacanza rovinata.<br />
Di fronte alla sola pena pecuniaria, poi,<br />
viene a cadere il ricorso all’udienza preliminare<br />
e si passa al rinvio a giudizio diretto.<br />
Ma c’è un altro problema che finora è<br />
stato in secondo piano, pur essendo di<br />
primaria importanza. Una garanzia di obiettività<br />
nel giudizio che il giudice esprimeva<br />
sul giornalista era la collegialità della corte.<br />
Che oggi è invece monocratica. La collegialità<br />
compensava le passioni (sempre<br />
forti in campo giornalistico) sia per i temi<br />
trattati dai giornalisti sia per le richieste di<br />
risarcimento esose. È necessaria poi la<br />
tempestività del giudizio, proprio per lo<br />
stesso fine, come prevedono le norme<br />
processuali sulla tempestività del processo.<br />
Utile, infine, ripristinare la funzione di<br />
conciliazione del pubblico ministero. Stabilita<br />
nel nuovo codice di procedura penale<br />
dell’89 e mai applicata”.<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
DAL GARANTE DELLA PRIVACY<br />
Divieto di diffusione<br />
delle foto segnaletiche<br />
<strong>dei</strong> protagonisti del giro romano<br />
di “coca e prostituzione”<br />
Roma, 27 novembre 2003. Per il “caso coca e prostituzione” di<br />
Roma, il Garante della privacy ha emesso “verdetto” di divieto alla<br />
diffusione da parte degli organi di polizia delle foto segnaletiche delle<br />
persone indagate ed ha anche sottolineato che gli “sgarri” costituiscono<br />
reato. La decisione è stato resa nota ieri al termine di una<br />
riunione del collegio del Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello,<br />
Gaetano Rasi e Mauro Paissan) indetta - come è affermato in<br />
un comunicato - “nel quadro del procedimento instaurato<br />
Il 21 novembre scorso in relazione all’indagine penale<br />
su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma”.<br />
L’Autorità del Garante ha anche annunciato che, chieste<br />
informazioni sugli uffici di polizia interessati alla<br />
vicenda, ha segnalato al capo della polizia “ la diffusione<br />
illecita registratasi nei giorni scorsi per quanto<br />
di competenza in relazione alle violazioni di ordine<br />
disciplinare”.<br />
Per quanto riguarda la pubblicazione di foto segnaletiche da parte di<br />
giornali e telegiornali, il Garante - sempre da quanto è stato reso noto<br />
nel comunicato - “definirà nel più breve tempo possibile il procedimento<br />
anche in riferimento agli altri profili della vicenda in esame,<br />
distinguendo le legittime attività di cronaca su fatti, nomi e notizie<br />
relative a persone coinvolte conformi alla disciplina vigente (compreso<br />
il codice di deontologia per l’attività giornalistica), dall’eventuale<br />
indebita diffusione di dettagli relativi al contenuto di conversazioni<br />
telefoniche, di estremi identificativi di utenze telefoniche e di altri dati<br />
personali raccolti o diffusi illecitamente”.<br />
di Giancarlo Salemi<br />
In sostanza si dovrebbero profilare severi provvedimenti sia per chi<br />
ha passato foto e documenti ai giornali, sia per chi li ha poi pubblicati.<br />
Sull’argomento “ foto segnaletiche” il Garante è sempre stato<br />
fermamente chiaro nell’affermare il divieto di diffonderle e pubblicarle<br />
salvo quando “ricorrono - parole sue - fini di giustizia e di polizia o<br />
motivi di interesse pubblico”.<br />
Su queste “eccezioni” moltissimi colleghi hanno però sempre auspi-<br />
cato maggiore chiarezza interpretativa in modo da alleggerire<br />
le gravi difficoltà nelle quali si va ad imbattere chi,<br />
pressato dalla tempestività imposta dai meccanismi<br />
dell’informazione, si trova chiamato ad assumersi in<br />
prima persona, senza i tempi tecnici per pareri preventivi<br />
dell’Autorità Garante, la responsabilità di decidere<br />
cosa far prevalere tra la tutela del diritto <strong>dei</strong> cittadini alla<br />
protezione <strong>dei</strong> propri “dati personali” e l’esercizio del<br />
dovere di dare agli stessi cittadini un’informazione il più<br />
possibile completa, anche in nome di quei “motivi di interesse pubblico”<br />
che lo stesso Garante prevede come deroga al divieto.<br />
Un clima di incertezze che era stato fatto rilevare anche dall’<strong>Ordine</strong><br />
nazionale <strong>dei</strong> giornalisti che, proprio il 13 novembre scorso in occasione<br />
di un incontro di verifica sul Codice deontologico, aveva chiesto<br />
al Garante maggiore chiarezza interpretativa delle norme, ottenendo<br />
la costituzione di un gruppo di studio congiunto che “avrà il compito -<br />
com’era stato poi annunciato - di elaborare testi e documenti utili per<br />
dare un concreto contributo al lavoro di chi opera nel mondo dell’informazione”.<br />
I principali sono Al Maghrebya, Espresso Latino, Gazeta Romanesca e Cina<br />
Immigrati: 33 giornali<br />
per 250mila copie diffuse<br />
Gli immigrati regolari in Italia all’inizio del 2003 sono 2 milioni e<br />
400mila, 800mila in più rispetto allo scorso anno. Rappresentano il<br />
5% della popolazione italiana e attorno a loro si è acceso recentemente<br />
un dibattito sulla necessità di concedere o meno il voto per le<br />
elezioni amministrative.<br />
Un nuovo bacino elettorale, ma non solo. Anche al mondo della<br />
comunicazione fanno gola questi lettori. Dove leggono gli extracomunitari<br />
le informazioni sui paesi d’origine? Quali sono le loro fonti per<br />
tenersi aggiornati? Ilte.net è in grado di ricostruire per la prima volta<br />
la mappatura <strong>dei</strong> giornali che parlano straniero in Italia, grazie al<br />
primo rapporto redatto dall’Osservatorio media etnici. In tutto la stampa<br />
extracomunitaria conta sul nostro territorio 33 testate pubblicate<br />
da 22 editori, 24 delle quali redatte in lingua straniera. Un business di<br />
oltre 250mila copie, per un fatturato che supera i 700mila euro, che<br />
vede in testa i fogli cinesi con 4 pubblicazioni regolari, seguiti dai<br />
sudamericani e dagli arabi con 3, mentre gli africani hanno dalla loro<br />
diverse piccole e micro testate.<br />
In particolare sono 4 i giornali più forti e diffusi sul territorio entrambi<br />
con 20mila copie di tiratura: Al Maghrebya, mensile arabo rivolto alla<br />
comunità magrebina (Marocco, Algeria, Tunisia) che conta in Italia<br />
300mila persone; Espresso Latino, che ha una redazione di giornalisti<br />
professionisti latinoamericani accreditati dal ministero degli Este-<br />
Giacinto Sarubbi<br />
guida la componente<br />
fiscale dello<br />
“Studio Legale Tributario<br />
in association<br />
with Ernst & Young”<br />
Lo Studio Legale Tributario, in association with Ernst & Young<br />
è attivo in Italia mediante una rete di oltre 700 professionisti.<br />
Opera in stretta collaborazione con colleghi del network internazionale<br />
ed è in grado di offrire servizi di consulenza mirati<br />
su specifiche problematiche internazionali anche grazie all’Italian<br />
Desk presente a New York e ai diversi Foreign Desk<br />
presenti in Italia specializzati sulla normativa fiscale di Usa,<br />
Francia, Paesi Bassi, Giappone e Germania.<br />
Sottolineato<br />
anche<br />
che gli “sgarri”<br />
costituiscono<br />
reato<br />
ri; Gazeta Romanesca, fondato 3 anni fa, bisettimanale scritto anche<br />
in italiano e rivolto ai 400mila immigrati rumeni e, infine, il settimanale<br />
Cina, scritto in cinese che vende quasi 10mila copie tra Milano e<br />
Roma.<br />
Ma non basta: negli ultimi 5 anni anche gli altri mezzi di comunicazione<br />
hanno preso piede, come le radio. Attualmente se ne contano 35,<br />
di cui 2 nazionali e 33 regionali. Le lingue più in onda sono lo spagnolo<br />
(20 programmi) e il francese (13). Tra gli argomenti, guidano la<br />
classifica musica e news (15 programmi ciascuno), seguono i<br />
programmi culturali e quelli che trattano di immigrazione e legge.<br />
Per quanto riguarda la tv le emittenti etniche sono dieci, di cui due<br />
nazionali, 7 regionali e una satellitare, mentre su internet il sito ufficiale<br />
è www.stranierinitalia.it. E a non prendere sottogamba la forza <strong>dei</strong><br />
media in lingua straniera pubblicati in Italia è il presidente della Stampa<br />
estera, Eric Jozsef, che spiega come lo statuto della sua Associazione<br />
(presente in Italia dal 1912) sia “rigido” e permetta l’iscrizione solamente<br />
ai giornalisti che “lavorano in Italia per testate edite all’estero”. Lancia<br />
anche una proposta concreta: “Questi media - dice - sono comunque<br />
un realtà che va incoraggiata, per questo spero possano presto<br />
raggrupparsi in un unico ente o associazione per poter stringere <strong>dei</strong><br />
rapporti di collaborazione con la nostra associazione”. Sulla stessa<br />
lunghezza d’onda anche Vittorio Roidi, segretario dell’<strong>Ordine</strong> nazionale<br />
<strong>dei</strong> giornalisti: “Disponibilità a parlare, a costituire un tavolo per confrontarsi,<br />
capire, aiutare quanto possibile l’integrazione di questi giornali<br />
nel panorama informativo italiano”. (da www.ilte.net)<br />
Giacinto Sarubbi, giornalista pubblicista e revisore <strong>dei</strong> conti dell’<strong>Ordine</strong><br />
<strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia, chiamato di recente alla guida della<br />
componente fiscale dello Studio Legale e Tributario, in association with<br />
Ernst & Young, ha il compito di realizzare gli obiettivi strategici del tax in<br />
Italia.<br />
Una rinnovata attenzione sarà data alla qualità come elemento cardine di<br />
differenziazione. L’obiettivo principale è quello di creare uno studio sempre<br />
più in grado di attrarre i talenti migliori e di generare, conseguentemente,<br />
vantaggi concreti ai clienti. Da un punto di vista strutturale, la nuova strategia<br />
mira a razionalizzare e riorganizzare lo studio, concentrandosi sulle<br />
principali città ed in particolare su Milano e Roma. Proprio in quest’ottica,<br />
la sede di Milano vedrà a breve l’ingresso di un professionista di spicco<br />
quale il dott. Ezio Maria Simonelli in qualità di partner dello studio.<br />
È stato rafforzato il Centro Studi, in cui oggi operano professionisti di riconosciuto<br />
valore, tra gli altri, i proff. Raffaello Lupi, Ivo Caraccioli, Francesco<br />
Crovato e Dario Stevanato. Il coordinamento del Centro Studi, così come<br />
di tutte le iniziative che si rivolgono allo sviluppo del mercato, al consolidamento<br />
della leadership professionale e di pensiero, alla creazione di qualità<br />
e di valore per i clienti sono affidate a Massimo Giaconia, presidente dello<br />
Studio.<br />
Specializzazione e capacità di individuare le soluzioni più appropriate continueranno<br />
ad essere garantite da una consolidata organizzazione per dipartimenti:<br />
Transaction Tax, Int’l Tax Services (Its), Corporate Tax, Global Tax<br />
Operate, Iva e Imposte Indirette, Contenzioso, Human Capital, Gfs - Global<br />
Financial Services, Corporate Services.<br />
5
TESI DI LAUREA<br />
Pubblichiamo la sintesi della tesi<br />
di laurea di Ottavia Eletta Molteni,<br />
dal titolo “Michael Schumacher,<br />
un mito tedesco. Ferrari, una leggenda<br />
italiana”, che ha partecipato al Premio<br />
tesi di laurea dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti<br />
della Lombardia, edizione 2002<br />
Ottavia Eletta Molteni si è laureata<br />
in Lingue e Letterature straniere,<br />
indirizzo linguistico-glottodidattico,<br />
specializzazione in Scienze<br />
dell’informazione e delle comunicazioni<br />
all’Università Cattolica del Sacro Cuore<br />
di Milano. Relatore professoressa Anna<br />
Lisa Carlotti, correlatore professor<br />
Giorgio Simonelli<br />
di Ottavia Eletta Molteni<br />
Consegnato definitivamente alla leggenda dopo le vicende<br />
che hanno interessato la coda del campionato 2003, Michael<br />
Schumacher ha mostrato di saper correre con la testa, al<br />
pari di un cuore, che batte al ritmo di “cavalli” rombanti.<br />
Campione impulsivo, talvolta irruente sino all’eccesso, il tedesco<br />
è parso sacrificare la propria incrollabile volontà di vittoria<br />
a favore di una tattica di gara più ponderata. Piazzamenti<br />
talora di natura modesta hanno scandito la rincorsa mondiale<br />
dell’alfiere di Maranello. Frammenti di agonismo, vissuti<br />
condividendo gioie e dolori con gli uomini in Rosso. Più che<br />
un team, una seconda famiglia.<br />
Il connubio fra la scuderia emiliana ed il corridore di Kerpen<br />
è apparso terreno ideale sul quale costruire un raffronto fra<br />
stampa italiana e tedesca, approfondendo la ricaduta, a<br />
termini culturali, di un evento che travalica l’ambito agonistico,<br />
per elevarsi quasi a paradigma di una rinnovata fraternità<br />
democratica fra Italia e Germania.<br />
Ci siamo avvalsi, quali fonti primarie, del Corriere della Sera,<br />
quotidiano milanese; e della Frankfurter Allgemeine Zeitung,<br />
testata edita a Francoforte.<br />
L’arco cronologico prescelto riguarda il<br />
quinquennio 1996-2000: si è inteso<br />
coprire, in questo modo, il periodo che<br />
prende avvio con l’arrivo di Michael<br />
Schumacher sotto i colori di Maranello,<br />
sino a giungere alla conquista, da<br />
parte del tedesco, del mondiale piloti.<br />
L’assunto di base mira a dimostrare<br />
come i diversi “ciottoli”, che hanno<br />
lastricato il “percorso iridato” del corridore,<br />
abbiano contribuito a segnare<br />
un’evoluzione, nella resa a mezzo<br />
stampa, del personaggio in esame. La<br />
strada segnata conosce idealmente il<br />
proprio punto d’arrivo con le lacrime<br />
versate dal fuoriclasse nella sala stampa<br />
del circuito di Monza: in quell’occasione<br />
Schumacher ha rivelato la<br />
propria natura di uomo, non più di<br />
“macchina”, segnando ad un tempo la<br />
morte del “pilota bionico”, grottesco<br />
stereotipo con il quale il campione di<br />
Kerpen si è trovato a dover convivere nel corso <strong>dei</strong> primi anni<br />
a Maranello.<br />
Può essere identificata, più precisamente, la sequenza di<br />
due fasi successive: nella prima il Pilota offusca l’Uomo,<br />
quasi ad inibire l’espressione di sentimenti ed emozioni, pur<br />
naturali; nella seconda l’Uomo riconquista pari dignità,<br />
concedendosi anche ad un pianto liberatorio.<br />
Nella lettura sequenziale <strong>dei</strong> quotidiani volevamo ritrovare,<br />
se possibile, un’evoluzione significativa ad un doppio livello.<br />
Nel Corriere della Sera, dall’iniziale inerenza al “mito-Ferrari”,<br />
sino all’appropriazione totale della “leggenda-Schumacher”;<br />
nella Frankfurter Allgemeine, dall’iniziale solidarietà<br />
con la “leggenda-Schumacher”, alla crescente complicità con<br />
il “mito-Ferrari”. L’analisi proposta ha inteso verificare, inoltre,<br />
in quale misura “l’appartenenza etnica” abbia influito nella<br />
descrizione degli eventi. Quest’ultimo elemento è stato interpretato<br />
secondo una duplice prospettiva: da un lato analizzando<br />
i particolari artifici narrativi applicati alle realtà “di casa”<br />
(macchina italiana-giornale italiano; pilota tedesco-giornale<br />
tedesco); dall’altro adottando, invece, un criterio incrociato,<br />
teso a rimarcare l’incidenza di evidenti diversità storico-culturali<br />
a livello di “modus narrandi” (monoposto italiana-quotidiano<br />
tedesco, e viceversa).<br />
L’approccio da noi recato alle testate ha poggiato su una<br />
premessa teorica: la natura circolare del rapporto che lega<br />
Michael Schumacher agli organi di informazione.<br />
Si è voluto dimostrare come i quotidiani di cui all’oggetto<br />
siano stati influenzati ed abbiano influenzato ad un tempo il<br />
comportamento del fuoriclasse germanico: possiamo affermare<br />
che il campione di Kerpen si è trovato a vivere una<br />
doppia evoluzione, personale e massmediatica, strettamente<br />
correlate l’una all’altra.<br />
Michael<br />
Schumacher,<br />
un mito<br />
tedesco<br />
Schumi sposa la Rossa<br />
ma è… unione d’interesse<br />
La Ferrari inizia a riflettere sul pilota da<br />
ingaggiare per il campionato successivo<br />
nella tarda primavera del 1995.<br />
Jean Todt, direttore sportivo della Scuderia,<br />
propone il nome di Michael Schumacher, in<br />
quel momento la migliore guida del Circus.<br />
Il suggerimento viene accolto in pieno e si<br />
dà così avvio alle trattative, propiziate dal<br />
fatto che il tedesco avverte di essere al<br />
termine di un ciclo della sua vita (con la<br />
Benetton ha ormai vinto due titoli mondiali<br />
consecutivi) e si sente attratto dalla sfida di<br />
riconfermarsi “numero uno” dopo essere<br />
ripartito da zero. Schumacher viene ingaggiato<br />
ufficialmente dalla Ferrari in occasione<br />
del Gran Premio d’Ungheria. Nel contratto<br />
del pilota, l’impegno a correre per il team<br />
del Cavallino Rampante nella stagione<br />
1996.<br />
Così Schumi ha sposato la Rossa: il Corriere<br />
della Sera descrive in questi termini,<br />
facendo ricorso ad una metafora matrimoniale,<br />
l’ingaggio ufficiale di Michael Schumacher.<br />
L’immagine presentata acquista<br />
nuova forza dalla scelta (felice ed efficace)<br />
di sostituire il nome della scuderia, Ferrari,<br />
con l’aggettivo sostantivato “Rossa”<br />
(evidente l’allusione al colore delle monoposto<br />
di Maranello): il termine appare, infatti,<br />
facilmente riconducibile anche ad una<br />
figura di sesso femminile, una sposa dalla<br />
capigliatura fulva. L’accostamento scuderiadonna<br />
viene sostenuto anche nel corso<br />
dell’articolo. Nestore Morosini afferma che<br />
Schumacher abbia ceduto alla Ferrari,<br />
colpito da “occhiate seducenti”.<br />
La preferenza accordata al team di Maranello<br />
ha “spezzato il cuore” delle altre “pretendenti”,<br />
anche se sono già in molti a sostenere<br />
che si tratti di un’unione d’”interesse” più<br />
che d’amore.<br />
Ferrari überzeugt mit Geld, Mythos und<br />
Herausforderung (“La Ferrari convince con<br />
soldi, mito e sfida”): dopo il quotidiano milanese,<br />
anche la Frankfurter Allgemeine si<br />
sofferma a riflettere sui motivi che hanno<br />
potuto spingere il tedesco a scegliere la<br />
scuderia del Cavallino Rampante. Un primo<br />
suggerimento: il pilota potrebbe essersi<br />
sentito attratto da ciò che la Ferrari rappresenta.<br />
Il motivo reale è, però, un altro: determinante,<br />
l’offerta economica. Il ventaglio <strong>dei</strong> possibili<br />
motivi alla base della scelta di Schumacher<br />
si completa con l’allusione ad un’altra<br />
tematica. Il campione di Kerpen ammette di<br />
sentirsi stimolato dalla sfida che l’attende.<br />
È in occasione della conquista della seconda<br />
iride che la dimensione più squisitamente<br />
umana del pilota inizia a lasciarsi intravedere.<br />
Il tedesco, in genere freddo e composto,<br />
si abbandona alle più tipiche manifestazioni<br />
di gioia. “Prima di questo secondo alloro,<br />
Schumacher era considerato un pilota di<br />
ghiaccio, un uomo alieno dalle simpatie<br />
personali e scarno nel rapporto con i<br />
meccanici.<br />
Per questo qualcuno aveva profetizzato che<br />
alla Ferrari, in mezzo a gente latina, quindi<br />
espansiva, si sarebbe trovato in difficoltà”<br />
(Cds, 23/10/1995).<br />
Fuoriclasse dal carattere<br />
freddo e impenetrabile<br />
Dopo i primi test, la F310 evidenzia grandi<br />
problemi di tenuta. Limiti che si evidenziano<br />
in occasione della prima gara iridata targata<br />
1996, il Gran Premio d’Australia. Schumacher<br />
è costretto al ritiro per un guasto all’impianto<br />
<strong>dei</strong> freni dopo trentatré giri. Seguono<br />
due corse durante le quali si alternano<br />
speranze e frustrazioni. In Brasile, il pilota<br />
tedesco sale per la prima volta sul podio<br />
(terzo posto), ma è staccato di un giro. In<br />
Argentina, parte in prima fila, ma si ritira per<br />
la rottura dell’alettone posteriore.<br />
L’impresa di Michael Schumacher sul circuito<br />
di Buenos Aires genera sulle pagine del<br />
Corriere della Sera un clima da Cuore e<br />
batticuore. “Sarà in pista Michael Schumacher,<br />
campione del mondo in carica, tedesco<br />
di nascita, già italiano d’adozione dopo il suo<br />
passaggio alla Ferrari, finalmente protagonista<br />
con la Rossa” (Cds, 7/4/1996). Si tratta<br />
della prima volta in cui si evidenzia un aperto<br />
senso di appropriazione nei confronti del<br />
campione; all’ammirazione subentra un vero<br />
e proprio coinvolgimento emotivo. Sottolinea<br />
il momento importante vissuto dal pilota<br />
anche la scelta del corredo iconografico.<br />
Dopo un mese, il quotidiano di via Solferino<br />
ci presenta una bella foto del fuoriclasse<br />
(Schumacher è ritratto mentre si trova all’interno<br />
della sua Rossa). In precedenza, era<br />
stato concesso spazio, in prevalenza, ai<br />
protagonisti in corsa.<br />
A Imola, la prima pole position stagionale<br />
viene vanificata da un problema alla frizione<br />
che rallenta il tedesco in partenza. La corsa<br />
si risolve, tuttavia, in modo positivo per la<br />
Ferrari (secondo posto). Il Corriere della Sera<br />
si sofferma a rimarcare con insistenza un lato<br />
della personalità di Michael Schumacher,<br />
peraltro di per sé noto agli appassionati del<br />
settore: perfetto in pista, viene descritto come<br />
freddo ed impenetrabile nei rapporti umani.<br />
La peculiarità caratteriale del fuoriclasse è<br />
posta dapprima in evidenza al termine delle<br />
prove di qualificazione. “Schiumata la prima<br />
legittima euforia, Schumi (abbreviazione<br />
dolciastra e tuttavia efficace) aveva, come<br />
sempre, l’atteggiamento di un alto funzionario<br />
della Deutsche Bank”. (Cds, 5/5/1996).<br />
Identico clima anche nel dopo gara. Il<br />
campione di Kerpen ha appena conquistato il<br />
secondo posto; nonostante questo il suo volto<br />
non tradisce alcuna emozione particolare.<br />
“Lui, il signore in rosso, si apprestava ad<br />
affrontare i giornalisti, in sala stampa, con<br />
l’aspetto più normale possibile: pareva che<br />
per lui, composto e pallidino, glaciale come<br />
sempre, la corsa dovesse ancora cominciare.<br />
[...] Mentre Schumi parlava, i televisori<br />
ripetevano al rallentatore la partenza del<br />
Gran Premio e le sue fasi salienti. Lui si<br />
riguardava senza tradire la minima emozione:<br />
gelido, alunno e insieme professore di se<br />
stesso” (Cds, 6/5/1996).<br />
A Montecarlo, la gara del tedesco non dura<br />
neanche trenta secondi (sbatte alla prima<br />
curva, quella del Portier). “Ieri ci aspettavamo,<br />
nella Ferrareide annunciata dalle qualificazioni,<br />
il do di petto di Schumacher. Poveri<br />
noi, come dice Lauda “anche Michael è un<br />
uomo” (Cds, 20/5/1996).<br />
6 ORDINE 1 <strong>2004</strong>
Ferrari,<br />
una<br />
leggenda<br />
italiana<br />
I segni del “disgelo”<br />
dopo un anno in Italia<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
Nel Gran Premio di Spagna, la prima guida<br />
di Maranello conquista la prima vittoria al<br />
volante della Ferrari. Viene recuperata la<br />
metafora con cui si era aperta l’avventura di<br />
Michael Schumacher in terra emiliana. “Ed<br />
eccolo arrivato, finalmente, il giorno del vero<br />
matrimonio fra Schumacher e la Ferrari. Un<br />
giorno bagnato e quindi, come dice il proverbio<br />
un po’ adattato, fortunato. Un giorno<br />
cominciato male e finito talmente bene da<br />
poter affermare che la Formula 1 ha un<br />
nuovo mago della pioggia che mette insieme<br />
tutte le qualità di Ayrton Senna” (Cds,<br />
3/6/1996).<br />
Dopo il trionfo sul circuito spagnolo, l’asso di<br />
Kerpen si trova a passare quasi tre mesi da<br />
incubo. A Spa e Monza, quindi, arrivano due<br />
strepitose vittorie.<br />
Il Gran Premio del Belgio vale a restituirci un<br />
Michael Schumacher inedito. Sul podio di<br />
Spa il tedesco, che sino a quel momento<br />
aveva cercato di celare le proprie emozioni<br />
più semplici ed immediate, abbraccia Jean<br />
Todt e lo alza di peso. Possiamo leggere nel<br />
fuoriclasse i primissimi segni di “disgelo”,<br />
complice quasi un anno di sole italiano.<br />
Anche il circuito brianzolo assiste ad esternazioni<br />
che non sembrava appartenessero<br />
alla sensibilità del due-volte campione del<br />
mondo. Schumacher racconta ai giornalisti<br />
di aver provato un’emozione fortissima. In<br />
piedi, sul gradino più alto del podio, ha capito<br />
finalmente che cosa rappresentasse la<br />
scuderia Ferrari nel panorama italiano e gli è<br />
venuta la pelle d’oca. “Da ieri il tedesco<br />
Schumacher è uno di noi; probabilmente<br />
anche lui ha scoperto quale forza, quale<br />
calore sappia ancora dare questo Paese se<br />
ha qualcosa in cui credere. Da quanto ha<br />
detto e da come l’ha detto, sembrava intenerito<br />
come un italiano, come un ferrarista da<br />
generazioni” (Cds, 9/9/1996).<br />
Campione ma anche<br />
padre di famiglia<br />
Le prime battute del campionato 1997<br />
segnano un importante cambiamento per<br />
quanto attiene la definizione, a termini<br />
mediatici, di Michael Schumacher. Il pilota,<br />
divenuto padre per la prima volta, il 20<br />
febbraio, della piccola Gina Maria, confessa<br />
di volere costruire il futuro primariamente<br />
intorno alla sua famiglia. “Se il giovane<br />
Michael, con la nascita di Gina Maria è<br />
cambiato ed è diventato uomo e padre, il<br />
professionista rimane sempre lo stesso.<br />
Rifiuta di commentare di nuovo l’incidente in<br />
cui morì Senna, non se la sente ancora di<br />
giudicare la battaglia fra Villeneuve e Frentzen<br />
alla Williams” (Cds, 28/3/1997).<br />
In Francia la Ferrari domina dal primo all’ultimo<br />
giro. Si fa largo l’idea che, in virtù <strong>dei</strong><br />
risultati conseguiti, Michael Schumacher<br />
possa aspirare alla conquista del terzo titolo<br />
mondiale. Il tedesco sembra, però, non volersi<br />
abbandonare del tutto a questa prospettiva.<br />
“Lui, questo degno epigono di Prost e di<br />
Senna, non lo ammetterà mai. Perché sotto i<br />
sorrisi che sempre dispensa dopo la vittoria,<br />
seguita a coltivare teutoniche freddezze, un<br />
senso istintivo e anche imparato del calcolo<br />
da consumarsi nell’assoluto privato” (Cds,<br />
30/6/1997).<br />
Sul tracciato di Silverstone, Carlo Grandini ci<br />
restituisce il campione di Kerpen in versione<br />
sala stampa. Dalle annotazioni del giornalista<br />
emerge un tratto di freddezza, evocata<br />
dalle espressioni “aria di distacco concepita<br />
in laboratorio”, “immutabilità caratteriale”,<br />
“equilibri di esposizione”. Siamo portati ad<br />
affermare che, a distanza di due anni dal suo<br />
arrivo a Maranello, il tedesco sia stato solo<br />
sfiorato dalla grande capacità di gioire e di<br />
piangere del “popolo Ferrari”. La proiezione<br />
di sé che si è faticosamente costruito nel<br />
corso della sua carriera si rivela ancora troppo<br />
forte.<br />
Più rispetto che amore<br />
da parte <strong>dei</strong> tifosi<br />
La Frankfurter Allgemeine propone una riflessione.<br />
Michael Schumacher è veramente<br />
amato dai tifosi della Ferrari? La prima parte<br />
del titolo recita Die Fans bewundern den<br />
‘Schumi-Ferrari’ (“I tifosi ammirano ‘Schumi-<br />
Ferrari’). Schumacher wird mehr geachtet als<br />
geliebt (“Schumacher è più rispettato che<br />
amato”). Il concetto si chiarisce nel corso del<br />
pezzo e ci restituisce l’idea di un pilota, osannato<br />
solo per i risultati che ha saputo conquistare<br />
alla Rossa. “Dietro a questo misto di<br />
uomo e macchina c’è meno un amore ardente<br />
per Schumacher, quanto il rispetto di fronte<br />
al due-volte campione del mondo. Schumacher<br />
non è un tipo impulsivo come Jean<br />
Alesi, non è uno che, dopo un errore, salta<br />
giù dalla macchina e lascia libero sfogo alla<br />
sua rabbia con un calcio contro la sua monoposto,<br />
non è uno che per la delusione piange<br />
pubblicamente” (Faz, 6/9/1997). Traspare<br />
quasi un senso di rimprovero nei confronti del<br />
popolo italiano, che non sembra in grado di<br />
affezionarsi sinceramente al campione di<br />
Kerpen a causa di una differenza culturale. Si<br />
legge ancora: “Il comportamento sempre<br />
disciplinato, le sue decisioni tattiche nel giro<br />
di pochi secondi, l’equilibrio con il quale ripete,<br />
giro dopo giro, i tempi richiesti fino al decimo<br />
di secondo, gli hanno procurato l’appellativo<br />
di “Computer”. […] Gli sfoghi sentimentali<br />
[…] colgono il pilota della Ferrari più facilmente<br />
nel silenzio. O rimangono inosservati”<br />
(ibidem).<br />
L’ultima prova iridata, a Jerez, consegna il<br />
titolo piloti a Jacques Villeneuve. Il canadese<br />
vince la corsa, dopo essere rimasto vittima,<br />
nel corso del quarantottesimo giro, di uno<br />
scontro con Michael Schumacher. L’episodio,<br />
lungamente riproposto dalle televisioni di<br />
mezzo mondo, vede il tedesco chiudere la<br />
traiettoria al diretto avversario in occasione<br />
di un tentativo di sorpasso in curva. I giorni<br />
che seguono la gara segnano una delle pagine<br />
più nere nella storia professionale ed<br />
umana di Michael Schumacher. Perso il terzo<br />
titolo iridato sul filo di lana, il pilota si trova ad<br />
affrontare critiche che giungono da ogni<br />
dove. “Ho commesso un errore, lo ammetto<br />
in tutta onestà. In seguito a questo sbaglio<br />
Jacques è diventato campione del mondo e<br />
io, perdendo, ho mostrato una dimensione<br />
umana. Sono uno che non commette molti<br />
errori quando guida una monoposto, però<br />
quello di Jerez è stato molto grosso” (Cds,<br />
29/10/1997). Interessante la sottolineatura<br />
“ho mostrato una dimensione umana”.<br />
Traspare, ancora una volta, un attacco velato<br />
nei confronti di un tipo di sensibilità, quella<br />
italiana, che ha sempre lasciato intendere, in<br />
modo concreto e preciso, la propria presa di<br />
distanza nei confronti di un atleta, avvertito<br />
come freddo e impenetrabile (elemento<br />
emerso d’altronde anche nel corso dell’analisi<br />
del quotidiano tedesco). Anno Hecker, in<br />
uno “schizzo” veloce del campione di<br />
Kerpen, definisce il campione Der Kontrolleur<br />
der Rennleidenschaft (“Il controllore<br />
della passione per le corse”). “Tutte le volte<br />
che Michael Schumacher viene interrogato<br />
riguardo ad una situazione inebriante in<br />
corsa, assume un atteggiamento distaccato.<br />
Come se temesse il potere del dolore e <strong>dei</strong><br />
sentimenti. (…) lo affascina il tentativo di<br />
controllare tutto sino nel dettaglio: se stesso,<br />
la monoposto, il team, ogni situazione in<br />
corsa. Domenica è naufragato in una situazione<br />
che non dominava. L’immagine, spesso<br />
utilizzata, del tipo gelido, del “Computer”<br />
Schumacher, è da collegarsi ad un periodo,<br />
quando l’allora ventottenne pilota cercava di<br />
nascondere in pubblico ogni sentimento”<br />
(Faz, 27/10/1997).<br />
Contratto prorogato<br />
a suon di miliardi<br />
La prima affermazione della Ferrari nel 1998<br />
arriva in Argentina, sul tracciato di Buenos<br />
Aires. Michael Schumacher, che già in qualifica<br />
è riuscito ad inserirsi tra le Mc-Laren<br />
Mercedes (suo il secondo posto sulla griglia),<br />
conquista il successo dopo aver superato<br />
prima Hakkinen e poi il leader della corsa,<br />
David Coulthard.<br />
Il “sogno Ferrari” prosegue lungo l’asse<br />
Canada-Francia-Inghilterra. Una tripletta<br />
miracolosa che consente al pilota di portarsi<br />
a ridosso di un Mika Hakkinen, sino a quel<br />
momento imprendibile.<br />
Si discute di questioni contrattuali. Il “rapporto<br />
di collaborazione” tra la Ferrari e Michael<br />
Schumacher, destinato a durare sino a tutto<br />
il 1999, viene prolungato ulteriormente di tre<br />
anni. L’annuncio, riportato in contemporanea<br />
da entrambe le testate analizzate, vale a tratteggiare<br />
un retroscena mai affermato con<br />
tanta chiarezza. Il “ritratto” offerto serve a<br />
demolire una certa iconografia, che i mezzi<br />
di comunicazione di massa sembrano aver<br />
“cucito addosso” al pilota di Kerpen. Lo<br />
“Schumi” adorato dai tifosi della Rossa è in<br />
realtà…<br />
Schumacher-Ferrari, le nozze d’oro, titola il<br />
Corriere della Sera. L’espressione “nozze<br />
d’oro” non si riferisce al numero di anni che i<br />
“coniugi” hanno trascorso insieme (i cinquant’anni<br />
di unione, denominati convenzionalmente<br />
in questo modo). Allude ai miliardi<br />
che il tedesco riceverà in cambio delle sue<br />
prestazioni in pista. È allora una mera<br />
questione economica? “A Maranello, Schumacher<br />
ha trovato un gruppo di uomini che<br />
gli ha fatto sentire il calore umano. Schumi<br />
sembra uomo freddo, nordico, capace<br />
soltanto di stabilire un contatto tedesco e poi<br />
una strategia di corsa con chi gli sta intorno.<br />
In realtà il suo rapporto con gli uomini della<br />
7
TESI DI LAUREA<br />
Ferrari è eccezionale: è il “piccolo” coccolato,<br />
vezzeggiato e amatissimo di tutta la squadra”<br />
(Cds, 18/7/1998). L’importanza del fattore<br />
ambientale ed il rapporto di affetto e stima<br />
reciproca, instaurato da Michael Schumacher<br />
con l’intero team della Rossa, vengono<br />
evidenziati anche dalla Frankfurter Allgemeine:<br />
“Schumacher si sente bene nella sua<br />
“pelle”. L’atmosfera in Scuderia funziona.<br />
Sensibile, il miglior pilota del momento si è<br />
guadagnato, nei primi due anni e mezzo, la<br />
fiducia dell’intero team” (Faz, 18/7/1998).<br />
Sequenze da brivido<br />
al Gran Premio del Belgio<br />
Il Gran Premio del Belgio del 31 agosto 1998<br />
regala una delle sequenze maggiormente<br />
riproposte dalle televisioni di mezzo mondo.<br />
Nel corso della venticinquesima tornata,<br />
Michael Schumacher, saldamente al comando<br />
della corsa dopo il ritiro del rivale Hakkinen,<br />
va a finire contro la monoposto di<br />
Coulthard che stava doppiando. Nell’impatto,<br />
causato, secondo il tedesco, da un’eccessiva<br />
decelerazione dello scozzese, il pilota di<br />
Kerpen perde una ruota ed è costretto a rientrare<br />
ai box.<br />
Il Corriere della Sera ritorna sull’argomento<br />
nell’edizione del martedì. Luca Goldoni sottolinea<br />
come l’alfiere della Rossa sia tanto<br />
amato dagli appassionati di Formula 1 per la<br />
sua capacità di regalare forti emozioni. Viene<br />
fornito un ritratto altamente evocativo, atto ad<br />
esprimere quanto il corridore possa emozionare<br />
quanti lo seguono davanti ad un televisore.<br />
“Schumacher è uno che, se c’è da ballare,<br />
balla. Quando è saldamente in testa e gli<br />
urliamo dai nostri divani, vai piano vai piano,<br />
lui tiene giù il piede e fa il giro record. Quando<br />
si fionda in un sorpasso che nessun altro<br />
azzarderebbe perché è contro le leggi di fisica<br />
balziamo in piedi come ad un gol della<br />
nazionale. Per questo Schumacher è amato,<br />
per questo è così popolare. Non agisce per<br />
far spettacolo, ma in sostanza lo fa regalandoci<br />
quei brividi che ci aspettiamo da un gran<br />
premio” (Cds, 1/9/1998). La “domenica nera”<br />
di Spa non sembra, però, essere trascorsa<br />
invano, perché alla crisi del Pilota ha fatto<br />
riscontro l’affermazione dell’Uomo. “Resta il<br />
fatto che Schumacher, invece di quel sorpasso,<br />
avrebbe potuto fermarsi, bere un caffè,<br />
risalire in macchina e vincere. Invece ha<br />
obbedito ad un impulso. A uno di quegli<br />
impulsi che tante volte ci hanno emozionato.<br />
Per questo anche se si è giocato il podio,<br />
umanamente mi piace di più” (ibidem).<br />
Dopo la drammatica e piovosa domenica<br />
vissuta nelle Ardenne, arriva il sole di Monza,<br />
e non solo dal punto di vista meteorologico.<br />
Michael Schumacher, alla sua prima pole<br />
stagionale, ed il compagno di squadra Eddie<br />
Irvine regalano alla Ferrari una storica<br />
doppietta. Un rapporto speciale sembra<br />
essersi instaurato fra l’alfiere di Maranello e i<br />
sostenitori della Rossa. Siamo in presenza di<br />
un “canale” di affetto e stima a doppia circolazione,<br />
dove a catturare l’attenzione generale<br />
è il comportamento del due-volte campione<br />
del mondo. Non appena sceso dalla sua<br />
monoposto, Schumacher corre, infatti, sotto<br />
la tribuna dell’autodromo gremita di pubblico,<br />
quasi a volersi far investire in pieno dall’ondata<br />
di entusiasmo che ha invaso il circuito<br />
brianzolo.<br />
Nell’ora del trionfo<br />
ricordando la nonna<br />
Il successo ottenuto dalla Ferrari sul tracciato<br />
brianzolo segna un momento importante<br />
nell’evoluzione di quello che abbiamo definito<br />
il “personaggio Schumacher”. Giunge ad un<br />
primo stadio di compimento il processo di<br />
“umanizzazione” del campione di Kerpen.<br />
Uno degli contributi, pubblicati dal Corriere<br />
della Sera, ci presenta, infatti, una figura, che,<br />
sino a quel momento, non era stata neppure<br />
accennata dai mezzi di comunicazione di<br />
massa, Anna, nonna del pilota tedesco.<br />
“Michael Schumacher che incrocia le dita alla<br />
vigilia e che parla della sua Anna, della sua<br />
nonna, nell’ora del trionfo più bello, non è più<br />
il freddo calcolatore tedesco. Campione scontroso,<br />
distaccato e irraggiungibile. Michael<br />
Schumacher è italianissimo. Nei vizi e nelle<br />
virtù. Nelle emozioni e nelle reazioni. Come i<br />
duecento tifosi che in tre giorni gli hanno<br />
trasmesso la carica e gli hanno regalato un<br />
pizzico del calore, dell’entusiasmo e delle<br />
trasgressioni di cui sono capaci” (Cds,<br />
14/9/1998). In questo estratto si presenta di<br />
estremo interesse la proposizione “Schumi è<br />
italianissimo”. Esprime un percorso di appropriazione<br />
prima di tutto culturale e poi umana,<br />
che è giunto ormai al termine. Ogni barriera è<br />
definitivamente caduta e i tifosi della Ferrari<br />
sentono di poter gioire con il tedesco come se<br />
si trattasse di uno di loro. Importante sottolineare<br />
la scelta del verbo “essere”: testimonia<br />
una realtà, che fino a qualche tempo prima si<br />
muoveva solo nell’ambito dell’apparenza. Non<br />
è la prima volta, infatti, che il quotidiano di via<br />
Solferino propone una notazione del genere.<br />
In occasione del Gran Premio d’Italia del<br />
1996, Giorgio Tosatti scriveva in un fondo:<br />
«sembrava intenerito come un italiano, come<br />
un ferrarista da generazioni».<br />
Il campionato 1998 vive le battute finali sul<br />
tracciato di Suzuka. Michael Schumacher,<br />
alla seconda pole position stagionale, è<br />
costretto dapprima a prendere il via dal fondo<br />
dello schieramento e poi a ritirarsi per lo<br />
scoppio dello pneumatico posteriore destro.<br />
Mika Hakkinen si laurea così nuovo campione<br />
del mondo; la McLaren conquista, invece,<br />
il titolo costruttori.<br />
Un dato permane comunque certo: “Questo<br />
mondiale lo ricorderemo perché ha regalato<br />
gioie e dolori ai ferraristi, perché ha offerto<br />
emozioni e rabbia e perché ha mostrato i<br />
sentimenti che agitano o tranquillizzano o<br />
scuotono un grande campione della formula<br />
uno costretto a rincorrere, ma felice di esaltare.<br />
Destinato a crollare sul filo di lana” (Cds,<br />
2/11/1998). L’alfiere di Maranello è uomo che<br />
sembra stupire non solo per le sue prestazioni<br />
in pista. Temperamento combattivo,<br />
sempre votato alla vittoria, Michael Schumacher<br />
guarda la piccola Gina Maria e capisce:<br />
in fondo non ha perso altro che un titolo.<br />
Un tremendo impatto<br />
a 107 km all’ora<br />
La stagione 1999 si può racchiudere in un’istantanea.<br />
Alle 14.03, ora italiana, il campionato<br />
mondiale di Michael Schumacher finisce<br />
contro il muro di gomme all’esterno della<br />
curva Stowe, sul circuito di Silvertsone. L’impatto<br />
a 107 km/h è tremendo. Il tedesco se la<br />
cava con la frattura di tibia e perone della<br />
gamba destra. Fabio Cavalera ci descrive<br />
quei drammatici momenti nel fondo a girare<br />
dalla prima pagina. Il giornalista si riferisce al<br />
pilota e lo chiama “l’uomo”. Il termine testimonia<br />
la situazione drammatica, che ha attraversato<br />
la prima guida Ferrari, una circostanza<br />
che lo ha svestito del ruolo di personaggio<br />
per evidenziarne la fragilità e la vulnerabilità<br />
tipiche di un essere umano. Il corridore tenta<br />
di uscire dalla propria monoposto. Le gambe,<br />
però, non lo sorreggono. Il fuoriclasse crolla<br />
nell’abitacolo della sua vettura, emettendo un<br />
gemito di dolore.<br />
L’incidente di Silverstone fa seguito a due<br />
belle affermazioni dell’asso di Kerpen prima<br />
a Imola, quindi a Montecarlo. Sul circuito<br />
monegasco, in particolare, il pilota era parso<br />
avvicinarsi, una volta di più, ad una completa<br />
“umanizzazione”. Sul podio “Schumacher,<br />
oltre ai salti acrobatici con Todt in braccio<br />
come un bambino, fa una cosa che non<br />
Michael Schumacher,<br />
un mito tedesco<br />
aveva fatto mai. Si commuove. Come un qualsiasi<br />
sentimentale di casa nostra” (Cds,<br />
17/5/1999).<br />
Mentre l’atleta tedesco si occupa della rieducazione<br />
della gamba fratturata, la Ferrari si<br />
trova ad affrontare il primo Gran Premio della<br />
stagione senza il proprio atleta di punta.<br />
Senza Schumi non è Ferrari, scrive la testata<br />
di via Solferino: l’espressione si riferisce, da<br />
un lato, ad un discorso prettamente tecnico;<br />
dall’altro ci racconta, invece, un profondo<br />
attaccamento umano nei confronti del<br />
campione di Kerpen. Il lato emotivo supera<br />
anzi in importanza il versante più squisitamente<br />
professionale. “I ragazzi della Ferrari<br />
sorridono, ma non sono allegri. Michael<br />
Schumacher ha lasciato un vuoto che mai<br />
avrebbero immaginato così grande. Quella<br />
gamba spezzata, forse, ha rotto anche la<br />
gioia del lavoro” (Cds, 24/7/1999) Anche la<br />
Frankfurter Allgemeine si sofferma ad<br />
evidenziare la reazione dell’ambiente delle<br />
corse all’infortunio di Michael Schumacher<br />
(Genervt und nervös reagiert die Formel 1<br />
auf den Beinbruch des Kerpeners – “la<br />
Formula 1 reagisce con nervosismo e stizza<br />
alla frattura della gamba del pilota di<br />
Kerpen”). Die Gegenwart des abwesenden<br />
Schumacher als Zeichen der Monokultur (“Il<br />
presente dell’assente Schumacher quale<br />
segno della monocultura), titola la corrispondenza<br />
di Anno Hecker. Il termine “monocultura”,<br />
di sapore sociologico, allude, nel caso<br />
specifico, ad una particolare attitudine, che<br />
esclude uno <strong>dei</strong> due elementi su cui si gioca<br />
la competizione in ambito automobilistico,<br />
precisamente la componente meccanica, a<br />
favore di quella umana; “Maschine im Schatten<br />
des Menschen” (“Macchina all’ombra<br />
dell’uomo”), prosegue, a questo riguardo,<br />
l’occhiello.<br />
«Il mito è effimero<br />
se non lo alimenti»<br />
Nel primo fine settimana di agosto la “carovana”<br />
della Formula 1 si sposta in Germania. Il<br />
racconto del Gran Premio è corredato, sul<br />
Corriere della Sera, dal box “Il grande assente”.<br />
Schumacher: «Tornerò dopo Monza. Il<br />
servizio riporta il contenuto del collegamento<br />
televisivo, che ha visto protagonista l’indiscusso<br />
talento dell’automobilismo e che è<br />
stato trasmesso dal maxischermo dell’autodromo<br />
prima dell’inizio della competizione. La<br />
“conferenza” via etere del fuoriclasse diventa<br />
spunto per un contributo dell’incisivo Luca<br />
Goldoni. Lo scrittore prospetta quella che<br />
nella testatina viene definita “intervista immaginaria”.<br />
Nelle sue intenzioni, precisare la<br />
reale portata del pensiero di Schumacher. Il<br />
tedesco è fatto stendere su un “lettino virtuale”;<br />
qui Goldoni lo sottopone ad “una breve<br />
seduta psicanalitica a distanza”. Le considerazioni<br />
emerse vengono riportate l’una dopo<br />
l’altra: “Io non c’ero nelle ultime due gare e<br />
tanti fans pensano che è stata colpa mia […]<br />
Schumi fa troppi errori, pensano anche i miei<br />
fedelissimi, e qualche dubbio comincia a<br />
venire anche a me […] sono frustrato, roso<br />
dai rimorsi e anche un po’ infuriato … dannazione,<br />
Irvine non poteva guidare sempre a<br />
quel modo, quando avevo bisogno di lui? …<br />
E che dovrei fare ora? Rientrare a Monza?<br />
La primadonna retrocessa a servetta portatrice<br />
d’acqua? Ma per carità” (Cds, 2/8/1999).<br />
Il pilota muta quindi registro. “Penso anche<br />
che il mito è effimero, se non lo alimenti, si<br />
affloscia: se allargassero l’abitacolo e ci incastrassero<br />
Kohl, la gente impazzirebbe per lui,<br />
così vanno le cose in Ferrari. E allora mi<br />
prospetto un altro scenario… Torno appena<br />
posso, sono tagliato fuori dal Mondiale, ma<br />
do una mano a Irvine, magari strappo una<br />
pole […]. Immagino i tifosi: Schumi da semidio<br />
a missionario. L’idolo risorge nell’umiltà<br />
ecc. Il vero protagonista tornerei io” (ibidem).<br />
Anche la Frankfurter Allgemeine, seppure<br />
8 ORDINE 1 <strong>2004</strong>
Ferrari, una<br />
leggenda italiana<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
con un giorno di distanza, si interroga sull’effettivo<br />
stato d’animo del corridore Ferrari.<br />
Eguale la tecnica scelta. Evi Simeoni introduce<br />
una telecamera di bordo virtuale e ne dirige<br />
l’obiettivo verso la villa svizzera del fuoriclasse<br />
per registrarne le reazioni. “Il pilota di<br />
Kerpen se ne sta rinchiuso, così in questo<br />
caso siamo guidati dall’immaginazione:<br />
Schumacher davanti al televisore, che sta a<br />
guardare la doppia vittoria Ferrari di Irvine e<br />
Hakkinen nel Gran Premio di Germania e si<br />
domanda che cosa significhi per il suo ruolo<br />
nel team. Qualcosa senza di lui va meglio<br />
quindi? Schumacher la mattina successiva<br />
mentre legge i giornali. […] No, il volto di<br />
Schumacher mentre legge questo tipo di<br />
stampa preferiamo non immaginarcelo” (Faz,<br />
3/8/1999).<br />
Michael Schumacher segna il ritorno alle<br />
competizioni in occasione del Gran Premio<br />
della Malesia, in coda ad un periodo travagliato,<br />
ritmato da continui test tecnici e clinici<br />
e da dichiarazioni di resa incondizionata,<br />
prontamente smentite.<br />
Sul tracciato di Sepang l’alfiere di Maranello<br />
conquista la pole dopo novantotto giorni di<br />
assenza dalle gare. Realizza il giro più veloce<br />
e consegna la vittoria finale a Eddie Irvine,<br />
lasciandolo sfilare in testa a tre tornate<br />
dal termine.<br />
Si arriva così in Giappone. Michael Schumacher<br />
parte nuovamente al palo. Una sua vittoria<br />
toglierebbe all’“antico” rivale finlandese<br />
ogni speranza di rimonta. Il tedesco sbaglia,<br />
però, lo start e si lascia infilare proprio dalla<br />
prima guida della McLaren, che si rivela poi<br />
imprendibile. Il titolo iridato piloti finisce<br />
nuovamente nelle mani del team anglo-tedesco;<br />
la Ferrari si consola, comunque, con la<br />
conquista del mondiale Costruttori.<br />
Stile di vita italiano<br />
per dovere d’immagine<br />
Le fasi iniziali del campionato 2000 si rivelano<br />
trionfali per Michael Schumacher e la<br />
Ferrari. Il campione di Kerpen sale sul gradino<br />
più alto del podio già nella prima gara, a<br />
Melbourne.<br />
Il Corriere della Sera ci regala un curioso<br />
retroscena. Negli ultimi giri che lo stavano<br />
conducendo verso la bandiera a scacchi, il<br />
fuoriclasse si è messo a parlare con la sua<br />
vettura, chiedendole di non tradirlo sul più<br />
bello. “Michael Schumacher dentro la rossa<br />
numero tre coccola con paroline di conforto<br />
la sua straordinaria Ferrari. Il verbo è sacrosanto<br />
e giusto. Racconterà proprio il tedesco,<br />
sempre meno tedesco per dovere di immagine<br />
e forse anche per scelta di vita e di sentimento,<br />
che lui l’ha “coccolata”. (Cds,<br />
13/3/2000). Nell’estratto viene rimarcato<br />
come l’alfiere Ferrari abbia svestito, da<br />
tempo, e in misura progressiva, “panni” tipicamente<br />
tedeschi, per assumere comportamenti<br />
che si avvicinino maggiormente alla<br />
sensibilità e allo stile di vita italiani. La scelta<br />
è legata, però, a “dovere di immagine” e si<br />
ricollega alle pesanti critiche, che hanno<br />
bersagliato il campione di Kerpen sin dal suo<br />
arrivo in Maranello. Contestazioni acuite dalla<br />
fitta trama di notizie e smentite, che hanno<br />
accompagnato il periodo di riabilitazione,<br />
seguito all’incidente di Silverstone. Si parla<br />
tuttavia anche di una “scelta di vita e di sentimento”.<br />
Soluzione che viene osservata, però,<br />
con occhio fortemente dubitativo (espresso<br />
dalla congiunzione “forse”).<br />
Anche la Frankfurter Allgemeine sottolinea<br />
come il Gran Premio d’Australia ci abbia regalato<br />
uno Schumacher inedito. Accanto ad<br />
alcuni elementi che sono entrati di diritto a far<br />
parte dell’iconografia legata al pilota tedesco,<br />
Anno Hecker mostra una nuova “immagine da<br />
trionfo”. “All’atleta Schumacher, che, dopo i<br />
trionfi, salta leggero sul podio come fosse un<br />
atleta di salto in alto, ci siamo abituati. Ai baci<br />
mandati all’indirizzo della squadra anche. Ma<br />
che Schumacher, mentre è ancora all’interno<br />
della vettura, allunghi entrambe le braccia<br />
fuori dal posto di guida per applaudire, all’ingresso<br />
della Parc Fermé, uno dopo l’altro gli<br />
uomini della squadra Ferrari schierati, è una<br />
nuova variante” (Faz, 13/3/2000). Nell’ultima<br />
sottolineatura è possibile leggere una sorta di<br />
“presa di distanza” latente. Quasi che, correndo<br />
per un team italiano, Michael Schumacher<br />
stia un poco smarrendo le proprie radici e la<br />
propria storia professionale.<br />
A rimarcare il cambiamento operato nel pilota,<br />
un articolo pubblicato dal quotidiano di via<br />
Solferino a due giorni dal Gran Premio d’Europa.<br />
“Quanto è diverso lo Schumacher di<br />
oggi rispetto a quello degli anni scorsi. È un<br />
pilota dal volto umano, non più un freddo<br />
robot o un marziano del volante in grado di<br />
guidare in modo pressoché perfetto un bolide<br />
da 800 cavalli, specialmente quando c’è la<br />
pioggia. Un uomo affezionato ai suoi due<br />
bambini, che porta nella tasca della tuta da<br />
corsa la spazzolina che gli ha mandato la<br />
figlia Gina Maria, quasi fosse la foto con la<br />
scritta “Non correre papà” che tanti automobilisti<br />
tengono sulla plancia della vettura”<br />
(Cds, 23/5/2000).<br />
“Doppiando” prestazioni a corrente alternata,<br />
si arriva al Gran Premio d’Italia. Michael<br />
Schumacher vi giunge in un momento particolare<br />
della sua carriera.<br />
Un pianto liberatorio<br />
in diretta televisiva<br />
A Monza il pilota tedesco si trova davanti ad<br />
un senso unico: deve vincere per ritornare in<br />
lotta per il Mondiale e riconquistare così la<br />
stima perduta. Il fuoriclasse risponde alla chiamata<br />
con una prestazione superba. Conquista<br />
dapprima la pole position e poi il gradino<br />
più alto del podio. In sala stampa accade,<br />
però, un elemento imprevisto. In diretta davanti<br />
alle telecamere, il campione di Kerpen scoppia<br />
in un pianto dirotto. Ad innescare la reazione,<br />
una domanda dell’intervistatore che gli<br />
chiede che cosa provi ad aver eguagliato il<br />
numero di successi di Senna. Quello di Schumacher<br />
è, però, soprattutto uno sfogo liberatorio<br />
dopo mesi di sconfitte e critiche.<br />
Le lacrime del tedesco rappresentano, a<br />
nostro avviso, la conclusione del percorso di<br />
“maturazione emotiva”, che ha interessato il<br />
“personaggio-Schumacher” nel suo primo<br />
quinquennio al volante della Rossa. Ci troviamo<br />
dinanzi alla definitiva affermazione<br />
dell’Uomo sul Pilota. Il campione di Kerpen si<br />
è offerto al proprio pubblico in una versione<br />
inedita, abbandonandosi ad uno sfogo, quello<br />
del pianto, che ne rivela una fragilità di<br />
fondo, mai supposta in precedenza. Si<br />
completa così una visione, a tutto fondo, della<br />
personalità del corridore: con i gesti abituali<br />
che parlano di gioia; ed ora anche con le<br />
reazioni che possono sorprenderlo, quando<br />
si ritrova a vivere una situazione difficile.<br />
A livello mediatico, l’episodio viene ampiamente<br />
trattato da entrambe le testate trascelte.<br />
Le lacrime di Michael, il pilota-computer fa<br />
un bagno d’umanità, scrive il Corriere della<br />
Sera. Il lead dell’articolo chiarisce da subito il<br />
particolare significato rivestito dal pianto di un<br />
Michael Schumacher, apostrofato come<br />
“superuomo” (tale è almeno l’immagine di sé<br />
che ha fornito sino a quel momento). Lo sfogo<br />
emotivo si è dimostrato fondamentale, perché<br />
ha aperto per il campione di Kerpen “una<br />
strada di riavvicinamento alla dimensione<br />
umana”. “Uomo bionico” (ovvero persona<br />
animata da una vita artificiale), Michael Schumacher<br />
ha finito, però, per cedere di schianto<br />
sotto il peso di un’emozione troppo forte da<br />
contenere. Il quotidiano di via Solferino<br />
racconta l’avvenimento fase dopo fase,<br />
proponendo una struttura per asindeto: “non<br />
ha retto più, ha chinato la testa e si è abbandonato<br />
ad un pianto dirotto”. L’articolo della<br />
testata milanese pone un quesito. Il passag-<br />
gio recupera alcuni degli appellativi (con<br />
valenza non certamente positiva), attribuiti al<br />
due-volte campione del mondo. “Dov’era finito,<br />
in questi momenti, l’uomo bionico, il pilota<br />
robot, il tedesco cuore di pietra che pensa<br />
solo ai milioni di dollari e parla un pessimo<br />
italiano dopo cinque anni di Ferrari? Finito,<br />
dissolto? Oppure, più semplicemente, nascosto<br />
sotto emozioni che non avrebbe mai<br />
immaginato tanto splendide e crudeli?” (Cds,<br />
11/9/2000).<br />
Der Triumph in Monza rührt Michael Schumacher<br />
zu Tränen (“Il trionfo di Monza commuove<br />
Michael Schumacher fino alle lacrime”),<br />
titola la Frankfurter Allgemeine. A differenza<br />
del corrispettivo italiano, il quotidiano tedesco<br />
non attribuisce particolare enfasi al pianto, che<br />
ha visto, quale protagonista inaspettato, il<br />
corridore della Ferrari. Il titolo dell’articolo di<br />
Anno Hecker sembra costruito piuttosto su di<br />
un’asse causa (“il trionfo”)-effetto (la “commozione<br />
sino alle lacrime”), richiamando alla<br />
memoria le immagini analoghe di molti sportivi<br />
dopo la conquista di un successo. Simile,<br />
invece, il “modus narrandi” <strong>dei</strong> due giornali.<br />
Entrambi restituiscono la scena, frammentata<br />
in tante piccole azioni, consecutive le une alle<br />
altre. Il lettore ha così l’impressione non di<br />
leggere una cronaca, ma di assistere direttamente<br />
all’evento (Faz, 11/9/2000).<br />
L’asso di Kerpen decide di chiudere il discorso<br />
iridato sul circuito di Suzuka: non vuole<br />
correre il rischio di arrivare a giocarsi il titolo<br />
all’ultima gara, La corsa giapponese si srotola<br />
secondo le più rosee aspettative: il corridore<br />
tedesco parte davanti a tutti ed offre una<br />
prestazione perfetta. Alle 16.03 (ora locale) si<br />
rompe per la Ferrari un “digiuno” lungo ventuno<br />
anni. Con un Gran Premio d’anticipo,<br />
Michael Schumacher si laurea nuovo<br />
campione del mondo.<br />
Il personaggio Schumacher<br />
tra emozione e cultura<br />
L’evoluzione del “personaggio Schumacher”,<br />
posta ad assunto, è parsa giocarsi, nei due<br />
quotidiani all’esame, secondo dinamiche<br />
differenti. Il Corriere della Sera propone un<br />
percorso di natura emotiva (dal “pilota bionico”<br />
al corridore “dal volto umano”). La Frankfurter<br />
Allgemeine sembra insistere, invece,<br />
su un’acquisizione di carattere culturale,<br />
evidenziando il progressivo avvicinamento<br />
del proprio atleta ad una sensibilità tipicamente<br />
italiana.<br />
La testata milanese presenta inizialmente il<br />
campione di Kerpen, insistendo su un preciso<br />
bagaglio iconografico: “messia” atteso dai tifosi<br />
Ferrari, Schumacher viene ritratto come<br />
freddo e calcolatore, con il giudizio umano<br />
anteposto spesso ad una valutazione di tipo<br />
tecnico.. È il Gran Premio di Italia, a “cadenza<br />
biennale” a ritmarne l’evoluzione sul piano<br />
emotivo. Emblematica la corsa del 2000. A<br />
seguito del pianto, l’Uomo vince definitivamente<br />
la propria battaglia contro la Macchina.<br />
Nel quotidiano di Francoforte la progressiva<br />
“italianizzazione” del fuoriclasse germanico,<br />
dapprima suggerita, assurge a piena espressione<br />
nel corso del campionato 2000. Le gare<br />
iniziali vedono la testata rimarcare alcuni<br />
atteggiamenti del pilota, vissuti come “anomali”:<br />
le descrizioni riportate testimoniano, a<br />
nostro personale avviso, quasi una presa di<br />
distanza nei confronti dell’atleta. Manca qualsiasi<br />
accenno ad un’evoluzione emotiva: Le<br />
lacrime di Monza vengono definite “piccola<br />
sconfitta nella battaglia quotidiana per il<br />
controllo di sé”. Un’esperienza “penosa” per<br />
l’asso tedesco, abituato a fondare la propria<br />
forza sul controllo <strong>dei</strong> sentimenti.<br />
Dalla piccola goccia, versata a Monza, è nato<br />
l’oceano dell’emotività, cui Michael Schumacher<br />
non sembra più volersi sottrarre. Altre<br />
lacrime ed altro calore latino si sono consegnati<br />
agli annali della Formula 1.<br />
Ottavia Eletta Molteni<br />
9
S I N D A C A T O<br />
I dati di applicazione<br />
del contratto sono molto positivi<br />
in quanto ogni mese<br />
si registrano nuove assunzioni<br />
di giornalisti disciplinate<br />
dal contratto<br />
Domenico Affinito (Alg) non firma<br />
Milano, 2 dicembre 2003. Domenico Affinito,<br />
rappresentante dell’Associazione lombarda<br />
giornalisti in seno alla commissione<br />
contratto Fnsi Aeranti-Corallo, non ha firmato<br />
il rinnovo economico biennale del contratto<br />
scaduto nell’ottobre 2002.<br />
Un’astensione motivata dalla contrarietà<br />
della maggioranza <strong>dei</strong> colleghi lombardi<br />
rispetto all’aumento proposto nell’accordo<br />
che varia da un minimo di 45,85 euro a un<br />
massimo di 65,64. Cifre non sufficienti a<br />
colmare l’erosione degli stipendi da parte<br />
dell’inflazione e ben lontane, comunque, da<br />
quelle <strong>dei</strong> rinnovi registrati in altre categorie.<br />
Nonostante, poi, l’aumento di alcuni istituti<br />
contrattuali (l’aumento del contributo a carico<br />
delle aziende per l’assicurazione infortuni,<br />
l’aumento della tredicesima da 26/26 a<br />
28/26), rimangono ancora sul tavolo grossi<br />
problemi. Il contributo Casagit, ad esempio,<br />
per i minimi molto bassi del contratto Aeranti<br />
EMITTENZA RADIOTV LOCALE<br />
Firmato l’accordo tra Fnsi e Aeranti-Corallo<br />
sulla parte economica biennale del contratto<br />
ACCORDO DI RINNOVO<br />
DELLA PARTE ECONOMICA<br />
DEL CCNL 3/10/2000<br />
Il giorno 3 dicembre 2003 in Roma, tra<br />
Aeranti-Corallo, Aeranti, Corallo e Fnsi, si è<br />
proceduto al rinnovo della parte economica<br />
del contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione<br />
del lavoro giornalistico nelle<br />
imprese di radiodiffusione sonora e televisiva<br />
in ambito locale, loro sindycations e agenzie<br />
di informazione radiofonica, sulla base<br />
<strong>dei</strong> seguenti contenuti, per il biennio 3 ottobre<br />
2002 – 2 ottobre <strong>2004</strong>.<br />
1) Incremento <strong>dei</strong> minimi<br />
I valori minimi tabellari in atto saranno incrementati<br />
a regime di euro 65,64 per il teleradiogiornalista<br />
tv con oltre 24 mesi di attività<br />
lavorativa nel settore giornalistico; di euro<br />
50,86 per il teleradiogiornalista radio con<br />
oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore<br />
giornalistico; di euro 45,85 per il teleradiogiornalista<br />
con meno di 24 mesi di attività<br />
lavorativa nel settore giornalistico.<br />
Il suddetto importo verrà corrisposto (come<br />
da tabella allegata) sulla base delle seguenti<br />
percentuali e cadenze:<br />
il 70% a partire dal 1° dicembre 2003;<br />
il 30% a partire dal 1° marzo <strong>2004</strong>.<br />
Sino al periodo di paga relativo al mese di<br />
novembre 2003 continuerà ad essere erogata<br />
l’indennità di vacanza contrattuale (nelle<br />
misure di cui alla tabella allegata) che<br />
cesserà a far data dal 1° dicembre 2003 e<br />
verrà quindi sostituita dai suddetti incrementi.<br />
2) Tredicesima mensilità<br />
A partire da dicembre 2003 l’ammontare<br />
della 13a mensilità sarà pari a 28/26esimi<br />
della retribuzione mensile ragguagliata al<br />
periodo di maturazione di tali 28/26esimi.<br />
3) Contributo a carico delle aziende<br />
per la assicurazione infortuni<br />
A decorrere dal 1° gennaio <strong>2004</strong> il contributo<br />
a carico delle aziende per la assicurazione<br />
infortuni previsto dall’art. 39 è elevato da<br />
euro 6,71 a euro 11,88 per ogni giornalista<br />
dipendente.<br />
Roma, 3 dicembre 2003. È stato sottoscritto oggi tra la<br />
Federazione nazionale della stampa e le organizzazioni<br />
delle emittenti locali Aeranti e Corallo il rinnovo biennale<br />
della parte economica del contratto collettivo di categoria<br />
che regola le prestazioni <strong>dei</strong> giornalisti impegnati nelle<br />
imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito<br />
locale, nelle sindycations e nelle agenzie di informazione<br />
radiofonica.<br />
La rinnovazione contrattuale prevede un aumento <strong>dei</strong> minimi<br />
tabellari a regime di 65,64 euro, un aumento della<br />
contribuzione a carico delle aziende per l’assicurazione<br />
infortuni, il raddoppio della quota di Tfr da destinare alla<br />
previdenza complementare, un aumento della contribuzione<br />
aziendale per l’assistenza sanitaria integrativa (Casagit)<br />
e un aumento della misura della tredicesima mensilità,<br />
che passa da 26/26 a 28/26.<br />
Si tratta, complessivamente, di un incremento economico<br />
percentuale leggermente superiore rispetto a quello ottenuto<br />
nel contratto collettivo Fieg-Fnsi con elementi signifi-<br />
4) Assistenza sanitaria integrativa<br />
7) Nuove tipologie contrattuali<br />
Nota a verbale<br />
Al fine di assicurare una adeguata applica- Le parti, preso atto dell’entrata in vigore del Aeranti-Corallo e Federazione nazionale della<br />
zione della normativa contrattuale inerente Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 stampa italiana si danno atto reciprocamente<br />
l’assistenza sanitaria integrativa gestita dalla in attuazione delle deleghe in materia di occu- degli sforzi compiuti per garantire una regola-<br />
Casagit, le parti costituiscono una commispazione e mercato del lavoro di cui alla Legge mentazione contrattuale in un settore in rapisione<br />
paritetica permanente, integrata da un 14 febbraio 2003 n. 30, convengono di proceda evoluzione tecnologica.<br />
rappresentante della Casagit, con il compito dere entro tre mesi dalla firma del presente Nell’ambito del rinnovo quadriennale <strong>2004</strong>di<br />
monitorare la popolazione giornalistica e i accordo, ad un esame congiunto della mate- 2008 saranno esaminati i problemi produttivi<br />
costi assistenziali del settore e individuare ria per definire gli aspetti applicativi delle e normativi relativi al digitale, satellitare e<br />
entro il 31/12/2003 soluzioni idonee a garan- nuove tipologie contrattuali in esso previste al terrestre, all’on line, alle agenzie di informatire<br />
i trattamenti assicurativi integrativi. Non<br />
appena definite tra le parti tali soluzioni, il<br />
contributo Casagit a carico delle aziende<br />
previsto dal comma 2 della prima nota a<br />
verbale dell’art. 42 è elevato dallo 0,50%<br />
della retribuzione imponibile allo 0,95% della<br />
medesima.<br />
5) Prestazioni previdenziali integrative<br />
A partire dal versamento al Fondo di previdenza<br />
complementare <strong>dei</strong> giornalisti italiani<br />
<strong>dei</strong> contributi inerenti la retribuzione del<br />
corrente mese di dicembre, la quota dell’accantonamento<br />
annuale del Tfr da versare al<br />
Fondo medesimo sarà pari all’ammontare<br />
doppio della contribuzione a carico dell’azienda<br />
dovuta per l’anno in corso.<br />
settore dell’emittenza radiotelevisiva privata.<br />
MINIMI DI STIPENDIO COMPRENSIVI<br />
zione.<br />
6) Inpgi e Fondo<br />
di previdenza complementare<br />
DELLA EX INDENNITÀ DI CONTINGENZA<br />
DA DICEMBRE 2003 DA MARZO <strong>2004</strong><br />
Nel corso della trattativa Aeranti-Corallo ha<br />
posto il problema di una propria rappresen- Tele-radiogiornalista TV 1621,14 1640,83<br />
tanza negli organi collegiali dell’Inpgi e nel con oltre 24 mesi di attività lavorativa<br />
Consiglio di amministrazione del Fondo di<br />
previdenza complementare. Al riguardo le<br />
nel settore giornalistico<br />
parti, nel prendere atto che l’Istituto naziona- Tele-radiogiornalista radio 1256,17 1271,43<br />
le di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti italiani è retto con oltre 24 mesi di attività lavorativa<br />
da uno statuto la cui modifica può avvenire<br />
soltanto con decreto del ministero del Lavo-<br />
nel settore giornalistico<br />
ro, e che il Fondo di previdenza complemen- Tele-radiogiornalista 1132,66 1146,42<br />
tare <strong>dei</strong> giornalisti italiani è stato costituito con meno di 24 mesi di attività lavorativa<br />
con atto notarile tra la Fnsi e la Fieg, in base<br />
alle disposizioni legislative che regolamentano<br />
la previdenza complementare, convengo-<br />
nel settore giornalistico<br />
no di procedere al più presto ai necessari INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE<br />
approfondimenti anche con la Federazione<br />
Italiana editori giornali e con il Consiglio di<br />
DA CORRISPONDERE MENSILMENTE SINO A NOVEMBRE 2003<br />
amministrazione dell’Inpgi, per quanto di Teleradiogiornalista TV con oltre 24 mesi 11,03<br />
rispettiva competenza, al fine di verificare la Teleradiogiornalista radio con oltre 24 mesi 8,54<br />
percorribilità della richiesta.<br />
Teleradiogiornalista con meno di 24 mesi 7,70<br />
Corallo spesso non arriva al minimo previsto<br />
dalla Cassa che, in questi anni, ha chiesto il<br />
conguaglio a molti colleghi e che, in un futuro,<br />
potrebbe decidere un taglio delle prestazioni.<br />
Senza contare poi i problemi delle<br />
grosse syndacation o agenzie, nelle quali i<br />
volumi di affari sono tali da permettere<br />
contratti del peso dell’Fnsi-Fieg e che invece<br />
sono equiparate alle piccole emittenti con<br />
meno di 5 giornalisti assunti. Problemi che<br />
l’accordo Fnsi Aeranti Corallo accenna, ma<br />
in modo nebuloso e non soddisfacente.<br />
Edmondo Rho (Qp) si astiene<br />
Milano, 2 dicembre 2003. L’ipotesi di accordo<br />
sulla parte economica del contratto<br />
Fnsi/Aeranticorallo per le emittenti locali è<br />
stata approvata dalla Giunta Fnsi con 7 voti<br />
favorevoli e 2 astensioni. Edmondo Rho,<br />
rappresentante di Quarto Potere nella Giunta<br />
Fnsi, ha motivato la sua astensione dicendo<br />
che “il contratto con Aeranti-Corallo non<br />
solo è insufficiente dal punto di vista economico,<br />
con aumenti intorno ai 50 euro lordi<br />
che oltretutto arrivano oltre un anno dopo la<br />
scadenza naturale, ma rischia di essere<br />
penalizzante e antisolidaristico per i colleghi<br />
che guadagnano meno e possono trovarsi<br />
in ulteriore difficoltà se dovranno versare<br />
un’integrazione alla Casagit”.<br />
Il problema riguarda in particolare quei colleghi<br />
che sono al di sotto del minimo di contribuzione<br />
previsto dalla Casagit: le aziende<br />
chiedono che non venga richiesta l’integrazione<br />
al minimo, ma intanto per il momento<br />
cativi, come quelli che riguardano la previdenza, l’assistenza<br />
sanitaria e la tredicesima mensilità.<br />
Il contratto quadriennale dell’emittenza locale scadrà il<br />
prossimo ottobre <strong>2004</strong>. È volontà della Federazione della<br />
stampa avviare da subito le consultazioni della categoria<br />
per definire in tempi rapidi una piattaforma che consenta<br />
di affrontare e risolvere, soprattutto sul piano normativo, gli<br />
aspetti più rilevanti che attengono all’esercizio della professione<br />
giornalistica in un settore in grande espansione e<br />
che assume un ruolo crescente nel panorama informativo<br />
italiano.<br />
“Siamo soddisfatti del rinnovo odierno – ha commentato il<br />
coordinatore di Aeranti-Corallo Marco Rossignoli – in quanto<br />
si tratta di un altro importante passaggio del percorso<br />
della contrattazione collettiva iniziato il 3 ottobre 2000 con la<br />
sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro. I<br />
dati di applicazione del contratto sono molto positivi – ha<br />
aggiunto Rossignoli – in quanto ogni mese si registrano<br />
nuove assunzioni di giornalisti disciplinate dal contratto”.<br />
non verseranno l’aumento del contributo<br />
Casagit dello 0,45% a carico degli editori<br />
dell’emittenza locale che scatterà solo quando<br />
una commissione paritetica tra Fnsi e<br />
Aeranti-Corallo avrà esaurito il monitoraggio,<br />
previsto entro il 31 dicembre 2003, su questa<br />
situazione.<br />
Va ricordato che l’anno scorso la Casagit<br />
aveva richiesto l’integrazione, che per ora è<br />
stata bloccata, e ora su questo aspetto<br />
dovrebbe essere la commissione paritetica a<br />
trovare una soluzione.<br />
Il segretario della Fnsi, Paolo Serventi<br />
Longhi, pur riconoscendo che in realtà l’accordo<br />
economico con Aeranti-Corallo dura<br />
soli undici mesi, ha chiesto di approvare la<br />
firma del contratto biennale perché “più si va<br />
avanti nel tempo e più si penalizzano i colleghi”:<br />
all’aumento del 4,16%, vanno aggiunte<br />
i miglioramenti ottenuti per la tredicesima e<br />
per l’assicurazione infortuni.<br />
10 ORDINE 1 <strong>2004</strong>
G I U R I S P R U D E N Z A<br />
Quando il trasferimento di sede<br />
di un inviato speciale è nullo<br />
L’azienda si è difesa sostenendo l’inapplicabilità<br />
dell’art. 2103 cod. civ., che consente il<br />
trasferimento da un’unità produttiva all’altra<br />
solo per comprovate ragioni organizzative e<br />
comunque la validità delle esigenze indicate<br />
nella motivazione del provvedimento; in<br />
proposito essa ha fatto presente che in Bologna<br />
non esisteva alcuna sua unità produttiva<br />
e che la presenza del giornalista a Roma era<br />
necessaria per agevolare la possibilità di<br />
contattarlo per motivi di servizio. Il Tribunale<br />
(Giudice dott. Massimo Pagliarini, ordinanza<br />
del 24 giugno 2003) ha accolto il ricorso con<br />
la seguente motivazione:<br />
“In via preliminare, occorre sottolineare che -<br />
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa<br />
della società convenuta - siamo in presenza<br />
nel caso in esame di un vero e proprio<br />
trasferimento della sede di lavoro (da Bologna<br />
a Roma) cui è applicabile l’art. 2103 c.c,<br />
ultima parte. Secondo la preliminare tesi<br />
difensiva della società non troverebbe applicazione<br />
la citata disposizione normativa per<br />
la “inesistenza in Bologna di alcuna unità<br />
produttiva della convenuta, non potendosi<br />
certo ritenere tale l’abitazione del Sig. V.”.<br />
“Al riguardo, è sufficiente richiamare il condivisibile<br />
principio giurisprudenziale secondo il<br />
quale l’art. 2103 c.c. tende a due distinti fini:<br />
a) nel caso di spostamento del lavoratore<br />
all’interno dello stesso complesso aziendale,<br />
oppure entro un ambito geografico ristretto<br />
(ad esempio, nel territorio del medesimo<br />
comune), esso protegge il lavoratore contro<br />
eventuali lesioni della sua dignità professionale<br />
(art. 2087 c.c.), cagionate da un trasferimento<br />
immotivato; in tale caso, tuttavia, il<br />
trasferimento è ravvisabile non in qualsiasi -<br />
anche insignificante - spostamento, ma solo<br />
nel passaggio da una ad altra unità produttiva,<br />
identificabile ex art. 35 Stat. Lav.; b) nel<br />
caso invece di spostamento territoriale, la<br />
norma tutela i lavoratori contro i disagi abitativi,<br />
familiari e personali dovuti al cambio di<br />
residenza ed in tale ipotesi l’unità produttiva<br />
può essere identificata con qualunque sede<br />
aziendale, senza requisiti dimensionali. Più<br />
precisamente essa va individuata in qualsiasi<br />
articolazione autonoma dell’impresa, avente<br />
sotto il profilo funzionale idoneità ad esplicare,<br />
in tutto o in parte, l’attività di produzione<br />
di beni e servizi dell’impresa stessa, della<br />
quale è elemento organizzativo (cfr. Cass.<br />
Parlamento Ue<br />
Strasburgo<br />
“difende”<br />
le professioni<br />
«elemento<br />
essenziale<br />
delle società<br />
europee»<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
Un giornalista inviato speciale<br />
con base presso la propria abitazione,<br />
in località diversa dalla sede del giornale,<br />
non può essere trasferito<br />
presso la redazione centrale<br />
senza comprovate ragioni organizzative<br />
6.8.1996, n. 7196 e Cass. 26.5.1999, n.<br />
5153).<br />
“Ciò detto, va osservato che nel caso in<br />
esame l’abitazione del ricorrente (o meglio,<br />
una stanza di essa), munita di mezzi (computer<br />
- collegato con il sistema elettronico<br />
centrale - e telefono) attraverso i quali il V.,<br />
oltre a ricevere disposizioni dalla redazione<br />
romana, acquisiva le necessarie informazioni<br />
ed inviava i servizi e gli articoli richiestigli,<br />
configura la nozione di unità produttiva ex art.<br />
2103 c.c., come sopra specificata ed individuata.<br />
“Quanto al fumus, va osservato che l’art.<br />
2103, ultima parte c.c., stabilisce che il lavoratore<br />
non può essere trasferito da una unità<br />
produttiva ad un’altra se non per comprovate<br />
ragioni tecniche, organizzative e produttive.<br />
Ebbene, la società convenuta ha giustificato<br />
il trasferimento del ricorrente con l’esigenza<br />
di “completare il progetto di riorganizzazione<br />
del team degli inviati, al fine di integrarne l’attività<br />
con quella <strong>dei</strong> servizi redazionali e per<br />
dare piena attuazione alla norma transitoria<br />
dell’art. 11 del vigente Ccnlg. Il progetto di cui<br />
sopra è già iniziato da tempo ed è in fase di<br />
avanzata attuazione col trasferimento già<br />
programmato di altri inviati dalla sede di Milano<br />
alla sede centrale di Roma” (cfr. lettera di<br />
trasferimento del 6.2.2003).<br />
“Nella precedente nota al Comitato di redazione<br />
del giornale in data 31.1.2003, il direttore<br />
- nel richiamare il progetto di avere<br />
disponibili presso la sede di Roma gli inviati<br />
residenti fuori - ha chiarito che “l’esigenza<br />
organizzativa che sottende questo progetto è<br />
quella di poter ottimizzare le professionalità<br />
elevate come quelle degli inviati, che notoriamente<br />
dipendono direttamente da me, con le<br />
articolate necessità <strong>dei</strong> servizi della sede<br />
centrale di Roma”, aggiungendo che “purtroppo<br />
capita spesso che avendo la necessità<br />
di affidare incarichi confacenti con le<br />
professionalità degli inviati fuori sede, non<br />
riesca a mettermi in contatto con loro per via<br />
della lontananza dalla direzione dove maturano<br />
scelte ed esigenze di servizi, spesso in<br />
tempi strettissimi”.<br />
“Da ciò si evince che il concreto ed effettivo<br />
motivo del trasferimento del ricorrente (al pari<br />
degli altri riguardanti gli inviati fuori sede) è<br />
soprattutto quello dettato dalla (supposta) più<br />
agevole possibilità di contattare lo stesso per<br />
Strasburgo. Sulle professioni il Parlamento<br />
europeo non intende fare da spettatore in attesa<br />
che il commissario alla Concorrenza, Mario<br />
Monti, tiri le fila del rapporto annunciato per i<br />
primi mesi del <strong>2004</strong>.<br />
Ieri, l'Aula di Strasburgo ha approvato a larga<br />
maggioranza una mozione in cui si ribadisce<br />
la necessità di regolamentazione - specifica<br />
per ogni professione - per garantire l'affidamento<br />
da parte del professionista e la tutela<br />
del consumatore. Il documento - che è il frutto<br />
di un compromesso tra le mozioni elaborate<br />
qualche settimana fa dai tre gruppi parlamentari<br />
<strong>dei</strong> popolari, <strong>dei</strong> socialisti e <strong>dei</strong> liberali - è<br />
stato approvato con 457 voti a favore, contro<br />
60 contrari e 18 astenuti.<br />
La mozione sottolinea il particolare equilibrio<br />
su cui si reggono le professioni liberali, che<br />
sono «espressione di un ordine democratico<br />
fondato sulla legge e un elemento essenziale<br />
delle società europee». Da un lato, infatti, le<br />
professioni non si sottraggono alla competizione<br />
e alla libera circolazione <strong>dei</strong> servizi. D'altra<br />
parte, però, non si può prescindere da regole,<br />
SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA<br />
Il giornalista Sandro V., dipendente della<br />
s.p.a. Il Messaggero con mansioni di inviato<br />
speciale, è stato destinato nel 1991 a Bologna,<br />
dove ha lavorato per oltre dodici anni<br />
utilizzando come ufficio una stanza della<br />
propria abitazione attrezzata con archivio e<br />
computer munito di una serie di programmi<br />
per il collegamento con il sistema elettronico<br />
centrale del giornale e con le agenzie di<br />
stampa; egli riceveva per telefono dalla redazione<br />
centrale le disposizioni in ordine al<br />
lavoro da svolgere, si recava sui luoghi degli<br />
avvenimenti, realizzava i servizi richiestigli e<br />
li inviava alla redazione a mezzo del computer<br />
o per telefono, redigeva presso la sua<br />
abitazione gli articoli richiestigli quando le<br />
informazioni erano reperibili in Bologna;<br />
come inviato egli si è normalmente recato in<br />
missione sull’intero territorio nazionale e<br />
motivi legati ad esigenze di servizio. Ora, a<br />
prescindere dalla non secondaria circostanza<br />
che le mansioni di inviato speciale presuppongono<br />
un impegno lavorativo, anche in<br />
termini quantitativi, soprattutto in servizi<br />
esterni, ciò che deve essere sottolineato è il<br />
fatto che la società non ha dedotto, né provato<br />
la sussistenza di concrete difficoltà, logistiche<br />
ed operative, derivanti dalla lontananza<br />
del V. dalla redazione romana.<br />
“La manifestata esigenza, espressa in termini<br />
generali, di mettersi più, facilmente in<br />
contatto, in tempi anche strettissimi, con gli<br />
inviati sembra al contrario essere stata, con<br />
riguardo alla posizione del V., pienamente<br />
rispettata. Il ricorrente, infatti, fin dall’1.1.1991,<br />
ha lavorato come inviato speciale con base<br />
in Bologna, e cioè in una città già da quell’epoca<br />
priva di una redazione del giornale; da<br />
tale data il ricorrente - destinatario di due<br />
premi di produzione - ha confezionato una<br />
numerosa serie di articoli e servizi, molti <strong>dei</strong><br />
quali non richiedenti attività fuori sede, contribuendo<br />
con la sua opera alla buona riuscita<br />
del quotidiano e facendo così fronte alle<br />
dedotte “articolate necessità <strong>dei</strong> servizi della<br />
sede centrale di Roma” (cfr. la documentazione<br />
allegata). Sicché, tenuto conto del<br />
periodo di tempo lavorativo trascorso dal V. a<br />
Bologna (più di 12 anni), <strong>dei</strong> soddisfacenti<br />
risultati nel medesimo tempo conseguiti e<br />
della carenza di allegazioni riguardanti in<br />
concreto la difficoltà di un rapporto lavorativo<br />
tra le parti dovuto alla distanza fisica tra di<br />
esse (difficoltà dedotte solo in linea generale<br />
per tutti gli inviati fuori sede), appaiono non<br />
sussistenti in concreto le ragioni tecniche,<br />
organizzative e produttive legittimanti il disposto<br />
trasferimento. Peraltro, appare significativo<br />
che dopo il suo trasferimento a Roma il V.<br />
è stato utilizzato nel servizio Economia della<br />
redazione centrale, materia da lui in passato<br />
trattata solo di rado, che è stato inviato fuori<br />
sede solo una volta e che gli sono stati richiesti<br />
solo pochi articoli da scrivere: elementi,<br />
questi, che contraddicono nei fatti la manifestata<br />
volontà aziendale di “ottimizzare le<br />
professionalità elevate come quelle degli<br />
inviati” (cfr. la lettera dell’ azienda del<br />
31.1.2003 al comitato di redazione). Né<br />
appare convincente la motivazione del trasferimento<br />
ai danni del V., con riguardo alla<br />
(pretesa) volontà di dare “piena attuazione”<br />
ritagliate sulle caratteristiche di ciascuna<br />
professione, relative a organizzazione, qualificazione,<br />
deontologia, responsabilità, imparzialità.<br />
Inoltre, le organizzazioni professionali<br />
devono essere messe in condizione di prevenire<br />
i conflitti di interesse e la pubblicità ingannevole.<br />
In questi termini le regole non costituiscono<br />
restrizioni alla concorrenza: anzi, assicurano<br />
la qualificazione <strong>dei</strong> professionisti e<br />
garantiscono la qualità <strong>dei</strong> servizi, «a beneficio<br />
<strong>dei</strong> clienti, della società in generale e a tutela<br />
dell'interesse pubblico».<br />
Il voto sulla mozione relativa alla regole del<br />
mercato e della concorrenza nelle professioni<br />
liberali è slittato un paio di volte per evitare che<br />
il Parlamento si dividesse sui tre documenti<br />
presentati dai popolari (Klaus-Heiner Lehne,<br />
Othmar Karas, Giuseppe Gargani, Marianne<br />
Thyssen e Stefano Zappalà), dai socialisti<br />
(Manuel Medina Ortega) e dai liberali (Willy De<br />
Clercq). L'intesa raggiunta sulla mozione votata<br />
ieri ha preso le mosse dal riconoscimento<br />
comune ai tre gruppi delle «esigenze etiche e<br />
professionali necessarie per una corretta<br />
all’estero; ha scritto oltre cento articoli l’anno.<br />
Nel febbraio del 2003 la società editrice<br />
gli ha comunicato il trasferimento a Roma,<br />
motivandolo con riferimento all’esigenza di<br />
completare un progetto di riorganizzazione<br />
del “team” degli inviati, al fine di integrarne<br />
l’attività con quella <strong>dei</strong> servizi redazionali e<br />
di dare piena attuazione alla norma transitoria<br />
dell’art. 11 del contratto nazionale di lavoro<br />
giornalistico.<br />
Dopo avere lavorato per circa un mese a<br />
Roma, scrivendo tre articoli, egli ha chiesto al<br />
Tribunale di Roma di sospendere, con provvedimento<br />
d’urgenza in base all’art. 700<br />
c.p.c., l’efficacia del trasferimento, sostenendo<br />
l’inesistenza del progetto di riorganizzazione<br />
indicato dall’azienda e facendo presente di<br />
avere subito in Roma un netto demansionamento<br />
sia qualitativo che quantitativo.<br />
Si applica la tutela prevista<br />
dall’art. 2103 cod. civ.<br />
(Tribunale civile di Roma,<br />
Sezione Lavoro, ordinanza<br />
del 24 giugno 2003, Giudice<br />
dott. Massimo Pagliarini)<br />
alla norma transitoria dell’art. 11 del Ccnlg<br />
2001/2005. Vi è al riguardo da osservare che<br />
rispetto alla disposizione previgente (che già<br />
prevedeva per l’inviato speciale che non<br />
fosse impegnato in servizi esterni l’obbligo di<br />
prestare attività in redazione, in mansioni<br />
richiedenti esclusivamente le sue specifiche<br />
competenze professionali), la nuova norma<br />
ha aggiunto che lo stesso inviato, quando<br />
non impegnato fuori sede, debba essere “alle<br />
dirette dipendenze” del direttore.<br />
“La società convenuta ha di fatto “pattuito”<br />
per più di 12 anni che il ricorrente svolgesse,<br />
non in una redazione in senso proprio, la sua<br />
attività lavorativa quando non impegnato in<br />
servizi esterni (“pattuizione” che indubbiamente<br />
ha determinato non solo vantaggi e<br />
facilitazioni per il ricorrente - più vicino al<br />
proprio nucleo familiare - ma anche per lo<br />
stesso quotidiano) ed il fatto che oggi il<br />
contratto collettivo parli di dirette dipendenze<br />
dal direttore del giornale sta a significare che<br />
esso ha voluto porre l’accento su una dipendenza<br />
di tipo gerachico-organizzativo e non<br />
certo di natura fisica o logistica. Pertanto,<br />
mancando in concreto le ragioni di cui all’art.<br />
2103 c.c., il trasferimento disposto nei<br />
confronti del ricorrente non appare legittimo.<br />
Sussiste anche il secondo requisito richiesto<br />
dalla legge per la concessione della misura<br />
cautelare (pregiudizio imminente ed irreparabile),<br />
poiché il trasferimento del V. presso la<br />
redazione centrale di Roma - oltre a determinare<br />
un evidente ed intuibile disagio alla vita<br />
familiare e di relazione, disagio determinato<br />
dall’allontanamento dal proprio coniuge<br />
(peraltro affetto da disturbi relativi alla fase<br />
premenopausale e da disturbi depressivi<br />
notevolmente peggiorati proprio in ragione<br />
del trasferimento del marito) e dai propri due<br />
figli - ha determinato un sensibile aggravamento<br />
delle condizioni di salute dello stesso<br />
ricorrente (già affetto da diabete insulinodipendente)<br />
che ha visto il suo stato ansioso-depressivo<br />
peggiorare notevolmente a<br />
seguito del trasferimento a Roma (cfr. la<br />
copiosa documentazione medica prodotta).<br />
Pertanto, il protrarsi del trasferimento a<br />
Roma, durante il tempo occorrente al V. per<br />
far valere nel giudizio ordinario il suo diritto,<br />
sarebbe fonte di grave danno al suo stato di<br />
salute”.<br />
(da “www.legge-e-giustizia.it”)<br />
prestazione». Ma da parte <strong>dei</strong> popolari si è<br />
rinunciato a pretendere tout court l'esclusione<br />
della nozione di impresa per l'<strong>Ordine</strong> professionale<br />
se il suo orizzonte è l'interesse generale.<br />
Il Parlamento chiede alla Commissione di tenere<br />
in conto la necessità di preservare, attraverso<br />
regole specifiche, l'alta qualificazione <strong>dei</strong><br />
professionisti. D'altra parte Monti, l'8 ottobre di<br />
fronte al Parlamento, ha ammesso che «si deve<br />
tenere assolutamente conto degli aspetti non<br />
economici ed esaminare accuratamente le<br />
ragioni che giustificano le differenti regolamentazioni».<br />
A questo proposito la Commissione<br />
sta lavorando a un'indagine sulle professioni di<br />
avvocato, notaio, commercialista, ingegnere,<br />
architetto e farmacista.<br />
«È possibile - ha spiegato Monti qualche giorno<br />
fa - che il rapporto ci spinga a proporre<br />
azioni degli Stati membri o delle stesse professioni».<br />
M.C.D.<br />
(Da Il Sole 24 Ore<br />
del 17 dicembre 2003)<br />
11
C E N T E N A R I<br />
Il giornalista Lino Pellegrini,<br />
che con Curzio Malaparte<br />
visse lunghi periodi<br />
sui campi di battaglia,<br />
rievoca la personalità<br />
del celebre scrittore<br />
sotto il profilo umano<br />
L’atteggiamento che tenni, nel 1941, verso gli<br />
ebrei di Romania, impressionò uno scrittore<br />
non certo tenero qual era Curzio Malaparte.<br />
Lo impressionò tanto da farmi uscire a testa<br />
alta dal suo celebre e corrosivo Kaputt. Ebbene,<br />
sia le rievocazioni dell’Olocausto sia la<br />
strage di Istanbul mi inducono a dire di Malaparte<br />
nell’atmosfera di oltre mezzo secolo fa.<br />
Curzio Malaparte l’avevo incontrato per la<br />
prima volta in Bulgaria, a Sofia, nel marzo<br />
1941, una mattina che chiacchieravo, dinanzi<br />
alla Legazione d’Italia, con i colleghi Max<br />
David e Virgilio Lilli.<br />
Io, avevo venticinque anni; Malaparte, quarantatré.<br />
Io, ero inviato del Popolo d’Italia; lui, del<br />
Corriere della Sera. Nonostante il contrasto<br />
professionale simpatizzammo sùbito: lui,<br />
perché ero un pivello che non poteva dargli<br />
ombra; io, perché influenzato dalla sua fama<br />
e dalla cordialità che mi dimostrava.<br />
In Bulgaria ci stemmo poche settimane, poi ci<br />
trasferimmo in Romania. Qui, Malaparte fece<br />
base a Bucarest. Io (assieme a mia moglie<br />
Elena: eravamo sposati da appena sei mesi)<br />
raggiunsi invece la città da Jasci, a ridosso del<br />
confine sovietico, perché da Valfrè di Bonzo,<br />
nostro addetto militare, avevo saputo con<br />
certezza dell’immente attacco germanico<br />
contro l’Urss. Il 22 giugno i tedeschi valicarono<br />
infatti, com’è noto, il vicinissimo fiume Prut,<br />
che segnava il confine.<br />
Quella trincea scavata<br />
nel vecchio cimitero<br />
di Lino Pellegrini<br />
Localmente, i sovietici reagirono bombardando,<br />
fra l’altro, il centro di Jasci, nel quale<br />
mi trovavo, con i loro Martin Bomber. Un<br />
vetro fracassato mi colpì a una palpebra; fu<br />
l’unica goccia di sangue che versai nel corso<br />
dell’intera guerra.<br />
Il sessanta per cento della popolazione di<br />
Jasci si componeva di israeliti. Poche sere<br />
dopo l’attacco germanico, parte di quegli<br />
israeliti si sollevarono. Contemporaneamente,<br />
aerei sovietici lanciavano paracadutisti per<br />
appoggiare la rivolta. Era una notte di pece.<br />
Tutti facevano fuoco come indemoniati. Elena<br />
ed io trascorremmo la notte alla mercé del<br />
destino, dentro una trincea scavata... in un<br />
vecchio cimitero. All’alba, una pattuglia romena<br />
ci disse che la rivolta era fallita. Ma si sparava<br />
ancora. Per gli ebrei, cominciava il peggio.<br />
Data la gravità degli avvenimenti, Malaparte<br />
si vide costretto a rinunciare alla sua comoda<br />
base di Bucarest ed a raggiungere il<br />
pivello. Venne anzi ad alloggiare, assieme<br />
ad Elena ed a me, nella villetta di un professore<br />
italiano, momentaneamente disabitata,<br />
dove facemmo causa comune. Io ero inorridito<br />
per l’atteggiamento di una parte <strong>dei</strong><br />
romeni verso gli ebrei; Malaparte caricava la<br />
dose, imprecando contro un certo colonnello<br />
Lupu, responsabile di stragi. Un giorno,<br />
mentre stavamo discutendo con un commissario<br />
di polizia pochissimo malleabile,<br />
Curzio mantenne la calma... e io la persi. La<br />
persi, fino al punto di urlare a quel commissario:<br />
“Lei è un assassino di ebrei!” Non so<br />
per qual mai santo, il poliziotto incassò<br />
senza reagire. Malaparte mi chiese poi se<br />
fossi impazzito. E il mio sdegno gli rimase<br />
così impresso che in Kaputt (pubblicato in<br />
ventisette lingue) egli mi tratteggia, sia pur<br />
definendomi “stupido fascista”, con espressioni<br />
di invidia dichiarata.<br />
Dopo Jasci, mi chiesi più volte se Malaparte<br />
avesse sangue ebreo (come qualcuno, in<br />
Italia, sussurrava). Si chiamava Kurt Erich<br />
Suckert; sua madre era italiana e, suo padre,<br />
tedesco, anzi sassone. A questo punto<br />
gorgogliano i pettegolezzi a doppio taglio, nei<br />
quali non voglio scivolare. Certo, Malaparte<br />
affermava la propria arianità. E peraltro, se<br />
Kurt Erich Suckert fosse davvero stato un<br />
semplice italo-tedesco, non sarebbe facile<br />
spiegare appieno un punto chiave: ossia il<br />
suo istinto antigermanico, ch’egli dimostrò<br />
sia durante la prima guerra mondiale (si<br />
arruolò nel 1914 con i garibaldini che<br />
combattevano contro la Germania, ascese al<br />
grado di ufficiale degli Alpini; si buscò un<br />
avvelenamento da iprite, causa, forse, della<br />
malattia finale), sia durante tutta la durata del<br />
nostro sodalizio.<br />
Tra villaggi incendiati<br />
e città distrutte<br />
Sopra,<br />
Curzio<br />
Malaparte<br />
nella<br />
stanza 213<br />
dell’albergo<br />
“Tori”,<br />
a Helsinki<br />
(Finlandia),<br />
convalescente<br />
dopo<br />
un’operazione<br />
di appendicectomia.<br />
Estate<br />
del 1942.<br />
Sotto,<br />
Curzio<br />
Malaparte<br />
a Jasci<br />
(Romania),<br />
all’esterno<br />
della<br />
famosa<br />
chiesa<br />
ortodossa.<br />
Malaparte<br />
porta<br />
i calzoni<br />
da ufficiale,<br />
il distintivo<br />
fascista<br />
e la<br />
crocetta<br />
cattolica.<br />
Luglio<br />
1941.<br />
Nel giro di pochi giorni ottenemmo, a Jasci, i<br />
lasciapassare per affiancarci a una colonna<br />
corazzata germanica, e riuscimmo a prendere<br />
a nolo una vecchia “Ford V-8”. Malaparte<br />
volle che guidassi sempre io: quale ufficiale<br />
carrista, sia pure di complemento, gli<br />
ispiravo fiducia. Ci demmo quindi a gareggiare<br />
con l’avanzata. Attraversammo - fra<br />
Bessarabia e Ucraina - villaggi incendiati,<br />
città distrutte, steppe in fiamme. Un giorno<br />
che Malaparte si accorse di aver perso nel<br />
fango il suo apparecchio fotografico<br />
“Contax”, il suo umore divenne pessimo. Io,<br />
quanto a cibi, avevo meno pretese ed ero<br />
meno schizzinoso di lui; ma la cosa finiva lì.<br />
Io dormivo nelle isbe, dove le donne bessarabiane<br />
ed ucraine mi ospitavano quasi<br />
affettuosamente; Curzio, invece, preferiva<br />
dormire in macchina. Siamo, ormai, con le<br />
avanguardie. Un giorno, esplosione vicinissima;<br />
mi getto al suolo; Curzio, no. Poi mi<br />
rimprovera: “Non era una granata sovietica,<br />
era una cannonata tedesca in partenza:<br />
avresti dovuto capirlo”. Già, lui aveva fatto la<br />
prima guerra mondiale, io la sua esperienza<br />
non l’avevo. Trascorsero alcuni minuti, sostavamo<br />
sopra un blando colle, il sole tramontava,<br />
le artiglierie rombavano; d’improvviso,<br />
da un carro-radio germanico si diffusero le<br />
note di Lily Marleen. Era un momento di<br />
quelli che si ricordano per tutta la vita, ma<br />
l’umore di Malaparte - ferito sia nella professione<br />
sia nell’interesse per la perdita della<br />
“Contax” - non mutò. A me, invece, Lily<br />
Marleen rimase nell’anima. Né mi sorprende<br />
che l’adottassero, sia pure cambiando le<br />
parole, anche le truppe inglesi.<br />
Curzio aveva visitato più di me la Russia<br />
sovietica, l’aveva studiata, nutriva simpatia<br />
per i russi, parlava un pochino di russo -<br />
mentre io mi arrangiavo col tedesco, donde<br />
una forma di collaborazione reciproca -, e<br />
accettava alcuni aspetti del regime comunista;<br />
di conseguenza, certi episodi agivano su<br />
di lui come altrettanti colpi di scena. Ad<br />
esempio, nella borgata di Soròca, sulla sponda<br />
del fiume Dniestr, fummo ospitati da una<br />
vecchia signora della borghesia russa, felice<br />
di trovarsi con due italiani e di rievocare i<br />
A quarantasei anni dalla scomparsa<br />
Malaparte<br />
autentico<br />
tempi zaristi; Malaparte ascoltò attentamente,<br />
ma concluse che si trattava di un fenomeno<br />
isolato. In Ucraina incontrammo un gruppo<br />
di prigionieri russi, uno <strong>dei</strong> quali aveva<br />
ucciso il suo commissario politico; Malaparte<br />
stentava a capacitarsene. Un’altra volta, a<br />
Olshanka - ancora in Ucraina -, vedemmo un<br />
gruppo di donne e di vecchi (gli uomini validi,<br />
beninteso, mancavano, perché sotto le<br />
armi) lavorare febbrilmente per restituire al<br />
culto una chiesa, trasformata dai comunisti<br />
in un deposito di cereali. Donne e vecchi ci<br />
chiesero se il loro pope (sacerdote), deportato<br />
chissà dove, da tempo, sarebbe tornato<br />
al villaggio. E Malaparte, contraddetto implicitamente<br />
nelle sue convinzioni, rispose che<br />
sì, che certamente sarebbe tornato, poi<br />
rimase pensieroso a lungo.<br />
Che fosse russofilo - confermo -, non c’è<br />
dubbio. Che fosse antitedesco, nemmeno.<br />
Ma, per il resto, fra riserve mentali, polivalenze<br />
politiche e contraddizioni acrobatiche,<br />
disorientava chicchessia.<br />
Populista, cercava l’amicizia <strong>dei</strong> potenti.<br />
Moderava la sua aggressività con l’astuzia<br />
dell’opportunismo. Odiava i fascisti della<br />
corrente - o fronda - di Galeazzo Ciano, ma<br />
per lui personalmente faceva eccezione,<br />
perché era stato Ciano a tirarlo fuori dal confino<br />
di Lipari. Le sue incoerenze, Malaparte le<br />
mimetizzava con argomentazioni tanto abili<br />
quanto fumose ed elusive. Appunto, il collega<br />
Enrico Emanuelli, pur di carattere alquanto<br />
rigido, mi raccontò: “Ero in Uruguay, in un<br />
salotto di Montevideo, assieme ad altri ospiti,<br />
fra i quali Malaparte, e si discorreva del giro<br />
ciclistico d’Italia. Ebbene, quando un uruguagio<br />
chiese il perché della maglia rosa, Malaparte<br />
spiegò che gli organizzatori l’avrebbero<br />
voluta rossa, ma che Mussolini si era opposto<br />
al colore del comunismo. Insomma, a<br />
sentir Malaparte, la maglia rosa rappresentava<br />
un compromesso politico-sportivo! Che<br />
cosa vuoi che ti dica? Era così ben trovata<br />
che lasciai correre, anzi annuii”.<br />
«Quanti di questi ragazzi<br />
non rivedranno l’Italia»<br />
Oltreché trasformista, Malaparte era mitomane.<br />
Credeva nella validità delle sue invenzioni,<br />
le difendeva, ci si beava. Lui, le stragi degli<br />
ebrei di Jasci non le vide mai, così come non<br />
vide i morti “fuggire” dai carri ferroviari; ma in<br />
Kaputt ha scolpito il tutto anche meglio di un<br />
testimone oculare. Lui, l’ebreo spiaccicato da<br />
un Panzerwagen e trasformato in bandiera -<br />
di fronte al quale, in La pelle, mi fa pronunciare<br />
un commento -, non lo vide affatto,<br />
perché non esisteva; ma, mentre scriveva<br />
della pelle-bandiera, probabilmente ci<br />
credette. Certo, aveva candidamente dimenticato<br />
la visione delle autoblindo e <strong>dei</strong> carri<br />
12 ORDINE 1 <strong>2004</strong>
In alto,<br />
al centro:<br />
il nostro<br />
generale<br />
Messe,<br />
comandante<br />
delle CSIR,<br />
col generale<br />
tedesco<br />
Von<br />
Schobert:<br />
loro primo<br />
incontro.<br />
Il secondo<br />
da sinistra<br />
è Curzio<br />
Malaparte,<br />
che sta<br />
scattando<br />
una foto.<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
armati sovietici, distrutti da proiettili e da<br />
incendi, con dentro gli ossami degli equipaggi.<br />
D’altra parte, sono il primo a riconoscere<br />
allo scrittore il diritto di inventare: anche se<br />
quando mi trovo chiamato in causa con<br />
nome e cognome, rettifico, puntualizzo,<br />
smentisco.<br />
Dopo la Bessarabia e l’Ucraina (vi vedemmo<br />
giungere le avanguardie del nostro Csir;<br />
Malaparte commentò: “Quanti di questi<br />
ragazzi non vedranno mai più l’Italia!”), Malaparte<br />
ed io ritornammo in Romania, quindi in<br />
Italia, ma solo per ritrovarci, pochi mesi dopo,<br />
in Finlandia. Curzio sapeva che i finnici attribuiscono<br />
la loro notoria efficienza fisica<br />
anche alla sauna, quindi la praticava con un<br />
preciso scopo; la praticava, ovviamente,<br />
nudo. (Atrettanto, il sottoscritto). Alto, atletico,<br />
bello, nonché narcisista, del nudismo Malaparte<br />
si compiaceva. Peraltro non superava<br />
certi limiti, tant’è vero che faceva uso di pillole<br />
a base di tiroide per consumare di più e<br />
così attenuare certi desideri: perché - diceva<br />
lui - “ogni volta che vai con una donna è un<br />
giorno di meno che si vive”.<br />
Scoprii che era superstiziosissimo: bastava<br />
nominargli un presunto iettatore per farlo<br />
passare dalla gaiezza alla serietà e magari<br />
all’ira. Egocentrico, costantemente preoccupato<br />
di sé medesmo, avrebbe voluto che<br />
molta gente, il più possibile, si occupasse<br />
costantemente di lui. In Finlandia gli capitò di<br />
dover essere operato di appendicite, con una<br />
degenza lunghetta, ma non so a che cosa<br />
egli desse più peso, se alla minaccia di<br />
complicazioni o al fatto che molti amici lo visitavano,<br />
facendo salotto attorno a lui. Di fronte<br />
a quegli amici gli chiesi: “Perché hai voluto<br />
chiamarti Malaparte?” Risposta: “Perché di<br />
Bonaparte ce n’era già uno”. Risate, complimenti,<br />
strette di mano.<br />
Un episodio di Kaputt<br />
nato da uno scherzo<br />
Durante un acquisto in un negozio di Helsinki<br />
mi rammentai della sensibilità zoofila di<br />
Curzio (in Ucraina lo avevo visto portare<br />
bracciate d’erba a un gruppo di cavalli feriti,<br />
e più volte lo avevo sentito parlare in modo<br />
patetico del suo cane Febo, malato a Capri),<br />
per cui cedetti alla tentazione di chiedergli se<br />
gli piacesse una certa pelle.<br />
Lui la palpò, mi domandò di che cosa fosse.<br />
“Di cane”, risposi. Lui ebbe un sussulto, impallidì,<br />
mormorò che uno scherzo simile non glielo<br />
avrei dovuto fare. Riconosco il mio torto, io<br />
stesso sono zoofilo, e come!, peraltro lo scherzo<br />
servì a Curzio per imbastire, in Kaputt, un<br />
episodio sul presidente della Finlandia, che a<br />
suo dire avrebbe calzato guanti di pelle di<br />
cane. Curzio, insomma, di tutto ciò che potes-<br />
Sopra,<br />
convoglio<br />
di cavalli<br />
feriti,<br />
diretti a un<br />
ospedale<br />
veterinario<br />
tedesco.<br />
Curzio<br />
Malaparte<br />
porta<br />
una<br />
bracciata<br />
d’erba<br />
a quei<br />
cavalli.<br />
(Ucraina,<br />
estate<br />
1941).<br />
se tornargli utile nulla perdeva, di fronte al<br />
tornaconto il naso non lo arricciava mai.<br />
In Finlandia seguii sistematicamente tutti i<br />
fronti, dall’oceano Artico alla Lapponia ai<br />
laghi Onega e Ladoga e infine a Leningrado.<br />
Quest’ultimo fronte interessava Malaparte<br />
più d’ogni altro, perché lui contava di entrare<br />
a Leningrado con le truppe finno-germaniche<br />
vittoriose, lui - come del resto il sottoscritto<br />
- a Leningrado c’era già stato, per cui<br />
ben sapeva quali irresistibili servizi se ne<br />
sarebbero potuti trarre. Ma - chiederà il lettore<br />
-, se Malaparte contava sulla caduta<br />
dell’ex capitale zarista, credeva dunque nella<br />
vittoria germanica globale? A mio avviso, nel<br />
periodo positivo di El Alamein e della massima<br />
penetrazione tedesca in Russia, la risposta<br />
è sì. In quel periodo, infatti, Malaparte già<br />
lavorava a Kaputt. Ma a un altro Kaputt: quello,<br />
appunto, della vittoria dell’“Asse Roma -<br />
Berlino”. A Helsinki, nella sua stanza - la 213<br />
- dell’albergo Torni, dove anche Elena ed io -<br />
alla 313 - alloggiavamo, mi disse: “Ho trovato<br />
il titolo per il mio nuovo libro. Lo chiamerò<br />
God shave the king. Capisci? Non save, ma<br />
shave. Dio non può più salvare il re britannico:<br />
Dio, tutt’al più, gli fa la barba...”<br />
Malaparte lasciò la Finlandia per Roma i<br />
primi di novembre del 1942, una o due settimane<br />
dopo di me, recando tranquillamente<br />
in valigia il testo di God shave the king. Fra<br />
le pagine che me ne aveva letto, alcune<br />
contenevano, fra l’altro, un giudizio positivo<br />
sul conto di Frank, governatore generale<br />
tedesco della Polonia, e i tedeschi le avrebbero<br />
certo gradite.<br />
Ma, siccome nel frattempo le sorti della guerra<br />
vanno capovolgendosi, viene capovolto<br />
anche il libro, per cui God shave the king,<br />
antinglese, diventa Kaputt, antitedesco.<br />
Siccome, però, a Malaparte dispiace di<br />
rinunciare all’indubbia trovata del God shave<br />
the king, egli intitola così un capitolo di<br />
Kaputt; solo che il sovrano del capitolo non è<br />
più Giorgio VI d’Inghilterra ma... Frank!, il<br />
quale si rade con sterco fatto sapone. Pochi<br />
mesi prima, Malaparte s’era vantato con me<br />
di trarre lauti frutti dalla sua collaborazione<br />
ad importanti riviste germaniche, ovviamente<br />
naziste. Né aveva esagerato.<br />
Malaparte ed io, dopo l’ottobre 1942 - data<br />
della nostra separazione in Finlandia - non ci<br />
vedemmo per undici anni. Poi, nel giugno<br />
1953 terminata una sua trasmissione televisiva<br />
negli studi Rai di Milano e ricevuta una mia<br />
telefonata, venne a trovarmi nella mia abitazione<br />
milanese di viale Andrea Doria. Non<br />
ruscii, quella volta, a fare con Malaparte un<br />
giro d’orizzonte politico, ma egli me ne fornì<br />
ugualmente un cospicuo spunto, basato sulla<br />
rivolta operaia di quei giorni, a Berlino Est,<br />
contro i sovietici. Già alla televisione - fra gli<br />
altri protagonisti della serata, Carlo De Martino<br />
e Marise Ferro -, Malaparte ne aveva<br />
Fotografie<br />
di Lino<br />
Pellegrini<br />
Sopra,<br />
Curzio<br />
Malaparte<br />
ritorna<br />
dalla Cina.<br />
Ha gravi<br />
disturbi<br />
alle vie<br />
respiratorie.<br />
sottolineato il significato gravissimo; a tu per<br />
tu, se ne mostrò sconvolto come da una rivelazione.<br />
Concluse: “La Russia vive e ti vince<br />
se la colpisci al cuore; invece s’inginocchia<br />
se le pungi la pelle. Vedi, cent’anni fa, in<br />
Crimea. Berlino, oggi, non è che il primo<br />
sintomo”. Ci indovinò, con un anticipo di quasi<br />
quarant’anni. Comunque il Malaparte del<br />
1953 mi parve molto lontano da quello del<br />
1941 e del 1942. E però, dopo la rivolta<br />
ungherese del 1956, ecco Malaparte compiere<br />
in Cina il suo ultimo viaggio. Che gli porge<br />
il destro di scrivere - vedi Io in Russia e in<br />
Cina - esaltando Mao ed ignorando totalmente<br />
le sofferenze del popolo cinese. Poche<br />
settimane più tardi, Curzio riceverà la tessera<br />
del Pci. Ed anche quella del Pri. Critiche implicite,<br />
le mie? Può darsi. Ma tengo a dire con<br />
chiarezza che Malaparte è stata la persona<br />
più intelligente che io abbia conosciuto. E<br />
della nostra amicizia mi faccio un vanto.<br />
L’8 aprile 1957, visito Curzio nella clinica<br />
Sanatrix, a Roma. Malaparte giace a letto, affilato,<br />
grigio, pieno di cancro. È felice di vedermi,<br />
ma, cessata l’azione degli stupefacenti,<br />
soffre. Il dolore, tuttavia, non gli attenua l’intelligenza,<br />
né la vanità. Quanto all’intelligenza,<br />
Curzio, pur conscio del suo male, mi parla non<br />
già di cancro ma di “tumore tubercolare”, per<br />
non mettermi troppo in imbarazzo, ossia per<br />
rendere possibile la conversazione.<br />
La vanità, invece, me la dimostra in vari modi,<br />
ecco qui. A Renato Angiolillo, direttore de Il<br />
Tempo, che gli telefona per avere notizie,<br />
Curzio risponde: “Sono qui con Lino Pellegrini,<br />
è venuto da Milano apposta per vedermi”.<br />
(Ma no, gli avevo spiegato chiaramente che<br />
mi trovavo a Roma perché in transito, alla<br />
volta del Congo Belga). Con me, continua:<br />
“Anche Fanfani è venuto a trovarmi”. Pausa.<br />
“E anche Togliatti”. (Polivalente sino all’ultimo,<br />
mi vien fatto di pensare). Tace, riprende fiato.<br />
“Il Papa... il papa ha fatto chiedere di me per<br />
telefono; ha detto di sapere che sono un’anima<br />
buona”. Il Papa? Un’anima buona?! In<br />
passato avevo conosciuto un Malaparte<br />
nazionalista e filoproletario, liberale e antiborghese,<br />
fascista e antinazista, aristocratico e<br />
mangiapreti: tutto, insomma, salvo che un<br />
Malaparte credente o tanto meno cattolico,<br />
benché portasse al collo una crocettina,<br />
donatagli, quand’era bimbo, dalla madre.<br />
Quindi, vanitose o meno che fossero, alle<br />
sue parole pronunciate sul letto di morte<br />
trasecolavo; ma mi resi conto della schiettezza<br />
della conversione quando Curzio,<br />
parlando del suo ritorno dalla Cina e dello<br />
sbarco all’aereoporto di Ciampino, mi disse<br />
con serietà, anzi con profondità, che a<br />
tenerlo in piedi era stato Gesù. Gesù... e,<br />
sul comodino della sua stanza alla Sanatrix,<br />
una immagine della Madonna. Gesù e<br />
la Madonna significavano, peraltro, l’ineluttabilità<br />
della fine di Curzio. Ad appena<br />
cinquantanove anni.<br />
«Stupido fascista»<br />
o difensore di ebrei?<br />
Somalia, luglio 1957. Sto volando con mia<br />
moglie Elena da Mogadiscio alla volta della<br />
remota Migiurtinia. Ci portano i giornali,<br />
appena giunti dall’Italia. Notizia: il pomeriggio<br />
del 19 luglio, Curzio Malaparte è mancato.<br />
Oggi, a quarantasei anni dalla tua scomparsa,<br />
consentimi, Curzio, una domanda<br />
maligna. Se la guerra l’avesse vinta l’“Asse<br />
Roma - Berlino”, tu, in Kaputt - anzi, in God<br />
shave the king, avresti continuato a definirmi<br />
“stupido fascista”, o mi avresti esaltato senza<br />
riserve, quale difensore di ebrei? No, non mi<br />
pento, non faccio ammenda della malignità.<br />
Per cui ti dico: nel 1991, quando Elena ed io<br />
siamo tornati a Jasci, ti abbiamo pensato più<br />
e più volte. E un giorno, nelle alture della tua<br />
Prato, proprio sulla vetta dello Spazzavento,<br />
dinanzi alla tua tomba ci rivedremo.<br />
Lino Pellegrini<br />
13
Gli esordi, i successi<br />
e l’insegnamento di un mancato<br />
ingegnere che ha “raccontato”<br />
attraverso sensazionali immagini<br />
fatti di cronaca e personaggi<br />
del mondo dello spettacolo<br />
e della politica<br />
di Alessandro Perna<br />
“Brigitte Bardot? Una ragazza da fiaba”.<br />
Così esordisce il fotoreporter Giancolombo<br />
in una intervista di un vecchio giornale in cui<br />
racconta il servizio esclusivo sull’attrice che<br />
realizzò a Cortina per Paris Match nel 1958.<br />
“Quando devo definire qualcosa di eccezionale<br />
e bello penso sempre alle fiabe <strong>dei</strong><br />
bambini, alle fate che appaiono improvvisamente<br />
nei boschi. Brigitte Bardot era così!”<br />
Una fata che gli apparve improvvisamente<br />
sul gran vialone dell’albergo Miramonti a<br />
Cortina.<br />
Con Brigitte Bardot aveva un feeling e un’intimità<br />
tutta speciale. Perché Giancolombo<br />
sapeva quale classe distingueva un semplice<br />
paparazzo da un grande fotoreporter. Lui<br />
regalava fiori mentre gli altri si accalcavano<br />
vocianti e sgomitando per rubare immagini.<br />
La prima volta che incontrò B.B. fu a<br />
Cannes. Era stato Vadim a presentargliela,<br />
allora inviato di Paris Match, giornale di cui<br />
Giancolombo era corrispondente dall’Italia.<br />
La carriera di lei era ancora tutta all’inizio e<br />
per nulla sicura. “Come si dice, era una<br />
splendida starlet che cercava di farsi notare”.<br />
Del loro primo incontro 4 anni prima<br />
Giancolombo tiene ancora delle immagini:<br />
B.B. ha in mano una Leica - che lui gli aveva<br />
prestato - con cui si diverte sulla spiaggia a<br />
giocare alla fotoreporter.<br />
“Va a Cortina – gli dissero quelli di Paris<br />
Match quel giorno - lei arriverà per riposarsi.<br />
E ti cercherà”. Avrebbe viaggiato con Paul<br />
Chaland, redattore del giornale, la sua<br />
controfigura e la sorella. Giancolombo partì<br />
subito per l’Hotel Miramonti, dove avrebbe<br />
soggiornato tutta la compagnia. Il giornale<br />
racconta che quando la incontrò rimase<br />
senza fiato. B.B. era vestita in nero. Esile e<br />
bellissima. “Si capisce subito perché un’attrice<br />
ha successo, e la sua controfigura per<br />
esempio pur assomigliandole non ne avrà<br />
mai” fu il pensiero di Giancolombo. È una<br />
questione di sfumature, di sguardi, di eleganza.<br />
“Insomma tutta un’altra cosa”. Fosse<br />
L’inizio della carriera<br />
Tutto era cominciato 10 anni prima. Dopo il<br />
liceo classico a Venezia Giancolombo era<br />
destinato all’università - ingegneria: “ci<br />
mancherebbe altro”. Erano tutti una famiglia di<br />
ingegneri: nonno, padre, e ora lui il nipote.<br />
Questione di tradizione. Era il tempo del fascismo,<br />
gli anni in cui il mondo andava incontro<br />
alla seconda guerra mondiale. Aveva appena<br />
cominciato a frequentare quando gli dissero:<br />
“Giancolombo! Classe 1921, tu sei volontario<br />
universitario e vai a Treviso”. “Chi? io?”. Non ci<br />
fu niente da fare: abile e arruolato. Tre mesi<br />
dopo era prima in Albania sergente d’artiglieria<br />
di montagna, e poi in Francia sulla costa,<br />
sottotenente sempre d’artiglieria negli alpini.<br />
Davanti aveva ancora l’8 settembre, un anno<br />
di campo di concentramento in Polonia prigioniero<br />
<strong>dei</strong> tedeschi, e un dito portato via dall’esplosione<br />
di un proiettile mentre era ufficiale<br />
armaiolo di stanza a Rapallo. Congedato<br />
perché disabile, tornò a Venezia a riprendere<br />
da dove aveva smesso: la facoltà di ingegneria.<br />
Il padre naturalmente lo voleva laureato.<br />
Ma non è che a Giancolombo riuscì bene di<br />
applicarsi allo studio. L’esperienza della guerra<br />
si fece sentire.<br />
“A Milano mio cugino Luciano Emmer mi diede<br />
una mano”. Dopo avergli offerto una breve<br />
esperienza nella produzione di film “mi<br />
presentò al direttore di un settimanale comunista<br />
stampato presso il Corriere della Sera.Mi<br />
misero in mano una Leica e mi spedirono a<br />
INTERVISTA AL GRANDE FOTOGRAFO<br />
Il mito<br />
Giancolombo<br />
stato il primo servizio che faceva su di lei era<br />
logico che rimanesse colpito. “Macché! L’avevo<br />
fotografata quattro anni prima a Cannes,<br />
l’avevo ritratta a Parigi, eravamo in un certo<br />
senso amici, fin dai tempi di Vadim. Eppure<br />
quella sera mi girava in corpo una strana<br />
sensazione”. Quando lei gli fu davanti e gli<br />
strinse la mano era triste, aveva gli occhi<br />
vaghi e lontani, un po’ rossi. “Occhi che potevano<br />
avere pianto” ricorda il fotografo.<br />
E non era improbabile. Era venuta a Cortina<br />
in uno <strong>dei</strong> suoi momenti più difficili. Cosa<br />
fosse successo del suo ultimo idillio con<br />
Gilbert Bécaud, cantante famoso dell’epoca,<br />
non si sapeva di preciso, ma di certo bene<br />
non era finito. Si diceva perfino che a Parigi<br />
avesse tentato di inghiottire qualche pastiglia<br />
di sonnifero. “Per fortuna, tentato o no il<br />
suicidio, ora era viva davanti a me”, in mezzo<br />
agli ospiti del grande salone un po’ antico del<br />
Miramonti. La gente intorno parlava fitto. Ma<br />
era come non ci fosse. Brigitte gli diede la<br />
mano e non parlò. Lui non le disse subito<br />
che era lì per lavoro, proprio per fotografare<br />
lei. Non aveva voglia di entrare subito nel<br />
suo ruolo. “Fu per questo forse, che si creò<br />
tra noi un’atmosfera diversa dal solito che<br />
durò per tutto il suo soggiorno”.<br />
Era un incanto nel suo vestito da sera.<br />
Presto, si formò un capannello di gente<br />
tutt’intorno: gli altri ospiti ci avevano messo<br />
poco a capire chi fosse. E di sicuro non<br />
erano i fan quelli che mancavano a B.B., che<br />
fossero donne o uomini. Lui capì che voleva<br />
liberarsi di quella gente, e che gli chiedeva<br />
di fare qualcosa. La prese per un braccio e<br />
l’accompagnò fuori. “Salimmo in macchina e<br />
andammo a ballare al Cristallo. Danzammo<br />
insieme in mezzo alla più aristocratica gente<br />
di Parigi, Milano e Roma. Ma lei voleva ballare<br />
solo con me. Non si fidava degli altri in<br />
quel momento”. L’indomani mattina fu lei a<br />
svegliarlo con una telefonata. Giancolombo<br />
aveva già fissato il programma. Era riuscito<br />
ad ottenere in esclusiva tutto il palazzo del<br />
ghiaccio, un’esclusiva assoluta. Giura che si<br />
sentiva fuori dal suo mestiere mentre le scattava<br />
foto su foto. Gli pareva che stesse<br />
facendo tutto per arricchire un suo album<br />
personale di ricordi. “I cinque giorni passarono<br />
in quest’atmosfera di curiosa intimità”.<br />
Così racconta il giornale. E se si domanda<br />
ancora oggi a Giancolombo come andarono<br />
esattamente le cose, lui ti risponde che la<br />
cronologia degli eventi non era proprio<br />
rispettata. E che un po’ di romanzo sul loro<br />
incontro a Cortina e sulla successiva permanenza<br />
il giornalista l’aveva fatto. Allora le<br />
tinte forti andavano di moda. Ma era vero<br />
dell’affettuosa amicizia e della stima reciproca<br />
che provavano l’una per l’altro, al di là del<br />
piano professionale. Come era vero che B.B.<br />
era una donna bellissima, con un fascino<br />
tutto speciale che era difficile ignorare.<br />
“Dopo il servizio allo stadio, Bredo, il proprietario<br />
del più famoso negozio di Cortina di<br />
abbigliamento ci invitò da lui. E B.B. si divertì<br />
a provare gran parte del campionario del<br />
negozio” ricorda adesso Giancolombo. È<br />
un’altra esclusiva. Poi tutti insieme nelle<br />
cucine dell’Hotel Ancora, nello stesso edificio,<br />
così il costante assedio <strong>dei</strong> fotografi<br />
poteva essere evitato. Altro giro, altra esclusiva.<br />
Non poteva andare sempre così bene.<br />
“Spesso trovavamo l’auto con le gomme<br />
sgonfiate - infatti - perché i miei colleghi<br />
erano veramente infastiditi dal fatto di non<br />
poter mai scattarle neanche una foto. E<br />
perciò si vendicavano così con noi e con<br />
me”. C’era da capirli.<br />
Il giorno dopo B.B. volle andare su al passo<br />
del Falzarego. Quella era una brutta mattina.<br />
Era nervosa, cominciava a sentirsi<br />
addosso tutta quell’attenzione in un momento<br />
così difficile. Ci voleva un’idea, uno stratagemma,<br />
uno di quelli buoni. “Facemmo partire<br />
una macchina con la sua controfigura<br />
perfettamente camuffata. Ci cascarono tutti.<br />
Noi la nascondemmo in un’altra auto e ce ne<br />
andammo per i fatti nostri su al passo”. A<br />
B.B. Giancolombo chiedeva sempre il<br />
permesso prima di fotografarla. Questi erano<br />
i patti. E lei poteva dire di sì o di no. Al Falzarego<br />
era tesa come una corda di violino e<br />
non aveva voglia di farsi riprendere, nemmeno<br />
da lui. “Perciò di foto se ne fecero poche”.<br />
Ma così andava fatto, perché se lei non vole-<br />
fare interviste agli operai negli stabilimenti”.<br />
Ritrovò uno <strong>dei</strong> suoi cugini, Claudio Emmer, in<br />
via Bagutta dove aveva uno studio. Claudio gli<br />
cedette una stanza in cambio di assistenza<br />
per i servizi fotografici che stava realizzando al<br />
Teatro alla Scala. “Cominciai così l’attività di<br />
fotografo per conto mio. Poi mi capitò di andare<br />
a Venezia. C’era un circo allestito in piazza<br />
San Marco. Mi affascinò l’idea”. Il risultato fu<br />
una foto con in primo piano <strong>dei</strong> cavalli durante<br />
un numero con lo sfondo della basilica.<br />
Giancolombo preferisce la destra alla sinistra:<br />
è per questo che pensò di offrire quelle foto di<br />
Venezia al Corriere Lombardo. Gliele pubblicarono<br />
e gli fecero pure i complimenti: fu la<br />
prima volta da libero professionista. “Poi,<br />
incontrai il direttore del giornale ad una cena<br />
in via Bagutta. Allora era ritrovo di giornalisti,<br />
artisti ed dell’intellighenzia modaiola di Milano.<br />
Il fotografo Patellani - quello che diventerà<br />
famoso - se n’era andato, e lui aveva di che<br />
lamentarsi - a suo dire - per essere stato<br />
lasciato così su due piedi”. Giancolombo gli<br />
offrì i suoi servigi. Il giorno dopo gli diedero due<br />
Leica in prestito e 20.000 lire al mese. Lui fece<br />
il resto: si procurò un impermeabile e un<br />
cappello a tese larghe, come allora andava di<br />
moda. E poi mise le mani su una moto <strong>dei</strong><br />
paracadutisti americani - un bidé come veniva<br />
chiamata, perché di piccolissime dimensioni<br />
per poter essere trasportata e paracadutata<br />
più facilmente. “E così combinato me ne andavo<br />
a caccia di fotografie”.<br />
Nel 1948 i comizi politici non si contavano:<br />
c’erano le prime elezioni libere italiane dai<br />
va, Giancolombo non la fotografava. Era<br />
anche per questo che andavano d’accordo.<br />
“Poi venne l’ultimo giorno, bisognava ripartire.<br />
Lei alla volta della Francia, di Parigi, e io<br />
per Milano. I rullini andavano sviluppati ed<br />
inviati in fretta Oltralpe”. Si lasciarono con<br />
quel tenero e cameratesco abbraccio che a<br />
volte lei distribuiva con disinvoltura agli amici.<br />
Il vecchio giornale racconta che rimasero<br />
fermi un istante prima di separarsi. Poi lei gli<br />
disse: “au revoir cherie”. La favola era finita.<br />
Brigitte Bardot la fotografò Giancolombo, e a<br />
nessuno dell’agenzia fotostampa di cui era<br />
proprietario avrebbe mai permesso di riprenderla<br />
al suo posto a meno di insormontabili<br />
impedimenti. Sophia Loren, Raf Vallone,<br />
Alberto Sordi, Claudia Cardinale, Clark<br />
Gable, Sylva Koscina e tutti i divi del periodo<br />
della Dolce Vita, a Cortina o altrove, potevano<br />
essere anche ripresi dagli altri fotografi<br />
della sua scuderia. Ma lei era una tutta un’altra<br />
storia. E di altri bravi fotografi tra le fila di<br />
Giancolombo - oltre a lui, al maestro - ce<br />
n’erano parecchi, perché la sua era una<br />
delle agenzie più importanti d’Italia. Fotografi<br />
tanto bravi da fare, allora e successivamente,<br />
la storia del fotogiornalismo nella<br />
penisola. E da rendere l’agenzia di Giancolombo<br />
nel periodo tra i primi anni ‘50 e la fine<br />
degli anni ‘60 un punto di riferimento per<br />
tutta l’editoria del nostro paese e per molta<br />
di quella straniera.<br />
L’aveva fondata col nome di “Giancolombo<br />
News Photos” nel 1949. Dopo i primi successi<br />
la rivista francese Paris Match gli aveva<br />
chiesto le corrispondenze per il Nord Italia.<br />
Nel contempo le maggiori agenzie estere<br />
avevano cominciato ad inviargli servizi da<br />
ogni paese, portando la Giancolombo in<br />
breve al massimo del suo sviluppo. Non si<br />
contano i giornali che ebbe per clienti: Europeo,<br />
Tempo, Panorama, Settimo Giorno,<br />
Oggi, Gente, Grazia, Epoca, Visto, Le Ore di<br />
Salvato Capelli. E all’estero a Paris Match se<br />
ne aggiunsero presto molti altri tra i più<br />
importanti dell’epoca: Life, Picture Post,<br />
Schweizer Illustriert, Stern, Jours de France,<br />
Daily Express.<br />
tempi del fascismo. C’era De Gasperi quel<br />
giorno in piazza Duomo ad arringare le folle.<br />
“E pioveva che Dio la mandava. Ebbi l’idea di<br />
arrampicarmi alle spalle del palco e di fotografare<br />
quella distesa di ombrelli tenuti su da chi<br />
lo stava ascoltando. Facevano impressione”.<br />
Aveva avuto il colpo di genio: la foto finì in<br />
prima pagina e la United Press gli comprò il<br />
negativo per 10.000 lire, spedendola ai giornali<br />
di tutto il mondo. Partì così la collaborazione<br />
con una delle più importanti agenzie<br />
fotografiche del mondo: lui gli faceva le fotografie<br />
in Lombardia e a Milano e loro le distribuivano<br />
in America. Di soldi però non ne giravano<br />
molti. A dormire se ne andava in un<br />
sottoscala di via della Spiga, quando ancora<br />
era una roba da squattrinati. E lì, solo con del<br />
legno trovato in giro, era riuscito a costruirsi<br />
una camera oscura.<br />
“Una mattina me ne stavo andando all’Innocenti<br />
a convincere l’ufficio stampa a consegnarmi<br />
una Lambretta. Passai davanti al<br />
Dazio, che era tutto un trambusto: il doganiere<br />
capo era impazzito e sparava a chiunque<br />
si avvicinasse. E io che feci? Mi avvicinai”. Per<br />
forza. Riuscì a fotografarlo con la pistola in<br />
mano da una finestra del cortile. La carriera<br />
cresceva: il giorno dopo 6 foto di spalla con<br />
tanto di elogi in prima pagina sul Corriere<br />
Lombardo. E naturalmente un soprannome,<br />
uno <strong>dei</strong> tanti che avrà.. “Lambretta! - urlavano<br />
alle mie finestre da quel giorno gli incaricati<br />
del Corriere Lombardo quando passavano<br />
per chiamarmi”. Allora erano in pochi a<br />
permettersi un telefono.<br />
14 ORDINE 1 <strong>2004</strong>
Il Dopoguerra<br />
con ironia<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
Il caso Rina Fort<br />
Uno <strong>dei</strong> primi servizi che incisero di più sulla<br />
sua professione fu il caso Caterina Fort, una<br />
friulana conosciuta come Rina. “La signora<br />
aveva una relazione con un uomo, un catanese<br />
di nome Pippo Ricciardi. Peccato che il<br />
Ricciardi fosse sposato e che lei non lo sapesse”.<br />
Neanche <strong>dei</strong> bambini sapeva nulla. Erano<br />
tre e tutti piccoli, più uno in arrivo e quasi giunto<br />
a destinazione. Quando lei lo scoprì impazzì<br />
letteralmente, trasformandosi in una belva<br />
assetata di morte - così raccontarono i giornali.<br />
Si recò a casa dell’amante assente e uccise<br />
la moglie e i tre bambini a colpi di bastone. A<br />
scoprirli fu Pina Somaschini, commessa del<br />
Ricciardi che in quei giorni si trovava appunto<br />
fuori Milano. Giancolombo era all’inizio della<br />
carriera e la cronaca nera, bianca o rosa che<br />
fosse era il suo pane quotidiano.<br />
“L’imperativo del momento era arrivare sul<br />
luogo del delitto prima degli altri. E naturalmente<br />
eludere ogni divieto che limitasse la<br />
possibilità di fare foto. Giocoforza che il nostro<br />
fosse spesso un mestiere rocambolesco, in cui<br />
si sviluppava il gusto della sfida, e che si creassero<br />
leggende e miti che agli stessi fotografi<br />
piaceva alimentare”. Lui nascose la macchina<br />
fotografica in tasca. E si presentò sul luogo del<br />
delitto come fosse lì un po’ per caso. Gli riuscì<br />
bene: lo fecero entrare. Una volta dentro era<br />
talmente sconosciuto e male in arnese che<br />
quelli della polizia lo scambiarono per uno di<br />
loro, qualcuno mandato dalla scientifica a fare<br />
le foto del delitto. Tanto che tutti si fecero in<br />
quattro per assecondare quel giovanotto che<br />
sembrava così inesperto. “Le fotografie del<br />
massacro furono pubblicate in prima pagina<br />
dal Corriere Lombardo del 1° dicembre 1946.<br />
La polizia scientifica non apprezzò la beffa, e<br />
ci mise un attimo a sequestrare i negativi”. Ma<br />
ormai era fatta e Giancolombo aveva ottenuto<br />
una delle sue prime e più famose copertine.<br />
Il colpo Bellentani<br />
Il colpo della Bellentani andò invece così: “La<br />
mattina del 16 settembre 1948, mentre ero<br />
ancora nelle braccia di Morfeo una telefonata<br />
mi raggiunse a casa svegliandomi di soprassalto”.<br />
“Gian corri subito stanno sfasciando<br />
l’agenzia” gli urlarono nella cornetta. “Che<br />
stava succedendo? Erano i redattori e i capiredattori<br />
<strong>dei</strong> giornali che si stampano a Milano,<br />
letteralmente impazziti”. È che a Giancolombo<br />
era capitato il colpaccio che succede<br />
una volta nella vita: il caso Bellentani. E gli era<br />
capitato senza neanche volerlo. Così per caso,<br />
perché il destino l’aveva voluto.<br />
Nel laboratorio era in corso una furibonda lotta<br />
all’ultimo fotogramma. “Oggetto del contendere<br />
erano <strong>dei</strong> negativi. Uno in particolare schizzava<br />
di mano in mano”. Era quello che valeva<br />
una fortuna. L’asta fu aperta a colpi di centomila.“Calma,<br />
che diavolo!”. Ci voleva della calma.<br />
“Quando ebbi zittito quei signori, finalmente mi<br />
fu consegnata la negativa. Peccato che era<br />
andata distrutta: impronte, graffi e sgualciture”<br />
racconta Giancolombo. A salvare tutto fu il<br />
provvido assistente di turno del laboratorio che<br />
ne aveva fatta una stampa. Quella era la foto<br />
di Pia Bellentani, poco prima che uccidesse a<br />
rivoltellate l’industriale e suo amante Carlo<br />
Sacchi ad una serata di gala a Como.<br />
“Da quella fotografia dipese il mio futuro” di<br />
fotografo, naturalmente. “Il settimanale Tempo<br />
ne fece la copertina. Il Corriere Lombardo la<br />
pubblicò in grande nella prima pagina, giornali<br />
di tutto il mondo me la chiesero. Mi fruttò la più<br />
alta cifra che fosse stata mai pagata fino ad<br />
allora in Italia per un singolo fotogramma. Fece<br />
conoscere il mio nome, mi permise di fare<br />
investimenti e di allargarmi”. Chi l’avrebbe<br />
detto che la foto di una signora di cui non gli<br />
importava nulla avrebbe fatto la sua fortuna. E<br />
La Dolce Vita a Cortina nelle immagini dell’archivio Giancolombo<br />
Una mostra fotografica che fissa gli istanti più affascinanti di<br />
un periodo indimenticabile è stata esposta nei locali del<br />
Vecchi Municipio a Cortina d’Ampezzo. Brigitte Bardot sui<br />
pattini allo Stadio Olimpico, Clark Gable all’Hotel Miramonti,<br />
Alberto Sordi al Rifugio Faloria sul set di Vacanze d’Inverno.<br />
Cinquanta immagini d’epoca in esposizione e ottanta nel<br />
libro che è stato edito per l’occasione.<br />
È veramente stato un caso che il comune della località forse<br />
più famosa ed esclusiva abbia voluto creare un evento nel<br />
suo agosto affollato, proponendo ai suoi ospiti una carrellata<br />
<strong>dei</strong> personaggi importanti che vi sono passati; un caso<br />
perché Giancolombo frequenta Cortina da 75 anni, la conosce<br />
e la ama. Ha quindi tratto dal suo archivio di fotogiornalismo<br />
una selezione di immagini che è stata anche un omaggio<br />
personale.<br />
Cortina è cambiata: in difetto, a sentire chi rimpiange i decenni<br />
passati con sentimentale mancanza di obiettività. In eccesso,<br />
a sentire invece chi cerca la purezza della montagna e<br />
della natura e depreca il traffico. Ma è indubbio che lo spirito<br />
della Conca non è cambiato e che ancora aleggiano nell’aria<br />
Sophia<br />
Loren danza<br />
con Raf<br />
Vallone,<br />
1956.<br />
frizzante il carattere mondano e la fierezza di viverlo. Il grande<br />
libro posato su un tavolino all’ingresso ha ricevuto le firme<br />
e i commenti <strong>dei</strong> visitatori che non sono riusciti a trattenere<br />
entusiasmo. Scorrendone le pagine, le parole di chi voleva<br />
semplicemente esprimere il proprio apprezzamento per la<br />
qualità delle immagini, appassionati di fotografia che amano<br />
i tagli di luce, la composizione, il contrasto del bianco e nero;<br />
oppure di coloro che avevano rispolverato la propria passione<br />
per la Bardot o per Buscaglione, l’ammirazione per<br />
Montanelli o per D’Inzeo. Spiccavano le frasi di coloro che a<br />
Cortina a quei tempi c’erano e ricordavano nostalgici una<br />
Dolce Vita di cui erano stati testimoni e a volte protagonisti;<br />
ma fra tutti i commenti, i più importanti erano quelli di coloro<br />
che per l’età non hanno vissuto il periodo che tutti rimpiangono.<br />
Le immagini di Giancolombo hanno dato soprattutto a<br />
costoro il senso di un passato affascinante e hanno ristabilito<br />
un volto di Cortina che fa parte della sua seduzione.<br />
La mostra ritornerà in esposizione per il pubblico di Bologna<br />
nel gennaio <strong>2004</strong>, a Palazzo D’Accursio in Piazza Maggiore.<br />
Susanna Colombo<br />
Brigitte<br />
Bardot<br />
sulla pista<br />
di curlng<br />
dell’Hotel<br />
Miramonti,<br />
1958.<br />
Alberto<br />
Sordi<br />
sul set<br />
di Vacanze<br />
d’Inverno<br />
di Camillo<br />
il suo nome. “Io non ci volevo andare alla sfilata<br />
di Villa d’Este della Biki” racconta Giancolombo.<br />
La Biki era la sarta dell’aristocrazia<br />
milanese. Come si faceva a dire di no alla Biki.<br />
“La sfilata era fatta in contemporanea con Dior,<br />
presentava anche lui <strong>dei</strong> nuovi modelli. Era<br />
una serata importante, non potevo dirle di rivolgersi<br />
a qualcun altro”.<br />
Al centro c’era la passerella, ai lati i tavoli per<br />
gli ospiti, e tutt’intorno una splendida sala<br />
settencentesca. E naturalmente ovunque tanta<br />
bella gente: il barone Rothschild, la principessa<br />
d’Alemberg, uno zio di Faruk, che allora era<br />
ancora re. E il fior fiore della nobiltà e dell’industria<br />
lombarda. La Biki sapeva come si faceva<br />
il suo mestiere. “Presi la speedgraphic, tenuta<br />
insieme con i cerotti, e cominciai a fotografare<br />
le modelle. Andava tutto bene, quando una<br />
signora, si avvicinò e mi chiese di fotografare<br />
un tavolo”. “No signora, che non le faccio la<br />
foto - le rispose lui - non sono mica di quelli<br />
che vanno di tavolo in tavolo a lasciare bigliettini”.<br />
Certo, che se ne andò, che gli importava.<br />
Anzi a dire il vero era pure un po’ offeso. “Ma<br />
mica smise quella di insistere”.<br />
Era finita la serata, e ci si sentiva bene quando<br />
una serata come quella finiva. Era l’una di<br />
notte e Giancolombo pensava solo ad andarsene.<br />
Quando la signora tornò alla carica:<br />
“Insomma me la fa o no questa benedetta fotografia?”.<br />
E no! Ancora lei!?!. “Che vi devo dire?<br />
Alla fine la feci: una lastra per fare uno scatto<br />
c’era ancora, e una lampadina per il flash<br />
pure”. Salì sulla passerella e fece la foto al<br />
tavolo <strong>dei</strong> tre sconosciuti. “Arrivederci” e se ne<br />
Mastrocinque, andò. Passò un’ora e una di quelle signore,<br />
al Rifugio quella seduta a destra, fece qualcosa che<br />
Col Drusciè, nessuno avrebbe potuto immaginare. Pia<br />
1959. Bellentani si alzò, andò al guardaroba e ritirò<br />
la pistola calibro nove del marito. Lui se l’era<br />
portata perché le precauzioni non sono mai<br />
troppe, e il dopoguerra era felice per pochi. I<br />
gioielli e gli ermellini delle belle signore al<br />
mercato nero valevano una fortuna. “Fu<br />
proprio sotto la stola di ermellino che Pia<br />
Bellentani nascose la pistola”. Quale più<br />
elegante nascondiglio per avvicinarsi al bar e<br />
ammazzare il proprio amante, quel Carlo<br />
Sacchi che l’aveva insultata. Sparò un unico<br />
colpo e l’uomo divenne pallido, barcollò, gli<br />
caddero gli occhiali. Chi intervenne lo adagiò<br />
su un divano. Altri gli si agitarono intorno, ma<br />
era tardi. Uno sparo solo ed era morto. Lei poi<br />
si puntò la pistola addosso e sparò. Ma c’era<br />
un unico proiettile nella calibro 9, ed era già<br />
andato a bersaglio.<br />
La Bellentani da ragazza faceva Pia Caroselli<br />
ed era moglie del conte Lamberto Bellentani,<br />
un modenese conosciutissimo per la produzione<br />
di carni insaccate. Carlo Sacchi, il morto, era<br />
un uomo che si era fatto tutto da sé vendendo<br />
seta. “Nessun fotografo era presente. Nessuno<br />
si era accorto di nulla. E nessuno all’infuori di<br />
me l’aveva fotografata” ricorda Giancolombo.<br />
“Enorme fu lo scalpore, incredibile il numero di<br />
pubblicazioni sui giornali che fece la foto in tutti<br />
i rotocalchi del mondo”. Nel 1971 la fotografia<br />
del delitto Bellentani è citata ancora una volta<br />
dal settimanale Grazia come una delle otto<br />
immagini che hanno fatto epoca, una delle più<br />
famose degli archivi di cronaca nera.<br />
“La prima volta che pubblicarono la foto per un<br />
errore di trascrizione, o forse per semplificazione,<br />
il mio nome venne trasformato da Gian<br />
Battista Colombo in Giancolombo”. Ed è inutile<br />
negare che gli piacque molto. “Lo trovai<br />
bello, caratteristico, perché non dirlo, e soprattutto<br />
facile da ricordare”. Un bel vantaggio per<br />
chi fa questo mestiere. Se aveva avuto ancora<br />
<strong>dei</strong> dubbi fino quel momento sul suo futuro di<br />
fotografo, “perché ero ancora giovane, e mio<br />
padre insisteva con l’ingegneria”, adesso non<br />
ce n’erano più, quella sarebbe stata la sua<br />
strada. Adesso non era più un Gian Battista<br />
Colombo qualunque. Anzi adesso aveva pure<br />
un soprannome: Giancolombo.<br />
15
Sopra a<br />
sinistra,<br />
Indro<br />
Montanelli<br />
a passeggio<br />
per corso<br />
Italia<br />
si ferma a<br />
chiacchierare<br />
con alcune<br />
persone che<br />
lo hanno<br />
riconosciuto,<br />
1961.<br />
A destra,<br />
Habib<br />
Bourguiba<br />
in una via<br />
di Cortina<br />
mentre<br />
il suo<br />
entourage<br />
acquista<br />
alcuni<br />
quotidiani<br />
da un<br />
ragazzo<br />
del luogo,<br />
1960.<br />
Fino ad allora aveva fotografato per diletto e<br />
per snobismo più che per vocazione. Alto,<br />
magrissimo, i capelli biondi, era un po’ l’enfant<br />
gaté dell’aristocrazia e del bel mondo milanese.<br />
“Facevo ritratti alle belle signore dell’alta<br />
società ed ero ricercato per gli avvenimenti<br />
mondani. Mi divertivo moltissimo, girando nei<br />
locali notturni. La gente allora aveva voglia di<br />
divertirsi, di godere della vita dopo la guerra”.<br />
Chi non poteva con poco. Chi invece aveva i<br />
mezzi li sfruttava e se la spassava. Le foto<br />
erano sempre ironiche. Sempre con magnati,<br />
re, attori, cantanti, divi della televisione, principi<br />
e principesse decaduti e non. “Era un<br />
mondo fatuo, che però mi piaceva perché ero<br />
stato in guerra, e non era stata questa gran<br />
allegria la mia giovinezza, come per tutta la<br />
mia generazione”. Era il dopoguerra italiano, e<br />
lui come gli altri ne fu coinvolto. Raffinato e<br />
pieno di spirito Giancolombo era divenuto il<br />
fotografo di questo mondo.<br />
L’impresa di Churchill<br />
Nel 1951, Giancolombo è a Venezia, città che<br />
conosce come le sue tasche. Questa volta<br />
l’obiettivo era di fotografare niente poco di<br />
meno che Churchill, il primo ministro inglese<br />
che aveva sostenuto le sorti dell’Inghilterra<br />
nell’interminabile seconda guerra mondiale. E<br />
Churchill ci teneva a fare il bagno nella bella<br />
Venezia. Considerava il suo tuffo mattutino al<br />
lido un piacere irrinunciabile. Di avvicinarsi a<br />
lui neanche a parlarne, la zona era tutta transennata<br />
e la polizia non faceva passare nessuno<br />
senza controllarlo. Né da terra, né dal mare,<br />
dove le forze dell’ordine si erano attrezzate con<br />
tanto di barchette. “Naturalmente i fotoreporter<br />
erano tutti banditi. Era lì per il festival di Venezia<br />
e tutti sapevano di quell’abitudine. Il luogo<br />
era ben conosciuto: accanto alla diga dell’hotel<br />
Excelsior. E l’ora era sempre la stessa: le<br />
11 di mattina. Tutti i fotografi che avessero con<br />
sé un teleobiettivo sufficientemente potente -<br />
molti avevano <strong>dei</strong> veri e propri cannoni - li<br />
avevano piazzati sui tetti degli alberghi vicini”<br />
ricorda Giancolombo.<br />
Ma niente da fare: lui risultava sempre minuscolo<br />
in ogni inquadratura, malgrado la sua<br />
notevole mole. “Studiai attentamente la situazione<br />
e decisi di travestirmi da turista inglese”.<br />
A Giancolombo per i suoi connotati fisici veniva<br />
bene. L’aveva già sperimentato che il trucco<br />
funzionava: bidonisti e pataccari nelle località<br />
turistiche pensavano sempre fosse un turista<br />
straniero e cercavano di rifilargli ogni volta<br />
fregature. Pantaloni bianchi e camicetta azzurra,<br />
una cravatta dal colore impossibile, scarpe<br />
gialle e occhiali neri, in testa un cappello alla<br />
Jacques Tati. Più anglosassone di così. “La<br />
sera prima mi accordai con il bagnino, che<br />
stava sempre lì di guardia per dare una mano<br />
agli sbronzi che vanno a fare il bagno all’alba.<br />
Gli avevo affidato la mia macchina, una<br />
primerflex con un teleobiettivo di 165 mm.”.<br />
Alle prime luci del giorno così conciato e con la<br />
pipa in bocca se ne andò a far finta di ammirare<br />
il sole sulla spiaggia. I poliziotti intorno riorganizzavano<br />
come ogni mattina la loro rete di<br />
protezione contro fotografi, giornalisti e malintenzionati.<br />
“Un paio di loro mi si avvicinò, e mi<br />
rivolse la parola. Ma io, biascicando con accento<br />
che a loro apparve oxfordiano una serie di -<br />
I’m sorry, non capire, I don’t understand, excuse<br />
me - li convinsi della mia origine anglosassone”.<br />
Il bagnino gli venne in soccorso, tanto si<br />
erano già messi d’accordo. “Cossa perdè<br />
tempo” disse “El xe un po mato. El passa il<br />
tempio a vardar le onde”. Fu piuttosto convincente.<br />
E i poliziotti decisero di lasciare perdere.<br />
Cento metri di distanza avevano proclamato<br />
ordini severi da Roma. Di brutte figure non<br />
bisognava farne con un ospite così importante:<br />
schieramento di polizia scientifico e i fotografi<br />
ben distanti. “Nel momento stesso in cui<br />
Sir Winston entrò in acqua, io mi levai gli<br />
occhiali e mi tuffai. Così com’ero, vestito di tutto<br />
punto”. Giancolombo si era organizzato: aveva<br />
calcolato esattamente la profondità del fondale<br />
in modo da emergere solo delle spalle. Il<br />
fedele bagnino gli passò la macchina e lui<br />
cominciò a scattare.“Ormai Churchill era a seisette<br />
metri da me. Sguazzava allegramente,<br />
sollevava alti spruzzi, si riempiva la bocca d’acqua<br />
che sembrava un ragazzino”.<br />
Il primo ministro non ci mise molto a capire<br />
cosa stesse succedendo. E cominciò a urlare<br />
a perdifiato. “Io in quel momento avevo finito il<br />
primo rullo e, sempre immerso fino al collo,<br />
con le braccia protese in alto, stavo cambiando<br />
pellicola”. Era scoperto: poliziotti inglesi e<br />
italiani non ci pensarono due volte a buttarsi in<br />
acqua ancora in uniforme ed a inseguirlo.<br />
Giancolombo non è uno che molla facilmente:<br />
mentre si diede alla fuga continuò a scattare. Il<br />
problema era dove fuggire. Come in ogni<br />
racconto rocambolesco che si rispetti c’è<br />
sempre chi ti toglie dai guai. Una barca gli si<br />
avvicinò e due braccia provvidenziali lo sollevarono.<br />
“Erano il collega Dino Jarach, e il giornalista<br />
Franco Schepis, che con un monopattino<br />
erano venuti in mio soccorso. Remando di<br />
foga mi portarono ad un centinaio di metri più<br />
in là lungo la spiaggia “.<br />
Rimaste al largo le barchette delle forze dell’ordine<br />
e indietro i poliziotti in acqua, con quelli a<br />
terra costretti a fare il giro lungo della strada, il<br />
Giancolombo ebbe tutto il tempo di infilarsi in<br />
una cabina, spogliarsi di tutto e confondersi con<br />
gli altri bagnanti. Infilandosi prima i rullini dentro<br />
al costume, naturalmente. “Beffai così la polizia,<br />
in piena agitazione, passandole accanto<br />
con gran disinvoltura, come niente fosse”. Di<br />
corsa all’albergo, abiti nuovi, e poi con il rullino<br />
via all’aeroporto di San Nicolò prima possibile.<br />
Un’ora dopo, con l’aereo per Milano in volo e il<br />
rullino al sicuro, il colpo risultava riuscito perfettamente.<br />
E poi, come ogni buon criminale, il<br />
Giancolombo volle ritornare sulla scena del<br />
delitto. Stavolta la polizia, che aveva capito<br />
bene cosa fosse successo, ci mise un attimo a<br />
fermarlo. Ma ormai era fatta. Winston Churchill,<br />
informato degli eventi, fece buon viso a cattivo<br />
gioco. “Seguirono tante scuse al primo ministro<br />
e la pubblicazione delle fotografie su Life”<br />
conclude Giancolombo.<br />
La beffa<br />
delle nozze del secolo<br />
Poi vennero le cosiddette nozze del secolo -<br />
come le definirono i giornali. “Le nozze blindate<br />
a Cannes nel 1952 della contessa fiorentina<br />
Sveva della Gherardesca col principe russo<br />
Nicola Romanov”. Nicola era discendente<br />
dello zar Nicola I e cugino in secondo grado<br />
dell’ultimo zar Nicola II, assassinato durante la<br />
rivoluzione del 1918. A Cannes Giancolombo<br />
c’era andato col giornalista Luigi Vacchi, che<br />
non aveva delle buone notizie per lui: la cerimonia<br />
del matrimonio sarebbe avvenuta all’interno<br />
della chiesa russa locale e a nessun<br />
fotografo sarebbe stato permesso di entrare.<br />
Per l’appunto era un classico invito per il Giancolombo<br />
a nozze… Era come lanciargli una<br />
sfida. Il piano d’azione fu presto pronto e piuttosto<br />
audace: si sarebbe travestito fingendosi<br />
un papavero dell’alta società.<br />
“Affittai un tight col cilindro nel miglior negozio<br />
di Cannes. Mi feci prestare da un teatro una<br />
dozzina di finte decorazioni piuttosto appariscenti.<br />
E tocco finale, noleggiai un’automobile<br />
adeguata: una Hispano Suiza foderata di pelli<br />
di Leopardo”. Perfetto. Vacchi si prestò al<br />
gioco: mise uniforme e cappello da chaffeur,<br />
con tanto di guanti bianchi perché i dettagli in<br />
alta società fanno sempre la differenza. “Arrivammo<br />
davanti alla chiesa un quarto d’ora<br />
prima dell’inizio della cerimonia. E Vacchi,<br />
perfettamente entrato nella parte, scese, si<br />
tolse il cappello, e inchinandosi con gran stile<br />
mi aprì la portiera”. La polizia non capì nulla, e<br />
neanche ci provò. Tutto era studiato nei minimi<br />
dettagli per non destare sospetti. “Come potevano<br />
pensare che sotto il cilindro avevo una<br />
macchina fotografica, una Rolleiflex”.<br />
Neppure il ciambellano di turno ebbe il minimo<br />
dubbio. Giancolombo era esattamente come<br />
doveva apparire. Nella sua dignitosa e nobile<br />
compostezza fu introdotto in chiesa in mezzo<br />
agli altri invitati. I colleghi fotografi lo riconobbero<br />
da dietro le transenne e cominciarono a<br />
protestare. Non ebbero il tempo di parlare che<br />
la polizia intervenne - come racconta un giornale<br />
dell’epoca - e ne manganellò pure qualcuno.<br />
“Ma la copertura non saltò… Quindi arrivarono<br />
gli sposi e le porte furono sbarrate per<br />
dare inizio alla cerimonia”. Era il momento: via<br />
il cilindro e fuori la macchina fotografica.<br />
Cominciarono i flash, molti e veloci perché in<br />
ogni momento poteva essere buttato fuori e i<br />
rullini sequestrati. Ma incredibilmente non<br />
successe nulla. “Gli sposi sorrisero, gli addetti<br />
alla sicurezza non intervennero, e gli invitati<br />
continuarono a seguire la cerimonia come<br />
niente fosse”.<br />
Era fatta: Giancolombo rimase fino alla fine,<br />
fece foto su foto, e poi se ne andò. Non che la<br />
cosa non seccò gli altri fotografi assiepati<br />
dietro le transenne fuori dalla chiesa. Ma il<br />
colpo era troppo audace e divertente perché<br />
non venisse apprezzato anche dai colleghi<br />
della concorrenza. Che naturalmente trasformarono<br />
la sua impresa in notizia del giorno.<br />
“Sui giornali diedero più spazio a me di quanto<br />
non ne ottenne la cronaca della cerimonia<br />
stessa”. Con tanto di foto di Giancolombo,<br />
sorridente e soddisfatto, in tight di fianco alla<br />
limousine.<br />
Da Agenzia<br />
ad archivio storico<br />
L’Agenzia dopo gli anni ’60 subisce una trasformazione<br />
e diventa soprattutto archivio storico.<br />
“Tanti fotografi miei collaboratori se ne erano<br />
ormai andati a cercare la loro strada personale.<br />
Molti giornali avevano a quel punto propri<br />
fotoreporter assunti. E la televisione era diventata<br />
una temibile concorrente per l’editoria. Infine<br />
i costi di gestione erano diventati troppo alti”<br />
spiega Giancolombo. Non è l’unico che deve<br />
fare i conti col cambiato clima editoriale,<br />
economico e sociale. Solo le grandi agenzie<br />
internazionali riescono a tenere il passo. Molti<br />
giornali, l’americano e mitico Life fra tutti, sono<br />
costretti a chiudere per mancanza di lettori e<br />
di inserzionisti. E poi non c’è solo questo: Giancolombo<br />
ha anche ormai una famiglia a cui<br />
deve dedicarsi e riservare tempo. Ma non per<br />
questo smette di scattare immagini. Continua<br />
a realizzare quei reportage che lo hanno fatto<br />
paragonare ai fotografi della Magnum. E,<br />
adeguandosi ai tempi, realizza servizi di moda<br />
e pubblicità. Non rinuncia neppure ad allevare<br />
fotografi: mette su una scuola che rimarrà<br />
aperta fino al 1980.<br />
Interviene nel mondo della fotografia anche a<br />
livello istituzionale. Nel 1964 fonda assieme a<br />
colleghi ed amici la prima Associazione di<br />
Fotoreporters – la Fia, di cui viene eletto presidente.<br />
Continua a detenere la carica per i<br />
successivi dieci anni. Darà le dimissioni in<br />
occasione dell’iscrizione ad honorem nell’<strong>Ordine</strong><br />
<strong>dei</strong> giornalisti, nel 1974. Partecipa anche<br />
alla fondazione prima dell’Afip - Associazione<br />
fotografi italiani professionisti, e poi dell’Airf –<br />
Associazione italiana reporters fotografici. Nel<br />
1990 viene chiamato per esporre, in una<br />
mostra collettiva al Senato a Roma, ritratti del<br />
mondo del giornalismo e dell’editoria della<br />
prima Repubblica. Oggi Giancolombo ha 82<br />
anni. “Ho smesso di fotografare solo dopo un<br />
incidente in macchina un paio d’anni fa”<br />
racconta. Di certo non ha smesso di avere<br />
tutta quella carica ed energia che lo hanno<br />
reso celebre. Né è uscito dalla storia del fotogiornalismo<br />
italiano, che tanto gli deve.<br />
Alessandro Perna<br />
16 ORDINE 1 <strong>2004</strong>
«Non posso esimermi dal richiamare<br />
l’attenzione del Parlamento<br />
su altre parti della legge che -<br />
per quanto attiene al rispetto<br />
del pluralismo dell’informazione -<br />
appaiono non in linea con la<br />
giurisprudenza della Corte<br />
costituzionale»<br />
Il provvedimento, così com’è stata<br />
approvato, permette «la formazione<br />
di posizioni dominanti», impoverendo<br />
i giornali e arrecando così «grave<br />
pregiudizio» alla libertà di informazione<br />
Roma, 15 dicembre 2003. Il presidente della Repubblica<br />
Carlo Azeglio Ciampi ha rinviato alle Camere la legge Gasparri<br />
sul riordino del sistema radiotelevisivo chiedendone la modifica.<br />
Lo ha comunicato il presidente della Camera, Pier Ferdinando<br />
Casini, che ha letto in Aula le cinque cartelle di cui si<br />
compone il messaggio del Capo dello Stato con le motivazioni<br />
della sua decisione. La legge riparte ora da Montecitorio, ramo<br />
del Parlamento che l’ha esaminata per primo.<br />
PLURALISMO - «Non posso esimermi dal richiamare l’attenzione<br />
del Parlamento su altre parti della legge che - per<br />
quanto attiene al rispetto del pluralismo dell’informazione -<br />
appaiono non in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale».<br />
È questo uno <strong>dei</strong> passaggi chiave del messaggio<br />
che il presidente della Repubblica ha inviato alle Camere per<br />
motivare il rinvio del ddl Gasparri. Le obiezioni sollevate da<br />
Ciampi sono molto puntuali. Non è possibile - sostiene in<br />
sostanza nelle motivazioni del rinvio - far slittare sine die il<br />
trasferimento sul satellite di Rete4 stabilito da una sentenza<br />
della Corte costituzionale. Ciampi riconosce che il digitale<br />
terrestre è destinato a modificare la situazione esistente,<br />
Signori parlamentari, in data 5 dicembre<br />
2003, mi è stata inviata per la promulgazione<br />
la legge: “Norme di principio in materia di<br />
assetto del sistema radiotelevisivo e della<br />
Rai- Radiotelevisione italiana Spa, nonchè<br />
delega al governo per l’emanazione del testo<br />
unico della radiotelevisione”, approvata alla<br />
Camera <strong>dei</strong> deputati il 3 aprile 2003, modificata<br />
dal Senato il 22 luglio 2003, nuovamente<br />
modificata dalla Camera <strong>dei</strong> deputati il 2<br />
ottobre 2003 e approvata in via definitiva dal<br />
Senato il 2 dicembre 2003.<br />
Il relativo disegno di legge era stato presentato<br />
dal governo alla Camera <strong>dei</strong> deputati il<br />
23 settembre 2002. Successivamente, il 20<br />
novembre 2002, era sopraggiunta la sentenza<br />
della Corte costituzionale n. 466, che<br />
dichiarava la illegittimità costituzionale<br />
dell’articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio<br />
1997, n. 249 (Istituzione della Autorità per le<br />
garanzie nelle comunicazioni e norme sui<br />
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),<br />
nella parte in cui non prevede la fissazione<br />
di un termine finale certo, e non prorogabile,<br />
che comunque non oltrepassi il 31<br />
dicembre 2003, entro il quale i programmi<br />
irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui<br />
al comma 6 dello stesso articolo 3, devono<br />
essere trasmessi esclusivamente via satellite<br />
o via cavo.<br />
La data del 31 dicembre 2003 era già stata<br />
indicata, come termine per la cessazione del<br />
regime transitorio di cui all’articolo 3, settimo<br />
comma, della legge n. 249 del 1997, dall’Autorità<br />
per le garanzie nelle comunicazioni<br />
(Deliberazione n. 346 del 7 agosto 2001).<br />
Detto articolo 3 rinvia ai limiti fissati dal sesto<br />
comma dell’articolo 2 della stessa legge n.<br />
249, laddove si stabilisce che ad uno stesso<br />
soggetto o a soggetti controllati o collegati<br />
non possono essere rilasciate concessioni<br />
né autorizzazioni che consentano di irradiare<br />
più del venti per cento rispettivamente<br />
delle reti televisive o radiofoniche analogiche<br />
e <strong>dei</strong> programmi televisivi o radiofonici<br />
numerici, in ambito nazionale, trasmessi su<br />
frequenze terrestri, sulla base del piano delle<br />
frequenze.<br />
La sentenza della Corte n. 466 del 20<br />
novembre 2002 muove dalla considerazione<br />
della situazione di fatto allora esistente che,<br />
a suo giudizio, non garantisce... l’attuazione<br />
del principio del pluralismo informativo esterno,<br />
che rappresenta uno degli ‘imperativi’<br />
ineludibili emergenti dalla giurisprudenza<br />
costituzionale in materia.<br />
Nell’ultima delle considerazioni in diritto, la<br />
Corte precisa che la presente decisione,<br />
concernente le trasmissioni televisive in<br />
ambito nazionale su frequenze terrestri<br />
analogiche, non pregiudica il diverso futuro<br />
assetto che potrebbe derivare dallo sviluppo<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
La “Gasparri” torna alle Camere<br />
Ciampi<br />
non firma<br />
la legge<br />
sulla<br />
riforma tv<br />
facendo superare le indicazioni della Consulta, ma questo<br />
mutamento - obietta - sarà possibile solo quando il digitale<br />
terrestre sarà una realtà e non un progetto futuro.<br />
PUBBLICITÀ - Ma anche la distribuzione delle risorse<br />
pubblicitarie allarma il Capo dello Stato: la legge Gasparri,<br />
così com’è stata approvata, permette «la formazione di posizioni<br />
dominanti», impoverendo i giornali e arrecando così<br />
«grave pregiudizio» alla libertà di informazione.<br />
Nel messaggio Ciampi chiede al Parlamento di eliminare dal<br />
testo della legge i riferimenti al decreto legislativo 198 sulle<br />
procedure di installazione delle infrastrutture delle tlc, già<br />
dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza<br />
303 del 2003. Allo stesso decreto - sottolinea Ciampi chiedendone<br />
la soppressione - fanno riferimento anche l’articolo<br />
5 e l’articolo 24 dello stesso disegno di legge. In sostanza,<br />
con la bocciatura del 198, i Comuni possono opporsi più efficacemente<br />
alla costruzione di nuovi impianti per le tlc.<br />
ITER - Il messaggio di Ciampi con le motivazioni, letto in Aula<br />
dal presidente Pier Ferdinando Casini, sarà assegnato, con<br />
il testo del provvedimento, alle commissioni competenti, in<br />
Il testo integrale<br />
del messaggio<br />
del Presidente<br />
della tecnica di trasmissione digitale terrestre,<br />
con conseguente aumento delle risorse<br />
tecniche disponibili.<br />
Dalla sentenza i cui contenuti essenziali<br />
sono stati richiamati dai presidenti delle<br />
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni<br />
e dell’Autorità garante della concorrenza e<br />
del mercato, nelle audizioni rese alle<br />
Commissioni riunite VII e IX della Camera<br />
<strong>dei</strong> deputati il 10 settembre 2003, discende<br />
pertanto che per poter considerate maturate<br />
le condizioni del diverso futuro assetto derivante<br />
dall’espansione della tecnica di<br />
trasmissione digitale terrestre e, quindi, per<br />
poter giudicare superabile il limite temporale<br />
fissato nel dispositivo, deve necessariamente<br />
ricorrere la condizione che sia intervenuto<br />
un effettivo arricchimento del pluralismo derivante<br />
da tale espansione.<br />
La legge a me inviata si fa carico di questo<br />
problema. Le norme che disciplinano l’aspetto<br />
sopra considerato sono contenute nell’articolo<br />
25, il cui primo comma stabilisce che,<br />
entro il 31 dicembre 2003, dovranno essere<br />
rese attive reti televisive digitali terrestri<br />
ponendo, in particolare, a carico della<br />
società concessionaria del servizio pubblico<br />
(secondo comma) l’obbligo di predisporre<br />
impianti (blocchi di diffusione) che consentano<br />
il raggiungimento del cinquanta per cento<br />
della popolazione entro il primo gennaio<br />
<strong>2004</strong> e del settanta per cento entro il primo<br />
gennaio 2005.<br />
L’articolo 25, terzo comma, stabilisce inoltre<br />
che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,<br />
entro i 12 mesi successivi al 31 dicembre<br />
2003, svolge un esame della complessiva<br />
offerta <strong>dei</strong> programmi televisivi digitali<br />
terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di<br />
popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali<br />
terrestri; b) la presenza sul mercato di decoder<br />
a prezzi accessibili; c) l’effettiva offerta al<br />
pubblico su tali reti anche di programmi diversi<br />
da quelli diffusi dalle reti analogiche.<br />
Ciò premesso, ritengo di dover formulare<br />
alcune osservazioni in merito alla compatibilità<br />
di talune disposizioni della legge in<br />
esame con la sentenza n.466/2002 della<br />
Corte costituzionale.<br />
Una prima osservazione riguarda il termine<br />
massimo assegnato all’Autorità per effettua-<br />
re detto esame: “entro i dodici mesi successivi<br />
al 31 dicembre 2003” (articolo 25, terzo<br />
comma). Questo lasso di tempo - molto<br />
ampio rispetto alle presumibili occorrenze<br />
della verifica - si traduce, di fatto, in una<br />
proroga del termine finale indicato dalla<br />
Corte costituzionale.<br />
Una seconda osservazione concerne i poteri<br />
riconosciuti alla Autorità: questa, entro i<br />
trenta giorni successivi al completamento<br />
dell’accertamento, invia una relazione al<br />
Governo e alle competenti Commissioni<br />
parlamentari, nella quale verifica se sia intervenuto<br />
un effettivo ampliamento delle offerte<br />
disponibili e del pluralismo nel settore televisivo<br />
ed eventualmente formula proposte di<br />
interventi diretti a favorire l’ulteriore incremento<br />
dell’offerta di programmi televisivi<br />
digitali terrestri e dell’accesso ai medesimi<br />
(articolo 25, terzo comma). Ne deriva che, se<br />
l’Autorità dovesse accertare, entro il termine<br />
assegnatole, che le supposte condizioni<br />
(raggiungimento della prestabilita quota di<br />
popolazione da parte delle nuove reti digitali<br />
terrestri, presenza sul mercato di decoder a<br />
prezzi accessibili; effettiva offerta al pubblico<br />
su tali reti anche di programmi diversi da<br />
quelli diffusi dalle reti analogiche) non si<br />
sono verificate, non si avrebbe alcuna conseguenza<br />
certa. La legge, infatti, non fornisce<br />
indicazioni in ordine al tipo e agli effetti <strong>dei</strong><br />
provvedimenti che dovrebbero seguire all’eventuale<br />
esito negativo dell’accertamento.<br />
Si consideri, inoltre, che il paragrafo 11,<br />
penultimo capoverso, delle considerazioni in<br />
diritto della sentenza n.466, recita: D’altro<br />
canto, la data del 31 dicembre 2003 offre<br />
margini temporali all’intervento del legislatore<br />
per determinare le modalità della definitiva<br />
cessazione del regime transitorio di cui al<br />
comma 7 dell’articolo 3 della legge n. 249<br />
del 1977. Ne consegue che il primo gennaio<br />
<strong>2004</strong> può essere considerato come il dies a<br />
quo non di un nuovo regime transitorio, ma<br />
dell’attuazione delle predette modalità di<br />
cessazione del regime medesimo, che devono<br />
essere determinate dal Parlamento entro<br />
il 31 dicembre 2003. Si rende, inoltre, necessario<br />
indicare il dies ad quem e, cioè, il<br />
termine di tale fase di attuazione.<br />
Tutto ciò detto in relazione alla compatibilità<br />
Dal Corriere<br />
della Sera<br />
di martedì<br />
16 dicembre.<br />
questo caso le commissioni Cultura e Trasporti, cui spetterà<br />
di riferire all’assemblea, al termine dell’istruttoria in sede referente.<br />
L’Aula «può» limitare la discussione alle parti che sono<br />
state oggetto del messaggio. Il provvedimento sarà votato in<br />
assemblea articolo per articolo. Infine il voto finale e il<br />
passaggio al Senato. Se le Camere approvano nuovamente<br />
la legge - recita il secondo comma dell’articolo 74 della Costituzione<br />
- questa deve essere promulgata.<br />
IL PREMIER - La decisione non ha colto di sorpresa il<br />
premier che era stato convocato nel pomeriggio al Quirinale<br />
dove aveva avuto un chiarimento con Ciampi. Non si aprirebbe<br />
un vulnus tra poteri dello Stato e richieste sensate di<br />
modifiche sarebbero accettate dal Parlamento, aveva<br />
commentato con i cronisti Silvio Berlusconi uscendo dalla<br />
Camera, dove più tardi ha avuto un colloquio anche con il<br />
presidente Pier Ferdinando Casini. Il presidente del Consiglio<br />
ha concluso: «Io non credo che sia nulla di eccezionale<br />
il rinvio della legge alle Camere, è già successo molte volte,<br />
dopo di che il capo dello Stato firmerà comunque la legge».<br />
(da www.corriere.it)<br />
delle succitate disposizioni della legge in<br />
esame con la sentenza n. 466 del 20 novembre<br />
2002, non posso esimermi dal richiamare<br />
l’attenzione del Parlamento su altre parti<br />
della legge che - per quanto attiene al rispetto<br />
del pluralismo dell’informazione - appaiono<br />
non il linea con la giurisprudenza della<br />
Corte costituzionale.<br />
Si consideri, a tale proposito, che la sentenza<br />
della Corte costituzionale n. 826 del 1988<br />
poneva come un imperativo la necessità di<br />
garantire “il massimo di pluralismo esterno,<br />
onde soddisfare, attraverso una pluralità di<br />
voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione”.<br />
E ancora, nella sentenza n. 420 del<br />
1994, la stessa Corte sottolineava l’indispensabilità<br />
di un’idonea disciplina che prevenga<br />
la formazione di posizioni dominanti.<br />
Nell’ambito <strong>dei</strong> principi fissati dalla richiamata<br />
giurisprudenza della Corte costituzionale<br />
si è mosso il messaggio da me inviato alle<br />
Camere il 23 luglio 2002.<br />
Per quanto riguarda la concentrazione <strong>dei</strong><br />
mezzi finanziari, il Sistema integrato delle<br />
comunicazioni (Sic) - assunto dalla legge in<br />
esame come base di riferimento per il calcolo<br />
<strong>dei</strong> ricavi <strong>dei</strong> singoli operatori della comunicazione<br />
- potrebbe consentire, a causa<br />
della sua dimensione, a chi ne detenga il 20<br />
per cento (articolo 15, secondo comma, della<br />
legge) di disporre di strumenti di comunicazione<br />
in misura tale da dar luogo alla formazione<br />
di posizioni dominanti.<br />
Quanto al problema della raccolta pubblicitaria,<br />
si richiama la sentenza della Corte costituzionale<br />
n. 231 del 1985 che, riprendendo<br />
principi affermati in precedenti decisioni,<br />
richiede che sia evitato il pericolo che la<br />
radiotelevisione, inaridendo una tradizionale<br />
fonte di finanziamento della libera stampa,<br />
rechi grave pregiudizio ad una libertà che la<br />
Costituzione fa oggetto di energica tutela.<br />
Si rende, infine, indispensabile espungere<br />
dal testo della legge il comma 14 dell’articolo<br />
23, che rende applicabili alla realizzazione di<br />
reti digitali terrestri le disposizioni del decreto<br />
legislativo 4 settembre 2002, numero 198,<br />
del quale la Corte costituzionale ha dichiarato<br />
l’illegittimità costituzionale con la sentenza<br />
numero 303 del 25 settembre/1° ottobre<br />
2003. Per la stessa ragione, va soppresso il<br />
riferimento al predetto decreto legislativo<br />
dichiarato incostituzionale, contenuto nell’articolo<br />
5, primo comma, lettera l) e nell’articolo<br />
24, terzo comma.<br />
Per i motivi innanzi illustrati, chiedo, alle<br />
Camere, a norma dell’articolo 74 primo<br />
comma, della Costituzione, una nuova deliberazione<br />
in ordine alla legge a me trasmessa<br />
il 5 dicembre 2003.<br />
(Roma, Palazzo del Quirinale,<br />
15 dicembre 2003)<br />
17 (25)
SOLIDARIETÀ<br />
Il pezzo che segue è di Roberto Zoldan<br />
e compare nel secondo numero<br />
del mensile VINCERE,<br />
un grande periodico a diffusione<br />
nazionale che racconta<br />
con consapevolezza e ottimismo<br />
il mondo dell’handicap.<br />
Pubblichiamo il servizio per il suo alto<br />
contenuto morale.<br />
VINCERE<br />
è diretto da Massimo Balletti<br />
Il 15 febbraio 1966 in una casa di contadini della Brianza, a<br />
pochi chilometri da Milano, si aspettava il lieto evento. Una<br />
giovane madre stava per dare alla luce una creatura nell’ospedale<br />
locale, gli auguri e i sogni che accompagnano l’arrivo<br />
della cicogna si rincorrevano nei dialoghi <strong>dei</strong> parenti e<br />
nella trepida attesa. Toccò al primario di ostetricia, poche<br />
ore dopo il parto, dire alla puerpera che le era nata una<br />
bambina con il corpicino deforme, forse con lesioni al sistema<br />
nervoso. Nelle settimane che seguirono la diagnosi fu<br />
confermata. I genitori caddero in un dolore cupo, si aggrapparono<br />
alla speranza ma i miglioramenti non vennero. La<br />
battezzarono col nome di Paola, la curarono con apprensione<br />
e amore. Mani e gambine rattrappite, la poppata difficile,<br />
gli occhi assenti, la piccola cresceva passando dalle<br />
braccia al lettino, inutile ogni cura specialistica, difficile l’assistenza.<br />
A 5 anni fu ricoverata all’Istituto Sacra Famiglia di Cesano<br />
Boscone, in provincia di Milano, dall’altra parte della metropoli.<br />
Paola si trova qui dal 1971. Adagiata su un lettinocarrozzina<br />
accanto agli altri degenti del reparto Santa Teresina,<br />
offre il volto al visitatore, se le si parla sorride, tende il<br />
braccino che termina con una mano atrofizzata cercando<br />
solidarietà o contatto. Gli infermieri l’assistono, i medici intervengono<br />
per ogni complicanza. Viene svegliata, lavata, accudita,<br />
nutrita come gli altri 62 ospiti. Ogni giorno da 32 anni.<br />
Attorno suoni, giocattoli, ombre amiche. Non le manca niente,<br />
se non la vita che del resto nemmeno conosce. I genitori<br />
vengono a trovarla ogni due domeniche con fedeltà immutata:<br />
soltanto quando sono ammalati può accadere che la visita<br />
venga rinviata. Sono persone semplici, soprattutto la<br />
madre che trasmette a Paola un’intensa affettività: durante la<br />
visita le sta accanto, tenendole la mano e sorridendole e il<br />
sorriso che Paola offre a tutti è speculare al suo.<br />
La riflessione<br />
di Roberto Zoldan<br />
C’è un ordine<br />
in questa<br />
sofferenza?<br />
C’è un ordine in questa sofferenza? La fede<br />
suggerisce la lettura di un misterioso disegno<br />
divino, i mistici di ogni appartenenza<br />
danno spiegazioni criptiche alle miserie della<br />
condizione umana. Padre Pio, mistico cattolico<br />
della modernità che poteva leggere al di<br />
là della materia, disse: “del tappeto tessuto<br />
dal Signore vediamo soltanto la trama ruvida<br />
da sotto, sopra essa è luminosa e splendida<br />
di colori”.<br />
E il laico, privo di un proprio Libro, più umilmente<br />
si chiede: “se nell’universo tutto è<br />
giusto e perfetto, se Dio sovrintende alla vita<br />
di ogni creatura, dove risiede l’armonia che<br />
muove il dolore di Paola e <strong>dei</strong> suoi genitori,<br />
di Pietro e di Luisa?” Il dubbio è sempre nella<br />
sacca del viaggiatore. E nel vangelo di<br />
Matteo (5,2 – 12): … “beati voi che ora piangete<br />
perché riderete”. I saniasi, gli illuminati<br />
d’oriente buddisti e induisti, raccontano del<br />
karma samsara, la catena delle vite e delle<br />
morti, della reincarnazione di corpo in corpo<br />
che riequilibrerebbe antiche disarmonie,<br />
ristabilendo col dolore rinnovate felicità spirituali<br />
fino alla liberazione e al distacco eterno<br />
dalla materia. E nel Corano (4:57) “coloro<br />
che hanno creduto e operato per il bene<br />
presto li faremo entrare nei giardini dove<br />
scorrono ruscelli e in cui rimarranno immortali<br />
in perpetuo...”. Una visione del mistero<br />
della vita, se ci pensate, non contraddice l’altra.<br />
Non si può operare per il bene se non c’è<br />
il male, ombra del bene, per la gioia se non<br />
c’è il dolore. E noi non siamo il nostro corpo,<br />
la nostra intima essenza è spirituale, così<br />
come l’Universo, se si può dire, è il corpo di<br />
Dio. E come farlo sapere ai disabili gravi che<br />
essi non sono il loro corpo?<br />
Bagliori<br />
nelle<br />
tenebre<br />
Al piano di sopra tra i gravi c’è una ragazza cerebrolesa,<br />
Luisa, adagiata su una poltroncina-seggiolone, gli occhi<br />
spesso bassi, il volto muto, il corpo piegato. Non comunica.<br />
Riceve ogni giorno la visita di Pietro, 40 anni, autistico, arrivato<br />
qui dalla Liguria nel 1983, la personalità irreparabilmente<br />
ferita da trauma da abbandono. La madre non lo riconobbe<br />
e lo affidò a un istituto. Da quando è ricoverato Pietro<br />
cerca qualcuno che gli dia affetto. Anni fa correva ogni giorno<br />
accanto a una coppia in visita al figlio degente e i due gli<br />
erano diventati amici. Una compensazione affettiva simile a<br />
quella che oggi lui rinnova facendo visita ogni giorno a Luisa.<br />
Sta in piedi accanto a lei, ben vestito, controllato, dialoga col<br />
L’Istituto Sacra Famiglia, alle porte di Milano, ha più di cent’anni<br />
La lunga storia dell’istituto.<br />
Osare la speranza! Curare fino a ...?<br />
Interrogativi sul futuro<br />
Quando fu fondato dava un tetto, un letto, pasti regolari e assistenza a un drappello di<br />
30 derelitti, storpi, ciechi, scemi, scaricati dalle famiglie, ignorati dalla pubblica assistenza,<br />
costretti a mendicare per sopravvivere, quasi a vegetare. Ora accoglie lungodegenti<br />
e malati con deformazioni accentuate, incapacità locomotorie e forte ritardo<br />
mentale. Una gamma sottile di sofferenze si snoda tra terapie e diagnosi, tentativi di<br />
recupero e ineluttabili abbandoni. Dal buio dell’incoscienza alla speranza, ai dialoghi<br />
muti segnati dalla carità e dall’amore.<br />
L’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone,<br />
alle porte di Milano, ha più di cent’anni<br />
di storia. Fondato nel 1896 per gli incurabili<br />
di campagna da don Domenico Pogliani,<br />
parroco del paese, “regalava un tetto, un<br />
letto, pasti regolari e assistenza a un drappello<br />
di 30 derelitti, storpi, ciechi, scemi,<br />
scaricati dalle famiglie, ignorati dalla pubblica<br />
assistenza, costretti a mendicare per<br />
sopravvivere, quasi a vegetare”, racconta<br />
la biografia del prete.<br />
L’Italia povera e contadina di fine ‘800<br />
contava un analfabeta su due e i cattolici<br />
erano in difficoltà dopo la legge voluta dal<br />
governo liberale di Crispi del 1890 che<br />
laicizzava l’assistenza, anche se lo Stato<br />
lasciò ai privati l’istruzione <strong>dei</strong> minori anormali<br />
fino alla riforma Gentile del 1923.<br />
Don Pogliani non respingeva nessuno e in<br />
pochi mesi i letti raddoppiarono: chiamò<br />
volontari e suore alle quali assegnò un<br />
emolumento che oggi sarebbe di 300 euro<br />
l’anno, vitto e alloggio gratis. Schierati dalla<br />
parte degli ultimi, i volontari posero le basi<br />
di una cattedrale di beneficenza. Nel 1921<br />
gli successe don Luigi Moneta che visse gli<br />
anni della prima espansione tra le due<br />
guerre e segnò quella più frenetica dopo il<br />
1950: darà il nome alla fondazione che ora<br />
sovrintende all’intero istituto e dal 1980<br />
promuove per la diocesi progetti e servizi<br />
sociali. Un padiglione ogni anno, si proponeva.<br />
Ampliò reparti, palestre rieducative e<br />
scuole professionali.<br />
Nel 1940 la Sacra Famiglia contava 3000<br />
ricoverati in 25 padiglioni. Quando Luigi<br />
Moneta, diventato monsignore, morì nel<br />
1955 ne aveva 3500. Sono occupati ora<br />
824 posti letto, distribuiti in più palazzine,<br />
la più antica delle quali è sede della Casa<br />
di cura ambrosiana, una clinica per esterni<br />
e per i degenti in aggravamento. L’istituto<br />
assiste in forma diurna 234 ammalati e altri<br />
a domicilio.<br />
Attorno, un complesso sociosanitario per<br />
disabili tra i più qualificati d’Italia, ormai<br />
ingoiato dalla megalopoli che si espande<br />
verso ovest, ai margini delle risaie di un<br />
tempo. L’istituto è specializzato nella lunga<br />
degenza, nell’assistenza ai disabili gravi<br />
come agli autosufficienti, agli anziani come<br />
a chi giace in un lettino da quando è venuto<br />
alla luce. Entre privato onlus dal 1997,<br />
bilancio di 65 milioni di euro, 1600 dipendenti<br />
e collaboratori: ausiliari socioassistenziali,<br />
infermieri, educatori, terapisti<br />
della riabilitazione, medici e psicologi,<br />
personale addetto ai servizi amministrativi,<br />
suo silenzio vigile. Luisa è per lui il simulacro di un’affettività<br />
mancata.<br />
Un giorno segnalò agli infermieri che la ragazza stava male,<br />
loro non se n’erano accorti, lui ne fu orgoglioso. Qualche<br />
volta una benefattrice, diventata sua tutrice, lo porta fuori,<br />
anche in pellegrinaggio fino a Roma, d’estate lo ospita in<br />
vacanza. Quando Pietro esce il suo disagio diminuisce. Gli<br />
assistenti gli affidano piccoli compiti, gli fanno stendere la<br />
biancheria, portare oggetti da un reparto all’altro. E lui si<br />
sente uomo. Come le decine di meno gravi che camminano<br />
nei viali dell’istituto, ogni incontro un saluto per sentirsi vivi e<br />
considerati. E il saluto parte sempre da loro.<br />
generali e alberghieri, quadri e dirigenti.<br />
Filiali a Fagnano di Gaggiano, Abbiategrasso,<br />
Andora (Savona), Cocquio (Varese),<br />
Regoledo di Perledo (Lecco), Verbania.<br />
Qui si fanno convegni di livello, come quello<br />
del 14 giugno scorso dal titolo Osare la<br />
speranza: curare fino a…?, indetto per l’Anno<br />
europeo delle persone disabili. Tema:<br />
c’è una via tra abbandono del paziente<br />
(terminale, costretto alla dipendenza senza<br />
fine, al limite della vita) e accanimento terapeutico?<br />
C’erano a discuterne tra gli altri il ministro<br />
della Sanità Sirchia, il presidente del Comitato<br />
nazionale per la bioetica D’Agostino, il<br />
direttore dell’Istituto di bioetica dell’università<br />
cattolica di Roma Carrasco de Paula e<br />
l’arcivescovo di Milano Tettamanzi. Con alte<br />
implicazioni scientifiche e morali la cui<br />
sintesi era: fino a che punto la solidarietà<br />
umana e la medicina hanno diritto di operare<br />
per la conservazione in vita di pazienti<br />
costretti a volte a una pulsione soltanto<br />
vegetativa?<br />
18 (26) ORDINE 1 <strong>2004</strong>
L’infermiere Pino<br />
De Caro chinato<br />
su una degente.<br />
Il dialogo con<br />
i pazienti più gravi<br />
è affidato<br />
alla sensibilità<br />
e all’intuizione<br />
<strong>dei</strong> terapeuti.<br />
Savino Lorusso, caposala,<br />
infermiere professionale:<br />
«Ogni rapporto con i disabili<br />
gravi è consolidato<br />
dall’intuizione al di là<br />
della terapia».<br />
Il dottor Carlo Viscardi,<br />
responsabile di gestione <strong>dei</strong><br />
cinque reparti che<br />
ospitano i pazienti più gravi.<br />
Interno di un reparto<br />
dell’Istituto Sacra Famiglia.<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
Viaggio nei reparti del dolore, dove un sorriso<br />
e una carezza valgono una terapia<br />
Il breve viaggio che proponiamo al lettore<br />
all’interno di questa realtà non darà la risposta,<br />
del resto soltanto tratteggiata dai relatori.<br />
Vi racconteremo più umilmente le virtù<br />
nobili <strong>dei</strong> terapeuti e <strong>dei</strong> pazienti, quando<br />
riescono ad accendere nei corpi alla deriva<br />
un bagliore di disponibilità e possono vincere<br />
la disperazione facendo intravvedere un<br />
piccolo traguardo di luce. Carlo Viscardi, 57<br />
anni, è responsabile di gestione <strong>dei</strong> cinque<br />
reparti che ospitano i pazienti più gravi, quelli<br />
con deformazioni accentuate, incapacità<br />
locomotorie e forte ritardo mentale. Cinque<br />
luoghi di carità e dolore nei quali una gamma<br />
sottile di sofferenze si snoda tra terapie e<br />
diagnosi, tentativi di recupero e ineluttabili<br />
abbandoni. Dal buio dell’incoscienza ai lievi<br />
bagliori del dialogo. Il Santa Teresina ha 63<br />
degenti affetti da forti disturbi neuromotori e<br />
gravi problemi di nutrizione alla quale si<br />
sopperisce con la peg (percutaneus endoscopic<br />
gastrostomy), un meccanismo che<br />
porta cibo semiliquido allo stomaco attraverso<br />
una cannuccia. Se il paziente impara a<br />
deglutire la peg può essere tolta: la speranza<br />
di rieducarlo alla nutrizione non muore<br />
mai. Qui c’è anche chi in una vita intera non<br />
si è mosso dal letto, come molti <strong>dei</strong> 60<br />
degenti del reparto Santi Innocenti 1. Simili e<br />
altrettanto gravi sono gli handicap <strong>dei</strong> 66<br />
ricoverati al Santa Rita. Il Santi Innocenti 2<br />
ospita gli autistici (ripiegamento introverso<br />
della personalità) e coloro che hanno ritardi<br />
mentali gravi manifestatisi nei primi anni di<br />
vita. Le rianimazioni oggi salvano molti traumatizzati<br />
ma chi si salva può essere costretto<br />
per sempre all’immobilità.<br />
Se il dolore ha una scala di lettura accettabile,<br />
le malattie degenerative come la sclerosi<br />
multipla e le polipatologie appaiono al secondo<br />
gradino di gravità e trovano ospitalità in<br />
reparti meno numerosi. Al Sant’Agnese ci<br />
sono 19 ospiti alcuni <strong>dei</strong> quali in coma in<br />
seguito a ictus, traumi cranici, complicazioni<br />
cerebrali postoperatorie. Qui la solidarietà<br />
<strong>dei</strong> parenti è ancora viva, le visite sono<br />
frequenti e anche quotidiane. Il paziente non<br />
è caduto nell’oblio, è ancora uno di casa,<br />
ricoverato con la speranza che un giorno ce<br />
la faccia a tornar fuori.<br />
Ogni degente<br />
è un caso<br />
irripetibile...<br />
Il dottor Viscardi entrò all’Istituto Sacra Famiglia<br />
a vent’anni. Era studente universitario,<br />
aveva attitudini all’assistenza e gli affidarono<br />
il recupero <strong>dei</strong> ragazzi disadattati, vittime<br />
dell’immigrazione selvaggia e del disagio<br />
delle periferie. Soggetti ora meno numerosi<br />
e assistiti dalle istituzioni parascolastiche.<br />
Laureatosi, qui si è costruito la carriera.<br />
Conosce bene il lavoro di base, quello degli<br />
ausiliari socioassistenziali ai quali ricorda<br />
sempre che quando curano quest’umanità<br />
sofferente, fanno il bagno ai paraplegici o<br />
imboccano i disfasici, i pazienti che non<br />
vogliono o non sono in grado di nutrirsi, stanno<br />
dialogando, anche in modo indiretto, con<br />
esseri umani, cioè con creature detentrici di<br />
dignità. Ogni degente un caso irripetibile,<br />
nella malattia e nella terapia.<br />
... Mario,<br />
rifiutato<br />
dalla morte<br />
Come quello di Mario, 24 anni, ricoverato per<br />
esito da trauma cranico in seguito a tentato<br />
suicidio. Arrivava dall’ospedale che gli aveva<br />
prestato le prime cure. Una vita di depressioni<br />
e dolori l’aveva spinto a cercare la morte:<br />
si sentiva solo e prigioniero di un labirinto.<br />
Uscito da un lungo coma in semiparesi, rifiutava<br />
il cibo, aveva difficoltà a deglutire e non<br />
poteva esprimersi. Dopo mesi di buio, negli<br />
occhi riapparve la malinconia lontana che<br />
aveva accompagnato la sua intera esistenza,<br />
lo stupore immoto per essere ancora di<br />
qua. Era nutrito meccanicamente. I medici<br />
avevano fatto il possibile con sollecitazioni,<br />
inviti a esprimersi, terapie accurate. Giorno<br />
dopo giorno ci si aspettava un segnale di<br />
vitalità. La morte l’aveva rifiutato ma la vita,<br />
per lui, era al di là di una barriera insormontabile.<br />
Mario non voleva fare il primo passo<br />
verso la luce, aspettava che qualcuno o qualcosa<br />
lo riportasse nel gorgo nero della fine.<br />
Fu affidato a Emanuela Faroldi, educatrice<br />
dal 1983. Giorno dopo giorno le parole tentavano<br />
di far breccia nell’abulia del giovane<br />
che mandava all’infermiera muti segnali di<br />
ostilità. Mario riuscì a strapparsi la peg, il<br />
meccanismo che porta cibo allo stomaco,<br />
voleva farla finita con quel calvario. Emanuela<br />
e la dottoressa Cinzia Rognoni decisero di<br />
intersificare i colloqui: parole sussurrate con<br />
voce calma, inviti ad aprire il cuore alla<br />
speranza. Carezze affettuose, forse le prime<br />
di una vita senz’amore. Un giorno di luglio,<br />
fuori il caldo infernale, Mario rispose. Dapprima<br />
con gli occhi: accettò di incontrare quelli<br />
dell’infermiera. Poi con un sorriso. Dopo due<br />
settimane deglutì il primo boccone. Non<br />
riusciva a parlare ma mosse le mani, a fatica,<br />
impugnando la matita che Emanuela gli<br />
porgeva. Ed ecco la risalita, lenta e costante<br />
fino all’autoalimentazione e ai messaggi<br />
scritti su fogli a quadretti, frammenti di brevi<br />
dialoghi nei quali Mario annota in segni<br />
incerti il suo diario quotidiano fatto di poche<br />
sillabe. Ma riesce a raccontare la sua condizione,<br />
scrive <strong>dei</strong> sogni, quando ci sono, e<br />
degli incubi ancora presenti. Come quello di<br />
un démone che qualche notte gli ricorda<br />
quanto lui sia brutto, indegno di vivere,<br />
condannato alla disperazione, ultima eco<br />
schizofrenica di un passato che sta sfumando.<br />
Emanuela interpreta ogni giorno i tracciati<br />
incerti della matita di Mario. La richiesta<br />
di un bicchiere d’acqua è una conquista, un<br />
sorriso è la speranza. La proiezione verso la<br />
vita una vittoria.<br />
...la ragazza<br />
psicopatica rifiutata<br />
dal padre<br />
La follia a volte s’insinua nella malattia fisica<br />
e il tormento diventa più grande e cupo. A<br />
Enrica, psicologa educatrice, fu assegnata<br />
un giorno una ragazza psicotica che<br />
frequentava il day hospital, 30 anni, inavvicinabile.<br />
Era aggressiva, non riusciva a stabilire<br />
rapporti, il padre l’aveva rifiutata. Dopo<br />
quattro anni di incontri quotidiani la poveretta<br />
si lasciò andare e accettò le attenzioni<br />
dell’infermiera, cominciò a risalire la china, in<br />
seguito socializzò con l’intero reparto. Enrica<br />
era l’unico essere umano al quale aveva<br />
dato fiducia. La ragazza si trasferì in Sicilia e<br />
quell’amicizia tormentata lasciò un segno:<br />
Enrica la ricorda ancora con tenerezza.<br />
Giusy, trent’anni,<br />
muore tra le<br />
braccia di Savino<br />
Il dialogo con un cerebroleso è difficile, legato<br />
a meccanismi imponderabili. Savino<br />
Lorusso, 38 anni, è caposala infermiere<br />
professionale dal 1987. Dice: “Ogni rapporto<br />
con i disabili gravi è consolidato dall’intuizione<br />
al di là della terapia. Quasi sempre il<br />
malato non dialoga e bisogna capire quali<br />
suggestioni lo possono togliere dall’abulia:<br />
una sollecitazione, una parola amica, la<br />
capacità di entrare nella sua anima. È l’unica<br />
strada per stabile un’intesa”. Il paziente<br />
diventa per il terapeuta una persona cara, a<br />
volte oggetto di un transfert affettivo. Giusy<br />
aveva 33 anni, metà passati immobile in un<br />
letto della Sacra Famiglia. Condizioni generali<br />
gravissime, un giorno ebbe un episodio<br />
di abingestis (il cibo di traverso la soffocava).<br />
La portarono alla rianimazione del Policlinico<br />
di Milano e Savino si mise al suo fianco<br />
sull’ambulanza: la conosceva bene, la<br />
sua presenza poteva essere utile. Stette<br />
accanto ai medici per ore sperando di<br />
salvarla. Nell’équipe del Policlinico c’era una<br />
dottoressa che si prodigò per tutto il giorno<br />
attorno alla malata.<br />
Alle 20 la ragazza spirò. Savino, colpito da<br />
quello zelo e da quell’emozione, chiese alla<br />
donna il perché di tanto impegno. “Ho una<br />
sorella come lei”, si sentì rispondere.<br />
Luciana Cimarelli è direttore medico <strong>dei</strong><br />
reparti <strong>dei</strong> disabili da tre anni. È alla Sacra<br />
Famiglia dal 1979, quando si pagava l’università<br />
assistendo gli anziani. Laureatasi con<br />
la specializzazione in geriatria, decise di<br />
rimanere. “Io sono soltanto la punta di quel<br />
grande iceberg che è il nostro complesso<br />
lavoro di équipe”, dice. “Ogni reparto è guidato<br />
da medici qualificati. Non c’è gerarchia, ci<br />
si consulta e ci si aiuta”. I colleghi che facevano<br />
carriera fuori nei primi anni le parlavano<br />
con sufficienza, sotteso l’amaro interrogativo:<br />
che medico è mai quello che sa di<br />
non poter guarire? “Sono felice della mia<br />
scelta”, commenta. “Rimasi qui certa che la<br />
medicina dovesse anche dare conforto al<br />
cammino <strong>dei</strong> disabili gravi. Alcuni vanno<br />
verso la fine lentamente, bisogna accompagnarli<br />
all’ultimo traguardo salvandone la<br />
dignità nel dolore”.<br />
Giovanni,<br />
il disastro<br />
di un cuore nuovo<br />
Ma ci sono anche casi di ripresa imprevedibile.<br />
Giovanni, 65 anni, per tutta la vita non è<br />
stato fortunato con la salute. Soffriva di gravi<br />
cadiopatie e arrivò qui nell’aprile 2002 dopo<br />
il trapianto di cuore subito a Pavia. Un disastro.<br />
Le complicanze postoperatorie lo<br />
avevano gettato in uno stato vegetativo<br />
permanente, non dava segni di vitalità.<br />
Quanto sarebbe durato in quelle condizioni?<br />
Una mattina del gennaio scorso l’infermiere<br />
di turno notò che rispondeva per la prima<br />
volta alle sollecitazioni. Dopo qualche giorno<br />
Giovanni spalancò gli occhi, sorrise al caposala<br />
del quale per mesi aveva sentito la voce<br />
in stato di incoscienza, si tolse il sondino e<br />
cominciò a essere alimentato per bocca. Ora<br />
vuole essere accudito soltanto da quell’infermiere,<br />
rifiuta gli altri. È clinicamente stabile,<br />
non parla ancora ma è stato rieducato all’autoalimetazione.<br />
Avrà Giovanni il tempo biologico<br />
per rimettersi in piedi e tornare a casa<br />
in buone condizioni?<br />
Antonio guarda<br />
le foglie gialle<br />
che cadono<br />
Antonio venne alla luce nel 1959. Era per i<br />
genitori il bimbo tanto atteso, ma il corpo<br />
apparve presto legato nei movimenti, la locuzione<br />
ritardata. Manifestò dopo qualche<br />
tempo un’insufficienza mentale media. La<br />
diagnosi gettò la madre nella disperazione,<br />
poi la donna si riprese e accettò quella sua<br />
creatura con amore assoluto. Il padre osservava<br />
nella penombra del vivere quotidiano la<br />
pena di quel figliolo sfortunato. Lo sguardo<br />
del piccolo cercava interlocutori, le carezze<br />
gli davano gioia, lo si capiva dai balbettii che<br />
sembravano borborigmi. Giorno dopo giorno<br />
la ritualità metodica sorretta dall’affetto: il<br />
lettino, l’imboccamento, la pulizia, il sonno. E<br />
spesso la visita del neurologo. Antonio è<br />
vissuto in casa frequentando il centro diurno<br />
della Sacra Famiglia fino al 1992 allorché la<br />
mamma, ormai vedova e ammalata, non fu<br />
più in grado di accudirlo. Antonio entrò in istituto<br />
in forma residenziale.<br />
È il più presente del reparto, gli occhi neri e<br />
vivi, il volto si accende di fronte al visitatore, è<br />
seduto al centro della stanza, trattenuto dai<br />
sostegni della carrozzina. Il televisore acceso<br />
sullo sfondo emette suoni e musica rassicuranti<br />
per tutti. Alle pareti i disegni colorati dalla<br />
scolaresca assente, ordinata e muta sotto gli<br />
occhi vigili degli assistenti. Attorno tante deformità,<br />
un casco a gabbia difende una ragazza<br />
dalle cadute prodotte da epilessia grave.<br />
Nessuno vede al di là delle finestre le prime<br />
foglie gialle che cadono dagli alberi.<br />
Due volte la settimana la madre viene a far<br />
visita ad Antonio per qualche ora, puntuale da<br />
undici anni, si affaccia il pomeriggio alla porta.<br />
Lui ne percepisce la voce, il volto gli si accende,<br />
il corpo vibra in un dialogo fatto di intese,<br />
pause del respiro, lunghi accorati silenzi. Antonio<br />
e sua madre, vicini, celebrano la loro vittoria<br />
sul dolore stringendosi le mani in un<br />
bagliore di affetto che squarcia le tenebre.<br />
Roberto Zoldan<br />
19 (27)
GIORNALI STORICI<br />
Era difficile esercitare<br />
il mestiere di scrivere<br />
nella seconda metà<br />
dell’Ottocento<br />
di Enzo Magrì<br />
La prima riunione <strong>dei</strong> cronisti milanesi si<br />
tenne nel 1877, in un pomeriggio di luglio. Fu<br />
convocata da Francesco Giarelli, redattore<br />
capo della Ragione (un giornale radicale che<br />
aveva la redazione in via San Pietro all’Orto<br />
16), nella Fiaschetteria Toscana di Aurelio<br />
Franzetti. All’ordine del giorno non c’erano<br />
temi di carattere sindacale, bensì un problema<br />
di marcata rilevanza sociale: l’atteggiamento<br />
che i giornalisti avrebbero dovuto<br />
tenere di fronte al crescente fenomeno <strong>dei</strong><br />
suicidi.<br />
Alla fine di giugno di quell’anno, i dati statistici<br />
del comune di Milano avevano messo in<br />
rilievo che nel primo semestre c’era stato un<br />
chiaro aumento del numero <strong>dei</strong> suicidi e <strong>dei</strong><br />
tentativi di suicidio in città e nella provincia.<br />
Alcuni medici, e tra questi il professor Gaetano<br />
Pini, avevano messo quella lievitazione in<br />
relazione con l’eccessiva sottolineatura che<br />
la cronaca dava alle informazioni intorno a<br />
coloro che avevano deciso di finirla con la<br />
vita. Come oggi si dà la colpa ai mass media<br />
per la recrudescenza di alcuni eventi criminali<br />
(comparsa di serial killer, delitti a sfondo<br />
sessuale, rapine e cosi via), accusandoli di<br />
offrire spunti a psicolabili e a criminali per<br />
commettere certe nefandezze, cosi allora<br />
parecchi sanitari ritenevano che “la frequenza<br />
<strong>dei</strong> suicidi fosse il portato di un fenomeno<br />
di suggestione”. Erano convinti che gli insani<br />
gesti sarebbero diminuiti se la stampa quotidiana<br />
si fosse risolta a sopprimere le notizie<br />
riguardanti quei tragici avvenimenti in quanto<br />
la pubblicità, “quella offerta con lusso di particolari”,<br />
fosse fatta apposta per sviluppare un<br />
pericoloso spirito di imitazione. Gli scienziati<br />
citavano casi nei quali dopo un clamoroso<br />
suicidio, esposto, lumeggiato e particolareggiato<br />
dai giornali “a pascolo della pubblica<br />
curiosità” spessissimo ne seguiva un altro<br />
che era la perfetta riproduzione, o quasi, del<br />
primo.<br />
Nella Milano del 1877<br />
si pubblicavano dieci giornali<br />
Per una settimana circa la questione aveva<br />
occupato largo spazio nei fogli cittadini.<br />
Alcuni di questi si erano schierati a favore<br />
dell’enunciato degli scienziati. Altri l’avevano<br />
contrastato accusando i medici d’inutile<br />
allarmismo. Per mettere a confronto le due<br />
tesi, Giarelli organizza quella che oggi si<br />
chiama una tavola rotonda fra i suoi colleghi.<br />
Nel 1877 a Milano si pubblicavano dieci<br />
giornali. Il più diffuso era Il Secolo (quasi 30<br />
mila copie di vendita), nato il 5 maggio del<br />
1866, con sede in via Pasquirolo. Seguivano:<br />
Il Pungolo, che nella sottotestata recava<br />
la scritta “giornale politico popolare”, La<br />
Perseveranza, conservatore, organo della<br />
classe dirigente cittadina; Il Corriere della<br />
Sera, coeditore proprietario, Eugenio Torelli<br />
Viollier; La Ragione, diretto da Felice Cavallotti;<br />
La Lombardia, periodico affidato alla<br />
direzione di Emilio Broglio; l’Unione, quotidiano<br />
della sinistra che appoggiava Depretis;<br />
Il Sole, organo politico economico<br />
fondato da aderenti al partito radicale; l’Osservatore<br />
Cattolico, foglio politico religioso<br />
diretto da don Davide Albertario, e, infine<br />
Lo Spettatore, di orientamento clerico-liberale.<br />
All’invito di Francesco Giarelli rispondono<br />
Daniele Rubbi, cronista della La Perseveranza,<br />
Luigi Perelli della Lombardia, Luigi Della<br />
Beffa del Sole, Vincenzo Broglio e Leopoldo<br />
Bignami del Pungolo, Luigi Menghini e<br />
Raffaello Barbiera del Corriere della Sera,<br />
Pietro Carboni dell’Unione, Lorenzo Lertora<br />
dell’Osservatore Cattolico ed Aristide<br />
Pecchio Ghiringhelli dello Spettatore.<br />
La riunione fu disertata dal rappresentante<br />
del Secolo con una “comunicazione motiva-<br />
La prima riunione di cronisti a Milano.<br />
Quattro informatori per le notizie di bianca e di nera. Collaboratori pagati in natura.<br />
L’insostituibile figura del dottor Forbice.<br />
Gli austriaci anticipano d’un secolo l’invenzione della regola delle cinque W.<br />
Il giornalismo americano e quello milanese.<br />
Scrivere un articolo era come pronunziare un’arringa.<br />
Quando i giornalisti<br />
facevano i commessi<br />
Il manifesto<br />
pubblicitario<br />
de Il Secolo<br />
del 5 maggio<br />
1866<br />
e in basso<br />
il manifesto<br />
per il lancio<br />
de Il Giorno<br />
del 1956.<br />
I due giornali<br />
più innovativi<br />
della storia<br />
del<br />
giornalismo<br />
italiano<br />
scelsero<br />
lo stesso<br />
tema<br />
di lancio<br />
a novant’anni<br />
di distanza.<br />
Il Secolo,<br />
con una<br />
donna<br />
che apre<br />
la finestra<br />
su Milano,<br />
Il Giorno,<br />
nell’illustrazione<br />
di Raymond<br />
Savignac,<br />
con un<br />
omino che la<br />
spalanca<br />
sul mondo.<br />
ta”. Per dare un formale aspetto d’assemblea<br />
a quel meeting (il quale, per la presenza <strong>dei</strong><br />
fiaschi sui tavoli avrebbe potuto essere<br />
confuso per una rimpatriata fra amici), sono<br />
nominati un presidente (Vincenzo Broglio) e<br />
un segretario (Raffaello Barbiera). La serietà<br />
dell’impegno che tutti vogliono profondere<br />
nella trattazione del tema, traspare sin dalle<br />
prime battute del dibattito anche se contemporaneamente<br />
emerge lo spirito di corpo<br />
della categoria usa a pensare “più che con la<br />
testa con la testata”. L’antifona si coglie alle<br />
prime battute quando i due rappresentanti<br />
<strong>dei</strong> giornali confessionali pongono pregiudiziali<br />
di tenore opposto. Lorenzo Lertora informa<br />
(“mellifluamente” sottolinea Giarelli) gli<br />
astanti che si è presentato per puro spirito di<br />
solidarietà e di fraternità giornalistica. Spiega:<br />
“Il suicidio, cari colleghi, è, secondo l’Osservatore<br />
Cattolico, un delitto come un altro<br />
e si deve narrare: e state certi che, per la loro<br />
fede cattolica, i lettori dell’Osservatore certamente<br />
non imiteranno”. Gli fa eco Aristide<br />
Pecchio Ghiringhelli dello Spettatore il quale<br />
sostiene che anch’egli è venuto per non<br />
guastare l’armonia fraterna di quella prima<br />
adunanza. Ma ammonisce: “Tenete bene a<br />
mente che qualunque conclusione dovesse<br />
prendere quest’assemblea, essa sarà irrilevante<br />
per il mio giornale il quale come non<br />
pubblicò prima alcuna notizia sui suicidi e sui<br />
tentativi di suicidio così non ne pubblicherà<br />
in futuro”.<br />
Francesco Giarelli ricorda che dopo quel<br />
“saggio armonico”, la discussione si fece<br />
“ardente e generale”. “Si torturarono la Filosofia,<br />
la Statistica, la Demografia, la Medicina<br />
in pro e contrariamente alla tesi”. Ci fu chi<br />
sostenne essere la minuta descrizione <strong>dei</strong><br />
suicidi una remora e non un incitamento alla<br />
imitazione. E chi propugnò l’opinione opposta.<br />
La discussione durò, serrata, animata,<br />
un paio d’ore. Esaurite tutte le documentazioni<br />
(“e i fiaschi di Chianti”) fu adottato un<br />
ordine del giorno proposto da Giarelli e da<br />
Perelli. Il documento è una breve antologia di<br />
motivazioni adottate per non prendere alcuna<br />
decisione. Intanto, assumendo a pretesto<br />
l’assenza “volontaria e pretestuosa” del<br />
Secolo si decise di continuare la pubblicazione<br />
delle notizie <strong>dei</strong> suicidi. Tutti assunsero<br />
“l’obbligo di scrivere sull’argomento in modo<br />
che mentre si rispettano le convenzioni<br />
sociali, si tutelino il segreto e la dignità della<br />
famiglia”. Contemporaneamente, fu nominata<br />
la “solita commissione incaricata di studiare<br />
la questione e di riferire in una seduta<br />
successiva”.<br />
Di questa struttura furono chiamati a far parte<br />
Broglio, Rubbi, Giarelli e Perelli. I quattro non<br />
vennero a capo di niente. Lascio ancora la<br />
parola a Giarelli: “Si capì subito che il sentimentalismo<br />
di chi voleva la soppressione<br />
delle notizie sui suicidi aveva dato nelle<br />
secche della pratica. La commissione non<br />
aveva dinanzi a sé che un obiettivo affatto<br />
platonico. Non se ne sarebbe fatto più nulla.<br />
Né la cosa poteva differentemente succedere,<br />
dal momento che all’adunanza non aveva<br />
voluto dare adesione Il Secolo, la cui diffusione<br />
superava allora quella di tutti gli altri<br />
giornali milanesi presi assieme. Se quindi<br />
avessimo approvata la soppressione delle<br />
notizie <strong>dei</strong> suicidi, Il Secolo non si sarebbe<br />
minimamente tenuto vincolato a risoluzioni<br />
cui non aveva partecipato; e ci saremmo<br />
trovati perciò di fronte al pubblico in un’inferiorità<br />
informativa incalcolabile, data la<br />
pubblicità che il giornale avrebbe concesso<br />
ai suicidi e ai tentativi di suicidio, che volevansi<br />
sopprimere nel notiziario cittadino”.<br />
La riunione nella Fiaschetteria Toscana non<br />
fu inutile. Approfittando di quella prima, sia<br />
pure infruttuosa, assemblea fra cronisti milanesi,<br />
il promotore “pronunciò un appropriato<br />
discorsetto in cui mostrava il supremo bisogno<br />
<strong>dei</strong> giornalisti di stringersi gli uni agli altri<br />
coi vincoli della vicendevole assistenza e del<br />
mutuo soccorso”. Presentò un ordine del<br />
giorno che fu approvato all’unanimità. Riconosciuta<br />
la necessità di un’associazione solidaristica<br />
fra i redattori <strong>dei</strong> giornali quotidiani,<br />
i presenti deliberarono di dare mandato ad<br />
una speciale commissione “per istudiare la<br />
questione e prendere le misure opportune<br />
mettendosi in comunicazione coll’identica<br />
associazione che si sta costituendo a Roma”.<br />
Un’«orgia cartacea» seguita<br />
alla cacciata degli austriaci<br />
Individualisti come quelli d’oggi (nonostante<br />
l’esistenza d’un’organizzazione sindacale<br />
nazionale e locale), i redattori di allora ubbidivano<br />
alla legge della concorrenza che<br />
contrapponeva fra loro i fogli nei quali militavano.<br />
Le testate che uscivano a Milano a<br />
ridosso degli anni Ottanta erano il risultato<br />
dell’energica selezione che aveva subito la<br />
stampa dopo la fioritura di numerose iniziative<br />
editoriali, frutto dell’euforica “orgia cartacea<br />
seguita alla cacciata degli austriaci”. Allora<br />
accadde quello che successe nello stesso<br />
capoluogo lombardo subito dopo il 25 aprile<br />
1945.<br />
Nel volgere di sei mesi (1859), a Milano<br />
escono 28 diari politici. I più interessanti sono<br />
quattro. La Gazzetta di Lombardia, giornale<br />
ufficioso che si propone di soppiantare La<br />
Gazzetta Ufficiale di Milano, che era stato il<br />
foglio “d’ordine” degli austriaci. Tuttavia aveva<br />
fatto male i suoi conti. Inaugurando una tradi-<br />
20 (28) ORDINE 1 <strong>2004</strong>
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
zione, che giungerà intatta fino al 1945, La<br />
Gazzetta Ufficiale di Milano, abolita l’aquila<br />
imperiale ed emendata la testata dall’aggettivo<br />
“ufficiale”, continuò le sue pubblicazione.<br />
Non saltò neppure una copia: dal 133, il<br />
numero di venerdì 2 giugno, stampato durante<br />
il regno austriaco, passò al 134, quello di<br />
sabato 3 giugno, che vide la luce sotto il<br />
governo sabaudo. Una variazione subì il<br />
romanzo d’appendice: I principati danubiani<br />
furono sostituiti da I cento anni di Rovani.<br />
Nello stesso mese di giugno uscì Il Pungolo<br />
di Leone Fortis che era stato soppresso<br />
dall’Austria nel 1858. In novembre apparve<br />
La Perseveranza, l’organo della destra milanese.<br />
Strumenti per diffondere opinioni più che<br />
informazioni nel paese appena unificato,<br />
dove l’analfabetismo raggiunge vette del 74<br />
per cento (gli alunni che nell’anno 1863-1864<br />
frequentano le scuole elementari sono appena<br />
1.100.000 unità), i giornali milanesi assomigliano<br />
a quelli nazionali. Poveri di mezzi,<br />
contano, generalmente, quattro pagine e<br />
hanno due diversi formati: quello grande, è di<br />
solito di 60 centimetri per 43; il piccolo, misura<br />
39 centimetri per 27. Gli articoli sono<br />
composti da tipografi i quali utilizzano caratteri<br />
mobili che sono assemblati dentro<br />
compositori di legno. Questi saranno successivamente<br />
sostituiti da quelli in ferro, inventati<br />
in Francia. Per combinare lettere e numeri<br />
in parole, cifre e righe necessarie e riempire<br />
un foglio di quotidiano, occorrono almeno 12<br />
mila pezzi che un addetto riesce a mettere<br />
insieme nell’arco d’una decina d’ore.<br />
Le pagine, sia quelle <strong>dei</strong> giornali di piccolo<br />
formato sia quelle <strong>dei</strong> fogli di grande formato,<br />
sono piatte. I titoli quasi sempre ad una<br />
colonna risultano alquanto generici. Lo stile<br />
<strong>dei</strong> pezzi è sovente trasandato. Qualche volta<br />
il testo risulta incomprensibile.<br />
Avvocati e procuratori<br />
nel mondo <strong>dei</strong> giornali<br />
Fatte le dovute eccezioni, nel decennio<br />
successivo alla proclamazione dell’Unità, la<br />
stampa italiana, a causa delle magre condizioni<br />
in cui versa e per via delle appassite<br />
idealità risorgimentali, ripiega su impegni<br />
municipalistici e clientelari. Il giornalismo, la<br />
gran parte, “si mette al servizio” (come scrive<br />
Gaspare Barbera, editore in Firenze nel<br />
1873) “di chiesuole politiche, prive dell’appoggio<br />
d’una valida maggioranza”. I professionisti<br />
(in genere notai, avvocati, medici)<br />
avevano rappresentato il nerbo del giornalismo<br />
patriottico. A partire dal 1859, sono<br />
soprattutto gli avvocati e i procuratori che<br />
assumono importanti ruoli nel mondo <strong>dei</strong><br />
giornali.<br />
Dopo la nascita della nazione, continuò la<br />
commistione tra attività giornalistica e fervore<br />
politico. Il fenomeno consentì ad alcuni<br />
periodici, sovvenzionati dal governo, di restare<br />
in vita. Agli ex avvocati si affiancarono giornalisti,<br />
letterati, insegnanti, militanti politici.<br />
Dario Papa, giornalista del Corriere della<br />
Sera, agli inizi degli anni Ottanta si reca insieme<br />
con Ferdinando Fontana negli Stati Uniti<br />
per un giro d’orizzonte sulla stampa di quel<br />
paese. Al suo ritorno, oltre a scrivere un libro,<br />
New York, abbandona Il Corriere della Sera,<br />
lascia le idee monarchico-costituzionali e<br />
abbraccia quelle del centrosinistra. Ammirato,<br />
come non poteva non esserlo, del giornalismo<br />
americano, nel suo volume lo pone a<br />
confronto con quello italiano, anzi con il<br />
lombardo, che è il più moderno. “Gli uffici <strong>dei</strong><br />
giornali americani non sono come i nostri,<br />
infestati da una quantità di uomini di lettere<br />
che non si sentono nati a fare i piccoli servizi<br />
del pubblico, che hanno sempre delle grandi<br />
idee da espettorare, ma rifuggono dalla fatica<br />
di fare del giornale un veicolo di notizie<br />
anziché un’accademia. E cosi avviene che<br />
quei giornali là hanno tutti fra loro un tipo<br />
Articoli-arringa<br />
conditi di retorica<br />
diverso e se ne possono leggere parecchi in<br />
un giorno sicuri di trovarvi sempre del nuovo.<br />
Da noi invece si rassomigliano tutti, eccetto<br />
che per le opinioni propugnate. Ci rassomigliamo<br />
nelle parlate lunghe e retoriche e<br />
magari irte di erudizioni prese dall’Enciclopedia.<br />
Ci rassomigliamo nell’infantilità con cui<br />
sono fatti i giornali che maggiormente pretendono<br />
di avere dello spirito; ci rassomigliamo<br />
nell’amore delle rubriche che mettiamo al<br />
posto di quello delle notizie”.<br />
Il giornalismo italiano è segnato dall’impronta<br />
cavillosa della sua larga componente<br />
avvocatesca e dal tratto aulico dell’altra: la<br />
letteraria. Generalmente, gli articoli sono<br />
costruiti secondo i canoni dell’arringa. Uggiosamente<br />
analitici, sono conditi di retorica.<br />
Iniziano in maniera ariosa, si dispiegano fra<br />
argomentate premesse e giungono alla<br />
sostanza della questione faticosamente.<br />
Tutto il contrario dello schema espositivo<br />
richiesto dal vero giornalismo il quale esige il<br />
metodo sintetico con l’immediata enunciazione<br />
dell’accaduto, corredato dagli elementi<br />
che ne accompagnano la comprensione e<br />
l’interpretazione. Questi canoni, che appartengono<br />
al modo di scrivere di oggi, erano<br />
osservati dalle agenzie che informavano con<br />
dispacci asciutti.<br />
Buona parte <strong>dei</strong> giornali italiani, in particolare<br />
quelli di provincia (e gli altri che non avevano<br />
mezzi sufficienti per mantenere un’adeguata<br />
struttura redazionale), era fatta con i<br />
ritagli di altre pubblicazioni nazionali ed estere.<br />
Sempre Dario Papa, ricorda l’importante<br />
ruolo che svolge “il dottor Forbice” nelle redazioni<br />
<strong>dei</strong> fogli milanesi. Ora siccome quello<br />
del capoluogo lombardo è il giornalismo per<br />
antonomasia, cui la maggior parte <strong>dei</strong> redattori<br />
del resto d’Italia s’ispira, c’è da ritenere<br />
che la figura lumeggiata da Papa sia un insostituibile<br />
primo attore anche negli altri giornali<br />
che si stampano nella Penisola.<br />
Il dottor Forbice, annota il giornalista, è il<br />
mattiniero collaboratore che si dedica allo<br />
spoglio <strong>dei</strong> giornali. Egli lavora “da filosofo,<br />
senza scomporsi, menando colpi di forbice a<br />
dritta e a manca, tagliando il mondo a<br />
pezzetti e a pezzettini cui dispone in ordine<br />
sul tavolo per poi consegnarli, ben titolati al<br />
proto, accorciando di qui, combinando le<br />
notizie <strong>dei</strong> vari giornali, segnando col lapis<br />
questo articolo d’un giornale per il direttore,<br />
quest’altro per il cronista, quest’altro ancora<br />
per l’appendicista a seconda delle diverse<br />
attribuzioni; sfogliandoli uno a uno, e dando,<br />
con una rapidità nota a lui solo, una occhiata<br />
a tutti e singoli settanta od ottanta giornali<br />
che gli stanno dinanzi, anche a quelli delle<br />
più oscure città di provincia e cogliendo, sicuro,<br />
come l’artiglio d’un falco, una notizietta<br />
buona, seppellita in mezzo a un deserto di<br />
inutilità, per trasportarla nel giornale proprio”.<br />
Per la gran parte, il mondo della carta stampata<br />
ha ancora un taglio artigianale. Il dilettantismo<br />
marchia la componente redazionale<br />
e quella editoriale. Qui non mancano i<br />
gabbamondo. Illuminante l’analisi di Fra Zeno<br />
nel suo Quarto potere (1889) su come e<br />
perché nascono certi fogli. “L’individuo che si<br />
sente votato alla direzione di un giornale<br />
proprio, se ha quattrini fonda Il Globo, l’Universo,<br />
Il Paese od altro periodico dal titolo<br />
ampolloso. Se tale individuo è povero in<br />
canna, va in cerca d’un tipografo di buona<br />
fede, d’un fabbricante di carta credenzone e<br />
di collaboratori che sappiano e possano<br />
attendere, anche a lungo, uno stipendio iperbolico.<br />
Trovati i merli, il predestinato alla<br />
proprietà e direzione di un giornale, mette<br />
alla luce, putacaso, l’Asmodeo, come punterebbe<br />
l’ultimo napoleone su una carta. Se il<br />
pubblico, mordendo all’amo, acquista il nuovo<br />
giornale, la speculazione può considerarsi<br />
come avviata ed il direttore proprietario tira<br />
innanzi fidando nella Dea Bendata. Se, viceversa,<br />
il gemito della macchina tipografica fu<br />
gemito buttato e le copie del neonato periodico<br />
finiscono dal pizzicagnolo, l’improvvisato<br />
direttore proprietario si eclissa lasciando a<br />
mani vuote e naso allungato il tipografo, il<br />
cartaio ed i poco avventurati sacerdoti del<br />
‘quarto potere’ che avevano accettato di<br />
essere collaboratori”.<br />
Anche se questa che illustra Fra Zeno è una<br />
situazione al limite, la condizione della<br />
maggior parte <strong>dei</strong> giornali è davvero precaria.<br />
La redazione è generalmente formata dal<br />
direttore e da un paio di redattori: uno che si<br />
occupa degli esteri, l’altro degli interni. Quanto<br />
alle fonti d’informazione, esse sono principalmente<br />
gli altri giornali, l’agenzia Stefani<br />
(per le aziende che se la possono permettere)<br />
e i corrispondenti “che di solito sono amici<br />
del direttore i quali scrivono lunghe e sgrammaticate<br />
lettere”.<br />
Privi d’inquadramento professionale e salariale,<br />
i giornalisti sono considerati “agenti o<br />
commessi degli editori”. Le strutture delle<br />
nostre redazioni sono mediamente scarne<br />
rispetto a quelle straniere. La Neue Freie<br />
Presse di Vienna occupa 600 dipendenti (tra<br />
questi figurano 50 tra redattori e collaboratori<br />
interni, 120 corrispondenti dall’interno e<br />
altrettanti dall’estero e 150 impiegati esclusi<br />
gli operai). Il Corriere della Sera negli anni<br />
dell’esordio dispone di 123 dipendenti:16<br />
redattori, 10 impiegati, 44 tipografi, 47 speditori<br />
e distributori e 6 portieri. Benché per fare<br />
un giornale come il foglio di via Solferino nel<br />
1889 si spendano 177 mila lire l’anno, i<br />
compensi per i giornalisti sono una componente<br />
marginale.<br />
Il Monitore <strong>dei</strong> droghieri<br />
paga… in natura<br />
A quel tempo non sono più di quattro i direttori<br />
di giornale che guadagnano seimila lire<br />
l’anno, vale a dire cinquecento lire il mese.<br />
Cavallotti, quando dirigeva il Gazzettino<br />
Rosa, ne percepiva trecento; Silvio Spaventa,<br />
riceveva per ogni articolo che scriveva<br />
centocinquanta lire. Fatta eccezione per le<br />
personalità professionali, tutti gli altri ricevevano<br />
emolumenti meschini. Con quello che<br />
guadagnavano facendo i redattori, molti non<br />
sarebbero potuti sopravvivere se non avessero<br />
fatto un’altra professione. In parecchi<br />
casi erano anzi i giornalisti che finanziavano i<br />
giornali acquistando carature della testata.<br />
Francesco Giarelli ricorda che non era raro<br />
che il giornalista fosse pagato in natura. Incaricato<br />
di scrivere articoli di fondo per il Monitore<br />
<strong>dei</strong> droghieri per un compenso di dieci<br />
lire, egli stesso, dopo il primo numero, si vide<br />
versare la collaborazione in generi di salsamenteria.<br />
Andato a riscuotere la retribuzione,<br />
trovò il committente, il signor Vincenzo Torta,<br />
con un cartoccio di prodotti che gli sciorinò<br />
su un tavolo. C’erano: un chilogrammo di<br />
caffè, un chilogrammo di zucchero, due<br />
pacchi di steariche, sapone, essenza di<br />
gelsomino, bottiglie di Malaga, Madera,<br />
Alicante, amido, lucido per le scarpe, due<br />
spugne, un pacchetto di tè, cicoria, gomma<br />
profumata e pasta di Napoli.<br />
La mancanza di mezzi si riverberava ovviamente<br />
su tutti i “settori” del giornale, in particolare<br />
sull’organizzazione della cronaca<br />
cittadina. Diversamente dal resto della redazione,<br />
questa era però sostenuta da una<br />
scrittura si può dire “moderna” mutuata da<br />
una sorta d’involontaria lezione di giornalismo<br />
che il mestiere milanese aveva ricevuto<br />
ed ereditato dalla pignoleria degli austriaci.<br />
Per offrire ai giornali, “organi di governo”,<br />
informazioni “all’oggetto di eccitare l’interesse<br />
<strong>dei</strong> lettori”, l’imperiale ministro dell’Interno<br />
aveva incaricato della raccolta delle notizie la<br />
questura, il municipio e la Camera di<br />
commercio. Il dicastero aveva emanato<br />
21 (29)
Notizie nazionali<br />
e notizie cittadine<br />
successivamente una circolare con la quale<br />
esemplificava come in funzionari <strong>dei</strong> tre uffici<br />
avrebbero dovuto scrivere quelle note. Per<br />
evitare che trascendessero nelle forme retoriche<br />
e letterarie in voga all’epoca, gli estensori<br />
erano stati muniti d’un formulario. I diversi<br />
modelli d’annuncio andavano dalla morte<br />
d’un ultracentenario (Salomone N. d... è<br />
morto nell’avanzata età di 113 anni), all’incendio<br />
d’una cascina (un incendio, di cui<br />
s’ignora la causa, è scoppiato...); dalla visita<br />
dell’autorità alle reclute d’una caserma, all’esecuzione<br />
di “un traditore” (Lunedì 9 corrente,<br />
venne passato per le armi a... l’avvocato<br />
N… di... nella cui abitazione fu trovata una<br />
quantità di armi nascosta. Il vescovo di... e<br />
parecchi rispettabili personaggi si erano, ma<br />
invano, interessati per salvargli la vita. Il<br />
supplizio di questo causidico fece una straordinaria<br />
impressione…).<br />
Nonostante il prontuario che anticipa di almeno<br />
un secolo certe regole del giornalismo<br />
moderno (quello delle cinque W, per intenderci),<br />
sui giornali milanesi dell’Italia appena<br />
nata, scarseggia la cronaca, nera o bianca<br />
che sia. La narrazione <strong>dei</strong> fatti accaduti in<br />
città era stata praticamente inventata agli inizi<br />
dell’Ottocento da madame Ester Guimont.<br />
Bella, spiritosa, elegante, la signora era<br />
amica di Balzac e di Dumas i quali frequentavano<br />
il suo salotto insieme con il mondo<br />
elegante parigino.<br />
Pare che sia stata proprio lei (lo racconta<br />
Balzac) a dare ad un redattore del Constitutionnel,<br />
lo stesso giornale che inventerà il<br />
feulletton, il consiglio di raccogliere in una<br />
speciale rubrica tutto ciò che accadeva nella<br />
capitale francese.<br />
Il nuovo modo di fare giornalismo approderà<br />
con molto ritardo nel capoluogo lombardo. La<br />
prima notizia di cronaca pubblicata dal paludato<br />
giornale La Perseveranza (un crollo),<br />
risale al 14 dicembre 1861, vale a dire 748<br />
giorni dopo la sua prima uscita. Successivamente,<br />
i fatti del giorno saranno radunati<br />
sotto due rubriche (una nazionale, l’altra di<br />
rilievo cittadino) intitolate Notizie varie e Notizie<br />
cittadine.<br />
Ad introdurre sistematicamente e organicamente<br />
la cronaca nelle pagine d’un giornale<br />
milanese, fu agli inizi degli anni ‘70, Carlo<br />
Romussi del Secolo (diretto da Teodoro<br />
Moneta) attraverso un’attiva squadra di<br />
reporter. Miniscolo, sfacciato e permaloso,<br />
baffi spioventi e occhiali a pince-nez, Romussi<br />
era un assiduo dell’osteria la Patona e per<br />
questo motivo era stato soprannominato<br />
Bardolino. Divenuto capocronista (“l’uomo<br />
più combattente e più combattuto del mondo<br />
politico giornalistico milanese”), si serviva di<br />
parecchi informatori. La sua cronaca faceva<br />
perno su un gruppo di reporter assunto<br />
stabilmente.<br />
L’impronta popolare, l’oculata amministrazione,<br />
la macchina a stampa Marinoni, ma<br />
soprattutto l’ampio ventaglio di notizie che la<br />
sua cronaca offriva, contribuirono all’affermazione<br />
del Secolo che nel 1871, in una Milano<br />
che contava duecentoquarantaseimila abitanti,<br />
aveva soppiantato il Pungolo di Leone<br />
Fortis. Prima che l’avvocato Carlo Romussi<br />
pubblicasse quotidianamente e sistemarticamente<br />
ciò che era successo nel capoluogo il<br />
giorno precedente attraverso l’operoso staff<br />
<strong>dei</strong> suoi redattori, la cronaca cittadina, (quella<br />
nera e quella bianca) <strong>dei</strong> diversi fogli, era<br />
monopolio d’un pool di quattro persone.<br />
Della nera si occupava Vincenzo Broglio.<br />
Cinquantenne, ex garibaldino, lavorava come<br />
cronista al Pungolo ma raccoglieva le notizie<br />
per la sua e per le altre testate. Fonte principale<br />
era naturalmente la Questura. Sistemato<br />
dapprima nei locali dell’ex sede della polizia<br />
asburgica, in via Santa Margherita 16, il<br />
comando del Corpo delle guardie di pubblica<br />
sicurezza era stato insediato nel 1871 in<br />
piazza San Fedele, nel convento che era<br />
appartenuto ai Gesuiti. Broglio vi si recava<br />
tutte le mattine.<br />
Qui, in un apposito “libro nero”, trovava<br />
segnati e riassunti i dati <strong>dei</strong> rapporti che arrivavano<br />
dai mandamenti della città e le relazioni<br />
delle varie sezioni di Ps.<br />
All’inizio della carriera da solo, successivamente<br />
con l’aiuto di un giovanotto, certo<br />
Bruni (che poco più tardi abbandonò la<br />
carriera di reporter per fare l’agente teatrale),<br />
il giornalista del Pungolo copiava i<br />
rapporti che passava anche agli altri colleghi.<br />
Capitava spesso che l’ex garibaldino e il<br />
suo aiutante indugiassero diffusamente su<br />
fatterelli banali e tralasciassero eventi più<br />
gravi con la scusa che su quei fatti “era stato<br />
mantenuto il silenzio più assoluto perché con<br />
notizie premature non si doveva intralciare<br />
l’opera dell’istruttoria giudiziaria”. Sostenuto<br />
però dall’egregio suo servizio di “riportaggio”,<br />
il Secolo pubblicava all’indomani la faccenda<br />
grossa spingendo i giornali che avevano patito<br />
lo scoop a protestare con i due reporter i<br />
quali non sapevano fare altro che “mandare<br />
a quel paese la Questura e il suo servizio<br />
informazioni”.<br />
Un cronista veterano<br />
delle patrie battaglie<br />
La fonte della cronaca bianca era naturalmente<br />
il Comune. Ad attingervi le notizie era<br />
un impiegato dello stato civile. Felice Venosta,<br />
nobile, “veterano delle patrie battaglie”,<br />
aveva scritto una storia popolare delle<br />
Cinque Giornate e collaborava alla Collana<br />
<strong>dei</strong> Martiri Italiani, una raccolta in volumetti.<br />
Corrispondente ufficiale del Secolo, che gli<br />
passava un assegno speciale, distribuiva<br />
informazioni anche alle altre cronache ma<br />
per mezzo d’un impiegato municipale, ufficiale<br />
sanitario in forza alle pompe funebri, certo<br />
Luigi Bellerio. Sollecitato dai cronisti, che<br />
ambivano a restituire parte <strong>dei</strong> “buchi” che<br />
subivano dall’imbattibile primo quotidiano<br />
cittadino, non di rado il burocrate esagerava.<br />
Anziché limitarsi a fornire soltanto le notizie<br />
comunali, compiva incursioni nel campo della<br />
nera. Apportando marginali modifiche alla<br />
sua tenuta d’impiegato (uniforme nera, sciarpa<br />
bianca, bandoliera e luma nel cappello a<br />
cencio), si faceva passare per un poliziotto e<br />
riusciva ad estorcere informazioni riservate<br />
agli agenti veri oppure a protagonisti e a testimoni<br />
<strong>dei</strong> crimini accaduti. Lo slancio di<br />
rendersi utile, o più probabilmente la brama<br />
del compenso, spingevano il funzionario a<br />
strafare e ad inventare particolari imbarazzanti<br />
per i giornali che si servivano della sua<br />
collaborazione.<br />
Un’informazione così vaga e malsicura<br />
procurava non pochi infortuni al giornalismo<br />
cittadino. La frequenza del fenomeno è<br />
evidenziata da questa storiella che Paolo<br />
Ferrari, spirito caustico e autore drammatico<br />
di successo, amava ripetere. “Se il Pungolo<br />
annuncia oggi che tu sei stato travolto sotto<br />
una carrozza in piazza del Duomo rimanendone<br />
ucciso; e domani tu stesso, in carne e<br />
ossa, vai a pregare il Pungolo, vai a pregare<br />
Broglio, il papa della cronaca cittadina, che<br />
rettifichi, egli metterà, tutt’al più, brontolando,<br />
un secondo articoletto intitolato Nuovi Particolari<br />
che dirà a un di presso così: Abbiamo<br />
naturalmente continuato ad assumere informazioni<br />
intorno al triste fatto di piazza del<br />
Duomo, ieri assai succintamente narrato e<br />
con piacere siamo venuti a conoscere la<br />
conferma (sic) del fatto aggiungendovi anzi<br />
che il nostro egregio amico non solo non è<br />
morto, per causa di quel malnato brumista<br />
del numero tale, ma sta bene ed ha presentato<br />
il dovuto reclamo alla questura. Egregiamente;<br />
così va fatto”.<br />
Enzo Magrì<br />
GIORNALI STORICI<br />
Felice<br />
Cavallotti<br />
Felice Cavallotti in alcune illustrazioni d’epoca:<br />
in carcere e a Villa Cellere a Roma, dove avvenne il 33°<br />
duello contro il deputato-giornalista Ferruccio Macola.<br />
22 (30) ORDINE 1 <strong>2004</strong>
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
di Fabrizio de Marinis<br />
La morte lo volle al terzo assalto del trentatreesimo<br />
duello all’arma bianca della sua<br />
esistenza battagliera, vissuta all’insegna<br />
della denuncia e della democrazia, in difesa<br />
<strong>dei</strong> diseredati, giornalista d’impeto e d’impegno.<br />
Quel fiotto di sangue che gli sgorgò<br />
dalla bocca alle tre del pomeriggio del 6<br />
marzo 1898, nei giardini di Villa Cellere, a<br />
mezz’ora di carrozza da Roma, fuori Porta<br />
Maggiore, si trasformò in breve in una grande<br />
tragedia tutta italiana.<br />
La notizia fece il giro della penisola in un<br />
baleno. L’Italia si fermò. Felice Cavallotti era<br />
morto trafitto dalla sciabola del conte<br />
Ferruccio Macola, direttore e proprietario<br />
della Gazzetta di Venezia giornalista anche<br />
lui e deputato liberal-monarchico. La tragedia<br />
scosse a tal punto il paese che i suoi<br />
funerali, tenutisi a Milano il 9 marzo, furono<br />
paragonati, per l’imponente partecipazione,<br />
a quelli di Garibaldi e si trasformarono in<br />
una manifestazione popolare contro le forze<br />
conservatrici e moderate.<br />
Anche Giosue Carducci commemorò Cavallotti<br />
all’Università di Bologna come un eroe<br />
rivoluzionario vittima della reazione governativa.<br />
Non mancò l’accusa a Crispi di vero<br />
mandante della ferreità della mano armata<br />
di Macola, tale era l’odio che correva tra i<br />
due. Il polemista Olindo Guerrini, sotto lo<br />
pseudonimo di Lorenzo Stecchetti accusò<br />
in versi il Verre Crispi capo del Governo che<br />
un anno dopo porterà l’Italia alla tragedia<br />
ben più grave di Adua, che gli costò le<br />
dimissioni. Ed or che in bocca la civil rampogna<br />
il ferro ti recide, Verre beato nella sua<br />
menzogna, Verre il ribaldo ride…Verre t’inganni!<br />
Nel mortal duello non fu tua la vittoria.<br />
Con un colpo di spada o di coltello Non<br />
si uccide la Storia.<br />
Garibaldino e fustigatore<br />
del malcostume politico<br />
Garibaldino, deputato socialista, ferocemente<br />
anticrispino e tuonante fustigatore del<br />
malcostume politico, da anni conduceva<br />
contro il presidente del Consiglio una<br />
campagna durissima, accusandolo innanzitutto<br />
<strong>dei</strong> torbidi della Banca Romana che<br />
sfociarono nel 1893 in uno <strong>dei</strong> più devastanti<br />
scandali bancari nella storia d’Italia, poi di<br />
bigamia, falsa testimonianza, aggiottaggio,<br />
concussione, millantato credito e corruzione.<br />
Ma la scomparsa del Bardo della democrazia,<br />
dell’Arcangelo fiammeggiante dell’ideale,<br />
come lo definivano allora artisti e<br />
letterati, fu in verità una doppia tragedia per<br />
il paese, perché Cavallotti era l’unica personalità<br />
politica che avrebbe potuto mediare<br />
quello che poi accadde. La rivoluzione del<br />
1898 che portò alle cannonate di Bava<br />
Beccaris, il 7 maggio 1898, con 80 morti<br />
ufficiali, oltre 500 secondo i manifestanti, e<br />
migliaia di feriti a Milano e le imponenti<br />
sollevazioni del 26 e 27 aprile 1898 a Faenza,<br />
Bari, Foggia, un incendio che si propagò<br />
anche a Siracusa, Palermo, Reggio Calabria,<br />
Benevento, Avellino, Minervino Murge,<br />
Ascoli Piceno, Caserta, Parma, Piacenza,<br />
Bologna, Ravenna, Livorno, Pisa, Siena,<br />
Brescia, Venezia, Genova. Una lacerazione<br />
devastante che attraversò l’intera penisola.<br />
Famosa di Cavallotti la Lettera agli onesti di<br />
tutti i partiti che fu pubblicata nel giugno del<br />
1895 sul Secolo di Milano del premio Nobel<br />
Ernesto Teodoro Moneta, in un apposito<br />
supplemento, e sul Don Chisciotte di Roma,<br />
nel pieno di una battaglia parlamentare che<br />
riguardava episodi di corruzione e concussione<br />
<strong>dei</strong> quali era accusato il primo ministro<br />
Francesco Crispi. Poeta anticesareo,<br />
come amava definirsi, Felice Cavallotti, nato<br />
a Milano il 6 ottobre del 1842, appartiene a<br />
quella folta schiera di intellettuali nati dalla<br />
Il trentatreesimo duello gli fu fatale. Poeta<br />
“anticesareo”, garibaldino, storico, drammaturgo<br />
e uomo politico anticrispino usò<br />
la sciabola con la stessa abilità della<br />
penna dando vita al Gazzettino Rosa e a<br />
La Ragione<br />
Il D’Artagnan<br />
del giornalismo italiano<br />
Milano <strong>dei</strong> Lumi del Verri e del Beccaria e<br />
forgiatisi nei campi di battaglia delle guerre<br />
d’Indipendenza. Oltre che giornalista fu<br />
storico e drammaturgo, ma soprattutto<br />
uomo politico, deputato radicale fin dal<br />
1873, rieletto per ben dieci legislature<br />
consecutive, sempre all’estrema sinistra.<br />
Iniziò fin da giovanissimo a scrivere poesie,<br />
investito da un sacro fuoco che lo divorerà<br />
fino alla morte, e già negli anni del liceo<br />
pubblicò con continuità articoli patriottici sul<br />
giornale Il Momento. La sua partecipazione<br />
all’Unità d’Italia lo vide nel 1860, fuggito di<br />
casa, nella spedizione di Giacomo Medici<br />
che raggiunse Garibaldi in Sicilia. Partecipò<br />
alla battaglia di Milazzo e iniziò la sua<br />
carriera di giornalista come corrispondente<br />
di guerra per La Gazzetta del Popolo della<br />
Lombardia. Raggiunse Napoli ed entrò nella<br />
redazione dell’Indipendente di cui era direttore<br />
Alessandro Dumas padre, autore <strong>dei</strong><br />
Tre Moschettieri, acceso finanziatore e<br />
sostenitore di Garibaldi.<br />
Una intensa attività<br />
letteraria e teatrale<br />
Tornato a Milano raggiunse Garibaldi in<br />
Trentino e continuò la sua carriera di giornalista,<br />
prima con Il Secolo, poi fondando<br />
nel 1867 il Gazzettino Rosa, il giornale della<br />
Scapigliatura milanese, e nel 1875 La<br />
Ragione, una delle più innovative testate<br />
della storia del giornalismo italiano. E qui è<br />
bene aprire una parentesi.<br />
L’importanza di Felice Cavallotti fu letteraria<br />
e teatrale con un’ampia produzione di opere<br />
quali Storia della insurrezione di Roma nel<br />
1867 (1869), I Pezzenti (1881), Il romanzo<br />
del tutore (1893), Guido e Agnese (1873),<br />
Alcibiade (1874), I Messeni (1877), La<br />
sposa di Menecle (1882), Il libro <strong>dei</strong> versi<br />
(1898).<br />
Ma fu soprattutto nel giornalismo che egli<br />
innovò stile e modalità, prima come inviato<br />
di guerra, poi rivoluzionando la Cronaca e<br />
trasformandola in uno <strong>dei</strong> massimi strumenti<br />
di competizione <strong>dei</strong> giornali che diresse e<br />
fondò, facendo scuola. La cronaca attiva e<br />
concorrenziale fu una scelta che funzionò e<br />
diede al giornalismo italiano nuova vitalità –<br />
scrive Paolo Murialdi in Storia del Giornalismo<br />
italiano - Il metodo adottato da Carlo<br />
Romussi al Secolo di Ernesto Teodoro<br />
Moneta, fu largamente approfondito da<br />
Francesco Giarelli nel giornale di Cavallotti<br />
La Ragione. Si trattava di un metodo di<br />
lavoro apparentemente semplice ma denso<br />
di capacità relazionali e diplomatiche e<br />
nuovo per il tempo. Andare tutti i giorni di<br />
persona, o mandare <strong>dei</strong> collaboratori-reporter,<br />
in municipio, negli uffici della polizia, in<br />
tribunale, all’ospedale; e frequentare con le<br />
orecchie aperte i teatri, i caffè, i salotti, le<br />
innaugurazioni e altri luoghi pubblici per<br />
cogliere ogni particolare, ogni notizia da<br />
riferire tempestivamente in redazione. Per<br />
capire meglio la datità storica di quanto<br />
parliamo dobbiamo fare riferimento all’intenso<br />
periodo innovativo nel quale tutto questo<br />
avveniva. Milano in quegli anni, sin dalla<br />
prima dominazione napoleonica, si<br />
trasformò nella capitale dell’editoria italiana.<br />
Fu il vero centro dell’ampio dibattito culturale<br />
promosso nell’Italia unita da giornali e<br />
riviste quali La Cronaca grigia, La Rivista<br />
minima, Il Gazzettino Rosa, Il Sole, La<br />
Farfalla, La Vita Nuova, Il Peludio. Tutte<br />
ospitavano articoli, recensioni, discussioni,<br />
polemiche i cui autori erano in gran parte i<br />
protagonisti della cultura scapigliata lombarda.<br />
L’intensa attività giornalistica favorì la<br />
nascita di una critica militante e di una<br />
cronaca attentissima, capace di colloquiare<br />
con intellettuali e scrittori di ogni parte del<br />
paese. Sono gli anni, per capirci in cui<br />
nasce, nel 1875 L’Illustrazione Italiana<br />
dell’editore e giornalista Emilio Treves, che<br />
Ebbe la carotide recisa in duello, il 6<br />
marzo 1898, da Ferruccio Macola, direttore<br />
della Gazzetta di Venezia, già fondatore<br />
e direttore del Secolo XIX<br />
grazie alle Tavole di Achille Beltrame e<br />
all’ampio spazio dato alle prime fotografie,<br />
si trasformò in un indice del costume italiano.<br />
Nel maggio del 1866 l’editore risorgimentale<br />
Sonzogno, dà vita a quello che sarà il più<br />
venduto quotidiano popolare italiano dell’epoca,<br />
Il Secolo, su cui trovano ampio<br />
spazio, appunto, le idee democratiche di<br />
Felice Cavallotti. Un ruolo importante svolgono<br />
anche altri due autorevoli quotidiani: il<br />
vecchio Pungolo, diretto da Leone Fortis e<br />
La Perseveranza, giornale di area cattolica.<br />
Nel 1876, l’intellettuale napoletano amico di<br />
Dumas padre, Torelli Viollier, fondò il Corriere<br />
della Sera, dando vita ad una delle più<br />
lunghe e combattute competizioni giornalistiche<br />
nella storia dell’editoria italiana, con il<br />
concorrenteIl Secolo, superato per numero<br />
di lettori solo nel 1904, con la direzione di<br />
Luigi Albertini.<br />
È il 1861, Cavallotti è corrispondente da<br />
Milano dell’Indipendente di Napoli, il giornale<br />
di Dumas. Nel paese si stanno preparando<br />
le elezioni <strong>dei</strong> deputati al primo Parlamento<br />
del Regno d’Italia. L’irruento giornalista<br />
manca per poco il suo primo duello. In<br />
una corrispondenza inviata al giornale se la<br />
prende con Visconti Venosta, già mazziniano<br />
e diventato uno degli esponenti del<br />
mondo politico lombardo. Lo definisce “un<br />
servo umilissimo del Ministro”. Il marchese<br />
Venosta, che non lo conosceva, lo sfida a<br />
duello e Cavallotti accetta. Lo salverà solo<br />
la sua giovane età: diciannove anni. Garibaldi,<br />
dopo la campagna del 1866, chiamerà<br />
quei tempi “ borgiani”. Il Gazzettino<br />
Rosa di Cavallotti li sfiderà. Contrariamente<br />
a quanto sembra promettere il nome della<br />
testata, da presse du coeur, si tratta di un<br />
giornale politico e letterario d’avanguardia.<br />
Vi collaborano firme del tempo come<br />
Tarchetti, Rovani, Praga e poi Fabrizio Galli<br />
(Coq), Icio Polese (Scoglio), Angelo Bonetti<br />
(Azzeccagarbugli), Carlo Arrigoni (Semplicione),<br />
Aristide Montrezza (Verderame e<br />
Demofilo), Achille Ravizza (Virgola), Pietro<br />
Ravizza (Nemo), Fulvio Fulgonio (Farfarello),<br />
Francesco Giarelli (don Lumachino),<br />
Giuseppe Mussi (il galletto di donna Cecca)<br />
Andrea Ghinosi (Anomalo), Giacomo<br />
Raimondi (Economista) e Antonio Briglia<br />
(Trombone). Cavallotti ne è il direttore, si<br />
firma “Poeta anti-Cesareo”, e vi satireggia<br />
persone e istituzioni, incappando con una<br />
certa frequenza in sequestri, arresti e<br />
processi clamorosi.<br />
La prima grande serie di duelli è quella che<br />
lo vede coinvolto nella settimana che va dal<br />
26 gennaio al primo febbraio 1868. Il Cavallotti<br />
su questioni di cuore e di politica ha<br />
gettato lì una parola di troppo contro un ufficiale<br />
del reggimento cavalleria Ussari di<br />
stanza a Milano e viene sfidato. Gli sono<br />
padrini Billia e Ghinosi, due suoi amici, che<br />
cercano di far rientrare la crisi. Ma un<br />
martedì sera davanti al Biffi in Galleria, a<br />
Milano, il maggiore Maglia gli sguaina la<br />
spada sotto il naso.<br />
Il duello trasformato<br />
in torneo cavalleresco<br />
Cavallotti dando notizia dell’accaduto scrive<br />
al comandante del reggimento accusando<br />
di barbarismo e assoluta mancanza di<br />
cavalleria il comportamento del militare (i<br />
duelli avevano una ritualità severissima e<br />
sguainare in pubblica piazza era un gesto<br />
da tagliagole e banditi) e gli chiede se riconosce<br />
o meno il gesto del suo subalterno:<br />
nel caso gli fosse stato solidale si sarebbe<br />
dovuto considerare sfidato.<br />
Risposta: solidale lui e solidali tutti gli ufficiali.<br />
Quello che doveva essere un semplice<br />
duello si trasformò in un vero torneo cavalleresco<br />
con assalti alla sciabola da ambo le<br />
parti. In una sola notte Felice Cavallotti,<br />
23 (31)
I duellanti di Montecitorio<br />
Cavallotti non fu certamente l’unico duellante di Montecitorio. Il<br />
duello in quegli anni era un costume. Chi volesse rileggere l’intensa<br />
storia politica italiana dal 1860 al primo ventennio del Novocento,<br />
sul “filo di una lama d’acciaio affilato”, rimarrebbe sbalordito<br />
nell’elencare una serie congrua di nomi che, in un modo o<br />
nell’altro, hanno avuto a che fare con i complessi urti cavallereschi:<br />
Cavour, Barzilai, Belcredi, Bizzoni, Cavallotti, Bixio, Bonacci,<br />
Bovio, Cairoli, Ciano, Cicciotti, Colaianni, Conte di Torino, Crespi,<br />
Carducci, D’Annunzio, D’Arco, De Felice, Tommaso Villa, Zanardelli,<br />
Sonnino, Santini, Rostignac, Nicotera, Nigra, Minghetti, Ettore<br />
Ferrari, Gioliltti, Depretis. Tutti duellanti.<br />
Ma spesso come nello scontro tra Treves e Federzoni, poiché<br />
erano in pochi a saper usare veramente la sciabola, finiva tutto in<br />
una serie di auliche messe in guardia, tempi lunghissimi di attesa<br />
e qualche fendente di piatto, con fermo al primo sangue. L’unico<br />
duello dove ci scappò il morto fu quello di Cavallotti e Macola.<br />
Negli anni, ad avere la peggio e ad essere messa da parte, fu la<br />
sciabola tradizionale, pericolossissima in mani inesperte, che<br />
apriva vasti squarci e sanguinamenti. Poi la pistola non rigata,<br />
nella stessa caserma degli Ussari, in uno<br />
stanzone adibito alla bisogna, affiancato dal<br />
collega Achille Bizzoni, aveva duellato in<br />
coppia con ben quattro ufficiali. Entrambi ne<br />
uscirono illesi. In breve tempo scenderà in<br />
campo una quindicina di volte e tra i suoi<br />
avversari, il 5 agosto 1869, figurerà un certo<br />
sottotenente Edmondo De Amicis del quale<br />
uscivano allora i bozzetti della Vita militare.<br />
Il duello salta, nonostante De Amicis fosse<br />
lì in attesa, perché nello stesso giorno, sullo<br />
stesso campo, nello scontro precedente<br />
Cavallotti e il luogotenente Ludovico Cisotti,<br />
che si stavano affrontando, si feriscono<br />
vicedendevolmente e il medico proibisce la<br />
successiva contesa tra i due letterati.<br />
Poesie ritenute offensive<br />
della pubblica decenza<br />
Il D’Artagnan del giornalismo italiano è<br />
costretto a riparare a Dagnente, sul lago<br />
Maggiore, perché inseguito da un mandato<br />
di cattura per la pubblicazione di alcune<br />
poesie ritenute offensive la pubblica decenza.<br />
Lì nascosto dà vita all’Alcibiade. La<br />
lunga catena di duelli riprenderà subito<br />
dopo la sua nomina a deputato, che ha il<br />
potere di sottrarlo al pericolo di finire nuovamente<br />
in galera. Ha tanto di immunità parlamentare<br />
ora e il 28 novembre 1873 si<br />
presenta alla Camera, dove lo si attende al<br />
varco del rituale giuramento di fedeltà alla<br />
monarchia sabauda di cui era un acerrimo<br />
fustigatore.<br />
Per farlo firmare dovrà scendere in campo<br />
Garibaldi che alla fine riesce a convincerlo.<br />
Al suo ingresso a Montecitorio si scatena<br />
una baraonda incredibile. Alla fine ci scappa<br />
il solito duello, il primo del suo soggiorno<br />
romano, che durerà venticinque anni. Avversario<br />
di turno il direttore del Fanfulla,<br />
Baldassarre Avanzini, reo di aver scritto un<br />
articolo sulla movimentata seduta che non<br />
era andata a genio al Cavallotti. Lo scontro<br />
alla sciabola avvenne, il 3 dicembre, fuori<br />
Porta San Sebastiano e il neodeputato<br />
venne ferito al braccio destro. Ma nel pomeriggio<br />
era già a tuonare in Parlamento<br />
perché venisse concessa l’autorizzazione<br />
contro di lui richiesta dal Procuraore del Re<br />
di Milano, ottenendola. Intanto telegrafa a<br />
Dario Papa, direttore del Pungolo:“ritenetevi<br />
schiaffeggiato”. Papa risponde “ritenetevi<br />
morto”. Il duello si terrà a Milano nei giorni<br />
del Natale successivo, quando verrà<br />
presentato il suo Alcibiade che in scena<br />
ottiene quaranta chiamate di applausi.<br />
Autorizzazione a procedere<br />
per il reato di duello<br />
Da oggi in poi negli atti parlamentari ricorrerà<br />
a periodi alterni l’annotazione di prammatica<br />
“Il Ministro Guardasigilli trasmette<br />
alla Camera domanda di autorizzazione a<br />
procedere per reato di duello contro il deputato<br />
Cavallotti”. Quasi un rito che accompagna<br />
la caduta del governo di Destra e la<br />
formazione del gabinetto Depretis, l’ascesa<br />
di Crispi e il trasformismo (una cagnetta che<br />
ha in campagna a Dagnente, il Cavallotti la<br />
battezza Lina, che è il nome della terza<br />
moglie di Crispi), la Triplice e l’uccisione di<br />
Oberdan, l’acquisto della baia di Assab e la<br />
questione di Tunisi.<br />
Cavallotti si batte a Bologna con Luigi Lodi,<br />
ancora a Bologna, nel giro di tre giorni, con<br />
quattro membri del Club Felsineo. A Genova<br />
affronta il capitano Araldi, a Roma il Berti<br />
e subito dopo alla sciabola il direttore della<br />
Gazzetta di Mantova, Luzio e il giornalista<br />
Luzzatto. Ma non è finita, mentre sfumano<br />
per motivi tecnici i duelli con il principe<br />
Colonna di Cesarò, con Arturo Lobbia e con<br />
Giovanni Bovio, lo prende di mira il Guerin<br />
andata in disuso per via della “carica addomesticata” dal tecnico<br />
armaiolo. Prevalse, infine, per le questioni cavalleresche, la rigida<br />
spada Greco, dal nome del famoso armaiolo spadaccino di<br />
Roma, con la sede a due passi da Montecitorio, con la quale si<br />
era obbligati a lavorare di sola punta, facile quindi ad essere<br />
governata dal direttore di scontro e perciò, alla peggio, solo in<br />
grado di arrecare ferite non oltre l’avambraccio o l’omero.<br />
Altri clamorosi scontri furono quelli tra il ministro della Guerra<br />
Mocenni, appena fuori Porta del Popolo, a Roma, e Salvatore<br />
Barzilai, che fu costretto a dieci punti di sutura e perse un pezzo<br />
d’orecchio. Niente di fatto si ebbe invece nello scontro tra Mussolini<br />
e Ciccotti Scozzese, che dopo quattordici assalti crollò per<br />
insufficienza cardiaca. Altri ancora, degni di menzione, furono i<br />
duelli tra il sottosegretario alla Giustizia Daneo e Roux e contemporaneamente<br />
tra gli onorevoli Enrico Ungaro e Eugenio Sacerdoti,<br />
direttore del Don Marzio, e Pierantoni e Ottolenghi.<br />
Qui siamo a fine Ottocento. Portare ferite d’arma bianca era spesso<br />
un vezzo di pregio. D’Annunzio si batté a Chieti nel 1885 per<br />
ragioni giornalistiche con tal Magnini e si fregiò di un gran cerotto<br />
per lungo tempo alla tempia destra, dopo breve ebbe un nuovo<br />
duello con Scarfoglio, che finì con una gran pranzo di riappacificazione.<br />
(fdm)<br />
Meschino che parafrasando il titolo di una<br />
sua opera, il Cantico <strong>dei</strong> Cantici, lo apostrofa<br />
Mantice <strong>dei</strong> Mantici e lo accusa a più<br />
riprese di varie incongruenze politiche.<br />
Cavallotti sfida a duello il direttore Giovanni<br />
Pozza e tutta la redazione inclusi i collaboratori.<br />
Ferisce il Bordini, viene ferito da Francesco<br />
Pozza e dopo la guarigione di<br />
Giovanni Pozza, con lo stesso direttore, dal<br />
quale riceve, contraccambiandola una botta<br />
sanguinosa. È quasi in fin di vita a Piacenza,<br />
dove accusa un affondo al torace dal<br />
tenente Ambrosini e nel maggio del 1885<br />
rassegna le dimissioni da deputato. La<br />
Camera le respinge. Guarito ritorna a Roma<br />
dove diventa di fatto il capo riconosciuto e<br />
prezioso dell’estrema sinistra. Poco prima<br />
delle votazioni sul Patto di Roma, si scontra<br />
a villa Ada con il generale Corvetto e lo<br />
colpisce gravemente al volto, il no a Giolitti<br />
e gli scandali bancari vengono seguiti dallo<br />
scontro con Raffaello Giovagnoli, mentre le<br />
leggi eccezionali e la questione morale<br />
sono accompagnate da un’ombra funesta,<br />
quella del Macola, direttore della Gazzetta<br />
di Venezia. La vertenza col Macola nasce<br />
da cose banali.<br />
Il giornale pubblica una notizia in cui asserisce,<br />
che Cavallotti aveva indebitamente<br />
partecipato ad una riunione per un’autorizzazione<br />
a procedere verso un altro deputato.<br />
Nulla di più. La risposta non si fa attendere<br />
e Macola viene indicato come “mentitore<br />
di mestiere”. Basta questo per un primo<br />
scambio di padrini che però non trovano<br />
luogo a procedere.<br />
La risposta della Gazzetta non si fa attendere<br />
e definisce il Cavallotti “il bacchifilo di<br />
Corteolona” La sera del 4 marzo gli onorevoli<br />
Camillo Tassi e Achille Bizzoni s’incontrano<br />
con i padrini del Macola, i deputati<br />
Carlo Donati e Guido Fusinato. L’incontro<br />
avviene in una sala di Montecitorio. La data<br />
è fissata e, il 6 marzo, a Villa Cellere sarà la<br />
stessa contessa di Cellere a fare gli onori di<br />
casa con la cappella di famiglia trasformata<br />
in infermeria. Cavallotti è allegro e definisce<br />
il luogo più adatto ad una scampagnata che<br />
ad un duello. Alle 14,30 i due avversari sono<br />
in guardia.<br />
L’assalto fatale<br />
nel racconto <strong>dei</strong> padrini<br />
Ecco la testimonianza <strong>dei</strong> padrini. “Gli<br />
assalti – annota Bizzoni – direi meglio le<br />
messe in guardia furono tre. Al secondo, il<br />
più vivace, credemmo che Cavallotti fosse<br />
ferito di punta al fianco destro, ma la lama<br />
lo aveva appena sfiorato. Al terzo, fulmineo,<br />
Cavallotti fu ferito di punta alla bocca. Avevo<br />
creduto che soltanto il labbro fosse offeso.<br />
Ahimè no! La lama, entrando di parecchi<br />
centimetri aveva reciso la carotide”. E il<br />
Tassi: “ Al terzo assalto si gridò l’alt essendosi<br />
visto che la puntata del Macola, data<br />
mentre egli scartava a destra, aveva colpito<br />
il Cavallotti alla bocca. Cavallotti non se ne<br />
era accorto. Fermatosi, portò la mano alla<br />
bocca e mentre chiedeva: che cosa è, gli<br />
uscì un fiotto di sangue”. Appoggiato ai<br />
padrini riuscì appena ad arrivare alla cappella.<br />
È la contessa di Cellere a dare la notizia.<br />
L’Arcangelo fiammeggiante dell’Ideale è<br />
spirato. Macola fugge e da allora non sarà<br />
più lo stesso. Nel 1910, emarginato con l’accusa<br />
di essere stato un esecutore omicida<br />
per mano di Crespi, si sparerà un colpo di<br />
pistola alla tempia sui banchi di Montecitorio.<br />
Dopo qualche mese, con la stessa<br />
arma, si suicidò anche l’ultima moglie, Lina.<br />
Il Bardo della democrazia lasciò un vuoto<br />
incolmabile. Non c’è strada, non c’è piazza<br />
in Italia che ancora non porti il suo nome.<br />
“Lugete, Ausoni, doctae lugete Camenae!”.<br />
Piangete, italiani, urlò Carducci, piangete<br />
dotte muse!<br />
Fabrizio de Marinis<br />
GIORNALI STORICI<br />
La stampa<br />
socialista<br />
di Fabrizio de Marinis<br />
Vergognose storie di schiavi bianchi, diseredati<br />
del mondo, che dalla nascita alla morte conoscevano<br />
solo la miseria. Venivano raccontate ora con<br />
toni da Scapigliatura ora con piglio rivoluzionario<br />
e anarchico inneggiante alla lotta di classe. Il<br />
Martello, Italia Operaia, il Reduce Italiano, il<br />
Becco Giallo, La Lotta, La Farfalla e poi i grandi<br />
giornali come Il Secolo, del futuro Nobel per la<br />
pace Ernesto Teodoro Moneta, Il Gazzettino<br />
Rosa, fondato nel 1867 da Achille Bizzoni e Felice<br />
Cavallotti, per citarne alcuni, La Plebe, fondata<br />
a Lodi nel 1868 da Enrico Bignami, e così salutata<br />
da Giuseppe Garibaldi il 15 giugno 1868:<br />
“Carissimo Bignami, il titolo La Plebe con cui<br />
volete fregiare il vostro giornale è molto onorevole.<br />
Dalla feudalità <strong>dei</strong> baroni a quella <strong>dei</strong> monarchi,<br />
dai “bravi” di quell’epoca ai nostri “bravi”<br />
moderni, la “Plebe” è sempre stata oppressa e<br />
oltraggiata. Propugnandone i diritti vi siete assunto<br />
una responsabilità grave. Ma vincerete, avendo<br />
da parte vostra la vera forza, la giustizia”.<br />
Giornali testimoni<br />
degli scontri di classe<br />
Testimoni di un’Italia rivoluzionaria, innovativa,<br />
proiettata nella Modernità, percorsa da fremiti intellettuali<br />
e polemiche, duelli e feroci scontri di classe<br />
o di fazioni, tra conservatori e progressisti, i giornali<br />
operai e il vasto mondo del socialismo reale che,<br />
a metà Ottocento iniziò a delinearsi nelle loro pagine,<br />
diedero finalmente un’identità, uno spazio<br />
umano dove raccontare l’oscuro patimento della<br />
fame e della disperazione, la sofferenza del dover<br />
solo chiedere lavoro, a milioni di persone. La classe<br />
operaia non era ancora nata e allora essere<br />
socialisti era un reato. Ciò nonostante gli intellettuali<br />
radicali italiani, soprattutto nella Milano <strong>dei</strong><br />
Lumi, non si lasciarono intimidire o mettere il bavaglio.<br />
Ne nacque un’epopea, con fatti di una portata<br />
enorme, come la rivoluzione del 1898 che<br />
infiammò tutta l’Italia e portò alle cannonate di<br />
Bava Beccaris sulla indifesa folla, con 80 morti ufficiali<br />
e 500 secondo i manifestanti, e migliaia di feriti<br />
per le vie di Milano. Ma si delineò anche un’epoca<br />
di profonda e variegata crescita intellettuale che<br />
segnerà per sempre l’Italia moderna.<br />
“ Parlare di “Stampa operaia” è senza dubbio<br />
improprio” - racconta lo storico Giancarlo Galli -<br />
Tutta l’area era infatti connotata da pubblicazioni<br />
non periodiche, che duravano lo spazio di qualche<br />
mese, delle quali solo una, la “Tipografia milanese”<br />
operò con periodicità regolare.Tutti gli altri giornali<br />
vicini al mondo operaio avevano una precisa<br />
connotazione politica. Innazitutto “Il Secolo”, che<br />
diventò in breve, con oltre 100 mila copie di tiratura<br />
giornaliera, il più autorevole quotidiano nazionale<br />
oltre che milanese fino al 1904, quando venne<br />
superato nelle vendite dal “Corriere della Sera”..<br />
Fondato da Edoardo Sonzogno, proprietario della<br />
maggiore tipografia milanese, repubblicano-radicale<br />
e promotore di circoli e associazioni operaie,<br />
nonostante l’ampia partecipazione di intellettuali<br />
illuministi e l’apertura sociale, questo giornale,<br />
legato alla borghesia progressista, fu sempre<br />
guardato con un certo sospetto nei circoli operai e<br />
socialisti impegnati. Il socialismo milanese ebbe<br />
poi a disposizione, sia pure in misura diversa, due<br />
altri quotidiani: “Il Gazzettino Rosa” e “La Plebe”.<br />
Cronistico e polemico il primo, più impegnato politicamente<br />
il secondo, che rappresentò l’elemento<br />
di confluenza e di coagulo del socialismo legalitario<br />
sul quale, poco alla volta, finirono con convergere<br />
anche gli anarchici di Bakunin: dal conte<br />
Carlo Cafiero allo stesso Andrea Costa, dopo che<br />
apparve evidente l’impossibilità di cambiare lo<br />
Stato con la forza. Accanto ai grandi giornali,<br />
anche se “Il Gazzettino Rosa” e “La Plebe” in verità<br />
non riuscirono mai a superare il traguardo delle 10<br />
mila copie di vendita, tant’è che chiusero dopo<br />
breve vita, ci fu comunque un fiorire di moltissime<br />
pubblicazioni, segno di una vitalità notevole”.<br />
Un’epopea ricca di profondi fermenti, propositiva e<br />
innovativa nel contempo, che seppe convogliare<br />
attraverso ricchi e battaglieri fogli di propaganda,<br />
24 (32) ORDINE 1 <strong>2004</strong>
un flusso di idee inarrestabile. Una ricchezza di<br />
vaste proporzioni per la storia del giornalismo<br />
italiano che è emersa nella mostra Socialismo<br />
italiano. Cento anni di storia. Il Psi 1892-1992,<br />
organizzata lo scorso ottobre dalla Fondazione<br />
Anna Kuliscioff all’Arengario di Milano e prossimamente<br />
itinerante perché già richiesta da varie città,<br />
tra cui Mantova, Brescia, Ravenna, Bologna e<br />
Napoli. “ Nel 1875, sulla scena giornalistica milanese<br />
compaiono due quotidiani di colore acceso:<br />
“La Ragione” e “La Plebe” – racconta Paolo Murialdi<br />
in Storia del giornalismo italiano - Il primo è un<br />
foglio della sinistra radicale guidato da Felice<br />
Cavallotti, che orami è diventato il “Bardo della<br />
democrazia”, eletto due anni prima deputato e<br />
famoso per le sue sferzanti arringhe anche contro<br />
i suoi compagni di schieramento. Più significativo<br />
– anche se il tentativo ha breve durata – è il trasferimento<br />
de “La Plebe” a Milano che diventa quotidiano.<br />
Fondato a Lodi nel 1868 da Enrico Bignami,<br />
come bisettimanale, fu sottoposto ad una serie di<br />
interminabili angherie da parte delle autorità con<br />
l’inasprimento <strong>dei</strong> controlli polizieschi e degli intralci<br />
amministrativi iniziati nel 1869 e culminati nel<br />
1871 per i timori sollevati dalla Comune di Parigi.<br />
Si tratta del primo quotidiano socialista italiano.<br />
Nell’articolo di presentazione ai milanesi il 21<br />
novembre, si legge “ La nuova fase in cui è entrata<br />
anche da noi la questione politico-sociale faceva<br />
vivamente deplorare la mancanza di un organo<br />
quotidiano che, mentre ne propugnasse la soluzione,<br />
servisse d’intermediario e diremo quasi di<br />
simbolo di alleanza fra i vari gruppi che costituiscono,<br />
o costituire dovrebbero, il gran partito rivoluzionario<br />
italiano”.<br />
Nell’arco di una giornata<br />
sospesi cento giornali<br />
Ma La Plebe ebbe vita dura, significativa del clima<br />
che regnava in quei tempi dove, spesso, l’arma del<br />
sequestro serviva a mettere in crisi i giornali radicali<br />
e di opposizione alla monarchia. Uno <strong>dei</strong> casi<br />
più eclatanti accadde proprio a Milano nel 1862.<br />
L’Unità italiana, giornale mazziniano, fu praticamente<br />
costretto alla serrata perché erano più le<br />
volte che rimaneva sequestrato in tipografia che<br />
quelle in cui riusciva ad uscire. “ Dopo aver tentato<br />
di impedire la comparsa della Plebe a Milano –<br />
continua Paolo Murialdi - il prefetto e il questore la<br />
tartassarono con frequenti sequestri e denunce.<br />
Per questo motivo, per la debolezza politica e<br />
sindacale del mondo operaio e per la mancanza<br />
di mezzi (“il Bignami non possiede beni di fortuna”<br />
riconosce un rapporto della polizia) Bignami e<br />
Osvaldo Gnocchi Viani, principale articolista, devono<br />
rinunciare dopo tre mesi e mezzo a uscire tutti<br />
i giorni. La Plebe continua fino al 1882: in sedici<br />
anni di vita colleziona venti sequestri e ottantasei<br />
processi.” Ma il clima di quei tempi era così e i<br />
rapporti tra le autorità e il movimento intellettuale<br />
liberale, repubblicano e socialista erano da vera<br />
guerra civile. Basti pensare che la notte stessa<br />
delle cannonate di Bava Beccaris, il 7 maggio<br />
1898, furono arrestati in un sol colpo Fillippo Turati,<br />
Andrea Costa, Leonida Bissolati, il giornalista<br />
Carlo Romussi, Paolo Valera, De Andreis, Nofri,<br />
Morgari, Chiesi, Anna Kuliscioff e don Davide<br />
Albertario. Nell’arco di 24 ore furono soppressi tutti<br />
i circoli socialisti e repubblicani e furono sospesi un<br />
centinaio di giornali tra cui Il Secolo, l’Italia del<br />
Popolo, Lotta di Classe, Il Mattino e L’Osservatore<br />
Cattolico. L’accusa: “aver oltraggiato le istituzioni,<br />
combattuta la Monarchia e suscitato l’odio di classe”.<br />
Il Secolo ritornò in edicola solo dopo tre mesi,<br />
a settembre, un sabato, con una tiratura di 400<br />
mila copie, salutato da una folla di oltre 500 mila<br />
milanesi festanti. Anche il partito clericale fu bersagliato<br />
dalla reazione: furono infatti sospesi 70 comitati<br />
diocesani, 2500 comitati parrocchiali e 3000<br />
associazioni cattoliche legate all’Opera <strong>dei</strong><br />
Congressi. Numerosi socialisti, tra cui Ettore<br />
Ciccotti e Arturo Labriola, ripararono in Svizzera e<br />
dai tribunali militari in rito da corte marziale furono<br />
inflitte gravi condanne. L’onorevole De Andreis fu<br />
condannato a 12 anni di reclusione, l’onorevole<br />
Pescetti a 10 anni, Carlo Romussi a 5 anni e tre<br />
mesi, Don Albertario a 3 anni, Paolo Valera a 5<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
I giornali radicali e operai tra la metà<br />
dell’Ottocento e i primi anni del Novecento<br />
cambiarono definitivamente il volto<br />
della nazione ed emanciparono la classe<br />
operaia.<br />
Il Secolo, La Plebe, il Gazzettino Rosa, il<br />
Martello, La Farfalla, Lotta di Classe, Tito<br />
anni e sei mesi, Costantino Lazzeri a un anno, la<br />
Kuliscioff a 2 anni di detenzione, Turati, in difesa<br />
del quale testimoniò Edmondo De Amicis, fu<br />
condannato, come De Andreis a 12 anni di reclusione.<br />
Benché molti dirigenti del Partito socialista<br />
fossero estranei all’organizzazione <strong>dei</strong> tumulti, che<br />
in molti casi erano nati spontaneamente mossi<br />
dalla fame come le disorganizzate tipiche rivolte<br />
contadine, il governo e gran parte della stampa filogovernativa<br />
(dopo i tumulti del 1898 non ne esisteva<br />
altra) sostennero la tesi opposta, accreditando<br />
presso l’opinione pubblica che i tumulti erano stati<br />
organizzati da associazioni sovversive di sinistra.<br />
Bissolati, ad esempio, che era stato arrestato e<br />
scontò pure due mesi in carcere, al processo riuscì<br />
a dimostrare che in quei giorni <strong>dei</strong> tumulti non era<br />
né a Milano e nemmeno in Italia. La repressione<br />
raggiunse livelli così alti e di tale veemenza contro<br />
la stampa e il mondo <strong>dei</strong> giornali, socialisti, operai<br />
e di area, in modo particolare, che a Roma, l’11<br />
maggio 1898, furono arrestati in una sola volta tutti<br />
i redattori dell’Avanti!, il giornale socialista fondato<br />
nella capitale, il 25 dicembre del 1896, e diretto da<br />
Leonida Bissolati. Il 12 maggio fu chiusa anche<br />
l’Università per impedire la commemorazione <strong>dei</strong><br />
morti e le manifestazioni di solidarietà con i fatti di<br />
Milano, Pavia, Firenze e Napoli.<br />
Siamo d’altronde nel pieno dell’innovazione epocale.<br />
L’Italia sta entrando nella Modernità e i conflitti<br />
di classe sono vastissimi e profondi. Il dinamismo<br />
produttivo e un radicale processo di trasformazione<br />
ed ammodernamento delle risorse tecnologiche,<br />
costituirono il tratto distintivo dell’economia<br />
milanese, rappresentativa dello sforzo economico<br />
del paese, degli ultimi decenni dell’Ottocento, dove<br />
andava affermandosi con forza una borghesia<br />
progressista ed innovativa. Gli investimenti nelle<br />
industrie tessili, meccaniche, chimiche e poligrafiche<br />
collocavano la città più europea dell’Italia del<br />
tempo, al centro di uno straordinario processo di<br />
trasformazione e di crescita economica. Negli anni<br />
che vanno dal 1880 al 1890 Milano diventa punto<br />
nevralgico del sistema bancario e assicurativo<br />
italiano. La “capitale morale” fu punto di attrazione<br />
anche degli imprenditori stranieri come Falck,<br />
Mylius, Bauer, Richard, che richiamarono denaro<br />
e grandi iniziative. Nomi come Pirelli, Breda si affermarono<br />
a Milano, mentre a Torino emergeva la<br />
famiglia Agnelli. I nuovi capitali venivano attratti<br />
soprattutto dalla carta stampata, e i nuovi industriali,<br />
molti <strong>dei</strong> quali progressisti ed illuminati, investirono<br />
ingenti capitali nel giornalismo, con le case<br />
editrici gestite sulla base di nuovi ed aggiornati<br />
criteri imprenditoriali. Nel 1892 l’industria poligrafica<br />
si collocava al terzo posto per numero di addetti<br />
ed era ancora in una fase di espansione. Undici<br />
quotidiani tra cui La Perseveranza, Il Secolo e il<br />
Corriere della Sera, nonché un’attivissima attività<br />
tipografica, svolta da piccole e piccolissime imprese,<br />
collegata alla stampa di libri e materiali cartacei<br />
di propaganda e per l’industria, sviluppavano<br />
lavoro e benessere.<br />
Scrittori professionisti, giornalisti “militanti”, autori di<br />
teatro e intellettuali impegnati erano gli artefici di<br />
una fervida attività culturale, costruita su una fitta<br />
trama di relazioni e d’iniziative.<br />
Anni di tumulti, di lotte<br />
e di grandi conquiste<br />
È questo il clima dove il crescente numero di giornali<br />
operai e di area cerca di farsi strada e attecchisce.<br />
“ Ci troviamo in una delle fasi più importanti<br />
per la nascita <strong>dei</strong> movimenti democratici italiani –<br />
sostiene Walter Galbusera, segretario della Uil milanese<br />
– avvenimenti di portata epocale che segnarono<br />
l’ingresso dell’Italia nel mondo Moderno. La<br />
base e le radici del movimento socialista, laico e<br />
liberaldemocratico nel nostro paese. Anni di tumulti<br />
e lotte di incredibile forza. Anni che andrebbero<br />
ristudiati e rivissuti per ritrovare la memoria. C’è un<br />
filo continuo tra repressione ed evoluzione. Non a<br />
caso la fase risorgimentale, che con i principi di<br />
libertà, eguaglianza, innovazione, crescita della<br />
qualità del lavoro e <strong>dei</strong> rapporti tra padroni ed<br />
operai, impose una svolta sostanziale alla storia<br />
del nostro paese, trovò come contraltare atti repressivi<br />
gravissimi come quelli che portarono alle<br />
Vezio, Critica Sociale e Avanti furono<br />
bandiere d’innovazione e di battaglia.<br />
Quell’epoca di grandi mutamenti è stata<br />
ripercorsa nella rassegna “Cento anni di<br />
storia del socialismo italiano (il Psi 1892-<br />
1992)” promossa dalla Fondazione Kuliscioff<br />
all’Arengario di Milano<br />
Storie di schiavi bianchi<br />
nell’Italia appena unita<br />
cannonate di Bava Beccaris e alle rivolte del 1898.<br />
Certo allora la grande molla fu la fame, ma era<br />
come se si raccogliessero i frutti di decenni di lotte<br />
illuministiche, socialiste e democratiche, poi nuovamente<br />
fermate con il fascismo. La continuazione di<br />
quei valori risorgimentali riprese, in certo qual<br />
modo, nel dopoguerra, con i grandi movimenti di<br />
solidarietà che hanno costituito la storia della lotta<br />
di classe in Italia. Allora si sviluppò un movimento<br />
innovativo che fu trasversale in tutte le classi e che<br />
determinò anche la nascita di una borghesia<br />
progressista, coraggiosa e riformista, nel segno di<br />
una nuova modernità. Prendiamo, ad esempio<br />
della qualità di certe pubblicazioni progressiste e<br />
vicine al mondo operaio, che furono sostanziali ed<br />
importantissime per diffondere idee e creare solidarietà<br />
e relazioni, giornali come la “Vita internazionale”<br />
del premio Nobel ErnestoTeodoro Moneta,<br />
che era, allora, ben superiore per la qualità degli<br />
interventi al New York Times, con firme del calibro<br />
di Tolstoj e <strong>dei</strong> migliori enomisti europei del tempo”.<br />
«L’avvenire operaio<br />
è opera degli operai»<br />
Ecco allora Il Martello, settimanale fondato nel<br />
1872 da Vincenzo Pezza, un collaboratore del<br />
Gazzettino Rosa, che si pone come portavoce del<br />
Circolo Operaio di Milano, una sezione socialista<br />
nata da poco in stretta corrispondenza con l’Internazionale<br />
londinese di Marx ed Engels. Il suo esordio,<br />
il 4 gennaio 1872, è caratterizzato dal sequestro<br />
della pubblicazione. Italia Operaia, esce nel<br />
1880, quando già c’è nell’aria l’allargamento del<br />
suffragio elettorale e la costituzione del Partito<br />
Operaio. Il programma del giornale si fonda su<br />
queste dichiarazioni: “L’avvenire operaio è opera<br />
puramente degli operai. Il nostro scopo principale<br />
è l’emancipazione intellettuale ed economica <strong>dei</strong><br />
lavoratori.” La Rivista internazionale del Socialismo,<br />
merita di essere ricordata, anche se non<br />
andò mai alle stampe, perché rappresenta proprio<br />
un segno <strong>dei</strong> tempi e del clima nel quale molti giornalisti<br />
e tipografi dovevano lavorare. In via Cappellari,<br />
a Milano stavano lavorando al progetto,<br />
Andrea Costa e Anna Kuliscioff, quando vi fu<br />
un’improvvisa irruzione della polizia che sequestrò<br />
manoscritti e bozzoni di stampa arrestando i due<br />
socialisti. Il Reduce Italiano, esce nel 1880, ma non<br />
riuscirà mai a far parlare di sé più che tanto. Molto<br />
significativo per il livello dello scontro di classe allora<br />
in atto è La Lotta che esce il primo luglio 1870 e<br />
si definisce subito “La voce della canaglia” e dichiara<br />
nelle prime righe di un editoriale di fuoco “ La<br />
Lotta scende in campo armata di zappone a<br />
demolire il putrescente edificio. Non rispetterà né<br />
istituzioni, né uomini, né partiti per quanto venerabili,<br />
destre, sinistre, preti, repubblicani, ambiziosi<br />
farabutti che si contendono a date ore il potere, la<br />
prebenda, la croce, verranno da noi ridotti malconci<br />
e pesti. Porterà in piazza vizi, turpitudini, miseria,<br />
odi, dolori, ire, lacrime, vendete, maledizioni,<br />
trionfi, disfatte”. Il giornale Tito Vezio, che esce a<br />
Milano nell’agosto del 1880 al quarto piano di via<br />
Cesare Beccaria, diretto da Cesare Cova, dirigente<br />
dell’associazione “I figli del Lavoro”, viene salutato<br />
così in una lettera, del 30 agosto, scritta da<br />
Giuseppe Garibaldi, ad uno <strong>dei</strong> suoi redattori,<br />
l’operaio Cappello. “Caro Cappello, Tito Vezio<br />
significa emancipazione degli schiavi bianchi. Io<br />
saluto di cuore i militi della Liberazione”. Da ricordare<br />
anche La Farfalla, perché fondata a Milano, il<br />
16 aprile del 1882, da Filippo Turati. A questi seguiranno<br />
a ritmo continuo altre decine di pubblicazioni<br />
come L’Avvenire <strong>dei</strong> Lavoratori, Il Becco Giallo di<br />
Alberto Giannini, Libertà, il bollettino d’informazione<br />
Italia, di Filipo Turati, Non Mollare, L’asino,<br />
L’Avanguardia, il giornale della gioventù socialista<br />
italiana, La Voce d’Italia, Il Quarto Stato, rivista<br />
socialista di cultura politica, Il Lavoro di Genova,<br />
Lotta di Classe, nato nel 1892, Pasquino, uscito a<br />
Torino, nel 1902, La Sera, il Fascio <strong>dei</strong> Lavoratori,<br />
uscito nel 1894 e forse il più importante, per quanto<br />
attiene il livello di dibattito ideologico e politico,<br />
Critica Sociale, fondata da Filippo Turati nel 1891.<br />
Giornali che hanno segnato un’epoca e che<br />
rappresentano le radici della democrazia italiana.<br />
Fabrizio de Marinis<br />
25 (33)
CENTENARI<br />
Vigevano<br />
ricorda<br />
Besozzi<br />
Vigevano, 5 dicembre 2003. Quando<br />
Bernardo Valli ha preso la parola dal palco<br />
del teatro Cagnoni nella serata in ricordo di<br />
Tommaso Besozzi, giornalista-principe originario<br />
di Vigevano, la platea ha capito che le<br />
sue parole ne avrebbero tracciato il ritratto<br />
più vicino alla realtà.<br />
Sapeva che si stava andando oltre il ricordo<br />
di maniera, e che dalle parole dell’editorialista<br />
di Repubblica non sarebbe uscita una<br />
riflessione sul giornalismo d’inchiesta o sul<br />
cambiamento <strong>dei</strong> media.<br />
Argomenti, questi, lasciati da Valli a Ferruccio<br />
de Bortoli, ex direttore del Corriere della<br />
Sera, a Massimo Fini giornalista e scrittore,<br />
al caporedattore di Sette Antonio D’Orrico, e<br />
ad Enrico Mannucci coordinatore della serata<br />
e autore di una biografia di Besozzi. Valli<br />
conobbe Tommaso Besozzi, con lui lavorò al<br />
Giorno e lo incontrò poco prima che si<br />
togliesse la vita, quando ormai il suo stato di<br />
depressione ne aveva minato la voglia di<br />
scrivere e di vivere.<br />
“L’ultima volta che ho incontrato Tommaso –<br />
ha cominciato a raccontare l’editorialista di<br />
Repubblica pescando nella propria memoria<br />
– eravamo a Roma. Lui era dall’altra parte<br />
della strada. Aveva la solita andatura e i<br />
vestiti più in disordine del solito”.<br />
Valli ha rammentato poi gli anni trascorsi con<br />
Besozzi al Giorno, quando il grande cronista<br />
vigevanese scriveva in una stanzina al primo<br />
piano in via Settala. “Lui stava davanti alla<br />
macchina da scrivere con il pavimento attorno<br />
cosparso di fogli appallottolati”.<br />
Per Besozzi lo scrivere da sempre costituiva<br />
fatica. Non fu mai giornalista dalla<br />
penna facile. Provava e riprovava, accartocciando<br />
fogli e buttandoli via dopo due<br />
righe, prima di trovare il giusto attacco.<br />
“Quando dovette occuparsi dell’esondazione<br />
del Po – continua Valli – perse un intero<br />
Il “Codice” di Abruzzo e un<br />
articolo di Giovanni Rossi<br />
Pubblichiamo la lettera che il presidente dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti<br />
della Lombardia ha indirizzato a Michele Urbano, direttore di <strong>Giornalisti</strong><br />
(mensile degli enti di categoria).<br />
Giovanni Rossi, nel pur pregevole articolo sull’esame di Stato (<strong>Giornalisti</strong>, n.<br />
5/2003), esprime “il suo stupore per aver trovato testi nei quali si critica e si<br />
polemizza con il contenuto del contratto di lavoro Fnsi-Fieg”. Si riferisce al<br />
mio manuale “Codice dell’Informazione” (Centro di documentazione giornalistica,<br />
Roma aprile 2003). Rossi aggiunge: “Ognuno può far giungere la<br />
propria propaganda a chi vuole, ma certo questa non può essere veicolata<br />
come testo tecnico consigliato per un esame professionale”.<br />
Giovanni Rossi, ne sono sicuro, non ha sfogliato i due volumi (per 2607 pagine).<br />
Il codice dedica al contratto l’intera parte V (che racchiude 16 paragrafi<br />
dedicati a leggi, regolamenti e statuti) nonché il paragrafo 10 della parte VII<br />
(da pagina 1642 a pagina 1816). Il paragrafo 10 (<strong>Giornalisti</strong>, leggi <strong>dei</strong> media,<br />
contratto, previdenza) in 65 domande spiega questi argomenti: il contratto di<br />
lavoro; le leggi sull’editoria e sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato; le<br />
regole Fnsi, Inpgi, Casagit, Fondo pensionistico integrativo; il giornalismo<br />
on-line e gli uffici stampa nella pubblica amministrazione. Il paragrafo è arricchito<br />
con cinque mie analisi pubblicate tutte su riviste giuridiche. Il paragrafo<br />
10 alla domanda 577 ha un titolo eloquente (“Commenti e analisi della Fnsi<br />
sul nuovo Contratto 2001-2005”) e si sviluppa da pagina 1654 a pagina<br />
1671 (quindi per ben 17 pagine). In sostanza sul contratto ho pubblicato per<br />
intero i commenti e le analisi della Fnsi tratti dal sito www.fnsi.it. Offro, quindi,<br />
ai praticanti giornalisti non una lettura, ma più letture critiche con l’aggiunta<br />
di una ricerca giurisprudenziale di 41 pagine (1775-1816) sugli istituti<br />
contrattuali e previdenziali.<br />
In conclusione ribadisco che Giovanni Rossi non ha sfogliato il mio manuale,<br />
che è completo, esaustivo, pluralista e di livello scientifico, frutto di una ricerca<br />
trentennale. Vivo il giornalismo come “informazione critica”.<br />
Grazie per l’ospitalità, cordialità<br />
prof. Francesco Abruzzo<br />
Premiati<br />
due<br />
studenti<br />
che<br />
hanno<br />
approfondito<br />
la figura<br />
del<br />
giornalista<br />
pomeriggio alla ricerca della frase precisa<br />
pronunciata dall’ingegnere mandato dal<br />
Tribunale del Po’, per l’attacco. Solo in<br />
serata si decise a scegliere un altro inizio<br />
per il proprio articolo”.<br />
Una precisione quasi maniacale, la ricerca<br />
della verità a tutti i costi e la voglia di andare<br />
sempre sul posto, hanno fatto di Besozzi un<br />
giornalista atipico per il proprio tempo e<br />
incollocabile nella schiera <strong>dei</strong> cronisti di oggi.<br />
La televisione, i telefoni e i nuovi media<br />
hanno contribuito a far scomparire queste<br />
figure, delle quali pure si avverte ancora<br />
bisogno. “L’eredità di Besozzi – ha commentato<br />
Ferruccio de Bortoli – è quella di un<br />
grande inviato, una figura eccentrica che<br />
cerca di scoprire le linee, che stanno sotto<br />
gli avvenimenti. Le tante piccole e grandi<br />
storie che ha raccontato hanno offerto un<br />
prezioso spaccato della storia d’Italia del<br />
dopoguerra”. L’osservazione per le piccole<br />
“Basta con i viaggi<br />
della speranza”<br />
Abbiamo ricevuto la lettera che segue da un praticante. Le considerazioni<br />
e le esperienze vissute ripropongono una serie di interrogativi<br />
sulla professione che meritano ampie riflessioni.<br />
Caro presidente,<br />
sono reduce dalla prova scritta dell’esame da giornalista<br />
professionista svoltasi il 31 ottobre a Roma. Le<br />
scrivo perché il punto è proprio questo: le sembra<br />
normale che per sostenere un esame di abilitazione<br />
professionale si debba andare a Roma? Perché non<br />
è ancora possibile sostenere questo esame nelle sedi<br />
degli Ordini regionali?<br />
La mia lettera potrebbe avere in coda centinaia di<br />
firme, quelle di tutti i colleghi che da Torino a Palermo,<br />
ad ovvia eccezione <strong>dei</strong> laziali, hanno dovuto raggiungere<br />
Roma per svolgere la prova. All’unanimità siamo<br />
convinti che tale regola sia un’assurdità. Siamo in<br />
piena epoca federalista, poteri ben più importanti<br />
stanno passando nelle mani delle Regioni e noi, aspiranti<br />
giornalisti professionisti, dobbiamo ancora fare il<br />
“ viaggio della speranza” a Roma per prendere un titolo?<br />
Quello che abbiamo appena fatto non è un<br />
concorso, non vinceremo nessun posto di lavoro.<br />
Eppure, a molti questo viaggio ha ricordato quei<br />
concorsi degli anni ‘80 e ‘90, quando l’Ergife si riempiva<br />
di aspiranti impiegati al ministero delle Finanze o<br />
alle ex Poste e Telecomunicazioni.<br />
In termini economici questo esame è già abbastanza<br />
proibitivo. Sinora abbiamo speso ben oltre i mille euro<br />
tra tasse, libri e seminario. E, dulcis in fundo, abbiamo<br />
dovuto aggiungere il costo del viaggio e quello dell’<br />
albergo (Ergife) dove una camera singola, per una<br />
Vigevano. L’immagine che ne dà chi lo ha conosciuto è quella<br />
di un uomo schivo e lontano dai riflettori. Tommaso Besozzi<br />
non fu mai sicuro delle proprie capacità di cronista né<br />
riuscì mai a sopportare la fama. Anche per questi motivi la<br />
sua figura è stata quasi totalmente dimenticata. L’Associazione<br />
<strong>dei</strong> giornalisti vigevanesi “Giancarlo Rolandi” ha deciso di<br />
rendere omaggio, nel centenario della sua nascita, al giornalista<br />
e scrittore nato a Vigevano, promuovendo un convegno<br />
tenutosi venerdì 5 novembre al teatro Cagnoni e dedicandogli<br />
un’intera sezione del sito internet (www.assorolandi.it). Vi<br />
saranno pubblicati le ricerche di Laura Mattioli e Andrea<br />
Ballone, due studenti di sociologia dell’Università di Milano<br />
Bicocca. Laura Mattioli ha realizzato nell’ambito del corso di<br />
Storia del giornalismo, tenuto dal professor Franco Abruzzo,<br />
una ricerca sul giornalismo di inchiesta con particolare attenzione<br />
al caso della morte del bandito Giuliano trattato da<br />
Tommaso Besozzi. Andrea Ballone, invece, nella propria tesi<br />
di laurea in Storia del giornalismo, con relatore il professor<br />
Franco Abruzzo, ha analizzato i vari aspetti del giornalismo<br />
della Lomellina, dedicando un capitolo all’inviato dell’Europeo<br />
e del Giorno. Entrambi gli studenti sono stati premiati<br />
dagli organizzatori del convegno nell’ambito del convegno<br />
per ricordare Tommaso Besozzi.<br />
“Il più grande inviato degli anni 50”<br />
cose e l’attenzione quasi maniacale per i<br />
particolari erano tra le caratteristiche di<br />
Tommaso Besozzi, considerato “il più scrittore<br />
tra i giornalisti” pur avendo pubblicato un<br />
solo libro.<br />
Su questo punto si è soffermato Massimo<br />
Fini che lo ha definito “uno scrittore che<br />
aveva bisogno della cronaca” facendo eco al<br />
ritratto conclusivo di Tommaso Besozzi che<br />
ha tracciato Bernardo Valli: “Era un prigioniero<br />
della realtà e della cronaca cui è rimasto<br />
fedele. In tutti i suoi reportage c’è sempre il<br />
gusto del racconto”. Della cronaca e del<br />
racconto Besozzi in un certo senso è rimasto<br />
realmente prigioniero.<br />
È successo quando il suo valore di giornalista<br />
fu universalmente riconosciuto. Fu lì che<br />
trovò sempre meno argomenti ai quali interessarsi,<br />
che non riuscì più a riempire le<br />
pagine, cadendo nel baratro della depressione<br />
che lo condusse al suicidio. A.B.<br />
sola notte, costa 115 euro. Stiamo scherzando? Il<br />
problema si potrebbe risolvere in un attimo facendo<br />
diventare sedi d’esame gli Ordini presenti in ogni<br />
capoluogo di regione. Inoltre gli Ordini regionali<br />
potrebbero disporre di un numero di computer sufficienti<br />
da far usare per la prova scritta. Ciò eviterebbe<br />
anche la circolazione “giurassica” della macchina per<br />
scrivere. Avere a disposizione 700 computer è certamente<br />
più difficile che averne 10 o al massimo 20.<br />
Stessa logica si potrebbe applicare al seminario.<br />
Perché per prepararsi all’esame da professionista si<br />
è costretti ad andare a Fiuggi? Perché gli Ordini regionali<br />
non organizzano corsi in completa autonomia<br />
come fa già la Lombardia? In Puglia abbiamo meno<br />
forze giornalistiche capaci di sostenere un seminario<br />
di preperazione per un esame di abilitazione professionale?<br />
Io non credo che le cose stiano in questi termini,<br />
credo solo che Roma non voglia mollare lo scettro di<br />
“caput mundi”, singolarità che le riconosciamo a livello<br />
storico ma non certamente per un esame di Stato.<br />
Con apposite riforme e con un rapporto più diretto<br />
con gli Ordini regionali anche questo esame potrebbe<br />
umanizzarsi.<br />
Dalla Puglia alla Sicilia, dal Piemonte all’Emilia, dalla<br />
Sardegna al Friuli, passando per tutte le restanti<br />
regioni italiane (Lazio esclusa), la richiesta è unica<br />
“BASTA AI VIAGGI DELLA SPERANZA”!<br />
26 (34) ORDINE 1 <strong>2004</strong>
Paolo Gussoni<br />
Un amore impari<br />
di Carmen Del Vecchio<br />
Fin dove può arrivare lo stato<br />
lirico di un poeta che vuole<br />
esprimere in versi la propria<br />
relazione con la figura paterna?<br />
Fino a dire. “Riduttivo/<br />
pensarti padre, genitore: / eri<br />
migliore”. Come fa Paolo<br />
Gussoni in una sua raccolta<br />
di liriche dedicate a suo padre.<br />
I pensieri dell’autore si<br />
snodano con un linguaggio<br />
estremamente semplice e accessibile<br />
addirittura prosastico<br />
in molti versi tesi a riprodurre<br />
una quotidianità borghese<br />
in cui era immersa l’adolescenza<br />
e la giovinezza di<br />
Gussoni, come quando pensa<br />
al padre che parla “con la<br />
mia compagna di classe<br />
Francesca Forino/ quella che<br />
suonava il violino”.<br />
Non mancano comunque interessanti<br />
figure poetiche e rime<br />
dal tenore assai musicale:<br />
“Eri dotto, invadente./ Intervenivo<br />
raramente”.<br />
Da rilevare anche l’ispirazione<br />
autobiografica nei versi sciolti<br />
che rievocano l’amore del pa-<br />
Vito Antonio Leuzzi<br />
Bari 28 luglio 1943 –<br />
Memoria di una strage<br />
di Massimiliano Ancona<br />
Avrebbero voluto festeggiare<br />
la fine del regime e incontrare<br />
gli intellettuali antifascisti, come<br />
Tommaso Fiore, Giulio<br />
Butticci, Giuseppe Laterza, direttore<br />
della libreria omonima,<br />
«e numerosi giovani esponenti<br />
del gruppo liberal-socialista»,<br />
che quel giorno sarebbero<br />
stati scarcerati.<br />
Morirono in via Niccolò<br />
dell’Arca, colpiti dai soldati e<br />
dagli squadristi. Morirono in<br />
venti a Bari. Forse ventitré - la<br />
verità, a 60 anni dall’accaduto,<br />
è ancora sconosciuta - la mattina<br />
del 28 luglio 1943.<br />
Cioè tre giorni dopo la caduta<br />
della dittatura fascista e l’arresto<br />
di Benito Mussolini per ordine<br />
del re Vittorio Emanuele<br />
III. Fra le vittime, un ragazzo di<br />
15 anni e Graziano Fiore, figlio<br />
di Tommaso, che aveva compiuto<br />
18 anni quattro mesi prima.<br />
I feriti furono trentotto. Fra<br />
loro, un bambino di 8 anni e<br />
Fabrizio Canfora, che sarebbe<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
dre per la musica, i grandi interpreti<br />
del pianoforte e la sua<br />
padronanza della cultura e<br />
dell’esperienza musicale.<br />
Per questo nel lettore può<br />
sorgere un forte disappunto<br />
nei versi di chiusura dove<br />
Gussoni si dichiara stanco di<br />
un riciclare senza senso.<br />
“Voglio qualcosa di eterno per<br />
la mia esistenza”.<br />
Parlando tuttavia della figura<br />
del padre nella poesia italiana<br />
non si può non pensare ad un<br />
grande ermetico del ‘900:<br />
Camillo Sbarbaro.<br />
In due celeberrime liriche<br />
Sbarbaro si rivolse al padre<br />
dicendogli: “Padre, se anche<br />
tu non fossi mio padre”…<br />
“Padre che muori tutti i giorni<br />
un poco”, con un linguaggio<br />
apparentemente molto più<br />
umile di quello di Gussoni per<br />
la semplicità delle scene rievocate<br />
ma destinate a vera<br />
immortalità per la sua forza<br />
trascendente.<br />
Paolo Gussoni,<br />
Un amore impari,<br />
Edizioni Libroitaliano Poeti<br />
Italiani Contemporanei,<br />
pagine 56, euro 9,29<br />
diventato uno <strong>dei</strong> maggiori<br />
esponenti del partito comunista.<br />
Morirono o furono feriti<br />
perché il fascismo – di fatto –<br />
non era ancora terminato.<br />
Morirono o furono feriti perché<br />
«salvaguardare gli interessi di<br />
casa Savoia e garantire la<br />
continuità dello Stato furono i<br />
princìpi ispiratori delle forze<br />
monarchico-badogliane nei<br />
quarantacinque giorni che separarono<br />
il 25 luglio dall’8 settembre»,<br />
giorno in cui venne<br />
reso noto l’armistizio con le<br />
forze angloamericane.<br />
Morirono o furono feriti perché<br />
i soldati applicarono alla lettera<br />
il decreto del generale<br />
Mario Roatta del 26 luglio<br />
1943 - ma ispirato dal maresciallo<br />
Pietro Badoglio, nuovo<br />
capo del governo – nel quale<br />
era scritto: «È fatto tassativo<br />
divieto di riunione in pubblico<br />
di più di tre persone, di tenere<br />
in locali chiusi adunate, manifestazioni,<br />
conferenze… Le<br />
truppe, le pattuglie, gli agenti<br />
della forza pubblica e dell’ordi-<br />
LA LIBRERIA DI TABLOID<br />
Goffredo Giovannetti<br />
Magnus<br />
di Vito Soavi<br />
Quando sono arrivato alla<br />
conclusione del romanzo di<br />
Giovannetti, a pagina 315, mi<br />
è dispiaciuto di non trovarne<br />
altrettante, da leggere, come<br />
le prime, tutte di un fiato.<br />
Perché la storia del conto cifrato<br />
Magnus depositato alle<br />
isole Cayman è affascinante<br />
e coinvolgente, e fa emergere<br />
le doti di cronista di classe<br />
dell’autore, che dalla realtà<br />
sa cogliere tutti gli spunti di<br />
fantasia, necessari a cucire<br />
una vicenda di sorprendente<br />
realismo.<br />
Partendo da un’inchiesta sui<br />
lavoratori schiavi del nazismo,<br />
ne, comunque alle mie dipendenze,<br />
sono incaricati della<br />
imposizione, occorrendo anche<br />
con le armi… Nella situazione<br />
attuale col nemico che<br />
preme, qualunque perturbamento<br />
dell’ordine pubblico anche<br />
minimo, et di qualsiasi tinta,<br />
costituisce tradimento et<br />
può condurre, ove non represso<br />
at conseguenze gravissime;<br />
qualunque pietà e qualunque<br />
riguardo nella repressione<br />
sarebbe pertanto delitto.<br />
Poco sangue versato inizialmente<br />
risparmia fiumi di sangue<br />
in seguito. Perciò ogni<br />
movimento deve essere<br />
stroncato in origine…». Così<br />
fu a Bari il 28 luglio del ‘43.<br />
Questo episodio «può considerarsi<br />
la prima strage<br />
dell’Italia all’indomani del crollo<br />
della dittatura e può aiutare a<br />
comprendere i pesanti condizionamenti<br />
del vecchio apparato<br />
statuale nel processo di<br />
transizione dal fascismo al dopo-fascismo»<br />
scrive lo storico<br />
e giornalista Vito Antonio<br />
in un futuribile anno 2009, che<br />
si conclude con uno spietato<br />
assassinio, l’autore ci trasporta,<br />
attraverso una fittissima rete<br />
di eventi e di capovolgimenti,<br />
ad un ricatto atomico all’Europa,<br />
finanziato da uno<br />
sceicco di Hamas, per detronizzare<br />
il suo avversario, il re<br />
dell’Arabia Saudita.<br />
Tutto viene narrato in modo<br />
perfettamente coerente, chiamando<br />
alla ribalta e coinvolgendo,<br />
di volta in volta, il fondamentalismo<br />
islamico, il servizio<br />
israeliano Mossad, la<br />
Jihad, e tutti i servizi di intelligence<br />
delle potenze mondiali<br />
in eterna lotta per il possesso<br />
della principale fonte energetica,<br />
il petrolio.<br />
Luciano Vaccaro e Claudio Stroppa<br />
Ora et labora. Le comunità religiose<br />
nella società contemporanea<br />
di Margherita Santagostino<br />
Il volume contiene gli atti del<br />
Convegno omonimo tenutosi<br />
presso l’Abbazia di Chiaravalle<br />
nel settembre 2002, promosso<br />
oltre che dalla stessa<br />
Fondazione Ambrosiana Paolo<br />
VI, dall’Università di Pavia e<br />
dall’Università Cattolica di Milano,<br />
da Banca Intesa, dalla<br />
Fondazione Cariplo, dal Comune<br />
e dalla Provincia di<br />
Milano e dalla Regione Lombardia.<br />
Esso è diviso in due<br />
parti: la prima curata da Luciano<br />
Vaccaro, segretario generale<br />
della Fondazione Ambrosiana<br />
Paolo VI, divisa in quattro<br />
sezioni, ognuna indicata<br />
da una frase di san Benedetto,<br />
e vi partecipano sociologi,<br />
filosofi della politica e della<br />
scienza, storici, psichiatri e<br />
diversi giuristi; la seconda<br />
parte è curata dal prof. Claudio<br />
Stroppa, sociologo del<br />
territorio dell’Università di<br />
Pavia ed ideatore del Convegno<br />
in cui sono presenti con<br />
saggi padre Giovanni Spinelli,<br />
storico del monachesimo dell’Abbazia<br />
di Pontida (Bg) e<br />
Maria Antonietta Crippa, storica<br />
dell’architettura del Politecnico<br />
di Milano, lo stesso prof.<br />
Stroppa con un saggio sul<br />
rapporto tempo-spazio e il<br />
monastero e una serie di<br />
schede in cui vengono illustrati<br />
monasteri benedettini e<br />
cistercensi - “le case madri<br />
degli ordini”, in Italia (ad es.<br />
Montecassino), in Francia (ad<br />
es. Beuron), in Austria (ad es.<br />
Kremsmunster) e in Spagna<br />
(ad es. Montserrat). Essendo il<br />
volume ricco di splendide fotografie,<br />
ne risulta una splendida<br />
poderosa opera, degna di<br />
un collezionista di libri d’arte (il<br />
prezzo è di 25 euro più spese<br />
di spedizione). Perché un lavoro<br />
a più specializzazioni sul<br />
monachesimo? Se da una<br />
parte esistono ottimi volumi<br />
sulla storia del monachesimo<br />
(ad es. padre Penco, lo stesso<br />
padre Spinelli, il prof. Picasso,<br />
benedettino docente dell’Università<br />
Cattolica di Milano), un<br />
dibattito interculturale sul ruolo<br />
del monachesimo rappresenta<br />
una novità. San Benedetto<br />
con la sua Regola ha introdotto<br />
in Europa (di cui è patrono)<br />
un nuovo modo di vivere nelle<br />
comunità monastiche: Ora et<br />
Labora non è solamente un<br />
nuovo modo di vivere la fede,<br />
ma per le stesse Università<br />
che sorgeranno sette secoli<br />
dopo (le prime in Italia a Bologna<br />
e Padova) fornisce la<br />
conservazione di importanti<br />
libri, scritti e documenti, per cui<br />
il monachesimo, specie nell’Alto<br />
Medioevo, ha significato<br />
la cultura. Non solo,- e l’Abbazia<br />
di Chiaravalle lo attesta- i<br />
monaci erano grandi costruttori<br />
e architetti e attiravano<br />
pittori e scultori per abbellire i<br />
Leuzzi nell’introduzione del volume<br />
Bari 28 luglio 1943 –<br />
Memoria di una strage (edizioni<br />
Dal Sud), realizzato per<br />
l’Istituto pugliese per la Storia<br />
dell’antifascismo e dell’Italia<br />
contemporanea. Il volume ha<br />
anche l’obiettivo di ricordare<br />
una verità troppo spesso (volutamente)<br />
dimenticata: la<br />
Puglia (e tutto il Sud) non fu<br />
quella terra che, secondo la<br />
storiografia ufficiale - che è poi<br />
quella insegnata a scuola - si<br />
adeguò senza combattere prima<br />
al fascismo, poi all’occupazione<br />
alleata, lasciando al<br />
Nord d’Italia l’epopea della<br />
Resistenza. In Puglia (come<br />
nel resto del Sud), si resistette.<br />
E tanto. La strage del 28 luglio<br />
ne è solo un esempio, proprio<br />
come l’opposizione spontanea<br />
(e vittoriosa), nel porto e nel<br />
borgo antico di Bari, da parte<br />
di militari e civili guidati dal generale<br />
Nicola Bellomo alle<br />
truppe tedesche, il 9 settembre<br />
dello stesso anno.<br />
Il volume comprende una raccolta<br />
di documenti – alcuni ufficiali,<br />
altri personali, altri inediti,<br />
come la lettera scritta dal<br />
carcere da Tommaso Fiore al<br />
figlio Graziano, che sarebbe<br />
stato ucciso in via Niccolò<br />
dell’Arca – e descrive ciò che<br />
avvenne quel 28 luglio 1943<br />
nel capoluogo pugliese.<br />
«L’ufficiale al comando delle<br />
truppe autrici della strage – il<br />
Il romanzo si ambienta a<br />
Bruxelles, a Lugano, a New<br />
York, a Londra, a Napoli, per<br />
concludersi a Capri, ed ogni<br />
incontro con queste località è<br />
ricco di citazioni logistiche che<br />
fanno sì che il lettore, riconoscendo<br />
con il pensiero luoghi<br />
famosi e a lui familiari, si trovi a<br />
suo agio e viva più intensamente,<br />
a fianco <strong>dei</strong> protagonisti,<br />
le vicende che vi vengono<br />
narrate. Spaccanapoli, il negozio<br />
di cravatte Marinella e i<br />
bar con due caffè (uno sospeso),<br />
a Napoli, il Grand Central<br />
Terminal di Midtown a New<br />
York, la pensione Primerose<br />
sulla collina di Paradiso a Lugano,<br />
condotta da Margherita<br />
Bernasconi, cognome ticine-<br />
propri monasteri: il canto<br />
gregoriano, uno <strong>dei</strong> primi<br />
momenti della musica, non<br />
solamente religiosa, nasce nei<br />
monasteri (ad es. Solesmes in<br />
Francia è famosa per questo),<br />
e l’agricoltura lombarda deve<br />
molto ai monaci che attorno a<br />
Chiaravalle crearono “le marcite”.<br />
Tutta Milano è presente<br />
con monasteri, da Santa<br />
Maria delle Grazie, domenicana,<br />
ai monasteri della periferia,<br />
Viboldone e Mirasole,<br />
senza poi parlare di Morimondo<br />
fino alla celebre Certosa di<br />
Pavia. Ma se la storia ci<br />
consegna il monachesimo del<br />
passato, come si evidenzia<br />
quella attuale? Sono i saggi di<br />
Padre Sterchal, <strong>dei</strong> professori<br />
Clemente Lanzetti, Stefano<br />
Martelli e Silvano Burgalassi<br />
ad illustrarli con la presenza di<br />
dati di ricerca, di una sociologia<br />
della religione che si<br />
presenta come una disciplina<br />
originale a sé stante. E i saggi<br />
sono tutti interessanti specie<br />
per i cultori di determinate<br />
discipline: qui possiamo citare<br />
primo colpo fu sparato dal sergente<br />
Domenico Carbonara –<br />
ricevette un elogio dal generale<br />
Roatta», scrive Leuzzi.<br />
Nelle ore e nella notte seguenti<br />
la manifestazione affogata<br />
nel sangue, furono arrestate<br />
molte delle duecento<br />
persone che vi avevano partecipato.<br />
Tra queste, Luigi De<br />
Secly, redattore capo del quotidiano<br />
La Gazzetta del<br />
Mezzogiorno, che il mattino<br />
del 28 luglio aveva annunciato<br />
in un articolo, sotto il titolo<br />
Viva la libertà, la scarcerazione<br />
<strong>dei</strong> detenuti politici, e lo<br />
stesso Canfora, piantonato<br />
mentre giaceva in un letto d’ospedale.<br />
Nei giorni che seguirono,<br />
scrive ancora Leuzzi, «a<br />
Bari e nel resto della regione<br />
si registrò un clima di vero e<br />
proprio stato d’assedio… La<br />
censura di guerra impedì che<br />
la notizia dell’eccidio di via<br />
Niccolò dell’Arca si propagasse<br />
e le salme <strong>dei</strong> caduti furono<br />
tumulate di notte in un clima di<br />
intimidazione anche nei confronti<br />
<strong>dei</strong> familiari… L’unico segno<br />
pubblico furono gli scarni<br />
necrologi riportati dalla Gazzetta<br />
del Mezzogiorno per alcune<br />
delle vittime».<br />
Sui fatti del 28 luglio 1943 vennero<br />
poi avviati due procedimenti<br />
giudiziari da parte dell’autorità<br />
militare. Il primo a<br />
Bari, su denuncia del questore<br />
Pennetta che «cercò con<br />
sissimo, il Grand Hotel<br />
Quisisana di Capri, sono<br />
realtà in un contesto virtuale,<br />
sapientemente inserite anche<br />
per allentare la tensione creata<br />
dal ritmo frenetico degli avvenimenti<br />
che l’autore riesce a<br />
costruire, e per dare, quando<br />
è necessario, attimi di respiro<br />
al racconto.<br />
Per concludere, due perle: nel<br />
racconto scopriamo che Carlo<br />
d’Inghilterra è succeduto al<br />
trono alla madre Elisabetta e<br />
che Al Quaeda è stata distrutta<br />
anni fa. Un’osservazione è<br />
doverosa: questa avvincente<br />
spy-story non è facilmente reperibile<br />
anche nelle librerie più<br />
fornite. Forse l’editore dovrebbe<br />
prestare più attenzione alla<br />
diffusione di Magnus; ne vale<br />
la pena.<br />
Goffredo Giovanetti,<br />
Magnus,<br />
Ananke 2003,<br />
pagine 317, euro 17<br />
Giovanni Cordini, Giorgio Recchia<br />
e Luciano Musselli, giuristi,<br />
Roberto De Vita, Sabino<br />
Acquaviva, Salvatore Abruzzese<br />
e Silvano Burgalassi,<br />
sociologi, Giorgio Picasso, storico<br />
medioevale, Giorgio Rumi,<br />
storico moderno, Sergio<br />
Zaninelli, economista, Giulio<br />
Giorello e Pietro Adamo, filosofi<br />
della scienza, Danilo Castellano,<br />
filosofo della politica.<br />
Sono inseriti anche saggi <strong>dei</strong><br />
cardinali Cheli e Martini, degli<br />
onorevoli Formigoni e Colli e<br />
del Sindaco Albertini.<br />
Ora et labora.<br />
Le comunità religiose<br />
nella società<br />
contemporanea,<br />
a cura di Luciano Vaccaro<br />
e Claudio Stroppa,<br />
pubblicato a cura della<br />
Fondazione Ambrosiana<br />
Paolo VI, Nomos Edizioni,<br />
Busto Arsizio, 2003<br />
(da richiedersi alla<br />
Fondazione Ambrosiana<br />
Paolo VI,Villa Cagnola,<br />
Gazzada - Varese)<br />
ogni mezzo di addossare la<br />
responsabilità dell’accaduto<br />
ad alcuni intellettuali che avevano<br />
preso parte alla manifestazione».<br />
Ma il Tribunale militare<br />
barese, sulla base delle<br />
notizie riferite dagli arrestati,<br />
come – ad esempio – De<br />
Secly e Canfora, e dopo le indagini<br />
affidate – tra gli altri –<br />
ad Aldo Moro, che prestava<br />
servizio alla Procura militare,<br />
ritenne invece di non dover<br />
dar seguito alla richiesta del<br />
questore.<br />
Il secondo procedimento giudiziario,<br />
a carico di Domenico<br />
Carbonara, il sergente del battaglione<br />
San Marco che per<br />
primo aveva sparato sui manifestanti,<br />
venne invece affidato<br />
per competenza al Tribunale<br />
militare di Taranto (l’imputato<br />
infatti faceva parte della<br />
Marina) e fu, di fatto, insabbiato.<br />
In questo modo, scrive<br />
Leuzzi «s’intese… porre una<br />
pietra sepolcrale sull’eccidio».<br />
Ma non sulla memoria, come<br />
risultò l’anno dopo in un articolo<br />
pubblicato dal settimanale<br />
“Italia del Popolo”, nel quale<br />
si sottolineò come «un capovolgimento<br />
maggiore <strong>dei</strong> fatti<br />
è difficile da riscontrare negli<br />
annali giudiziari».<br />
Vito Antonio Leuzzi,<br />
Bari 28 luglio 1943 –<br />
Memoria di una strage,<br />
Edizioni Dal Sud,<br />
pagine 167, euro 10<br />
27 (35)
LA LIBRERIA DI TABLOID<br />
Mauro Paissan<br />
Privacy<br />
e Giornalismo<br />
di Sabrina Peron<br />
Il volume Privacy e Giornalismo.<br />
Diritto di cronaca e<br />
diritti <strong>dei</strong> cittadini, a cura di<br />
Mauro Paissan (membro,<br />
peraltro dell’Autorità Garante<br />
per la protezione <strong>dei</strong> dati<br />
personali), edito dal Garante<br />
per la protezione <strong>dei</strong> dati<br />
personali, è una raccolta delle<br />
decisioni più significative<br />
rese dal Garante, negli anni<br />
1997-2003, in materia di<br />
informazione e tutela della<br />
privacy.<br />
Il libro si apre con una presentazione<br />
dello stesso<br />
Paissan che tratteggia in modo<br />
efficace i passi più significativi<br />
del codice deontologico<br />
relativo al trattamento <strong>dei</strong> dati<br />
personali nell’esercizio dell’attività<br />
giornalistica e sintetizza<br />
i vari aspetti ed argomenti<br />
che hanno caratterizzato<br />
le pronunce del Garante.<br />
Segue la parte dedicata<br />
alla pubblicazione <strong>dei</strong> provvedimenti<br />
del Garante organizzata<br />
per grandi temi e preceduta<br />
da una breve scheda<br />
riassuntiva degli aspetti più<br />
significativi. Per finire, il volume<br />
è completato da alcuni allegati<br />
normativi.<br />
La lettura di Privacy e Giornalismo<br />
si consiglia a tutti coloro<br />
che intendono schiarirsi<br />
le idee su questa delicata<br />
materia, sia perché è la prima<br />
opera che raccoglie in modo<br />
sistematico le pronunce del<br />
Garante che riguardano l’esercizio<br />
dell’attività giornalistica<br />
sia, perché fa il punto delle<br />
problematiche emerse e degli<br />
orientamenti espressi dal<br />
Garante in un momento in cui<br />
si è alle soglie dell’entrata in<br />
vigore - 1° gennaio <strong>2004</strong> - del<br />
Testo Unico in materia di riservatezza<br />
<strong>dei</strong> dati personali,<br />
meglio noto come Codice<br />
Privacy (che assorbe la<br />
Legge 675/1996, riordinando<br />
l’intera materia).<br />
A quest’ultimo riguardo, recentemente,<br />
tra l’Autorità<br />
Garante e l’<strong>Ordine</strong> nazionale<br />
<strong>dei</strong> giornalisti si è decisa la<br />
costituzione di un gruppo di<br />
lavoro con il compito di elaborare<br />
testi e documenti utili per<br />
dare un concreto contributo<br />
all’attività di chi opera nel<br />
mondo dell’informazione. Il<br />
gruppo di lavoro si occuperà<br />
anche di alcuni aspetti applicativi<br />
riguardanti il nuovo testo<br />
unico in materia di protezione<br />
<strong>dei</strong> dati personali che<br />
entrerà in vigore a partire dal<br />
1° gennaio <strong>2004</strong>.<br />
Proprio con riferimento alla<br />
ormai prossima entrata in vigore<br />
del Codice Privacy si<br />
segnala che è già diventato<br />
tema di dibattito il valore normativo<br />
del Codice deontologico<br />
relativo al trattamento<br />
<strong>dei</strong> dati, personali nell’esercizio<br />
dell’attività giornalistica.<br />
Difatti, come ricordato da<br />
Paissan nel suo volume, sotto<br />
il vigore della Legge<br />
675/1996, il Codice deontologico<br />
doveva considerarsi<br />
quale fonte di diritto di rango<br />
secondario; tuttavia, poiché<br />
detto codice si trova oggi allegato<br />
(Allegato A) al Codice<br />
Privacy, si è affermato che<br />
“come Allegato A, il Codice è<br />
qualcosa di più di una norma<br />
secondaria: ha sostanzialmente<br />
il rango di norma primaria!”<br />
(così, F. Abruzzo, in<br />
Diritto di cronaca giustizia e<br />
privacy, pubblicato quale<br />
dossier allegato a questa rivista<br />
nel numero di novembre<br />
2003, che, tra l’altro, contiene<br />
un’ampia rassegna delle decisioni<br />
adottate dal Consiglio<br />
dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti della<br />
Lombardia, nella sua veste<br />
di giudice amministrativo disciplinare<br />
in materia di tutela<br />
della riservatezza).<br />
Dalla lettura del libro di<br />
Paissan si evince che gli<br />
aspetti della privacy che più<br />
hanno indaffarato il Garante<br />
sono quelli relativi la tutela<br />
<strong>dei</strong> minori e dell’identità personale,<br />
la pubblicazione di<br />
fotografie, la tutela <strong>dei</strong> dati<br />
sensibili (sanitari e sessuali),<br />
l’essenzialità dell’informazione<br />
e la lealtà nella raccolta<br />
dati.<br />
Partendo proprio da quest’ultima<br />
problematica si segnala<br />
la decisione del Garante sulla<br />
messa in onda, da parte di un<br />
programma satirico, delle dichiarazioni<br />
registrate ad insaputa<br />
dell’interessato (un noto<br />
parlamentare).<br />
Il Garante muovendo dal presupposto<br />
che i dati e le informazioni<br />
devono essere rac-<br />
Enzo Macrì<br />
L’alfabeto della vita<br />
di Filippo Senatore<br />
“Daremo forse il nome d’eternità<br />
alla parola non detta che<br />
lega per quell’attimo la favilla,<br />
alla stella, la terra al cielo, la<br />
nostra mente all’immensità<br />
del cosmo? Quando, come<br />
succede appunto nella poesia,<br />
l’intero fluire della nostra<br />
vita psichica sembra mescolarsi<br />
al fluire della realtà?”<br />
Queste domande si pone<br />
Donatella Bisutti ne La poesia<br />
salva la vita la quale conclude:<br />
“La poesia non ci può<br />
dare una vera risposta. Può<br />
solo continuare a suggerire...”.<br />
Solo con questa premessa<br />
possiamo distinguere la dualità<br />
come sbocco poetico necessario.<br />
Nella poesia di Enzo Macrì,<br />
L’alfabeto della vita, appare<br />
colti dal giornalista con realtà<br />
e correttezza, “senza violenza<br />
o inganno e in un quadro<br />
di trasparenza” (come peraltro<br />
evidenziato dal Codice<br />
deontologico che prevede il<br />
dovere di evitare “artifici e<br />
pressioni indebite”), ha ritenuto<br />
che i responsabili della trasmissione<br />
avrebbero dovuto<br />
tempestivamente informare<br />
l’interessato, al fine di consentirgli<br />
di poter dare la sua opinione<br />
e, eventualmente, di<br />
opporsi all’eventuale trattamento<br />
(Autorità Garante<br />
22.07.1998).<br />
Quanto all’essenzialità dell’informazione,<br />
al giornalista è<br />
fatto obbligo di applicare i principi<br />
etici della sua professione<br />
tutelando la dignità della persona<br />
e rispettando la verità <strong>dei</strong><br />
fatti senza travalicare i limiti<br />
dell’essenzialità dell’informazione<br />
riguardo a notizie di interesse<br />
pubblico. L’essenzialità<br />
dell’informazione, inoltre, impone<br />
ai giornalisti di effettuare<br />
“un attento vaglio sulle notizie<br />
acquisite e sulle modalità della<br />
loro acquisizione, evitando di<br />
diffondere quelle che attengono<br />
a comportamenti o persone<br />
non direttamente connessi<br />
alla vicenda riportata” (Autorità<br />
Garante 10.04.2002).<br />
A ciò si aggiunga, che il segreto<br />
professionale sulla fonte<br />
della notizia, non fa venir<br />
meno il dovere del giornalista<br />
di acquisire in modo lecito la<br />
documentazione inerente il<br />
pezzo che si accinge a redigere<br />
e di utilizzarla, tenendo<br />
conto del principio di pertinenza<br />
rispetto alle finalità<br />
perseguite (Autorità Garante<br />
16.10.1997).<br />
Lesiva del principio dell’essenzialità<br />
è stata pertanto<br />
considerata la prassi adottata<br />
da un quotidiano di<br />
pubblicare (all’interno di<br />
una sezione dedicata alle<br />
informazioni su traffico e sui<br />
trasporti pubblici) i numeri<br />
delle targhe ed altre informazioni<br />
relative alle automobili<br />
parcheggiate irregolarmente:<br />
ad avviso del<br />
Garante, tali dati non potevano<br />
considerarsi essenziali<br />
in relazione alla finalità<br />
informativa dell’articolo, potendo<br />
questa “essere perseguita<br />
limitandosi ad indicare,<br />
per esempio, il tipo di<br />
autovetture che ostacolavano<br />
il traffico” (Autorità<br />
Garante 11.03.2002).<br />
Ne consegue che quando<br />
una vicenda riveste un particolare<br />
interesse pubblico, gli<br />
operatori dell’informazione<br />
sono tenuti ad alcune cautele<br />
riguardanti il rispetto <strong>dei</strong> diritti<br />
l’ulteriore operazione di segmentazione<br />
del verso, come<br />
prodotto chimico biologico.<br />
Per evitare la frammentazione<br />
l’autore compie un’operazione<br />
di assemblaggio con<br />
una carica di ironia e simpatia<br />
che invita ad innamorarsi<br />
del mondo, così come è, pieno<br />
di contaminazioni e di limiti.<br />
Intelligenza e sensibilità<br />
ripercorrono momenti dolorosi.<br />
<strong>dei</strong> soggetti coinvolti nella vicenda<br />
stessa.<br />
Ad esempio, l’obbligo di trattare<br />
dati personali completi esige<br />
che i mezzi di informazione,<br />
nel riferire vicende giudiziarie,<br />
evidenzino correttamente<br />
lo stato iniziale dell’inchiesta<br />
e la posizione processuale<br />
del soggetto indagato riguardo<br />
ad essa: ciò al fine di<br />
evitare che detta posizione<br />
possa essere confusa, agli<br />
occhi dell’opinione pubblica,<br />
con quella di un altro soggetto<br />
già imputato o addirittura condannato<br />
(Autorità Garante<br />
19.02.2002).<br />
Non va, inoltre, dimenticato il<br />
divieto di pubblicare l’indirizzo<br />
di una persona, quando<br />
questo realizzi una interferenza<br />
alla sfera privata altrui<br />
non giustificata ai fini dell’esercizio<br />
del diritto di cronaca,<br />
con la precisazione che “l’ulteriore<br />
diffusione <strong>dei</strong> dati relativi<br />
al nome, all’immagine<br />
ed alla professione può ritenersi<br />
giustificata solo quando<br />
la loro conoscenza posa risultare<br />
essenziale in ragione<br />
dell’eventuale ulteriore sviluppo<br />
<strong>dei</strong> fatti” (Autorità<br />
Garante 12.10.1998).<br />
Con riguardo agli altri aspetti<br />
della privacy trattati dal<br />
Garante, dai provvedimenti<br />
pubblicati emerge che questi,<br />
più volte, ha richiamato l’attenzione<br />
alla necessità di rispettare<br />
l’art. 7 del Codice<br />
deontologico che prescrive al<br />
giornalista di astersi dal pubblicare<br />
nomi o altri elementi<br />
(ad esempio fotografie) idonei<br />
ad identificare minori coinvolti<br />
in fatti di cronaca (salvo che il<br />
giornalista non reputi sotto la<br />
sua responsabilità che tale<br />
scelta risponda ed un’effettiva<br />
rilevanza pubblica e sia fatta<br />
nell’interesse oggettivo del<br />
minore), precisando che l’eventuale<br />
consenso del genitore<br />
alla diffusione di tali dati<br />
non esime il giornalista dall’obbligo<br />
di verificare l’esistenza<br />
di un interesse oggettivo<br />
del minore alla diffusione delle<br />
informazioni che lo riguardavano<br />
(Autorità Garante<br />
15.11.2001).<br />
Del resto, come giustamente<br />
rimarca Paissan, i minori sono<br />
i soggetti più indifesi ed<br />
esposti al rischio di una lesione<br />
<strong>dei</strong> diritti fondamentali da<br />
parte <strong>dei</strong> mezzi di informazione.<br />
Per tale motivo, ad esempio,<br />
il Garante è ripetutamente<br />
intervenuto sul delicato caso<br />
del “delitto di Cogne”, inibendo<br />
la pubblicazione di<br />
informazioni e di immagini<br />
del fratellino di sette anni della<br />
vittima, del quale “erano<br />
Così il paradosso può vestirsi<br />
di speranza. “La poesia<br />
allora mette in salvo colui<br />
che scrive ed ad essa è<br />
richiesto lo stesso compito<br />
dell’acqua, ripulire cioè la<br />
vissuta coscienza”.<br />
L’autore denuncia l’emarginazione<br />
con una mitologia<br />
polemica della realtà urbana.<br />
Il mondo dell’handicap è<br />
il filtro da cui vedere la sintesi<br />
di una società malata.<br />
Solo la forza rigeneratrice<br />
dello spirito può risolvere<br />
con un colpo d’ala una situazione<br />
paradossale d’immobilità.<br />
“Parlare con i dinosauri impossibili”<br />
è forse la chiave di<br />
lettura più autentica <strong>dei</strong> versi<br />
state diffuse immagini (scattate<br />
con teleobiettivo), frasi,<br />
stati d’animo dichiarazioni rese<br />
al magistrato” (Autorità<br />
Garante 10.04.2002).<br />
Particolare cautela si impone<br />
poi al giornalista che raccoglie<br />
dati personali presso una<br />
struttura sanitaria. In questo<br />
caso le persone interessate<br />
devono venire informate, nei<br />
modi previsti dell’art. 2 del<br />
Codice deontologico, e devono<br />
inoltre adottarsi opportune<br />
modalità che consentano ai<br />
malati interessati di comprendere<br />
appieno le finalità della<br />
raccolta delle informazione e<br />
la loro destinazione ad<br />
un’ampia diffusione che può<br />
renderli riconoscibili, in questo<br />
caso il consenso non può<br />
considerarsi un adempimento<br />
meramente formale, dovendo<br />
basarsi su un’idonea<br />
informativa (Autorità Garante<br />
20.06.2001).<br />
Interessante, infine, la pronuncia<br />
del Garante che qualifica<br />
l’intervista (al pari di qualsiasi<br />
altra dichiarazione, opinione<br />
o manifestazione del<br />
pensiero) come fonte di<br />
“informazioni che riguardano<br />
una persona e, come tali, dati<br />
personali”, rimanendo “irrilevante<br />
la forma in cui sono<br />
trattate o gli supporti che le<br />
contengono”, con conseguente<br />
diritto dell’interessato,<br />
una volta che gli venga confermata<br />
l’esistenza <strong>dei</strong> propri<br />
dati personali, di ottenere “la<br />
comunicazione in forma chiaramente<br />
intelligibile (attraverso,<br />
ad esempio, la riproduzione<br />
su supporto sonoro o cartaceo,<br />
da trasmettere allo<br />
stesso interessato), a cura<br />
dell’editore o, direttamente,<br />
della giornalista” (Autorità<br />
Garante, 28.11.1998).<br />
A conclusione di questa breve<br />
panoramica di alcune delle<br />
decisioni adottate dal<br />
Garante, non si può che concordare<br />
con quanto affermato<br />
dall’Autore, ossia che in tema<br />
di privacy non esiste una<br />
ricetta valida sempre e comunque,<br />
così da poterla applicare<br />
ai singoli casi concreti:<br />
“la responsabilità del giornalista<br />
è sempre preminente. È<br />
il giornalista a dover alla fine<br />
decidere, spesso sotto pressione<br />
dell’urgenza della messa<br />
in onda o della chiusura<br />
della pagine del giornale. E<br />
deve decidere in base alle<br />
norme, al codice deontologico<br />
e alla propria etica”. E tra i<br />
problemi che i giornalisti si<br />
trovano quotidianamente ad<br />
affrontare in materia di privacy,<br />
si va dal dubbio se dare<br />
o meno una notizia (ma ram-<br />
di Macrì il quale non maschera<br />
il disagio con parole<br />
che celano, ma svela con disincanto<br />
la realtà cruda della<br />
poesia.<br />
A volte i versi si fanno “pietrosi”<br />
per evitare di cadere<br />
nel pietoso. Una lucida scelta<br />
che condividiamo.<br />
L’autore ha effettuato un taglio<br />
chirurgico del superfluo<br />
ed è andato al cuore del<br />
problema, aprendo un varco<br />
prezioso di comunicazione<br />
con un lettore disincantato,<br />
ma pronto agli<br />
slanci illuminanti del poeta<br />
il quale, in alcuni momenti,<br />
sembra attingere alla saggezza<br />
del Simposio di<br />
Platone.<br />
menta Paissan che il giornalismo<br />
è selezione e che spesso<br />
una notizia si può dare<br />
senza dettagli che possano<br />
offendere gratuitamente delle<br />
persone), alla decisione se<br />
affidarsi - più o meno passivamente<br />
- ad una fonte, o ancora,<br />
alla scelta di “pubblicare<br />
tutto” quando il personaggio<br />
è un uomo pubblico, a causa<br />
dell’affievolimento della sua<br />
sfera privata, facendo però i<br />
conti con il codice deontologico<br />
che esige comunque il rispetto<br />
della sfera privata<br />
dell’homo publicus, se la notizia<br />
o i dati non hanno alcun<br />
rilievo sul suo ruolo o sulla<br />
sua vita pubblica.<br />
Mauro Paissan constata anche<br />
un utilizzo regressivo della<br />
legge sulla privacy, a volte<br />
impiegata in modo strumentale<br />
per giustificare il rifiuto alla<br />
trasparenza, in particolare<br />
da parte delle pubbliche amministrazioni,<br />
mortificando<br />
così il diritto di accesso agli<br />
atti amministrativi di cui alla<br />
legge n. 241/1990.<br />
L’autore segnala, infine, i problemi<br />
supplementari apportati<br />
alla necessità della tutela<br />
della riservatezza, dall’utilizzo<br />
di internet, grazie al quale<br />
è possibile reperire, accumulare<br />
e trattare, senza limiti di<br />
spazio e di tempo, un vastissimo<br />
numero di informazioni.<br />
Questi sono: da un lato, il rischio<br />
che venga meno il c.d.<br />
“diritto all’oblio”, che mira a<br />
salvaguardare il riserbo imposto<br />
dal tempo ad un notizia<br />
già resa di dominio pubblico,<br />
poiché una volta nella rete<br />
sarà difficile per il soggetto interessato<br />
impedire la circolazione<br />
del dato che lo riguarda;<br />
dall’altro lato, il rischio<br />
che, la diffusione in rete una<br />
notizia falsa (o anche solo imprecisa),<br />
renda estremamente<br />
difficoltosa per l’interessato<br />
la correzione del dato falso<br />
che lo riguarda.<br />
In definitiva lo sviluppo della<br />
società dell’informazione, anche<br />
grazie alle nuove frontiere<br />
aperte da internet, ha ampliato<br />
il potenziale conflitto tra<br />
la tutela della vita privata e<br />
dell’identità personale ed il libero<br />
flusso delle informazioni:<br />
la ricerca dell’equilibrio tra<br />
questi valori rappresenta la<br />
chiave di volta per assicurare,<br />
anche nell’era digitale, i diritti<br />
fondamentali di libertà e democrazia.<br />
Mauro Paissan,<br />
Privacy e Giornalismo,<br />
Editore Garante<br />
per la protezione<br />
<strong>dei</strong> dati personali<br />
Enzo Macrì,<br />
L’alfabeto della vita,<br />
Edizioni del Leone,<br />
Venezia 2003,<br />
72 pagine, euro 6,20<br />
28 (36) ORDINE 1 <strong>2004</strong>
Franco Capelvenere<br />
Meucci. L’uomo<br />
che ha inventato il telefono<br />
di Vittorio Franchini<br />
Cronache dall’Ottocento, pagine<br />
minute, fatte di cose modeste<br />
ma che assumono nuovi<br />
interessi se si pensa che<br />
protagonista della storia è tale<br />
Antonio Meucci, 1808, da<br />
Firenze, “l’uomo che ha inventato<br />
il telefono”, ma al quale,<br />
solo un anno fa, è stata riconosciuta<br />
l’invenzione, attribuita<br />
fino ad allora a<br />
quell’Alexander Graham Bell<br />
che aveva vinto una causa rimasta<br />
famosa.<br />
Bisognerà dunque riscrivere i<br />
libri di storia per restituire a<br />
questo italiano ciò che gli è<br />
dovuto, anche se il riconoscimento<br />
giunge a più di un secolo<br />
dalla sua morte avvenuta<br />
nel 1889.<br />
Se pensiamo all’Ottocento la<br />
storia di Meucci può sembrare<br />
una favola: secolo della<br />
carrozza l’Ottocento che sul<br />
finire, come per miracolo, si è<br />
trasformato nel secolo delle<br />
invenzioni. In Europa era al<br />
culmine il grande fenomeno<br />
letterario, filosofico e artistico<br />
del Romanticismo quando,<br />
negli Stati Uniti, Sholes, nel<br />
1868, aveva inventato la macchina<br />
per scrivere senza pen-<br />
Romano Battaglia<br />
Il mare in discesa<br />
di Olimpia Gargano<br />
Per gli amanti del New Age di<br />
buona fattura, il nuovo libro di<br />
Romano Battaglia sarà una<br />
corroborante immersione nel<br />
pensiero positivo.<br />
Il viaggio iniziatico del protagonista<br />
del Mare in discesa<br />
si svolge nell’elemento forse<br />
più caro all’autore, il mare,<br />
appunto. Un mare che accoglie<br />
e nutre, che ammalia e<br />
cattura, a volte per sempre.<br />
“Il mare è come la vita”, dice<br />
Adelmo, navigante in solitario<br />
dopo che il mare gli ha<br />
portato via la donna amata.<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
sare che avrebbe trasformato<br />
la narrativa, accellerandone i<br />
ritmi, quando Meucci nel<br />
1876 aveva inventato il telefono<br />
(ma la scoperta fu attribuita<br />
a Bell) non immaginava<br />
che il suo apparecchio avrebbe<br />
eliminato l’isolamento delle<br />
comunità rurali e posto fine<br />
alla produzione di lettere,<br />
quando Edison un anno più<br />
tardi aveva inventato il modo<br />
di registrare voci e suoni, incidendo<br />
lui stesso, su un cilindro,<br />
una filastrocca infantile,<br />
Mary had a little lamb, non<br />
poteva neppure supporre<br />
quale grande industria del<br />
suono e della musica ne sarebbe<br />
scaturita, quando<br />
Watermann, nel 1884 aveva<br />
creato la penna stilografica<br />
non immaginava che avrebbe<br />
smantellato la torre d’avorio<br />
dello scrittore inchiodato all’immobilità<br />
del suo calamaio<br />
e quando Mergenthaler, un<br />
anno dopo, era arrivato alla linotype,<br />
chi avrebbe potuto<br />
supporre che quella strana<br />
macchina avrebbe mutato<br />
addirittura la faccia della società?<br />
Anni di grandi scoperte, dunque,<br />
ma anche di viaggi che<br />
coinvolgevano sempre più<br />
persone, musicisti, letterati, fi-<br />
“Ha profondità abissali e superfici<br />
calme. Nella sua<br />
profondità vivono mostri e sirene<br />
che, con le loro improvvise<br />
apparizioni, da sempre<br />
rappresentano l’allegoria della<br />
vita piena di tentazioni e<br />
distruzione.” Mostri, sirene,<br />
abissi marini come cifre simboliche<br />
del “viaggio” per eccellenza:<br />
la vita umana.<br />
Ecco, se un appunto si può<br />
muovere alla seduzione affabulatoria<br />
di Romano Battaglia,<br />
narratore dal ritmo fluido<br />
come il mare azzurro di una<br />
giornata serena, è proprio<br />
questa troppo generosa sollecitudine<br />
nel rendere esplici-<br />
Nicoletta Picchio<br />
L’Italia che conta<br />
di Giacomo Ferrari<br />
Piccola impresa, in Italia, è<br />
spesso sinonimo di innovazione,<br />
di originalità, ma anche<br />
di coraggio e impegno personale.<br />
Dietro ciascuna realtà<br />
aziendale c’è sempre un’idea<br />
vincente. E c’è anche un uomo<br />
che quella idea ha maturato<br />
e poi ha lottato per imporla.<br />
Nicoletta Picchio, che dalle<br />
colonne del Sole-24 Ore racconta<br />
quotidianamente la cosiddetta<br />
economia reale, ha<br />
individuato una serie di “storie”<br />
di successo e le ha raccontate<br />
in modo impeccabile:<br />
con un linguaggio brillante ma<br />
senza indulgere alla retorica;<br />
utilizzando numeri e date, ma<br />
senza mai annoiare il lettore.<br />
Il risultato? Una lettura istruttiva<br />
(oltre che piacevole) per<br />
chi vuole affermarsi nell’era<br />
LA LIBRERIA DI TABLOID<br />
losofi, artisti, ma anche gente<br />
semplice che lasciava la vita<br />
di borgata per cercare l’avventura.<br />
Meucci fu uno di questi<br />
“ pionieri”. Per la verità il padre<br />
non credeva molto in quel<br />
suo rampollo che affermava<br />
di voler diventare famoso, ma<br />
che nulla sembrava fare per<br />
acquistare almeno un posto<br />
decente nella civile Firenze.<br />
Anzi era finito addirittura in<br />
prigione.<br />
Poi un impiego come attrezzista<br />
al Teatro della Pergola,<br />
quindi il volo: Cuba dove,<br />
all’Avana, aveva lavorato al<br />
teatro Tacon e cominciato i<br />
suoi primi esperimenti. Da lì<br />
agli Stati Uniti, America amara,<br />
che non gli aveva dato<br />
niente per realizzare le sue<br />
scoperte, che lo aveva costreto<br />
ad una vita di fatica e di<br />
stenti e con una vecchiaia<br />
consumata in povertà a<br />
Staten Island, dove aveva<br />
ospitato addirittura Garibaldi.<br />
E chi era questo Bell che per<br />
113 anni ha avuto la paternità<br />
del telefono?<br />
Era nato a Edimburgo nel<br />
1847, in una famiglia borghese<br />
e intellettuale, si era trasferito<br />
a Londra per completare i<br />
suoi studi, era anche diventato<br />
insegnante. Il padre,<br />
ti i “segni” di cui è costellato il<br />
suo universo creativo. Un po’<br />
come fare sogni corredati di<br />
testo a fronte che ne spiegasse<br />
il significato. Il bello <strong>dei</strong><br />
sogni è nella loro - apparente<br />
- insensatezza: trovarne le<br />
chiavi di lettura dovrebbe essere<br />
lasciato a cura del sognatore.<br />
L’andar per mare di Adelmo<br />
è trasparente metafora del<br />
viaggio quotidiano che ognuno<br />
di noi compie intorno e<br />
dentro di sé. Questo mare<br />
che è “dimora di tutto ciò che<br />
abbiamo perduto, di quello<br />
che non abbiamo avuto, <strong>dei</strong><br />
desideri infranti, <strong>dei</strong> dolori,<br />
della competitività globale. Da<br />
ogni singola vicenda aziendale<br />
narrata – una ventina –<br />
emerge un dettaglio, una particolarità,<br />
un risvolto che in<br />
realtà rappresentano la chiave<br />
per comprendere i motivi<br />
del successo ottenuto.<br />
I protagonisti sono personaggi<br />
i cui nomi ricorrono spesso<br />
nelle cronache economiche,<br />
pur non essendo frequentatori<br />
abituali del jet-set. Ci sono per<br />
esempio la regina della grappa<br />
Giannola Nonino e l’editore<br />
Alessandro Laterza; il patron<br />
della It Holding Tonino Perna e<br />
il nobile siciliano Lucio Tasca<br />
d’Almerita; il re delle piastrelle<br />
Filippo Marazzi e quello degli<br />
occhiali Vittorio Tabacchi. E<br />
Alexander Melville, aveva inventato<br />
un complicato sistema<br />
fonetico, che aveva chiamato<br />
“parola visibile” costituito<br />
da una serie di simboli<br />
scritti che rappresentavano i<br />
suoni, una sorta di alfabeto<br />
universale.<br />
Erano anni in cui molti studiosi<br />
lavoravano attorno alla possibilità<br />
di creare una “macchina<br />
parlante” e il giovane Bell<br />
aveva studiato, in modo particolare,<br />
un testo del tedesco<br />
Helmholtz.<br />
“Sull’analisi <strong>dei</strong> suoni mediante<br />
l’orecchio”. Poi era finito in<br />
Canada, quindi all’università<br />
di Boston, dove aveva iniziato<br />
a fare degli esperimenti che<br />
certo dovevano parere assurdi,<br />
ed anche atroci, a coloro<br />
che gli stavano vicini: aveva<br />
ottenuto un orecchio umano,<br />
staccato da un cadavere, lo<br />
aveva collegato con una cannuccia<br />
e attraverso questa,<br />
urlando nel padiglione auricolare,<br />
era riuscito a tracciare<br />
<strong>dei</strong> segni su un vetro affumicato.<br />
Queste storie, affascinanti come<br />
un romanzo, appaiono in<br />
questa nuova edizione del libro<br />
di Franco Capelvenere,<br />
un libro scritto con rigore, ma<br />
anche con una bella vena<br />
narrativa: lo si legge in un fiato<br />
e, una volta arrivati alla parola<br />
fine, si è diventati grandi amici<br />
dello sfortunato Meucci.<br />
Franco Capelvenere,<br />
Meucci. L’uomo che ha<br />
inventato il telefono,<br />
Vallecchi editore,<br />
pagine 262, euro 18<br />
delle lacrime che abbiamo<br />
versato” richiama alla memoria<br />
il vallone lunare che<br />
nell’Orlando Furioso conserva,<br />
oltre al senno perduto di<br />
Orlando, “le lacrime e i sospiri<br />
degli amanti, l’inutil tempo<br />
che si perde a giuoco, e l’ozio<br />
lungo d’uomini ignoranti...”.<br />
Le profondità marine, che nel<br />
nostro immaginario continuano<br />
a essere fonte di mistero<br />
al pari della luna, sono<br />
luoghi che nascondono segreti.<br />
Vi si possono trovare<br />
rottami, relitti di naufragi, o<br />
tesori inestimabili. Come negli<br />
abissi dell’anima, immergervisi<br />
è un rischio ma anche<br />
una scommessa, dove la posta<br />
in gioco è la conoscenza<br />
di sé.<br />
Romano Battaglia,<br />
Il mare in discesa,<br />
Rizzoli, pagine 152,<br />
euro 14<br />
molti altri ancora. Alcuni noti<br />
anche perché ricoprono un<br />
ruolo pubblico o perché il loro<br />
nome è legato a specifiche iniziative<br />
(come Giancarlo Cerutti,<br />
vicepresidente di Confindustria,<br />
o come Diego Della<br />
Valle, il creatore delle scarpe<br />
Tod’s). Tutti imprenditori con<br />
una caratteristica comune:<br />
hanno alle spalle un percorso<br />
vincente. C’è chi l’azienda l’ha<br />
ereditata e chi l’ha creata ex<br />
novo. Ma ciascuno di loro in<br />
ogni caso ha fatto scuola.<br />
Ricostruire (e Picchio lo ha fatto<br />
con precisione) le tappe <strong>dei</strong><br />
loro cammini personali e professionali<br />
significa, come scrive<br />
il ministro delle Attività produttive<br />
Antonio Marzano nella<br />
Francesco Alberoni<br />
Il mistero<br />
dell’innamoramento<br />
di Vittorio Franchini<br />
Indagare sull’innamoramento<br />
è un vecchio “vizio” di Alberoni.<br />
Ricordo bene l’interesse<br />
suscitato, nel 1979, dal suo<br />
Innamoramento e amore.<br />
Nessuno ancora aveva cercato<br />
di sondare l’animo umano<br />
in quel particolare e felice momento<br />
in cui due individui, inspiegabilmente<br />
fascinati l’uno<br />
dall’altro, si mettono insieme.<br />
La psicanalisi ci aveva parlato<br />
di “regressione”, cioè l’amore<br />
visto come ricupero delle<br />
esperienze infantili provate<br />
nei confronti della madre, ma<br />
l’uomo della fine del<br />
Novecento non sembrava<br />
convinto da questa idea.<br />
Credo che, piuttosto, preferisse<br />
pensare ad una sorta di<br />
slancio istintivo, magari imparentato,<br />
sia pure alla lontana,<br />
con l’estro degli animali. Ma<br />
Alberoni, già allora, aveva delineato<br />
una sua teoria originale,<br />
ovvero lo “ stato nascente<br />
di un movimento collettivo a<br />
due”, inteso come sradicamente<br />
dal passato, spinta in<br />
avanti, come una improvvisa<br />
rivoluzione pronta a lasciarsi<br />
tutto alle spalle per proiettarsi<br />
in una nuova vita. Una rinascita,<br />
insomma, e ripensandoci,<br />
magari anche banalmente,<br />
senza avere la cultura dello<br />
studioso, davvero l’amore ci<br />
appare spesso come un momento<br />
rivoluzionario, grazie al<br />
quale ci si stacca dalla madre,<br />
dalla famiglia, dagli amici, per<br />
chiudersi nel bozzolo sensazionale<br />
di uno scambio a due.<br />
Ora con questo nuovo lavoro<br />
Alberoni approfondisce il suo<br />
studio e lo alimenta con altre<br />
intuizioni. Per esempio distingue<br />
fra amore a prima vista,<br />
quel love at first sight, come<br />
dicono gli inglesi, dall’innamoramento<br />
che, dice, è invece il<br />
frutto di un processo. La fascinazione<br />
è il primo impatto, ma<br />
non basta a dare seguito ai<br />
sentimenti. “ Il vero innamoramento<br />
– scrive lo studioso – è<br />
la sua capacità di fondere<br />
sempre più profondamente<br />
due individui distinti.<br />
L’innamorato, ogni tanto, rimane<br />
come incantato davanti<br />
all’amata. Scopre in lei cose<br />
che non aveva mai visto pri-<br />
prefazione, portare alla luce il<br />
ruolo dell’imprenditore “come<br />
agente dello sviluppo, non solo<br />
economico ma anche sociale<br />
e morale”.<br />
Sono questi, insomma, i rappresentanti<br />
di una classe imprenditoriale<br />
che non solo fa<br />
onore al nostro Paese, ma<br />
che resiste alla volatilità <strong>dei</strong> cicli<br />
economici. Non a caso il titolo<br />
del libro è L’Italia che<br />
conta. Se, infatti, le grandi imprese<br />
spesso hanno dovuto<br />
confrontarsi con le ricorrenti,<br />
pesanti crisi, nel loro complesso<br />
quelle medio-piccole<br />
hanno saputo superare più<br />
agevolmente le difficoltà.<br />
Grazie proprio a fantasia e innovazione.<br />
ma e ne resta rapito e si meraviglia<br />
che quella creatura<br />
stupenda lo ricambi.” In pratica,<br />
dunque, un continuo succedersi<br />
di “colpi di fulmine”<br />
che, dopo il primo impatto,<br />
prendono corpo, creano legami<br />
sempre più stretti, realizzano<br />
una unione che può anche<br />
durare decenni, senza mai<br />
perdere di intensità.<br />
Il libro spiega e confuta pareri<br />
di illustri studiosi, filosofi o<br />
neuropsicologi, parla del momento<br />
della nascita come di<br />
una liberazione contrapponendo<br />
questa sua idea a<br />
quella degli esistenzialisti che<br />
la definivano un “essere gettati”<br />
nel mondo, un incontro<br />
negativo, dunque, con il freddo,<br />
la fame, la sete. E ancora<br />
si sofferma sul mistero dell’altro<br />
e distingue fra l’attrazione<br />
erotica e quella, assai più<br />
complessa, dell’amore.<br />
Chiude, infine, con un breve<br />
accenno alla storia, quando la<br />
società imponeva il matrimonio<br />
e, quindi, l’innamoramento<br />
appariva come una forza<br />
devastante che si opponeva<br />
ad ogni regola. E basterebbe<br />
citare la vicenda d’amore di<br />
Lancillotto e Ginevra, per capire<br />
quale era la situazione.<br />
Un libro, dal quale forse non<br />
potremo trarre utili suggerimenti<br />
comportamentali, ma di<br />
facile lettura che, in qualche<br />
modo, ci spinge a guardare in<br />
noi stessi e, magari, ci aiuta a<br />
vivere nel quotidiano.<br />
Francesco Alberoni,<br />
Il mistero<br />
dell’innamoramento,<br />
Rizzoli, pagine 169,<br />
euro 15<br />
Nicoletta Picchio,<br />
L’Italia che conta,<br />
Edizioni Il Sole-24 Ore,<br />
pagine 210, euro 23<br />
29 (37)
LA LIBRERIA DI TABLOID<br />
Milza, Berstein, Tranfaglia, Mantelli<br />
Dizionario <strong>dei</strong> fascismi<br />
di Dario Fertilio<br />
Per molti di coloro che hanno<br />
vissuto con preoccupazione<br />
l’amara stagione politica<br />
del Sessantotto, il termine<br />
“fascista” resta tutt’ora carico<br />
di significati ambigui, intimidatori.<br />
“Fascista”, durante<br />
quegli anni, serviva a designare<br />
estensivamente, ad<br />
additare al pubblico disprezzo,<br />
chiunque si differenziasse<br />
dal pensiero unico dominante,<br />
una vulgata marxistapopulista-maoista<br />
fin dall’inizio<br />
di fondo egemonico e<br />
dottrinario. I “fascisti” dovevano<br />
essere tenuti lontani<br />
dai luoghi in cui si esprimevano<br />
i “democratici”, e se necessario<br />
messi in condizione<br />
di non nuocere, magari a<br />
suon di bastonate. Per questo,<br />
in seguito, la polemica<br />
intorno al significato del fascismo<br />
come “malattia morale”<br />
ed “eterna”, una specie<br />
di virus sempre in agguato<br />
contro le forze sane e progressiste<br />
del popolo, ha costantemente<br />
allungato dietro<br />
di sé, persino quando è stata<br />
rilanciata da studiosi di storia<br />
degni di ogni rispetto, un’ombra<br />
vagamente sinistra.<br />
Tanto più importante, quanto<br />
a completezza e pragmatismo,<br />
la pubblicazione del<br />
Dizionario <strong>dei</strong> fascismi compilato<br />
da Pierre Milza e Serge<br />
Berstein per il pubblico<br />
francese, ma adattato con<br />
efficacia da Nicola Tranfaglia<br />
e Brunello Mantelli agli interessi<br />
di casa nostra.<br />
L’idea di fondo, che cioè sia<br />
possibile apparentare tra loro<br />
le varie forme di fascismo<br />
sviluppatesi in Europa nella<br />
prima metà del Novecento,<br />
tiene doverosamente conto<br />
delle differenze tra un regime<br />
e l’altro, e non pretende<br />
di ridurle ad alcun denominatore<br />
comune, morale o<br />
spirituale. La grande varietà<br />
delle voci, dalla “notte <strong>dei</strong><br />
lunghi coltelli” alla biografia<br />
di Claretta Petacci, dalle<br />
guardie di ferro di Codreanu<br />
agli intellettuali fiancheggiatori<br />
del nazismo, fa del<br />
Dizionario un ottimo strumento<br />
di consultazione non<br />
solo per lo studioso, ma anche<br />
per il semplice amante<br />
della storia.<br />
Il che non ci esenta dal passare<br />
brevemente in rassegna<br />
le tesi esposte da Nicola<br />
Tranfaglia nell’introduzione,<br />
perché essa è in gran parte<br />
dedicata “all’uso pubblico e<br />
politico della storiografia”,<br />
dunque riveste un particolare<br />
interesse per i giornalisti.<br />
Tranfaglia spiega il “primato”<br />
italiano nella nascita del primo<br />
fascismo europeo, che<br />
poi servì da modello a Hitler<br />
e ad altri, con le scarse radici<br />
democratiche e il forte nazionalismo<br />
interno italiani,<br />
oltre che con il fallimento<br />
precedente della classe politica<br />
liberale. Queste premesse<br />
lo conducono a una conclusione<br />
in linea con la scuola<br />
di pensiero post-marxista,<br />
secondo la quale il fascismo<br />
non fu un fenomeno di massa<br />
e “di sinistra” (tesi cara a<br />
De Felice) ma piuttosto un<br />
movimento nato fin dall’inizio<br />
in funzione anticomunista, e<br />
sorto in difesa delle classi<br />
possidenti. Nazionalismo e<br />
anticomunismo, dunque,<br />
avrebbero avviato il regime<br />
in quella direzione “totalitaria”<br />
destinata ad essere raggiunta<br />
ben più rapidamente<br />
dal nazionalsocialismo tedesco.<br />
Se il processo non ven-<br />
Ariberto Segàla<br />
Sultano delle nevi<br />
di Guido Re<br />
Ci sono vari modi di andare in<br />
montagna. Questo bel libro di<br />
Segàla, giornalista di lungo<br />
corso, scrittore e fotografo, ci<br />
insegna forse il modo più appagante:<br />
guardare, anche ciò<br />
che magari si è già visto mille<br />
volte, e ascoltare, anche<br />
quando tutt’intorno ci pare<br />
che sia solo silenzio. Perché<br />
la natura è ricca di misteri, di<br />
sorprese, di incontri inattesi,<br />
di rumori che ancora non percepisci<br />
ma che si stanno formando:<br />
e sono quelli di<br />
ghiaioni pronti a scivolare a<br />
fondovalle, di valanghe appena<br />
sopite sui pendii impennacchiati<br />
di neve, di vecchi rami<br />
che aspettano un soffio di<br />
vento per schiantarsi a terra<br />
con un colpo secco. In montagna,<br />
soprattutto lassù, nulla<br />
resta identico a se stesso, ma<br />
cambia di continuo, attimo dopo<br />
attimo. «Puoi percorrere<br />
cento volte lo stesso sentiero»,<br />
scrive Luciano Violante<br />
nella introduzione, «mettere<br />
le mani cento volte sulla stessa<br />
pietra, guardare cento volte<br />
lo stesso tratto di torrente, o<br />
lo stesso albero o lo stesso<br />
cespuglio, e ogni volta vedi<br />
una cosa leggermente diversa».<br />
La storia di Sultano non<br />
sfugge alla regola.<br />
È una storia vera, dice il sottotitolo,<br />
e poeticamente si dipana<br />
come un’elegia di sapore<br />
antico, arricchita da immagini<br />
preziose, più d’una mozzafiato.<br />
L’ambiente della storia è<br />
l’alta valle di Rhêmes, nel<br />
comprensorio del Gran<br />
Paradiso. I protagonisti sono<br />
tanti: sono gli uomini e gli animali,<br />
le rocce e le piante che<br />
animano il parco aostano, il<br />
ne mai completato del tutto,<br />
fu perché ne mancò il tempo,<br />
oltre che per influenza<br />
della chiesa cattolica e delle<br />
stesse organizzazioni degli<br />
imprenditori. Il fascismo, insomma,<br />
si collocò secondo<br />
Tranfaglia all’incirca a metà<br />
di una scala ideale che include,<br />
sul gradino più alto, il genocida<br />
nazionalsocialismo<br />
hitleriano, e su quello più<br />
basso i relativamente blandi<br />
autoritarismi “cattolici” di<br />
Spagna e Portogallo.<br />
Ancora: un elemento comune<br />
a tutti i fascismi fu un certo<br />
grado di “disordine interno”,<br />
con relativi scontri fra i<br />
gerarchi alla conquista di posizione<br />
di potere (sia pure<br />
nell’ombra del capo).<br />
Queste interpretazioni del<br />
fascismo certo non tengono<br />
conto del suo carattere intimamente<br />
anti-borghese, anti-liberale<br />
e, nella linea di<br />
tendenza (come dimostra il<br />
programma della Repubblica<br />
sociale italiana) avversario<br />
della proprietà privata.<br />
Inoltre non spiegano le affinità,<br />
in qualche caso addirittura<br />
le alleanze con i regimi<br />
primo creato in Italia, e lo fanno<br />
vivere e sopravvivere nonostante<br />
gli assalti spesso<br />
sconsiderati <strong>dei</strong> suoi visitatori.<br />
Ma protagonista assoluto è<br />
lui: uno stambecco dal portamento<br />
maestoso e dal trofeo<br />
superbo e inconfondibile. Due<br />
corna a scimitarra eccezionalmente<br />
lunghe (111 centimetri<br />
il destro, due di più il sinistro:<br />
come dire oltre 20 centimetri<br />
la misura considerata<br />
straordinaria) e divaricate alle<br />
punte di ben 108 centimetri,<br />
quasi 30 più di un’apertura<br />
già fuori del comune.<br />
Tutto ha inizio una mattina di<br />
giugno del 1985. Nel cannocchiale<br />
del guardaparco Provino<br />
Chabod, 51 anni, una<br />
lunga barba grigia e due occhi<br />
penetranti, si staglia l’ombra<br />
di uno stambecco bellissimo,<br />
mai visto prima da quelle<br />
parti, né da lui che pure conosce<br />
la valle di Rhêmes come<br />
le sue tasche né dai suoi colleghi<br />
che sono soliti annotare<br />
giorno per giorno ogni “novità”<br />
sui loro quaderni. L’animale<br />
«avanzava con alterigia e il<br />
corpo sembrava, in controluce,<br />
un antichissimo idolo nero.<br />
Le corna parevano gettate<br />
totalitari comunisti, in testa<br />
l’Unione Sovietica. Hanno<br />
però il pregio di liberare la<br />
storiografia progressista dal<br />
fardello ormai insostenibile<br />
del “doppiopesismo”: che a<br />
lungo le ha impedito di accettare<br />
i confronti fra comunismo<br />
sovietico e nazionalsocialismo<br />
tedesco, e addirittura<br />
di applicare la categoria<br />
di totalitarismo al bolscevismo<br />
genocida di Lenin e di<br />
Stalin. Tranfaglia, nella sua<br />
introduzione al Dizionario,<br />
chiarisce in modo esplicito<br />
che il dibattito su questi punti<br />
si può considerare ormai<br />
concluso, e le tesi considerate<br />
a suo tempo “revisionistiche”<br />
sono ormai di dominio<br />
comune.<br />
Non risparmia, infine, un accenno<br />
alle democrazie “plebiscitarie”<br />
di oggi, e ai rischi<br />
che diano vita a nuove incarnazioni<br />
semi-fasciste. Un tema<br />
delicato e controverso,<br />
sul quale il Dizionario ovviamente<br />
non può dire nulla, e<br />
che resterà probabilmente<br />
un nodo da sciogliere nelle<br />
interpretazioni degli anni a<br />
venire.<br />
Pierre Milza,<br />
Serge Berstein,<br />
Nicola Tranfaglia,<br />
Brunello Mantelli,<br />
Dizionario <strong>dei</strong> fascismi.<br />
Personaggi,<br />
partiti, culture e istituzioni<br />
in Europa dalla Grande<br />
guerra a oggi,<br />
Bompiani,<br />
pagine 800, euro 38<br />
all’indietro in atto di sfida. Una<br />
scultura, pensò la guardia,<br />
una scultura intagliata nel legno».<br />
Contando gli anelli sulla<br />
parte posteriore delle corna,<br />
Chabod ne calcola l’età: otto<br />
anni. Ma dove si è nascosta<br />
una bestia così fantastica per<br />
tutto questo tempo? Da dove<br />
proviene? Come ha fatto a<br />
passare inosservata?<br />
Domande destinate a restare<br />
senza risposta. Un altro mistero<br />
della montagna.<br />
Con quella mole possente e<br />
quelle corna regali, che certamente<br />
durante la stagione<br />
degli amori scoraggiano i rivali<br />
e attirano le femmine del<br />
branco, il nome Sultano diventa<br />
d’obbligo. Chabod gli si<br />
mette alle calcagna, ne spia i<br />
movimenti, cerca di carpirne i<br />
segreti. E Sultano si fa leggenda.<br />
Scrive Segàla: «Sorprenderlo<br />
sulla vertigine di uno strapiombo<br />
era come affrontare<br />
un viaggio a ritroso, secolo<br />
dopo secolo, fino a raggiungere<br />
quella sterminata tenebra<br />
luminosa dove sono nati i<br />
miti e abitano ancora oggi i<br />
grandi archetipi dell’universo.<br />
Soprattutto Sultano sembrò<br />
Romano F. Tagliati<br />
Dopo l’esilio<br />
di Fabrizio de Marinis<br />
L’esilio come segno del destino<br />
o come fuga rigenerativa<br />
per navigare il vasto oceano<br />
dell’esistenza. Andare, cambiare,<br />
crescere per resistere<br />
ad un mondo dalla morale<br />
sempre più dubbia, dove la<br />
realtà ha, spesso, di gran lunga<br />
superato la fantasia.<br />
Cogliere il segno forte del fato<br />
e non resistergli perché ci sono<br />
momenti in cui è bene<br />
cambiare rotta. Chi di noi non<br />
ha vissuto o desiderato un<br />
suo piccolo grande esilio? E<br />
Simone Ventura intuisce che<br />
a volte il destino è più forte di<br />
ogni altra cosa. Il momento riflessivo<br />
del personaggio dell’ultimo<br />
romanzo di Romano<br />
F. Tagliati, per anni collaboratore<br />
del Resto del Carlino, La<br />
Voce, La Gazzetta di Mantova<br />
e direttore della rivista letteraria<br />
La Corte, si dipana in<br />
una lunga storia di emozioni,<br />
di riflessioni, di premonizioni.<br />
E il bilancio di una vita avviene<br />
una giornata di fine ottobre,<br />
dalle sette del mattino alle<br />
otto di sera, il giorno del suo<br />
cinquantesimo compleanno,<br />
in cui il protagonista passa in<br />
rassegna le fasi principali della<br />
sua esistenza, attraverso il<br />
lungo viaggio del ricordo.<br />
Uomo d’intuito e d’intelligenza<br />
con ambizioni politiche e letterarie,<br />
partendo da un casuale<br />
part time in una banca<br />
milanese, emigra in giovane<br />
età negli Stati Uniti con la giovane<br />
moglie e si ritrova dopo<br />
una carriera internazionale ai<br />
massimi vertici di una holding<br />
bancaria multinazionale. Da<br />
quel momento ha inizio un<br />
processo interiore di revisione<br />
attraverso il quale scopre di<br />
aver tradito la propria vocazio-<br />
vivere per preparare un capolavoro:<br />
la sua morte».<br />
La fine arriva il 16 marzo<br />
1994: ma Provino Chabod<br />
non c’è, non se l’è sentita di<br />
dare l’addio a quel compagno<br />
che ha seguito passo passo<br />
per un decennio, e che gli ha<br />
cambiato la vita. Così il compito<br />
di filmare la morte dello<br />
stambecco viene affidato alla<br />
guardia Stefano Borney.<br />
Sultano si è faticosamente arrampicato<br />
su un terrazzino erboso.<br />
Il suo ultimo trono: davanti<br />
gli si spalanca la cerchia<br />
<strong>dei</strong> monti sui quali ha lungamente<br />
regnato. L’animale è<br />
immobile, di tanto in tanto un<br />
lieve sussulto. Se non fosse<br />
per quelle corna, sarebbe irriconoscibile<br />
dato che ha perso<br />
metà del suo peso. È allo stremo<br />
delle forze. Con il poco di<br />
energia vitale che gli è rimasta<br />
cerca di sollevarsi. Uno<br />
sforzo immenso, ma ce la fa. Il<br />
trofeo svetta con orgoglio sulle<br />
montagne che l’hanno visto<br />
dominare incontrastato. Poi<br />
pesantemente ricade sul petto.<br />
I maschi giovani del branco,<br />
i suoi competitori in amore,<br />
gli si avvicinano per rendergli<br />
omaggio, sostano per<br />
ne, sacrificando a logiche paradossali<br />
quelle forze che, secondo<br />
la sua indole liberale e<br />
le sue origini, avrebbe dovuto<br />
invece impiegare in favore di<br />
coloro che avrebbe dovuto difendere.<br />
In un attimo di coraggio<br />
lascia il prestigioso incarico<br />
e torna in Italia. Genova lo<br />
accoglie con le sue dinamiche<br />
secolari e molti onori con<br />
un prestigioso incarico finanziario.<br />
Ma quello per lui è orami<br />
un mondo che lo inaridisce.<br />
Le crisi affettive con la<br />
moglie Veronica, l’amante<br />
Sissy, il ritrovato rapporto con<br />
il figlio, dopo un lungo tunnel<br />
di incomprensioni. Quella di<br />
Simone Ventura è la storia del<br />
desiderio di fuga e d’esilio,<br />
che ognuno di noi porta dentro,<br />
è l’odissea di un uomo,<br />
che impara a leggere i segni<br />
del destino e che con lui si allea.<br />
Mantovano d’origine dalla<br />
poetica antica, Romano F.<br />
Tagliati intrattiene il lettore sulle<br />
grandi tematiche della vita<br />
e dell’esistenza e sugli intricati<br />
rapporti della provincia italiana<br />
di cui è un profondo studioso<br />
e conoscitore. Ha al suo<br />
attivo dodici libri tradotti in<br />
molte lingue e un’intensa vita<br />
vissuta all’estero, soprattutto<br />
in Germania, negli Stati Uniti<br />
e in Estremo Oriente. Da ricordare<br />
Discorso in Piazza<br />
(1968), Icaro (1987), Le mani<br />
in tasca (1990), Elogio al<br />
prodigo (1993), Un uomo di<br />
provincia (1998) e La ragazza<br />
rumena (2002). Il libro, con<br />
prefazione del luminare di<br />
medicina Mario Tiengo, è tra i<br />
testi della biblioteca virtuale<br />
dell’Associazione Italiana Lotta<br />
al Dolore, Ailad.<br />
Romano F. Tagliati<br />
Dopo l’esilio,<br />
MNL Editore,<br />
pagine 188, euro 16<br />
qualche attimo a guardarlo e<br />
se ne vanno mogi.<br />
Termina così una delle più<br />
straordinarie avventure svoltesi<br />
nel Gran Paradiso. Ma del<br />
suo protagonista il ricordo<br />
non è svanito: lo dimostrano<br />
le migliaia di persone che<br />
presso il Centro del parco a<br />
Chavaney si soffermano ogni<br />
anno ad ammirare il corpo imbalsamato<br />
dello stambecco<br />
più famoso che abbia scorrazzato<br />
in Val di Rhêmes.<br />
Ariberto Segàla,<br />
Sultano delle nevi,<br />
Arca Edizioni<br />
Daniela Piazza Editore,<br />
pagine 191, euro 18<br />
30 (38) ORDINE 1 <strong>2004</strong>
LA LIBRERIA DI TABLOID<br />
Vittorio Agnoletto<br />
Prima persone<br />
di Massimo Cobelli<br />
In occasione del secondo<br />
Forum sociale europeo, tenutosi<br />
a Parigi Saint-Denis a<br />
metà novembre, le cronache<br />
del quotidiano Libération<br />
erano permeate da uno<br />
scetticismo sintetizzato da<br />
alcune dichiarazioni <strong>dei</strong> partecipanti:<br />
“C’è sempre più<br />
povertà e indigenza, bisogna<br />
reagire”; “Bisogna battersi<br />
perché ci siano meno<br />
ineguaglianze fra i paesi poveri<br />
e i paesi ricchi. Come<br />
del resto fra Parigi e la sua<br />
periferia”; “La logica di mercato,<br />
ecco cosa dobbiamo<br />
contrastare… anche se si innervosiscono,<br />
e cosa ci importa<br />
se i politici sono i loro<br />
servi”; “un altro mondo è<br />
possibile, ma non sappiamo<br />
ancora quale”; “nelle loro<br />
manifestazioni c’è di tutto. E<br />
ciascuno rivendica quello<br />
che gli interessa difendere. È<br />
una prassi poco chiara”.<br />
Queste affermazioni tornano<br />
alla mente leggendo le pagine<br />
di Prima persone, storia<br />
privata di Vittorio Agnoletto,<br />
una storia che si fa progressivamente<br />
sempre più pubblica,<br />
cioè politica. E dove la<br />
Storia, quella con la esse<br />
maiuscola, viene giudicata e<br />
vissuta da una sensibilità e<br />
da una cultura di parte, dove<br />
dubbio e scetticismo sono<br />
quasi del tutto assenti.<br />
Vittorio Agnoletto non è “nato”<br />
con il G8 di Genova o come<br />
portavoce del Genova<br />
social forum e neppure con il<br />
vestito “no global”, ma è<br />
giunto come tanti alla militanza<br />
nel movimento contro<br />
la globalizzazione attraverso<br />
un percorso specifico e preciso.<br />
Il suo attuale attivismo<br />
ORDINE 1 <strong>2004</strong><br />
è la diretta conseguenza di<br />
una militanza sociale ultradecennale<br />
nel mondo associativo<br />
e del volontariato. Nel<br />
1987 insieme ad altri ha fondato<br />
la Lila e da allora per<br />
quindici anni si è occupato a<br />
tempo pieno, in campo<br />
scientifico e sociale, della<br />
lotta all’Aids e della difesa<br />
<strong>dei</strong> diritti delle persone sieropositive.<br />
Come scrive lo<br />
stesso Agnoletto, egli ha vissuto<br />
questa esperienza nell’interezza<br />
della sua dimensione<br />
umana, senza separare<br />
il cervello dal cuore, la razionalità<br />
dai sentimenti, il rigore<br />
scientifico dall’emotività.<br />
Con questo libro si pone l’obiettivo<br />
di illustrare la storia,<br />
le ragioni ed anche le difficoltà<br />
del movimento <strong>dei</strong> movimenti<br />
e soprattutto di rendere<br />
chiare a tutti le principali<br />
proposte. Il tentativo è duplice:<br />
fornire uno strumento<br />
utile al confronto dentro il<br />
movimento e informare chi<br />
del movimento non fa parte<br />
e magari non ne condivide<br />
neppure le idee, ma non rinuncia<br />
a “camminare do-<br />
mandando”. “Procederò anche<br />
attraverso il racconto di<br />
episodi <strong>dei</strong> quali sono stato<br />
diretto protagonista o testimone,<br />
episodi a volte noti<br />
(almeno nella loro versione<br />
ufficiale), a volte sconosciuti”,<br />
scrive l’autore.<br />
Prima persone sintetizza l’obiettivo<br />
ultimo del movimento:<br />
ogni persona, indipendentemente<br />
dal genere, dalla<br />
religione, dal colore della<br />
pelle e dalla regione del pianeta<br />
dove ha avuto il destino<br />
di nascere, deve essere al<br />
centro <strong>dei</strong> nostri progetti e<br />
delle nostre preoccupazioni<br />
per il mondo futuro che stiamo<br />
costruendo; ma con le<br />
parole Prima persone Agnoletto<br />
desidera anche sottolineare<br />
come in questo cammino<br />
verso un nuovo mondo<br />
possibile ognuno di noi, e<br />
quindi anche lui stesso, mette<br />
in gioco direttamente se<br />
stesso e la propria storia.<br />
Un movimento, quindi, che<br />
pone in discussione la vita<br />
quotidiana di ciascuno di<br />
noi, ad esempio ricordandoci<br />
come tutti i giorni, quando<br />
facciamo la spesa, mentre<br />
scegliamo il prodotto da acquistare,<br />
compiamo un gesto<br />
con una precisa valenza<br />
sociale. Non a caso le realtà<br />
impegnate nel consumo critico<br />
ci ricordano che “ogni<br />
volta che entri in un supermercato<br />
entri in una cabina<br />
elettorale”. Affermazione che<br />
dovrebbe essere tenuta presente<br />
ogni volta che si entra<br />
una chiesa o in una sede politica,<br />
ogni volta che si utilizza<br />
la “cultura” accendendo il<br />
televisore o entrando in un<br />
cinema o teatro o libreria,<br />
frustrati come siamo da una<br />
società virtuale il cui comune<br />
denominatore è la logica del<br />
mercato.<br />
È però come portavoce del<br />
Genova social forum nel luglio<br />
2001 che Agnoletto acquista<br />
una forte visibilità mediatica:<br />
par condicio oblige<br />
(vista l’ormai dilagante controinformazione<br />
sostenuta<br />
da controprove documentali<br />
Candida Morvillo<br />
La repubblica delle veline<br />
di Paolo A. Paganini<br />
Anche le “veline”, dunque, come<br />
tutto quello che in Italia<br />
passa per “nazional-popolare”,<br />
da fenomeno televisivo,<br />
hanno rischiato di diventare<br />
un caso socio-politico. Nei primi<br />
giorni dello scorso mese di<br />
luglio, è stata pubblicata la notizia<br />
che, su iniziativa della<br />
Regione Campania, con una<br />
consistente borsa europea di<br />
un milione e 280 mila euro,<br />
sarà aperta la prima scuola<br />
ufficiale delle “veline”. Da carne<br />
privilegiata per schermi tv<br />
e calciatori zuzzurelloni, le<br />
“veline” stanno per avere titolo<br />
professionale con tanto di ufficialità<br />
sancita da un diploma.<br />
La notizia non è passata inosservata.<br />
Da An a Rifondazione si è<br />
scatenata una travolgente rid-<br />
da di critiche contro la Regione<br />
Campania, che perpetuerebbe,<br />
attraverso l’ipocrita<br />
titolo di “figuranti dello spettacolo”,<br />
l’indegno mercato dello<br />
sfruttamento del corpo femminile.<br />
Si è scomodata perfino<br />
la Costituzione. È stata presentata<br />
un’interrogazione<br />
parlamentare. Sono scesi in<br />
campo sociologi, psicologi,<br />
scrittori, saggisti e moralisti.<br />
Tutto per un po’ di ragazzotte<br />
in mutande.<br />
Questa nostra premessa, che<br />
riguarda soprattutto la cronaca,<br />
serve a capire il sorprendente<br />
e spregiudicato libro di<br />
Candida Morvillo, La repubblica<br />
delle veline, che, con<br />
fantascientifica malizia, verrebbe<br />
voglia di pensare sia<br />
stato propiziato ad arte dal<br />
gran parapiglia sollevato dai<br />
giornali sul caso della Regione<br />
Campania. Non è certo<br />
così. Ma, leggendo il suo coraggioso<br />
libro, sembra che la<br />
Morvillo sia capace di tutto.<br />
Possiede la colorita ed accattivante<br />
abilità della narratrice<br />
con impavido gusto anche<br />
per i più scabrosi argomenti e<br />
vanta la stupefacente disinvoltura<br />
di una disinibita cronista<br />
di razza. Indaga, raccoglie<br />
e svela, con certosino accanimento,<br />
lavorando su notizie e<br />
pettegolezzi indifferente alle<br />
presumibili, fatali inimicizie<br />
che inevitabilmente si sarà<br />
procurata. D’altra parte non<br />
avrebbe potuto fare altrimenti<br />
dedicandosi a una specie di<br />
diario di bordo della scemenza<br />
femminile nello starnazzante<br />
carrozzone Tv.<br />
Incurante, determinata, e con<br />
qualche tentazione alla ferocia,<br />
la Morvillo fa la storia delle<br />
veline, o comunque siano<br />
state chiamate, letterine, mi-<br />
che la tecnologia ci mette a<br />
disposizione) che nelle cronache<br />
<strong>dei</strong> fatti di Genova si<br />
dia spazio per una lettura <strong>dei</strong><br />
fatti anche al portavoce del<br />
movimento <strong>dei</strong> movimenti:<br />
chi è questa persona minuta<br />
dalla voce ferma ed appassionata<br />
che non perde occasione<br />
per ricordarci i diritti<br />
quotidianamente negati ai<br />
più deboli ed emarginati?<br />
L’ingiustizia e l’inutilità della<br />
guerra come risolutrice della<br />
conflittualità e il progressivo<br />
deterioramento della qualità<br />
della vita e dell’ambiente,<br />
subìto non solo dai più deboli<br />
ma anche da tutti gli altri,<br />
ricchi e straricchi inclusi, che<br />
portano ciecamente avanti<br />
queste contraddizioni boomerang.<br />
Il Capitale di Marx e i Vangeli<br />
riportati ai loro veri e soli valori<br />
di fondo: carità sì ma nel<br />
contempo lottare per eliminare<br />
le cause che rendono<br />
necessaria questa carità.<br />
L’una senza l’altra sono solo<br />
vuote parole, parole prive di<br />
dignità, di pari dignità.<br />
Ma dove il libro delude, è<br />
nell’affrontare la tematica<br />
con la quale il movimento<br />
<strong>dei</strong> movimenti deve confrontarsi,<br />
quella della sua rappresentatività<br />
politica istituzionale.<br />
Dibattito e confronto<br />
assolutamente non rinviabili,<br />
un tema al quale si dovrebbe<br />
dedicare almeno un intero<br />
social forum, vitale per lo<br />
stesso movimento, che contrariamente<br />
rischia di farsi<br />
consumare e strumentalizzare<br />
dalla sua generica e ripetitiva<br />
riaffermazione di diritti<br />
negati invece di “incarnarsi”<br />
in prima persona nelle<br />
istituzioni democratiche.<br />
Vittorio Agnoletto liquida il<br />
“problema <strong>dei</strong> problemi” in<br />
poche righe: “La rinuncia del<br />
movimento ad un’autorappresentazione<br />
nelle sedi istituzionali<br />
– la non identificazione<br />
con partiti o ideologie<br />
di riferimento – non può essere<br />
confusa con la rinuncia<br />
all’auto-organizzazione e all’autogestione<br />
delle nostre<br />
crofonine, biscardine, schedine,<br />
postine, prezzemoline,<br />
calcioline eccetera, a cominciare<br />
dalla mitica Edy<br />
Campagnoli fino alle veline di<br />
“Striscia la notizia”, fino agli<br />
ultimi maliziosi sculettamenti.<br />
Una storia lunga mezzo secolo<br />
attraverso l’immaginario<br />
erotico televisivo. E attraverso<br />
il mito, il miraggio, il grande<br />
sogno, l’eterna illusione ch’è<br />
la Televisione, facile e redditizio<br />
viatico per arrivare, con un<br />
paio di disinvolte apparizioni,<br />
a un successo tanto strepitoso,<br />
quanto effimero. Orde di<br />
fanciulle, non sempre in fiore,<br />
di ogni ceto e di ogni stazza,<br />
si presentano alle varie selezioni<br />
indifferenti ad ogni brutta<br />
figura. D’altronde, a fronte della<br />
possibilità d’un lavoro facile<br />
(non si richiede nessuna particolare<br />
abilità, se non quella<br />
dell’esibizione della propria<br />
A cura di Gianni Rizzoni<br />
Agenda letteraria<br />
<strong>2004</strong><br />
di Massimo Cobelli<br />
La prima Agenda letteraria<br />
è nata nel 1991. Ad essa<br />
sono seguite nel corso degli<br />
anni le altre agende<br />
specializzate. Per il <strong>2004</strong><br />
infatti sono stati programmati<br />
cinque titoli (Letteratura,<br />
Arte, Scienza, Musica<br />
e Moda) più due agende<br />
di formato maggiore dedicate<br />
a Dante Alighieri<br />
(con le illustrazioni di Doré<br />
per il Purgatorio ed il<br />
Paradiso) e a Francesco<br />
Petrarca in occasione del<br />
settimo centenario della<br />
nascita.<br />
Ma torniamo alla decana,<br />
all’Agenda letteraria. Con<br />
l’edizione del <strong>2004</strong> ha raggiunto<br />
la tredicesima edizione.<br />
È diventata ormai<br />
un’agenda “mito”, un volume<br />
da collezione, oltre che<br />
un indispensabile strumento<br />
di lavoro per giornalisti<br />
culturali, bibliotecari, insegnanti,<br />
librai.<br />
Realizzata in collaborazione<br />
con Mondolibri e, da alcuni<br />
anni, con il premio<br />
Grinzane Cavour e con la<br />
Società Dante Alighieri, l’agenda<br />
si apre con un utile<br />
elenco <strong>dei</strong> “Centenari” culturali<br />
che cadono nel <strong>2004</strong>:<br />
nascita e morte di scrittori,<br />
proposte. Negli anni recenti il<br />
mondo politico e i media non<br />
hanno potuto fare a meno di<br />
porre al centro della loro attenzione<br />
molte delle tematiche<br />
sollevate dal movimento;<br />
anche se le risposte sono<br />
state spesso diverse da<br />
quelle attese, siamo diventati<br />
un interlocutore dal quale<br />
nessuno può prescindere”.<br />
Ma c’è una contraddizione di<br />
fondo. Agnoletto infatti afferma:<br />
“Il movimento, oggi, è<br />
dotato di una grande forza,<br />
che sempre di più riesce a<br />
coinvolgere soggetti sociali<br />
anche molto diversi e a spingerne<br />
altri a ricercare comunque<br />
un colloquio con noi<br />
su alcuni temi importanti:<br />
questo fatto è in grado di<br />
bellezza) e ben retribuito (si<br />
può arrivare a prendere anche<br />
15 mila euro al mese con<br />
le varie comparsate pubblicitarie!),<br />
ogni sacrifico diventa<br />
legittimo.<br />
Scrupolosa, precisa, quasi<br />
maniacale nella sua ricerca,<br />
la ventinovenne scrittrice (è<br />
attualmente giornalista di<br />
Vanity Fair dopo aver militato<br />
a Oggi), mette sulla graticola<br />
qualcosa come 650 nomi, rivelando<br />
scene e retroscene,<br />
non sempre edificanti, suddivise<br />
meticolosamente in capitoli,<br />
con l’accuratezza impietosa<br />
d’un entomologo che<br />
non concede nulla ad ombre<br />
ed ipotesi. Annota, rivela, e<br />
basta. “Uno specchio dell’Italia<br />
che ci ritroviamo”, chiosa<br />
giustamente. Ecco, dunque,<br />
partendo dai primordi di<br />
“Lascia e raddoppia”, la storia<br />
<strong>dei</strong> nostri ultimi cinquant’anni,<br />
“delle nostre passioni, <strong>dei</strong> nostri<br />
miti, delle bugie che ogni<br />
tanto amiamo raccontarci...”<br />
Anche i duri talvolta amano<br />
intenerirsi. Appena un poco,<br />
perché il prezzo della celebrità<br />
è quasi sempre spietato,<br />
e dietro sorrisi smaglianti, curve<br />
vertiginose, sederi e cosce<br />
di uomini di cultura, pubblicazione<br />
di libri celebri,<br />
eventi culturali.<br />
Il volumetto si chiude con<br />
un’appendice di una quarantina<br />
di pagine dedicate<br />
a premi letterari, alle case<br />
editrici italiane, alle pagine<br />
letterarie di quotidiani e periodici,<br />
a catene librarie, librerie<br />
virtuali, agenti letterari,<br />
associazioni, parchi<br />
letterari… fornendoci date,<br />
il nome <strong>dei</strong> responsabili, indirizzi<br />
e numeri telefonici. Il<br />
tutto intercalato da splendide<br />
illustrazioni in bicromia.<br />
Agenda letteraria <strong>2004</strong>,<br />
a cura di Gianni Rizzoni,<br />
Libri Scheiwiller,<br />
pagine 160, euro 12<br />
modificare i rapporti cui eravamo<br />
abituati tra movimento<br />
e società politica. La forza<br />
del movimento sembra in<br />
grado di mettere in moto anche<br />
un processo di trasformazione<br />
del quadro politico”.<br />
In queste parole egli afferma<br />
indirettamente la necessità<br />
che solo chi vive all’interno<br />
del movimento è in<br />
grado di rappresentarne e<br />
concretizzarne la forza propositiva,<br />
di tutte le sue anime,<br />
per “muoversi globalmente<br />
e agire localmente”.<br />
Vittorio Agnoletto,<br />
Prima persone,<br />
Editori Laterza,<br />
pagine 248, euro 14<br />
della più perfetta ed estatica<br />
ammirazione (costruita quasi<br />
sempre da abili chirurghi), si<br />
celano drammi umani, qualche<br />
volta risolti con un buon<br />
matrimonio, altre volte sul lettino<br />
dello psicanalista, dopo<br />
aver conosciuto altri letti.<br />
Candida Morvillo,<br />
La repubblica<br />
delle veline -<br />
Vita, vezzi e vizi<br />
della ragazze della tivù<br />
dagli anni ‘50<br />
ai giorni nostri, Rizzoli,<br />
pagine 270, euro 12<br />
31 (39)
Aumentano<br />
le quote<br />
per coniugi<br />
e genitori<br />
Ritoccato il tariffario Casagit:<br />
rimborsi e contributi più pesanti<br />
Innanzi tutto l’aumento medio previsto è<br />
del 10%, anche se i ritocchi sono a pioggia.<br />
Ad essere privilegiate sono state le<br />
prestazioni più richieste, quelle dove la<br />
differenza fra i massimali previsti e la spesa<br />
effettiva era più elevata e quelle per le<br />
patologie più gravi. È necessario ricordare<br />
però che tutti i giornalisti iscritti alla cassa<br />
riceveranno a casa il nuovo tariffario insieme<br />
alle convenzioni in atto in tutta Italia.<br />
E sarà inoltre disponibile sul sito della<br />
cassa www.casagit.it. Gli esempi più<br />
eloquenti sono quelli delle visite specialistiche<br />
che, nel nuovo elenco, passano da<br />
61,97 a 80 euro, mentre le visite omeopatiche<br />
da 41,32 a 50 euro.<br />
A loro volta, la degenza retta giornaliera<br />
passa da 232,41 a 250 euro, la retta per<br />
malattie nervose da 154,94 a 200 euro,<br />
quella per lungodegenza da 30,99 a 35<br />
euro. Per la chirurgia generale invece l’aumento<br />
medio è del 10% come per le cure<br />
dentarie, mentre la fisioterapia lievita del<br />
20 ed entra la nuova voce dell’assistenza<br />
di Francesca Romanelli<br />
Rivoluzione Casagit al via dal 1° gennaio<br />
<strong>2004</strong>. Con il nuovo cambia il tariffario della<br />
Cassa <strong>dei</strong> giornalisti e i soci troveranno nelle<br />
loro tasche rimborsi più pesanti per tutta una<br />
valanga di prestazioni mediche. Ma, sull’altro<br />
piatto della bilancia, arrivano ritocchi ai<br />
contributi da versare per tutte le categorie<br />
degli operatori dell’informazione. E l’adozione<br />
di nuove procedure basate sul silenzio<br />
LE VARIAZIONI PER LE PRESTAZIONI<br />
ai malati terminali (150 euro al giorno). Il<br />
settore psicoterapia vede un aumento delle<br />
sedute da 35 a 40 euro l’anno e del<br />
concorso per visita da 25,82 a 30 euro. La<br />
diagnostica, infine, assiste anch’essa<br />
all’aumento medio del 10%.<br />
Tutto questo, ossia l’onere complessivo<br />
dell’aumento <strong>dei</strong> rimborsi, costerà circa<br />
4.600.000 euro l’anno pari a 9 miliardi del<br />
vecchio conio. E a finanziare la spesa<br />
sono, per oltre il 90%, i colleghi tutelati dal<br />
contratto nazionale di lavoro giornalistico.<br />
Per l’aumento di contributi <strong>dei</strong> soci non<br />
contrattualizzati è previsto infatti un introito<br />
aggiuntivo di 400.000 euro l’anno, mentre<br />
resterà stabile il contributo <strong>dei</strong> pensionati.<br />
Il resto della spesa per il nuovo tariffario è<br />
coperto dalla lievitazione delle trattenute<br />
Casagit dovuta per agli aumenti conquistati<br />
dalla categoria con l’ultimo contratto e<br />
per l’aumento dallo 0,50 allo 0,95% del<br />
contributo per la salute a carico degli editori,<br />
strappato dal sindacato nel corso della<br />
vertenza contrattuale.<br />
VARIAZIONI TARIFFARIO<br />
prima dopo<br />
visite specialistiche 61,97 euro 80 euro<br />
visite omeopatiche 41,32 euro 50 euro<br />
degenza retta giornaliera 232,41 euro 250 euro<br />
retta per malattie nervose 154,94 euro 200 euro<br />
retta per lungodegenza 30,99 euro 35 euro<br />
assistenza malati terminali - 150 euro al giorno<br />
psicoterapia aumento delle sedute 35 euro 40 euro<br />
psicoterapia aumento del concorso per visita 25,82 euro 30 euro<br />
VARIAZIONI CONTRIBUTO ASSISTENZA FAMILIARI<br />
prima dopo<br />
quota per coniuge o convivente more uxorio 703 euro 744 euro<br />
quota per figli dai 26 e fino ai 30 anni 1.055 euro 1.116 euro<br />
quota per figli di età superiore ai 30 e fino ai 35 anni 1.406 euro 1.488 euro<br />
quota per un genitore 1.406 euro 1.488 euro<br />
quota per entrambi i genitori 2.112 euro 2.232 euro<br />
I 4 modi<br />
per pagare<br />
la quota<br />
annuale<br />
dovuta<br />
all’<strong>Ordine</strong><br />
■Il tradizionale<br />
sportello<br />
esattoriale<br />
assenso per l’invio di documentazione fiscale<br />
come l’attribuzione ad una determinata<br />
fascia di reddito. Numeri e modalità di azione<br />
che modificano il rapporto degli iscritti con la<br />
cassa, perché il tariffario era ormai datato, i<br />
rimborsi erano fermi dal 1998, l’elenco delle<br />
prestazioni previste era in vigore da più<br />
tempo ancora. Tutte le novità dell’anno che<br />
verrà, e che ora è alle porte, sono state varate<br />
dal Consiglio di amministrazione della<br />
Casagit il 12 novembre scorso. A quella data<br />
TRATTENUTE SU STIPENDI E PENSIONI<br />
Chi ha la fortuna di lavorare con lo scudo del<br />
contratto giornalistico, ma anche i pensionati,<br />
continueranno a pagare per la Casagit il<br />
3,50% su stipendi e pensioni. L’incremento è<br />
stato infatti virtuale, nel senso che l’aliquota<br />
risale infatti la revisione del tariffario, che ha<br />
riscritto l’elenco delle prestazioni e ha accresciuto<br />
l’entità <strong>dei</strong> rimborsi. Una rivisitazione<br />
che è stata anticipata il 25 novembre scorso<br />
all’Associazione lombarda <strong>dei</strong> giornalisti, in<br />
viale Montesanto 7, per un’assemblea<br />
straordinaria degli iscritti che ha visto la<br />
presenza del presidente Casagit Andrea<br />
Leone e della fiduciaria lombarda Bianca<br />
Mazzoni. Quali sono però, in concreto, le<br />
innovazioni in arrivo?<br />
trattenuta è rimasta numericamente invariata,<br />
ma i giornalisti hanno già visto lievitare il<br />
contributo Casagit con gli aumenti derivati<br />
dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro<br />
<strong>dei</strong> giornalisti.<br />
CONTRIBUTO SOCI NON CONTRATTUALIZZATI<br />
Cambia radicalmente il criterio di calcolo<br />
del contributo. Non sarà più presa in considerazione<br />
come punto di riferimento la retribuzione<br />
convenzionale sulla base della<br />
quale ogni anno veniva ricalcolato il contributo<br />
<strong>dei</strong> non contrattualizzati, bensì la<br />
spesa media sostenuta dalla cassa per<br />
ciascun associato.<br />
Il tutto ricordando che per retribuzione<br />
convenzionale si intende una sorta di stipendio<br />
medio dell’operatore dell’informazione.<br />
Viene inoltre introdotta anche fra i soci non<br />
contrattualizzati una forma di mutualità e<br />
solidarietà: chi guadagna di più pagherà di<br />
più. Quest’anno, calcolando il contributo con<br />
il vecchio sistema ancorato allo stipendio<br />
medio della categoria, il contributo sarebbe<br />
stato di 2.400 euro l’anno.<br />
Con i nuovi conteggi invece i versamenti<br />
saranno di 2.256 euro per chi non supera il<br />
reddito annuo di 71.315,00 euro, di 2.496<br />
euro per chi ha un reddito fra i 71.315,00 e i<br />
100.000,00 euro e di 2.748 per chi supera il<br />
reddito annuo indicato in precedenza. In tutti<br />
questi casi il contributo, con le vecchie<br />
normative, sarebbe stato di 2.400 euro.<br />
CONTRIBUTO PRE L’ASSISTENZA AI FAMILIARI<br />
In questo caso invece, e sino alla fine del<br />
<strong>2004</strong>, il sistema per riconteggiare la quota<br />
aggiuntiva finalizzata all’assistenza <strong>dei</strong> familiari<br />
rimane quello della retribuzione del giornalista<br />
medio, valore incrementato dal rinnovo<br />
del contratto di lavoro di categoria.<br />
Perciò le nuove quote ammontano a 744 per<br />
coniuge o convivente more uxorio, a 1.116<br />
ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI<br />
“Esiste la necessità di far pagare di più a chi<br />
ha di più” afferma Leone durante l’incontro<br />
del 25 novembre. “Gli aumenti sono dovuti al<br />
rinnovo del contratto.<br />
presso il quale è possibile effettuare i pagamenti senza<br />
nessun costo (a Milano ce ne sono uno in via San<br />
Gregorio 53 ed un altro in via Temolo 6, altri sono presenti<br />
in tutti i capoluoghi e nei maggiori centri delle provincie<br />
di Milano, Brescia, Pavia, Varese e Lodi)<br />
■Il telefono,<br />
con carta di credito<br />
chiamando il Servizio TAXTEL<br />
al numero 199.191.191,<br />
nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 17, al costo di € 2,32<br />
per versamenti fino all’importo di € 258,00. La quietanza<br />
viene tempestivamente recapitata per posta all’indirizzo<br />
indicato dal contribuente. Carte di credito abilitate: VISA –<br />
MASTERCARD – MONETA – AMERICAN EXPRESS –<br />
AURA – DINERS<br />
■Internet,<br />
collegandosi al sito<br />
www.taxtel.it<br />
con modalità identiche a quelle telefoniche, a parte l’orario,<br />
ovviamente.<br />
Le agenzie bancarie e quelle postali, utilizzando i bollettini<br />
Rav allegati all’avviso di pagamento;<br />
per i figli dai 26 fino a 30 anni, a 1.488 per i<br />
figli di età superiore a 30 e fino a 35 anni, a<br />
1.488 per un genitore e a 2.232 per entrambi.<br />
la prima eventualità vede un incremento<br />
di 41 euro rispetto al 2003, la seconda vede<br />
lievitare il contributo di 61 euro. La terza<br />
conosce un aumento di ben 82 euro e la<br />
quarta di 120.<br />
Per quanto riguarda invece i parenti come<br />
figli e genitori rimane in vigore la normativa<br />
precedente alla revisione di fine <strong>2004</strong>”<br />
conclude Leone.<br />
■In conto corrente<br />
bancario-Rid<br />
Da quest’anno è possibile richiedere l’addebito permanente<br />
in conto corrente bancario-Rid.<br />
Non si devono più ricordare le scadenze e si risparmia<br />
tempo!<br />
Confermata l’adesione al servizio Rid, secondo le modalità<br />
ed i termini sotto indicati, Esatri provvederà, ad ogni<br />
scadenza, a partire dalla quota addebitata con l’avviso di<br />
pagamento di quest’anno e per i prossimi anni, al pagamento<br />
automatico con addebito degli importi sul conto<br />
corrente bancario.<br />
Per aderire al servizio Rid è sufficiente:<br />
• compilare il modulo Rid contenuto nell’avviso di pagamento<br />
che sarà inviato agli iscritti e trasmetterlo ad<br />
Esatri via fax al 199.160.771.071, attenzione!, non<br />
deve essere presentato alla propria banca;<br />
• oppure compilare il modulo Rid elettronico disponibile<br />
su Internet al sito www.taxtel.it;<br />
• oppure comunicare via telefono i dati richiesti nel<br />
modulo Rid al n. 199 104 343 (dal lunedì al venerdì<br />
dalle 8.30 alle 17.00), disponibile anche per informazioni<br />
relative al Rid;<br />
Avvertenze<br />
• Chi aderisce al Rid non dovrà effettuare direttamente<br />
nessun pagamento;<br />
• I pagamenti addebitati saranno verificabili dall’estratto<br />
conto corrente bancario;<br />
• Il costo del servizio fissato per l’anno <strong>2004</strong> è di 2,07<br />
euro per ogni addebito effettuato.<br />
32 (40) ORDINE 1 <strong>2004</strong>