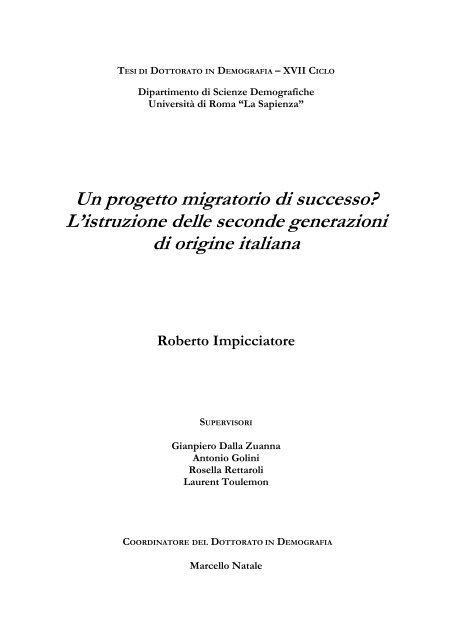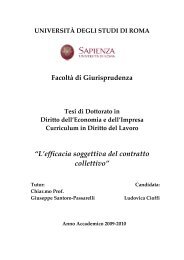L'istruzione delle seconde generazioni di origine ... - Padis - Sapienza
L'istruzione delle seconde generazioni di origine ... - Padis - Sapienza
L'istruzione delle seconde generazioni di origine ... - Padis - Sapienza
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
TESI DI DOTTORATO IN DEMOGRAFIA – XVII CICLO<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Scienze Demografiche<br />
Università <strong>di</strong> Roma “La <strong>Sapienza</strong>”<br />
Un progetto migratorio <strong>di</strong> successo?<br />
L’istruzione <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana<br />
Roberto Impicciatore<br />
SUPERVISORI<br />
Gianpiero Dalla Zuanna<br />
Antonio Golini<br />
Rosella Rettaroli<br />
Laurent Toulemon<br />
COORDINATORE DEL DOTTORATO IN DEMOGRAFIA<br />
Marcello Natale
Ai miei genitori,<br />
a mio zio che costruiva grattacieli in America latina,<br />
a chi ha vissuto la sfida dell’emigrazione,<br />
ai miei cugini d’oltreoceano che non ho mai conosciuto.
3<br />
Chi non ha mai commesso un errore<br />
non ha mai fatto una scoperta.<br />
(Samuel Smiles)
Introduzione p. 9<br />
Riferimenti bibliografici p. 13<br />
5<br />
INDICE<br />
Capitolo I. Aspetti, problematiche e interpretazioni del fenomeno “<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>”<br />
1.1 Perché parlare <strong>di</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>. p. 15<br />
1.2 Una molteplicità <strong>di</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> p. 16<br />
1.3 Peculiarità e problematiche <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> p. 18<br />
1.3.1 Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partenza:”capitale umano”<br />
e “capitale sociale p. 19<br />
1.3.2 Nuovi modelli <strong>di</strong> consumo, nuove aspirazioni e la<br />
“<strong>di</strong>ssonanza generazionale” p. 20<br />
1.3.3 Senso <strong>di</strong> appartenenza p. 21<br />
1.3.4 L’apertura del paese <strong>di</strong> accoglienza p. 22<br />
1.3.5 Il genere p. 23<br />
1.4 Problemi terminologici, problemi sostanziali p. 24<br />
1.5 Il recente <strong>di</strong>battito negli USA sulle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> p. 26<br />
1.5.1 “Vecchie” e “nuove” <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> p. 26<br />
1.5.2 L’assimilazione “progressiva” p. 29<br />
1.5.3 L’assimilazione “segmentata” p. 31<br />
1.6 L’istruzione dei figli degli immigrati:meto<strong>di</strong>, letteratura e<br />
ipotesi <strong>di</strong> lavoro p. 34<br />
1.6.1 Meto<strong>di</strong> p. 34<br />
1.6.2 Letteratura e ipotesi p. 34<br />
1.7 Assimilazione linguistica e bilinguismo p. 38<br />
1.8 L’emigrazione italiana nel mondo p. 40<br />
Riferimenti bibliografici p. 43<br />
Capitolo II. In Francia<br />
2.1 L’emigrazione italiana in Francia p. 49<br />
2.1.1 Dall’unità d’Italia alla prima guerra mon<strong>di</strong>ale: la<br />
grande emigrazione p. 49
2.1.2 Gli anni tra le due guerre mon<strong>di</strong>ali p. 50<br />
2.1.3 Dal secondo dopoguerra alla fine degli anni sessanta p. 51<br />
2.2 Il sistema scolastico francese p. 53<br />
2.3 Dati e definizioni p. 54<br />
2.4 Una descrizione del campione p. 56<br />
2.5 Analisi multivariata p. 63<br />
2.5.1 L’interazione tra la storia migratoria familiare e la<br />
classe socio-economica p. 70<br />
2.5.2 Differenze nei risultati scolastici nelle <strong>di</strong>verse aree <strong>di</strong><br />
residenza p. 73<br />
2.6 La lingua parlata dai genitori e gli effetti del bilinguismo p. 74<br />
2.7 Conclusioni p. 79<br />
Riferimenti bibliografici p. 80<br />
Capitolo III. In Australia<br />
3.1 L’emigrazione italiana in Australia p. 85<br />
3.2 Il sistema scolastico in Australia p. 88<br />
3.3 Dati e definizioni p. 90<br />
3.4 Una descrizione del campione p. 92<br />
3.5 Analisi multivariata p. 96<br />
3.6 Conclusioni p. 102<br />
Riferimenti bibliografici p. 104<br />
Capitolo IV. In Svizzera<br />
4.1 L’emigrazione italiana in Svizzera p. 107<br />
4.2 Il sistema scolastico in Svizzera p. 110<br />
4.3 Dati e definizioni p. 112<br />
4.4 Una descrizione del campione p. 114<br />
4.5 Analisi multivariata p. 119<br />
4.6 Conclusioni p. 122<br />
Riferimenti bibliografici p. 123<br />
Capitolo V. L’istruzione dei figli dei meri<strong>di</strong>onali emigrati nel Centro-Nord Italia<br />
5.1 Le gran<strong>di</strong> migrazioni interne in Italia nell’ultimo secolo p. 125<br />
5.1.1 Prima della seconda guerra mon<strong>di</strong>ale p. 126<br />
6
5.1.2 Il secondo dopoguerra p. 128<br />
5.1.3 Accoglienza e integrazione degli immigrati meri<strong>di</strong>onali p. 130<br />
5.2 Dati e ipotesi specifiche p. 131<br />
5.3 Definizioni <strong>delle</strong> variabili <strong>di</strong> interesse p. 133<br />
5.4 Un quadro descrittivo: le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partenza p. 138<br />
5.5 Analisi multivariata p. 143<br />
5.5.1 Zona <strong>di</strong> destinazione Nord Ovest p. 146<br />
5.5.2 Zona <strong>di</strong> destinazione Centro- Nord Est p. 147<br />
5.6 Il problema della selezione nel campione analizzato: presentazione<br />
e applicazione del modello <strong>di</strong> Heckman p. 148<br />
5.7 Conclusioni e <strong>di</strong>scussione p. 152<br />
5.7.1 Storia migratoria familiare e investimento nell’istruzione :<br />
qualche spunto <strong>di</strong> riflessione sui possibili meccanismi p. 155<br />
Riferimenti bibliografici p. 157<br />
Capitolo VI. Conclusioni e spunti <strong>di</strong> riflessione<br />
6.1 Riepilogo dei risultati ottenuti p. 161<br />
6.2 Spunti <strong>di</strong> riflessione p. 163<br />
Riferimenti bibliografici p. 166<br />
Ringraziamenti p. 169<br />
7
9<br />
INTRODUZIONE<br />
Il nuovo ruolo dell’Italia , quale paese <strong>di</strong> immigrazione, si va affermando quando non si è ancora<br />
spenta l’eco <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fficoltà vissute dagli emigrati italiani all’estero. Nei paesi storici<br />
d’accoglienza tardano a sparire gli stereotipi e le caricature legate alla figura dell’italiano nel<br />
mondo. Tra<strong>di</strong>zionale paese esportatore <strong>di</strong> manodopera, l’Italia, nel giro <strong>di</strong> un secolo, ha visto<br />
partire più <strong>di</strong> venti milioni <strong>di</strong> suoi citta<strong>di</strong>ni. Molti <strong>di</strong> loro hanno fatto ritorno, ma non sono pochi<br />
quelli che hanno deciso <strong>di</strong> restare all’estero, portando la famiglia con sé o formandone una<br />
nuova, mettendo al mondo dei figli, che nel tempo sono <strong>di</strong>ventati citta<strong>di</strong>ni statunitensi, francesi,<br />
argentini o australiani. I mo<strong>di</strong>, i costumi e le tra<strong>di</strong>zioni italiane hanno attecchito nei vari angoli<br />
del pianeta, strade, quartieri e ad<strong>di</strong>rittura intere citta<strong>di</strong>ne parlavano italiano e italiano era il loro<br />
nome. Ma i figli degli emigrati, cresciuti a stretto contatto con la realtà del paese d’arrivo,<br />
attraverso la scuola e al gruppo dei pari, hanno acquisito una duplice identità culturale,<br />
fungendo spesso da ponte tra il mondo dell’immigrazione e la realtà locale. In bilico tra due<br />
mon<strong>di</strong>, due lingue, due universi culturali, le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> rappresentano un soggetto<br />
sociale particolarmente interessante e l’emigrazione italiana ha dato un contributo notevole alla<br />
formazione <strong>di</strong> questo gruppo in vari paesi del mondo.<br />
La grande emigrazione italiana all’estero inizia alla fine Ottocento e paesi come gli Stati<br />
Uniti, l’Argentina e la Francia hanno visto nascere sono non solo i figli degli immigrati, ma<br />
anche le terze e le quarte <strong>generazioni</strong>. Sebbene non sempre in maniera lineare, i processi <strong>di</strong><br />
integrazione degli italiani all’estero sono avanzati velocemente nel susseguirsi <strong>delle</strong><br />
<strong>generazioni</strong>. La scomparsa dei problemi linguistici e l’alta incidenza dei matrimoni misti hanno<br />
reso, nella maggior parte dei casi, ormai in<strong>di</strong>stinguibili i <strong>di</strong>scendenti degli italiani. Spesso resta<br />
solo un cognome dal suono buffo a memoria dell’esperienza migratoria dei propri antenati.<br />
Ripensando alle tante storie <strong>di</strong> emigrazione, ai lunghi viaggi oltre-oceano che duravano<br />
settimane, agli sbarchi a Ellis Island con pochi dollari intasca, alle baracche degli operai italiani<br />
in Svizzera, ai pochi <strong>di</strong>ritti in terra straniera, alle con<strong>di</strong>zioni igieniche approssimative, alla<br />
<strong>di</strong>scriminazione, ai tanti episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> violenza razzista subita, si resta ammirati e stupiti nel<br />
constatare il successo raggiunti da tanti <strong>di</strong>scendenti dei <strong>di</strong>scendenti dei protagonisti <strong>di</strong> storie<br />
spesso tragiche.<br />
«E tantissimi fecero davvero fortuna. Come Amedeo Obici, che partì da Le<br />
Havre a un<strong>di</strong>ci anni e sgobbando come un matto <strong>di</strong>ventò il re <strong>delle</strong> noccioline<br />
americane: «Mister Peanuts». […] O Geremia Lunardelli che, come racconta<br />
Ulderico Bernar<strong>di</strong> in Ad<strong>di</strong>o Patria, arrivò in Brasile senza una lira e finì per<br />
affermarsi in pochi anni come il re del caffè carioca, quin<strong>di</strong> mon<strong>di</strong>ale » (Stella,<br />
2003, pag. 10).
Superando le enormi <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento, tanti immigrati italiani hanno compiuto con<br />
successo il loro progetto migratorio fornendo ai propri figli pari opportunità <strong>di</strong> affermazione<br />
sociale rispetto ai figli degli autoctoni. L’apporto degli italiani e dei loro <strong>di</strong>scendenti è stato<br />
davvero importante in moltissimi paesi, sia economicamente che culturalmente.<br />
«Abbiamo dato alla Francia pittori come Paul Cézanne il cui vero cognome era<br />
Cesana, statisti come Léon Gambetta che restituì l’orgoglio al suo paese dopo la<br />
sconfitta <strong>di</strong> Sedan o scrittori come Emile Zola […]. Abbiamo dato all’Argentina<br />
patrioti quali Manuel Belgrano che era figlio <strong>di</strong> un genovese ed è ricordato non<br />
solo come l’ideatore della ban<strong>di</strong>era nazionale bianca e azzurra ma anche come<br />
uno dei padri dell’in<strong>di</strong>pendenza della Spagna, al punto che la sua data <strong>di</strong><br />
nascita è <strong>di</strong>ventata una festa nazionale: la Giornata dell’Emigrante. E poi<br />
scrittori come Ernesto Sabato, gran<strong>di</strong> musicisti come Astor Piazzola, calciatori<br />
come Antonio Valentino Angelillo, mitici piloti automobilistici com Juan Manuel<br />
Fangio, industriali come Agostino Rocca» (Stella, 2003, pag. 8).<br />
E poi ancora Fiorello La Guar<strong>di</strong>a, uno dei più amati sindaci <strong>di</strong> New York, Mario Cuomo,<br />
Rodolfo Valentino, Robert De Niro, Leonardo Di Caprio, John Fante, Martin Scorsese. Ma non<br />
solo persone illustri e famose. Sono tanti anche i casi <strong>di</strong> successo personale vissuto da gente<br />
comune. Esempi <strong>di</strong> compiuta integrazione, <strong>di</strong> mobilità sociale ascendente, per i quali il progetto<br />
migratorio dei genitori si è concretizzato nel giro <strong>di</strong> due <strong>generazioni</strong>, come per i componenti <strong>di</strong><br />
alcune famiglie <strong>di</strong> Lapio in Lucania emigrate negli Stati Uniti:<br />
«Dei figli <strong>di</strong> Raffaele Carbone e <strong>di</strong> Catello Romano, entrambi <strong>di</strong> cultura<br />
universitaria, il primo si de<strong>di</strong>ca al commercio dei gioielli, <strong>di</strong>ventando manager <strong>di</strong><br />
una importante società americana; il secondo, architetto ingegnere, <strong>di</strong>venta<br />
Ispettore Generale del governo americano in Washington. Ma anche i figli <strong>di</strong><br />
Saverio Romano <strong>di</strong> professione notaio, proseguono con successo la vita america:<br />
in particolare, il secondogenito Dante, nato nel 1900 a Boston, si <strong>di</strong>ploma alla<br />
English High School e, quattro anni dopo, al Mass. College of Pharmacy. Nel<br />
1935 occupa la posizione <strong>di</strong> manager in un azienda <strong>di</strong> prodotti farmaceutici a<br />
Brighton, dove risiede con la sua famiglia. […]<br />
Carmine Melchionne […] dà una svolta alla sua con<strong>di</strong>zione occupazionale <strong>di</strong><br />
lustrascarpe […] e spiana anche la via a sua figlia Margareth che, insieme alla<br />
sorella minore Adelaide, attiva una vera e propria rete <strong>di</strong> affari nel campo<br />
dell’estetica e <strong>delle</strong> acconciature» (Scartezzini et al., 1994).<br />
La grande emigrazione dall’Italia non si è arrestata neanche quando il nostro paese si andava<br />
imponendo a livello mon<strong>di</strong>ale come grande realtà industriale ed economica. Durante il<br />
“miracolo italiano” nuove ondate migratorie si <strong>di</strong>ressero in Francia, in Belgio, in Germania, in<br />
Svizzera, in Australia, tanto per citare le principali destinazioni. Parallelamente, facevano la loro<br />
10
comparsa nuove leve <strong>di</strong> <strong>di</strong>scendenti. Tra vecchie e nuove <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> italiani, il<br />
processo <strong>di</strong> integrazione, l’acculturazione, il successo economico e sociale è stato davvero così<br />
universale come gli esempi appena fatto sembrano mostrare?<br />
Le emergenze della sopraggiunta immigrazione in Italia hanno fatto velocemente stornare<br />
l’attenzione dagli italiani all’estero agli stranieri in Italia. Si tende ormai a pensare<br />
all’emigrazione come un fenomeno del passato, superato dai tempi. Al più oggi si parla <strong>di</strong> “fuga<br />
<strong>di</strong> cervelli”, identificando un tipo <strong>di</strong> emigrazioni lontano anni luce non solo da quello dei<br />
lustrascarpe e dei men<strong>di</strong>canti con le scimmiette in spalla <strong>di</strong> inizio Novecento, ma anche da<br />
quella che negli anni Cinquanta e Sessanta era <strong>di</strong>retta verso le industrie tedesche o i cantieri<br />
svizzeri, francesi o australiani. Certo le con<strong>di</strong>zioni degli italiani sono cambiate e così anche le<br />
ambizioni dei migranti. Ma la vicende migratorie del passato restano ancora ampiamente visibili<br />
nei tanti italiani all’estero, emigrati con la speranza <strong>di</strong> trovar con<strong>di</strong>zioni migliori rispetto a<br />
quelle <strong>di</strong> partenza. E con loro ci sono i figli, ibri<strong>di</strong> culturali, portatori <strong>di</strong> norme e valori propri<br />
della cultura italiana, che vivono, stu<strong>di</strong>ano e lavorano fianco a fianco con i figli dei nativi. Sono<br />
loro l’ere<strong>di</strong>tà più visibile e importante dell’emigrazione italiana.<br />
Laddove le rilevazioni statistiche riportano l’esperienza migratoria propria e dei genitori, le<br />
<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> possono essere identificate e utilizzate nell’ambito della ricerca socio-<br />
demografica. Proprio grazie ad alcune indagini campionarie, è stato possibile , nel presente<br />
lavoro, rintracciare il gruppo composto dai figli degli immigrati italiani in Francia, Australia e<br />
Svizzera e realizzare una serie <strong>di</strong> elaborazioni statistiche al fine <strong>di</strong> valutare l’influenza<br />
dell’esperienza migratoria del nucleo familiare sull’istruzione dei figli. Essendo comunemente<br />
ritenuto una risorsa fondamentale nel processo <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> posizioni sociali privilegiate, il<br />
livello d’istruzione va inteso come un fattore fondamentale nel processo <strong>di</strong><br />
integrazione/assimilazione.<br />
L’analisi è stata realizzata seguendo un’ottica <strong>di</strong>fferenziale: l’interesse non è quello <strong>di</strong><br />
misurare la riuscita scolastica e universitaria dei figli degli emigrati italiani in termini assoluti,<br />
ma <strong>di</strong> stimare le <strong>di</strong>fferenze tra questi e i figli dei nativi in termini <strong>di</strong> probabilità <strong>di</strong> raggiungere<br />
specifici traguar<strong>di</strong> nell’istruzione. In tal modo, si riduce fortemente l’influenza del contesto sul<br />
risultato (si pensi, ad esempio, alle specificità nazionali in tema <strong>di</strong> istruzione obbligatoria, alle<br />
<strong>di</strong>fferenze tra i <strong>di</strong>versi sistemi <strong>di</strong> istruzione e formazione al lavoro tra un paese e l’altro, alle<br />
mo<strong>di</strong>fiche intervenute nel corso degli anni all’interno <strong>di</strong> uno stesso paese). Nel perseguire tale<br />
obiettivo, si è cercato <strong>di</strong> limitare gli effetti del forte processo selettivo insito nella migrazione,<br />
tenendo sotto controllo l’effetto <strong>di</strong> aspetti osservati che caratterizzano un gruppo piuttosto che<br />
un altro, atti a identificare uno specifico family background (in termini soprattutto <strong>di</strong> classe<br />
sociale dei genitori, livello d’istruzione dei genitori e composizione familiare). L’analisi<br />
statistica multivariata è stata realizzata grazie all’ausilio dei modelli <strong>di</strong> regressione logistica, uno<br />
strumento particolarmente adatto alla valutazione <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> probabilità posseduta da<br />
<strong>di</strong>versi sottogruppi <strong>di</strong> popolazione <strong>di</strong> avere/non avere una specifica caratteristica.<br />
Quantunque il lavoro sia focalizzato sulle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> provenienti <strong>di</strong> italia ni<br />
all’estero, l’argomento e l’approccio utilizzato si inseriscono nel più vasto ambito dello stu<strong>di</strong>o<br />
sulle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> in un particolare contesto nazionale , che, iniziato e sviluppatosi negli<br />
11
Stati Uniti, è <strong>di</strong> crescente interesse anche in Europa. Nel primo capitolo, a scopo introduttivo,<br />
viene presentato il quadro teorico <strong>di</strong> riferimento. Inizialmente sono fornite alcune in<strong>di</strong>cazioni e<br />
chiavi <strong>di</strong> lettura comuni al variegato mondo <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>. La base <strong>di</strong> partenza è la<br />
vasta letteratura proveniente principalmente dagli USA dove, più che altrove, l’argomento è<br />
stato ed è fonte <strong>di</strong> una intensa ricerca scientifica. Il termine “seconda generazione” nasce, non a<br />
caso, in questo paese all’inizio del secolo scorso quando cominciano ad acquisire organicità gli<br />
stu<strong>di</strong> sui figli degli immigrati dall’Europa. Nel prosieguo del capitolo si focalizza sull’istruzione<br />
<strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>. La lettura <strong>di</strong> parte della letteratura mon<strong>di</strong>ale sull’argomento aiuta a<br />
sviluppare lo schema <strong>di</strong> ipotesi e i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> analisi utili per l’impostazione dei capitoli<br />
successivi. Si cerca anche <strong>di</strong> inquadrare brevemente la questione legata all’assimilazione<br />
linguistica, al bilinguismo e alle relazioni tra questi aspetti e la carriera scolastica. Il primo<br />
capitolo si conclude con un breve excursus sulla storia dell’emigrazione italiana nel mondo,<br />
tema che fa da ponte con i tre capitoli successivi nei quali si indaga sul successo nell’istruzione<br />
da parte dei figli degli emigrati italiani in Francia (capitolo II), in Australia (capitolo III) e in<br />
Svizzera (capitolo IV), paesi tra i più importanti importatori <strong>di</strong> manodopera italiana nel secondo<br />
dopoguerra.<br />
Nel capitolo V, spostando l’attenzione dalle migrazioni internazionali a quelle interne, si<br />
considera il successo scolastico e universitario dei figli degli emigrati meri<strong>di</strong>onali nel Centro-<br />
Nord Italia. A tal proposito, vale la pena <strong>di</strong> rimarcare che parte dell’Italia accoglie immigrati già<br />
da <strong>di</strong>versi decenni e che, pertanto, le <strong>di</strong>verse zone del paese si presentano all’appuntamento con<br />
l’arrivo <strong>di</strong> stranieri con esperienze molto <strong>di</strong>verse. Alcune regioni del paese hanno conosciuto<br />
solo l’esodo e l’emigrazione, solo l’abbandono dei paesi e <strong>delle</strong> campagne, sia che si partiva per<br />
l’America, la Germania o il Piemonte. Altre invece hanno già una esperienza decennale <strong>di</strong><br />
immigrazione che, seppure interna al paese, ha già più volte richiesto la necessità <strong>di</strong> porsi<br />
domande e <strong>di</strong> prospettare soluzioni per l’accoglienza e l’inserimento <strong>di</strong> nuovi arrivati. Le<br />
migrazioni interne nel nostro paese hanno avuto un peso e una importanza in<strong>di</strong>scutibili<br />
innescando, nelle regioni <strong>di</strong> accoglienza, una serie <strong>di</strong> effetti a breve e a lungo termine non<br />
<strong>di</strong>ssimili da quelli che più recentemente si stanno verificando nel nostro paese per<br />
l’immigrazione straniera. Tra questi, la formazione <strong>di</strong> un sottogruppo della popolazione del<br />
Centro-Nord Italia composta dai figli degli immigrati meri<strong>di</strong>onali. Non si tratta certo <strong>di</strong> una<br />
componente facilmente identificabile, come può esserlo quella dei figli <strong>di</strong> persone con tratti<br />
asiatici o africani, ma costituisce lo stesso un gruppo con una esperienza comune e con<br />
specifiche problematiche. Lo scopo <strong>di</strong> questo capitolo è anche quello <strong>di</strong> sottolineare l’interesse<br />
nell’estendere lo stu<strong>di</strong>o <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> anche nell’ambito interno <strong>di</strong> uno specifico<br />
paese. Come sottolineano Valverde e Vila (2003), questa applicazione è <strong>di</strong> estremo interesse<br />
poiché entra nello specifico <strong>di</strong> uno degli aspetti più problematici <strong>delle</strong> società moderne: la<br />
persistente ineguaglianza tra i membri <strong>di</strong> una popolazione.<br />
Il lavoro si chiude con il capitolo VI nel quale, oltre a un riepilogo dei principali risultati<br />
ottenuti, si cerca <strong>di</strong> tracciare <strong>delle</strong> conclusioni generali fornendo degli spunti <strong>di</strong> riflessione a<br />
scopo esplicativo.<br />
12
Sia chiaro sin d’ora: questo lavoro non vuole mettere a confronto o creare parallelismi tra le<br />
<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> italiani all’estero e quelle in Italia derivate dall’immigrazione straniera.<br />
Si tratta <strong>di</strong> contesti, momenti storici e attori <strong>di</strong>versi. Nessuna <strong>delle</strong> conclusioni a cui si giungerà<br />
avrà l’ambizione <strong>di</strong> essere estesa anche alle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> in Italia. Ciò non toglie che<br />
tanto più si conosce dell’esperienza degli altri paesi, e dunque degli stessi italiani all’estero, e<br />
<strong>delle</strong> passate esperienze e <strong>di</strong> integrazione nelle regioni italiane già interessate da migrazioni in<br />
entrata, tanti più elementi ci saranno per decifrare la mutata realtà italiana e per cercare <strong>di</strong><br />
anticipare <strong>delle</strong> strategie. Ce lo conferma anche Pugliese (2002): «lo stu<strong>di</strong>o dell’esperienza<br />
migratoria degli italiani, quella più recente e più antica, se correttamente inquadrata nel suo<br />
contesto storico e sociale permette anche <strong>di</strong> comprendere l’esperienza migratoria <strong>di</strong> coloro i<br />
quali vengono ora in Italia e le problematiche che essi vivono».<br />
Gli effetti della migrazione non si esauriscono in un viaggio o in pochi anni <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà.<br />
L’inserimento in una nuova realtà è un processo lungo, faticoso che può ad<strong>di</strong>rittura richiedere<br />
più <strong>di</strong> una generazione per il suo espletamento. Gli immigrati sono <strong>di</strong>sposti ad accettare<br />
posizioni sociali <strong>di</strong> basso profilo, percepirsi come temporanei, non avere esplicite ambizioni <strong>di</strong><br />
mobilità sociale, conservare lo stimolo e il vincolo <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>re le rimesse, in poche parole essi<br />
conservano uno stretto legame con la comunità d’<strong>origine</strong> e con essa confrontare la propria<br />
situazione. Per i loro figli nati e socializzati in una nuova realtà non è così. Essi formano le loro<br />
ambizioni e aspettative sui modelli locali e non più sulla comunità d’<strong>origine</strong> dei genitori,<br />
richiedono trattamenti e possibilità <strong>di</strong> ascesa sociale pari al resto della popolazione.<br />
Nell’insieme <strong>delle</strong> relazioni con gli autoctoni, i loro problemi e le loro peculiarità <strong>di</strong>ventano<br />
capaci <strong>di</strong> trasformare ra<strong>di</strong>calmente la società ospitante e <strong>di</strong> mettere in <strong>di</strong>scussione aspetti ritenuti<br />
fino a poco prima come intoccabili. Ci si rende, dunque, ben conto dell’importanza del<br />
fenomeno <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>, sia che queste derivino dall’emigrazione italiana nel mondo, sia<br />
che provengano dall’immigrazione straniera in Italia.<br />
Riferimenti bibliografici<br />
Pugliese E., 2002 L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Bologna, Il<br />
Mulino.<br />
Stella G. A., 2002, L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi, Milano, BUR.<br />
Scartezzini R., Gui<strong>di</strong> R. Zaccaria A.M., 1994, Tra due mon<strong>di</strong>: l’avventura americana tra i<br />
migranti italiani <strong>di</strong> fine secolo. Un approccio analitico, Milano, Franco Angeli.<br />
Valverde J.R. e Vila M.R., 2003, Internal migration and inequalities. The influence of migrant<br />
origin on educational attainment in Spain, European sociologal review, 19(3).<br />
13
15<br />
CAPITOLO I<br />
Aspetti, problematiche e interpretazioni del<br />
1.1 Perché parlare <strong>di</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>.<br />
fenomeno “<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>”<br />
I figli <strong>di</strong> immigrati si situano su una posizione <strong>di</strong> frontiera: socializzati a metà tra i valori dei<br />
genitori portatori <strong>di</strong> una cultura “altra” e quelli della scuola e della società in cui vivono. Ciò<br />
attribuisce alle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> un’importanza che travalica i problemi legati<br />
all’integrazione degli immigrati investendo, con la sua portata, l’intera società. Inventando e<br />
alimentando le interazioni sociali e culturali, l’avvento <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> assume un<br />
valore estremamente significativo sia per la società ospitante, che prende coscienza<br />
dell’irreversibile trasformazione che sta vivendo, sia per la prima generazione <strong>di</strong> immigrati, che<br />
consolida la propria affermazione quale parte integrante della società ricevente (Golini, 2003).<br />
La crescita <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> comporta un cambiamento importante della società<br />
ricevente potenzialmente capace tanto <strong>di</strong> innescare problemi reali quanto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere ansie<br />
ingiustificate. L’acquisizione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui, contrad<strong>di</strong>stinti da un’accentuata ibridazione culturale,<br />
pone in essere una re-interpretazione <strong>di</strong> alcuni principi ritenuti ormai acquisiti nonché un<br />
maggiore senso critico verso il senso <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne sociale. Si pensi al fatto che essi, ancor più dei<br />
loro genitori, prima o poi cominciano a richiedere parità <strong>di</strong> trattamento e <strong>di</strong> promozione sociale<br />
ma anche il riconoscimento della propria identità e <strong>di</strong> spazi <strong>di</strong> autonomia nella società <strong>di</strong> cui<br />
sono entrati a far parte (Ambrosini, 2004). Sono numerose le problematiche emergenti <strong>di</strong> cui<br />
bisogna tener conto. La questione legata alla religione, che in Europa non si sono poste con<br />
enfasi per la prima generazione <strong>di</strong> immigrati composta per lo più da uomini soli con progetti<br />
migratori temporanei, esplode con tutte le sue contrad<strong>di</strong>zioni con la crescita <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong>. La richiesta <strong>di</strong> spazi collettivi per il culto, <strong>di</strong> regimi alimentari appropriati nelle<br />
mense scolastiche e lavorative, <strong>di</strong> opportunità per realizzare pratiche educative conformi a<br />
precetti <strong>di</strong>versi da quelli dettati dal cristianesimo. A ciò si aggiunga che le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
pongono degli interrogativi sulla concezione stessa degli stati nazionali europei. Il principio <strong>di</strong><br />
unità etnica, linguistica e religiosa della popolazione che ha alimentato tra ‘700 e ‘900 l’idea <strong>di</strong><br />
nazione, sono destinate a conoscere una profonda ri-definizione, se non una crisi irreversibile<br />
(Ambrosini, 2001). Ma è la scuola che per prima e in maniera molto intensa sperimenta la<br />
delicatezza della questione: l’introduzione <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fformità vanno a intaccare quei
presupposti finora considerati incrollabili <strong>di</strong> presunta universalità e uguaglianza <strong>di</strong> questa<br />
istituzione (Ambrosini, 2004).<br />
In breve, non appare inverosimile considerare le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> come un fattore <strong>di</strong><br />
avanguar<strong>di</strong>a per cercare <strong>di</strong> valutare non solo l’esito dell’esperienza dell’immigrazione nelle<br />
nostre società ma anche verso cosa si evolvono le nostre società (De Wind et al, 1997).<br />
Ma come interpretare i fenomeni sociali legati alle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>? Le peculiarità <strong>delle</strong><br />
<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> richiedono una impostazione concettuale <strong>di</strong>versa da quella utilizzata nello<br />
stu<strong>di</strong>o <strong>delle</strong> migrazioni. L’integrazione dei figli degli immigrati segue percorsi e meccanismi<br />
propri tanto da richiedere una prospettiva ad hoc. Non a caso capita piuttosto <strong>di</strong> frequente<br />
sentire dagli stu<strong>di</strong>osi della materia nei paesi <strong>di</strong> più recente immigrazione come l’Italia,<br />
espressioni quali “ri-definire” oppure “re-impostare” le precedenti impostazioni teoriche sulle<br />
immigrazioni: tener conto <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> vuol <strong>di</strong>re estendere l’analisi dei processi <strong>di</strong><br />
integrazione dei nuovi arrivati in una prospettiva intergenerazionale<br />
Mentre in Europa l’interesse per le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> si è andato <strong>di</strong>ffondendo solo <strong>di</strong><br />
recente anche tra i paesi con più lunga esperienza <strong>di</strong> immigrazione, negli USA vi è una lunga<br />
tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sull’argomento. Non a caso proprio da questo paese arrivano i contributi più<br />
importanti e le indagini più approfon<strong>di</strong>te e mirate. La recrudescenza <strong>delle</strong> immigrazioni negli<br />
USA a partire dalla fine degli anni ’60, ha favorito la ripresa e lo sviluppo un filone <strong>di</strong> ricerca<br />
che ha l’ambizione <strong>di</strong> fornire un quadro teorico specifico per le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>. Sebbene<br />
strettamente legato al fenomeno migratorio, lo stu<strong>di</strong>o <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> è andato ben<br />
oltre l’analisi del processo migratorio del nucleo familiare, estendendosi alle relazioni<br />
intergenerazionali, alla segregazione territoriale, all’importanza della comunità etnica. Lo<br />
sviluppo <strong>di</strong> una ricerca altrettanto vivace anche in Europa potrebbe fornire elementi preziosi <strong>di</strong><br />
confronto nonché perfezionare e generalizzare la portata dei risultati ottenuti nella realtà<br />
statunitense 1 .<br />
1.2 Una molteplicità <strong>di</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
Essere figlio <strong>di</strong> immigrati è una con<strong>di</strong>zione che racchiude una molteplicità <strong>di</strong> situazioni e<br />
significati. Come vedremo nei prossimi capitoli, le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> presentano aspetti e<br />
comportamenti peculiari <strong>di</strong>mostrando una variabilità al loro interno tutt’altro che marginale. E’<br />
1 Varie cause giustificano la lunga mancanza <strong>di</strong> interesse per questo argomento in Europa. Sebbene<br />
molti paesi del vecchio continente accolgono immigrati già da molto tempo, solo dagli anni ’60 la<br />
provenienza dei flussi è <strong>di</strong>ventata extra-europea. Ma, soprattutto, solo nel recente passato tali paesi hanno<br />
iniziato a considerarsi come paesi d’immigrazione: la maggior parte <strong>delle</strong> politiche si è basata nel passato<br />
su programmi <strong>di</strong> importazione <strong>di</strong> manodopera che non hanno tenuto conto della possibilità<br />
dell’inse<strong>di</strong>amento definitivo. L’accento posto sul carattere temporaneo dell’immigrazione, ha contribuito<br />
notevolmente alla scarsità <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> sull’integrazione. Si aggiunga che la citta<strong>di</strong>nanza, piuttosto che il<br />
gruppo etnico <strong>di</strong> appartenenza o il luogo <strong>di</strong> nascita, è stato il principale criterio classificatorio in molti<br />
paesi europei e dunque, una volta acquisita tale con<strong>di</strong>zione non è più possibile identificare gli immigrati e<br />
i loro <strong>di</strong>scendenti (Recano e Roig, 2001).<br />
16
questo il motivo che spinge a preferire l’utilizzo de l plurale, riferendosi dunque alle “<strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong>”.<br />
Le <strong>di</strong>fficoltà insite nella definizione <strong>di</strong> un tale gruppo si incontrano anche nelle definizioni<br />
<strong>di</strong> uso comune. Intanto, nell’uso comune e giornalistico, il termine “seconda generazione” ha<br />
spesso assunto accezioni specifiche riflettendo in tal modo un uso funzionale all’etichettamento<br />
<strong>di</strong> qualcosa <strong>di</strong> estraneo o marginale alla società. In Francia , quando si parla <strong>di</strong> <strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong> ci si riferisce per lo più ai figli <strong>di</strong> algerini e <strong>di</strong> maghrebini in generale (Wihtol de<br />
Wenden, 2004) ; negli U.S.A. il termine si è spostato negli anni dai figli <strong>di</strong> europei ai figli <strong>di</strong><br />
asiatici e ispanici. Insomma, sembra che il termine venga ripescato in riferimento alle situazioni<br />
più critiche e connesse ad ondate migratorie in pieno corso e per questo preoccupanti, come se il<br />
“seconda generazione” in<strong>di</strong>chi per forza qualcosa <strong>di</strong> cui doversi allarmare. Neppure un<br />
cambiamento terminologico sembra risolvere un uso non sempre politicamente corretto del<br />
soggetto sociale. L’unico tentativo che si può fare è quello <strong>di</strong> cercare una formalizzazione della<br />
definizione e un uso legato all’obiettività <strong>di</strong> tale definizione.<br />
La definizione <strong>di</strong> seconda generazione molto comune in letteratura è: l’insieme degli<br />
in<strong>di</strong>vidui nati da almeno un genitore immigrato. Tuttavia, questa definizione ci appare troppo<br />
generica poiché è capace <strong>di</strong> contenere una pluralità molto eterogenea <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong> cui bisogna<br />
tener conto. Per poter aggiungere valore esplicativo all’analisi della complessa realtà dei figli<br />
degli immigrati, bisogna scomporre questo gruppo quantomeno nelle sue tre <strong>di</strong>mensioni<br />
principali:<br />
a. uno o entrambi i genitori immigrati.<br />
Nel primo caso si parlerà <strong>di</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> miste. Le teorie sull’assimilazione<br />
tendono a interpretare i matrimoni misti, e più in generale l’eterogamia etnica, come un<br />
in<strong>di</strong>catore dell’apertura del gruppo immigrato e come strumento <strong>di</strong> mobilità sociale.<br />
Tuttavia, nella letteratura scientifica il significato <strong>di</strong> tale eterogamia è ancora<br />
controverso e i matrimoni misti non sempre comportano dei benefici in termini <strong>di</strong><br />
miglioramento dello status sociale (Simon, 2003).<br />
b. il luogo <strong>di</strong> provenienza del nucleo familiare.<br />
La <strong>di</strong>stinzione dei sottogruppi è solitamente univoca: nell’ambito <strong>di</strong> una specifico<br />
territorio, si parlerà <strong>di</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> messicane, italiane, senegalesi, coreane ecc.<br />
in base al paese <strong>di</strong> nascita dei genitori (o del genitore immigrato, nel caso in cui l’altro<br />
sia un autoctono). Come vedremo meglio più avanti, numerosi stu<strong>di</strong> mostrano come tra<br />
i <strong>di</strong>versi gruppi etnici vi siano rilevanti <strong>di</strong>fferenze anche agendo su un medesimo<br />
territorio. Le numerose conferme <strong>delle</strong> specificità etniche non lasciano a<strong>di</strong>to a dubbi.<br />
Tra le altre cose, questa <strong>di</strong>mensione può rivelare <strong>di</strong>verse strategie <strong>di</strong> investimento sul<br />
capitale umano dei figli a seconda del paese <strong>di</strong> <strong>origine</strong>.<br />
17
c. i tempi della migrazione nel ciclo <strong>di</strong> vita.<br />
La velocità e le modalità <strong>di</strong> integrazione sono assai <strong>di</strong>verse per chi nasce nel paese<br />
d’arrivo, per chi vi giunge in tenera età, durante l’adolescenza o da adulto. Non <strong>di</strong> rado<br />
il gruppo dei figli degli immigrati viene inquadrato in una sorta <strong>di</strong> continuum che va da<br />
chi è nato nel luogo <strong>di</strong> destinazione da due genitori stranieri a chi vi giunge in età<br />
adulta. Nascere nella società d’arrivo e ivi percorrere l’intero processo <strong>di</strong><br />
socializzazione, può costituire un indubbio vantaggio. Invece, subire il movimento<br />
migratorio durante l’infanzia, sperimentare una duplice socializzazione, essere soggetti<br />
a forti asimmetrie culturali, interrompere il proprio percorso formativo e introdursi nel<br />
nuovo sistema scolastico, magari senza le competenze linguistiche necessarie,<br />
chiaramente pongono degli svantaggi che non sempre è banale superare e che possono<br />
innescare spirali <strong>di</strong> emarginazione e produrre i presupposti per l’insorgere <strong>di</strong> catene <strong>di</strong><br />
svantaggi futuri (Ceravolo, 2001). Inoltre, nell’ambito <strong>di</strong> migrazioni internazionali, non<br />
nascere nel paese d’arrivo pone maggiori <strong>di</strong>fficoltà nell’acquisizione della citta<strong>di</strong>nanza.<br />
Seguendo la <strong>di</strong>stinzione proposta da Warner e Srole (1945) in un loro famoso stu<strong>di</strong>o sul<br />
sistema <strong>delle</strong> relazioni etniche in una città degli USA, è possibile <strong>di</strong>stinguere all’interno<br />
del gruppo dei figli <strong>di</strong> immigrati, tra seconda generazione (stricto sensu), nate nel luogo<br />
<strong>di</strong> destinazione e generazione 1,5, nata nel luogo d’<strong>origine</strong> e immigrata durante<br />
l’infanzia 2 . Inoltre, la generazione 1,5 può essere ulteriormente scomposta <strong>di</strong>stinguendo<br />
tra coloro i quali sono giunti nella prima infanzia (prima dell’inizio della scuola) o in<br />
seguito, nel qual caso sarebbero stati costretti a interrompere il proprio percorso<br />
formativo 3 .<br />
Basandoci sulle in<strong>di</strong>cazioni appena riportate, nei successivi capitoli verranno volta per volta<br />
fornite le definizioni dettagliate per i <strong>di</strong>versi sottogruppi <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> immigrati, adattate alle<br />
<strong>di</strong>verse basi <strong>di</strong> dati utilizzate.<br />
1.3 Peculiarità e problematiche <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
I figli degli immigrati sono spesso considerati a rischio poiché più facilmente <strong>di</strong> altri possono<br />
incanalarsi in situazioni <strong>di</strong> svantaggio relativo. Certamente una buona riuscita dei figli <strong>di</strong>pende<br />
dal grado <strong>di</strong> integrazione dei genitori e dall’ammontare <strong>di</strong> risorse a loro <strong>di</strong>sposizione. Ma quali<br />
sono le risorse capaci <strong>di</strong> favorire o inibire la loro ascesa sociale? E poi, cosa contrad<strong>di</strong>stingue i<br />
figli dai loro genitori immigrati? Quali possono essere i terreni <strong>di</strong> scontro tra prima e seconda<br />
2<br />
La specificazione della classe <strong>di</strong> età che identifica l’infanzia non è univoca in letteratura e varia, in<br />
base all’autore, tra i 10 e i 15 anni.<br />
3<br />
Per tener conto <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>fferenze, Rumbaut (1997) considera come generazione 1,5 quella che ha<br />
cominciato il processo <strong>di</strong> socializzazione e la scuola primaria nel paese d’<strong>origine</strong> ma che ha completato<br />
l’educazione scolastica nel nuovo paese (ragazzi e ragazze emigrati con i loro genitori tra i 5 e i 13 anni.<br />
Egli aggiunge poi la generazione 1.25, quella che emigra tra i 13 e i 17 anni, e la generazione 1.75, cioè<br />
quella che emigra tra i 0 e i 5 anni <strong>di</strong> età.<br />
18
generazione? Se e come può influire la popolazione autoctona nei percorsi <strong>di</strong> vita <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong>? Seguendo la letteratura inerente l’argomento, cerchiamo <strong>di</strong> fornire <strong>delle</strong><br />
in<strong>di</strong>cazioni in tal senso.<br />
1.3.1 Le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partenza: “capitale umano” e “capitale sociale”<br />
Solitamente, i genitori desiderano il meglio per i loro figli e investono molto nel tentativo <strong>di</strong><br />
realizzare le ambizioni sul loro futuro. Ma questo aspetto è forse ancora più accentuato tra gli<br />
immigrati, che comunemente vedono la realizzazione <strong>delle</strong> loro aspirazioni non tanto nella<br />
propria con<strong>di</strong>zione ma in quella dei loro figli. Anzi, è stato sottolineato come la migrazione sia<br />
da intendere come processo intergenerazionale: il fattore che spesso motiva la migrazione è<br />
proprio il benessere futuro dei figli (Portes e MacLeod, 1996).<br />
Nel perseguire tale ambizione, il background familiare può influire in maniera decisiva sul<br />
successo scolastico e sulle collocazioni socio-professionali dei figli. In altri termini, gioca un<br />
ruolo fondamentale l’ammontare <strong>di</strong> risorse a <strong>di</strong>sposizione, risorse che sono sostanzialmente <strong>di</strong><br />
due tipi:<br />
1. quelle che forniscono l’accesso ai beni economici e alle opportunità <strong>di</strong> lavoro;<br />
2. quelle che rinforzano il loro controllo sui figli.<br />
Relativamente al primo punto, i genitori con più elevato capitale umano 4 riusciranno più<br />
facilmente a promuovere l’inserimento del figlio nella società potendo <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to<br />
maggiore ed essendo capaci <strong>di</strong> fornire maggiori informazioni sulle opportunità e i rischi<br />
dell’ambiente circostante (Portes e Rumbaut, 2001). Tuttavia, per le famiglie <strong>di</strong> immigrati,<br />
comportamenti <strong>di</strong>scriminatori e una legislazione che tende a ostacolare la loro integrazione,<br />
possono ostacolare fortemente l’esplicitarsi dei benefici derivanti da un elevato capitale umano.<br />
Altri aspetti capaci <strong>di</strong> influenzare le risorse economiche a <strong>di</strong>sposizione, possono essere la<br />
<strong>di</strong>mensione familiare (un numero elevato <strong>di</strong> figli può costringere a una <strong>di</strong>visione più<br />
svantaggiosa <strong>delle</strong> risorse economiche a <strong>di</strong>sposizione) (Blake, 1989), e l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> nascita (sui<br />
figli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne più basso l’investimento <strong>di</strong> risorse per la formazione potrebbe essere più elevato).<br />
Passando al secondo punto, bisogna premettere che i genitori immigrati, si trovano ad<br />
affrontare compiti educativi particolarmente gravosi a causa della loro posizione in bilico tra la<br />
volontà <strong>di</strong> conservare il patrimonio culturale tra<strong>di</strong>zionale e il desiderio <strong>di</strong> integrazione e ascesa<br />
4 Il concetto <strong>di</strong> capitale umano nasce da un parallelismo con il capitale monetario: così come il<br />
risparmio nel presente permette <strong>di</strong> godere <strong>di</strong> un maggior capitale monetario nel futuro, allo stesso modo<br />
investire nello stu<strong>di</strong>o da giovani permetterà <strong>di</strong> godere degli effetti benefici nel futuro. Questo approccio,<br />
sviluppato principalmente da Becker (1993), parte dal presupposto che gli in<strong>di</strong>vidui esibiscono <strong>di</strong>versi<br />
stili <strong>di</strong> vita, che a loro volta sono il riflesso <strong>di</strong> scelte condotte in precedenza. Una persona istruita, oltre a<br />
fronteggiare migliori prospettive retributive e occupazionali, conduce una vita più sana, ha una speranza<br />
<strong>di</strong> vita più lunga e possiede una capacità <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento estetico me<strong>di</strong>amente più elevato <strong>di</strong> una persona<br />
meno istruita.<br />
19
sociale nel contesto della società ospitante. Il grado <strong>di</strong> apertura nei confronti del paese <strong>di</strong><br />
immigrazione e le con<strong>di</strong>zioni sociali degli immigrati <strong>di</strong> prima generazione, influenzano in<br />
maniera determinante il processo <strong>di</strong> formazione della identità culturale <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong> (Keidler e Pugliese, 1983). Quando l’integrazione dei genitori è <strong>di</strong>fficile, se hanno<br />
poca autonomia, scarse competenze linguistiche e ridotta capacità <strong>di</strong> movimento nella società<br />
ospitante, il loro sostegno nel processo educativo e nell’inserimento sociale dei figli potrebbe<br />
ridursi. Frequentando la scuola, i figli si trovano in una più avanzata integrazione culturale,<br />
soprattutto sotto il profilo della padronanza della lingua. Questo può portare a un rovesciamento<br />
dei ruoli dove i figli assumono precocemente responsabilità adulte nei confronti dei loro<br />
genitori, <strong>di</strong>ventando la loro guida nella società e supporto per l’utilizzo <strong>di</strong> servizi pubblici,<br />
sanità, scuola ecc. La superiorità nella capacità <strong>di</strong> comprensione e nella facilità <strong>di</strong> circolazione<br />
dei figli rispetto ai loro genitori porta facilmente allo scontro con l’autorità dei genitori basata,<br />
spesso, su co<strong>di</strong>ci comportamentali tra<strong>di</strong>zionali (Ambrosini, 2004).<br />
Allo stesso modo, la <strong>di</strong>sgregazione del nucleo familiare, non permettendo la presenza <strong>di</strong><br />
entrambi i genitori durante la crescita dei figli, può significare minore attenzione e controllo. In<br />
tali situazioni, la voce dei genitori può non essere ascoltata e i desideri <strong>di</strong> ambizione per i figli<br />
possono rimanere insod<strong>di</strong>sfatti. Tuttavia, l’aiuto <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui esterni al nucleo familiare con i<br />
quali si hanno forti legami, come può capitare con gli altri membri della propria comunità<br />
etnica, può essere determinante nel non perdere l’autorità sul figlio e nel perpetuare specifici<br />
valori e norme comportamentali. L’importanza della comunità etnica <strong>di</strong> appartenenza, riconduce<br />
al concetto <strong>di</strong> capitale sociale 5 , la cui importanza si esplica non solo nel fornire un supporto alla<br />
collocazione professionale , ma anche e soprattutto nel rinforzare il controllo sui figli e nel<br />
proteggere contro il <strong>di</strong>vorzio e la <strong>di</strong>sgregazione familiare (Portes e Rumbaut, 2001). Laddove il<br />
capitale umano dei genitori sia insufficiente a garantire adeguati mezzi <strong>di</strong> ascesa sociale, la<br />
solidarietà del proprio gruppo etnico può costituire una barriera contro percorsi <strong>di</strong> mobilità<br />
verso il basso e un aiuto per perseguire elevati livelli d’istruzione.<br />
1.3.2 Nuovi modelli <strong>di</strong> consumo, nuove aspirazioni e la “<strong>di</strong>ssonanza generazionale”<br />
I genitori hanno vissuto il processo migratorio al fine <strong>di</strong> trovare nuove e migliori con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
vita, per sé e per la propria famiglia. Si tratta <strong>di</strong> aspirazioni non strettamente legate a una<br />
concreta ascesa sociale personale quanto piuttosto a un miglioramento della con<strong>di</strong>zione<br />
economica. Tuttavia, rispetto alla posizione che si aveva nel paese d’<strong>origine</strong>, molto spesso la<br />
con<strong>di</strong>zione sociale ne risulta realmente migliorata e non è raro che il migrante venga visto da<br />
coloro i quali sono rimasti in patria come una classe sociale spesso invi<strong>di</strong>abile. Ne segue che gli<br />
5 Il capitale sociale è un concetto che nasce nell’ambito della teoria economica per descrivere<br />
l’impatto che le relazioni sociali dell’ambiente circostante esercitano sulla formazione <strong>delle</strong> nuova<br />
<strong>generazioni</strong>. Seguendo le argomentazioni <strong>di</strong> Coleman (1988), il capitale sociale è costituito dalle relazioni<br />
sociali e dall’insieme <strong>di</strong> regole formali e non che guidano e <strong>di</strong>sciplinano il comportamento dei singoli in<br />
una comunità. Se tale comunità, ad esempio, sostiene e ricompensa l’investimento in istruzione, <strong>di</strong>venta<br />
più probabile il conseguimento <strong>di</strong> titoli più elevati.<br />
20
ancora stretti legami con la società originaria comportano una sorta <strong>di</strong> appagamento della<br />
con<strong>di</strong>zione raggiunta nel paese d’arrivo, anche nel caso in cui questa sia poco ambita dagli<br />
autoctoni. A tal proposito, Ambrosini (2004) richiama il meccanismo <strong>di</strong> integrazione<br />
subalterna: l’immigrato è ammesso nella società principalmente perché <strong>di</strong>sposto ad accettare<br />
lavori poco gra<strong>di</strong>ti ai locali. Sono molti gli esempi in molte parti del mondo dove la nascita e lo<br />
sviluppo <strong>di</strong> particolari <strong>di</strong>rettrici migratorie sono state alimentati da una forte segmentazione del<br />
mercato del lavoro nel paese d’arrivo. L’immigrato è allora bene accetto solo se si presenta in<br />
totale umiltà e se non ha pretese o riven<strong>di</strong>cazioni.<br />
Per le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> i legami con la società d’<strong>origine</strong> sono solitamente meno stretti e<br />
il confronto avviene non tanto con questa quanto con quella d’accoglienza. In generale, quanto<br />
più precoce è il processo <strong>di</strong> socializzazione nel contesto d’arrivo, tanto più i criteri <strong>di</strong> creazione<br />
<strong>delle</strong> aspettative e <strong>delle</strong> aspirazioni saranno forgiati sui modelli della nuova società. Il termine <strong>di</strong><br />
paragone <strong>di</strong>venta la con<strong>di</strong>zione degli autoctoni e sempre meno fa riferimento alla rete parentale<br />
e amicale del luogo <strong>di</strong> <strong>origine</strong>. Se il processo <strong>di</strong> integrazione è <strong>di</strong>fficoltoso, non permettendo<br />
grosse possibilità <strong>di</strong> ascesa sociale per gli immigrati, allora per le <strong>seconde</strong> generazione si avrà<br />
un <strong>di</strong>vario tra aspettative e con<strong>di</strong>zioni oggettive non certo positivo e si troveranno in una<br />
con<strong>di</strong>zione persino svantaggiata rispetto ai propri genitori, quantomeno a livello psicologico<br />
(Harker, 2001; Abouguen<strong>di</strong>a e Noels, 2001). Piore (1979) parla <strong>di</strong> “ribellione della seconda<br />
generazione” per identificare la risposta al mancato adeguamento dei figli a quelli che sono stati<br />
gli standard lavorativi, umili e precari, dei loro genitori. Come effetto <strong>di</strong>retto si assiste alla<br />
svalorizzazione dei genitori agli occhi dei figli, la cosiddetta <strong>di</strong>ssonanza generazionale : le<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>sagiate della famiglia possono <strong>di</strong>ventare motivo <strong>di</strong> vergogna per i giovani figli<br />
quando questi vengono a contatto con i loro pari età autoctoni più agiati (Zhou, 1997). In<br />
generale, una situazione caratterizzata da una forte <strong>di</strong>ssonanza generazionale può condurre a un<br />
rapido allentarsi del controllo da parte dei genitori e da per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> autorevolezza.<br />
1.3.3 Senso <strong>di</strong> appartenenza.<br />
I figli degli immigrati tendono a sentire un senso <strong>di</strong> appartenenza verso il paese dove vivono più<br />
intenso rispetto ai loro genitori, solitamente più legati alla loro zona d’<strong>origine</strong>. Piore (1979) ci<br />
descrive l’evoluzione nel tempo dell’orientamento della prima generazione. Inizialmente, si vive<br />
un rapporto estremamente strumentale con il lavoro svolto, essendo l’esperienza migratoria<br />
intesa come temporanea. Gli scopi sono prettamente utilitaristici, si cerca <strong>di</strong> guadagnare il<br />
massimo nel più breve tempo possibile in previsione del ritorno e l’investimento in relazioni<br />
sociali è minimo e rivolto per lo più verso i colleghi connazionali. Tuttavia, man mano si<br />
sviluppa un nuovo atteggiamento <strong>di</strong> maggior apertura verso la società d’accoglimento che può<br />
spingere fino all’inse<strong>di</strong>amento definitivo e alla formazione <strong>di</strong> un nucleo familia re. Per le<br />
<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> non c’è questa evoluzione, non viene vissuta quella prima fase <strong>di</strong> rapporto<br />
strumentale e non appare la scissione tra identità personale (riferita alla con<strong>di</strong>zione socio-<br />
economica nell’area <strong>di</strong> provenienza) e il lavoro svolto nella società <strong>di</strong> immigrazione.<br />
21
Se per i genitori l’idea del ritorno può essere una costante nella loro vita, per i figli essa<br />
rappresenta una sorta <strong>di</strong> rifugio immaginario, un mito alimentato dalla lontananza ma non una<br />
possibilità concreta: si tratterebbe, per loro, <strong>di</strong> una nuova immigrazione.<br />
Concentrandosi sull’emigrazione italiana all’estero, il legame con la cultura e le società del<br />
paese <strong>di</strong> provenienza è molto forte nella prima generazione e possibile fonte <strong>di</strong> tensione con la<br />
seconda generazione. Per i genitori l’identità culturale è chiara, essi sono italiani all’estero e i<br />
loro modelli culturali sono quelli del paese <strong>di</strong> provenienza dove spesso aspirano a tornare, anche<br />
se solo dopo il pensionamento. Per i loro figli, l’Italia non è che il paese d’<strong>origine</strong>, un posto che<br />
sicuramente conoscono per viaggi frequenti ma che non è per loro un posto dove tornare poiché<br />
hanno vissuto buona parte della loro vita, se non tutta, in un altro luogo. Questa <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong><br />
progetti <strong>di</strong> vita, <strong>di</strong> aspirazioni, <strong>di</strong> miglioramento, sono perennemente messe in <strong>di</strong>scussione da<br />
tale <strong>di</strong>vergenza e possono provocare un forte senso <strong>di</strong> precarietà esistenziale (Keidler, Pugliese,<br />
1983).<br />
1.3.4 L’apertura del paese d’accoglienza<br />
Il processo <strong>di</strong> assimilazione dei figli degli immigrati <strong>di</strong>pende naturalmente anche dal paese<br />
ospitante. Le <strong>generazioni</strong> nate da immigrati saranno tanto più <strong>di</strong>sponibili a riconoscersi<br />
nell’identità locale quanto più si sentiranno accettati dalla società. La maggiore facilità<br />
nell’ottenimento della citta<strong>di</strong>nanza, sia per la prima che per la seconda generazione, il<br />
riconoscimento <strong>delle</strong> credenziali educative acquisite prima <strong>di</strong> partire, la possibilità <strong>di</strong> partecipare<br />
attivamente alla vita politica del paese grazie al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto, possono influire notevolmente<br />
nel far sentire l’immigrato e suo figlio “a casa”, parte <strong>di</strong> una comunità nella quale si<br />
identificano.<br />
L’ostilità della popolazione e politiche <strong>di</strong>scriminatorie e repressive hanno risvolti<br />
pesantissimi sui nuclei familiari immigrati. Per gli adulti <strong>di</strong>venta molto più <strong>di</strong>fficile riuscire a<br />
sfruttare il capitale umano a loro <strong>di</strong>sposizione e a metterlo a <strong>di</strong>sposizione dei figli. Le maggiori<br />
<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> inserimento, l’insuccesso e la precarietà <strong>delle</strong> famiglie non facilitano il ruolo<br />
educativo dei genitori e il loro controllo sui figli. Inoltre, <strong>di</strong>venta più <strong>di</strong>fficile sviluppare e<br />
rinsaldare i legami all’interno <strong>di</strong> comunità solidali che possono costituire un valido supporto per<br />
i genitori. Di conseguenza, le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> percepiranno la realtà come minacciosa, le<br />
loro aspirazioni e i loro risultati scolastici ne soffriranno e saranno più preoccupati ad affermare<br />
e coltivare la propria identità etnica piuttosto che puntare sui propri sforzi per raggiungere la<br />
propria affermazione sociale (Portes e Rumbaut, 2001).<br />
Anche politiche <strong>di</strong> assimilazione forzosa hanno risvolti negativi poiché, tendendo a<br />
delegittimare la cultura e la lingua dei genitori, favoriscono l’insorgere <strong>di</strong> una elevata<br />
<strong>di</strong>ssonanza generazionale.<br />
Numerosi stu<strong>di</strong> hanno stabilito che il fattore chiave per determinare la riuscita<br />
dell’integrazione <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> immigrati non sta nelle <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> cultura che intercorrono fra il<br />
paese d’<strong>origine</strong> e quello <strong>di</strong> destinazione, bensì nelle politiche <strong>di</strong> accoglienza del paese <strong>di</strong><br />
22
destinazione (Kymlicka, 1996). Laddove più forte la tendenza a considerare l’immigrato come<br />
lavoratore ospite presente sul territorio solo in maniera temporanea, potrebbe <strong>di</strong>ffondersi con<br />
maggior facilità la sensazione dell’illegittimità della presenza <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>.<br />
Posizioni <strong>di</strong> maggior apertura come quella francese, dove lo jus soli ha goduto <strong>di</strong> maggior<br />
simpatia, potrebbero, in tal senso, aver significato la possibilità <strong>di</strong> un più facile inserimento<br />
<strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> rispetto a situazioni <strong>di</strong> maggior chiusura verso i nuclei familiari<br />
immigrati come quella tedesca o svizzera, dove invece si è sempre data preferenza allo jus<br />
sanguinis. Vi è tuttavia da considerare che politiche più restrittive <strong>di</strong> ingresso e concessione<br />
della citta<strong>di</strong>nanza, basate su aspetti maggiormente legati alle capacità nel mercato del lavoro,<br />
sono capaci <strong>di</strong> selezionare positivamente gli immigrati, innalzando le performance lavorative e<br />
scolastiche <strong>di</strong> immigrati e dei loro figli (Chiswick, 1999).<br />
Di certo, un ruolo <strong>di</strong> primaria importanza è quello svolto dalla scuola, dal suo grado <strong>di</strong><br />
apertura nei confronti <strong>di</strong> alunni con un retroterra linguistico e culturale <strong>di</strong>verso, dagli<br />
investimenti nel sostegno all’inserimento e all’affermazione dell’educazione interculturale come<br />
valore. Bisogna poter fornire al figlio <strong>di</strong> immigrato e al figlio del nativo reali possibilità <strong>di</strong><br />
competizione, eliminando il gra<strong>di</strong>no sociale <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenza che spesso caratterizza le prime<br />
<strong>generazioni</strong> immigrate. In generale, le istituzioni <strong>di</strong> promozione degli immigrati, quali, oltre alla<br />
scuola, i servizi sociali e i sindacati, hanno un ruolo importante nel favorire l’inserimento e<br />
l’affermazione sociale <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>, così come appare per la realtà <strong>di</strong> New York<br />
(Kasinitz, 2002).<br />
L’immigrazione è stata ed è capace <strong>di</strong> scaturire forti paure ed ansie con il risultato <strong>di</strong><br />
provocare un <strong>di</strong>ffuso astio verso il nuovo arrivato, se non vero e proprio razzismo. Le sensazioni<br />
provate verso la prima generazione possono essere trasferite sui loro figli, specie se possessori<br />
<strong>di</strong> tratti somatici riconoscibili. Tuttavia, la questione più profonda che preoccupa il genitore<br />
autoctono è, probabilmente, il classico timore della società adulta nei confronti dei giovani e<br />
cioè che non accettino <strong>di</strong> introiettare e riprodurre l’or<strong>di</strong>ne sociale esistente (DeWind e Kasinitz,<br />
1997). Se questa sensazione può essere già presente rispetto ai propri figli, può <strong>di</strong>ventare<br />
<strong>di</strong>lagante rispetto ai figli <strong>di</strong> immigrati portatori <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse tra<strong>di</strong>zioni culturali.<br />
1.3.5 Il genere<br />
La <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> genere tra le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> può nascondere <strong>di</strong>verse strategie nel rapporto<br />
genitore-figlio e <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> investimento sul futuro dei figli. In generale, le ragazze<br />
tendono a essere sottoposte a una educazione più protettiva e, <strong>di</strong> conseguenza a maggiori<br />
pressioni da parte dei loro genitori. Anche nelle case meno tra<strong>di</strong>zionali, dove cioè la <strong>di</strong>visione<br />
dei ruoli <strong>di</strong> genere che vede l’uomo lavoratore e la donna impegnata nella cura della casa e dei<br />
figli, è meno rigida, le ragazze adolescenti sono più propense a conformarsi alle aspettative dei<br />
genitori (ve<strong>di</strong> Portes e Rumbaut, 2001).<br />
23
1.4. Problemi terminologici, problemi sostanziali.<br />
La <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> definire un lessico adeguato a descrivere i percorsi <strong>di</strong> inserimento dei figli degli<br />
immigrati nella società d’accoglienza si rivela una questione piuttosto delicata. La pluralità <strong>di</strong><br />
visioni nell’opinione pubblica, nei me<strong>di</strong>a così come nei progetti politici, si riflette<br />
nell’imprecisione del nostro linguaggio. Termini quali integrazione, assimilazione,<br />
acculturazione, pre<strong>di</strong>spongono a interpretazioni <strong>di</strong>fferenti e spesso è facile fare confusione. Se<br />
poi ci si sposta nell’ottica <strong>di</strong> comparazione internazionale, ci si rende conto ancora <strong>di</strong> più <strong>di</strong><br />
quanto sia talvolta <strong>di</strong>fficile il <strong>di</strong>alogo non essendovi un vocabolario minimo con<strong>di</strong>viso. Si pensi,<br />
ad esempio, al termine francese intégration che pare molto più controverso <strong>di</strong> quanto non sia il<br />
più neutrale integrazione italiano o integratión spagnolo. Gli inglesi parlano senza <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong><br />
race relations, una espressione che tradotta alla lettera apparirebbe inaccettabile nella maggior<br />
parte <strong>delle</strong> altre lingue europee (De Marie e Molina S, 2004). Negli Stati Uniti, il termine<br />
assimilation ha riconquistato negli ultimi anni molte simpatie nel mondo della sociologia e<br />
tende a includere il nostro “integrazione”; in Europa, invece, richiama spesso quella visione <strong>di</strong><br />
predominio culturale degli autoctoni rispetto agli immigrati.<br />
Nel <strong>di</strong>battito in corso sulle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> il termine “assimilazione” rappresenta un<br />
perno fondamentale sui cui ruotano nuove e vecchie interpretazioni teoriche. Ma prima <strong>di</strong><br />
parlare <strong>delle</strong> più recenti interpretazioni ed evoluzioni del concetto, ci sembra opportuno<br />
soffermarci sul significato tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> assimilazione nonché su altri termini che ne hanno<br />
rappresentato una alternativa sia formale che sostanziale.<br />
Il termine assimilazione (da intendere come traduzione dall’inglese <strong>di</strong> assimilation) si<br />
<strong>di</strong>ffonde dopo l’uscita del libro scritto nel 1921 da Park e Burgess dal titolo “Introduction to the<br />
Science of Sociology”, destinato a <strong>di</strong>ventare uno de i principali testi nel storia della sociologia<br />
americana. Gli autori la definiscono come «un processo <strong>di</strong> penetrazione e fusione nel quale le<br />
persone e i gruppi acquisiscono le memorie, i sentimenti e le attitu<strong>di</strong>ni <strong>delle</strong> altre persone e<br />
gruppi e, con<strong>di</strong>videndone la storia e le esperienze, <strong>di</strong>ventano un unico gruppo con una comune<br />
vita culturale » (Park e Burgess, 1924). Insita in questa definizione vi è un percorso <strong>di</strong><br />
incorporazione del gruppo <strong>di</strong> minoranza dentro nuova società (Taft e Robbins, 1955), un<br />
progressivo adeguarsi ai modelli culturali, alle norme e ai valori dominanti, attraverso<br />
l’abbandono da parte degli immigrati e <strong>delle</strong> loro famiglie <strong>delle</strong> caratteristiche linguistiche,<br />
sociali e culturali d’<strong>origine</strong>. Il termine assimilazione viene usato con <strong>di</strong>verse sfumature<br />
passando dalla conformità a tutti i livelli sociali del gruppo <strong>di</strong> minoranza a quello <strong>di</strong><br />
maggioranza, al semplice superamento della identità etnica ed è visto in contrapposizione al<br />
conflitto che può manifestarsi dallo scontro tra gruppi non integrati. In ogni caso, è insita una<br />
concezione etnocentrica del processo <strong>di</strong> integrazione (Alberoni e Baglioni, 1965), che è da<br />
attuarsi attraverso un percorso uni<strong>di</strong>rezionale e intransitivo che conduce al modello <strong>di</strong> vita della<br />
borghesia bianca americana, ritenuto come il più desiderabile.<br />
La consapevolezza nell’ambito accademico statunitense della limitatezza <strong>di</strong> una tale visione<br />
nonché della sua presunzione <strong>di</strong> fondo, ha condotto più volte alla necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> nuovi<br />
termini, più elastici, capaci <strong>di</strong> spiegare anche la presenza <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> integrazione pluralistiche.<br />
24
Si parlò allora <strong>di</strong> accomodamento (accomodation) per in<strong>di</strong>care la situazione nella quale il<br />
gruppo degli immigrati conserva ancora la propria separata identità senza necessariamente<br />
ottenere la completa accettazione da parte degli altri membri della comunità (Zubrzycki, 1956).<br />
Oppure, nelle parole <strong>di</strong> Taft e Robbins (1955), «quando le persone si accordano in senso<br />
limitato, quando c’è una temporanea sospensione <strong>di</strong> conflitti e consenso sul procedere<br />
unitamente, ma con piccole adatte relazioni».<br />
La coesistenza tra più gruppi con proprie caratteristiche sociali senza che ognuno <strong>di</strong> essi<br />
perda le proprie caratteristiche e dunque, senza che il gruppo <strong>di</strong> minoranza tende a <strong>di</strong>ventar<br />
simile a quello <strong>di</strong> maggioranza è stata spesso apostrofata con il termine multiculturalismo. Di<br />
fatto, questo concetto si pone in antitesi alla visione classica <strong>di</strong> assimilazione: il mantenimento<br />
dei propri valori d’<strong>origine</strong> non mina, <strong>di</strong> per se stesso, all’equilibrio socio-culturale del nuovo<br />
ambiente ma ne può anzi arricchire le priorità e potenzialità.<br />
Un termine che esplicita una <strong>delle</strong> componenti legate al percorso <strong>di</strong> inserimento è<br />
acculturazione. Negli anni ’40 nelle università americane il termine veniva convenzionalmente<br />
usato per descrivere il processo <strong>di</strong> adozione da parte degli immigrati della cultura locale<br />
(comportamenti, valori, ruoli, simboli, ecc.) contestualmente all’abbandono della propria<br />
identica etnica (Eisenstadt, 1954; Gans, 1997). Nel tempo si è cercato <strong>di</strong> eliminare il significato<br />
unilaterale puntando l’attenzione sullo scambio tra portatori <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi bagagli culturali. Si può<br />
allora tentare <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care per acculturazione quel processo <strong>di</strong> interazione tra due gruppi sociali<br />
appartenenti a culture <strong>di</strong>verse tramite il quale ciascun gruppo recepisce dall’altro alcuni tratti (e<br />
non tutti) dell’altrui cultura. Come conseguenza del processo, i tratti acquisiti molto facilmente<br />
assumono formulazioni del tutto nuove date dal combinarsi <strong>delle</strong> due culture.<br />
Il termine adattamento è importato dalla biologia e tende a identificare la risposta <strong>di</strong> un<br />
organismo vivente all’ambiente circostante. E’ stato utilizzato anche nelle scienze sociali, per<br />
identificare le modalità con le quali un gruppo sociale si inserisce e stabilizza nel suo ambiente<br />
adattandosi e reagendo, come nel caso <strong>delle</strong> migrazioni, alle mutate situazioni culturali. Rispetto<br />
all’integrazione, che coinvolge in modo più specifico l’atteggiamento del singolo, l’adattamento<br />
riguarda più specificatamente i gruppi (Cavallaro R. in Tassello, 1987). Più specificatamente<br />
in<strong>di</strong>viduale è invece il concetto <strong>di</strong> assorbimento con il quale si è in<strong>di</strong>cata l’assunzione da parte<br />
dell’immigrato <strong>di</strong> una attività economica-produttiva e a cui segue l’assimilazione e<br />
l’acculturazione (Duncan e Lieberson, 1959). Eisenstadt (1954), si riferisce con questo termine<br />
all’estensione della partecipazione dell’in<strong>di</strong>viduo al <strong>di</strong> fuori dei gruppi primari.<br />
L’espressione integrazione (come traduzione dall’inglese integration) è stata avanzata da<br />
W. Bernard durante una conferenza a l’Havana sull’immigrazione negli Stati Uniti (Alberoni e<br />
Baglioni, 1965) intendendo lo scambio e l’apporto reciproco tra immigrato e società <strong>di</strong><br />
accoglimento. Con ciò, viene riconosciuto il <strong>di</strong>ritto degli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> partecipazione nella realtà<br />
sociale come portatori <strong>di</strong> valori e attitu<strong>di</strong>ni non necessariamente convergenti con quelli<br />
dominanti. L’elemento centrale è costituito dal duplice processo <strong>di</strong> apertura: da un lato, da parte<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo e del gruppo che viene dall’esterno a norme, valori e usi del paese d’accoglienza,<br />
dall’altro, da parte della società stanziale nei confronti <strong>delle</strong> specificità culturali dei nuovi<br />
arrivati. In questa accezione, il concetto <strong>di</strong> integrazione si oppone a quello <strong>di</strong> assimilazione che,<br />
25
ponendosi come processo unilaterale, prevede solo la prima apertura. Inoltre, tende a coincidere<br />
con il termine acculturazione. Al fine <strong>di</strong> dotare il concetto <strong>di</strong> maggiore specificità, si può far<br />
riferimento all’integrazione sociale che si valuta in base alla partecipazione alle strutture della<br />
società (scuola, mondo del lavoro, gruppi nei quali è strutturata la società). Sotto quest’ottica<br />
l’integrazione si oppone alle nozioni <strong>di</strong> marginalizzazione e segregazione.<br />
Nell’uso comune, il termine integrazione ha assunto nel tempo il connotato <strong>di</strong> nozione-<br />
contenitore tendendo a in<strong>di</strong>care genericamente i rapporti tra l’immigrato e la società che lo<br />
accoglie o, in maniera un po’ più precisa, la progressiva adozione <strong>di</strong> modelli <strong>di</strong> comportamento<br />
atti a ridurre le tensioni sociali e l’eterogeneità tra i modelli della società d’<strong>origine</strong> e <strong>di</strong> quella<br />
del nuovo ambiente. Ne è seguito uno sviluppo del concetto <strong>di</strong> integrazione particolarmente<br />
elastico e sfaccettato il cui significato si pone in un continuum che va dall’assimilazione al<br />
multiculturalismo (Macura e Coleman, 1994). La varietà <strong>di</strong> <strong>di</strong>scorsi e <strong>di</strong> situazioni in cui viene<br />
evocato il concetto <strong>di</strong> integrazione è tale che l’ambiguità e il malinteso sono sempre in agguato.<br />
Essendo noi interessati a valutare la riuscita scolastica dei figli <strong>di</strong> immigrati, la nostra<br />
attenzione si posa sull’integrazione sociale così come definita poc’anzi. Pertanto, nel prosieguo<br />
del lavoro il termine integrazione, se non specificato <strong>di</strong>versamente, farà riferimento a questa<br />
accezione.<br />
1.5 Il recente <strong>di</strong>battito negli USA sulle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
1.5.1 “Vecchie” e “nuove” <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
La lunga esperienza statunitense ci insegna che le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> rappresentano un punto<br />
<strong>di</strong> svolta del processo <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento migratorio. I loro <strong>di</strong>versi percorsi <strong>di</strong> inserimento e<br />
adattamento caratterizzano nel lungo periodo le comunità etniche sviluppatesi dai flussi<br />
migratori, con conseguenze per l’intera società. Negli USA, paese <strong>di</strong> lunga immigrazione, la<br />
questione <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> viene affrontata già da tempo. Si pensi, ad esempio, al<br />
contributo <strong>di</strong> Child (1943) che, in un’analisi socio-psicologica dei figli degli italiani descrisse<br />
tre <strong>di</strong>fferenti reazioni <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> fronte alla tensione provocata dall’essere a<br />
cavallo tra due culture, atti a identificare una generazione “ribelle”, “<strong>di</strong> gruppo” e “apatica”. Il<br />
primo caso è caratterizzato dal rigetto dell’identità italiana e dal desiderio <strong>di</strong> farsi accettare dal<br />
gruppo <strong>di</strong> maggioranza. E’ la situazione propria <strong>di</strong> quelli che cambiarono il loro cognome (ad<br />
esempio da Falegname a Carpenter), che si sposavano e andavano ad abitare fuori dalle Little<br />
Italy e che smettevano ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong> mangiare spaghetti. Il secondo caso è quello <strong>di</strong> coloro che<br />
abbracciavano l’ere<strong>di</strong>tà italiana, stu<strong>di</strong>avano la lingua e glorificavano il fascismo. Infine, la<br />
reazione apatica consiste nell’evitare il conflitto tra le due scelte e nel trovare un compromesso.<br />
Ancora prima Thomas e Znaniecki in uno stu<strong>di</strong>o sull’immigrazione polacca in America nel<br />
secondo decennio del XX secolo, riscontrarono una maggiore propensione verso comportamenti<br />
devianti da parte dei figli <strong>di</strong> immigrati rispetto ai genitori (Thomas e Znaniecki, 1968).<br />
26
Ma le problematiche relative ai figli degli immigrati rimangono ancor oggi <strong>di</strong> grande rilevanza<br />
nel paese nord-americano. Infatti, terminati i flussi dall’Europa, che tanto hanno caratterizzato<br />
la realtà statunitense tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, dopo la riforma<br />
legislativa del 1965, sono arrivate nuove ondate migratorie con provenienza asiatica e latino-<br />
americana. Solo nel decennio 1990-2000 questo paese ha infatti accolto più <strong>di</strong> 11 milioni <strong>di</strong><br />
immigrati. Tra i giovani al <strong>di</strong> sotto dei 18 anni, uno su cinque è un immigrato o un figlio <strong>di</strong><br />
immigrati e questa proporzione continua a crescere (Jensen, 2001). Il cambiamento nelle<br />
caratteristiche dei flussi in entrata e dei paesi <strong>di</strong> provenienza pone la necessità <strong>di</strong> rielaborare ed<br />
estendere le tra<strong>di</strong>zionali interpretazioni assimilazionistiche. L’intento è quello <strong>di</strong> comprendere le<br />
modalità <strong>di</strong> inserimento <strong>delle</strong> “nuove” <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> e costruire un confronto con le<br />
“vecchie”, cercando <strong>di</strong> evidenziare i punti in comune e le <strong>di</strong>fferenze.<br />
Diversi stu<strong>di</strong> sostengono la presenza <strong>di</strong> nuove e accresciute problematiche per i figli degli<br />
immigrati più recenti. In misura maggiore rispetto all’inizio del XX secolo, essi si trovano oggi<br />
a fronteggiare un ambiente pluralistico e frammentato, che produce, al tempo stesso, una ricca<br />
gamma <strong>di</strong> opportunità ma anche gravi rischi a un positivo processo <strong>di</strong> adattamento (Fernandez-<br />
Kelly, 1995). I rischi legati al mancato inserimento, portano Gans (1992) a parlare <strong>di</strong> “declino<br />
della seconda generazione”: i figli degli immigrati non sono <strong>di</strong>sposti ad accettare i lavori<br />
sottopagati e sotto-qualificati che sono spettati ai loro genitori con il rischio <strong>di</strong> essere esclusi dai<br />
flussi economici principali. Essi non hanno gli stessi vincoli dei genitori, primo tra tutti il<br />
rischio dell’espatrio, e neppure gli stessi stimoli, come il desiderio <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>re le rimesse in patria<br />
e <strong>di</strong>mostrare a se stessi e agli altri che il percorso migratorio affrontato è stato utile e<br />
remunerativo. Dalla loro prospettiva, i lavori da immigrati sono degradanti mentre attività<br />
illegali ed espe<strong>di</strong>enti possono essere più remunerativi e fornire una migliore immagine sociale.<br />
Portes e Rumbaut (2001) in<strong>di</strong>viduano alcuni ostacoli che tenderebbero a rendere l’inserimento<br />
<strong>delle</strong> recenti <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> recenti più <strong>di</strong>fficile rispetto a quelle passate:<br />
a) Mercato del lavoro<br />
Nei primi decenni del XX secolo, gli USA generarono una enorme domanda <strong>di</strong> lavoro<br />
per l’industria. L’imme<strong>di</strong>ata <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> posti <strong>di</strong> lavoro in questo settore e<br />
l’esistenza <strong>di</strong> una gerarchia occupazionale all’interno del sistema, posero le basi per una<br />
graduale mobilità verso l’alto della seconda generazione <strong>di</strong> <strong>origine</strong> europea, senza<br />
bisogno <strong>di</strong> una formazione scolastica avanzata. A partire dagli anni sessanta, la struttura<br />
del mercato del lavoro americano cominciò a cambiare <strong>di</strong>ventando sempre più “a<br />
clessidra”. A fronte <strong>di</strong> un netto calo dell’occupazione nell’industria, si è assistito negli<br />
USA a una biforcazione del mercato del lavoro nel settore dei servizi con la presenza da<br />
un lato <strong>di</strong> occupazioni dequalificate e sottopagate (la base della clessidra) e dall’altro <strong>di</strong><br />
lavori ad alta professionalità (la parte superiore), con un <strong>di</strong>radamento <strong>delle</strong> posizioni<br />
tecniche interme<strong>di</strong>e (il collo della clessidra), cioè proprio quelle che tra<strong>di</strong>zionalmente<br />
consentivano agli immigrati, e specialmente ai loro figli, <strong>di</strong> inserirsi nella classe me<strong>di</strong>a e<br />
<strong>di</strong> puntare verso i livelli superiori <strong>delle</strong> gerarchie professionali. In una situazione del<br />
genere, i figli degli immigrati devono superare nel giro <strong>di</strong> una sola generazione quel gap<br />
27
<strong>di</strong> formazione scolastica che i loro predecessori, <strong>di</strong>scendenti degli immigrati europei,<br />
hanno superato nel corso <strong>di</strong> più <strong>generazioni</strong>.<br />
b) Differenza razziale<br />
I nuovi immigrati portano aspetti somatici facilmente <strong>di</strong>stinguibili e quin<strong>di</strong> più<br />
facilmente etichettabili. Il perdurare <strong>di</strong> forme più o meno intense <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione<br />
comporta tutta una serie <strong>di</strong> svantaggi in termini <strong>di</strong> opportunità <strong>di</strong> affermazione sociale.<br />
Per le migrazioni più antiche, questo aspetto era marginale poiché i migranti <strong>di</strong> allora<br />
erano bianchi e potevano confondersi più agevolmente con la maggioranza<br />
anglosassone. In più, essendo le nuove coppie immigrate per lo più omogame (alta<br />
incidenza <strong>di</strong> partner appartenenti allo stesso gruppo etnico), la caratterizzazione razziale<br />
si trasmette anche ai rispettivi figli.<br />
c) Controculture<br />
L’emergere <strong>di</strong> stili <strong>di</strong> vita devianti nelle inner cities americane è in parte legato alla<br />
trasformazione del mercato del lavoro presentate nel punto precedente. A causa della<br />
loro povertà, si assiste a una forte concentrazione <strong>di</strong> famiglie immigrate in specifiche<br />
aree <strong>delle</strong> città. Secondo l’US Bureau of Census (2003), quasi il 40% <strong>di</strong> tali famiglie si<br />
stabilisce nelle zone centrali <strong>delle</strong> città, che costituiscono le aree più povere e degradate.<br />
Una tale situazione rende i figli degli immigrati più esposti a valori e norme che<br />
spingono verso una cultura dell’opposizione, come risposta alla percepita<br />
<strong>di</strong>scriminazione e alle scarse possibilità <strong>di</strong> successo attraverso i tra<strong>di</strong>zionali canali <strong>di</strong><br />
mobilità sociale.<br />
Perlmann e Wal<strong>di</strong>nger (1997) contestano questa visione affermando che le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong><br />
integrazione <strong>delle</strong> ultime ondate <strong>di</strong> immigrazione non sono superiori a quelle <strong>delle</strong> ondate<br />
precedenti. Essi considerano la visione a clessidra del mercato del lavoro statunitense troppo<br />
stilizzata poiché, se è innegabile la terziarizzazione dell’economia, è anche vero che la<br />
<strong>di</strong>stribuzione <strong>delle</strong> minoranze immigrate nel mercato del lavoro non coincide con quella<br />
dell’intera popolazione, essendo, tali minoranze (soprattutto quella <strong>di</strong> <strong>origine</strong> asiatica), ancora<br />
ampiamente impiegate nell’occupazione industriale e in particolare nelle piccole imprese ad alta<br />
intensità <strong>di</strong> lavoro presenti nel cuore <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> città. Per quanto attiene a problemi razziali,<br />
Perlmann e Wal<strong>di</strong>nger (1997) sottolineano in maniera ampia e documentata come gli immigrati<br />
europei dei primi del Novecento, e soprattutto <strong>di</strong> italiani, polacchi e ebrei, erano considerati<br />
come appartenenti a razze <strong>di</strong>verse: per i <strong>di</strong>scendenti degli immigrati europei la razza bianca è<br />
stata una conquista e non un carattere ascritto. Gli italiani venivano considerati alla stregua della<br />
gente <strong>di</strong> colore, furono spesso vittime <strong>di</strong> linciaggi e non mancarono neppure pubblicazioni con<br />
presunzione <strong>di</strong> scientificità atti a confermare la <strong>di</strong>fferenza razziale (e l’inferiorità) degli ebrei o<br />
dei popoli me<strong>di</strong>terranei (Stella, 2002). Inoltre, i problemi legati alle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> o<strong>di</strong>erne<br />
negli USA sono inerenti per lo più alla componente <strong>di</strong> <strong>origine</strong> messicana che rappresenta la<br />
componente più numerosa e meno qualificata. Per gli altri figli <strong>di</strong> immigrati, la composizione<br />
28
socio-economica è molto più vicina a quella della classe me<strong>di</strong>a americana <strong>di</strong> quanto non fosse<br />
nei primi anni del Novecento (Wal<strong>di</strong>nger e Perlmann, 1997).<br />
Gli stessi autori, in un altro contributo (Wal<strong>di</strong>nger e Perlmann, 1998) , rievocano le <strong>di</strong>fficoltà<br />
<strong>delle</strong> “vecchie” <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> nell’accesso all’istruzione nonché i problemi legati alla<br />
concorrenza da parte <strong>di</strong> altri immigrati e dei loro figli, nell’accedere al lavoro a bassa<br />
qualificazione. I progressi successivi sono stati in buona parte ottenuti grazie ai loro sforzi<br />
collettivi, alla sindacalizzazione e al sostegno del New Deal. La presunta maggiore facilità della<br />
loro integrazione <strong>di</strong>penderebbe allora dal focalizzare l’attenzione sul risultato e non sul percorso<br />
che è stato necessario compiere.<br />
1.5.2 L’assimilazione”progressiva”<br />
Un importante filone del <strong>di</strong>battito sulle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> tende a rilanciare il tra<strong>di</strong>zionale<br />
concetto <strong>di</strong> assimilazione, pur depurandolo dai presupposti <strong>di</strong> superiorità della cultura americana<br />
rispetto a quella degli immigrati. Per Brubaker (2001) l’assimilazione non è più da intendere<br />
come un obbligo da porre a chi arriva, frutto <strong>di</strong> una pretesa da parte della società ricevente, ma<br />
va intesa come il “<strong>di</strong>venire simili” e l’essere trattati come tali. Non si tratta <strong>di</strong> somigliare alla<br />
società <strong>di</strong> arrivo, ma l’accezione del termine si evolve a comprendere un processo <strong>di</strong>namico che<br />
coinvolge tutti e capace <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare l’intera società. L’assimilazione è per l’autore un<br />
processo sociale che avviene in maniera non intenzionale, a livello aggregato più che<br />
in<strong>di</strong>viduale, da perseguire a livello socio-economico. Inoltre, il concetto <strong>di</strong> assimilazione non è<br />
da contrapporre a quello <strong>di</strong> “non <strong>di</strong>fferenza” ma alla segregazione, alla ghettizzazione e<br />
all’emarginazione (Brubaker, 2001).<br />
Anche Alba e Nee (1997) insistono sulla visione classica dell’assimilazione, considerando<br />
questo concetto ancora utile nello stu<strong>di</strong>o <strong>delle</strong> migrazioni, a patto che non lo si consideri come<br />
un programma normativo imposto dall’alto, teso a sra<strong>di</strong>care le minoranze culturali, ma come un<br />
processo sociale spontaneo e non intenziona le che agisce nel corso <strong>delle</strong> interazioni tra<br />
minoranza e maggioranza. In tal senso, l’assimilazione non è più un processo unilaterale che<br />
vede mo<strong>di</strong>ficare solo la parte minoritaria, ma un percorso <strong>di</strong> cambiamento comune. Osservando<br />
la realtà americana, i due autori notano come le influenze degli immigrati sulla cultura<br />
americana dominante avvengono continuamente coinvolgendo l’intero vissuto, non solo quei<br />
domini dove l’ibridazione è più visibile come la musica e il cibo (Alba e Nee, 1997). Tuttavia,<br />
quantunque si ridefinisca il punto d’arrivo del processo, modellato attivamente anche dai nuovi<br />
arrivati e non teso rigidamente verso un “way-of-life” <strong>di</strong> tipo anglosassone, resta insita in questa<br />
visione uno degli aspetti fondamentali dell’ipotesi classica assimilazionistica, ossia l’aspetto <strong>di</strong><br />
progressività: i <strong>di</strong>scendenti degli immigrati e gli autoctoni <strong>di</strong>ventano man mano più simili con il<br />
passare del tempo e <strong>delle</strong> <strong>generazioni</strong> e, dopo un certo punto, le due popolazioni <strong>di</strong>venteranno<br />
in<strong>di</strong>stinguibili (ipotesi <strong>di</strong> assimilazione progressiva). Questa ipotesi è detta “ottimista” poiché<br />
considera l’assimilazione come inevitabile, basta solo aver pazienza. Essa trae ispirazione<br />
dall’osservazione <strong>delle</strong> esperienze migratorie vissute tra fine Ottocento e i primi decenni del<br />
29
Novecento, quando le prime ondate <strong>di</strong> europei, benché non senza problemi e in maniera<br />
indolore, vissero un processo <strong>di</strong> assimilazione nel giro <strong>di</strong> una o al più <strong>di</strong> due <strong>generazioni</strong>. Anche<br />
se con qualche eccezione, i figli e i nipoti <strong>delle</strong> prime ondate migratorie hanno sperimentato in<br />
gran parte una mobilità socio-economica <strong>di</strong> tipo ascendente, l’integrazione residenziale e un alto<br />
ricorso al matrimonio misto nel corso del XX secolo (Alba 1990; Lieberson 1980). Nello stesso<br />
modo, i nuovi immigrati e i loro figli avanzeranno nella scala sociale e, eventualmente, saranno<br />
assorbiti nelle istituzioni politiche e sociali della società americana (Alba e Nee, 1999).<br />
Ma non tutti sono così fiduciosi. Nel loro stu<strong>di</strong>o sui risultati scolastici <strong>di</strong> 25 gruppi etnici<br />
negli USA, Hirschman e Falcon (1985) hanno riscontrato che i figli degli immigrati più istruiti<br />
conseguono sistematicamente risultati scolastici migliori rispetto alla quarta o quinta<br />
generazione <strong>di</strong>scendente da immigrati poveri e poco istruiti, in<strong>di</strong>pendentemente dal gruppo<br />
etnico. Perlmann (1998) mostra che, anche a parità <strong>di</strong> categoria sociale <strong>di</strong> appartenenza, i<br />
successi scolastici ed economici restano fortemente con<strong>di</strong>zionati dalle <strong>di</strong>fferenze etniche anche<br />
nella seconda generazione e oltre. Portes e Borocz (1989) parlano <strong>di</strong> gerarchie basate sull’etnia<br />
che limitano alle minoranze etniche e agli immigrati l’accesso all’istruzione, all’abitazione e al<br />
lavoro, comportando una persistente <strong>di</strong>sparità etnica nei livelli <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to, <strong>di</strong> livello d’istruzione<br />
e carriere lavorative.<br />
Insomma, il persistere <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze etniche con il passare <strong>delle</strong> <strong>generazioni</strong> rappresenta<br />
indubbiamente una prima anomalia nello schema assimilazionista e l’ottimismo verso le nuove<br />
<strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> <strong>origine</strong> messicana non sembra più così scontato.<br />
Che l’inserimento negli USA degli immigrati e dei loro <strong>di</strong>scendenti non sia sempre stato un<br />
processo <strong>di</strong> accumulazione lineare è una idea tutt’altro che nuova. Warner e Srole (1945)<br />
sostenevano che, sebbene le <strong>di</strong>fferenze culturali e <strong>di</strong> lingua sarebbero sparite nel corso <strong>di</strong><br />
qualche generazione, le minoranze etniche facilmente identificabili come i neri avrebbero avuto<br />
percorsi <strong>di</strong> mobilità sociale fortemente limitati. All’opposto, Thomas e Znaniecki (1920) fecero<br />
notare che gli immigrati polacchi, nonostante avessero mantenuto legami comunitari forti e una<br />
identità culturale <strong>di</strong>stinta, presentavano un livello <strong>di</strong> integrazione molto elevato. Questi ultimi<br />
due contributi ci in<strong>di</strong>rizzano verso una seconda anomalia nell’approccio assimilazionista:<br />
l’avvicinamento culturale tra gruppo <strong>di</strong> minoranza e maggioranza e piena integrazione (intesa<br />
nel senso socio-economico) non sempre corrono parallelamente. Gordon (1964), ancorché<br />
consideri l’assimilazione come un percorso in<strong>di</strong>viduale e non <strong>di</strong> gruppo, mise in risalto<br />
chiaramente questo punto. Nel sottolineare il carattere estremamente generico dell’approccio<br />
assimilazionista tra<strong>di</strong>zionale, egli identificava <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>mensioni del percorso <strong>di</strong> inserimento<br />
cercando <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare anche le loro possibili relazioni. La <strong>di</strong>stinzione fondamentale nel suo<br />
contributo è quella tra acculturazione, che egli considera come un processo unilaterale, e<br />
assimilazione “strutturale”, cioè l’ingresso <strong>di</strong> un membro <strong>di</strong> una minoranza etnica nel gruppo <strong>di</strong><br />
maggioranza tramite lo stabilirsi <strong>di</strong> relazioni da gruppo primario. L’acculturazione <strong>di</strong> solito<br />
avvia l’inserimento dell’in<strong>di</strong>viduo ma può anche durare indefinitamente, qualora non facciano<br />
seguito altre forme <strong>di</strong> assimilazione, tra cui quella strutturale (Gordon, 1964).<br />
Il processo che partendo dall’allentamento o dalla per<strong>di</strong>ta della identità etnica conduce<br />
all’”americanizzazione”, sia che con questo termine si intenda un processo unilaterale <strong>di</strong><br />
30
convergenza verso la classe me<strong>di</strong>a bianca anglo-sassone, sia l’affluire in un “unified non-ethnic<br />
core of American society” formata come me<strong>di</strong>a ponderata <strong>delle</strong> influenze culturali presenti sul<br />
territorio (Zhou, 1997), non è né il passo decisivo verso la piena integrazione né garanzia <strong>di</strong><br />
ascesa sociale. Anzi, la conservazione <strong>di</strong> tratti culturali minoritari può ad<strong>di</strong>rittura costituire una<br />
valore aggiunto. In tempi recenti, soprattutto tra le famiglie <strong>di</strong> <strong>origine</strong> asiatica, il successo<br />
scolastico <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> negli USA è spesso associato con la conservazione <strong>di</strong><br />
co<strong>di</strong>ci culturali etnicamente <strong>di</strong>stinti anziché con l’assorbimento nella cultura americana (Portes<br />
et al, 2004). Non si può negare la possibilità che gli alunni <strong>di</strong> famiglie immigrate siano più<br />
motivati a stu<strong>di</strong>are <strong>di</strong> quanto non lo siano molti scolari autoctoni poiché si attendono <strong>di</strong> più dalla<br />
scuola e che tali motivazioni tendano a scemare con l’avanzare dell’integrazione culturale,<br />
quando cioè l’influenza dei coetanei è più forte. Dice Steinberg (1997): «Gli studenti più<br />
americanizzati, quelli le cui famiglie hanno vissuto in America per un tempo più lungo, sono<br />
meno impegnati a far bene a scuola si quanto non lo siano i loro colleghi immigrati. Diventare<br />
americanizzati è negativo per i risultati scolastici dei giovani, ed è terribile per la loro salute<br />
mentale complessiva». Sulla stessa linea, Rumbaut (1997) fornisce numerosi esempi che<br />
mostrano la correlazione negativa tra il grado <strong>di</strong> acculturazione alla società americana e<br />
situazioni <strong>di</strong> svantaggio (malattie infantili e giovanili, consumo <strong>di</strong> alcool, tabacco e droghe,<br />
delinquenza, <strong>di</strong>vorzialità). Secondo l’autore, è il legame con la comunità etnica <strong>di</strong> appartenenza<br />
a rappresentare una <strong>di</strong>fesa contro questi comportamenti e non certo la lunghezza della<br />
permanenza negli Stati Uniti.<br />
In definitiva, l’evidenza empirica conferma la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> riferirsi a un comune percorso <strong>di</strong><br />
integrazione per le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>. Sebbene l’assimilazione può ancora rappresentare un<br />
concetto chiave, vi sono troppe varianti e imprevisti nei percorsi <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento degli<br />
immigrati per poter sostenere l’idea unica <strong>di</strong> un sentiero rettilineo e uniforme (Portes et al.,<br />
2004).<br />
1.5.3 L’assimilazione “segmentata”<br />
Alla luce della esperienza migratoria più recente, il riesame <strong>delle</strong> impostazioni teoriche esistenti<br />
ha condotto a una nuova proposta teorica che, anziché tematizzare un generico concetto <strong>di</strong><br />
assimilazione, si basa sulla molteplicità <strong>di</strong> traiettorie possibili. Si è così giunti alla formulazione<br />
dell’ipotesi <strong>di</strong> assimilazione segmentata (Portes and Zhou, 1993), un approccio teorico che tiene<br />
conto del come e del perché <strong>di</strong>versi sottogruppi <strong>di</strong> immigrati (e <strong>di</strong> loro figli) possono seguire<br />
percorsi <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong> inserimento nella società americana. La questione centrale non è più se le<br />
<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> si assimileranno o meno negli Stati Uniti, ma piuttosto a quale segmento<br />
della società americana finiranno per assimilarsi. E’ possibile <strong>di</strong>stinguere tra:<br />
1) Piena acculturazione e occupazione professionistica<br />
Per le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> figlie <strong>di</strong> genitori con un elevato capitale umano (situazione<br />
<strong>di</strong>ffusa nella classe me<strong>di</strong>a) è facile prevedere una transizione “morbida” nel circuito <strong>di</strong><br />
31
opportunità sociali a <strong>di</strong>sposizione degli autoctoni. Essi hanno garantite le risorse per una<br />
buona istruzione e talvolta anche opportunità impren<strong>di</strong>toriali. Acculturazione e<br />
avanzamento socio-economico procedono <strong>di</strong> pari passo. L’etnicità per le <strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong> è una questione <strong>di</strong> scelta personale e non influisce sulle reali opportunità <strong>di</strong> vita.<br />
Come per i <strong>di</strong>scendenti degli europei dei precedenti flussi migratori, essi si identificheranno<br />
con le loro ra<strong>di</strong>ci in occasioni specifiche e quando lo riterranno conveniente.<br />
2) Acculturazione “<strong>di</strong>ssonante” e bassi livelli <strong>di</strong> istruzione.<br />
Quando le risorse dei genitori immigrati sono limitate, come nel caso della classe operaia,<br />
essi non saranno in grado <strong>di</strong> investire nell’educazione dei figli in modo da fornire loro<br />
possibilità <strong>di</strong> mobilità sociale ascendente. In questa circostanza, la seconda generazione può<br />
essere esposta alla cultura adolescenziale deviante dei ghetti urbani che tende a deprimere la<br />
fiducia nella scuola e nella mobilità sociale. L’etnicità <strong>di</strong>venta un fattore <strong>di</strong> etichettamento<br />
volto a innescare meccanismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione. Il rischio <strong>di</strong> confluire negli strati<br />
svantaggiati della popolazione è molto alto con poche possibilità <strong>di</strong> fuoriuscire da una<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> esclusione sociale. Questa situazione è propria <strong>di</strong> vasta parte della comunità<br />
ispanica negli USA dei giorni nostri.<br />
3) Acculturazione “selettiva”, buone possibilità <strong>di</strong> successo scolastico e mobilità sociale<br />
ascendente.<br />
In presenza <strong>di</strong> scarso capitale umano e limitata ricchezza familiare, le reti relazionali<br />
all’interno della propria comunità etnica possono costituire una importante risorsa per il<br />
successo scolastico e per l’ascesa sociale ed economica. In una tale situazione l’etnicità,<br />
<strong>di</strong>venta dunque un punto <strong>di</strong> forza. Si tratta <strong>di</strong> un percorso <strong>di</strong> “assimilazione limitata”<br />
(Hirschman, 2001), nel senso che da un lato l’acculturazione nella realtà americana è frenata<br />
dal perpetuarsi dei valori culturali tra<strong>di</strong>zionali, dall’altro è la comunità stessa a favorire<br />
meccanismi <strong>di</strong> affermazione sociale. E’ questo il caso dei giovani <strong>di</strong> <strong>origine</strong> asiatica e dei<br />
figli <strong>di</strong> immigrati provenienti dal Vietnam e da Laos/Cambogia in particolare, che ottengono<br />
risultati scolastici superiori a quelli attesi in base all’ammontare dell capitale umano<br />
posseduto dai genitori (Portes e Rumbaut, 2001).<br />
Se l’ipotesi <strong>di</strong> assimilazione progressiva ipotizza sicuri vantaggi per la seconda generazione<br />
rispetto ai genitori, l’assimilazione segmentata prevede anche la possibilità che una più lunga<br />
permanenza nel paese sia ad<strong>di</strong>rittura svantaggiosa. E’ questo il caso <strong>di</strong> chi, crescendo insieme<br />
alle minoranze più svantaggiate, subisce un processo <strong>di</strong> assimilazione in specifiche subculture<br />
marginali proprie dei ghetti urbani. Questa situazione, definita <strong>di</strong> downward assimilation<br />
(Portes, 1995), tende a introiettare la convinzione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>scriminazione insuperabile da parte<br />
della maggioranza autoctona e l’idea dell’inutilità <strong>di</strong> ogni sforzo <strong>di</strong> miglioramento. Isolamento<br />
sociale e deprivazione alimentano una cultura oppositiva e un ra<strong>di</strong>camento alla propria etnia<br />
come forma <strong>di</strong> reazione a una realtà ostile. Si rifiutano le norme e i valori della società<br />
maggioritaria, l’impegno negli stu<strong>di</strong> viene giu<strong>di</strong>cato insignificante ai fini della mobilità sociale e<br />
32
chi riesce o mostra <strong>di</strong> crederci è considerato come un venduto a un potere oppressivo (Portes e<br />
Zhou, 1993).<br />
Va sottolineata la rilevanza attribuita al ruolo della comunità etnica, e più specificatamente<br />
al capitale sociale da intendersi come la capacità <strong>di</strong> accedere a risorse tramite l’appartenenza a<br />
reti sociali e a strutture sociali ampie . Le risorse così ottenute possono essere <strong>di</strong> ogni tipo,<br />
materiali e non materiali (Coleman, 1988; Portes, 1998). L’etnicità <strong>di</strong>viene la base per forme <strong>di</strong><br />
cooperazione capaci <strong>di</strong> superare gli svantaggi strutturali attraverso ambienti sociali ristretti,<br />
vigilanti, culturalmente integrati che favoriscono la conformità ai valori familiari e, <strong>di</strong><br />
conseguenza, l’impegno scolastico, prevenendo, <strong>di</strong> converso, l’acculturazione negli strati più a<br />
rischio della società americana (Zhou, 1997). In un paese straniero, il controllo dei genitori può<br />
rapidamente allentarsi a causa dell’imposizione <strong>di</strong> nuovi stili <strong>di</strong> vita, nuove aspirazioni, nuovi<br />
consumi e dall’influenza dei coetanei. Per una famiglia isolata, si può verificare lo svuotamento<br />
del potere dei genitori e il coinvolgimento dei figli in stili <strong>di</strong> vita devianti. Quando, invece, la<br />
voce dei genitori è supportata dalla comunità etnica, quando vi è reciproco sostegno tra i <strong>di</strong>versi<br />
nuclei familiari nei compiti educativi, l’autorità dei genitori ne esce rinforzata e la <strong>di</strong>sgregazione<br />
familiare limitata. Per i ragazzi della comunità, le barriere contro la cultura <strong>di</strong> strada e il<br />
consumismo prematuro saranno più solide (Portes et al., 2004). Si noti come il capitale sociale a<br />
<strong>di</strong>sposizione più che dal successo socioeconomico e occupazionale degli immigrati, <strong>di</strong>pende<br />
dalla densità dei legami tra loro esistenti 6 .<br />
E’ chiaro a questo punto come l’ipotesi <strong>di</strong> assimilazione segmentata contesta la tesi che<br />
un’accettazione completa dei valori, <strong>delle</strong> aspirazioni e dei modelli <strong>di</strong> lavoro della maggioranza<br />
della popolazione sia necessariamente la migliore strategia per la mobilità sociale della seconda<br />
generazione. In alcune circostanze, al contrario, è la conservazione dei valori della comunità<br />
immigrata che potenzialmente offre <strong>di</strong> più (Andall, 2002).<br />
Portes e Rumbaut (2001) hanno isolato quattro fattori vengono considerati decisivi nel<br />
processo <strong>di</strong> segmentazione nell’assimilazione:<br />
1) la storia della prima generazione;<br />
2) il ritmo <strong>di</strong> acculturazione fra i genitori e i figli e il suo effetto sull’integrazione<br />
normativa;<br />
3) le barriere culturali ed economiche che i giovani <strong>di</strong> seconda generazione devono<br />
affrontare nella ricerca <strong>di</strong> un inserimento sod<strong>di</strong>sfacente;<br />
4) le risorse che la famiglia e la comunità etnica mettono a <strong>di</strong>sposizione per superare tali<br />
barriere<br />
Un importante risorsa per testare la valenza <strong>delle</strong> teorie appena espresse è costituita dal Progetto<br />
CILS (Children of Immigrant Longitu<strong>di</strong>nal Study) 7 condotta su un campione <strong>di</strong> giovani <strong>di</strong><br />
seconda generazione in Florida e California, intervistati tre volte nell’arco <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci anni dall’età<br />
6 Considerando la possibilità che pur non avendo vissuto una integrazione economica, si sia invece<br />
verificata una assimilazione culturale agli stili <strong>di</strong> vita e ai consumi, Ambrosini (2004) <strong>di</strong>stingue una<br />
quarta traiettoria che chiama “assimilazione anomica o illusoria”. Questa situazione, <strong>di</strong> forte svantaggio<br />
relativo, sarebbe fortemente caratterizzata da una persistenza carenza <strong>di</strong> strumenti atti a sod<strong>di</strong>sfare le<br />
aspettative sorte.<br />
7 Informazioni <strong>di</strong>sponibili sul sito internet http://cmd.princeton.edu<br />
33
dell’adolescenza in poi (Portes et al, 2004). I risultati della ricerca mostrano importanti<br />
<strong>di</strong>fferenze tra i gruppi etnici <strong>di</strong> nuova immigrazione ma, in generale, viene confermata<br />
l’importanza del capitale sociale come fattore <strong>di</strong> estrema importanza e capace <strong>di</strong> sostituirsi alla<br />
mancanza <strong>di</strong> risorse in termini <strong>di</strong> ricchezza e istruzione da parte dei genitori immigrati.<br />
1.6 L’istruzione dei figli degli immigrati: meto<strong>di</strong>, letteratura e ipotesi <strong>di</strong> lavoro.<br />
1.6.1 Meto<strong>di</strong><br />
La problematica dell’assimilazione/integrazione ha molteplici sfaccettature che coinvolgono<br />
<strong>di</strong>verse sfere della vita dell’in<strong>di</strong>viduo e pertanto va valutata in un ottica multi-<strong>di</strong>mensionale.<br />
Nella presente analisi, ci si è concentrati su una <strong>delle</strong> <strong>di</strong>mensioni ritenute più importanti:<br />
l’istruzione. Nello specifico, si è proceduto nella determinazione <strong>delle</strong> probabilità (valutate ex-<br />
post) <strong>di</strong> raggiungere specifici livelli d’istruzione in chiave <strong>di</strong>fferenziale tra i figli degli<br />
immigrati e i figli <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui stabili sul territorio. Per tener conto dell’effetto selezione proprio<br />
del processo migratorio, il confronto tra i gruppi deve avvenire a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni familiari <strong>di</strong><br />
partenza. Questo obiettivo è ottenibile attraverso l’utilizzo <strong>di</strong> meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> analisi statistica<br />
multivariata e, in particolare, dei modelli <strong>di</strong> regressione logistica che bene si prestano alla<br />
valutazione <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> probabilità tra <strong>di</strong>versi sottogruppi.<br />
I risultati dell’analisi multivariata verranno presentati come odds ratio atti a esprimere la<br />
variazione moltiplicativa nella probabilità <strong>di</strong> avere il livello d’istruzione specificato per gli<br />
in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> una specifica categoria rispetto agli in<strong>di</strong>vidui appartenenti alla categoria scelta come<br />
riferimento. Gli odds ratio, chiamati anche rischi relativi, sono ottenuti come l’esponenziale<br />
(anti-logaritmo) <strong>delle</strong> stime dei coefficienti dei regressori. Posta uguale a 1 la probabilità <strong>di</strong><br />
ottenere il titolo specificato per la categoria <strong>di</strong> riferimento, un rischio relativo maggiore<br />
(minore) <strong>di</strong> 1, esprime una misura <strong>di</strong> quanto maggiore (minore) è la probabilità <strong>di</strong> ottenere tale<br />
livello d’istruzione per la modalità specificata rispetto a quella <strong>di</strong> riferimento. Ogni odds ratio<br />
verrà accompagnata dalla rispettiva significatività statistica.<br />
Le ricerche sull’istruzione raggiunta dalle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> hanno avuto una <strong>di</strong>ffusione<br />
relativamente recente se si pensa alla lunga esperienza immigratoria <strong>di</strong> alcuni paesi. Una<br />
persistente limitazione che ha caratterizzato molte analisi, sta nella mancata <strong>di</strong>stinzione tra le<br />
<strong>di</strong>verse <strong>generazioni</strong> (Schaafsma e Sweetman, 1999). Pertanto, particolare attenzione verrà posta<br />
nella definizione dei sottogruppi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in base alla storia migratoria propria e dei rispettivi<br />
genitori, tenendo conto <strong>di</strong> quanto riportato nel paragrafo 2 <strong>di</strong> questo capitolo.<br />
1.6.2 Letteratura e ipotesi<br />
I meccanismi me<strong>di</strong>ante i quali i titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o influiscono sui destini lavorativi degli<br />
in<strong>di</strong>vidui non sono ancora stati compresi pienamente, ma in generale gli stu<strong>di</strong>osi sono d’accordo<br />
34
nel ritenere che in tutte le società avanzate l’istruzione svolge un ruolo fondamentale nel<br />
processo <strong>di</strong> collocazione degli in<strong>di</strong>vidui all’interno dello spazio sociale (tra gli altri Ballarino e<br />
Cobalti, 2003; Checchi, 1998; Ichino et al., 1997; Shavit e Muller, 1998; Shavit e Blossfeld,<br />
1993). Al crescere del titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o raggiunto aumentano regolarmente le probabilità <strong>di</strong><br />
accedere alle classi me<strong>di</strong>e e superiori, mentre <strong>di</strong>minuiscono i rischi <strong>di</strong> occupare le posizioni<br />
sociali più svantaggiate (Pisati, 2002). Appare, dunque, giustificato tener conto del livello<br />
d’istruzione raggiunto quale componente primaria nel definire le opportunità <strong>di</strong> carriera<br />
professionale e <strong>di</strong> accesso alle classi me<strong>di</strong>o-alte. Ma, nonostante la <strong>di</strong>ffusione dei principi<br />
universalistici e meritocratici <strong>di</strong> selezione sociale, le opportunità <strong>di</strong> successo nell’istruzione<br />
continuano a essere fortemente influenzate dalle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partenza, cioè dall’ammontare <strong>di</strong><br />
risorse che i genitori riescono a mettere a <strong>di</strong>sposizione dei figli per facilitare la loro<br />
affermazione sociale. In sostanza, tali risorse possono essere <strong>di</strong> tre tipi (Goldthorpe et al., 1987):<br />
- economiche: corrispondono alla ricchezza in senso stretto e includono, in particolare, il<br />
denaro e la proprietà <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> produzione quali imprese già avviate, stu<strong>di</strong><br />
professionali ecc.<br />
- culturali: l’ammontare <strong>di</strong> risorse umane in termini <strong>di</strong> livello d’istruzione dei genitori<br />
unitamente al livello <strong>di</strong> consumi culturali effettuato;<br />
- sociali: rete <strong>di</strong> relazioni sociali in cui è inserito il nucleo familiare, che consistono nella<br />
capacità <strong>di</strong> attivare determinati canali <strong>di</strong> influenza o <strong>di</strong> accedere a specifiche<br />
informazioni.<br />
La classe sociale <strong>di</strong> appartenenza (approssimabile attraverso la posizione socio-professionale dei<br />
genitori) e il capitale umano dei genitori (approssimabile con il livello d’istruzione) sono fattori<br />
fortemente correlati all’ammontare <strong>di</strong> queste risorse e, pertanto, capaci <strong>di</strong> influenzare<br />
l’investimento in istruzione dei figli.<br />
Oggi come ieri, si assiste a una <strong>di</strong>suguaglianza <strong>delle</strong> opportunità educative tra le <strong>di</strong>verse<br />
fasce <strong>di</strong> popolazione, nonostante la forte espansione de ll’istruzione me<strong>di</strong>a e superiore. Infatti,<br />
avendo la corsa all’istruzione coinvolto in eguale misura tutte le fasce della popolazione, lascia<br />
sostanzialmente inalterate le <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> accesso ai vari gra<strong>di</strong>. La ripartizione dei titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
resta fortemente <strong>di</strong>somogenea tra le <strong>di</strong>verse classi sociali d’<strong>origine</strong> con una presenza <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o più elevati che cresce all’interno <strong>delle</strong> classi più prestig iose, sia in Italia (Ballarino e<br />
Cobalti, 2003) sia negli altri paesi occidentali, tanto da far parlare <strong>di</strong> una “Persistent inequality”<br />
(Shavit e Blossfeld, 1993).<br />
Nell’ambito <strong>di</strong> questo meccanismo sociale, l’esperienza migratoria vissuta dalla famiglia<br />
d’<strong>origine</strong> (che possiamo chiamare storia migratoria familiare) può avere un ruolo importante e<br />
in<strong>di</strong>pendente. Tenendo sotto controllo le risorse <strong>di</strong> partenza, essere figlio <strong>di</strong> immigrati potrebbe<br />
costituire una con<strong>di</strong>zione capace <strong>di</strong> influenzare il raggiungimento <strong>di</strong> livelli d’istruzione elevati.<br />
In tal senso, il processo <strong>di</strong> migrazione comporterebbe una serie <strong>di</strong> effetti a lungo termine che si<br />
riflettono anche sui figli degli attori principali del processo stesso.<br />
35
Se per la prima generazione il successo o fallimento dell’esperienza migratoria si misurano in<br />
gran parte nell’ambito lavorativo, per i loro figli la vera sfida sta nell’istruzione, cioè nel dotarsi<br />
<strong>di</strong> uno dei principali strumenti <strong>di</strong> mobilità sociale. Se i figli <strong>di</strong> immigrati hanno minori<br />
opportunità <strong>di</strong> accesso e <strong>di</strong> riuscita nel sistema scolastico, i loro percorsi <strong>di</strong> mobilità sociale<br />
risulteranno inevitabilmente svantaggiati. Spesso nel passato, durante flussi migratori <strong>di</strong> massa,<br />
gli immigrati avevano bassi livelli d’istruzione e ridotta qualificazione professionale. Essi<br />
accettavano con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro che la popolazione locale rifiutava e le loro possibilità <strong>di</strong><br />
ascesa sociale personale erano limitate. Ma, le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> integrazione e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro<br />
non sempre gratificanti potevano essere sopportate in virtù dell’ambizione <strong>di</strong> fornire ai propri<br />
figli concrete possibilità <strong>di</strong> ascesa sociale. In tal senso, l’istruzione dei figli assumeva un ruolo e<br />
un significato particolarmente importante per gli immigrati. Miller e Volker (1989) nel riportare<br />
la bassa istruzione posseduta dagli immigrati in Australia provenienti dal Sud Europa, avanzano<br />
come spiegazione la maggiore attenzione da parte degli immigrati da questi paesi verso<br />
l’istruzione dei figli piuttosto che verso la propria.<br />
Queste considerazioni ci portano a inquadrare il processo <strong>di</strong> integrazione in una prospettiva<br />
multi-generazionale : in<strong>di</strong>pendentemente dalla posizione socio-economica raggiunta dai genitori<br />
nel paese d’arrivo, il percorso <strong>di</strong> inserimento nella nuova società può essere considerato<br />
completo solo nel momento in cui i loro figli <strong>di</strong>ventano competitivi nel mercato del lavoro, e<br />
abbiamo già visto quanto il livello d’istruzione sia importante in tal senso. Ne segue che le<br />
aspettative sull’istruzione dei figli potrebbero essere più elevate nelle famiglie immigrate<br />
rispetto alla me<strong>di</strong>a della popolazione. Ciò può tradursi da un lato in una maggiore pressione sui<br />
figli e dall’altro in specifici comportamenti atti a superare le <strong>di</strong>fficoltà contingenti per favorire la<br />
mobilità sociale dei propri figli come, ad esempio, svolgere un doppio lavoro per comprare casa<br />
in un quartiere con scuole migliori; spostarsi in città dove più forte è la presenza della propria<br />
comunità etnica al fine <strong>di</strong> incrementare i legami sociali; utilizzare il sostegno dei nonni<br />
nell’educazione dei figli; ecc. (Portes e Rumbaut, 2001). Tuttavia, per realizzare una mobilità<br />
sociale ascendente multi-generazionale è necessario che vi siano le giuste con<strong>di</strong>zioni: «quando<br />
la <strong>di</strong>scriminazione è limitata, le leggi <strong>di</strong> ingresso e il contesto sono favorevoli, la voce dei<br />
genitori può essere ascoltata e il loro desiderio <strong>di</strong> una elevata istruzione per i propri figli essere<br />
sod<strong>di</strong>sfatta» (Portes e Rumbaut, 2001).<br />
Nella letteratura socio-economica, sono numerosi i contributi che mettono in evidenza i<br />
buoni risultati dei figli degli immigrati. Anzi, non è raro che le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> ottengano<br />
risultati ad<strong>di</strong>rittura migliori rispetto ai pari età figli <strong>di</strong> nativi. In Canada, chi ha entrambi i<br />
genitori immigrati, ottiene livelli d’istruzione e status occupazionale migliori rispetto agli<br />
autoctoni, seppur con qualche <strong>di</strong>fferenza in termini <strong>di</strong> provenienza (Boyd e Grieco, 1998).<br />
Questi risultati sono stati confermati in un altro lavoro (Boyd, 2002), dove si sottolinea anche<br />
come il successo <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> non viene eguagliato dalle terze <strong>generazioni</strong>. In<br />
generale, sostiene Boyd, le minoranze visibili hanno ottenuto livelli scolastici migliori <strong>delle</strong><br />
36
minoranze non visibili 8 . Nello stesso paese, Schaafsma e Sweetman (1999) hanno rilevato che<br />
il successo nell’istruzione varia sistematicamente in funzione dell’età <strong>di</strong> arrivo con un<br />
sostanziale vantaggio per chi giunge molto giovane (generazione 1,5) rispetto a chi arriva più<br />
tar<strong>di</strong>. Chiswick e DebBurman (2003), sostengono che gli adulti <strong>di</strong> seconda generazione negli<br />
USA hanno livelli d’istruzione me<strong>di</strong>amente più alti sia rispetto agli autoctoni sia rispetto a chi è<br />
nato all’estero. Perfino la generazione 1,5 ottiene titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o più elevati dei figli dei nativi<br />
ma con un vantaggio decrescente all’aumentare dell’età <strong>di</strong> arrivo fino ad arrivare ad invertire la<br />
relazione quando tale età è superiore ai 12 anni 9 .<br />
Chiswick (2000) propone l’ipotesi che i migliori risultati <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
sarebbero il frutto de ll’influenza positiva data da genitori positivamente selezionati tra gli<br />
in<strong>di</strong>vidui con maggior abilità nel lavoro e motivazioni sopra la me<strong>di</strong>a. Questo approccio parte<br />
dalla proposizione con<strong>di</strong>visa in letteratura che considera la migrazione (e la permanenza nel<br />
territorio <strong>di</strong> destinazione) un processo fortemente selettivo e che vede i migranti economici<br />
favorevolmente selezionati in relazione al successo nel mercato del lavoro. Questi migranti<br />
tenderebbero, in me<strong>di</strong>a, a essere più abili, ambiziosi, aggressivi e intraprendenti rispetto a coloro<br />
i quali sono rimasti (o sono tornati) nel loro posto d’<strong>origine</strong> (Chiswick, 1999). Quanto più le<br />
regole <strong>di</strong> ingresso sono restrittive e basate su caratteristiche socio-professionali, tanto più la<br />
selezione sarà positiva 10 .<br />
Tuttavia, per i figli <strong>di</strong> immigrati non sempre la situazione nel campo dell’istruzione è rosea.<br />
Si prenda ancora una volta il caso degli USA. Nel complesso le performance sono buone ma da<br />
un lato ci sono le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> <strong>origine</strong> asiatica, che superano sistematicamente gli<br />
autoctoni nella scuola, dall’altro si assiste ai risultati preoccupanti dei figli <strong>di</strong> immigrati <strong>di</strong><br />
lingua ispanica, per lo più provenienti dal Messico e Portorico (Farley e Alba, 2002; Hirschman,<br />
2001; McPartland, 1998; Rumbaut, 1997). Questi gruppi evidenziano l’emergere <strong>di</strong> percorsi <strong>di</strong><br />
mobilità verso il basso (downward assimilation) nelle quali una permanenza più lunga nel<br />
territorio si associa ad<strong>di</strong>rittura a peggiori performance scolastiche (Portes e Rumbaut, 2001).<br />
8 Alcune critiche ai due lavori appena citati sono sopraggiunte in ragione della mancanza<br />
dell’informazione relativa al livello d’istruzione dei genitori. I buoni risultati <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> in<br />
Canada figlie <strong>delle</strong> ultime ondate <strong>di</strong> immigrazione, in particolar per quelle provenienti dall’Asia,<br />
potrebbero <strong>di</strong>pendere dalla elevata istruzione dei genitori, frutto <strong>di</strong> flussi in ingresso caratterizzati da una<br />
selezione verso coppie più istruite.<br />
9 Sia Schaafsma e Sweetman (1999) che Chiswick e DebBurman (2003) notano una relazione<br />
negativa tra l’età <strong>di</strong> arrivo e il livello d’istruzione raggiunto, quantunque compiere la migrazione negli<br />
anni associati all’istruzione secondaria superiore rappresenta la situazione più svantaggiosa che non<br />
emerge se l’immigrazione avviene pochi anni prima o dopo.<br />
10 Secondo l’autore, nel complesso l’effetto positivo <strong>di</strong> selezione degli immigrati <strong>di</strong>pende dalla<br />
tipologia <strong>di</strong> domanda <strong>di</strong> immigrati, dalla restrizioni applicate e dai criteri utilizzati per gli ingressi. Tali<br />
criteri possono basarsi su una o più caratteristiche capaci <strong>di</strong> influenzare le possibilità <strong>di</strong> guadagno nel<br />
mercato del lavoro, quali, tra gli altri, il livello d’istruzione, la qualifica professionale, l’età, le capacità<br />
linguistiche. Alternativamente, i criteri possono basarsi su aspetti apparentemente in<strong>di</strong>pendenti dal livello<br />
<strong>di</strong> abilità, come legami <strong>di</strong> parentela, le lotterie, ecc. Sebbene la selezione gioca in entrambi i casi, i primi<br />
criteri selezionano, in me<strong>di</strong>a, un sottogruppo con maggiori possibilità <strong>di</strong> successo nel mercato del lavoro<br />
rispetto a quelli che entrerebbero nel paese d’arrivo attraverso l’applicazione del secondo gruppo <strong>di</strong><br />
criteri. Allo stesso modo, la selezione positiva è meno intensa per gli immigrati non-economici (rifugiati,<br />
immigrati per motivi ideologici).<br />
37
Differenze tra autoctoni e figli <strong>di</strong> immigrati nel sistema educativo possono <strong>di</strong>pendere dalla<br />
presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazioni o preferenze su base etnica. Crescere in una comunità problematica<br />
ed essere soggetto a <strong>di</strong>scriminazioni, può far arrendere anche i più motivati (Portes e Rumbaut,<br />
2001). E’ sempre molto <strong>di</strong>fficile valutare la presenza <strong>di</strong> atteggiamenti <strong>di</strong>scriminatori, soprattutto<br />
con dati <strong>di</strong> indagine, ma certo la persistenza <strong>di</strong> ineguaglianze a parità <strong>di</strong> altre con<strong>di</strong>zioni, non<br />
gioca a favore <strong>di</strong> un rifiuto <strong>di</strong> tale ipotesi. Inoltre, è sempre in agguato il rischio che nel sistema<br />
scolastico <strong>di</strong> un determinato paese emergano <strong>delle</strong> corsie svantaggiate occupati dai figli <strong>di</strong><br />
immigrati nei quali la <strong>di</strong>scriminazione etnica, più <strong>di</strong>ffusa durante i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> elevato afflusso<br />
immigratorio, sia capace <strong>di</strong> influenzare i risultati scolastici in maniera significativa (Coenders e<br />
Scheepers, 1998). Questo è il caso <strong>delle</strong> scuole ad hoc per i figli <strong>di</strong> immigrati, come è successo<br />
in Baviera (Thränhardt, 2004), o <strong>di</strong> situazioni caratterizzate da un stretta associazione tra<br />
segregazione territoriale e scolastica (Rosenbaum e Friedman, 2001; Simon, 2003). Da questo<br />
punto <strong>di</strong> vista, la domanda da porre è se vi siano uguali opportunità e molto spesso, creare o<br />
permettere che si creino scuole <strong>di</strong> serie A e <strong>di</strong> serie B può costituire una barriera insormontabile<br />
per la mobilità sociale.<br />
In generale, in Europa la letteratura recente spesso <strong>di</strong>segna una pessimistica situazione <strong>di</strong><br />
impe<strong>di</strong>mento strutturale per i nuclei familiari <strong>di</strong> immigrati, con la seconda generazione che<br />
tenderebbe a ere<strong>di</strong>tare gli svantaggi sperimentati dai loro genitori (Weels, 2000; Widgren, 1986;<br />
Wilpert, 1988). Ma, anche in situazioni <strong>di</strong> svantaggio relativo, una via <strong>di</strong> salvezza può giungere<br />
dal capitale sociale: ci sono situazioni nelle quali vivere a stretto contatto con la propria<br />
comunità etnica può <strong>di</strong>ventare un punto <strong>di</strong> forza. Cresce il numero <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> che sottolineano<br />
l’importanza del capitale sociale: così come per i numerosi stu<strong>di</strong> negli Stati Uniti, anche in<br />
Germania è stato notato che la <strong>di</strong>mensione del network etnico ha un effetto positivo sul risultato<br />
scolastico <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> (Gang e Zimmerman, 2000).<br />
1.7 Assimilazione linguistica e bilinguismo<br />
L’uso della lingua corrente nel paese <strong>di</strong> accoglienza è un in<strong>di</strong>catore cruciale del livello <strong>di</strong><br />
adattamento al nuovo contesto tanto per i genitori quanto per i loro figli. La situazione<br />
linguistica dei figli degli immigrati può essere espressa lungo un asse che va dalla piena<br />
assimilazione linguistica (uso fluente della sola lingua del paese nel quale si vive), alla totale<br />
mancanza <strong>di</strong> assimilazione (uso fluente della sola lingua dei genitori). Tra queste due posizioni<br />
limite vi sono <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> bilinguismo caratterizzate dall’utilizzo più o meno scorrevole<br />
<strong>delle</strong> due lingue, tra le quali vi è anche la situazione <strong>di</strong> bilinguismo perfetto dato dalla capacità<br />
<strong>di</strong> padroneggiare entrambe le lingue.<br />
Fino a qualche decennio fa, nell’ambiente accademico si riteneva ancora che il bilinguismo<br />
fosse associato negativamente con lo sviluppo cognitivo creando confusione mentale e<br />
danneggiando il benessere psicologico dei figli degli immigrati. Inoltre, la necessità <strong>di</strong> una<br />
subitanea e piena assimilazione linguistica, che non lasciasse spazio al bilinguismo, era<br />
considerata una necessità per le democrazie interessate dai flussi <strong>di</strong> immigrazione poiché il<br />
38
precetto «uno stato, una lingua» era ampiamente dominante. Numerosi stu<strong>di</strong> sulle capacità dei<br />
figli <strong>di</strong> immigrati a partire dai primi anni sessanta misero in <strong>di</strong>scussione queste tesi<br />
evidenziando come eventuali <strong>di</strong>fficoltà dei figli <strong>di</strong> immigrati nel sistema educativo erano legate<br />
a una <strong>di</strong>versa posizione socio-economica del nucleo familiare (Portes e Schauffler, 1996) più<br />
che a problemi linguistici e <strong>di</strong> assimilazione. Ciò che invece è ampiamente con<strong>di</strong>viso è<br />
l’influenza sulle capacità linguistiche dall’età alla quale si compie la migrazione: chi giunge nel<br />
paese <strong>di</strong> destinazione in età più avanzata tenderà ad avere più problemi rispetto a chi vi è giunto<br />
molto giovane a causa <strong>di</strong> una più lunga esposizione al linguaggio e alla cultura del paese natale<br />
(McManus, Gould e Welch, 1983). Meno scontata è invece l’importanza del contesto nel quale<br />
si realizza l’inserimento del giovane figlio <strong>di</strong> immigrato: chi cresce in un ambiente dove la<br />
lingua locale è dominante, vivrà il passaggio a tale lingua in maniera più rapida a <strong>di</strong>scapito<br />
dell’utilizzo della lingua dei genitori; <strong>di</strong> converso, crescere in un contesto fortemente<br />
caratterizzato da lla presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui con una medesima <strong>origine</strong> territoriale, favorirà la<br />
conservazione della lingua originaria riducendo le opportunità e gli incentivi a imparare la<br />
nuova lingua (Jasso e Rosenzweig, 1990; Stevens, 1992). In generale, la <strong>di</strong>ffusione del<br />
bilinguismo, come alternativa alla piena assimilazione linguistica, è inversamente proporzionale<br />
alla durata della presenza sul territorio e alla <strong>di</strong>spersione sul territorio dei gruppi immigrati<br />
(Portes e Shauffler, 1996).<br />
Relativamente alla realtà americana, è stato mostrato che le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> hanno in<br />
generale una piena padronanza dell’inglese, quantunque, nel passaggio dall’adolescenza all’età<br />
adulta cresce tra i figli <strong>di</strong> immigrati il desiderio <strong>di</strong> utilizzare anche la lingua dei genitori nonché<br />
<strong>di</strong> educare, a loro volta, i propri figli al bilinguismo (Portes e Rumbaut, 2001). E’ piuttosto<br />
intuitivo pensare che chi conosce meglio l’inglese ha risultati migliori nel sistema scolastico<br />
americano. L’indagine CILS ci mostra a tal proposito che chi parla l’inglese in maniera fluente<br />
ha un netto vantaggio in termini <strong>di</strong> motivazioni, autostima e aspettative per il futuro, rispetto a<br />
quelli la cui lingua dominante è quella dei genitori. Tuttavia, chi insieme all’inglese parla in<br />
maniera fluente anche una seconda lingua , fornisce <strong>delle</strong> performance ancora migliori (Portes e<br />
Rumbaut, 2001). Per i figli degli immigrati, conoscere una lingua ad<strong>di</strong>zionale non si configura<br />
come uno svantaggio migliorando, piuttosto che deprimere, le possibilità <strong>di</strong> successo (Figueroa<br />
e Garcia, 1994). Il vantaggio dei bilingui è stato notato anche in Francia (Tribalat, 1995). Una<br />
possibile spiegazione <strong>di</strong> questi risultati è che il bilinguismo fluente rende possibile una migliore<br />
comunicazione con i genitori e con la propria comunità etnica, con l’effetto <strong>di</strong> allentare tensioni<br />
intergenerazionali e mantenere rapporti migliori con i coetanei della stessa etnia. Ci si rende ben<br />
conto <strong>di</strong> come l’appren<strong>di</strong>mento della lingua e dei costumi del paese d’accoglienza non implica<br />
necessariamente l’abbandono della lingua dei genitori o dei valori positivi della loro cultura<br />
(Portes e Hao, 2002). Di più: lo sviluppo del bilinguismo è utile sia per mantenere aperti i canali<br />
<strong>di</strong> comunicazione tra le <strong>generazioni</strong> ed evitare che i genitori restino linguisticamente isolati, sia<br />
per avere un “altro modo” <strong>di</strong> guardare al mondo essendo così capaci <strong>di</strong> una visio ne più critica<br />
verso i messaggi culturali provenienti dall’ambiente circostante (Hakuta, 1986).<br />
In generale, rinunciare a comunicare nella lingua dei genitori costituisce una enorme per<strong>di</strong>ta<br />
culturale, un <strong>di</strong>ssipamento <strong>di</strong> una risorsa sempre più utile anche nel mondo del lavoro sempre<br />
39
più inter<strong>di</strong>pendente a livello globale (Portes e Rumbaut, 2001). C’è chi però ha fatto notare che<br />
la ricchezza fornita dal bilinguismo in ambito familiare è da applicare con molta attenzione al<br />
mondo della scuola (Glenn, 2004). Il programma che negli USA aveva come fine quello <strong>di</strong><br />
valorizzare la conservazione del bilinguismo separando gli scolari “latini” per tre anni o più da<br />
quelli <strong>di</strong> lingua inglese, ha avuto come risvolto negativo l’incompleto appren<strong>di</strong>mento da parte<br />
dei figli <strong>di</strong> immigrati della lingua che loro devono padroneggiare al fine <strong>di</strong> affermarsi<br />
scolasticamente e economicamente nella società americana. L’errore, per Glenn (2004), non è<br />
l’insegnamento <strong>di</strong> più lingue, che anzi è un vantaggio, ma l’isolare gli alunni immigrati dagli<br />
alunni nativi poiché i bambini apprendono il linguaggio non solo attraverso l’istruzione formale<br />
ma anche tramite le interazioni informali. Purtroppo, la separazione dei figli <strong>di</strong> immigrati dagli<br />
autoctoni è stata una costante nelle regioni tedesche come la Baviera e Baden-Würtemberg dove<br />
più intensa è stata l’immigrazione dall’Italia e dove la riuscita scolastica dei figli <strong>di</strong> italiani è<br />
stata particolarmente scarsa (Thränhardt, 2004).<br />
Relativamente al legame tra capacità linguistiche e successo scolastico, è facile immaginare<br />
come la scarsa padronanza della lingua del luogo nel quale si vive comporti dei problemi nella<br />
scuola. Tuttavia, potrebbe configurarsi la presenza <strong>di</strong> una relazione spuria dove entrambi i<br />
fattori, conoscenza della lingua e successo scolastico, sono espressione <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong><br />
integrazione (Keidler e Pugliese, 1983).<br />
1.8 L’emigrazione italiana nel mondo<br />
In chiusura <strong>di</strong> questo capitolo apriamo una breve <strong>di</strong>gressione sull’emigrazione italiana nel<br />
mondo, allo scopo <strong>di</strong> introdurre l’argomento dei prossimi capitoli: le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong><br />
italiani in Francia, Svizzera e Australia.<br />
Prima <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare paese <strong>di</strong> immigrazione l’Italia è stata protagonista <strong>di</strong> una lunga e<br />
drammatica emigrazione all’estero e non va <strong>di</strong>menticato che tale fenomeno ha costituito una<br />
componente fondamentale della vita demografica, economica e sociale del Paese. Grosso modo,<br />
si può ritenere che nel secolo successivo all’unità, almeno 24 milioni <strong>di</strong> persone abbiano<br />
lasciato il paese per lavorare e vivere all’estero (tavola 1.1). Nel periodo 1875-1928 si sono<br />
registrati me<strong>di</strong>amente 3,4 milioni <strong>di</strong> emigranti ogni <strong>di</strong>eci anni e 2 milioni tra il 1929 e il 1975<br />
(Del Boca e Venturini, 2003). Molti sono tornati in patria ma, sebbene sia <strong>di</strong>fficile una esatta<br />
quantificazione del fenomeno, si può ritenere che i rimpatriati non siano stati più <strong>di</strong> 11-13<br />
milioni <strong>di</strong> persone. Ne segue che la per<strong>di</strong>ta netta dell’Italia, a causa dell’emigrazione nel corso<br />
del secolo 1870-1970, si può stimare in 12-14 milioni <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui (Golini, 1996).<br />
Le conseguenze demografiche dell’emigrazione italiana sono state impressionanti. Gli<br />
italiani sono stati una componente numerosa della forza lavoro in Francia, Svizzera e Germania,<br />
sia prima che dopo la Seconda guerra mon<strong>di</strong>ale; città come San Paolo, Buenos Aires, New<br />
York, Toronto hanno accolto un numero enorme <strong>di</strong> italiani. Oggi le persone <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana<br />
rappresentano il <strong>di</strong>eci per cento della popolazione francese, il 21 per cento <strong>di</strong> quella Argentina e<br />
circa il 15 per cento <strong>di</strong> quella statunitense (Gabaccia, 1997).<br />
40
Tavola 1.1 Le mete dell’emigrazione italiana 1876-1976 (dati assoluti; valori in migliaia).<br />
Principali paesi europei Paesi extraeuropei<br />
Francia 4117 USA 5691<br />
Svizzera 3990 Argentina 2969<br />
Germania 2453 Brasile 1457<br />
Belgio 535 Canada 650<br />
Gran Bretagna 264 Australia 428<br />
Altri 1188 Venezuela 285<br />
Totale 12547 Totale 11481<br />
Fonte: G.Rosoli, 1978.<br />
Risalgono al 1870 i primi movimenti migratori <strong>di</strong> un certo peso dall’Italia. Inizialmente i flussi,<br />
che partono in prevalenza dalle regioni settentrionali, sono destinati in egual misura verso<br />
l’Europa, Francia in primo luogo, e verso i paesi d’oltreoceano (Argentina, Brasile e poi gli<br />
Stati Uniti). Ai primi del ‘900 l’emigrazione si intensifica e la destinazione extraeuropea prende<br />
decisamente il sopravvento. In particolare circa il 45% <strong>di</strong> tutta l’emigrazione è assorbita dagli<br />
Stati Uniti e a partire sono le genti meri<strong>di</strong>onali che contribuiscono per oltre il 70% (Golini,<br />
1996).<br />
Nel periodo tra le due guerre mon<strong>di</strong>ali, si assiste a un progressivo assottigliarsi dei flussi in<br />
uscita a causa <strong>delle</strong> restrizioni legislative imposte da alcuni paesi <strong>di</strong> accoglienza (soprattutto da<br />
parte degli USA dove il Johnson Act del 1924, stabilendo quote per ogni gruppo nazionale ,<br />
riduceva drasticamente le possibilità <strong>di</strong> accesso per gli italiani), della grande crisi economica e<br />
dalle politiche fasciste tese a limitare le uscite. In questo periodo è la Francia la destinazione più<br />
comune.<br />
Conclusasi la seconda guerra mon<strong>di</strong>ale, i movimenti in uscita acquistano nuovo vigore e la<br />
propensione a emigrare è crescente fino all’inizio degli anni ’60. L’emigrazione <strong>di</strong>venta una<br />
prerogativa dell’Italia meri<strong>di</strong>onale. I flussi si <strong>di</strong>rigono inizialmente verso l’America Latina<br />
(essendo impraticabile la via verso gli Stati Uniti), l’Australia, il Canada ma sempre più<br />
orientati verso le destinazioni europee. Quest’ultime accolgono il 44,7% degli espatri negli anni<br />
1946-57; il 79,5% nel 1958-63; il 77,6% nel 1964-75 (Sori, 2001). E’ nel periodo del “miracolo<br />
economico”, cioè a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta, che le emigrazioni raggiungono la<br />
massima intensità relativamente al periodo post-bellico. Le principali mete sono fino alla metà<br />
degli anni ’50 sono Francia, Svizzera e Belgio, mentre negli anni successivi le nuove possibilità<br />
<strong>di</strong> occupazione nei servizi, nell’e<strong>di</strong>lizia e nell’industria rendono particolarmente intensi gli<br />
espatri verso Germania e Svizzera. L’emigrazione <strong>di</strong> questo periodo è in generale più<br />
qualificata, grazie anche ai corsi <strong>di</strong> formazione professionale tenuti nei paesi d’arrivo e, molto<br />
frequentemente, controllata e assistita (Golini, 1996)<br />
Le migrazioni verso paesi europei sono quelle maggiormente caratterizzate da una maggiore<br />
frequenza <strong>di</strong> ritorni in patria. Nel periodo 1946-70 a fronte <strong>di</strong> quattro milioni e mezzo <strong>di</strong><br />
41
partenze verso paesi europei, ben tre milioni hanno fatto ritorno; per destinazioni extraeuropee<br />
su 2.200.000 partenze solo 560.000 sono rimpatriati (CSER, 1975).<br />
Esponenti governativi e stu<strong>di</strong>osi, anche nell’area progressista, caldeggiarono negli anni ‘50<br />
l’emigrazione come soluzione all’eccedenza <strong>di</strong> manodopera e alla sovrappopolazione <strong>delle</strong><br />
regioni del Mezzogiorno. Come sottolinea Pugliese (2002), c’erano le con<strong>di</strong>zioni che rendevano<br />
l’emigrazione necessaria: in particolare lo squilibrio tra popolazione e risorse, nonché la fame <strong>di</strong><br />
terra dei conta<strong>di</strong>ni, con<strong>di</strong>zioni aggravate dalla politica “anti-urbanesimo” partita nel periodo<br />
fascista e prolungatasi fino a comprendere tutti gli anni Cinquanta che, congelando nelle<br />
campagne un eccesso <strong>di</strong> popolazione e forza lavoro, aveva reso ancora più dura la situazione nel<br />
Mezzogiorno e nelle altre regioni prevalentemente rurali del paese. Sebbene gli ambiti lavorativi<br />
che si andarono a occupare nei paesi d’arrivo (per lo più industria ed e<strong>di</strong>lizia) richiedevano<br />
nessuna o una scarsa qualificazione professionale, non solo braccianti, conta<strong>di</strong>ni e manovali<br />
intrapresero la via dell’emigrazione, ma anche artigiani e strati della piccola borghesia con un<br />
certo grado <strong>di</strong> scolarizzazione (Pugliese, 2002).<br />
All’estero, gli emigrati italiani fronteggiarono nazioni con visioni e aspettative molto<br />
<strong>di</strong>verse. Negli Usa, in Australia e Canada la <strong>di</strong>versità culturale degli italiani è data per scontata<br />
senza che questo infici il loro <strong>di</strong>venire citta<strong>di</strong>ni del luogo d’arrivo. Nelle società multiculturali<br />
dei paesi anglofoni, la doppia appartenenza costituì più una regola che un’eccezione. Al<br />
contrario, in Francia lo Stato accentratore e unitario non ha incoraggiato le identità multiple e,<br />
allo scopo <strong>di</strong> perseguire una nozione <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza sufficientemente unitaria, si cercò <strong>di</strong><br />
escludere i simboli etnici e religiosi dall’arena pubblica (Gabaccia, 1997). Infine, vi erano le<br />
situazioni limite <strong>di</strong> non appartenenza, vissute in Germania e in Svizzera dove i collegamenti tra i<br />
contratti <strong>di</strong> lavoro e i permessi <strong>di</strong> residenza contribuirono a costruire la figura dell’italiano<br />
immigrato come sojourner e Gastarbaiter, definendo gli immigrati decisamente come citta<strong>di</strong>ni<br />
italiani, non come potenziali citta<strong>di</strong>ni del paese in cui lavoravano.<br />
Nel complesso possiamo <strong>di</strong>re che la nostra storia <strong>di</strong> emigranti è nel complesso positiva. Non<br />
mancano le prove per testimoniare il successo vissuto da molti compatrioti negli Stati Uniti, nel<br />
Canada, nell’Australia o in Francia, ma in alcune situazioni è stata davvero <strong>di</strong>fficile: se nel Sud<br />
America furono numerosi le esperienze migratorie fallimentari conclusesi nel giro <strong>di</strong> brevi<br />
perio<strong>di</strong>, in Belgio non andò meglio e a simbolo della dura esperienza nelle miniere resta ancora<br />
il ricordo della trage<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Marcinelle del 1956.<br />
Le emergenze della sopraggiunta immigrazione in Italia hanno fatto velocemente stornare<br />
l’attenzione dagli italiani all’estero agli stranieri in Italia. Si tende ormai a pensare<br />
all’emigrazione come un fenomeno del passato, superato dai tempi. Fioriscono antologie, opere<br />
letterarie e raccolte <strong>di</strong> documentazioni relative a questo aspetto del nostro passato che hanno<br />
spesso finalità meramente storiche. Ma volgendo lo sguardo all’estero, ci si rende conto <strong>di</strong> come<br />
gli effetti <strong>delle</strong> emigrazioni <strong>di</strong> massa <strong>di</strong> lavoratori italiani rappresentino ancora una questione<br />
aperta. Il numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana nel mondo è impressionante: 58 milioni e<br />
mezzo, <strong>di</strong> cui 2 in Europa, 16,1 in Nord America, 39,8 in America Latina, 0,5 in Oceania e<br />
42
0,056 in Africa 11 . In generale, i percorsi <strong>di</strong> integrazione vissuti dai figli <strong>di</strong> questi emigrati sono<br />
un fenomeno tanto attuale quanto scarsamente conosciuto. Oggi, essi sono parte integrante<br />
dell’economia <strong>di</strong> paesi come la Francia, Australia, Germania e Svizzera. Hanno concluso i loro<br />
stu<strong>di</strong> e hanno formato un nuovo nucleo familiare. E’ a loro che adesso va la nostra attenzione.<br />
Riferimenti bibliografici<br />
Abouguen<strong>di</strong>a M. e Noels K.A., 2001, General and acculturation-related daily hassles and<br />
psychological adjustment in first- and second-generation South Asian immigrants to<br />
Canada, International Journal of psychology, 36(3).<br />
Alba R e Nee V., 1997, Rethinking assimilation theory for a new era of immigration, in<br />
International Migration review, 31(4).<br />
Alberoni F. e Baglioni G., 1965, L’integrazione dell’immigrato nella società industriale,<br />
Bologna, Il Mulino.<br />
Ambrosini M. e Molina S., 2004, Seconde <strong>generazioni</strong>. Un’introduzione al futuro<br />
dell’immigrazione in Italia , Torino, E<strong>di</strong>zioni Fondazione Giovanni Agnelli.<br />
Ambrosini M., 2001, La fatica <strong>di</strong> integrarsi. Immigrazione e lavoro in Italia, Bologna, Il<br />
Mulino.<br />
Ambrosini M., 2004, Il futuro in mezzo a noi. Le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> scaturite<br />
dall’immigrazione nella società italiana dei prossimi anni, in Ambrosini e Molina (2004).<br />
Andall J., 2002, Second generation attitude? African-Italians in Milan, Journal of ethnic and<br />
migration stu<strong>di</strong>es, 28 (3) , pp.389-407.<br />
Ballarino G. e Cobalti A., 2003, Mobilità sociale , Roma, Carocci.<br />
Becker G., 1993, Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to<br />
education, Chicago, University of Chicago press,<br />
Bianco M.L. (a cura <strong>di</strong>), 2001, L’Italia <strong>delle</strong> <strong>di</strong>suguaglianze, Roma, Carocci.<br />
Blake J., 1989, Family size and achievement, Los Angeles, CA, University of California,<br />
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6489p0rr/ .<br />
Boyd M. e Grieco E. M., 1998, Triumphant transitions: socioeconomic achievements of the<br />
second generation in Canada, International Migration Review 32(4), pp. 853-76.<br />
Boyd M., 2002, Educational attainments of immigrant offspring: success or segmented<br />
assimilitation?, International Migration Review, 36(4), pp. 1037-60.<br />
Brubaker R., 2001, The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its<br />
sequels in France, Germany and the United States, Ethnic and racial stu<strong>di</strong>es, 24 (4), pp.<br />
531-48.<br />
Ceravolo F., Eve M. e Meraviglia C., 2001, Migrazioni e integrazione sociale: un percorso a<br />
sta<strong>di</strong> in Bianco (2001).<br />
11 Secondo il Direttore generale dell’emigrazione del Ministero degli Affari esteri in una au<strong>di</strong>zione<br />
presso il Senato (“Migranti press” 19-25.11.1994) (cit. da Golini, 1996)<br />
43
Checchi D., 1998, Povertà e istruzione: alcune riflessioni e una proposta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori, Politica<br />
Economica, XIV (2).<br />
Child I., 1943, Italian or American? The second generation in conflict, New Haven, Yale<br />
University Press.<br />
Chiswick B.R, 1999, Are immigrants favorably self selected?, American economic review<br />
89(2).<br />
Chiswick B.R. e DebBurman N., 2003, Educational attainment: analysis by immigrant<br />
generation, IZA <strong>di</strong>scussion paper n. 731.<br />
Chiswick B.R., 2000, Are immigrants self-selected? An economic analysis, IZA <strong>di</strong>scussion<br />
paper n.131.<br />
Cobalti A. e Schizzerotto A., 1994, La mobilità sociale in Italia, Il Mulino, Bologna.<br />
Coenders M. e Scheepers P., 1998, Support for ethnic <strong>di</strong>scrimination in the Netherlands 1979-<br />
1993: effects of period, cohort and in<strong>di</strong>vidual characteristics, European sociological<br />
review, 14(4).<br />
Coleman J., 1988, Social capital in the creation of human capital, American journal of<br />
sociology, 94 (supplemento).<br />
Cologna D. e Breveglieri L. (a cura <strong>di</strong>), 2003 Figli dell'immigrazione. Ricerca sull'integrazione<br />
dei giovani immigrati a Milano, Milano, Franco Angeli.<br />
Crul M. e Vermeulen H., 2003, The second generation in Europe, International migration<br />
review, 37(4).<br />
CSER, 1975, L’emigrazione italiana negli anni ‘70, Roma, CSER.<br />
Dalla Zuanna G., Impicciatore R. e Michielin F., 2005, Le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> in Italia: una<br />
nuova vecchia storia, in Livi Bacci M. (2005).<br />
Dayan J. L., Echardour A. e Glaude M., 1996, Le parcours professionnel des immigrés en<br />
France : une analyse longitu<strong>di</strong>nale , Économie et statistique, n° 299.<br />
Del Boca D. e Venturini A., 2003, Italian migration, CHILD and IZA Bonn <strong>di</strong>scussion paper<br />
series no. 938, http://www.iza.org.<br />
Demarie M. e Molina S., 2004, Le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>. Spunti per il <strong>di</strong>battito italiano, in<br />
Ambrosini e Molina (2004).<br />
Dewind J. e Kasinitz P., 1997, Everything old is new again? Processes and theories of<br />
immigrant incorporation, International Migration review, 31(4).<br />
Duncan O.D. e Lieberson S., 1959, Ethnic segregation and assimilation, American journal of<br />
sociology, 64(4).<br />
Eisenstadt S. N., 1954, The absorption of immigrants, London, Routlege and Kegan Paul.<br />
Farley R. e Alba R., 2002, The new second generation in the United States, International<br />
migration review, 36(3).<br />
Fernandez-Kelly M. P., 1995, Social and cultural capital in the urban ghetto: implications for<br />
the economic sociology of immigration, in Portes (1995).<br />
Figueroa R.A. e Garcia E., 1994, Issue in testing students from culturally and linguistically<br />
<strong>di</strong>verse backgrounds, Multicultural education, 2.<br />
44
Gabaccia D. 1997, Per una storia italiana dell’emigrazione, Altreitalie, 16,<br />
http://www.fga.it/altreitalie/16_saggi1a.htm .<br />
Gang I. N. e Zimmermann K. F., 2000, Is child like parent? Educational attainment and ethnic<br />
origin, in Journal of human resources, 35(3).<br />
Gans H.J., 1997, Toward a reconciliation of “assimilation” and “pluralism”: the interplay of<br />
acculturation and ethnic retention, International Migration review, 31(4).<br />
Gans, H., 1992, Second Generation Decline: Scenarios for the Economic and Ethnic Futures of<br />
Post-1965 American Immigrants, Ethnic and Racial Stu<strong>di</strong>es, 15 (April), pp. 173-92.<br />
Glenn C., 2004, I figli degli immigrati a scuola: lezioni per l’Italia dalle esperienze <strong>di</strong> altri<br />
paesi, in Ambrosini e Molina (2004).<br />
Goldthorpe J. H., Payne C., Llewellyn C., 1987, Social mobility and Class Structure in Modern<br />
Britain, Oxford, Clarendon Press.<br />
Golini A., 1996, L’Italia <strong>delle</strong> gran<strong>di</strong> migrazioni. Tendenze e politiche, contributo presentato<br />
alla XXXVII riunione scie ntifica annuale della società italiana degli economisti, Bologna,<br />
25-26 ottobre.<br />
Golini A., 2005, Politiche migratorie, in Livi Bacci M. (2005).<br />
Gordon M., 1964, Assimilation in american life, New York, Oxford University Press.<br />
Hakuta K., 1986, Mirror of language: the debate on bilingualism, New York, Basic Books.<br />
Harker K., 2001 Immigrant generation, assimilation, and adolescent psychological well-being,<br />
Social forces, 79(3).<br />
Hirschman C. e Falcon L., 1985, The educational attainment of religio -ethnic groups in the<br />
United States, Research in Sociology of Education and Socialization, 5.<br />
Hirschman C., 2001, The educational enrolment of immigrant youth: a test of the segmented-<br />
assimilation hypothesis, in Demography, 38(3).<br />
Ichino A., Rustichini A.. e Checchi D., 1997, Scuola e mobilità sociale: un analisi comparata ,<br />
in Rossi (1997).<br />
Jasso G. e Rosenzweig M.R., 1990, The new chosen people: immigrants in the United States,<br />
New York, Russel Sage Foundation.<br />
Jensen L., 2001, The demographic <strong>di</strong>versity of immigrants and their children, in Rumbaut e<br />
Portes (2001).<br />
Kasinitz P., Mollenkopf J. e Waters M.C., 2002, BecomingAmerican / becoming New Yorkers:<br />
immigrant incorporation in a majority minority city, International migration review, 36(4).<br />
Keidler S., Pugliese E., 1983, Problemi della seconda generazione degli immigrati in RFT,<br />
Inchiesta, 62.<br />
Kymlicka, W., 1996, Le sfide del multiculturalismo, Il Mulino, 370.<br />
Lestaeghe R. (a cura <strong>di</strong>), 2000, Communities and generations: Turkish and Moroccan<br />
populations in Belgium, Brussels, NIDI CBGS.<br />
Lieberson S., 1973, Generational <strong>di</strong>fferences among blacks in the north , in American journal of<br />
sociology, 79.<br />
Livi Bacci M., 2005, L’incidenza economica dell’immigrazione, Torino, Giappichelli E<strong>di</strong>tore.<br />
45
Macura M. e Coleman D.A (a cura <strong>di</strong>)., 1994, International Migration: Regional Processes and<br />
Responses, UN Economic Commission for Europe, UN Population Fund, Economic Stu<strong>di</strong>es<br />
n. 7, New York and Geneva.<br />
Mc Partland J., 1998, Project 7126: The adaptation of immigrant children in the American<br />
educational system center for research on the education of <strong>di</strong>sadvantaged students (CDS),<br />
Johns Hopkins University, www.csos.jhu.edu .<br />
McManus W. S., Gould W. e Welch F., 1983, Earnings of Hispanic Men: The Role of English<br />
Language Proficiency, Journal of Labor Economics 1(2), pp.101-30.<br />
Miller P.W. e Volker P.A., 1989, Socioeconomic influences on educational attainment in<br />
Australian journal of statistics, special volume 31A, Youth employment and unemployment,<br />
august, pp. 47:50.<br />
Park R.E. e Burgess E.W., 1924, Introduction to the science of Sociology (1921), ristampa,<br />
University Chicago Press.<br />
Perlman J. e Wal<strong>di</strong>nger R., 1997, Second generation decline? Children of immigrants, past and<br />
present, a reconsideration, International Migration review, 31(4).<br />
Perlman J., 1988, Ethnic <strong>di</strong>fferences: schooling and social structure among the Irish, Jews and<br />
Blacks in an American city, 1988-1935, New York, Cambridge University press.<br />
Piore M. J., 1979, Birds of passage. Migrant labor and industrial societies, New York,<br />
Cambridge University Press.<br />
Pisati M., 2002, La mobilità sociale , Bologna, Il Mulino.<br />
Portes A. (a cura <strong>di</strong>), 1995, The economic sociology of immigration: essays in network,<br />
ethnicity, and entrepreneurship, New York, Russel Sage Foundation.<br />
Portes A. e MacLeod, 1996, Educational progress of children of immigrants: the role of class,<br />
ethnicity and school context, Sociology of education, 69(Ottobre), pp. 255-75.<br />
Portes A. e Rumbaut R., 2001, Legacies: the story of the immigrant second generation,<br />
Berkeley, CA, University of California Press and Russel Sage Foundation.<br />
Portes A. e Schauffler R., 1996, Language and the second generation: bilingualism yesterday<br />
and today, in Portes (1996).<br />
Portes A. e Zhou M., 1993, The new second generation: segmented assimilation and its<br />
variants, Annals of the American Academy of political and social science, n.530, novembre,<br />
pp. 74-96.<br />
Portes A.(a cura <strong>di</strong>), 1996, The new second generation, New York, Russel Sage Foundation.<br />
Portes A., 1998, Social capital: its origin and application in modern sociology, Annual review<br />
of sociology, 24.<br />
Portes A., Fernandez-Kelly P. e Haller J.H., 2004, L’assimilazione segmentata alla prova dei<br />
fatti: la nuova seconda generazione alle soglie dell’età adulta negli Stati Uniti, in<br />
Ambrosetti e Molina (2004).<br />
Portes A., Hao L., 2002, The price of uniformity: language, family and personal adjustment in<br />
the second generation, Ethnic and racial stu<strong>di</strong>es, 25.<br />
Portes, A. e Borocz J., 1989, Contemporary immigration: theoretical perspective on its<br />
determinats and modes of incorporation, International migration review, 23.<br />
46
Pugliese E., 2002 L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Bologna, Il<br />
Mulino.<br />
Recano J. e Roig M., 2001, International migration and inequalities: the influence of migrant<br />
origin in educational attainment in Spain, contributo presentato alla XXIV conferenza<br />
generale sulla popolazione (IUSSP), Salvador de Bahia, Brazil, August 2001.<br />
Rosenbaum E. e Friedman S., 2001, Differences in the locational attainment of immigrant and<br />
native-born househilds with children in New York city , Demography, 38(3).<br />
Rosoli G., 1978, Un secolo <strong>di</strong> emigrazione Italiana 1876-1976, Roma, CSER.<br />
Rossi N. (a cura <strong>di</strong>), 1997 L’istruzione in Italia: solo un pezzo <strong>di</strong> carta?, Bologna, Il Mulino.<br />
Rumbaut R.G. e Portes A., (a cura <strong>di</strong>), 2001, Ethnicities : children of immigrants in America,<br />
Berkeley, CA. UC Press and Russel Sage Foundation.<br />
Rumbaut R.G., 1997, Assimilation and its <strong>di</strong>scontents: between rhetoric and reality,<br />
International Migration review, vol. 31(4).<br />
Shaafsma J. e Sweetman A., 1999, Immigrant earnings: age at immigration matters, Cana<strong>di</strong>an<br />
Journal of economics, 34(4).<br />
Shavit Y. e Blossfeld H.P. (a cura <strong>di</strong>) 1993. Persistent inequality. Changing educational<br />
attainment in thirteen countries, Boulder (CO), Westview press.<br />
Shavit, Y. e Müller W. (a cura <strong>di</strong>), 1998, From school to work , Oxford, Oxford University<br />
Press.<br />
Simon P., 2003, France and the unknown second generation: preliminary results on social<br />
mobility, International migration review, 37(4).<br />
Smith J.P. e Edmonston, 1997, B., The new Americans: economic, demographic and fiscal<br />
effects of immigration, Washington, DC, National Academy Press.<br />
Sori E., 2001, L’emigrazione italiana in Europa tra Ottocento e Novecento, Stu<strong>di</strong> emigrazione,<br />
XXXVIII, 142.<br />
Steinberg L., 1997, Beyond the classroom, New York, Simon & Schuster.<br />
Stella G.A., 2002, L’orda. Quando gli albanesi eravamo noi, Milano, BUR.<br />
Stevens G., 1992, The social and demographic context of language use in the United States,<br />
American sociological review, 57(2), pp.171-85.<br />
Taft D.R. e Robbins R. (a cura <strong>di</strong>), 1955, International migrations, New York, Ronald Press<br />
Company.<br />
Tassello G. (a cura <strong>di</strong>), 1987, Lessico Migratorio , Roma, Centro Stu<strong>di</strong> Emigrazione.<br />
Thomas I.T. e Znaniecki F., 1968, Il conta<strong>di</strong>no polacco in Europa e in America, Milano,<br />
Comunità (ed. or. 1918-1920).<br />
Thränhardt D., 2004, Le culture degli immigrati e la formazione della «seconda generazione» in<br />
Germania, in Ambrosini e Molina (2004).<br />
Tribalat M., 1995, Faire France. Une grande enquête sur les immigrés et leurs enfants, Paris,<br />
La Découverte.<br />
U.S. Bureau of Census, 2003, The foreign-born population in the United States: March 2002,<br />
Current population reports.<br />
47
Valverde J.R. e Vila M.R., 2003, Internal migration and inequalities. The influence of migrant<br />
origin on educational attainment in Spain, European sociological review, 19(3).<br />
Vecoli R.J., 2002, Negli Stati Uniti, in Bevilacqua et al. (2003).<br />
Wal<strong>di</strong>nger R., e Perlmann J., 1998, Second generation: past, present, future, Journal of Ethnic<br />
and migration stu<strong>di</strong>es, vol. 24 (1).<br />
Warner, W. e Srole, L., 1945, The social system of American ethnic groups, Yankee city series<br />
vol.3, New Haven and London, Yale university press.<br />
Weels K., 2000, Education and the transition to employment: young Turkish and Moroccan<br />
adults in Belgium in Lesthaeghe R.(2000).<br />
Widgren J., 1986, The position of the “second generation” migrants in western Europe: policy<br />
failures and policy prospects, Stu<strong>di</strong> Emigrazione, 81.<br />
Wihtol de Wenden C., 2004, Giovani <strong>di</strong> seconda generazione: il caso francese, in Ambrosini e<br />
Molina (2004).<br />
Wilpert C., 1988, Entering the working world: following the descendants of Europe’s immigrant<br />
labour force, England, Gower publishing.<br />
Zhou M., 1997, Segmented assimilation: issues, controversies, and recent research on the new<br />
second generation, International Migration review, 31(4).<br />
Zubrzycki J., 1956, Polish immigrants in Britain (A study of adjustment), The Hague, Martinus<br />
Nijhoff.<br />
48
2.1 L’emigrazione italiana in Francia<br />
49<br />
CAPITOLO II<br />
In Francia<br />
L’emigrazione <strong>di</strong> massa degli italiani in Francia è un fenomeno <strong>di</strong> lunga durata che affonda le<br />
proprie ra<strong>di</strong>ci in tempi lontani e che, nella sua fase più intensa, si prolunga per circa un secolo.<br />
Il primato della Francia, nei flussi in uscita dall’Italia verso l’Europa, è dovuto alla prossimità<br />
territoriale tra i due paesi; al loro <strong>di</strong>verso sviluppo demografico (già nell’Ottocento la Francia e<br />
in particolare il Sud-Est francese è caratterizzata da bassa natalità e debole accrescimento<br />
naturale della popolazione mentre l’Italia mostrava andamenti opposti); alle se<strong>di</strong>mentate<br />
esperienze collettive e i percorsi già tracciati da decenni <strong>di</strong> esperienze migratorie (Corti, 2003;<br />
Sori, 2001); alla funzione svolta dalla Francia <strong>di</strong> accoglienza dei transfughi da guerre <strong>di</strong><br />
religione e da persecuzioni politiche (Sori, 1989). Tra il 1880 e il 1965, più <strong>di</strong> quattro milioni<br />
sono stati gli italiani giunti in Francia (Bacchetta e de Azevedo, 1990) con il risultato che oggi<br />
circa cinque milioni <strong>di</strong> francesi hanno un antenato italiano (Corti, 2003). E’ possibile<br />
in<strong>di</strong>viduare tre gran<strong>di</strong> fasi dell’emigrazione italiana in Francia. Ve<strong>di</strong>amole nel dettaglio.<br />
2.1.1 Dall’unità d’Italia alla prima guerra mon<strong>di</strong>ale: la grande emigrazione<br />
Già nel 1876 gli italiani in Francia erano 163.000 e all’inizio del nuovo secolo il loro numero<br />
complessivo era salito a 330.000. Nel 1911 gli italiani superano il numero dei belgi <strong>di</strong>ventando<br />
il primo gruppo <strong>di</strong> stranieri presenti nel paese e costituendo il 36% degli immigrati e oltre l’1%<br />
dell’intera popolazione francese. Alla vigilia della prima guerra mon<strong>di</strong>ale gli italiani in Francia<br />
sono circa mezzo milione (Corti, 2003).<br />
Si partiva dalle regioni centro-settentrionali dell’Italia, dal Piemonte in primo luogo ma<br />
anche dalla Toscana, Lombar<strong>di</strong>a, Emilia -Romagna e Veneto; si giungeva nelle aree più vicine<br />
alla frontiera (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes e Corsica) e nella regione <strong>di</strong> Parigi.<br />
La scelta <strong>delle</strong> destinazioni era legata alla vicinanza territoriale tra luogo <strong>di</strong> partenza e d’arrivo,<br />
alla presenza <strong>di</strong> cantieri e <strong>di</strong> centri <strong>di</strong> sviluppo industriale e commerciale.<br />
Gli immigrati italiani erano maschi adulti. Si andava a lavorare nell’e<strong>di</strong>lizia, in miniera o a<br />
svolgere altri lavori manuali come il taglialegna e lo scaricatore ma nel tempo alcuni italiani<br />
passarono dalle attività e occupazioni più tra<strong>di</strong>zionali alla grande industria e alle miniere,
innescando processi <strong>di</strong> mobilità occupazionale non sempre gra<strong>di</strong>ti dagli autoctoni. Sono anni nei<br />
quali il nazionalismo si unisce al rifiuto dello straniero che lavora troppo e accetta salari bassi.<br />
Si registrano scioperi contro i lavoratori italiani a Nancy, a Marsiglia , a La Mure. Gli episo<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
insofferenza comprendono anche linciaggi, omici<strong>di</strong>, incen<strong>di</strong> e saccheggi a negozi <strong>di</strong> italiani.<br />
Celebre è l’episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Aigues-Mortes sul Rodano dove, dopo una rissa nelle saline, si <strong>di</strong>ffonde<br />
la voce infondata che dei francesi siano morti provocando una violenta reazione degli autoctoni:<br />
8 sono i morti italiani secondo la polizia, 50 secondo il Times.<br />
Il soggiorno è spesso provvisorio e la libertà <strong>di</strong> circolazione è ancora la regola. Ci sono <strong>delle</strong><br />
concentrazioni <strong>di</strong> italiani sul territorio ma non si identificano vere e proprie Little Italies<br />
prevalendo, <strong>di</strong> norma, la mescolanza (Vial, 2002).<br />
2.1.2 Gli anni tra le due guerre mon<strong>di</strong>ali<br />
Dopo l’interruzione dovuta al primo conflitto bellico, i flussi migratori dall’Italia ripresero con<br />
ritrovato slancio negli anni successivi: i flussi aumentano, gli italiani sono un terzo degli<br />
stranieri, il doppio dei polacchi, il triplo degli spagnoli, il quadruplo dei belgi. Nel 1931, poco<br />
prima che si facessero sentire gli effetti della crisi economica e <strong>delle</strong> leggi restrittive del<br />
fascismo, gli italiani in Francia erano più <strong>di</strong> 800.000 (Schor, 1996), ma è verosimile che tra<br />
clandestini e stagionali il loro numero effettivo si attestasse intorno al milione <strong>di</strong> unità (Vial,<br />
2002). Grande importanza per lo scambio <strong>di</strong> manodopera ebbero gli accor<strong>di</strong> bilaterali italo-<br />
francesi (Tosi, 2002) e un trattato del 1919 prevede parità <strong>di</strong> trattamento in materia <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong><br />
assistenza, <strong>di</strong> scuole e <strong>di</strong> pensioni per gli immigrati (Vial, 2002).<br />
In questi anni, la richiesta <strong>di</strong> manodopera e la maggiore facilità nelle comunicazioni<br />
allargano le possibili destinazioni e cambia la <strong>di</strong>stribuzione degli italiani sul territorio francese.<br />
Le regioni del Sud-Est perdono parte della loro capacità <strong>di</strong> attrazione a vantaggio dell’area<br />
parigina (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne), che vede triplicare la presenza italiana tanto<br />
che Parigi supera Marsiglia in fatto <strong>di</strong> presenze italiane, e <strong>di</strong> nuovi poli <strong>di</strong> richiamo: l’area<br />
settentrionale (Nord-Pas-de-Calais, Alsazia, Lorena), dove il bisogno <strong>di</strong> manodopera per la<br />
ricostruzione post-bellica si associa alla richiesta <strong>di</strong> lavorator i nelle miniere e nelle industrie<br />
chimiche e siderurgiche, e le regioni sud-occidentali (Acquitaine, Mi<strong>di</strong>-Pyrénees, Languedoc-<br />
Roussillon) dove la richiesta nasceva dal popolamento <strong>di</strong> vaste aree agricoli (Corti, 2003).<br />
Per quanto riguarda le regioni <strong>di</strong> provenienza è da rilevare il forte aumento della<br />
componente veneta che, <strong>di</strong> debole entità prima della guerra, si accresce anche a causa della<br />
progressiva chiusura dei tra<strong>di</strong>zionali appro<strong>di</strong> transoceanici e Nord-Europei. Buona parte <strong>di</strong> tale<br />
componente confluisce nel Sud-Ovest agricolo (Guillaume, 1995). Il peso dei piemontesi nei<br />
flussi in uscita dall’Italia si riduce notevolmente ma nel complesso le regioni centro-meri<strong>di</strong>onali<br />
continuano ad avere un ruolo marginale.<br />
50
2.1.3 Dal secondo dopoguerra alla fine anni sessanta<br />
Nel secondo dopoguerra, così come era accaduto con il primo, la Francia necessita <strong>di</strong><br />
manodopera per la ricostruzione <strong>delle</strong> regioni settentrionali e orientali devastate dal conflitto.<br />
Bisogna colmare dei vuoti soprattutto al Nord e in Lorena. L’ita liano, considerato fino a quel<br />
momento con ostilità e <strong>di</strong>ffidenza, <strong>di</strong>venta, nell’imme<strong>di</strong>ato dopoguerra, lo straniero desiderabile<br />
nel pensiero e nell’azione dello stato francese, fermo restando una <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> privilegi<br />
accordata agli italiani del Nord, come <strong>di</strong>mostra il fatto che le autorità francesi decisero <strong>di</strong><br />
installare l’Office National d’Immigration (ONI) prima a Torino e poi a Milano. A questo<br />
ufficio compete <strong>di</strong> organizzare i flussi migratori, <strong>di</strong>rigerli verso i settori deficitarii e scegliere<br />
lavoratori forniti della competenze necessarie.<br />
Dileguatasi l’immagine dell’italiano “tra<strong>di</strong>tore” formatasi dopo la scesa in campo <strong>di</strong><br />
Mussolini nel secondo conflitto mon<strong>di</strong>ale, l’immigrazione italiana venne ricercata a tal punto da<br />
essere l’oggetto <strong>di</strong> un regime <strong>di</strong> deroga favorevole rispetto alla normativa generale relativa, basti<br />
pensare alle agevolazioni nell’ottenimento dei permessi <strong>di</strong> soggiorno e all’attribuzione<br />
dell’assegno familiare in forma integrale anche se la famiglia era rimasta in Italia (Spire, 2002).<br />
Inoltre, dato che al Governo d’oltralpe non interessava una immigrazione temporanea quanto<br />
piuttosto l’assimilazione dell’immigrato, si cercò <strong>di</strong> favorire ricongiungimenti familiari e nel<br />
maggio del 1947, il ministero della Popolazione si assunse la responsabilità <strong>di</strong> prendersi carico<br />
finanziariamente della venuta in Francia dei familiari degli operai italiani 12 . Solo dopo quattro<br />
anni questa misura fu estesa anche agli immigrati <strong>di</strong> altra provenienza, tra cui gli algerini<br />
sebbene godessero della citta<strong>di</strong>nanza francese (Spire, 2002)<br />
Ma la Francia attira meno rispetto al passato. L’arrivo <strong>di</strong> italiani è quantitativamente meno<br />
consistente rispetto ai perio<strong>di</strong> precedenti restando, tuttavia, almeno per un decennio, <strong>di</strong> gran<br />
lunga la più importante tra le immigrazioni straniere in Francia (Bechelloni, 2002). Nel solo<br />
1957 sono 115.000 gli immigrati italiani (Bacchetta e de Azevedo, 1990); nel 1962 si contano<br />
628.000 italiani, il doppio degli spagnoli e algerini (Vial, 2002).<br />
Le regioni d’arrivo preferite restano quelle <strong>delle</strong> aree industriali del Nord-Est e della regione<br />
parigina mentre continua a <strong>di</strong>minuire il peso relativo dell’affluenza nelle regioni me<strong>di</strong>terranee,<br />
che erano state le prime ad accogliere folti gruppi <strong>di</strong> italiani alla fine dell’800. In generale, la<br />
presenza degli italiani subisce una maggiore <strong>di</strong>spersione sul territorio sebbene restino visibili<br />
fino ad oggi le aree caratterizzate da una più intensa immigrazione dall’Italia (figura 1).<br />
12 Quanto fosse forte la volontà <strong>di</strong> orientare le politiche d’immigrazione a favore dell’arrivo e<br />
dell’assimilazione degli italiani appare chiaro dalle parole del celebre demografo Sauvy, nominato nel<br />
1945 segretario generale del settore Famiglia e Popolazione e successivamente <strong>di</strong>rettore dell’INED, il<br />
quale sosteneva come fosse possibile <strong>di</strong>mostrare che in Francia «un italiano si adatta più facilmente <strong>di</strong> un<br />
Arabo» (Sauvy, 1948, cit. in Spire, 2002). Ma lo stesso Sauvy ben <strong>di</strong>stingueva tra italiani del Sud e del<br />
Nord tanto da firmare un documento nel quale si riconosceva che «tanto dal punto <strong>di</strong> vista del suo valore<br />
come lavoratore quanto per la sua qualità sociale, si è d’accordo nel riconoscere che l’italiano del Nord<br />
è decisamente migliore dell’italiano del Sud» (Commissione interministeriale sull’immigrazione, 20<br />
marzo 1946, Archivio <strong>di</strong>plomatico, 3° v.,995; cit. in Spire, 2002).<br />
51
Figura 2.1. Italiani e naturalizzati <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana. Censimento 1990.<br />
[Tratto da Bechelloni, 2002, pag. 307]<br />
Sul piano professionale le occupazioni prevalenti in passato, come l’e<strong>di</strong>lizia, miniere, lavori<br />
pubblici, siderurgia e chimica, cedono il passo alle attività legate alla industria meccanica e<br />
automobilistica (Bilsky, 1995). Ma il cambiamento più importante del fenomeno migratorio in<br />
Francia è il forte aumento della componente meri<strong>di</strong>onale: nel 1959 ormai quasi il 60% degli<br />
espatriati proveniva dalle regioni del Centro-Sud, tra le quali un peso particolare era rivestito da<br />
Sicilia, Calabria e Puglia. Sebbene proprio da queste regioni proseguirà per tutti gli anni<br />
sessanta un deciso flusso, non si raggiungono i numeri degli anni trenta e il ciclo si avvia alla<br />
conclusione, essendo i flussi in uscita maggiormente attratti da Svizzera, Germania e dalla<br />
crescente importanza dell’alternativa offerta dalle migrazioni nel Nord Italia in pieno boom<br />
economico. Ad ogni modo, ancora oggi, la presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana in Francia è<br />
tutt’altro che irrilevante: nel 1999 le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> italiani sono le più numerose,<br />
seguite a breve <strong>di</strong>stanza dai figli <strong>di</strong> algerini (Simon, 2003).<br />
Nel corso <strong>di</strong> un secolo <strong>di</strong> emigrazione, gli italiani ebbero accesso in Francia a quei settori<br />
dove più forte era la richiesta <strong>di</strong> manodopera poco o per nulla specializzata e a basso costo.<br />
Anche nel secondo dopoguerra la manodopera italiana conservò la sua <strong>di</strong>mensione proletaria sul<br />
mercato del lavoro francese (Sori, 2001). Tuttavia, altre analisi hanno sottolineato la presenza <strong>di</strong><br />
percorsi <strong>di</strong> successo per gli italiani, soprattutto tra le ondate migratorie più recenti, mettendo in<br />
risalto lo sviluppo <strong>di</strong> imprese e<strong>di</strong>li, la crescita <strong>di</strong> attività commerciali, la formazione <strong>di</strong> proprietà<br />
fon<strong>di</strong>arie, il progressivo aumento <strong>di</strong> manodopera qualificata nel settore industriale, l’abbandono<br />
del lavoro <strong>di</strong> fabbrica per altre attività <strong>di</strong> tipo autonomo (Milza, 1993). Meno frequenti sono i<br />
mutamenti <strong>di</strong> status nelle attività <strong>di</strong> tipo industriale e nella grande industria (Corti, 2002) mentre<br />
52
il successo dei conta<strong>di</strong>ni veneti, trentini e friulani nelle campagne del Sud-Ovest della Francia<br />
rappresenta un importante esempio <strong>di</strong> mobilità ascendente in ambito agricolo 13 .<br />
2.2 Il sistema scolastico francese<br />
La maggior parte <strong>delle</strong> scuole sono pubbliche e gratuite 14 . A partire dal 1967, la scuola è<br />
obbligatoria fino ai 16 anni. Il livello primario (école primarie) inizia a 6 anni <strong>di</strong> età e dura<br />
cinque anni. A 11 anni in me<strong>di</strong>a parte il grado inferiore del livello secondario (collège<br />
d’enseignment secondaire) che generalmente dura 4 anni e nel quale gli studenti frequentano i<br />
corsi dal 6° al 3°. L’istruzione secondaria superiore, che inizia <strong>di</strong> solito ai 15 anni, è composta<br />
da due possibili percorsi:<br />
- il Lycée, dura generalmente 3 anni (2°, 1° e corso conclusivo) e prepara gli studenti<br />
all’istruzione universitaria. In base al percorso scelto, conduce all’ottenimento del<br />
Baccalauréat generale, Baccalauréat tecnologico e del Diploma <strong>di</strong> tecnico (Brevet de<br />
technicien). Il Lycée offre inoltre dei corsi <strong>di</strong> preparazione per le Grandes Ecoles e per<br />
corsi tecnici <strong>di</strong> livello superiore. Dopo aver concluso il 2°, gli studenti hanno<br />
l’opportunità <strong>di</strong> prepararsi per il Diploma <strong>di</strong> tecnico che fornisce accesso <strong>di</strong>retto al<br />
mercato del lavoro o permette <strong>di</strong> accedere allo IUT (Istituti universitari <strong>di</strong> tecnologia).<br />
- il Lycée d’enseignement professionnel fornisce una istruzione più orientata al mondo<br />
professionale e conduce gli studenti, lungo un percorso biennale, all’ottenimento del CAP<br />
(Certificato <strong>di</strong> attitu<strong>di</strong>ne professionale) che permette <strong>di</strong> iniziare una attività professionale,<br />
e del BEP (Brevetto professionale) che fornisce il titolo <strong>di</strong> lavoratore o impiegato<br />
qualificato. Dopo il BEP, gli studenti possono continuare per altri due anni fino a ottenere<br />
il Baccalauréat professionnel.<br />
L’istruzione terziaria in Francia continua all’università, alle Grand Ecoles e allo IUT. I corsi più<br />
brevi durano due anni dopo il Bac e sono popolarmente noti come Bac+2 mentre stu<strong>di</strong> più<br />
lunghi sono conosciuti come Bac+3 e così via, in base al numero <strong>di</strong> anni svolti dopo il Bac. Gli<br />
studenti in possesso del Bac (generale, tecnico o vocazionale) sono nella con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> poter<br />
accedere all’istruzione universitaria, <strong>di</strong> solito senza la necessità <strong>di</strong> superare un esame d’ingresso.<br />
Il primo ciclo universitario dura solitamente due anni nei quali viene fornita una istruzione<br />
universitaria <strong>di</strong> base e al termine dei quali si ottiene un <strong>di</strong>ploma universitario generico (DEUG).<br />
Nel secondo si seguono stu<strong>di</strong> più approfon<strong>di</strong>ti e conducono all’ottenimento <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ploma<br />
13 A partire dal 1922, 45.000 conta<strong>di</strong>ni provenienti dalle regioni del Nord-Est Italia ebbero accesso a<br />
contratti <strong>di</strong> mezzadria e riuscirono ad acquistare terreni a basso costo nel Sud-Ovest della Francia. Tra<br />
questi, nel 1930, si contavano già 200.000 capi <strong>di</strong> tenuta che davano da vivere a 100.000 persone e<br />
coltivavano centinaia <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> ettari, in affitto o in proprietà (Guillaume, 1995).<br />
14 Le scuole private, per lo più istituti cattolici che hanno firmato degli accor<strong>di</strong> con lo Stato,<br />
accolgono il 17% degli studenti (Eurybase, 2002). Alcune scuole private richiedono una retta, sebbene<br />
nelle scuole che hanno ricevuto finanziamenti <strong>di</strong> supporto le tariffe no sono molto elevate. In tali scuole i<br />
programmi <strong>di</strong>dattici sono supervisionati dallo Stato e devono seguire quelli adottati nelle scuole<br />
pubbliche.<br />
53
(License) o, prolungando ulteriormente gli stu<strong>di</strong>, del titolo <strong>di</strong> Maîtrise. Il terzo ciclo d’istruzione<br />
terziario è inteso per le persone che vogliono entrare nel mondo della ricerca.<br />
Gli stu<strong>di</strong> tecnologici allo IUT durano solitamente due anni al fine <strong>di</strong> ottenere il <strong>di</strong>ploma<br />
universitario <strong>di</strong> tecnologia (DUT). L’istruzione terziaria più prestigiosa si ottiene negli istituti<br />
non universitari chiamati Grand Ecoles, caratterizzati da una procedura <strong>di</strong> ammissione molto<br />
selettiva.<br />
L’abbandono degli stu<strong>di</strong> è un fenomeno che si osserva principalmente al termine del college<br />
(scuola me<strong>di</strong>a inferiore) e durante il lycée e nelle scuole professionali (Simon, 2003). Ne segue<br />
che, per le <strong>generazioni</strong> più giovani, la prima forte selezione in termini educativi si è avuta nella<br />
scuola secondaria superiore, livello nel quale inizia a palesarsi l’effetto <strong>di</strong> specifici costi-<br />
opportunità che vedono l’investimento in istruzione andare a detrimento <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to<br />
imme<strong>di</strong>ato (Valverde e Vila, 2003). Un fattore <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione nella carriera scolastica può<br />
essere dato dalla tipologia <strong>di</strong> percorso seguito (generale vs professionale): alcuni sottogruppi <strong>di</strong><br />
popolazione potrebbero avere una minore propensione all’investimento in istruzione mostrando<br />
una più alta probabilità incidenza <strong>di</strong> iscritti nelle scuole professionali. Sfortunatamente,<br />
nell’indagine EHF non si hanno informazioni dettagliate sulla carriera scolastica ma si conosce<br />
solo il più alto titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o mai raggiunto. Non ci è dunque possibile conoscere il tipo <strong>di</strong><br />
scuola frequentato dagli in<strong>di</strong>vidui in possesso <strong>di</strong> un livello d’istruzione terziario. Tuttavia,<br />
considerando la probabilità <strong>di</strong>fferenziale <strong>di</strong> ottenere un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o terziario tra <strong>di</strong>versi<br />
sottogruppi <strong>di</strong> popolazione, si tiene conto implicitamente della <strong>di</strong>fferenziazione nei percorsi<br />
scolastici.<br />
2.3 Dati e definizioni<br />
Al fine <strong>di</strong> fornire <strong>delle</strong> evidenze empiriche sulla loro istruzione, una fonte <strong>di</strong> dati<br />
particolarmente versatile e potente è fornita dall’indagine “INSEE, Enquête Etude de l’histoire<br />
familiale 1999” (EHF) 15 : durante il 1999, unitamente alla rilevazione censuaria, 380.000 uomini<br />
e donne residenti in abitazioni provate hanno compilato un modulo ad<strong>di</strong>zionale sulla loro “storia<br />
familiare”, includendo informazioni sulle loro origini, sui figli, le esperienze <strong>di</strong> coppia, sui<br />
propri genitori e sul linguaggio (sia nazionale che regionali) trasmesso da questi nell’ambito<br />
familiare <strong>di</strong> appartenenza 16 . Tutte le informazioni contenute nel questionario del censimento,<br />
come il livello d’istruzione, luogo e data <strong>di</strong> nascita, sono altresì <strong>di</strong>sponibili, così come le date <strong>di</strong><br />
acca<strong>di</strong>mento dei più importanti eventi atti a identificare la transizione allo stato adulto. Tramite<br />
15 Dati forniti dall’INED, Parigi.<br />
16 Sin dal 1954 unitamente al censimento si cerca <strong>di</strong> reperire informazioni più approfon<strong>di</strong>te sulle<br />
<strong>di</strong>namiche familiari in Francia. Ogni indagine è stata in<strong>di</strong>rizzata verso uno specifico tema, come la<br />
partecipazione femminile nel mercato del lavoro (1982) o la cura dei figli (1990). L’oggetto scelto per il<br />
1999 è la trasmissione intergenerazionale <strong>di</strong> lingue e <strong>di</strong>aletti. Il questionario dell’indagine del 1999 è stato<br />
accuratamente ri<strong>di</strong>segnato ed è il primo a essere in<strong>di</strong>rizzato sia agli uomini che alle donne. Fornisce<br />
materiale prezioso per numerosi stu<strong>di</strong> sia nell’ambito familiare che linguistico. Informazioni sul sito<br />
http://www-ehf.ined.fr/.<br />
54
il luogo d’<strong>origine</strong> dei genitori e l’anno <strong>di</strong> arrivo in Francia per i nati all’estero, è possibile<br />
<strong>di</strong>stinguere dal resto della popolazione i figli <strong>di</strong> immigrati, cioè tutti gli in<strong>di</strong>vidui che risiedono<br />
stabilmente in Francia al 1999, nati o arrivati in Francia durante l’adolescenza con almeno un<br />
genitore immigrato. In base alle informazioni <strong>di</strong>sponibili nell’indagine EHF, <strong>di</strong>stinguiamo,<br />
all’interno <strong>di</strong> questo gruppo tra:<br />
- Seconda generazione mista (G2mix Italia): nati in Francia da un genitore nato in Italia e<br />
uno nato in Francia.<br />
- Seconda generazione (stricto sensu) (G2 Italia): nati in Francia da genitori nati entrambi<br />
in Italia 17 .<br />
- Generazione 1,5 (G1,5 Italia): giunti in Francia prima del decimo compleanno, con<br />
entrambi i genitori nati in Italia.<br />
- Generazione 1 (G1 Italia): giunti in Francia dopo il decimo compleanno. In questo caso,<br />
l’in<strong>di</strong>viduo è considerato come immigrato <strong>di</strong>retto.<br />
Tutte queste categorie saranno poste a confronto con il gruppo <strong>di</strong> riferimento dato dagli<br />
autoctoni: in<strong>di</strong>vidui nati in Francia da genitori entrambi nati in Francia.<br />
Come ulteriore termine <strong>di</strong> paragone, si considereranno anche i figli <strong>di</strong> immigrati spagnoli,<br />
sud<strong>di</strong>visi seguendo le stesse definizioni appena fornite per i figli <strong>di</strong> italiani, ottenendo quin<strong>di</strong> i<br />
sottogruppi G2mix Spagna, G2 Spagna, G1,5 Spagna e G1 Spagna. La scelta è ricaduta sulla<br />
Spagna a causa della presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse analogie nei flussi migratori da questo paese e quelli<br />
provenienti dall’Italia. Innanzitutto, sebbene gli immigrati dalla Spagna sono stati meno<br />
numerosi, i tempi <strong>delle</strong> migrazioni sono simili: entrambi i flussi sono iniziati alla fine del XIX<br />
secolo, hanno seguito percorsi simili e si sono fortemente ridotti a cavallo tra la fine degli anni<br />
Sessanta e gli inizi degli anni Settanta. Inoltre, l’emigrazione da entrambi i paesi è stata<br />
caratterizzata dalla ridotta incidenza <strong>di</strong> lavoratori ad alta qualificazione e con elevato livello<br />
d’istruzione. Ad ogni modo, se non specificato altrimenti con le sigle G2mix, G2, G1,5 e G1 si<br />
considerano gli in<strong>di</strong>vidui con <strong>origine</strong> italiana.<br />
Nella tavola 2.1 possiamo osservare una prima descrizione del campione EHF considerando<br />
tutti i possibili gruppi definiti dalla storia migratoria familiare 18 . Si precisa che, dal campione<br />
EHF, verranno considerati tutti i nati fino al 1979 (si escludono in pratica i nati nel 1980). Ben<br />
11.315 in<strong>di</strong>vidui intervistati hanno almeno un genitore nato in Italia e, tra questi, nove mila<br />
possono essere considerati come figli <strong>di</strong> immigrati, costituendo il gruppo più ampio tra tutti i<br />
figli <strong>di</strong> immigrati in Francia. La categoria più numerosa è la G2mix Italia mentre la G1,5 non è<br />
17<br />
Si include in questo gruppo anche chi, nato in Italia, giunge in Francia nei primi sei mesi <strong>di</strong> vita.<br />
18<br />
La categoria “altro o mancante” si riferisce a:<br />
1) in<strong>di</strong>vidui con almeno un genitore nato in un paese <strong>di</strong>verso dalla Francia, l’Italia e la Spagna (ad<br />
esempio, chi ha almeno un genitore nato in Algeria o Germania) (55.751 casi);<br />
2) in<strong>di</strong>vidui con un genitore nato in Italia e uno in Spagna (72 casi);<br />
3) in<strong>di</strong>vidui nati fuori dalla Francia da entrambi i genitori francesi (2665 casi) o da un genitore<br />
italiano e uno francese (121 casi) o da un genitore spagnolo e uno francese (128 casi).<br />
4) in<strong>di</strong>vidui per i quali l’in<strong>di</strong>cazione del paese <strong>di</strong> nascita <strong>di</strong> almeno un genitore è mancante (37051).<br />
55
molto ampia e tende a <strong>di</strong>minuire tra le coorti più giovani (come per la G1), a <strong>di</strong>mostrazione<br />
della netta <strong>di</strong>minuzione dei flussi migratori dall’Italia dagli anni Sessanta. Appare evidente dalla<br />
tavola l’antica e stabile presenza degli italiani in Francia.<br />
Tavola 2.1. Il campione proveniente dall’indagine “étude de l’histoire familiale (EHF)” condotta nel 1999<br />
(dati pesati).<br />
fino al 1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 Tot<br />
Autoctoni 39188 31194 37315 47247 47687 42544 245175<br />
G2 mix Italia 462 547 832 984 898 712 4435<br />
G2 Italia 618 581 407 680 805 315 3406<br />
G1,5 Italia 374 62 261 334 61 14 1106<br />
G1 Italia 878 661 403 195 127 44 2308<br />
G2mix Spagna 180 201 420 489 509 444 2243<br />
G2 Spagna 286 258 236 269 490 271 1810<br />
G1,5 Spagna 103 87 53 241 147 18 649<br />
G1 Spagna 633 500 427 187 79 44 1870<br />
Altro o mancante 13152 10866 14980 18910 19624 18256 95788<br />
Totale 55874 44957 55334 69536 70427 62662 358790<br />
Lo scopo della presente analisi è <strong>di</strong> valutare i legami tra istruzione e storia migratoria familiare<br />
attraverso il confronto tra figli <strong>di</strong> immigrati italiani e autoctoni. Quanto è avanzato il processo <strong>di</strong><br />
assimilazione tra i figli <strong>di</strong> italiani in termini <strong>di</strong> istruzione? Hanno avuto le stesse possibilità dei<br />
figli dei francesi? Possiamo <strong>di</strong>re che l’assimilazione può considerarsi completa solo quando i<br />
<strong>di</strong>scendenti degli immigrati hanno le stesse opportunità <strong>di</strong> affermazione sociale della<br />
popolazione autoctona. Controllando per la classe sociale dei genitori e altre caratteristiche<br />
concernenti la famiglia d’<strong>origine</strong>, si cercherà <strong>di</strong> fornire <strong>delle</strong> evidenze empiriche che possano<br />
permettere <strong>di</strong> fornire <strong>delle</strong> risposte, seppur parziali, ai quesiti posti. Inoltre, dato che l’indagine<br />
EHF riporta alcune in<strong>di</strong>cazioni sul linguaggio parlato dai genitori durante l’infanzia, si cercherà<br />
<strong>di</strong> valutare l’impatto <strong>di</strong> questo aspetto sui risultati scolastic i e universitari.<br />
.<br />
2.4 Una descrizione del campione.<br />
Nell’analisi, l’attenzione si concentrerà sulla probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un:<br />
1- livello d’istruzione secondaria superiore (classes de <strong>seconde</strong>, première ou<br />
terminale);<br />
2- livello terziario (études supérieures, facultés, IUT, grandes écoles, etc.).<br />
L’ipotesi sottostante è che più elevato è il titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o considerato, maggiore è la selezione<br />
tra gli studenti.<br />
56
Nella figura 2.2 è mostrata la <strong>di</strong>ffusione dei livelli d’istruzione nei sottogruppi <strong>di</strong> popolazione.<br />
Risulta subito evidente la bassa incidenza <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati tra i figli <strong>di</strong> immigrati<br />
italiani, soprattutto tra le G1,5, sia tra le vecchie che tra le giovani coorti. Si noti anche il<br />
cambiamento della figura dell’immigrato <strong>di</strong>retto tra la prima e la seconda metà del XX secolo.<br />
Figura 2.2. Distribuzione percentuale dei titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (almeno un titolo secondario superiore e almeno<br />
un titolo terziario) all’interno dei sottogruppi <strong>di</strong> popolazione definiti in base alla storia migratoria<br />
familiare. Francia, EHF 1998.<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
Coorti fino al 1949 Coorti 1950-1979*<br />
Autoctoni G2 mix G2 G1,5 G1<br />
* Per il livello terziario si considerano le coorti fino al 1974.<br />
Lo scarso successo dei figli degli immigrati può però <strong>di</strong>pendere dalle <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
partenze. E’ necessario tener conto dell’effetto composizione dei sottogruppi, cioè includere<br />
nell’analisi quegli aspetti potenzialmente capaci <strong>di</strong> influire sui risultati nel campo<br />
dell’istruzione, aspetti che verranno implementati nei modelli multivariati come fattori <strong>di</strong><br />
controllo. Nello specifico, si terrà conto <strong>delle</strong> seguenti variabili:<br />
a) coorte <strong>di</strong> nascita del rispondente (co<strong>di</strong>ficata in classi quinquennali).<br />
La crescente scolarizzazione dell’ultimo secolo ha mo<strong>di</strong>ficato profondamente le<br />
probabilità <strong>di</strong> raggiungere un livello d’istruzione elevato e dunque ci aspettiamo che tali<br />
probabilità siano decisamente più elevate per le coorti più giovani.<br />
b) genere.<br />
Almeno sec. sup Almeno terziario<br />
Se nella prima metà del XX secolo, l’istruzione era prettamente maschile, negli ultimi<br />
decenni la rapida crescita della scolarizzazione femminile ha portato ad<strong>di</strong>rittura a<br />
sorpassare gli uomini nell’incidenza <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati.<br />
c) Classe socio-economica <strong>di</strong> appartenenza.<br />
Si è già sottolineato come il raggiungimento <strong>di</strong> livelli d’istruzione elevati sia fortemente<br />
con<strong>di</strong>zionato dall’<strong>origine</strong> sociale: quando la posizione socio-economica dei genitori è<br />
più elevata, le possibilità crescono. Al fine <strong>di</strong> identificare questa variabile, si utilizza<br />
l’ultimo lavoro svolto dai parenti all’intervista (o l’ultimo lavoro svolto dalle persone<br />
57<br />
60,0<br />
50,0<br />
40,0<br />
30,0<br />
20,0<br />
10,0<br />
0,0<br />
Autoctoni G2 mix G2 G1,5 G1<br />
Almeno sec. sup Almeno terziario
itirate dal lavoro) 19 . Lo schema classificatorio utilizzato per la definizione <strong>delle</strong> classi<br />
sociali parte dalla classificazione a 11 posizioni proposta da Erikson e Goldthorpe<br />
(1992), procedendo con successive aggregazioni in presenza <strong>di</strong> gruppi troppo piccoli e<br />
quando la <strong>di</strong>stinzione risulti problematica in base alla natura dei dati <strong>di</strong>sponibili. Per<br />
ogni genitore si considerano le seguenti posizioni (in parentesi le definizioni in<br />
francese):<br />
1) classe <strong>di</strong> servizio superiore (Chefs d’enterprise de 10 salariés ou plus ;<br />
professions; cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et<br />
artistiques, cadres d’enterprise);<br />
2) classe <strong>di</strong> servizio inferiore (professions interme<strong>di</strong>aries de l’enseignement, de la<br />
santé et de la function publique et assimilés, professions intermé<strong>di</strong>aires<br />
administratives et commerciales des enterprises, techniciens, contremaitres,<br />
agents de maitrise);<br />
3) impiegati esecutivi (employés de la fonction publique, employés administratifs<br />
d’entreprises, employés de commerce, personnels des services <strong>di</strong>rects aux<br />
particuliers);<br />
4) piccola borghesia urbana (artisans, commerçants et assimilés);<br />
5) piccola borghesia agricola (agriculteurs exploitants);<br />
6) lavoratori manuali qualificati (ouvriers qualifiés);<br />
7) lavoratori manuali non qualificati (ouvriers non qualifiés, ouvriers agricoles).<br />
La classe sociale per l’intero nucleo familiare si ottiene seguendo il “principio <strong>di</strong><br />
dominanza” (Erikson, 1984). Considerando i tre gruppi sociali or<strong>di</strong>nati in base alla<br />
presenza <strong>di</strong> relazioni gerarchiche tra loro:<br />
- classe <strong>di</strong> servizio superiore,<br />
- classe me<strong>di</strong>a (classe <strong>di</strong> servizio inferiore, impiegati esecutivi, piccola borghesia<br />
urbana e agricola),<br />
- classe operaia (lavoratori manuali qualificati e non),<br />
se i due genitori appartengono a gruppi <strong>di</strong>versi, si prende come classe sociale familiare<br />
quella più elevata, se appartengono allo stesso gruppo, si considera quella del padre.<br />
L’idea è che l’occupazione del padre è ancora oggi più importante rispetto a quella della<br />
madre nel definire la posizione sociale del nucleo familiare preso come unità.<br />
d) composizione familiare.<br />
Una famiglia numerosa può voler <strong>di</strong>re minori risorse da investire nell’istruzione dei figli<br />
(Blake, 1989). Dove le risorse economiche sono limitate, ulteriori <strong>di</strong>fficoltà possono<br />
19 Solitamente, per la finalità specificata si utilizza la categoria socio-professionale dei genitori<br />
occupata quando il figlio aveva 14 o 15 anni ma questa informazione non è <strong>di</strong>sponibile nell’indagine<br />
EHF. Tuttavia, la scarsa incidenza della mobilità sociale intra-generazionale (all’interno della carriera <strong>di</strong><br />
un soggetto), rispetto a quella inter-generazionale (<strong>di</strong>fferenze tra genitori e figli) e i problemi relativi<br />
all’”effetto memoria”, che agiscono quando si domanda qualcosa su un passato che può essere anche<br />
molto lontano, non comportano gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenze nell’uso <strong>delle</strong> due variabili. In altre parole, in mancanza<br />
<strong>di</strong> altre informazioni, l’ultimo lavoro svolto dai genitori può essere considerata un accettabile<br />
approssimazione della categoria socio-professionale.<br />
58
emergere per i figli con fratelli e sorelle più vecchi: in una prole numerosa i primi figli<br />
possono usare le poche risorse <strong>di</strong>sponibili e gli altri figli potrebbero trovare maggiori<br />
<strong>di</strong>fficoltà nel proseguire gli stu<strong>di</strong> nei gra<strong>di</strong> superiori. Ad ogni modo, l’inclusione <strong>delle</strong><br />
due variabili “numero <strong>di</strong> fratelli/sorelle” e “or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> nascita” provocherebbe la<br />
presenza <strong>di</strong> uno zero strutturale 20 . Per evitare questo problema, possiamo considerare<br />
l’interazione tra le due variabili, ottenendo in tal modo 10 possibili modalità: figlio<br />
unico, primo <strong>di</strong> due figli, secondo <strong>di</strong> due figli, primo <strong>di</strong> tre,…quarto o più <strong>di</strong> quattro o<br />
più figli.<br />
e) viveva con i genitori a 14 anni.<br />
I figli che vivono con entrambi i genitori biologici riportano risultati scolastici migliori<br />
rispetto a chi vive con uno o nessun genitore (Astone e Mclanahan, 1991; Rumbaut,<br />
1994). Sotto l’ipotesi che due genitori forniscono maggiore supporto e supervisione ai<br />
figli, e che la loro autorità e i loro desideri sono rinforzati dal fatto <strong>di</strong> essere in due, ci si<br />
aspetta un effetto positivo sul livello d’istruzione dato dal vivere con entrambi i genitori<br />
a 14 anni.<br />
f) area <strong>di</strong> residenza.<br />
Questa variabile cerca <strong>di</strong> tener conto <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze in termini <strong>di</strong> livelli d’istruzione tra<br />
le <strong>di</strong>verse aree all’interno del territorio francese. A tal proposito, è necessario<br />
sottolineare come il valore dato all’istruzione non è lo stesso nelle <strong>di</strong>verse regioni. Nelle<br />
regioni me<strong>di</strong>terranee, la partecipazione scolastica è cresciuta molto velocemente negli<br />
ultimi decenni sorpassando i livelli del più ricco Nord e, oggigiorno, l’istruzione gioca<br />
un ruolo molto più importante <strong>di</strong> quanto accade nelle altre aree del paese (Le Bras,<br />
1986). E’ dunque ipotizzabile che vi siano <strong>di</strong>fferenze significative nella probabilità <strong>di</strong><br />
raggiungere uno specifico livello d’istruzione tra un’area e un’altra. Siccome abbiamo<br />
già avuto modo <strong>di</strong> vedere come la <strong>di</strong>stribuzione degli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana non è<br />
uniforme sul territorio francese, non tener conto <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze tra le <strong>di</strong>fferenti aree<br />
potrebbe inficiare i risultati dell’analisi. Una informazione utile in tal senso sarebbe la<br />
regione <strong>di</strong> residenza ai 14 anni. Purtroppo si <strong>di</strong>spone solo della regione <strong>di</strong> residenza<br />
all’intervista. Il rischio nell’usare questo carattere sta nella possibilità <strong>di</strong> migrazioni<br />
interne compiute per completare i propri stu<strong>di</strong> o dopo la fine degli stu<strong>di</strong>. Come<br />
conseguenza, alcune specifiche aree del paese potrebbero mostrare una elevata<br />
incidenza <strong>di</strong> titoli elevati solo perché al loro interno sono presenti molte università e<br />
attività capaci <strong>di</strong> attrarre persone altamente istruite da altre aree (questo è il caso, ad<br />
esempio, dell’area parigina). Pertanto, si corre il rischio <strong>di</strong> una possibile inversione<br />
nella relazione causale (non l’area <strong>di</strong> residenza il luogo a influenzare il livello <strong>di</strong><br />
istruzione ma è quest’ultimo a in<strong>di</strong>rizzare verso specifiche aree del paese), rischio tanto<br />
più intenso quanto più forti sono i movimenti migratori interni. Un modo <strong>di</strong> limitare<br />
questa <strong>di</strong>storsione è quella <strong>di</strong> considerare solo tre gran<strong>di</strong> macroaree scelte in modo da<br />
20 Le due variabili sono strettamente connesse, essendo l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> nascita <strong>di</strong>pendente dal numero <strong>di</strong><br />
figli. Inoltre, la modalità “figlio unico” comporta una modalità in comune per le due variabili<br />
59
massimizzare le <strong>di</strong>fferenze in termini <strong>di</strong> incidenza <strong>di</strong> titoli d’istruzione, minimizzare gli<br />
scambi migratori tra <strong>di</strong> esse nonché delineare aree con specificità proprie in relazione<br />
alla storia migratoria italiana in Francia 21 :<br />
- Nord Est: Ile de France, Champagne-Ardenne, Picar<strong>di</strong>e, Bourgogne, Nord-<br />
Pas-de-Calais; Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Haute-<br />
Norman<strong>di</strong>e, Basse-Norman<strong>di</strong>e, Centre, Pays de la Loire,<br />
Bretagne,Poitou-Charentes<br />
- Sud Ovest: Aquitaine, Mi<strong>di</strong>-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Languedoc-<br />
Rouss.,<br />
- Sud Est : Rhône-Alpes, Provence Alpes Cote d’Azur, Corse;<br />
La presenza dei figli <strong>di</strong> italiani in queste macro-aree è specificata nella tavola 2.2. E’<br />
possibile osservare come il Sud-Est continui ad essere la zona con la maggior presenza<br />
<strong>di</strong> nuclei familiari immigrati dall’Italia.<br />
Figura 2.3. Sud<strong>di</strong>visione del territorio francese adottata nell’analisi.<br />
In tavola 2.3 sono elencate tutte le variabili <strong>di</strong> controllo incluse nei modelli. Per ognuna <strong>di</strong><br />
queste, si riporta la <strong>di</strong>stribuzione percentuale nel campione comple ssivo (colonna 1), l’incidenza<br />
dei vari livelli d’istruzione (colonne 2-4) e la <strong>di</strong>stribuzione nei sottogruppi definiti in base alla<br />
storia migratoria familiare (colonne 5-8).<br />
21 L’incidenza <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati, più elevata nelle regioni meri<strong>di</strong>onali della Francia (come<br />
osserveremo nelle prossime pagine), giustifica la <strong>di</strong>stinzione tra Sud e Nord. l’Ile de France è la regione<br />
<strong>di</strong> gran lunga con la più elevata presenza <strong>di</strong> persone altamente istruite e pertanto andrebbe considerata<br />
come un area a sé. Tuttavia, il forte scambio <strong>di</strong> popolazione tra questa area e le regioni a<strong>di</strong>acenti,<br />
caratteristica presente ieri come oggi (Baccaïni, 2001), ci obbliga a includere quest’area nel Nord. La<br />
<strong>di</strong>stinzione tra Sud-Est e Sud-Ovest è dovuta principalmente alla <strong>di</strong>fferenze caratterizzazione<br />
dell’immigrazione italiana nelle due aree.<br />
60
Tavola 2.2. Distribuzione geografica degli autoctono e dei figli <strong>di</strong> italiani immigrati in Francia nel<br />
campione EHF (dati pesati).<br />
Nord Sud Ovest Sud Est<br />
Autoctoni 166695 43251 39548<br />
G2 mix Ita 2082 619 1781<br />
G2 Ita 1603 401 1413<br />
G1,5 Ita 540 116 449<br />
G1 Ita 1141 219 948<br />
L’incidenza dei vari titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per coorte <strong>di</strong> nascita, rivela che il livello secondario<br />
inferiore <strong>di</strong>venta quasi universale tra gli in<strong>di</strong>vidui nati dagli anni sessanta in poi. Questo<br />
risultato, unitamente alla crescita della <strong>di</strong>ffusione anche dei titoli più elevati, rende evidente la<br />
<strong>di</strong>ffusione della scolarizzazione lungo l’ultimo secolo.<br />
In generale, tutti gli aspetti concernenti il retroterra familiare sono importanti al fine <strong>di</strong><br />
prevedere le possibilità dei figli <strong>di</strong> raggiungere un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevato. E’ più facile<br />
proseguire verso una istruzione più elevata se la classe socio-economica <strong>di</strong> appartenenza è più<br />
prestigiosa, se la <strong>di</strong>mensione familiare è ridotta, se l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> nascita è basso, se si è vissuta<br />
l’adolescenza con entrambi i genitori (tavola 2.3). L’influenza sull’istruzione <strong>di</strong> tutti questi<br />
aspetti rende evidente l’esigenza <strong>di</strong> una analisi multivariata al fine <strong>di</strong> valutare le <strong>di</strong>fferenze in<br />
termini <strong>di</strong> istruzione raggiunta.<br />
Sempre in tavola 2.3, all’interno dei singoli sottogruppi definiti in base alla storia migratoria<br />
familiare, si può notare come la <strong>di</strong>stribuzione <strong>delle</strong> coorti rivela una concentrazione <strong>delle</strong> nascite<br />
per le G1,5 all’inizio del Novecento e negli successivi la seconda guerra mon<strong>di</strong>ale, in accordo<br />
con i momenti <strong>di</strong> maggior flusso migratorio dall’Italia, mentre le nascite <strong>delle</strong> G2 sono meno<br />
<strong>di</strong>luite nel tempo, mostrando una <strong>di</strong>stribuzione non molto <strong>di</strong>ssimile da quella dell’intera<br />
popolazione, a parte il rapido calo durante gli anni Settanta.<br />
Passando alla classe socio-economica, è evidente come un secolo <strong>di</strong> flussi migratori<br />
dall’Italia, composti per lo più <strong>di</strong> lavoratori poco o per nulla qualificati, abbia comportato la<br />
considerevole sotto-rappresentazione <strong>delle</strong> classi <strong>di</strong> servizio e della prevalenza <strong>di</strong> lavoratori<br />
manuali tra le famiglie immigrate rispetto a quelle autoctone. L’incidenza della classe operaia è<br />
elevata per le G2 e soprattutto per le G1,5 mentre per le G2mix è più simile agli autoctoni. E’<br />
tuttavia interessante approfon<strong>di</strong>re l’osservazione della composizione sociale ponendo a<br />
confronto le migrazioni più antiche da quelle più recenti. Nella tavola 2.4 la <strong>di</strong>stribuzione <strong>delle</strong><br />
classi sociali per storia migratoria familiare è presentata in base a due gruppi <strong>di</strong> coorti: nati<br />
prima e dopo il 1950. La percentuale della piccola borghesia urbana e agricola è chiaramente<br />
<strong>di</strong>minuita nel tempo per tutto il campione ma in particolar modo per le famiglie <strong>delle</strong> G2 e G1,5.<br />
All’interno <strong>di</strong> questi due sottogruppi si è assistito a una crescita dei lavoratori manuali: nelle<br />
coorti nate dopo il 1950 circa due figli su tre nati da genitori italiani appartengono a questa<br />
classe; la stessa proporzione tra gli autoctoni è uno su quattro. A fronte <strong>di</strong> un aumento del peso<br />
della classe operaia tra le famiglie immigrate <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana, cresce tuttavia la componente<br />
qualificata al suo interno (tavola 2.4). In tal senso, i risultati qui mostrati confermano quanto già<br />
detto da altri autori (Milza, 1993; Bacchetta e de Azavedo, 1990).<br />
61
Tavola 2.3. Caratteristiche del campione (dati pesati). Francia, EHF 1999.<br />
Coorte <strong>di</strong> nascita<br />
Genere<br />
Classe socio-economica<br />
%<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
Campione nel complesso % <strong>di</strong>stribuzione nei sottogruppi:<br />
% almeno un<br />
titolo <strong>di</strong><br />
scuola<br />
secondaria<br />
inferiore<br />
% almeno un<br />
titolo <strong>di</strong><br />
scuola<br />
secondaria<br />
superiore<br />
62<br />
% almeno un<br />
titolo <strong>di</strong><br />
istruzione<br />
terziaria<br />
Autoct.<br />
G2mix<br />
Italia<br />
G2 Italia<br />
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)<br />
fino al 1929 15,6 32,7 14,1 6,0 16,0 10,4 18,1 33,8<br />
1930-1934 6,4 41,3 16,2 6,8 6,5 5,9 9,7 2,9<br />
1935-1939 6,2 50,2 21,9 9,9 6,2 6,5 7,3 2,7<br />
1940-1944 6,3 61,7 30,3 15,2 6,0 8,3 5,7 8,7<br />
1945-1949 9,1 70,2 35,9 18,6 9,2 10,5 6,2 14,9<br />
1950-1954 9,7 78,4 38,1 20,4 9,6 12,0 9,7 16,8<br />
1955-1959 9,7 90,5 42,6 22,8 9,6 10,2 10,3 13,5<br />
1960-1964 10,1 95,3 46,6 26,3 10,0 10,8 13,9 4,0<br />
1965-1969 9,6 96,5 50,1 32,7 9,5 9,4 9,7 1,4<br />
1970-1974 9,6 97,7 62,8 44,2 9,5 9,1 6,4 0,9<br />
1975-1979 7,9 98,4 70,6 46,8 7,8 7,0 2,9 0,5<br />
G1,5<br />
Italia<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Uomini 38,0 77,4 38,8 23,6 37,7 37,7 38,1 40,4<br />
Donne 62,0 71,5 39,0 22,1 62,3 62,3 61,9 59,6<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Classe <strong>di</strong> servizio superiore 8,7 97,1 84,4 64,2 9,0 5,4 1,4 1,0<br />
Classe <strong>di</strong> servizio inferiore 9,8 93,1 66,0 43,6 10,9 10,2 4,4 2,9<br />
Impiegati esecutivi 20,9 84,0 43,1 22,9 22,7 20,8 10,7 6,7<br />
Picola borghesia urbana 12,0 79,3 44,6 24,7 12,6 18,0 11,5 9,6<br />
Piccola borghesia agricola 14,3 48,7 20,9 10,4 17,2 6,0 7,1 8,4<br />
Lav. manuali qualificati 12,8 72,2 24,4 10,8 12,5 20,8 31,9 34,2<br />
Lav. manuali non qualificati 12,2 59,0 18,5 8,0 11,4 15,4 27,9 30,5<br />
Mancante 9,3 58,3 22,3 10,8 3,8 3,4 5,1 6,7<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Composizione familiare<br />
Figlio unico 11,1 74,0 74,0 25,4 10,0 10,3 4,3 4,3<br />
Primo <strong>di</strong> due figli 10,5 85,1 85,1 36,5 11,8 12,4 6,8 4,8<br />
Secondo <strong>di</strong> due figli 12,0 81,3 81,3 30,7 13,1 13,8 9,5 6,9<br />
Primo <strong>di</strong> tre figli 6,7 82,7 82,7 30,9 7,3 6,9 5,1 7,3<br />
Secondo <strong>di</strong> tre figli 7,0 80,2 80,2 27,1 7,6 8,0 6,9 6,1<br />
Terzo <strong>di</strong> tre figli 7,6 77,8 77,8 24,9 8,1 9,4 9,0 5,2<br />
Primo <strong>di</strong> quattro o più figli 7,5 69,1 69,1 17,6 7,1 6,3 6,2 12,5<br />
Secondo <strong>di</strong> quattro o più figli 7,8 67,8 67,8 15,7 7,6 6,8 7,8 15,9<br />
Terzo <strong>di</strong> quattro o più figli 8,0 67,5 67,5 15,3 7,6 8,0 10,5 12,6<br />
Quarto figlio o or<strong>di</strong>ne superiore 21,8 63,4 63,4 12,2 19,9 18,0 33,9 24,4<br />
Viveva con entrambi i genitori a<br />
14 anni<br />
Zona <strong>di</strong> residenza<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Sì 88,2 76,5 41,2 24,3 89,9 90,9 89,1 90,4<br />
No 11,8 52,4 21,0 10,4 10,1 9,1 10,9 9,6<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Nord 64,8 73,2 38,0 22,3 66,8 46,4 46,8 48,9<br />
Sud Ovest 17,2 73,4 39,7 22,9 17,4 13,9 11,8 10,5<br />
Sud Est 18,0 75,9 41,4 23,9 15,9 39,7 41,4 40,6<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tornando alla tavola 2.3, si osserva che la <strong>di</strong>mensione familiare è maggiore tra le G2 e G1,5<br />
Italia: la elevata percentuale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui con tre o più fratelli e sorelle per questi gruppi è<br />
testimone della più elevata fecon<strong>di</strong>tà <strong>delle</strong> donne italiane immigrate in Francia nel passato.<br />
Tavola 2.4. Incidenza <strong>delle</strong> classi socio-economiche all’interno dei sottogruppi definiti in base alla storia<br />
migratoria familiare per gruppi <strong>di</strong> coorti (dai pesati). Francia, EHF 1999.<br />
Fino al 1949<br />
1950-1979<br />
Autoctoni G2mix Italia G2 Italia G1,5 Italia<br />
Classe <strong>di</strong> servizio 12,4 10,4 4,5 3,9<br />
Impiegati esecutivi 18,7 17,1 8,3 4,3<br />
Piccola borghesia urbana 14,1 19,4 13,5 11,2<br />
Piccola borghesia agricola 25,4 8,3 11,1 12,4<br />
Lav. manuali qualificati 11,7 23,1 28,0 30,4<br />
Lav. manuali non qualificati 13,1 17,4 28,2 30,6<br />
Mancante 4,6 4,2 6,4 7,2<br />
100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Classe <strong>di</strong> servizio 25,7 19,2 7,0 3,7<br />
Impiegati esecutivi 25,9 23,4 12,8 10,5<br />
Picola borghesia urbana 11,4 17,0 9,7 6,9<br />
Piccola borghesia agricola 10,8 4,4 3,5 1,7<br />
Lav. manuali qualificati 13,1 19,2 35,4 40,9<br />
Lav. manuali non qualificati 10,1 13,9 27,7 30,6<br />
Mancante 3,1 2,8 4,0 5,6<br />
2.5 Analisi multivariata<br />
63<br />
100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Nell’analisi si è fatto uso <strong>di</strong> modelli logistici con variabile <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong>cotomica<br />
(possedere/non possedere almeno uno specifico titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o) meglio conosciuti come modelli<br />
logistici binomiali, che ben si adattano al tipo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o in questione permettendo <strong>di</strong> stimare le<br />
<strong>di</strong>fferenze tra gruppi in termini <strong>di</strong> probabilità <strong>di</strong> raggiungere almeno un particolare livello<br />
d’istruzione.<br />
In tavola 2.5 e 2.6 sono mostrati rischi relativi <strong>di</strong> raggiungere almeno un livello d’istruzione<br />
secondario superiore rispettivamente per le coorti nate prima e dopo il 1950. Vengono<br />
presentati, separatamente per genere, sia i modelli parziali (che includono solo le due variabili<br />
storia migratoria familiare e coorte <strong>di</strong> nascita), sia quelli completi ( con tutte le covariate<br />
presentate nel precedente paragrafo).<br />
I modelli parziali mostrano il sistematico svantaggio dei figli <strong>di</strong> immigrati rispetto agli<br />
autoctoni, in ogni gruppo <strong>di</strong> coorte e per ogni genere. Le <strong>di</strong>fferenze crescono passando dalle<br />
G2mix alle G2 Italia e la situazione peggiore è quella <strong>delle</strong> G1,5: un in<strong>di</strong>viduo nato in Italia<br />
dopo il 1950 e giunto in Francia durante l’infanzia con i suoi genitori, ha una probabilità<br />
<strong>di</strong>mezzata <strong>di</strong> raggiungere un <strong>di</strong>ploma secondario superiore rispetto a un autoctono. Se è nato<br />
prima del 1950 allora la probabilità <strong>di</strong>venta un terzo. Non sembrano palesarsi <strong>di</strong>fferenze degen<br />
<strong>di</strong> nota tra i due generi.
Tavola 2.5. Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o secondario superiore. Modelli <strong>di</strong><br />
regressione logistica stimati separatamente per genere. Coorti <strong>di</strong> nascita fino al 1949. Francia, EHF 1999.<br />
Uomini Donne<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 40452 1 71771 1 1<br />
G2 mix Italia 588 0,71 *** 0,68 *** 1011 0,78 *** 0,72 ***<br />
G2 Italia 487 0,54 *** 0,82 846 0,57 *** 0,81 **<br />
G1.5 Italia 220 0,29 *** 0,45 *** 340 0,40 *** 0,74 *<br />
G1 Italia 572 0,29 *** 0,44 *** 919 0,16 *** 0,25 ***<br />
G2 mix Spagna 363 0,92 0,86 558 1,11 1,18<br />
G2 Spagna 319 0,61 *** 0,92 508 0,48 *** 0,72 **<br />
G1.5 Spagna 86 0,37 *** 0,63 147 0,37 *** 0,63<br />
G1 Spagna 479 0,26 *** 0,40 *** 896 0,20 *** 0,26 ***<br />
Altro o mancante 12046 0,95 ** 1,10 *** 19860 0,98 1,02<br />
Coorte <strong>di</strong> nascita<br />
fino al 1929 16664 1 1 36109 1 1<br />
1930-1934 8458 1,03 1,05 14230 1,22 *** 1,25 ***<br />
1935-1939 8534 1,44 *** 1,53 *** 13692 1,82 *** 1,91 ***<br />
1940-1944 8997 2,09 *** 2,12 *** 13490 2,96 *** 3,11 ***<br />
1945-1949 12959 2,42 *** 2,42 *** 19335 4,03 *** 4,29 ***<br />
Classe socio -economica<br />
Classe <strong>di</strong> servizio superiore 3282 1 4975 1<br />
Classe <strong>di</strong> servizio inferiore 3276 0,25 *** 5398 0,27 ***<br />
Impiegati esecutivi 9719 0,11 *** 16946 0,12 ***<br />
Picola borghesia urbana 7478 0,13 *** 12881 0,15 ***<br />
Piccola borghesia agricola 12681 0,03 *** 22386 0,04 ***<br />
Lav. manuali qualificati 6678 0,04 *** 11366 0,05 ***<br />
Lav. manuali non qualificati 7510 0,03 *** 13791 0,03 ***<br />
Mancante<br />
Composizione familiare<br />
4988 0,04 *** 9113 0,07 ***<br />
Figlio unico 6837 1 12575 1<br />
Primo <strong>di</strong> due figli 5243 1,06 8474 1,06<br />
Secondo <strong>di</strong> due figli 6266 0,96 10598 0,88 ***<br />
Primo <strong>di</strong> tre figli 3492 0,87 *** 5672 0,87 ***<br />
Secondo <strong>di</strong> tre figli 3512 0,78 *** 5927 0,80 ***<br />
Terzo <strong>di</strong> tre figli 3789 0,73 *** 6827 0,77 ***<br />
Primo <strong>di</strong> quattro o più figli 4942 0,70 *** 8274 0,73 ***<br />
Secondo <strong>di</strong> quattro o più figli 4842 0,57 *** 8453 0,59 ***<br />
Terzo <strong>di</strong> quattro o più figli 4709 0,52 *** 8077 0,53 ***<br />
Quarto figlio o or<strong>di</strong>ne superiore 11980<br />
Viveva con entrambi i gen. a 14 anni<br />
0,48 *** 21979 0,46 ***<br />
Sì 46252 1 79606 1<br />
No 9360 0,63 *** 17250 0,69 ***<br />
Zona <strong>di</strong> residenza<br />
Nord 36579 1 62075 1<br />
Sud Ovest 10642 1,15 *** 19512 1,23 ***<br />
Sud Est 8391 1,23 *** 15269 1,29 ***<br />
Costante<br />
0,25 *** 3,76 *** 0,14 *** 1,78 ***<br />
Casi totali 55612 96856<br />
-2 loglikelihood 60028 49802 90046 76043<br />
R2 Cox and Snell 0,033 0,201 0,056 0,186<br />
R2 Nagelkerk 0,049 0,294 0,089 0,293<br />
Significatività statistica: ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
64
Tavola 2.6. Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o secondario superiore. Modelli <strong>di</strong><br />
regressione logistica stimati separatamente per genere. Coorti <strong>di</strong> nascita 1950-79. Francia, EHF 1999.<br />
Uomini Donne<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 56628 1 1 87228 1 1<br />
G2 mix Italia 939 0,82 *** 0,88 * 1542 0,94 1,01<br />
G2 Italia 694 0,69 *** 1,25 *** 1085 0,63 *** 1,14 **<br />
G1.5 Italia 160 0,55 *** 1,16 211 0,49 *** 0,82<br />
G1 Italia 116 0,96 1,59 *** 171 1,02 1,15<br />
G2 mix Spagna 586 0,90 0,94 911 1,08 1,09<br />
G2 Spagna 445 0,74 *** 1,33 *** 672 0,90 1,56 ***<br />
G1.5 Spagna 178 0,39 *** 0,67 ** 285 0,52 *** 0,98<br />
G1 Spagna 79 0,46 *** 0,77 192 0,81 0,98<br />
Altro o mancante 18819 0,94 *** 1,25 *** 28568 0,75 *** 0,96 ***<br />
Coorte <strong>di</strong> nascita<br />
1950-1954 13825 1 1 21132 1 1<br />
1955-1959 13758 1,2 *** 1,11 *** 21365 1,26 *** 1,28 ***<br />
1960-1964 14321 1,21 *** 1,08 *** 21886 1,57 *** 1,51 ***<br />
1965-1969 13541 1,42 *** 1,17 *** 20897 1,78 *** 1,53 ***<br />
1970-1974 12929 2,34 *** 1,83 *** 19947 3,05 *** 2,48 ***<br />
1975-1979 10270 3,03 *** 2,24 *** 15638 4,73 *** 3,73 ***<br />
Classe socio -economica<br />
Classe <strong>di</strong> servizio superiore 7675 1 11944 1<br />
Classe <strong>di</strong> servizio inferiore 10057 0,32 *** 15769 0,35 ***<br />
Impiegati esecutivi 19280 0,14 *** 29690 0,15 ***<br />
Picola borghesia urbana 8709 0,19 *** 13610 0,20 ***<br />
Piccola borghesia agricola 7730 0,12 *** 11566 0,14 ***<br />
Lav. manuali qualificati 11172 0,07 *** 17090 0,08 ***<br />
Lav. manuali non qualificati 8771 0,07 *** 13930 0,07 ***<br />
Mancante<br />
Composizione familiare<br />
5250 0,07 *** 7266 0,07 ***<br />
Figlio unico 6837 1 10195 1<br />
Primo <strong>di</strong> due figli 9608 1,20 *** 14571 1,12 ***<br />
Secondo <strong>di</strong> due figli 10264 0,89 *** 15373 0,91 ***<br />
Primo <strong>di</strong> tre figli 6258 0,96 9264 0,90 ***<br />
Secondo <strong>di</strong> tre figli 6431 0,77 *** 9668 0,72 ***<br />
Terzo <strong>di</strong> tre figli 6793 0,73 *** 10263 0,70 ***<br />
Primo <strong>di</strong> quattro o più figli 5095 0,62 *** 8063 0,56 ***<br />
Secondo <strong>di</strong> quattro o più figli 5631 0,54 *** 8664 0,48 ***<br />
Terzo <strong>di</strong> quattro o più figli 6062 0,54 *** 9578 0,45 ***<br />
Quarto figlio o or<strong>di</strong>ne superiore 15665<br />
Viveva con entrambi i gen. a 14 anni<br />
0,45 *** 25226 0,38 ***<br />
Sì 73277 1 112787 1<br />
No 5367 0,65 *** 8078 0,67 ***<br />
Zona <strong>di</strong> residenza<br />
Nord 54204 1 80820 1<br />
Sud Ovest 13472 1,07 *** 21889 1,12 ***<br />
Sud Est 10968 1,05 ** 18156 1,19 ***<br />
Costante<br />
0,61 *** 5,79 *** 0,69 *** 6,58 ***<br />
Casi totali 78644 120865<br />
-2 loglikelihood 105639 92505 156436 136634<br />
R2 Cox and Snell 0,039 0,187 0,062 0,206<br />
R2 Nagelkerk 0,052 0,249 0,082 0,275<br />
Significatività statistica : ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
65
Per i figli <strong>di</strong> immigrati dalla Spagna, i risultati sono in linea <strong>di</strong> massima molto simili. Fanno<br />
eccezione le G2mix Spagna che non mostrano svantaggi significativi, le G1 Spagna che<br />
continuano a mostrare bassi livelli d’istruzione anche nelle coorti più recenti e una maggiore<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> genere, a favore degli uomini nelle coorti più anziane e <strong>delle</strong> donne in quelle nate<br />
dopo il 1950.<br />
La minore propensione a proseguire gli stu<strong>di</strong> oltre l’obbligo da parte dei figli <strong>di</strong> immigrati<br />
per le coorti più anziane è confermata anche nei modelli completi ottenuti con l’introduzione <strong>di</strong><br />
tutte le covariate presentate (tavola 2.5). Tra le donne, i figli <strong>di</strong> immigrati italiani hanno un gap<br />
negativo pari a circa il 25% per le G2 e al 37% per G1,5 e G2mix; tra gli uomini lo svantaggio<br />
è simile per G2 e G2mix ma cresce fino al 120% per le G1,5 22 .<br />
Le stime nei modelli completi relativi alle coorti nate dopo il 1950, vanno nella <strong>di</strong>rezione<br />
opposta (tavola 2.6): a parità <strong>di</strong> altre con<strong>di</strong>zioni i figli <strong>di</strong> immigrati italiani non solo non<br />
mostrano più particolari <strong>di</strong>fficoltà ma ad<strong>di</strong>rittura tendono a superare le performance degli<br />
autoctoni, eccetto le G2mix maschili che confermano qualche <strong>di</strong>fficoltà. Tra le G2, gli uomini<br />
hanno il 25% e le donne il 14% <strong>di</strong> probabilità in più <strong>di</strong> ottenere un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o secondario<br />
superiore rispetto agli autoctoni. Per le G1,5, appare una <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> genere: gli uomini sono<br />
in linea con gli autoctoni mentre le donne restano al <strong>di</strong> sotto.<br />
Nel complesso, appare dunque un forte effetto coorte. I figli <strong>delle</strong> ondate <strong>di</strong> emigrazione<br />
dall’Italia più antiche mostrano <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fficoltà che non sembrano essere strettamente legate alla<br />
<strong>di</strong>versa composizione socio-economica tra famiglie immigrate e non. A tal proposito vale la<br />
pena sottolineare che sebbene dall’inizio del novecento la legislazione francese in materia <strong>di</strong><br />
istruzione parificava gli stranieri agli autoctoni e ammetteva i loro figli nelle scuole francesi e<br />
all’insegnamento gratuito, spesso non ci si curava <strong>di</strong> controllare se l’obbligo della frequenza<br />
fosse rispettato per i ragazzi tra i 6 e i 13 anni e viste le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita molto spesso <strong>di</strong>sagiate<br />
e <strong>di</strong> povertà dei figli degli italiani, non <strong>di</strong> rado i loro figli rinunciavano all’istruzione (Tosi,<br />
1988, pag. 191-192). Ad ogni modo, gli italiani giunti in Francia nella prima metà del<br />
Novecento, hanno senza dubbio affrontato <strong>di</strong>fficoltà se non vera e propria <strong>di</strong>scriminazione che,<br />
ostacolando l’integrazione nella società francese, possono essere state trasmesse ai figli<br />
influenzandone il livello d’istruzione. Al contrario, gli in<strong>di</strong>vidui che hanno preso parte alle<br />
ultime gran<strong>di</strong> ondate migratorie dall’Italia hanno vissuto con<strong>di</strong>zioni migliori, sono stati accolti<br />
meglio e al loro processo <strong>di</strong> integrazione è stato più rapido: in un contesto favorevole, le<br />
<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> italiani, nate e cresciute in Francia, raggiungono risultati ad<strong>di</strong>rittura<br />
migliori degli autoctoni nel sistema scolastico e universitario d’oltralpe.<br />
Le G2 spagnole rivelano comportamenti simili a quelli visti per chi è originario dall’Italia,<br />
mostrando alcuni svantaggi per le coorti più anziane ma performance particolarmente elevate tra<br />
chi è nato dopo il 1950, soprattutto tra le donne, così come era già stato fatto notare da Tribalat<br />
(1995).<br />
22 Queste percentuali sono ottenute come 1/Exp(B).<br />
66
Tavola 2.7 Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o terziario. Modelli <strong>di</strong> regressione<br />
logistica stimati separatamente per genere. Coorti <strong>di</strong> nascita fino al 1949. Francia, EHF 1999.<br />
Uomini Donne<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 40452 1 1 71771 1 1<br />
G2 mix Italia 588 0,63 *** 0,66 *** 1011 0,64 *** 0,64 ***<br />
G2 Italia 487 0,50 *** 0,83 846 0,47 *** 0,74 *<br />
G1.5 Italia 220 0,22 *** 0,36 *** 340 0,23 *** 0,51 **<br />
G1 Italia 572 0,36 *** 0,58 *** 919 0,21 *** 0,37 ***<br />
G2 mix Spagna 363 0,72 * 0,71 * 558 0,76 0,86<br />
G2 Spagna 319 0,47 *** 0,74 508 0,36 *** 0,61 *<br />
G1.5 Spagna 86 0,29 ** 0,54 147 0,79 1,71<br />
G1 Spagna 479 0,36 *** 0,62 ** 896 0,21 *** 0,33 ***<br />
Altro o mancante 12046 1,05 * 1,21 *** 19860 1,11 *** 1,16 ***<br />
Coorte <strong>di</strong> nascita<br />
fino al 1929 16664 1 1 36109 1 1<br />
1930-1934 8458 0,98 0,98 14230 1,21 *** 1,20 ***<br />
1935-1939 8534 1,36 *** 1,39 *** 13692 1,95 *** 1,91 ***<br />
1940-1944 8997 1,97 *** 1,86 *** 13490 3,54 *** 3,37 ***<br />
1945-1949 12959 2,31 *** 2,16 *** 19335 4,78 *** 4,51 ***<br />
Classe socio -economica<br />
Classe <strong>di</strong> servizio superiore 3282 1 4975 1<br />
Classe <strong>di</strong> servizio inferiore 3276 0,29 *** 5398 0,34 ***<br />
Impiegati esecutivi 9719 0,13 *** 16946 0,14 ***<br />
Picola borghesia urbana 7478 0,17 *** 12881 0,17 ***<br />
Piccola borghesia agricola 12681 0,04 *** 22386 0,06 ***<br />
Lav. manuali qualificati 6678 0,05 *** 11366 0,04 ***<br />
Lav. manuali non qualificati 7510 0,04 *** 13791 0,03 ***<br />
Mancante<br />
Composizione familiare<br />
4988 0,06 *** 9113 0,08 ***<br />
Figlio unico 6837 1 12575 1<br />
Primo <strong>di</strong> due figli 5243 1,11 ** 8474 1,09 *<br />
Secondo <strong>di</strong> due figli 6266 1,01 10598 0,86 ***<br />
Primo <strong>di</strong> tre figli 3492 1,01 5672 0,89 **<br />
Secondo <strong>di</strong> tre figli 3512 0,91 5927 0,76 ***<br />
Terzo <strong>di</strong> tre figli 3789 0,78 *** 6827 0,81 ***<br />
Primo <strong>di</strong> quattro o più figli 4942 0,83 *** 8274 0,84 ***<br />
Secondo <strong>di</strong> quattro o più figli 4842 0,66 *** 8453 0,67 ***<br />
Terzo <strong>di</strong> quattro o più figli 4709 0,66 *** 8077 0,63 ***<br />
Quarto figlio o or<strong>di</strong>ne superiore 11980<br />
Viveva con entrambi i genitori a 14 anni<br />
0,55 *** 21979 0,52 ***<br />
Sì 46252 1 79606 1<br />
No 9360 0,65 *** 17250 0,73 ***<br />
Zona <strong>di</strong> residenza<br />
Nord 36579 1 62075 1<br />
Sud Ovest 10642 1,03 19512 1,10 ***<br />
Sud Est 8391 1,12 *** 15269 1,14 ***<br />
Costante<br />
0,12 *** 1,24 *** 0,04 *** 0,40 ***<br />
Tot cases 55612 96856<br />
-2 loglikelihood 43867 36790 50895 43095<br />
R2 Cox and Snell 0,020 0,120 0,034 0,110<br />
R2 Nagelkerk 0,036 0,249 0,078 0,254<br />
Significatività statistica : ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
67
Tavola 2.8. Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o terziario. Modelli <strong>di</strong> regressione<br />
logistica stimati separatamente per genere. Coorti <strong>di</strong> nascita 1950-79. Francia, EHF 1999.<br />
Uomini Donne<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 49294 1 1 76150 1 1<br />
G2 mix Italia 829 0,70 *** 0,76 *** 1365 0,81 *** 0,89 *<br />
G2 Italia 656 0,68 *** 1,26 ** 1023 0,55 *** 1,06<br />
G1.5 Italia 160 0,38 *** 0,85 207 0,51 *** 0,96<br />
G1 Italia 114 1,03 1,68 ** 160 1,43 ** 1,68 ***<br />
G2 mix Spagna 509 0,86 0,93 795 1,07 1,11<br />
G2 Spagna 413 0,73 *** 1,43 *** 618 0,78 ** 1,48 ***<br />
G1.5 Spagna 178 0,25 *** 0,47 ** 281 0,45 *** 0,96<br />
G1 Spagna 78 0,41 ** 0,77 181 1,16 1,55 **<br />
Altro o mancante 16143 1,00 1,26 *** 24447 0,81 *** 1,01<br />
Coorte <strong>di</strong> nascita<br />
1950-1954 13825 1 1 21132 1 1<br />
1955-1959 13758 1,10 *** 1,08 ** 21365 1,19 *** 1,18 ***<br />
1960-1964 14321 1,26 *** 1,11 *** 21886 1,49 *** 1,39 ***<br />
1965-1969 13541 1,64 *** 1,36 *** 20897 2,08 *** 1,80 ***<br />
1970-1974 12929 2,49 *** 1,94 *** 19947 3,55 *** 2,94 ***<br />
Classe socio -economica<br />
Classe <strong>di</strong> servizio superiore 6377 1 9876 1<br />
Classe <strong>di</strong> servizio inferiore 8245 0,38 *** 12946 0,39 ***<br />
Impiegati esecutivi 16193 0,16 *** 25184 0,16 ***<br />
Picola borghesia urbana 7715 0,24 *** 12055 0,23 ***<br />
Piccola borghesia agricola 7295 0,13 *** 10871 0,17 ***<br />
Lav. manuali qualificati 9881 0,08 *** 15270 0,09 ***<br />
Lav. manuali non qualificati 7974 0,08 *** 12575 0,07 ***<br />
Mancante<br />
Composizione familiare<br />
4694 0,09 *** 6450 0,09 ***<br />
Figlio unico 5741 1 8618 1<br />
Primo <strong>di</strong> due figli 7795 1,13 *** 11749 1,11 ***<br />
Secondo <strong>di</strong> due figli 8292 0,91 ** 12481 0,91 ***<br />
Primo <strong>di</strong> tre figli 5216 1,00 7751 0,94 *<br />
Secondo <strong>di</strong> tre figli 5414 0,78 *** 8136 0,79 ***<br />
Terzo <strong>di</strong> tre figli 5865 0,77 *** 8902 0,76 ***<br />
Primo <strong>di</strong> quattro o più figli 4604 0,64 *** 7206 0,59 ***<br />
Secondo <strong>di</strong> quattro o più figli 5130 0,61 *** 7858 0,53 ***<br />
Terzo <strong>di</strong> quattro o più figli 5599 0,57 *** 8854 0,48 ***<br />
Quarto figlio o or<strong>di</strong>ne superiore 14718<br />
Viveva con entrambi i genitori a 14 anni<br />
0,49 *** 23672 0,41 ***<br />
Sì 63459 1 97853 1<br />
No 4915 0,66 *** 7374 0,71 ***<br />
Zona <strong>di</strong> residenza<br />
Nord 47160 1 70526 1<br />
Sud Ovest 11570 0,94 ** 18824 1,06 ***<br />
Sud Est 9644 1,00 15877 1,12 ***<br />
Costante<br />
0,27 *** 1,99 *** 0,27 *** 1,88 ***<br />
Tot cases 68374 105227<br />
-2 loglikelihood 78216 68356 120304 104792<br />
R2 Cox and Snell 0,020 0,157 0,044 0,179<br />
R2 Nagelkerk 0,035 0,226 0,063 0,254<br />
Significatività statistica : ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
68
Un risultato inatteso è il sistematico svantaggio <strong>delle</strong> G2mix rispetto alle G2, sia per i nuclei<br />
familiari d’<strong>origine</strong> italiana che spagnola tra le coorti nate dopo il 1950. La maggiore prossimità<br />
culturale data dal fatto <strong>di</strong> avere un genitore francese, non si traduce in un vantaggio rispetto alle<br />
altre categorie <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> immigrati. Per gli immigrati <strong>di</strong>retti dall’Italia (Generazione 1), gli odds<br />
ratio evidenziano i cambiamenti intervenuti nel tempo nella tipologia degli emigrati e<br />
l’incremento del livello d’istruzione posseduto dalle più recenti ondate migratorie verso la<br />
Francia.<br />
I rischi relativi per le altre covariate inserite nei modelli presentati nelle tavola 2-5 e 2.6,<br />
forniscono in<strong>di</strong>cazioni in linea con le aspettative. L’effetto coorte mostra un trend crescente <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati lungo il XX secolo, particolarmente intenso per le donne. La<br />
classe socio-economica <strong>di</strong> appartenenza è un fattore fondamentale nella carriera scolastica sia<br />
per gli uomini che per le donne. Considerando la classe <strong>di</strong> servizio superiore come riferimento,<br />
la probabilità per le altri classi è enormemente inferiore, sebbene nel passato più recente<br />
l’effetto sembra essere <strong>di</strong>minuito: per le coorti nate dopo il 1950, i figli <strong>di</strong> genitori della classe<br />
<strong>di</strong> servizio superiore mostrano una probabilità <strong>di</strong> continuare i loro stu<strong>di</strong> almeno fino<br />
all’ottenimento <strong>di</strong> un titolo secondario superiore 14 volte superiore a quella dei pari età figli <strong>di</strong><br />
lavoratori manuali non qualificati; per le coorti precedenti lo stesso rapporto arriva a 30. La<br />
composizione familiare, in termini <strong>di</strong> numero <strong>di</strong> fratelli/sorelle e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> nascita, rivela un<br />
altro risultato interessante: entrambe le <strong>di</strong>mensioni sono importanti e una elevata significatività<br />
statistica supporta l’effetto negativo sull’istruzione dato dall’avere una famiglia numerosa e<br />
fratelli e sorelle più anziani, effetto che <strong>di</strong>venta particolarmente chiaro nelle famiglie con tre o<br />
più figli. L’importanza <strong>di</strong> vivere con entrambi i genitori durante l’infanzia è confermata dalle<br />
stime dei modelli e resta valida per ogni genere e coorte. Come ci aspettavamo, la probabilità <strong>di</strong><br />
proseguire negli stu<strong>di</strong> è più bassa nell’area Nord della Francia ma le <strong>di</strong>fferenze tra aree tendono<br />
a ridursi nelle coorti più giovani.<br />
In generale, tutte le variabili incluse nei modelli esercitano un effetto significativo sulla<br />
variabile <strong>di</strong>pendente. Di conseguenza, tutte costituiscono un controllo statistico utile a valutare<br />
le <strong>di</strong>fferenze tra autoctoni e la seconda generazione.<br />
Focalizzando sulle probabilità <strong>di</strong> raggiungere un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o universitario o simile, i<br />
risultati non cambiano nella loro sostanza (tavole 2.7 e 2.8). Al più si può notare che nel livello<br />
terziario aumentano le <strong>di</strong>fficoltà per le coorti meno giovani, specialmente per gli uomini <strong>delle</strong><br />
G1,5 e per tutti i tre sottogruppi <strong>di</strong> donne figlie <strong>di</strong> immigrati, mentre per le coorti 1950-79 le<br />
donne appartenenti alle G2 Italia non mostrano più un vantaggio ma rimangono in linea con gli<br />
autoctoni. Gli effetti <strong>delle</strong> altre covariate rimangono sostanzialmente simili a quelli visti nelle<br />
tavole 2.5 e 2.6.<br />
Nei modelli visti finora sono stati analizzati congiuntamente in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> classe sociale e<br />
area geografica <strong>di</strong>versa. Di certo la regressione logistica ci permette <strong>di</strong> tenere sotto controllo<br />
l’effetto <strong>di</strong> queste variabili nel valutare la relazione tra le due variabili d’interesse (livello<br />
d’istruzione e storia migratoria familiare) ma, nei rischi relativi, alcuni effetti <strong>di</strong> compensazione<br />
potrebbe nascondere altri interessanti risultati. Il prossimo passo dell’analisi consiste nello<br />
sviluppare <strong>di</strong>versi modelli logistici per alcuni sottogruppi identificati in base alla classe sociale e<br />
69
all’area geografica. Ci concentreremo solo sull’effetto della variabile storia migratoria familiare,<br />
omettendo la lettura degli effetti forniti dalle covariate <strong>di</strong> controllo se questi non mostrano<br />
nuove peculiarità rispetto a quelle già viste. D’ora in poi, tutte le stime provengono da modelli<br />
che includono tutte le covariate (modelli completi).<br />
2.5.1 L’interazione tra la storia migratoria familiare e la classe socio -economica.<br />
All’interno del sottoinsieme campio nario composto esclusivamente da in<strong>di</strong>vidui appartenenti<br />
alla classe <strong>di</strong> servizio, le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> italiane mostrano un minore successo nelle scuole<br />
francesi rispetto agli autoctoni (tavola 2.9). Lo svantaggio, particolarmente intenso per le coorti<br />
più anziane, permane anche in quelle nate dopo il 1950, quantunque perda <strong>di</strong> significatività per<br />
le G2 Italia. Se nelle classi me<strong>di</strong>e (impiegati esecutivi, piccola borghesia urbana e agricola) le<br />
<strong>di</strong>fferenze tra figli <strong>di</strong> immigrati italiani e autoctoni si assottigliano, il risultato più sorprendente<br />
emerge tra gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> estrazione operaia nate dopo il 1950: G2mix e G2 mostrano<br />
rispettivamente un vantaggio del 32% e del 42% nella probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un livello<br />
secondario superiore in confronto con gli autoctoni. Questi risultati sono supportati da una<br />
elevata significatività statistica (tavola 2.9).<br />
Limitando l’attenzione alla probabilità <strong>di</strong> possedere un livello d’istruzione terziario, le<br />
<strong>di</strong>fferenze all’interno dei vari segmenti sociali risultano rafforzate (tavola 2.10). Lo svantaggio<br />
<strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> italiani all’interno <strong>delle</strong> classi più elevate è ora particolarmente<br />
evidente sia in termini <strong>di</strong> intensità che <strong>di</strong> significatività, sia per le vecchie che per le nuove<br />
coorti. Tra i figli <strong>di</strong> lavoratori manuali, la situazione si capovolge: se per le coorti più anziane<br />
non appaiono <strong>di</strong>fferenze significative (tranne che per le G1,5), è tra le coorti nate nella seconda<br />
metà del XX secolo che si palesa un vantaggio significativo per ogni sottogruppo <strong>di</strong> <strong>origine</strong><br />
italiana, superiore ad<strong>di</strong>rittura del 60% nel caso <strong>delle</strong> G2.<br />
Riepilogando, le <strong>di</strong>fferenze tra figli <strong>di</strong> immigrati italiani e autoctoni emergono in due mo<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>versi in base allo specifico segmento sociale d’appartenenza. Questo aspetto è particolarmente<br />
evidente per le coorti nate dopo il 1950 che mostrano un cambiamento <strong>di</strong> segno <strong>delle</strong> relazioni<br />
nel passaggio tra classi <strong>di</strong> servizio e classi operaie. Questa tipo <strong>di</strong> relazioni vale anche per i figli<br />
<strong>di</strong> immigrati dalla Spagna.<br />
Data l’enorme effetto della classe sociale <strong>di</strong> <strong>origine</strong> sull’istruzione, i risultati appena<br />
presentati non sembrano indurre al pessimismo. Infatti, percorsi <strong>di</strong> assimilazione verso il basso<br />
(Portes, 1995) tendono a manifestarsi proprio nelle classi sociali meno agiate e il constatare che<br />
al loro interno, le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> riescano meglio degli autoctoni, non lascia presumere<br />
una forte incidenza <strong>di</strong> percorsi <strong>di</strong> assimilazione svantaggiati per i figli <strong>di</strong> italiani. Questo<br />
risultato potrebbe essere collegato alla maggior presenza <strong>di</strong> lavoratori qualificati nei flussi partiti<br />
dall’Italia dopo la seconda guerra mon<strong>di</strong>ale. Non è tuttavia da escludere l’effetto benefico <strong>di</strong> una<br />
accresciuta sensibilità verso lo strumento istruzione e dal desiderio <strong>di</strong> una ascesa sociale<br />
particolarmente intens i nelle famiglie immigrate.<br />
70
Tavola 2.9 Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o secondario superiore. Modelli <strong>di</strong><br />
regressione logistica stimati separatamente per coorte <strong>di</strong> nascita (nati prima e dopo il 1950) e per classe<br />
socio-economica. Francia, EHF 1999.<br />
Classi <strong>di</strong> servizio (inferiore e<br />
superiore)<br />
Cooorti<br />
fino al 1949<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
Piccola borghesia urbana e<br />
agricola; impiegati esecutivi<br />
Cooorti<br />
fino al 1949<br />
71<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
Lavoratori manuali<br />
(qualificati e non)<br />
Cooorti<br />
fino al 1949<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 12932 1 34712 1 66940 1 70729 1 27842 1 34205 1<br />
G2 mix Italia 176 0,47 *** 480 0,79 ** 695 0,78 *** 1074 0,85 *** 662 0,75 ** 864 1,32 ***<br />
G2 Italia 64 0,58 ** 112 0,75 427 0,83 459 0,99 769 0,81 1140 1,42 ***<br />
G1.5 Italia 20 - 14 - 144 0,77 65 0,65 * 356 0,64 ** 275 1,25<br />
G1 It alia 61 0,43 *** 35 1,98 705 0,24 *** 112 0,90 611 0,48 *** 125 1,85 ***<br />
G2 mix Spagna 76 1,26 310 0,90 429 0,80 * 699 0,86 * 379 1,18 445 1,46 ***<br />
G2 Spagna 34 0,54 59 1,10 262 0,66 ** 369 0,94 483 1,15 647 2,01 ***<br />
G1.5 Spagna 8 - 18 - 69 0,69 104 0,62 ** 133 0,67 325 1,26 *<br />
G1 Spagna 68 0,47 *** 24 16,4 580 0,30 *** 113 0,91 591 0,24 *** 114 0,68<br />
Altro o mancante 3492 1,18 *** 9681 1,12 *** 11840 1,15 *** 16861 1,05 *** 7519 1,00 12823 1,16 ***<br />
Significatività statistica : ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
L’odds ratio non è mostrato se la numerosità del sottogruppo considerato è costituito da meno <strong>di</strong> 30 casi.<br />
Altre variabili incluse nei modelli: coorte <strong>di</strong> nascita, genere, classe socio-economica, composizione familiare, viveva con i genitori fino ai 14 anni, zona <strong>di</strong> residenza. Per i<br />
modelli complete con le stime per tutte le covariate, si veda in tavola A.1 in Appen<strong>di</strong>ce.<br />
Tavola 2.10. Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o terziario. Modelli <strong>di</strong><br />
regressione logistica stimati separatamente per coorte <strong>di</strong> nascita (nati prima e dopo il 1950) e per classe<br />
socio-economica. Francia, EHF 1999.<br />
Classi <strong>di</strong> servizio (inferiore e<br />
superiore)<br />
Cooorti<br />
fino al 1949<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
Piccola borghesia urbana e<br />
agricola; impiegati esecutivi<br />
Cooorti<br />
fino al 1949<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
Lavoratori manuali<br />
(qualificati e non)<br />
Cooorti<br />
fino al 1949<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 12932 1 28614 1 66940 1 62134 1 27842 1 30991 1<br />
G2 mix Italia 176 0,43 *** 397 0,67 *** 695 0,78 ** 942 0,79 *** 662 0,73 801 1,28 **<br />
G2 Italia 64 0,60 * 100 0,52 *** 427 0,69 * 419 0,89 769 1,12 1095 1,61 ***<br />
G1.5 Italia 20 - 12 - 144 0,75 65 0,45 ** 356 0,29 *** 273 1,44 **<br />
G1 Italia 61 0,69 35 2,91 *** 705 0,35 *** 102 1,16 611 0,55 * 122 1,83 **<br />
G2 mix Spagna 76 0,61 * 243 0,88 429 0,74 610 0,98 379 1,11 414 1,54 ***<br />
G2 Spagna 34 0,28 ** 52 0,65 262 0,80 329 1,32 ** 483 0,93 611 1,85 ***<br />
G1.5 Spagna 8 - 18 - 69 2,02 * 103 0,66 133 0,67 322 1,16<br />
G1 Spagna 68 0,51 * 19 - 580 0,45 *** 109 1,23 591 0,32 *** 112 1,03<br />
Altro o mancante 3492 1,26 *** 7954 1,12 *** 11840 1,26 *** 14500 1,08 *** 7519 1,16 ** 10959 1,24 ***<br />
Significatività statistica : ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
L’odds ratio non è mostrato se la numerosità del sottogruppo considerato è costituito da meno <strong>di</strong> 30 casi.<br />
Altre variabili incluse nei modelli: coorte <strong>di</strong> nascita, genere, classe socio-economica, composizione familiare, viveva con i genitori fino ai 14 anni, zona <strong>di</strong> residenza. Per i<br />
modelli complete con le stime per tutte le covariate, si veda in tavola A.2 in Appen<strong>di</strong>ce.<br />
Un ulteriore risultato che emerge dall’analisi riguarda la minore influenza della classe sociale<br />
sulle opportunità educative tra i figli <strong>di</strong> immigrati. Questo aspetto, pur desumibile da quanto già<br />
mostrato, <strong>di</strong>viene tuttavia evidente considerando l’interazione tra la variabile storia migratoria<br />
familiare e classe socio-economica. Presa la classe operaia come gruppo <strong>di</strong> riferimento (odds<br />
ratio pari a 1), la figura 2.3 mostra la probabilità <strong>di</strong> ottenere un livello d’istruzione secondaria
superiore per gli altri due gruppi <strong>di</strong> classi socio-economiche (classi centrali e classi <strong>di</strong> servizio)<br />
separatamente per gli autoctoni, le G2mix e le G2 Italia.<br />
Figura 2.3. Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere un almeno un titolo d’istruzione secondaria superiore.<br />
Modelli logistici. Intera zione tra classe socio-economica e categoria definita in base alla storia migatoria<br />
familiare.<br />
a) Coorti fino al 1949.<br />
15<br />
13<br />
11<br />
9<br />
7<br />
5<br />
3<br />
1<br />
-1<br />
classe operaia classi centrali classe <strong>di</strong><br />
servizio<br />
b) Coorti 1950-1979<br />
15<br />
13<br />
11<br />
9<br />
7<br />
5<br />
3<br />
1<br />
-1<br />
classe operaia classi centrali classe <strong>di</strong><br />
servizio<br />
72<br />
Autoctoni<br />
G2 Mix Italia<br />
G2 Italia<br />
Autoctoni<br />
G2 Mix Italia<br />
G2 Italia<br />
Altre variabili incluse nel modello: coorte <strong>di</strong> nascita, genere, composizione familiare, viveva con entrambi i genitori a 14 anni, zona <strong>di</strong> residenza.<br />
Tutte le stime e le relative significatività statistiche possono essere lette in tavola A.3 dell’appen<strong>di</strong>ce.<br />
Tra le coorti più anziane, la <strong>di</strong>fferenza tra classi è molto marcata: tra le G2mix la probabilità <strong>di</strong><br />
ottenere un titolo secondario superiore è cinque volte più elevata per le classi <strong>di</strong> servizio rispetto<br />
a quella operaia, lo stesso rapporto <strong>di</strong>venta <strong>di</strong> sette volte per le G2 e <strong>di</strong> ben 12 volte per gli<br />
autoctoni (grafico 2a). Tra le coorti più giovani le <strong>di</strong>fferenze tra le classi e tra i gruppi definiti in<br />
base alla storia familiare si riducono, quantunque continui a essere quello degli autoctoni il<br />
gruppo nel quale si esplicano le maggiori <strong>di</strong>fferenze tra classi.<br />
Questo interessante risultato rende esplicita la maggiore capacità da parte <strong>delle</strong> famiglie<br />
immigrate <strong>di</strong> sopperire a risorse limitate senza per questo privare i propri figli <strong>di</strong> una adeguata<br />
istruzione.
2.5.2 Differenze nei risultati scolastici nelle <strong>di</strong>verse aree <strong>di</strong> residenza<br />
Nel tentativo <strong>di</strong> valutare se le <strong>di</strong>fferenze tra figli <strong>di</strong> immigrati e non sono omogenee all’interno<br />
della Francia o se invece vi sono <strong>delle</strong> peculiarità legate al territorio, sono stati stimati dei<br />
modelli per ogni macroarea preservando la consueta <strong>di</strong>fferenziazione tra gruppi <strong>di</strong> coorti nati<br />
prima e dopo il 1950 (tavole 2.11 e 2.12).<br />
Per le coorti meno giovani, qualunque titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o si consideri, è il Sud Est l’area dove si<br />
evidenziano le maggiori <strong>di</strong>fficoltà dei figli <strong>di</strong> immigrati italiani. Nel resto del paese le relazioni<br />
sono meno esplicite e raramente la significatività statistica è tale da poter trarre <strong>delle</strong><br />
conclusioni. Ma la vera sorpresa è che nel Sud-Est a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto accade per la Francia<br />
nel complesso, anche nelle coorti nate nella seconda metà del XX secolo le <strong>di</strong>fferenze tra figli <strong>di</strong><br />
immigrati italiani e autoctoni, seppur ridotte rispetto alle coorti precedenti, restano<br />
significativamente a vantaggio <strong>di</strong> questi ultimi. Mostrano invece un gap positivo le G2 nel Nord<br />
(odds ratio pari a 1,46 e 1,38 per la probabilità <strong>di</strong> raggiungere rispettivamente almeno un titolo<br />
secondario superiore e uno terziario).<br />
Tavola 2.11. Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o secondario superiore. Modelli<br />
<strong>di</strong> regressione logistica stimati separatamente per coorte <strong>di</strong> nascita (nati prima e dopo il 1950) e per zona<br />
<strong>di</strong> residenza. Francia, EHF 1999.<br />
Coorti<br />
fino al 1949<br />
NORD SUD OVEST SUD EST<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
Coorti<br />
fino al 1949<br />
73<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
Coorti<br />
fino al 1949<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 75586 1 100841 1 21419 1 24688 1 15218 1 18327 1<br />
G2 mix Italia 683 0,87 1340 1,04 232 0,74 * 352 0,95 684 0,56 *** 789 0,79 ***<br />
G2 Italia 491 0,87 1069 1,46 *** 201 1,24 152 1,23 641 0,64 *** 558 0,77 ***<br />
G1.5 Italia 274 0,80 210 1,27 70 0,46 * 22 - 216 0,44 *** 139 0,59 ***<br />
G1 Italia 793 0,33 *** 160 1,73 *** 149 0,38 *** 17 - 549 0,32 *** 110 0,82<br />
Significatività statistica : ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
Altre variabili incluse nei modelli: coorte <strong>di</strong> nascita, genere, classe socio-economica, composizione familiare, viveva con i genitori fino ai 14 anni. Per i modelli complete con le<br />
stime per tutte le covariate, si veda in tavola A.4 in Appen<strong>di</strong>ce.<br />
In conclusione, nelle regioni del Sud-Est della Francia non si palesano <strong>di</strong>fferenze sostanziali nel<br />
passaggio dalle vecchie alle nuove coorti restando, i figli degli immigrati italiani,<br />
inequivocabilmente in ritardo nella corsa all’istruzione. Forse non è un caso se Temime e<br />
Vertone (1988, pag. 9) sostengono che rispetto all’immigrazione italiana nel resto della Francia,<br />
quella nel Sud-Est è la più antica, la più massiccia e, allo stesso tempo, la più sensibile alle<br />
<strong>di</strong>fficoltà 23 .<br />
23 Oltre alla regione <strong>di</strong> residenza (raggruppata in macro aree), un altro possibile fattore <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fferenziazione è dato dalla <strong>di</strong>mensione urbana. Così come accadeva per la regione <strong>di</strong> residenza, anche in<br />
questo caso l’informazione migliore sarebbe la <strong>di</strong>mensione urbana del luogo nel quale si viveva ai 14-15<br />
anni ma tale informazione è <strong>di</strong>sponibile solo all’intervista. E’ evidente come il problema <strong>di</strong> un eventuale<br />
inversione della relazione causale sull’istruzione è ora un rischio ancora più elevato rispetto a quanto
Tavola 2.12. Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o terziario. Modelli <strong>di</strong><br />
regressione logistica stimati separatamente per coorte <strong>di</strong> nascita (nati prima e dopo il 1950) e per zona <strong>di</strong><br />
residenza. Francia, EH F 1999.<br />
Coorti<br />
fino al 1949<br />
NORD SUD OVEST SUD EST<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
Coorti<br />
fino al 1949<br />
74<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
Coorti<br />
fino al 1949<br />
Coorti<br />
1950-1979<br />
n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 75586 1 88118 1 21419 1 21197 1 15218 1 16129 1<br />
G2 mix Italia 683 0,83 1161 0,81 *** 232 0,77 322 0,82 684 0,47 *** 711 0,83 **<br />
G2 Italia 491 0,65 * 998 1,38 *** 201 1,82 ** 151 1,09 641 0,59 *** 530 0,77 **<br />
G1.5 Italia 274 0,52 * 209 1,22 70 0,49 21 - 216 0,32 *** 137 0,50 **<br />
G1 Italia 793 0,44 *** 154 2,36 *** 149 0,93 16 - 549 0,42 *** 104 0,98<br />
Significatività statistica : ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
Altre variabili incluse nei modelli: coorte <strong>di</strong> nascita, genere, classe socio-economica, composizione familiare, viveva con i genitori fino ai 14 anni. Per i modelli complete con le<br />
stime per tutte le covariate, si veda in tavola A.5 in Appen<strong>di</strong>ce.<br />
2.6 La lingua parlata dai genitori e gli effetti del bilinguismo .<br />
L’indagine EHF del 1999 prevedeva un modulo specificatamente orientato alla rilevazione della<br />
lingua o del <strong>di</strong>aletto parlato in famiglia.<br />
La conoscenza del francese è in<strong>di</strong>spensabile nella scuola e i figli <strong>di</strong> immigrati potrebbero<br />
avere possibilità <strong>di</strong> successo molto <strong>di</strong>verse a seconda del grado <strong>di</strong> padronanza <strong>di</strong> tale lingua. In<br />
tal senso, la lingua utilizzata nella comunicazione con i loro figli durante la loro infanzia, che<br />
<strong>di</strong>pende dal grado <strong>di</strong> assimilazione dei genitori e dai tempi della migrazione, può dunque<br />
influire sui destini scolastici dei figli.<br />
L’abilità linguistica degli in<strong>di</strong>vidui, focalizzata sulla predominanza del francese nella<br />
comunicazione, può essere espressa lungo un asse che corre dalla piena assimilazione<br />
linguistica (padronanza del solo francese) alla totale mancanza <strong>di</strong> assimilazione (padronanza<br />
della sola lingua <strong>di</strong> provenienza dei genitori) con <strong>di</strong>versi gra<strong>di</strong> interme<strong>di</strong> <strong>di</strong> bilinguismo. In base<br />
alle informazioni <strong>di</strong>sponibili nei dati EHF, possiamo allora collocare gli in<strong>di</strong>vidui lungo l’asse<br />
specificato come segue:<br />
1. Solo Francese: piena assimilazione linguistica. Per entrambi i genitori il francese è la<br />
lingua predominante nella comunicazione con i figli per i quali il contatto con la lingua<br />
<strong>di</strong> <strong>origine</strong> dei genitori è assente o marginale.<br />
accadeva per la regione <strong>di</strong> residenza, a causa del fatto che oltre alle migrazione inter-regionali, bisogna<br />
ora tener conto anche <strong>delle</strong> migrazioni intra-regionali. Tuttavia, tenendo presenti tutti i possibili limiti del<br />
caso, si è cercato <strong>di</strong> valutare l’impatto della <strong>di</strong>mensione urbana lanciando i modelli separatamente per gli<br />
in<strong>di</strong>vidui residenti nei gran<strong>di</strong> centri (più <strong>di</strong> 200.000 abitanti) e quelli residenti nei centri più piccoli. I<br />
risultati (qui non mostrati) confermano che la coorte <strong>di</strong> nascita è il principale fattore <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione.<br />
Tuttavia, per le coorti nate prima del 1950 lo svantaggio riportato dai figli degli immigrati italiani è più<br />
evidente in un contesto urbano <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni; per le coorti nate dopo il 1950 il vantaggio notato<br />
per le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> si concentra nelle piccole città e nel contesto rurale. Di conseguenza, nelle<br />
gran<strong>di</strong> città i figli <strong>di</strong> immigrati italiani tendono ad avere performance relativamente inferiori rispetto a<br />
quelle osservate nei piccoli centri e in campagna. Questa relazione è valida in ogni area della Francia.
2. Francese predominante. E’ la prima modalità <strong>di</strong> bilinguismo: la preferenza verso il<br />
francese non ostacola la trasmissione <strong>di</strong> una seconda lingua parlata abitualmente o<br />
occasionalmente dai genitori.<br />
3. Francese occasionale . La seconda modalità <strong>di</strong> bilinguismo considera la prevalenza<br />
della lingua straniera nella comunicazione intergenerazionale accompagnata dall’uso<br />
occasionale del francese.<br />
4. Francese mai: totale assenza <strong>di</strong> assimilazione linguistica.<br />
Come primo passo nella nostra analisi, <strong>di</strong>amo una occhiata al grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione del francese<br />
nelle famiglie immigrate prese nel loro insieme, ovvero per qualunque <strong>origine</strong>. Nella tavola 2.13<br />
notiamo che, rispetto alle precedenti, per le <strong>generazioni</strong> nate dopo il 1950 <strong>di</strong>venta meno<br />
frequente per tutti i sottogruppi la totale assenza del francese. Tra le G2 però <strong>di</strong>minuisce anche la<br />
quota <strong>di</strong> chi parla solo il francese a fronte <strong>di</strong> un aumento dell’uso della doppia lingua (dal 46,6%<br />
al 62,9%). Sembra dunque che per i nati dopo la seconda guerra mon<strong>di</strong>ale da genitori entrambi<br />
immigrati aumenti la tendenza alla preservazione della lingua originaria. Quando almeno un<br />
genitore è francese la lingua straniera non è quasi mai quella principale.<br />
Focalizzando sui figli <strong>di</strong> immigrati italiani, resta valido quanto appena detto. Si vuole però<br />
sottolineare l’uso <strong>di</strong>ffuso del solo francese nelle G2 nelle coorti nate prima del 1950 rispetto alle<br />
successive. Va notato a tal proposito che per tutta la prima metà del XX secolo, i gruppi<br />
immigrati italiani, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> altre provenienze (pola cchi e spagnoli), non avevano una<br />
lingua nazionale e le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> comunicare anche con i propri connazionali potrebbero aver<br />
favorito l’appren<strong>di</strong>mento del francese.<br />
Tavola 2.13. Predominanza del francese nelle lingue parlate dagli immigrati ai loro figli durante la loro<br />
infanzia in base alla coorte <strong>di</strong> nascita dei figli. Francia, EHF 1999.<br />
fino al 1949<br />
1950-1979<br />
Genitori immigrati <strong>di</strong> ogni <strong>origine</strong> Genitori immigrati dall’Italia<br />
G2 mix G2 G1.5 G2 mix G2 G1.5<br />
Solo Francese 72,2 34,8 17,6 76,6 40,9 12,8<br />
Francese predominante 18,8 26,2 14,8 18,2 28,8 18,4<br />
Francese occasionale 4,2 20,4 25,9 2,7 15,2 24,9<br />
Francese mai 3,6 17,9 40,8 1,2 14,2 43,1<br />
Mancante 1,2 0,8 0,9 1,3 0,8 0,9<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Solo Francese 76,1 23,1 19,6 71,8 22,9 4,4<br />
Francese predominante 20,2 31,8 15,6 25,8 39,1 19,6<br />
Francese occasionale 1,9 31,1 30,4 1,0 25,4 31,5<br />
Francese mai 0,9 13,6 33,7 0,6 11,9 43,8<br />
Mancante 0,9 0,5 0,8 0,8 0,6 0,7<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
75
Tavola 2.14. Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno uno specificato livello d’istruzione (secondario<br />
inferiore, superiore o terziario). Confronto tra le stime ottenute dai modelli <strong>di</strong> regressione logistica senza e<br />
con la covariata che tiene conto della predominanza del Francese nelle lingue parlate dai genitori ai loro<br />
figli durante l’infanzia (F). Francia, EHF 1999.<br />
Almeno livello secondario inferiore Almeno livello secondario superiore<br />
Coorti fino al 1949 Coorti 1950-79 Coorti fino al 1949 Coorti 1950-79<br />
Senza F Con F Senza F Con F Senza F Con F Senza F Con F<br />
Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 1 1 1 1 1 1 1 1<br />
G2 mix Italia 0,84 *** 0,82 *** 1,12 1,09 0,70 *** 0,69 *** 0,96 0,93<br />
G2 Italia 0,91 1,01 1,35 *** 1,78 *** 0,81 ** 0,87 * 1,19 *** 1,17 ***<br />
G1.5 Italia 0,69 *** 0,97 1,12 2,26 *** 0,60 *** 0,76 ** 0,95 0,98<br />
G1 Italia 0,41 *** 0,69 *** 0,47 *** 1,17 0,34 *** 0,46 *** 1,33 ** 1,40 ***<br />
G2 mix Spagna 0,98 0,98 1,24 1,22 1,05 1,04 1,02 0,99<br />
G2 Spagna 0,99 1,20 ** 1,46 ** 2,27 *** 0,80 * 0,93 1,46 *** 1,46 ***<br />
G1.5 Spagna 0,70 ** 1,05 0,88 2,06 *** 0,63 * 0,84 0,87 0,91<br />
G1 Spagna 0,37 *** 0,63 *** 0,34 *** 0,88 0,32 *** 0,44 *** 0,93 0,98<br />
Altro o mancante 0,85 *** 0,97 * 0,51 *** 0,74 *** 1,05 *** 1,14 *** 1,07 *** 1,09 ***<br />
Predominanza del francese nella comunicazione genitori-figli<br />
Solo Francese 1 1 1 1<br />
Francese predominante 1,00 1,13 *** 1,00 1,12 ***<br />
Francese occasionale 0,67 *** 0,64 *** 0,62 *** 0,94 **<br />
Francese mai 0,51 *** 0,32 *** 0,67 *** 0,94 ***<br />
Mancante 0,61 *** 0,61 *** 0,60 *** 0,53 ***<br />
(continua)<br />
(Tavola 2.14 segue)<br />
Almeno livello terziario<br />
Coorti fino al 1949 Coorti 1950-79<br />
Senza F Con F Senza F Con F<br />
Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 1 1<br />
G2 mix Italia 0,65 *** 0,65 *** 0,84 *** 0,83 ***<br />
G2 Italia 0,79 * 0,81 * 1,14 * 1,12 *<br />
G1.5 Italia 0,43 *** 0,47 *** 0,92 0,91<br />
G1 Italia 0,49 *** 0,52 *** 1,69 *** 1,65 ***<br />
G2 mix Spagna 0,79 * 0,79 * 1,03 1,01<br />
G2 Spagna 0,67 ** 0,72 * 1,46 *** 1,46 ***<br />
G1.5 Spagna 1,06 1,17 0,77 0,75 *<br />
G1 Spagna 0,47 *** 0,49 *** 1,33 * 1,29 *<br />
Altro o mancante 1,18 *** 1,22 *** 1,10 *** 1,11 ***<br />
Predominanza del francese nella comunicazione genitori-figli<br />
Solo Francese 1 1<br />
Francese predominante 0,99 1,06 ***<br />
Francese occasionale 0,68 *** 0,94 **<br />
Francese mai 0,94 1,04<br />
Mancante 0,66 *** 0,53 ***<br />
Significatività statistica: ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
Altre variabili incluse nei modelli: coorte <strong>di</strong> nascita, genere, classe socio-economica, composizione familiare, viveva con i genitori fino ai 14 anni, zona <strong>di</strong> residenza. Per i<br />
modelli complete con le stime per tutte le covariate, si veda in tavola A.7 in Appen<strong>di</strong>ce.<br />
76
Considerato che chi cresce in contatto con la lingua locale tenderà a sviluppare più<br />
precocemente la conoscenza della lingua e data l’importanza del francese nella scuola, ci<br />
aspettiamo che l’uso del francese da parte dei genitori permetta ai loro figli <strong>di</strong> ottenere migliori<br />
risultati scolastici. Le nostre aspettative sono rafforzate dal fatto che l’uso del francese gioca un<br />
ruolo fondamentale nel processo <strong>di</strong> acculturazione in Francia: parlare francese ai propri figli,<br />
sebbene con <strong>di</strong>fficoltà e mischiando altre lingue, ha un valore simbolico e mostra il desiderio <strong>di</strong><br />
far parte della società francese (Tribalat, 1995). Tuttavia, come abbiamo già riportato nel primo<br />
capitolo, conoscere una seconda lingua non è più visto come un han<strong>di</strong>cap quanto piuttosto come<br />
un vantaggio nella scuola e a questa regola sembra essere valida anche in Francia (Tribalat,<br />
1995). Conservare la lingua originaria vuol <strong>di</strong>re tenere aperto un percorso privilegia to <strong>di</strong><br />
comunicazione con i genitori e i propri pari all’interno della comunità etnica con conseguente<br />
rafforzamento dei legami (Portes and Hao, 2002). Tenuto conto <strong>di</strong> ciò, non ci aspettiamo una<br />
relazione negativa <strong>di</strong> tipo lineare tra la presenza dell’Italiano (o <strong>di</strong> un’altra lingua straniera) e il<br />
successo scolastico: seguendo le in<strong>di</strong>cazioni presenti in letteratura, ci aspettiamo che in Francia,<br />
tra chi parla francese in famiglia, essere bilingui costituisca un fattore ad<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> vantaggio.<br />
Inoltre, le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento della lingua locale vissute dai figli degli immigrati,<br />
potrebbero costituire un fattore esplicativo per gli svantaggi nei risultati scolastici mostrati dalle<br />
G2 e dalle G1,5 <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana nate prima del 1950.<br />
Aggiungendo la variabile “predominanza del francese nella comunicazione genitori-figli”, è<br />
possibile controllare i due effetti menzionati. In tavola 2.14 è possibile confrontare le <strong>di</strong>fferenze<br />
tra sottogruppi in termini <strong>di</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un certo titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o con e senza<br />
l’inclusione <strong>di</strong> questa variabile nel modello.<br />
Tra chi è nato prima del 1950, lo scarso uso del francese è capace <strong>di</strong> spiegare parte <strong>delle</strong><br />
<strong>di</strong>fficoltà incontrate dalle G2 e G1,5 nel tenere il passo degli autoctoni nella scuola. Ad esempio<br />
l’odds ratio per raggiungere almeno un titolo secondario inferiore passa da 0,69 (significatività<br />
massima) nel modello senza la variabile sulla lingua a un livellamento <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze rispetto<br />
agli autoctoni quando invece tale variabile viene inserita. Per le <strong>generazioni</strong> successive, tener<br />
conto della lingua serve per enfatizzare le buone performance <strong>di</strong> G2 e soprattutto G1,5 nelle<br />
probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo secondario inferiore. Non appaiono invece cambiamenti<br />
negli odds ratio passando a tit oli superiori, a <strong>di</strong>mostrazione che tanto più si focalizza verso<br />
livelli d’istruzione elevati quanto meno influente è l’inclusione della lingua parlata nell’infanzia<br />
tra i fattori <strong>di</strong> controllo. Considerazioni analoghe possono essere tracciate per i figli <strong>di</strong> immigrati<br />
spagnoli. In breve, l’importanza della lingua utilizzata dai genitori si rivela decrescente lungo i<br />
percorsi scolastici dei figli degli immigrati dall’Italia e dalla Spagna.<br />
Continuando nella lettura della tavola 2.14, l’effetto della variabile sulla lingua mostra che,<br />
come ipotizzato, una maggiore esposizione al francese durante l’infanzia risulta un fattore<br />
importante e positivo nella carriera scolastica: i genitori che non usano affatto la lingua locale<br />
forniscono ai loro figli minori probabilità <strong>di</strong> successo nell’istruzione rispetto a chi parla solo<br />
francese. Tuttavia, parlare una seconda lingua occasionalmente, non rappresenta un limite<br />
quanto piuttosto un vantaggio in ogni livello d’istruzione, soprattutto per i nati nella seconda<br />
metà del XX secolo che mostrano il 13%, il 12% e il 6% <strong>di</strong> probabilità in più <strong>di</strong> ottenere<br />
77
ispettivamente almeno un titolo secondario inferiore, secondario superiore o terziario rispetto a<br />
chi cresce parlando esclusivamente francese. In accordo con la letteratura, premesso che la<br />
conoscenza del francese è fondamentale, il bilinguismo sembra dunque pro<strong>di</strong>go <strong>di</strong> effetti<br />
benefici. E’ però necessario far notare che questi risultati riguardano il campione nella sua<br />
interezza che dunque include anche gli autoctoni. Pertanto, l’effetto della variabile relativa alla<br />
lingua tiene conto non solo <strong>delle</strong> lingue straniere ma anche dei <strong>di</strong>aletti che caratterizzano alcune<br />
zone della Francia. In altri termini, il risultato ottenuto non è proprio <strong>delle</strong> sole <strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong> (con qualsivoglia <strong>origine</strong>) così come invece risulta essere per la letteratura citata.<br />
Tavola 2.15. Probabilità (odds ratio) <strong>di</strong> ottenere almeno uno specificato livello d’istruzione (secondario<br />
inferiore, superiore o terziario) in base alla predominanza del francese nelle lingue parlate dai genitori ai<br />
loro figli durante l’infanzia. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica stimati separatamente per coorte e applicati a<br />
sottoinsiemi del campione. Francia, EHF 1999.<br />
a) Figli <strong>di</strong> immigrati (G2, G1.5, G2mix) da ogni provenienza.<br />
Almeno<br />
sec. inf.<br />
Coorti fino al 1949 Coorti 1950-1979<br />
Almeno<br />
sec. sup.<br />
78<br />
Terziario<br />
Almeno<br />
sec. inf.<br />
Almeno<br />
sec. sup.<br />
Terziario<br />
(1)<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Lingua parlata dai genitori<br />
Solo Francese 5583 1 1 1 12212 1 1 1<br />
Francese predominante 2443 0,95 1,10 0,90 6148 0,84 ** 0,90 *** 0,95<br />
Francese occasionale 1628 0,75 *** 0,85 * 0,88 4188 0,58 *** 0,85 *** 0,92<br />
Francese mai 1846 0,60 *** 0,75 *** 0,73 ** 2622 0,46 *** 0,78 *** 0,90<br />
(1) Coorti 1950-1974<br />
Significatività: ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
Altre variabili incluse nei modelli: storia migratoria familiare, coorte <strong>di</strong> nascita, genere, classe socio-economica, composizione familiare, viveva con i genitori fino ai 14 anni,<br />
zona <strong>di</strong> residenza.<br />
b) Figli <strong>di</strong> immigrati (G2, G1.5, G2mix) dall’Italia. Francia, EHF 1999.<br />
Almeno<br />
sec. inf.<br />
Coorti fino al 1949 Coorti 1950-1979<br />
Almeno sec.<br />
sup.<br />
Terziario<br />
Almeno sec.<br />
inf.<br />
Almeno sec.<br />
sup.<br />
Terziario (1)<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Lingua parlata dai genitori<br />
Solo Francese 1801 1 1 1 2164 1 1 1<br />
Francese predominante 786 1,05 1,30 ** 1,20 1386 0,94 0,96 0,88<br />
Francese occasionale 395 0,84 0,92 1,45 641 0,80 0,93 1,03<br />
Francese mai 475 0,66 *** 0,81 0,69 411 1,15 1,05 0,95<br />
(1) Coorti 1950-1974<br />
Significatività: ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
Altre variabili incluse nei modelli: storia migratoria familiare, coorte <strong>di</strong> nascita, genere, classe socio-economica, composizione familiare, viveva con i genitori fino ai 14 anni,<br />
zona <strong>di</strong> residenza.<br />
Stimando i modelli logistici per la sola sottopopolazione dei figli <strong>di</strong> immigrati (tavola 2.15a),<br />
permane lo svantaggio nei primi gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> istruzione per chi ha utilizzato poco o mai il francese<br />
in famiglia ma non si hanno più evidenze empiriche relativamente al vantaggio del bilinguismo.
Infatti tra le coorti 1950-79 anche chi comunicava con i genitori in una seconda lingua, seppur<br />
occasionalmente, presenta un han<strong>di</strong>cap nell’istruzione secondaria.<br />
Infine, limitando il sotto-campione ai figli degli immigrati italiani, gli effetti sono solo<br />
raramente statisticamente significativi e nessuna particolare conclusione può essere tratta.<br />
L’unica eccezione riguarda la probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un livello d’istruzione secondaria<br />
per le coorti nate prima del 1950, caso nel quale il bilinguismo (con la prevalenza del Francese)<br />
è confermato come un vantaggio.<br />
2.7 Conclusioni<br />
Il titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è principalmente un carattere largamente preve<strong>di</strong>bile in base alle<br />
caratteristiche della famiglia <strong>di</strong> appartenenza. Il successo in campo scolastico e universitario è<br />
strettamente legato alla classe sociale (più elevato è lo status socio-economico, maggiori sono le<br />
probabilità <strong>di</strong> raggiungere livelli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o più avanzati) e alla composizione familiare (le<br />
possibilità sono inferiori per i membri <strong>di</strong> famiglie numerose e per in<strong>di</strong>vidui con or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> nascita<br />
elevato). Questi aspetti rappresentano la <strong>di</strong>mensione maggiore <strong>di</strong> <strong>di</strong>suguaglianza nel sistema<br />
scolastico e, in generale, si osserva una sostanziale conservazione dei meccanismi che tendono a<br />
riprodurre le posizioni sociali pre-esistenti (Simon, 2003). Le <strong>di</strong>fferenze tra autoctoni e figli <strong>di</strong><br />
immigrati in Francia sono fortemente influenzati da questi meccanismi, essendo spesso il frutto<br />
della <strong>di</strong>versa composizione socio-economica dei gruppi posti a confronto. Tuttavia, anche dopo<br />
aver tenuto conto <strong>di</strong> questi effetti ci sono circostanze nelle quali emergono de lle <strong>di</strong>fferenze.<br />
Innanzitutto, va rimarcato l’effetto coorte: le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> nate prima del 1950, e<br />
dunque derivanti dai flussi migratori più antichi, mostrano sistematici svantaggi nell’istruzione.<br />
Lo scenario cambia ra<strong>di</strong>calmente volgendo l’attenzione alle coorti nate tra il 1950 e il 1979 per<br />
le quali i risultati nel campo dell’istruzione si evolvono verso risultati decisamente migliori,<br />
sorpassando, in molti casi gli stessi autoctoni. Per le coorti nate dopo il 1950, importanti<br />
<strong>di</strong>fferenze emergono in relazione alla segmentazione socio-economica e all’area <strong>di</strong> residenza: è<br />
all’interno <strong>delle</strong> classi meno privilegiate che le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> mostrano performance<br />
scolastiche particolarmente brillanti se paragonate a quelle degli autoctoni; nel Sud-Est, l’area<br />
con la più ampia presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana, esse mostrano le maggiori <strong>di</strong>fficoltà,<br />
anche tra le coorti più giovani.<br />
Lo sforzo <strong>di</strong> tenere separati i figli <strong>di</strong> immigrati in tre sottogruppi ha permesso <strong>di</strong> mostrare che i<br />
figli <strong>di</strong> genitori entrambi immigrati (G2) sono coloro i quali mostrano i risultati migliori.<br />
Emergono invece particolari <strong>di</strong>fficoltà per le G1,5, anche se il ridotto numero dei casi per questo<br />
gruppo è spesso un ostacolo al fine <strong>di</strong> ottenere risultati supportati da una adeguata significatività<br />
statistica. In generale, si può <strong>di</strong>re che laddove le G2 mostrano un gap negativo con gli autoctoni,<br />
le G1,5 sono particolarmente svantaggiate. In tal senso, la probabile interruzione del percorso<br />
scolastico e la doppia socializzazione che le G1,5 si trovano a vivere, possono lasciare una<br />
impronta sui risultati scolastici. Infine, non senza sorpresa, le G2mix mostrano risultati<br />
decisamente peggiori <strong>di</strong> quelli <strong>delle</strong> G2.<br />
79
La lingua utilizzata dai genitori ai figli durante la loro infanzia, si è rivelata importante<br />
nell’influenzare i percorsi scolastici dei figli solo nei livelli d’istruzione mentre <strong>di</strong>viene man<br />
mano meno rilevante procedendo verso titoli più elevati soprattutto per le coorti più giovani.<br />
In conclusione, è interessante notare che il forte effetto coorte che si evince dall’analisi<br />
rispecchia le in<strong>di</strong>cazioni fornite in letteratura sulle con<strong>di</strong>zioni degli immigrati italiani in Francia.<br />
I cambiamenti intervenuti nel secondo dopoguerra, in relazione alle leggi d’ingresso e alle<br />
politiche in tema <strong>di</strong> integrazione adottate dal Governo francese ma soprattutto nella<br />
pre<strong>di</strong>sposizione all’accoglimento degli italiani da parte dei citta<strong>di</strong>ni francesi, hanno<br />
ra<strong>di</strong>calmente mo<strong>di</strong>ficato il quadro. Dagli anni ’60 gli italiani in Francia non sono veramente<br />
degli stranieri: a fronte <strong>delle</strong> crescenti problematiche date dalle nuove immigrazioni, la <strong>di</strong>stanza<br />
culturale tra italiani e francesi, in tempo insormontabile sembra ormai trascurabile e le carriere<br />
scolastiche dei bambini convergono con quelle degli autoctoni, tanto che l’immigrazione<br />
dall’Italia sembra essere svanita nel nulla (Vial, 2002). Non a caso l’immigrazione italiana è<br />
riportata come la più assimilata alla società francese (Blanc-Chaléard e Bechelloni, 2002). Di<br />
certo il costante turnover dei flussi tra i due paesi ha costituito un fattore decisamente<br />
favorevole per l’integrazione <strong>delle</strong> ondate migratorie successive (Milza, 1993). Il lungo e<br />
ripetuto contatto tra i due paesi nel tempo ha reso più facile il processo <strong>di</strong> integrazione degli<br />
italiani in Francia rispetto a quanto è accaduto ai gruppi <strong>di</strong> più recente arrivo. I <strong>di</strong>scendenti <strong>delle</strong><br />
ondate migratorie precedenti hanno messo in atto meccanismi <strong>di</strong> adattamento e <strong>di</strong> mobilità<br />
sociale, hanno avuto accesso alla lingua francese, hanno con<strong>di</strong>viso con gli autoctoni gli spazi<br />
della vita sociale e del tempo libero. Questa vicinanza ha permesso alle nuove ondate migratorie<br />
<strong>di</strong> inserirsi in modo meno traumatico nel tessuto della società francese. Questo spiega anche<br />
perché il conflitto xenofobo nel secondo dopoguerra sia stato molto meno forte del passato,<br />
nonostante la prevalenza <strong>di</strong> immigrati <strong>di</strong> provenienza meri<strong>di</strong>onale e conta<strong>di</strong>na, con un retroterra<br />
sociale e culturale ben più <strong>di</strong>stante da quello degli abitanti <strong>di</strong> una Francia ormai industrializzata<br />
(Milza, 1993).<br />
Riferimenti bibliografici<br />
Ambrosini M. 2004, Il futuro in mezzo a noi. Le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> scaturite<br />
dall’immigrazione nella società italiana dei prossimi anni, in Ambrosini e Molina<br />
(2004).<br />
Ambrosini M. e Molina S., 2004, Seconde <strong>generazioni</strong>: un’introduzione al futuro<br />
dell’immigrazione in Italia , Torino, E<strong>di</strong>zioni Fondazione Giovanni Agnelli.<br />
Astone N. M. e McLanahan S.S., 1991, Family structure, parental practices and high school<br />
completion, American sociological review, 56, pp.309-320.<br />
Baccaïni B., 2001, Internal migration in France, 1990-1999, reduced mobility and a shift to the<br />
Atlantic regions, contributo presentato alla Conferenza europea sulla popolazione,<br />
Helsinki, Finlan<strong>di</strong>a, 7-9 Giugno 2001.<br />
80
Bacchetta P. e Cagiano de Azevedo R., 1990, Le comunità italiane all’estero, Torino,<br />
Giappichelli.<br />
Bechelloni A., 2002, L’emigrazione italiana in Francia dopo il 1945. Cenni storico-statistici, in<br />
Stu<strong>di</strong> Emigrazione, XXXIX, 146.<br />
Bechelloni A., Dreyfus M. e Milza P. (a cura <strong>di</strong>), 1995, L’intégration italienne en France. Une<br />
siècle de présence italienne dans trois régions françaises (1880-1980), Bruxelles,<br />
Complexe.<br />
Belzil C. e Hansen J., 2003, Structural estimates of the intergenerational education correlation,<br />
Journal of applied econometrics, 18.<br />
Bevilacqua P., De Clementi A. e Franzina E. (a cura <strong>di</strong>), 2002, Storia dell’emigrazione italiana,<br />
Roma, Donzelli E<strong>di</strong>tore.<br />
Bilsky E., 1995, Le passage par la grande industrie : le cas des italiens aux usines Renault<br />
(1919-1962), in Bechelloni et al. (1995).<br />
Blake J., 1989 Family size and achievement, Los Angeles, CA, University of California,<br />
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6489p0rr/ .<br />
Blanc-Chaléard M.C. e Bechelloni A., 2002, L’emigrazione italiana in Francia dopo il 1945,<br />
Stu<strong>di</strong> Emigrazione, XXXIX, 146.<br />
Boyd M. e Grieco E.M., 1998, Triumphant Transitions: Socioeconomic Achievements of the<br />
Second Generation in Canada, International Migration Review 32(4), pp. 853-76.<br />
Boyd M., 2002, Educational attainments of immigrant offspring: success or segmented<br />
assimilitation?, in International Migration Review, 36(4), pp.1037-60.<br />
Checchi D., 1998, Povertà e istruzione: alcune riflessioni e una proposta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori, Politica<br />
Economica, XIV (2).<br />
Chiswick B.R, 1999, Are immigrants favorably self selected?, American economic review<br />
89(2).<br />
Coenders M. e Scheepers P., 1998, Support for ethnic <strong>di</strong>scrimination in the Netherlands 1979-<br />
1993: effects of period, cohort and in<strong>di</strong>vidual characteristics, European sociological<br />
review, 14(4).<br />
Corti P., 2003, L’emigrazione italiana in Francia: un fenomeno <strong>di</strong> lunga durata, Altreitalie, 26.<br />
Dayan J. L., Echardour A. e Glaude M., 1996, Le parcours professionnel des immigrés en<br />
France : une analyse longitu<strong>di</strong>nale , Économie et statistique, n° 299.<br />
Erikson R. e Goldthorpe J.H., 1992, The constant flux, Oxford, Clarendon Press.<br />
Erikson R., 1984, Social class of men, women and families, Sociology, 4, pp. 500-514.<br />
Eurybase, 2002 The educational system in France, on-line database on educational systems in<br />
Europe by Euri<strong>di</strong>ce, http://www.eury<strong>di</strong>ce.org/eurybase/application/eurybase.htm.<br />
Farley R. e Alba R., 2002, The new second generation in the United States, International<br />
migration review, 36(3).<br />
Figueroa R.A. e Garcia E., 1994, Issue in testing students from culturally and linguistically<br />
<strong>di</strong>verse backgrounds, Multicultural education, 2.<br />
French ministry of education, research and technology, Le système éducatif , information<br />
available at the web site of the Ministry of education, http://www.education.gouv.fr.<br />
81
Guillaume P., 1995, Les italiens en Aquitaine, propos sur une recherche, in Bechelloni et al.<br />
(1995).<br />
Hakuta K., 1986, Mirror of language: the debate on bilingualism, New York, Basic Books.<br />
Hirschman C., 2001, The educational enrolment of immigrant youth: a test of the segmented-<br />
assimilation hypothesis, Demography, 38(3).<br />
Keidler S. and Pugliese E., 1983, Problemi della seconda generazione degli immigrati in RFT,<br />
Inchiesta, 62.<br />
Le Bras H., 1986, Les trois France, Paris, E<strong>di</strong>tions O<strong>di</strong>le Jacob.<br />
Mc Partland J., 1998, Project 7126: The adaptation of immigrant children in the American<br />
educational system center for research on the education of <strong>di</strong>sadvantaged students<br />
(CDS), Johns Hopkins University, www.csos.jhu.edu .<br />
Miller P.W. e Volker P.A., 1989, Socioeconomic influences on educational attainment,<br />
Australian journal of statistics, special volume 31A, Youth employment and<br />
unemployment, august, pp. 47-50.<br />
Milza P., 1993, Voyage en Ritalie, Paris, Plon.<br />
Payet J.P., 1999, Mixités et segregations dans l’école urbaine, Hommes et migrations, 1217.<br />
Pisati M., 2002, La mobilità sociale , Bologna, Il Mulino.<br />
Portes A. (a cura <strong>di</strong>), 1995, The economic sociology of immigration: essays in network,<br />
ethnicity, and entrepreneurship, New York, Russel Sage Foundation.<br />
Portes A. e Hao L., 2002, The price of uniformity: language, family and personal adjustment in<br />
the second generation, Ethnic and racial stu<strong>di</strong>es, 25.<br />
Portes A. e Rumbaut R., 2001, Legacies: the story of the immigrant second generation,<br />
Berkeley, CA, University of California Press and Russel Sage Foundation.<br />
Portes A. e Schauffler R., 1996, The new second generation, New York, Russel Sage<br />
Foundation.<br />
Rosenbaum E. e Friedman S., 2001, Differences in the locational attainment of immigrant and<br />
native-born househilds with children in New York city , Demography, 38(3).<br />
Rumbaut R.G., 1997, Assimilation and its <strong>di</strong>scontents: between rhetoric and reality,<br />
International Migration review, vol. 31(4).<br />
Rumbaut, R.G., 1994, The crucible within: Ethnic identity, self -esteem, and segmented<br />
assimilation among children of immigrants, International Migration Review, 28, pp.<br />
748-794.<br />
Sauvy A., 1948, Le problème démographique français, Paris, Cahiers français d’information,<br />
118, p. 47.<br />
Schor R., 1996, Histoire de l’immigration en France, Paris, Colin.<br />
Shaafsma J. e Sweetman A., 1999, Immigrant earnings: age at immigration matters, Cana<strong>di</strong>an<br />
Journal of economics, 34(4).<br />
Shavit Y. e Blossfeld H.P. (a cura <strong>di</strong>), 1993, Persistent inequality. Changing educational<br />
attainment in thirteen countries, Boulder (CO), Westview press.<br />
Shavit, Y. e Müller W. (a cura <strong>di</strong>), 1998, From school to work, Oxford, Oxford University<br />
Press.<br />
82
Simon P., 2003, France and the unknown second generation: preliminary results on social<br />
mobility, International migration review, 37(4).<br />
Sori E., 1989, Alcune determinanti dell’emigrazione italiana in Francia tra Ottocento e<br />
Novecento, Stu<strong>di</strong> emigrazione, XXVI, 93.<br />
Sori E., 2001, L’emigrazione italiana in Europa tra Ottocento e Novecento, Stu<strong>di</strong> Emigrazione,<br />
142, pp. 259-295.<br />
Spire A., 2002, Un régime dérogatoire pour une immigration convoitée. Le politiques<br />
françaises et italiennes d’immigration/émigration après 1945, Stu<strong>di</strong> Emigrazione,<br />
XXXIX, 146.<br />
Temime E. e Vertone T. (a cura <strong>di</strong>), 1988, Gli italiani nella Francia del Sud e in Corsica,<br />
1860-1980, Milano, Franco Angeli.<br />
Thränhardt D., 2004, Le culture degli immigrati e la formazione della «seconda generazione» in<br />
Germania, in Ambrosini e Molina, 2004.<br />
Tosi L., 1988, L’emigrazione umbra nel Sud-Est della Francia dal 1890 al 1914, in Temine e<br />
Vertone (1988).<br />
Tosi L., 2002, La tutela internazionale dell’emigrazione , in Bevilacqua et al. (a cura <strong>di</strong>), 2002.<br />
Tribalat M., 1995, Faire France. Une enquête sur les immigrés et leurs enfants, Paris, La<br />
Découverte/essais.<br />
Valverde J.R. e Vila M.R., 2003, Internal migration and inequalities. The influence of migrant<br />
origin on educational attainment in Spain, European sociological review, 19(3).<br />
Vial E., 2002, In Francia, in Bevilaqua et al.(2002)<br />
Warner, W. e Srole, L., 1945, The social system of American ethnic groups, Yankee city series,<br />
vol.3, New Haven and London, Yale university press.<br />
83
3.1 L’emigrazione italiana in Australia<br />
85<br />
CAPITOLO III<br />
In Australia<br />
Gli italiani in Australia rappresentano il gruppo etnico più numeroso <strong>di</strong> <strong>origine</strong> non britannica.<br />
L’emigrazione verso questo paese assunse una certa portata solo dopo le pesanti restrizioni<br />
imposte dalle autorità statunitensi sulle entrate nel loro paese 24 . In Australia, invece, fino al<br />
1928, l’entrata nel paese era imme<strong>di</strong>ata non essendo richiesto alcun visto <strong>di</strong> ingresso. Tuttavia, i<br />
limiti posti dal regime fascista all’emigrazione e la crisi economica del 1929 che coinvolse<br />
anche l’Australia , non permisero l’attuarsi <strong>di</strong> ingenti flussi migratori prima della seconda guerra<br />
mon<strong>di</strong>ale. A questi fattori va aggiunta l’enorme <strong>di</strong>stanza, l’assenza <strong>di</strong> una linea <strong>di</strong> navigazione<br />
italiana e <strong>di</strong> comunità italiane già inse<strong>di</strong>ate come invece si aveva per le Americhe. Nel 1933, il<br />
censimento australiano segnalò la presenza <strong>di</strong> più <strong>di</strong> 26.000 persone nate in Italia contro le circa<br />
8.000 del 1921 (Zubrzycky, 1960). Si trattava per lo più <strong>di</strong> emigranti <strong>di</strong> sesso maschile in età<br />
lavorativa provenienti dalle regioni settentrionali; molti <strong>di</strong> loro saranno raggiunti in seguito da<br />
mogli e figli in età lavorativa e da altri parenti (Boncompagni, 2002), formando, negli anni<br />
Trenta le prime comunità <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento stabile. C’è chi sostiene che le cifre fornite<br />
sottostimerebbero la presenza italiana in quanto, <strong>di</strong>versamente da quanto avvenne in seguito, nel<br />
periodo precedente al secondo conflitto mon<strong>di</strong>ale molti emigrati rientrarono in Italia anche, e<br />
soprattutto, a causa della ostilità e della <strong>di</strong>scriminazione mostrata dai locali (Thompson, 1980).<br />
Gli italiani erano scarsamente integrati nella comunità e malvisti dai lavoratori locali in<br />
quanto, accettando qualsiasi con<strong>di</strong>zione lavorativa, tendevano ad abbassare il costo del lavoro.<br />
E’ in questo clima che nel Gennaio 1934 si ebbero gli scontri <strong>di</strong> Kalgoorlie scatenati dalla morte<br />
accidentale <strong>di</strong> un eroe sportivo causata da un barista italiano. Questo incidente, che infiammò il<br />
risentimento <strong>di</strong> molti minatori anglo-australiani contro gli italiani, sfociò in due giorni <strong>di</strong> scontri<br />
nei quali negozi e abitazioni <strong>di</strong> italiani e altri sud-europei furono devastate (Cresciani, 1983).<br />
Nonostante la condanna dell’accaduto da parte dei me<strong>di</strong>a, l’opinione pubblica verso gli italiani<br />
non cambiò e continuarono a essere considerati come in<strong>di</strong>vidui culturalmente inferiori<br />
(Boncompagni, 1999).<br />
I flussi migratori verso l’Australia assunsero un peso importante solo dopo la seconda<br />
guerra mon<strong>di</strong>ale in corrispondenza dell’attuazione <strong>di</strong> un vasto programma <strong>di</strong> immigrazione<br />
24 Negli USA venne fissato nel 1921 un limite massimo <strong>di</strong> accessi annuali <strong>di</strong> italiani e nel 1924 le<br />
misure si inasprirono.
volto a incrementare la popolazione del paese a fini strategici, economici e militari. Le autorità<br />
australiane negoziarono trattati formali con alcuni paesi europei al fine <strong>di</strong> riaprire le correnti<br />
migratorie interrotte dalla guerra e facilitare il ricongiungimento familiare per gli immigrati già<br />
presenti sul territorio. Nel 1945, il primo ministro dell’immigrazione Arthur Calwell, usò lo<br />
slogan «Populate or perish». L’intento era quello <strong>di</strong> attirare quanti più immigrati anglosassoni.<br />
Ma ben presto <strong>di</strong>venne evidente l’impossibilità <strong>di</strong> sostenere una ampia immigrazione solo dai<br />
paesi <strong>di</strong> lingua inglese e si iniziò, allora, a reclutare persone <strong>di</strong> altra provenienza adottando un<br />
sistema <strong>di</strong> preferenze per i “tipi desiderabili” <strong>di</strong> immigrati: i britannici erano al primo posto<br />
seguiti dai nordeuropei, dagli europei dell’Est e infine da quelli del Sud (Castles, 1992). I non<br />
europei, in particolare asiatici e persone <strong>di</strong> colore, erano del tutto esclusi. Il risultato fu un<br />
sistema <strong>di</strong> immigrazione a due livelli: gli immigrati inglesi e in seguito quelli nordeuropei<br />
venivano sovente assistiti nel viaggio e all’arrivo godevano <strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>ritti civili e professionali,<br />
a <strong>di</strong>fferenza degli immigrati dell’Europa orientale e meri<strong>di</strong>onale generalmente trattati come<br />
inferiori (Collins, 1988, pag. 23-24). Questa politica è il frutto <strong>di</strong> un atteggiamento fortemente<br />
anglocentrico da parte <strong>delle</strong> istituzioni australiane basato sulla volontà <strong>di</strong> perpetuare una società<br />
nella quale il pluralismo non era contemplato. Ancora nel 1969, il ministro conservatore per<br />
l’immigrazione Billy Snedden sosteneva <strong>di</strong> essere convinto che «si debba avere una<br />
monocultura in cui tutti vivono allo stesso modo, si comprendono e con<strong>di</strong>vidono le stesse<br />
aspirazioni» (Wilton e Bosworth, 1984, pag. 17). A <strong>di</strong>fferenza dei nordeuropei e britannici, gli<br />
italiani fino al 1969, non ebbero <strong>di</strong>ritto alle agevolazioni previste per il viaggio e gli alloggi<br />
nonché per quelle sul ricongiungimento familiare<br />
Nel 1951 venne firmato l’”Accordo <strong>di</strong> emigrazione assistita tra Italia e Australia” che <strong>di</strong>ede<br />
il via al periodo <strong>di</strong> emigrazione <strong>di</strong> massa tra i due paesi. Nel ventennio 1951-61, era <strong>di</strong> circa<br />
18.000 in<strong>di</strong>vidui l’anno il saldo migratorio netto in arrivo in Australia. In totale, furono più <strong>di</strong><br />
360.000 gli italiani che giunsero in Australia tra il 1947 e il 1976 (Castles e Vasta, 1992, pag.<br />
106).<br />
Si arrivava in Australia tramite un sistema <strong>di</strong> chiamate garantite, spesso avallate dai tanti<br />
parenti aperti anche agli italia ni già presenti da tempo in Australia (MacDonald, 1970), a<br />
<strong>di</strong>mostrazione che l’emigrazione in Australia si è ben presto caratterizzata come una catena<br />
migratoria che ha favorito la formazione <strong>di</strong> nuclei regionali ben determinati (Tosi, 1984).<br />
In generale, il periodo <strong>di</strong> più intensa emigrazione si ebbe dalla fine degli anni ’50 alla fine<br />
degli anni ’60. Il basso numero <strong>di</strong> rientri fa sì che gli immigrati <strong>di</strong> questo periodo costituiscano<br />
la spina dorsale della comunità <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana o<strong>di</strong>erna (Cavallaro, 2003). Chi arriva ha un<br />
basso livello d’istruzione e scarsa qualificazione professionale: l’inse<strong>di</strong>amento non fu facile e<br />
spesso bisognava accettare lavori dequalificanti (Bertelli, 1987). Le regioni <strong>di</strong> provenienza sono<br />
quelle del meri<strong>di</strong>one: tra il 1959 e il 1979 l’ 81,5% degli immigrati italiani giunge dalle regioni<br />
meri<strong>di</strong>onali e dalle isole, con Calabria e Sicilia in testa (Bertelli, 1983).<br />
Dalla metà degli anni Sessanta si riduce il flusso degli italiani e come Bertelli (1986 e 1987)<br />
mette in evidenza, si assiste in questo periodo a importanti cambiamenti nella figura del<br />
migrante. Iniziano ad arrivare in<strong>di</strong>vidui socialmente, politicamente e professionalmente più<br />
qualificati, spesso in possesso <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o secondario superiore. Per molti <strong>di</strong> loro la<br />
86
migrazione, specialmente negli anni ’70, non derivava da un bisogno impellente <strong>di</strong> cibare e<br />
vestire la propria famiglia, quanto piuttosto dalla possibilità <strong>di</strong> autorealizzazione: i nuovi<br />
immigrati hanno una consapevolezza ben maggiore dei <strong>di</strong>ritti dei lavoratori e del welfare<br />
(Bertelli, 1987). I flussi si assottigliano ulteriormente nella metà degli anni ’70: la grande<br />
emigrazione verso l’Australia può <strong>di</strong>rsi conclusa.<br />
I dati censuari australiani del 1971 in<strong>di</strong>cano in 289.000 le persone nate in Italia che<br />
decrescono fino a 254.000 nel 1991. Cresce invece il numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui con almeno un<br />
genitore nato in Italia: al censimento del 1996 sono 334 mila su una popolazione totale <strong>di</strong> 17,8<br />
milioni <strong>di</strong> persone. Oggi, la maggior parte <strong>delle</strong> persone <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana vive negli stati più<br />
industrializzati della nazione (Melbourne, Sydney, Adelaide, Perth ma anche centri minori come<br />
Wollongong e Newcastle ) a <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> come la massiccia emigrazione del secondo<br />
dopoguerra si sia in<strong>di</strong>rizzata prevalentemente verso il settore industriale (Boncompagni, 2002).<br />
Ad ogni modo, non sono una vera e propria eccezione né gli italiani de<strong>di</strong>ti all’agricoltura, come<br />
<strong>di</strong>mostra il fatto che gli abitanti <strong>di</strong> alcuni centri agricoli degli stati <strong>di</strong> Victoria, New South Wales<br />
e Queensland sono in maggioranza <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana e in gran parte possessori <strong>delle</strong> terre che<br />
coltivano (Boncompagni, 2002), né quelli che si sono spostati nelle località limitrofe ai gran<strong>di</strong><br />
centri urbani per de<strong>di</strong>carsi ai settori della ristorazione, <strong>delle</strong> costruzioni e del commercio,<br />
soprattutto a seguito della crisi industriale della metà degli anni settanta (Cresciani, 1988). Nel<br />
complesso, il Victoria è lo stato che ha ospitato il maggior numero <strong>di</strong> italiani, più <strong>di</strong> centomila<br />
nella sola Melbourne.<br />
La decisione <strong>di</strong> andare in Australia è stata spesso realizzata per perseguire finalità<br />
puramente economiche e per molti è stato possibile realizzare una ascesa sociale, ne è prova il<br />
grande numero <strong>di</strong> nomi italiani nell’industria, nel commercio e nella politica. In generale, i dati<br />
censuari sul red<strong>di</strong>to mostrano come oggi la comunità italiana sia nel complesso benestante. Pur<br />
presentando un profilo socioeconomico leggermente svantaggiato rispetto al totale della<br />
popolazione, gli immigrati dall’Italia mostrano una situazione occupazionale positiva, vantando<br />
la più bassa percentuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione (Bureau of Statistics, 1996), e la più elevata<br />
proporzione <strong>di</strong> famiglie con casa <strong>di</strong> proprietà tra tutti i gruppi etnici non <strong>di</strong> lingua inglese<br />
(Hugo, 1999). La letteratura tende a sottolineare il successo nell’istruzione da parte <strong>delle</strong><br />
giovani <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> originarie dell’Europa meri<strong>di</strong>onale sia rispetto ai loro genitori<br />
immigrati, sia in confronto alla popolazione nel complesso (DIMIA, 2002; Martin e Meade,<br />
1979; Meade, 1983). Questo esito positivo, che deve molto alla fiducia attribuita all’importanza<br />
dell’istruzione da parte degli immigrati <strong>di</strong> quest’area (Birrell e Khoo, 1995), è in grado <strong>di</strong><br />
realizzare una elevata mobilità sociale (Vasta, 1992) sebbene non si traduca necessariamente in<br />
una maggiore capacità <strong>di</strong> guadagno (Giorgias, 1999).<br />
La comunità italiana in Australia è caratterizzata dallo sviluppo <strong>di</strong> una rete sociale, culturale<br />
e politica capace <strong>di</strong> conservare modelli culturali, religiosi e sociali importati dall’Italia. Tuttavia ,<br />
più che una singola comunità omogenea e coesa, si sono costituite <strong>di</strong>fferenti comunità basate<br />
essenzialmente sui legami regionali. La via all’integrazione adottata dagli italiani è consistita<br />
nella conservazione della lingua originaria o del <strong>di</strong>aletto parlato nell’ambito familiare, nella<br />
perpetuazione <strong>di</strong> rituali e tra<strong>di</strong>zioni, in sostanza, nella valorizzazione della propria etnicità, non<br />
87
in maniera inerte e statica ma piuttosto adattata alle con<strong>di</strong>zioni locali (Boncompagni, 1999).<br />
Nonostante questo aspetto, per gli italiani così come per altri gruppi etnici (escludendo gli<br />
aborigeni), ci sono scarse evidenze <strong>di</strong> forti concentrazioni abitative caratterizzate da isolamento<br />
rispetto alla popolazione locale, povertà e criminalità <strong>di</strong>ffusa (Bureau of Statistics, 1995) 25 . Ciò<br />
non esclude che vi siano talune zone urbane a connotazione tipicamente italiana grazie<br />
soprattutto ai negozi, caffè e ristoranti nonché alla presenza <strong>di</strong> circoli, chiese, opere assistenziali<br />
e strutture per anziani (Castles e Vasta, 1992, pag. 118).<br />
3.2 Il sistema scolastico in Australia<br />
La scuola in Australia inizia a 5 anni <strong>di</strong> età (year 1) ed è obbligatoria fino ai 15 anni (year 10). Il<br />
livello primario si conclude intorno ai 12 anni <strong>di</strong> età (year 7) e il livello secondario inferiore si<br />
conclude con l’ottenimento <strong>di</strong> un junior high school certificate .<br />
Dopo la scuola dell’obbligo, sono possibili due percorsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o:<br />
1) Senior secondary education (years 11-12)<br />
Si tratta due anni <strong>di</strong> scuola opzionali il cui completamento, segnato dal superamento <strong>di</strong><br />
un esame finale, dà <strong>di</strong>ritto a un <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola secondaria (high school <strong>di</strong>ploma) e<br />
facilita l’ammissione alle università. In questi due anni è possibile scegliere le materie<br />
in modo da in<strong>di</strong>rizzare la propria preparazione per stu<strong>di</strong> successivi. Alcune scuole<br />
inseriscono nel year 12 alcuni corsi <strong>di</strong> preparazione all’università e forniscono cre<strong>di</strong>ti<br />
per l’ottenimento dei certificates I-IV.<br />
2) VET (Vocational education and training institute)<br />
In alternativa ai due anni della senior secondary school, è possibile intraprendere<br />
percorsi <strong>di</strong> formazione professionale e in appren<strong>di</strong>stato, al fine <strong>di</strong> un più rapido ingresso<br />
nel mondo del lavoro o per proseguire gli stu<strong>di</strong> nell’ambito professionale. Le scuole<br />
VET pubbliche riconosciute dal governo nazionale (TAFE: Technical and Further<br />
Education) coprono la gran parte dell’educazione terziaria in Australia con circa 250<br />
istituti e più <strong>di</strong> un milione <strong>di</strong> studenti. Meno <strong>di</strong>ffuse sono le scuole VET private.<br />
I requisiti necessari all’ingresso nei programmi TAFE sono solitamente più bassi<br />
rispetto a quelli richiesti dalle università: year 10 e year 11 danno l’accesso ai<br />
Certificate Course e talvolta anche agli Advanced Certificate Course, mentre year 12<br />
permette l’accesso ai più prestigiosi Diploma courses.<br />
25 Il Governo australiano ha una lunga tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> impegno teso a evitare la formazione <strong>di</strong> “ghetti”.<br />
Già nel 1881, il governo del New South Wales era pronto a negare l’assistenza a un gruppo <strong>di</strong> italiani<br />
in<strong>di</strong>genti appena giunti in questo stato, qualora si fossero inse<strong>di</strong>ati insieme in una sola località (Bureau of<br />
Statistics, 1995).<br />
88
La durata della carriera scolastica può variare in base al tipo <strong>di</strong> certificato o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma<br />
raggiunto (tavola 3.1). Molti istituti TAFE hanno stipulato degli accor<strong>di</strong> con <strong>delle</strong> università,<br />
permettendo agli studenti <strong>di</strong> guadagnare cre<strong>di</strong>ti per l’istruzione terziaria.<br />
Tavola 3.1 Certificati e <strong>di</strong>plomi VET.<br />
qualifica durata competenza<br />
Certificate I 4-6 mesi competent operator<br />
Certificate II 6-8 mesi advanced operator<br />
Certificate III circa 12 mesi qualified tradesperson or technician<br />
Certificate IV 12-18 mesi supervisor<br />
Diploma 18-24 mesi para-professional<br />
Advanced <strong>di</strong>ploma 24-36 mesi junior manager<br />
Figura 3.1 Il sistema scolastico australiano.<br />
Graduate Certificate<br />
and Graduate<br />
Diploma<br />
Livello<br />
secondario<br />
superiore<br />
Master Degree and<br />
Doctorate Degree<br />
Bachelor Degree<br />
Senior Secondary Certificate of Education<br />
Secondary School Education (10 years)<br />
Livello terziario<br />
Il livello terziario si sviluppa principalmente in ambito universitario. Sia le università pubbliche<br />
che private offrono programmi undergradute e postgraduate. La qualificazione undergraduate<br />
<strong>di</strong> base è il Bachelor degree che richiede un minimo <strong>di</strong> tre anni (+ 1 per l’attestato Honours).<br />
Al Bachelor possono essere aggiunte <strong>delle</strong> qualificazioni postgraduate con durata variabile:<br />
Graduate Certificate (6 mesi), Graduate Diploma (1 anno), Master (1 anno), Master Honour<br />
(1,5 anni), Phd (2 anni). In ogni caso, questi titoli non sono misurati in base al tempo ma in base<br />
89<br />
Diploma and<br />
Adv. Diploma<br />
Certificates I-IV
al numero <strong>di</strong> corsi e materie superate e il tempo necessario per ottenere il rispettivo titolo può<br />
variare da soggetto a soggetto, quantunque spesso ci siano dei limiti <strong>di</strong> tempo massimo 26 .<br />
3.3 Dati e definizioni<br />
I dati utilizzati in questo capitolo provengono dalla prima wave dell’indagine HILDA<br />
(Household, Income and Labour Dynamics in Australia ) finanziata dal Department of Family<br />
and Community Services (FaCS) e realizzata dal Melbourne Institute for Economic and Social<br />
Research dell’Università <strong>di</strong> Melbourne. Tra il 1 Settembre 2001 e il 23 Gennaio 2002, sono<br />
state condotte sul territorio australiano 13.965 interviste faccia -a-faccia a tutti gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong><br />
almeno 15 anni presenti in abitazioni private e residenti e permanentemente presenti in<br />
Australia 27 .<br />
La spiccata sensibilità dei ricercatori e <strong>delle</strong> istituzioni australiane sui temi inerenti<br />
l’immigrazione, ha spinto a includere nel questionario domande relative all’<strong>origine</strong> territoriale<br />
dell’intervistato e dei suoi genitori, informazioni che ci permettono <strong>di</strong> impostare l’analisi sui<br />
figli degli immigrati italiani sebbene le finalità della rilevazione vadano in altra <strong>di</strong>rezione.<br />
Nell’insieme, il campione HILDA è rappresentativo dell’intera popolazione australiana<br />
quantunque si avvisi qualche limite che tuttavia non riguarda strettamente i figli <strong>di</strong> immigrati 28<br />
(MIAESR, 2002).<br />
Dal campione complessivo si è deciso <strong>di</strong> limitare l’analisi agli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età compresa tra<br />
i 20 e i 69 all’intervista, essendo praticamente assenti figli <strong>di</strong> italiani con età maggiore. Inoltre,<br />
data la vastità dell’Australia, in alcuni stati (Tasmania, Northern Territories e Australian Capital<br />
Territory) e nelle aree remote degli altri, non compaiono interviste a figli <strong>di</strong> italiani e, pertanto,<br />
si è deciso <strong>di</strong> eliminare tali contesti dal computo.<br />
Con la stessa impostazione presentata per il caso francese, possiamo definire le seguenti<br />
categorie <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui:<br />
- Seconda generazione mista (G2mix Italia): nati in Australia da un genitore nato in Italia<br />
e uno nato in Australia.<br />
- Seconda generazione (stricto sensu) (G2 Italia): nati in Australia da genitori nati<br />
entrambi in Italia.<br />
26 Le informazioni sul sitema scolastico australiano sono tratte da:<br />
Australian Government, education portal: http://studyinaustralia.gov.au ;<br />
YES Australia http://www.yesaustralia.com/cursoestudo-sistemaensinoing.htm ;<br />
INFOZEE http://www.infozee.com/in<strong>di</strong>atimes/australia/education.htm .<br />
27 Maggiori dettagli sul sito http://www.melbourneinstitute.com/hilda/.<br />
28 Nel campione HILDA (prima ondata) sono sovra-rappresentate le donne e gli in<strong>di</strong>vidui sposati, a<br />
fronte <strong>di</strong> una sottorapresentazione <strong>di</strong> uomini e non sposati; gli immigrati provenienti da paesi non a lingua<br />
inglese sono il 14,5% a fronte <strong>di</strong> un 17,5% per l’intera popolazione; gli abitanti <strong>di</strong> Sydney sono sottorappresentati.<br />
Delle altre caratteristiche considerate, le <strong>di</strong>fferenze sono piccole e spesso insignificanti<br />
(MIAESR, 2002).<br />
90
- Generazione 1,5 (G1,5 Italia): giunti in Australia prima del decimo compleanno, con<br />
entrambi i genitori nati in Italia.<br />
- Generazione 1 (G1 Italia): giunti in Australia dopo il decimo compleanno e pertanto<br />
considerati come immigrati <strong>di</strong>retti.<br />
Ognuno <strong>di</strong> questi gruppi può essere posto a confronto con gli Autoctoni: in<strong>di</strong>vidui nati in<br />
Australia da genitori entrambi nati in Australia 29 .<br />
Tavola 3.2. Il campione HILDA (dati pesati; 20-69 anni d’età; escluse NT, ACT, TAS e zone remote).<br />
Autoctoni 5.539 52,2%<br />
G2 mix 50 0,5%<br />
G2 132 1,2%<br />
G1,5 26 0,2%<br />
G1 78 0,7%<br />
Altro o mancante 4.787 45,1%<br />
Totale 10.612 100%<br />
Tuttavia, il dettaglio della classificazione, come mostrato in tavola 3.2, comporta una<br />
numerosità piuttosto esigua per alcuni sottogruppi. Risulta, pertanto, conveniente compiere <strong>delle</strong><br />
riaggregazioni. Un primo modo <strong>di</strong> procedere consiste nel considerare congiuntamente i figli <strong>di</strong><br />
immigrati dall’Italia e dalla Grecia, date le numerose analogie tra questi due gruppi (DIMIA,<br />
2002). In tal modo, si riesce quantomeno a estendere il gruppo G2 fino a 194 casi mentre le G1<br />
e soprattutto le G1,5 continuano a mostrare una numerosità scarsa.<br />
Una seconda soluzione è quella <strong>di</strong> far riferimento alla definizione <strong>di</strong> seconda generazione<br />
adottata nel rapporto del <strong>di</strong>partimento dell’immigrazione (DIMIA, 2002): in<strong>di</strong>vidui nati in<br />
Australia da almeno un genitore nato all’estero (nel caso specifico in Italia). Conveniamo <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>care questa categoria con 2nd Gen Italia (209 casi 30 ). Chi invece ha almeno un genitore<br />
italiano ma è nato all’estero ed è giunto in Australia in seguito, confluirà nel gruppo residuale<br />
denominato Altri figli <strong>di</strong> italiani (114 casi):<br />
29 La categoria “altro o mancante” si riferisce a:<br />
5) in<strong>di</strong>vidui con almeno un genitore nato in un paese <strong>di</strong>verso dalla Australia o l’Italia (ad esempio,<br />
chi ha almeno un genitore nato in Inghilterra o nelle Filippine) (4601 casi);<br />
6) in<strong>di</strong>vidui nati all’estero da entrambi i genitori australiani o da un genitore italiano e uno<br />
australiano (19 casi).<br />
7) in<strong>di</strong>vidui per i quali l’in<strong>di</strong>cazione del paese <strong>di</strong> nascita <strong>di</strong> almeno un genitore è mancante (167<br />
casi).<br />
30 Si noti come il gruppo 2nd Gen non coincida perfettamente con la somma <strong>di</strong> G2 e G2mix poiché<br />
include al suo interno anche chi ha entrambi i genitori immigrati <strong>di</strong> cui uno è nato in Italia e uno in un<br />
altro paese, in<strong>di</strong>vidui precedentemente inclusi nella categoria Altro.<br />
91
3.4 Una descrizione del campione<br />
L’ interesse della ricerca ricade sulla probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un:<br />
3- livello d’istruzione secondaria superiore (year 12, advanced <strong>di</strong>ploma, cert. I-IV);<br />
4- livello terziario (bachelor, graduate <strong>di</strong>ploma, graduate certificate ).<br />
Dividendo il campione in due gruppi <strong>di</strong> coorti (20-39 anni e 40-69 anni), è possibile riscontrare<br />
<strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> rilievo nelle percentuali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in possesso <strong>di</strong> titoli d’istruzione elevati<br />
(figura 3.2): se tra i più giovani i risultati scolastici <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana<br />
(e greca) sono molto positivi, mostrando ad<strong>di</strong>rittura un leggero vantaggio rispetto agli autoctoni,<br />
tra le persone meno giovani la relazione si inverte e sono gli autoctoni a mostrare risultati<br />
migliori, soprattutto relativamente al livello terziario.<br />
Figura 3.2. Distribuzione percentuale dei titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (almeno un titolo secondario superiore e almeno<br />
un titolo terziario) all’interno dei sottogruppi <strong>di</strong> popolazione definiti in base alla storia migratoria<br />
familiare. Australia, HILDA, 2000.<br />
100,0<br />
80,0<br />
60,0<br />
40,0<br />
20,0<br />
0,0<br />
40-69 anni all’intervista 20-39 anni all’intervista*<br />
Autoctoni G2 2nd Gen G2<br />
Italia+Grecia<br />
Almeno sec. sup. Almeno terziario<br />
* Per il livello terziario si considerano le classi <strong>di</strong> età 25-39 anni all’intervista<br />
Seguendo lo stesso schema <strong>di</strong> ipotesi e la stessa letteratura vista nel caso francese, le altre<br />
variabili incluse nel modello sono:<br />
a) età all’intervista (in classi quinquennali);<br />
b) genere;<br />
c) classe socio-economica <strong>di</strong> appartenenza. La costruzione della classe socio-economica dei<br />
genitori è basata sulla categoria socio-professionale dei genitori quando l’intervistato<br />
aveva 14 anni. Tale carattere è specificato nel campione HILDA in base alla<br />
classificazione ASCO (Australian Standard Classifications of Occupations, second<br />
92<br />
100,0<br />
80,0<br />
60,0<br />
40,0<br />
20,0<br />
0,0<br />
Autoctoni G2 2nd Gen G2<br />
Italia+Grecia<br />
Almeno sec. sup. Almeno terziario
e<strong>di</strong>tion, 1997) 31 . Seguendo lo schema classificatorio <strong>di</strong> Erikson e Goldthorpe (1992), le<br />
classi socio-economiche, per ogni genitore, sono definite come segue:<br />
1) Classe <strong>di</strong> servizio superiore (managers, administrators e professionals);<br />
2) Classe <strong>di</strong> servizio inferiore (associate professionals);<br />
3) Impiegati esecutivi (advanced and interme<strong>di</strong>ate clerical and service workers);<br />
4) Piccola borghesia urbana (tradespersons and related workers);<br />
5) Piccola borghesia agricola (farmers);<br />
6) Lavoratori manuali qualificati (interme<strong>di</strong>ate production and transport workers).<br />
7) Lavoratori manuali non qualificati (elementary clerks and service workers,<br />
labourers and related workers).<br />
La classe sociale per l’intero nucleo familiare si ottiene seguendo il “principio <strong>di</strong><br />
dominanza” 32 (Erikson, 1984).<br />
d) composizione familiare (interazione tra or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> nascita e numero <strong>di</strong> fratelli/sorelle);<br />
e) viveva con i genitori a 14 anni;<br />
f) area <strong>di</strong> residenza. Negli stati del New South Wales e Victoria, che occupano lo spicchio<br />
sud-orientale dell’Australia, si concentrano molte <strong>delle</strong> principali città (Sydney,<br />
Melbourne, Newcastle, Wollongong). In questi due stati, che più <strong>di</strong> altri hanno accolto<br />
immigrati italiani, sono caratterizzati da una istruzione me<strong>di</strong>amente più elevata rispetto<br />
al resto dell’Australia. Pertanto, introdurre una variabile che tenga conto dell’essere<br />
residenti in questi due stati piuttosto che in altri, permette <strong>di</strong> tener sotto controllo<br />
l’eventuale effetto spurio sulle <strong>di</strong>fferenze tra autoctoni e figli <strong>di</strong> immigrati italiani che<br />
potrebbe risultare da una <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>stribuzione sul territorio dei due sottogruppi.<br />
Nella tavola 3.3 per ognuna <strong>delle</strong> variabili <strong>di</strong> controllo che verranno considerate nell’analisi<br />
multivariata, è riportata la <strong>di</strong>stribuzione percentuale nel campione (colonna 1), la percentuale <strong>di</strong><br />
persone in possesso almeno <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore (colonna 2) e almeno <strong>di</strong><br />
un titolo <strong>di</strong> livello terziario (colonne 3), la <strong>di</strong>stribuzione percentuale nei sottogruppi degli<br />
autoctoni, <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana (2nd Gen) e dei sottogruppi G2mix e G2<br />
(colonne 4-7).<br />
L’età all’intervista mostra la crescente <strong>di</strong>ffusione della scolarizzazione in Australia negli<br />
ultimi 50 anni. Il background familiare, come nelle attese, si rivela molto importante nel<br />
determinare le probabilità <strong>di</strong> successo nella scuola e nell’università: essere figli <strong>di</strong> operai,<br />
crescere in una famiglia numerosa e non poter <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> entrambi i genitori durante<br />
l’adolescenza, costituiscono dei chiari fattori <strong>di</strong> svantaggio nella corsa all’istruzione. Infine, se<br />
31 L’ ASCO è lo standard classificatorio utilizzato dall’ufficio <strong>di</strong> statistica australiano (ABS) per il<br />
mercato del lavoro. Per la corrispondenza tra le categorie ASCO e quelle ISCO88 si veda Kelley (1990).<br />
Ci sono alcune <strong>di</strong>fferenze tra l’ASCO e la classificazione <strong>di</strong> Goldthorpe usata negli altri capitoli. Ad<br />
esempio, nella co<strong>di</strong>fica ASCO, l’autonomia dell’impiego non costituisce un fattore fondamentale e, in<br />
generale, l’attenzione è maggiormente focalizzata sui settori del mercato del lavoro più che sullo specifico<br />
status sociale collegato all’impiego occupazionale.<br />
32 Ve<strong>di</strong> paragrafo 2.4.<br />
93
nel South Wales e Victoria rispettivamente il 72% e il 22% degli in<strong>di</strong>vidui possiede un titolo<br />
secondario superiore, negli altri stati considerati, tali percentuali scendono al 67 e al 17 per<br />
cento.<br />
Figura 3.3. Sud<strong>di</strong>visione territoriale dell’Australia.<br />
Siccome le ondate migratorie più consistenti dall’Italia sono avvenute negli anni cinquanta e<br />
sessanta, non ci stupisce trovare una forte concentrazione <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> nelle classi<br />
<strong>di</strong> età 30-49 anni (tavola 3.3, colonne 4-7).. Da sottolineare il <strong>di</strong>verso peso dei due generi tra i<br />
sottogruppi, con una maggiore incidenza femminile per gli autoctoni e maschile per le <strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong>. Passando al profilo socioeconomico, è possibile mettere in risalto le forti <strong>di</strong>fferenze<br />
tra i sottogruppi. Se da un lato, le famiglie caratterizzate da genitori entrambi immigrati<br />
dall’Italia mostrano una chiara caratterizzazione operaia, gli autoctoni, ma anche le G2mix, si<br />
situano all’estremo opposto mostrando una incidenza ben maggiore <strong>di</strong> classi me<strong>di</strong>o-alte.<br />
Confrontando i profili socio-economici familiari dei due gruppi <strong>di</strong> età 20-39 anni e 40-69 anni<br />
(tavola 3.4), emerge una sostanziale costanza nell’incidenza della classe operaia per le G2 a<br />
fronte <strong>di</strong> una <strong>di</strong>minuzione tra gli autoctoni. Nel complesso, dunque, contrariamente alle<br />
aspettative, le <strong>di</strong>fferenze in termini <strong>di</strong> classe socio-economico tra questi due sottogruppi si<br />
mostrano crescenti nel passaggio dalle coorti più anziane alle più giovani.<br />
Constatata la forte relazione tra classe sociale <strong>di</strong> appartenenza e istruzione, la<br />
caratterizzazione operaia <strong>delle</strong> G2 da ancora più risalto agli ottimi risultati nel campo<br />
dell’istruzione raggiunti da questo gruppo (mostrati in figura 3.2), soprattutto tra i più giovani.<br />
94
Tavola 3.3. Caratteristiche del campione (dati pesati; 20-69 anni d’età; escluse NT, ACT, TAS e zone<br />
remote). Australia, HILDA 2000.<br />
Età all'intervista<br />
Genere<br />
%<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
Campione nel complesso % <strong>di</strong>stribuzione nei sottogruppi:<br />
% almeno un<br />
titolo <strong>di</strong> scuola<br />
secondaria<br />
superiore<br />
95<br />
% almeno un<br />
titolo <strong>di</strong><br />
istruzione<br />
terziaria<br />
Autoc. 2nd gen. G2mix G2<br />
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)<br />
20-29 22,5 82,3 22,4 21,9 19,6 28,6 14,4<br />
30-39 23,8 75,2 24,5 23,2 39,7 38,8 41,7<br />
40-49 23,3 71,6 23,5 25,1 31,1 16,3 37,1<br />
50-59 18,3 60,1 17,1 18,5 6,2 12,2 3,0<br />
60-69 12,2 52,1 12,1 11,3 3,3 4,1 3,8<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Uomo 49,9 75,7 20,7 48,6 54,5 59,2 53,0<br />
Donna 50,1 65,1 21,1 51,4 45,5 40,8 47,0<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Classe socio -economica<br />
Classe <strong>di</strong> servizio (sup.+inf.) 37,6 82,5 33,2 38,1 23,9 38,8 16,5<br />
Piccola borghesia, impiegati. 40,4 65,6 15,5 41,3 42,1 46,9 40,6<br />
Lavoratori manuali 18,2 56,0 8,5 18,5 28,7 12,2 36,1<br />
Mancante 3,8 70,4 16,9 2,0 5,3 2,0 6,8<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Composizione familiare<br />
Primo <strong>di</strong> 1-3 figli 25,7 77,4 27,4 24,8 30,1 34,0 27,8<br />
Successivo <strong>di</strong> 2-3 figli 26,6 75,2 22,3 27,3 33,5 30,0 35,3<br />
Primo <strong>di</strong> 4+ figli 10,3 67,5 20,5 10,6 8,6 10,0 9,0<br />
Successivo of 4+ figli 36,8 62,7 15,4 37,3 27,8 26,0 27,8<br />
Mancante 0,5 83,3 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Viveva con i genitori a 14 anni<br />
Sì 82,4 71,8 22,3 82,5 91,9 82,0 97,0<br />
Sì, solo con uno 14,3 65,9 15,0 14,6 6,2 12,0 2,3<br />
No 3,3 55,6 11,5 2,9 1,9 6,0 0,8<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Area <strong>di</strong> residenza<br />
New South Wales e Victoria 62,7 72,5 23,2 60,5 67,5 65,3 68,4<br />
Queensland, S. e W. Australia 37,3 66,9 17,2 39,5 32,5 34,7 31,6<br />
100.0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Tornando alla tavola 3.3, è possibile mettere in luce che, a <strong>di</strong>fferenza del caso francese, in<br />
Australia gli autoctoni hanno mostrato nel recente passato una fecon<strong>di</strong>tà più elevata rispetto agli<br />
immigrati italiani, ne è prova la più elevata percentuale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui con più <strong>di</strong> due fratelli.<br />
Infine, si rimarca la maggiore concentrazione <strong>di</strong> famiglie <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana negli stati del New<br />
South Wales e Victoria.
Tavola 3.4 Incidenza <strong>delle</strong> classi socio-economiche all’interno dei sottogruppi definiti in base alla storia<br />
migratoria familiare per gruppi <strong>di</strong> coorti (dati pesati). Australia, HILDA 2000.<br />
20-39 anni<br />
40-69 anni<br />
Aut. 2nd gen G2mix G2 G2 Ita+Gre<br />
Classe <strong>di</strong> servizio 45,5 24,0 41,2 13,5 20,2<br />
Piccola borghesia, impiegati 35,8 40,8 44,1 41,9 37,9<br />
Lavoratori manuali 15,6 27,2 11,8 35,1 33,1<br />
Mancante 3,1 8,0 0,0 9,5 8,9<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Classe <strong>di</strong> servizio 32,0 23,5 33,3 20,7 24,3<br />
Piccola borghesia, impiegati 45,9 44,7 53,3 39,7 40,0<br />
Lavoratori manuali 20,9 30,6 13,3 37,9 34,3<br />
Mancante 1,2 1,2 0,0 1,7 1,4<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
3.5 Analisi multivariata.<br />
Analogamente a quanto visto nel capitolo precedente, l’ausilio <strong>di</strong> modelli logistici binomiali ci<br />
permette <strong>di</strong> valutare le <strong>di</strong>fferenze tra gruppi in termini <strong>di</strong> probabilità <strong>di</strong> raggiungere almeno un<br />
particolare livello d’istruzione al netto dei fattori <strong>di</strong> controllo.<br />
Le ridotte numerosità per il campione australiano non ci permettono <strong>di</strong> scendere nel<br />
dettaglio visto per la Francia tuttavia, non è raro trovare elevate significatività statistiche a<br />
supporto dei risultati. Nella tavola 3.5 e 3.6 si utilizza la definizione più estesa <strong>di</strong> seconda<br />
generazione: in<strong>di</strong>vidui nati in Australia con almeno un genitore nato in Italia (2nd Gen). Come<br />
si può notare, sono stati considerati separatamente due gruppi <strong>di</strong> coorti, tali da identificare<br />
percorsi migratori e formazione scolastica dei figli <strong>di</strong> immigrati avvenuti in perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi.<br />
Nella sostanza, gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> 20-39 anni all’intervista apparterranno molto probabilmente a<br />
nuclei familiari giunti in Australia dagli anni Cinquanta, mentre gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> 40-69 anni,<br />
sono figli <strong>di</strong> immigrati giunti precedentemente. Ogni modello è stato stimato dapprima<br />
introducendo solo la storia migratoria familiare, l’età all’intervista e il genere e poi aggiungendo<br />
le restanti covariate.<br />
A parità <strong>di</strong> altre con<strong>di</strong>zioni, le giovani <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italia na (2nd Gen <strong>di</strong><br />
età 20-39 anni) mostrano un successo scolastico sorprendente: la propensione <strong>di</strong> ottenere<br />
almeno un livello d’istruzione secondario superiore è 1,67 volte quello degli autoctoni nel<br />
modello ridotto e sale a 1,91 in quello completo dove anche la significatività statistica risulta<br />
aumentata (tavola 3.5). Focalizzare sulla probabilità <strong>di</strong> raggiungere un livello terziario (l’analisi<br />
è qui limitata agli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 25-39), non permette, invece, <strong>di</strong> cogliere <strong>di</strong>fferenze<br />
significative tra figli <strong>di</strong> italiani e figli <strong>di</strong> australiani.<br />
Tra i meno giovani (40-69 anni), la situazione è completamente ribaltata: il gruppo 2nd Gen<br />
appare sistematicamente in svantaggio rispetto agli autoctoni continuando a mostrare, anche<br />
dopo aver inserito tutte le covariate considerate nel modello, una probabilità inferiore del 50% e<br />
del 90% <strong>di</strong> ottenere rispettivamente un titolo secondario superiore e terziario (tavola 3.6).<br />
96
Tavola 3.5. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno 1)<br />
un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore; 2) un titolo <strong>di</strong> livello terziario. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong><br />
massima verosimiglianza dei parametri e relativa significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-39 anni<br />
all’intervista. Australia, HILDA 2000.<br />
1.Almeno livello sec. sup. 2.Livello terziario (1)<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 2574 1 1 2068 1 1<br />
2nd Gen 116 1,67 ** 1,91 *** 107 0,90 1,22<br />
Altri figli <strong>di</strong> italiani 13 - - 11 - -<br />
Altro o mancante 2088 1,30 *** 1,31 *** 1658 1,51 1,55 ***<br />
Età all'intervista<br />
20-24 anni 947 1 1<br />
25-29 anni 1130 0,88 0,85 1130 1 1<br />
30-34 anni 1304 0,68 *** 0,67 *** 1304 0,87 0,89<br />
35-39 anni 1410 0,55 *** 0,56 *** 1410 0,80 ** 0,85<br />
Genere<br />
Uomo 2238 1 1 1781 1 1<br />
Donna 2553 0,81 *** 0,82 *** 2063 1,09 1,13<br />
Classe socio -economica<br />
Classe <strong>di</strong> servizio superiore 1492 1 1191 1<br />
Classe <strong>di</strong> servizio inferiore 578 0,57 *** 483 0,61 ***<br />
Impiegati esecutivi 512 0,41 *** 403 0,47 ***<br />
Piccola borghesi a urbana 919 0,34 *** 761 0,27 ***<br />
Piccola borghesia agricola 293 0,40 *** 250 0,31 ***<br />
Lav. manuali qualificati 362 0,28 *** 299 0,18 ***<br />
Lav. manuali non qualificati 403 0,21 *** 330 0,13 ***<br />
Mancante<br />
Composizione familiare<br />
232 0,26 *** 127 0,26 ***<br />
Primo <strong>di</strong> 1-3 figli 1310 1 998 1<br />
Successivo <strong>di</strong> 2-3 figli 1431 0,94 1130 0,74 ***<br />
Primo <strong>di</strong> 4+ figli 424 0,68 *** 347 0,85<br />
Successivo of 4+ figli 1593 0,63 *** 1355 0,61 ***<br />
Mancante<br />
Viveva con i genitori a 14 anni<br />
33 1,92 14 3,26 **<br />
Sì 3779 1 3060 1<br />
Sì, solo con uno 867 0,62 *** 670 0,50 ***<br />
No 145 0,45 *** 114 0,41 ***<br />
Area <strong>di</strong> residenza<br />
New South Wales e Victoria 2832 1 2254 1<br />
Queensland, S. e W. Australia 1959<br />
Costante<br />
0,79 *** 1590 0,95 0,72 ***<br />
4,89 *** 16,45 *** 0,31 *** 0,95<br />
Casi totali 4791 3844<br />
-2 loglikelihood 5018 4693 4235 3846<br />
R2 Cox and Snell 0,015 0,078 0,010 0,108<br />
R2 Nagelkerk 0,023 0,121 0,015 0,158<br />
(numerosità non pesate)<br />
(1) 25-39 anni<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%<br />
97
Tavola 3.6. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno 1)<br />
un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore; 2) un titolo <strong>di</strong> livello terziario. Anti-logarit mo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong><br />
massima verosimiglianza dei parametri e relativa significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 40-69 anni<br />
all’intervista. Australia, HILDA 2000.<br />
1.Almeno livello sec. sup. 2.Livello terziario (1)<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 3228 1 1 3228 1 1<br />
2nd Gen 83 0,57 ** 0,64 ** 83 0,44 ** 0,53 *<br />
Altri figli <strong>di</strong> italiani 95 0,53 *** 0,76 95 0,51 * 0,76<br />
Altro o mancante 2372 1,33 *** 1,31 *** 2372 1,27 *** 1,23 ***<br />
Età all'intervista<br />
40-44 anni 1388 1 1 1388 1 1<br />
45-49 anni 1167 1,00 1,04 1167 0,96 1,01<br />
50-54 anni 1061 0,68 *** 0,67 *** 1061 0,77 *** 0,78 **<br />
55-59 anni 840 0,46 *** 0,47 *** 840 0,49 *** 0,52 ***<br />
60-64 anni 735 0,45 *** 0,47 *** 735 0,48 *** 0,50 ***<br />
65-69 anni 587 0,37 *** 0,39 *** 587 0,37 *** 0,37 ***<br />
Genere<br />
Uomo 2787 1 1 2787 1 1<br />
Donna 2991 0,47 *** 0,45 *** 2991 0,86 ** 0,85 **<br />
Classe socio -economica<br />
Classe <strong>di</strong> servizio superiore 1261 1 1261 1<br />
Classe <strong>di</strong> servizio inferiore 622 0,48 *** 622 0,51 ***<br />
Impiegati esecutivi 549 0,50 *** 549 0,49 ***<br />
Piccola borghesi a urbana 1337 0,39 *** 1337 0,30 ***<br />
Piccola borghesia agricola 722 0,25 *** 722 0,27 ***<br />
Lav. manuali qualificati 534 0,28 *** 534 0,17 ***<br />
Lav. manuali non qualificati 659 0,23 *** 659 0,22 ***<br />
Mancante<br />
Composizione familiare<br />
94 0,49 *** 94 0,49 ***<br />
Primo <strong>di</strong> 1-3 figli 1362 1 1362 1<br />
Successivo <strong>di</strong> 2-3 figli 1385 0,77 *** 1385 0,67 ***<br />
Primo <strong>di</strong> 4+ figli 685 0,66 *** 685 0,61 ***<br />
Successivo of 4+ figli 2340 0,51 *** 2340 0,44 ***<br />
Mancante<br />
Viveva con i genitori a 14 anni<br />
6 0,21 6 0,00<br />
Sì 4888 1 4888 1<br />
Sì, solo con uno 695 0,82 ** 695 0,88<br />
No 195 0,56 *** 195 0,62 **<br />
Area <strong>di</strong> residenza<br />
New South Wales e Victoria 3537 1 3537 1<br />
Queensland, S. e W. Australia 2241<br />
Costante<br />
0,80 *** 2241 0,67 ***<br />
3,47 *** 14,17 *** 0,31 *** 1,30 **<br />
Casi totali 5778 5778<br />
-2 loglikelihood 7104 6681 5373 4942<br />
R2 Cox and Snell 0,066 0,133 0,022 0,093<br />
R2 Nagelkerk 0,090 0,182 0,036 0,151<br />
(numerosità non pesate)<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%<br />
98
Tavola 3.7. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno 1)<br />
un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore; 2) un titolo <strong>di</strong> livello terziario. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong><br />
massima verosimiglianza dei parametri e relativa significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-69 anni<br />
all’intervista. Australia, HILDA 2000.<br />
a.<br />
b.<br />
20(25)-39 anni all'intervista 40-69 anni all'intervista<br />
1.Almeno livello<br />
sec. sup.<br />
99<br />
2.Livello<br />
terziario<br />
1.Almeno livello<br />
sec. sup.<br />
2.Livello<br />
terziario<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 2574 1 1 3228 1 1<br />
G2mix 34 1,27 0,65 17 - -<br />
G2 67 2,00 ** 1,45 56 0,52 ** 0,58<br />
G1,5 4 - - 20 - -<br />
G1 2 - - 72 0,55 ** 0,09 **<br />
Altro o mancante 2110 1,32 *** 1,56 *** 2385 1,31 *** 1,22 ***<br />
20(25)-39 anni all'intervista 40-69 anni all'intervista<br />
1.Almeno livello<br />
sec. sup.<br />
2.Livello<br />
terziario<br />
1.Almeno livello<br />
sec. sup.<br />
2.Livello<br />
terziario<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 2068 1 1 3228 1 1<br />
G2mix Italia e Grecia 40 1,82 1,23 18 - -<br />
G2 Italia e Grecia 106 1,78 ** 1,56 * 69 0,52 *** 0,53<br />
G1,5 Italia e Grecia 7 - - 21 - -<br />
G1 Italia e Grecia 5 - - 102 0,62 ** 0,18 **<br />
Altro o mancante 1618 1,31 *** 1,55 *** 2340 1,33 *** 1,24 ***<br />
NOTA: Gli effetti <strong>delle</strong> altre covariate inserite nei modelli non sono mostrati poiché restano identici a quelli presenti nelle tavole 3.4 e 3.5.<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%<br />
In relazione all’effetto <strong>delle</strong> altre covariate presenti nel modello notiamo in breve come si<br />
confermi l’effetto negativo dell’età all’intervista sul livello d’istruzione e come le donne<br />
tendano a mostrare livelli d’istruzione più bassi. In generale, vengono confermate le in<strong>di</strong>cazioni<br />
viste nell’analisi descrittiva del paragrafo precedente e l’elevata significatività statistica mette in<br />
risalto l’importanza <strong>di</strong> tutte le variabili assunte come fattori <strong>di</strong> controllo.<br />
Ulteriori in<strong>di</strong>cazioni sul successo <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> ci giungono considerando nel<br />
dettaglio i vari sottogruppi dei figli <strong>di</strong> immigrati (tavola 3.7a). Nonostante il basso numero <strong>di</strong><br />
casi tenda a ridurre le significatività statistiche, continua ad apparire fondamentale la <strong>di</strong>stinzione<br />
in base alla coorte <strong>di</strong> nascita. Se tra gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 40-69 anni all’intervista, lo svantaggio in<br />
termini <strong>di</strong> istruzione si conferma anche per le sole G2, tra gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni, appare<br />
chiaro come sia proprio il gruppo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui nati in Australia da genitori entrambi immigrati<br />
dall’Italia a mostrare i migliori risultati con una probabilità doppia <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo<br />
superiore rispetto agli autoctoni, a parità <strong>di</strong> altre con<strong>di</strong>zioni. Con ciò si vuole mettere in risalto<br />
come le performance <strong>delle</strong> giovani G2 nel sistema scolastico siano sottostimate se l’analisi non<br />
tiene conto del <strong>di</strong>verso background familiare. Per gli altri gruppi <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> immigrati italiani, la<br />
scarsa numerosità non permette <strong>di</strong> trarre conclusioni.
Nella tavola 3.7b, sono mostrati i rischi relativi per i vari sottogruppi <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> immigrati <strong>di</strong><br />
provenienza italiana e greca presi congiuntamente. L’obiettivo è quello <strong>di</strong> far crescere le<br />
numerosità in modo da raggiungere livelli <strong>di</strong> significatività più elevati e, quin<strong>di</strong>, sostenere i<br />
risultati già mostrati. Seguendo questa strada, si confermano sia le ottime performance per le G2<br />
tra i 20 e i 39 anni all’intervista (odds ratio pari a 1,78 per un titolo secondario superiore e 1,56<br />
per il terziario), sia gli scarsi risultati <strong>delle</strong> coorti precedenti (odds ratio uguali a 0,52 e 0,53).<br />
L’aumentata numerosità i permette <strong>di</strong> osservare un aumento nella significatività statistica dei<br />
risultati.<br />
Cerchiamo ora <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re l’analisi sulle <strong>di</strong>fferenze tra figli <strong>di</strong> immigrati e autoctoni<br />
concentrando l’attenzione su specifici segmenti sociali. La ridotta numerosità dei casi non ci<br />
permette <strong>di</strong> stimare dei modelli all’interno <strong>di</strong> tre gruppi <strong>di</strong> classi socio-economiche, come si era<br />
fatto per la Francia, riusciamo però a ottenere <strong>delle</strong> stime limitatamente ai figli <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui<br />
appartenenti alle classi socio-economiche me<strong>di</strong>o-basse (in pratica si escludono le classi <strong>di</strong><br />
servizio). Ebbene, all’interno <strong>di</strong> questo sottocampione, le performance dei figli <strong>di</strong> immigrati<br />
italiani <strong>di</strong> età 20-39 all’intervista, risultano ancora più evidenti: a parità degli altri fattori<br />
specificati, la probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo secondario superiore è 2 volte e mezza<br />
superiore a quella degli autoctoni per il gruppo 2nd Gen (tavola 3.8) e più <strong>di</strong> tre volte per il<br />
gruppo G2 (tavola 3.9a). Gli ottimi risultati si estendono anche ai figli <strong>di</strong> immigrati dalla Grecia<br />
(tavola 3.9b). Tutti questi risultati sono supportati da una elevatissima significatività statistica.<br />
Anche per le coorti meno giovani si evidenziano importanti cambiamenti rispetto a quanto<br />
appariva per la totalità del campione. Infatti, sebbene sia per le 2nd Gen che per le G2 <strong>di</strong> <strong>origine</strong><br />
italiana e sud europea il segno <strong>delle</strong> relazioni resta negativo (odds ratio minore <strong>di</strong> uno), le<br />
<strong>di</strong>fferenze non sono più significative.<br />
I risultati relativi alle giovani <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> confermano ed estendono quelli ottenuti<br />
con dati del censimento 1996 i quali mostrano che i figli <strong>di</strong> immigrati italiani e greci <strong>di</strong> 15-21<br />
anni hanno un elevato tasso <strong>di</strong> partecipazione all’istruzione secondaria superiore e universitaria<br />
e una alta proporzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui con qualificazioni post-scolastiche (DIMIA, 2002, pag. 53).<br />
Inoltre, la proporzione <strong>di</strong> iscritti all’università per i figli <strong>di</strong> italiani e greci <strong>di</strong> 20-21 anni è<br />
ad<strong>di</strong>rittura più elevata dei coetanei figli <strong>di</strong> autoctoni se si considerano in<strong>di</strong>vidui con status socio-<br />
economico familiare me<strong>di</strong>o-basso (DIMIA, 2002, pag. 64) il che lascia presumere buone<br />
possibilità <strong>di</strong> impiego e una maggiore mobilità ascendente.<br />
Nell’interpretare i migliori risultati nell’istruzione <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> originarie del<br />
Sud Europa in Australia, Birrell e Khoo (1995) fanno notare come l’importanza data<br />
all’istruzione da parte dei genitori immigrati sia superiore a quella degli autoctoni anche perché<br />
molti immigrati provenienti da quest’area hanno un background agricolo e dunque i loro figli, se<br />
non sorretti da una elevata istruzione, avrebbero ben poche alternative a lavori poco qualificati.<br />
Infine, è stato anche fatto notare che l’espansione della scuola secondaria e terziaria e<br />
soprattutto l’abolizione <strong>delle</strong> tasse universitarie negli anni Settanta, potrebbe aver agevolato<br />
l’accesso all’istruzione per i figli <strong>di</strong> immigrati soprattutto per quelli provenienti da background<br />
meno privilegiati (DIMIA, 2002).<br />
100
Tavola 3.8. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno 1)<br />
un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore; 2) un titolo <strong>di</strong> livello terziario. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong><br />
massima verosimiglianza dei parametri e relativa significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-69 anni<br />
all’intervista appartenenti a classi sociali me<strong>di</strong>o-basse (si escludono le classi <strong>di</strong> servizio). Australia,<br />
HILDA 2000.<br />
20(25)-39 anni all'intervista 40-69 anni all'intervista<br />
1.Almeno livello sec.<br />
sup.<br />
2.Livello terziario<br />
101<br />
1.Almeno livello sec.<br />
sup.<br />
2.Livello terziario<br />
n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig. n Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 1373 1 1114 1 2164 1 2164 1<br />
2nd Gen 81 2,46 *** 76 1,42 66 0,79 66 0,44<br />
Altri figli <strong>di</strong> italiani 8 - 8 - 85 0,77 85 0,91<br />
Altro o mancante 1027 1,27 ** 845 1,47 *** 1486 1,39 *** 1486 1,24<br />
Età all'intervista<br />
20-24 anni 446 1<br />
25-29 anni 574 0,99 574 1<br />
30-34 anni 699 0,76 ** 699 0,86<br />
35-39 anni 770 0,60 *** 770 0,80<br />
40-44 anni 860 1 860 1<br />
45-49 anni 735 1,08 735 0,97<br />
50-54 anni 697 0,65 *** 697 0,71 **<br />
55-59 anni 594 0,46 *** 594 0,48 ***<br />
60-64 anni 508 0,52 *** 508 0,47 ***<br />
65-69 anni 407 0,43 *** 407 0,42 ***<br />
Genere<br />
Uomo 1137 1 930 1 1829 1 1829 1<br />
Donna 1352 0,80 ** 1113 1,20 1972 0,43 *** 1972 0,84 *<br />
Classe socio -economica<br />
Impiegati esecutivi 512 1,00 403 1,00 549 1,00 549 1,00<br />
Piccola borghesi a urbana 919 0,82 761 0,58 *** 1337 0,77 ** 1337 0,63 ***<br />
Piccola borghesia agricola 293 0,96 250 0,67 * 722 0,50 *** 722 0,57 ***<br />
Lav. manuali qualificati 362 0,68 ** 299 0,37 *** 534 0,56 *** 534 0,35 ***<br />
Lav. manuali non qualificati 403 0,51 *** 330 0,28 *** 659 0,45 *** 659 0,46 ***<br />
Composizione familiare<br />
Primo <strong>di</strong> 1-3 figli 637 1 497 1 840 1 840 1<br />
Successivo <strong>di</strong> 2-3 figli 732 0,99 581 0,73 * 853 0,81 ** 853 0,77 **<br />
Primo <strong>di</strong> 4+ figli 209 0,78 173 0,75 445 0,74 ** 445 0,67 **<br />
Successivo of 4+ figli 910 0,66 *** 791 0,65 *** 1662 0,57 *** 1662 0,43 ***<br />
Viveva con i genitori a 14 anni<br />
Sì 1922 1 1609 1 3224 1 3224 1<br />
Sì, solo con uno 496 0,64 *** 374 0,65 ** 458 0,93 458 1,11<br />
No 71 0,46 *** 60 0,53 119 0,66 ** 119 0,62<br />
Area <strong>di</strong> residenza<br />
New South Wales e Victoria 1407 1 1145 1 2281 1 2281 1<br />
Queensland, S. e W. Australia 1082 0,83 ** 898 0,70 *** 1520 0,80 *** 1520 0,70 ***<br />
Costante<br />
5,93 *** 0,44 *** 6,34 *** 0,60 ***<br />
Casi totali 2489 2043 3801 3801<br />
-2 loglikelihood 2791 1586 4738 2719<br />
R2 Cox and Snell 0,052 0,040 0,104 0,042<br />
R2 Nagelkerk 0,075 0,069 0,140 0,079<br />
(numerosità non pesate)<br />
(1) 25-39 anni<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%
Tavola 3.9. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno 1)<br />
un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore; 2) un titolo <strong>di</strong> livello terziario. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong><br />
massima verosimiglianza dei parametri e relativa significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-69 anni<br />
all’intervista appartenenti a classi sociali me<strong>di</strong>o-basse (si escludono le classi <strong>di</strong> servizio). Australia,<br />
HILDA 2000.<br />
a.<br />
b.<br />
20(25)-39 anni all'intervista 40-69 anni all'intervista<br />
1.Almeno livello<br />
sec. sup.<br />
102<br />
2.Livello<br />
terziario<br />
1.Almeno livello<br />
sec. sup.<br />
2.Livello<br />
terziario<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 1373 1 1 2164 1 1<br />
G2mix 20 - - 11 - 0,57<br />
G2 53 3,30 *** 2,39 *** 47 0,70 0,53<br />
G1,5 4 - - 20 - -<br />
G1 1 - - 63 0,53 ** 0,14 *<br />
Altro o mancante 1038 1,28 *** 1,45 *** 1496 1,38 *** 1,23 **<br />
20(25)-39 anni all'intervista 40-69 anni all'intervista<br />
1.Almeno livello<br />
sec. sup.<br />
2.Livello<br />
terziario<br />
1.Almeno livello<br />
sec. sup.<br />
2.Livello<br />
terziario<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 1373 1 1 2164 1 1<br />
G2mix Italia e Grecia 26 - - 12 - 0,55<br />
G2 Italia e Grecia 82 2,54 *** 2,48 *** 56 0,75 0,45<br />
G1,5 Italia e Grecia 6 - - 21 - -<br />
G1 Italia e Grecia 3 - - 90 0,61 ** 0,25 **<br />
Altro o mancante 999 1,27 ** 1,43 *** 1458 1,41 *** 1,26 **<br />
NOTA: gli effetti <strong>delle</strong> altre covariate inserite nei modelli non sono mostrati poiché restano identici a quelli presenti nelle tavole 3.7.<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%<br />
3.6 Conclusioni<br />
Analogamente a quanto appare in Francia, anche in Australia la coorte ha una importanza<br />
cruciale: a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partenza, i risultati scolastici e universitari dei figli <strong>di</strong><br />
immigrati italiani sono inferiori a quelli degli autoctoni per i nati prima del 1960 e migliori per i<br />
nati successivamente. Cosa può aver provocato un tale cambiamento?<br />
Innanzitutto, è cambiata nel tempo la fisionomia del migrante italiano in Australia. Come<br />
sottolineato nel primo paragrafo, gli ultimi protagonisti della grande ondata migratoria, quelli<br />
cioè che sono partiti dopo la metà degli anni Sessanta, hanno un profilo socio-economico<br />
generalmente migliore, dunque livelli d’istruzione più elevati, professionalmente più qualificati,<br />
ma anche una maggiore consapevolezza del loro ruolo <strong>di</strong> immigrati. Non nascendo da necessità<br />
impellenti, la migrazione si configura come una sfida alla propria autorealizzazione e alla<br />
possibilità <strong>di</strong> regalare alla propria famiglia più risorse, più possibilità <strong>di</strong> ascesa sociale. Questo<br />
cambiamento <strong>di</strong> prospettiva e <strong>di</strong> risorse si rifletterebbe sulle possibilità dei loro figli che, in<br />
primis, sarebbero più motivati e stimolati al raggiungimento <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevato. Lo
stesso <strong>di</strong>scorso può essere fatto anche per la Francia, ma probabilmente in Australia è ancora più<br />
calzante: le motivazioni che spingevano oltreoceano, all’altro capo del nostro pianeta, possono<br />
essere <strong>di</strong>verse da quelle che in<strong>di</strong>rizzavano verso un paese ben più vicino come la Francia. Il<br />
basso numero <strong>di</strong> rientri dall’Australia prova da un lato che gli italiani hanno avuto modo <strong>di</strong><br />
inserirsi in questo paese, ma è prova anche <strong>delle</strong> <strong>di</strong>verse ragioni sottostanti la decisione stessa<br />
della partenza. Ricalcando una visione <strong>di</strong>ffusa nella letteratura <strong>delle</strong> migrazioni, maggiore è la<br />
<strong>di</strong>stanza, più forte potrebbe essere il processo <strong>di</strong> selezione insito nella migrazione: tra chi è<br />
partito per la Francia nel secondo dopoguerra, il ritorno in patria non era una possibilità così<br />
remota come invece doveva apparire a chi doveva sostenere i costi per tornare dall’Australia.<br />
Una seconda riflessione attiene alle profonde trasformazioni interne sopravvenute in<br />
Australia nel dopoguerra, in tema <strong>di</strong> politiche sociali, <strong>di</strong> rapporti con l’Inghilterra ma soprattutto<br />
in relazione alle immigrazioni. Il passaggio da una visione strettamente assimilazionista a una <strong>di</strong><br />
stampo multiculturale e la messa in <strong>di</strong>scussione dell’approccio anglocentrico, hanno, con molta<br />
probabilità, contribuito a migliorare l’immagine e le ambizioni degli immigrati e dei loro figli e<br />
a far tramontare l’epoca <strong>delle</strong> <strong>di</strong>scriminazioni. Credo valga la pena <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re l’argomento.<br />
In Australia, <strong>di</strong>versamente da altri paesi <strong>di</strong> immigrazione, è sempre stato piuttosto semplice<br />
ottenere la citta<strong>di</strong>nanza. Nel dopoguerra bastavano 5 anni <strong>di</strong> residenza, successivamente ridotti a<br />
3 e poi a 2 (Castles, Vasta e Lo Bianco, 1992, pag. 125). Vale, inoltre il principio dello jus soli e<br />
dunque, chiunque nasca nel paese ne <strong>di</strong>viene automaticamente citta<strong>di</strong>no. Ma ciò non significa<br />
assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione. Dalla fine della seconda guerra mon<strong>di</strong>ale a tutti gli anni Sessanta, la<br />
con<strong>di</strong>zione per l’ammissione <strong>di</strong> l’immigrato non britannico e non nordeuropeo era <strong>di</strong> accettare il<br />
lavoro proposto dal Department of Immigration per due anni almeno, il che significava lavorare<br />
in località remote o svolgere mansioni rifiutate dai locali. Gli ostacoli per chi non parlava<br />
inglese erano enormi risultando i servizi sociali spesso inaccessibili a chi non conosceva la<br />
lingua. L’orientamento <strong>di</strong> fondo era che qualunque provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sposto per gli immigrati<br />
avrebbe ostacolato l’assimilazione al modello sociale <strong>di</strong> stampo britannico: era meglio che gli<br />
immigrati si immergessero completamente nella società australiana (Castles, Vasta e Lo Bianco,<br />
1992, pag. 126). Per perseguire tale percorso, la scuola doveva avere un ruolo cruciale essendo<br />
capace <strong>di</strong> introiettare la cultura dominante nei figli degli immigrati. Non erano previsti corsi<br />
appositi per le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>, si incoraggiava a parlare esclusivamente in inglese, si<br />
negava che i figli degli immigrati potessero avere particolari problemi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento (IAC,<br />
1960 cit. in Castles, Vasta e Lo Bianco, 1992).<br />
Solo alla fine degli anni Sessanta, constatata l’inapplicabilità del modello assimilazionista a<br />
un paese così fortemente <strong>di</strong>pendente dalle immigrazioni e ricco <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità, si incominciò a<br />
parlare sempre più frequentemente <strong>di</strong> integrazione fino a giungere al multiculturalismo espresso<br />
nel pensiero e nell’azione del governo Whiltman (1972-1975). Questo esecutivo laburista oltre a<br />
introdurre l’assistenza sanitaria sociale, mo<strong>di</strong>ficò ra<strong>di</strong>calmente la politica estera australiana<br />
riducendo la subor<strong>di</strong>nazione agli Stati Uniti, rinunciò definitivamente alla politica dell’Australia<br />
Bianca e mise in seria <strong>di</strong>scussione le politiche <strong>di</strong>scriminatorie e assimilazioniste nei confronti<br />
<strong>delle</strong> minoranza etniche (Castles, 1992, pag 84-85). Il ministro dell’immigrazione del governo<br />
Al Grassby sosteneva che molti immigrati <strong>di</strong> <strong>origine</strong> non anglosassone erano svantaggiati<br />
103
strutturalmente e, pertanto, erano necessari provve<strong>di</strong>menti atti a garantire pari opportunità,<br />
essendo le comunità etniche un arricchimento culturale ed economico per l’Australia (Castles,<br />
Vasta e Lo Bianco, 1992). Fu istituita una Migrant Task Force per accertare le esperienze <strong>delle</strong><br />
comunità etniche e varato l’Australian Assistance Plan teso a migliorare e ristrutturare i servizi<br />
sociali tenendo conto <strong>delle</strong> necessità degli immigrati non britannici, previa consultazione <strong>di</strong><br />
quest’ultimi.<br />
Finalmente si incominciò anche a parlare dei problemi scolastici <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>.<br />
Alcune ricerche misero in luce che costoro ottenevano risultati inferiori a quelli <strong>di</strong> altri studenti.<br />
Il problema venne affrontato seguendo la nuova strategia del multiculturalismo che nello<br />
specifico prevedeva: valorizzazione <strong>delle</strong> lingue parlate dalle varie comunità etniche<br />
rappresentate, insegnamenti bilingui, insegnamento specializzato dell’inglese come seconda<br />
lingua, assunzione <strong>di</strong> insegnanti con titoli esteri e attuazione <strong>di</strong> programmi socio-culturali volti a<br />
favorire una immagine positiva <strong>di</strong> sé nei ragazzi <strong>di</strong> <strong>origine</strong> non anglosassone (Kalantzis e Cope,<br />
1984). L’impostazione multiculturale rimase anche nei governi successivi, sebbene ridefinito<br />
come pluralismo culturale.<br />
Riferimenti bibliografici<br />
Bartocci E. e Cotesta V. (a cura <strong>di</strong>), 1999, L’identità italiana: emigrazione, immigrazione,<br />
conflitti etnici, Roma, E<strong>di</strong>zioni lavoro.<br />
Bertelli L., 1983, La comunità italo -australiana nelle prospettive degli anni ’80, Stu<strong>di</strong><br />
emigrazione, 69, Roma, CSER.<br />
Bertelli L., 1986, A sociocultural profile of the Italian community in Australia , Melbourne,<br />
CIRC paper, 48.<br />
Bertelli L., 1987, Profilo socio -culturale della collettività italiana in Australia , Il Veltro, 31(1-<br />
2), pp. 31-53.<br />
Bevilacqua P., De Clementi A. e Franzina E. (a cura <strong>di</strong>), 2002, Storia dell’emigrazione italiana<br />
Roma, Donzelli E<strong>di</strong>tore.<br />
Birrell B. e Khoo S.E., 1995, The second generation in Australia: educational and occupational<br />
characteristic, Statistical report no. 14, Canberra, Bureau of immigration, multicultural and<br />
population research.<br />
Boncompagni A., 1999, From the appennines to the Bush: «temporary» migrants from Tuscany<br />
and the Western Australia’s «italophobia», 1921-1939, Altreitalie, 19.<br />
Boncompagni A., 1999, Il senso <strong>di</strong> identità nazionale della comunità italiana d’Australia, tra<br />
patriottismi e pulsioni particolaristiche, in Bartocci e Cotesta (1999).<br />
Boncompagni A., 2002, In Australia, in Bevilacqua et al. (2002).<br />
Bureau of statistics, 1995, Yearbook Australia , Canberra.<br />
Bureau of statistics, 1996, Yearbook Australia , Canberra.<br />
Castles S., 1992, Lo sviluppo postbellico dell’Australia, in Castles, Alcorso, Rando e Vasta<br />
(1992).<br />
104
Castles S., 1994, Italians in Australia: the impact of a recent migration on the culture and<br />
society of a post colonial nation, in Tomasi, Gastaldo e Row, 1994.<br />
Castles S., Alcorso C., Rando G. e Vasta E., 1992, Italo-australiani. La popolazione <strong>di</strong> <strong>origine</strong><br />
italiana in Australia , Torino, E<strong>di</strong>zioni della Fondazione Gianni Agnelli.<br />
Castles S., Vasta E. e Lo Bianco J., 1992, Dall’assimilazione al multiculturalismo, in Castles,<br />
Alcorso, Rando e Vasta (1992).<br />
Cavallaio F., 2003, Italians in Australia: migration and profile, Altreitalie, 26.<br />
Collins J., 1988, Migrant hands in a <strong>di</strong>stant land: Australia’s postwar immigration, Sydney,<br />
Pluto Press.<br />
Cresciani G., 1983, L’integrazione dell’emigrazione italiana in Australia e la politica <strong>delle</strong><br />
Trade Unions dagli inizi del secolo al fascismo, in Bezza B., Gli italiani fuori dall’Italia:<br />
gli emigrati italiani nei movimenti operai dei paesi d’adozione 1880-1940, Milano, Franco<br />
Angeli.<br />
Cresciani G., 1988, Italians in Australia: past, present and future, in Affari sociali<br />
internazionali, 2, Milano, Franco Angeli.<br />
DIMIA, 1999, Community profile. 1996 Census. Italy born, Novembre 1999, Canberra.<br />
DIMIA, 2002, Second Generation Australians. Report for the Department of Immigration and<br />
Multicultural and In<strong>di</strong>genous Affairs, Canberra, Aprile 2002.<br />
Erikson R. e Goldthorpe J.H., 1992, The constant flux, Oxford, Clarendon press.<br />
Erikson R., 1984, Social class of men, women and families, Sociology, 4, pp. 500-14.<br />
Giorgias D., 1999, Social <strong>di</strong>stance, social capital and segmented assimilation: the labour and<br />
marriage market experiences of second generation Australians, tesi <strong>di</strong> dottorato,<br />
Australian National University.<br />
Hugo G., 1999, Atlas of Australian people 1996 Census, Canberra, AGPS.<br />
IAC (Commonwealth Immigration Advisory), 1960, Dovey report: progress and assimilation of<br />
migrant children, Canberra, AGPS.<br />
Kalantzis M. e Cope B., 1984, Multiculturalism and education policy, in G. Bottomley and M.<br />
De Lepervanche (a cura <strong>di</strong>), Ethnicity, Class and Gender in Australia, Sydney, George<br />
Allen and Unwin.<br />
Kelley J., 1990, The Failure of a Para<strong>di</strong>gm: Log-linear Models of Social Mobility, pp. 319-346<br />
in Clarke J., Modgil S. e Modgil C. (a cura <strong>di</strong>), John Goldthorpe: Consensus and<br />
Controversy, London: Falmer Press.<br />
MacDonald, 1970, Migration from Italy to Australia: conflict betweeen manifest functions of<br />
Bureaucracy versus latent functions of informal networks, Journal of social history, 3(3).<br />
Martin J. e Meade P., 1979, The educational experience of Sydney High School students,<br />
Canberra, AGPS.<br />
Martin L.M., 1994, Equity and general performance in<strong>di</strong>cators in higher education, volume 1,<br />
Equity in<strong>di</strong>cators, Canberra, AGPS.<br />
Meade P., 1983, The educational experiences of Sydney High school students, report no. 3,<br />
Canberra, AGPS.<br />
105
MIAESR, 2002, Hilda survey annual report 2002, Melbourne Institute of applied economic and<br />
social research, University of Melbourne, www.melbourneinstitute.com .<br />
Thompson S.L., 1980, Australia through Italian eyes: a study of settlers returning from<br />
Australia to Italy , Melbourne, Oxford University Press.<br />
Tomasi L. F., Gastaldo P. e Row T. (a cura <strong>di</strong>), 1994, The Columbus people. Perspective in<br />
Italian immigration to the Americas and Australia, Center for migration stu<strong>di</strong>es e<br />
Fondazione Giovanni Agnelli, New York.<br />
Tosi A., 1984, Immigration and bilingual education: a case study of movement of population,<br />
language change and education within the EEC, New York, Pergamon.<br />
Vasta E., 1992, La seconda generazione, in Castles et al. (1992).<br />
Wilton J. e Bosworth R., 1984, Old worlds and new Australia, Ringwood (Victoria), Penguin.<br />
Zubrzycky J., 1960, Immigrants in Australia: a demographic survey based upon the 1954<br />
census, Department of demography, Australian national University, Canberra.<br />
106
4.1 L’emigrazione italiana in Svizzera.<br />
107<br />
CAPITOLO IV<br />
In Svizzera<br />
L’emigrazione in Svizzera ha una lunga tra<strong>di</strong>zione iniziata nella seconda metà del XIX secolo.<br />
Nel 1900, gli italiani in Svizzera sono 117.000, nel 1910 arrivano a più <strong>di</strong> 200.000, il 37% <strong>di</strong><br />
tutta la componente straniera. Si tratta per lo più <strong>di</strong> e<strong>di</strong>li e operai che scaveranno i trafori alpini<br />
provenienti, in primo luogo, dalle regioni del nordest, Friuli e Veneto (Meyer Sabino, 2002).<br />
Dopo il freno avutosi con la prima guerra mon<strong>di</strong>ale e il fascismo, i flussi migratori ripartono con<br />
rinnovato slancio nel secondo dopoguerra coinvolgendo, in proporzione sempre maggiore, i<br />
lavoratori del Sud e <strong>delle</strong> isole. Nel 1950 i 140.000 italiani costituiscono quasi la metà degli<br />
stranieri; cinque anni dopo arrivano a 160.000 unità (quasi il 60% degli stranieri presenti sul<br />
territorio), <strong>di</strong> cui il 70% proviene dal Nord Italia, l’11% dal Centro e il 19% dal Sud e isole. Nel<br />
1965, la composizione degli italiani è ribaltata con i meri<strong>di</strong>onali che arrivano al 60% (Meyer<br />
Sabino, 2002).<br />
Il flusso verso la Svizzera è particolarmente intenso nel periodo del miracolo economico<br />
italiano. A trainare l’emigrazione è la vicinanza geografica e la forte necessità <strong>di</strong> manodopera<br />
durante lo sviluppo industriale che il paese elvetico sta vivendo in concomitanza con quello<br />
italiano.<br />
Il carattere temporaneo dell’emigrazione italiana in Svizzera è ad<strong>di</strong>rittura più marcato <strong>di</strong><br />
quella in Germania. La specificità <strong>delle</strong> politiche in tema <strong>di</strong> visti e <strong>di</strong> permessi <strong>di</strong> soggiorno<br />
rendono dominante la figura del lavoratore stagionale. Nel secondo dopoguerra, le politiche<br />
svizzere identificano 4 categorie <strong>di</strong> stranieri:<br />
- gli stagionali: non gli è permesso cambiare lavoro né cantone e gli è preclusa la<br />
possibilità <strong>di</strong> farsi raggiungere dalla famiglia. Si tratta <strong>di</strong> addetti nell’e<strong>di</strong>lizia che spesso<br />
abitano in baracche.<br />
- gli annuali: hanno un permesso <strong>di</strong> soggiorno rinnovabile annualmente; possono<br />
cambiare cantone e tipo <strong>di</strong> lavoro e farsi raggiungere dalla famiglia. Dopo 5 anni uno<br />
stagionale <strong>di</strong>venta un annuale.
- i domiciliati: hanno le stesse con<strong>di</strong>zioni degli annuali e possono anche avviare una<br />
attività in proprio.<br />
- i frontalieri: risiedono fuori dalla Svizzera dove però si recano giornalmente a lavorare.<br />
Negli anni cinquanta ad arrivare in Svizzera sono soprattutto uomini occupati nell’e<strong>di</strong>lizia,<br />
nell’industria metalmeccanica e nel settore alberghiero ai quali è concesso un permesso<br />
stagionale. Le mogli che vogliono ricongiungersi con i mariti dovranno a loro volta ottenere un<br />
permesso <strong>di</strong> soggiorno legato al posto <strong>di</strong> lavoro, generalmente nelle industrie tessili.<br />
La popolazione italiana continua a crescere negli anni seguenti toccando nel 1975 la punta<br />
massima <strong>di</strong> 573.000 presenze, i due terzi della popolazione straniera in Svizzera, seguiti da<br />
spagnoli (140.000), jugoslavi (49.000) e i turchi (27.000). Alla metà degli anni ’70, nell’arco <strong>di</strong><br />
cinque anni, gli italiani si ridurranno <strong>di</strong> circa un terzo a causa della grave crisi occupazionale<br />
che costringe al ritorno in patria masse <strong>di</strong> emigrati. Negli anni ottanta e novanta la comunità<br />
italiana continua a ridursi fino ad arrivare, nel 2000, a 319.614 unità, restando, comunque, la<br />
prima comunità straniera in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> importanza costituendo il 40% degli immigrati presenti in<br />
Svizzera (Meyer Sabino, 2002).<br />
Tavola 4.1. Flussi migratori dall’Italia per la Svizzera. Ammontare <strong>di</strong> espatriati e rimpatriati dal 1946 al<br />
1969. Valori in migliaia.<br />
Espatriati Rimpatriati Saldo<br />
1946-51 379 251 128<br />
1952-57 411 337 74<br />
1958-63 675 502 174<br />
1964-69 560 500 60<br />
tot 2079 1644 435<br />
Fonte: CSER[1975]<br />
La collettività italiana è presente soprattutto a Zurigo e nel Ticino. A <strong>di</strong>fferenza della Germania,<br />
la destinazione svizzera mostra da subito un grado maggiore <strong>di</strong> articolazione della presenza, con<br />
un impiego già dagli inizi nel settore terziario (Pugliese, 2002). Dalla fine degli anni Settanta la<br />
popolazione italiana ha conosciuto una crescita costante del numero <strong>di</strong> lavoratori in<strong>di</strong>pendenti,<br />
che ora è prossima a quella degli svizzeri, quantunque i settori <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>vergono da quelli<br />
locali concentrandosi nell’e<strong>di</strong>lizia, ristorazione, manutenzione e servizi alle persone (Cesari<br />
Lusso, 1997).<br />
Tuttavia , gli emigranti italiani in Svizzera e Germania furono tra quelli che incontrarono i<br />
problemi maggiori. Come ci fa notare Ginsborg (1989):<br />
«per <strong>di</strong>eci mesi all’anno non facevano quasi altro che lavorare duramente per<br />
molte ore e vivere in isolamento lontano dalle loro case e dalle persone amate.<br />
[..] Nel 1964 e nel 1965 don Antonio Ribal<strong>di</strong>, <strong>di</strong> Santa Ninfa nel Belice, si recò<br />
in visita ai suoi oltre 500 parrocchiani emigrati in Svizzera. All’entrata <strong>di</strong> un<br />
108
parco pubblico in una città svizzera egli lesse “Vietato l’ingresso ai cani e agli<br />
italiani”. […] Tutti i resoconti confermano l’amara vita degli italiani in nord<br />
Europa» (Ginsborg, 1989, pag. 309).<br />
Gli alloggi sono rari costosi e soprattutto non accessibili agli italiani. Quelli che riuscirono a<br />
raggiungere l’obiettivo <strong>di</strong> un appartamento non potevano, con un permesso stagionale, farsi<br />
raggiungere dai figli. Chi non resisteva alla lontananza li faceva venire <strong>di</strong> nascosto: negli anni<br />
settanta i bambini clandestini italiani erano valutati tra i <strong>di</strong>eci e i quin<strong>di</strong>ci migliaia (Tribune de<br />
Lousanne 12,11, 1971 cit. da Meyer Sabino, 2002).<br />
La situazione <strong>di</strong> clandestinità prevedeva una vita <strong>di</strong> pura reclusione per i giovani figli <strong>di</strong><br />
italiani: il rischio <strong>di</strong> essere scoperti e rimpatriati insieme con i genitori costringeva a non far<br />
rumore, a una vita nel silenzio senza televisione né ra<strong>di</strong>o, senza potersi affacciare alle finestre.<br />
Questa con<strong>di</strong>zione era del tutto incompatibile con la possibilità <strong>di</strong> seguire degli stu<strong>di</strong> regolari.<br />
La forte <strong>di</strong>scriminazione vissuta in questo paese, le dure con<strong>di</strong>zioni abitative, la costante<br />
minaccia del rimpatrio e, più in generale, il senso <strong>di</strong> precarietà degli italiani e <strong>delle</strong> loro<br />
famiglie, vennero sopportate anche grazie alla presenza <strong>di</strong> un forte intreccio <strong>di</strong> solidarietà tra<br />
famiglie italiane. Si svilupparono movimenti, organi <strong>di</strong> stampa, federazioni regionali, circoli<br />
culturali e sportivi, formazioni politiche, strutture previdenziali e assistenziali. La rete<br />
associativa degli italiani in Svizzera sarà la più sviluppata d’Europa contando più <strong>di</strong> mille<br />
strutture (Cesari Lusso, 1997).<br />
Difficilmente la prima generazione rinuncia ai propri valori e alla propria cultura originaria.<br />
Si continua a frequentare connazionali e si forma una sorta <strong>di</strong> comunità autonoma poco integrata<br />
nel contesto svizzero. Da una ricerca della fondazione ECAP sui <strong>di</strong>soccupati risulta che il 20%<br />
parla male o non parla affatto la lingua locale o il <strong>di</strong>aletto e che sono scarsamente integrati. E’<br />
più uno stare accanto che uno stare insieme (ECAP, 2002).<br />
Nonostante le <strong>di</strong>fficoltà iniziali e l’emarginazione sofferta, non sono rari i casi <strong>di</strong> mobilità<br />
ascendente da parte degli italiani, almeno per coloro i quali, superata la forte selezione, hanno<br />
deciso <strong>di</strong> rimanere in Svizzera. I figli degli immigrati che riescono a frequentare dei corsi <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o regolari incontrano spesso grosse <strong>di</strong>fficoltà nei primi anni <strong>di</strong> scuola con il rischio <strong>di</strong><br />
essere emarginati nelle classi speciali, tuttavia, è piuttosto frequente che il gap iniziale con gli<br />
autoctoni venga recuperato alle scuole superiori o all’università (Cesari Lusso, 1997). In<br />
generale, più tar<strong>di</strong>vo è l’arrivo in Svizzera, più <strong>di</strong>fficile l’inserimento e il recupero del ritardo<br />
dovuto alle <strong>di</strong>fficoltà linguistiche iniziali. Quelli che si sono ricongiunti ai genitori solo verso i<br />
14-15 anni e quelli che sono stati pendolari tra Svizzera e Italia sono i più <strong>di</strong>sadattati a scuola e<br />
nel mondo del lavoro (Meyer Sabino, 1997). Vari stu<strong>di</strong> citati da Thränhardt (2004, p.204)<br />
condotti tra il 1982 e il 1998 nella regione <strong>di</strong> Zurigo, riportano il maggior successo degli italiani<br />
nel sistema scolastico rispetto agli altri gruppi immigrati <strong>di</strong> provenienza me<strong>di</strong>terranea. La<br />
situazione è decisamente migliore <strong>di</strong> quella tedesca dove invece la partecipazione scolastica dei<br />
figli d’italiani è scarsa o si concentra nella poco qualificata hauptschule se non ad<strong>di</strong>rittura alle<br />
scuole speciali sonderschule orientate a uno sbocco che esclude l’accesso alle università. Il<br />
risultato particolarmente negativo in Germania <strong>delle</strong> G2 italiane è però parzialmente spiegato<br />
109
dalla loro maggiore concentrazione nei due stati della Baviera e del Baden-Würtemberg dove la<br />
selezione scolastica è più severa e precoce, dove il passaggio ad altri rami del sistema scolastico<br />
è <strong>di</strong>fficile anche per chi ha buoni voti e dove, soprattutto, le politiche scolastiche sono più<br />
segregazioniste. I figli degli italiani sono confluiti per lo più in scuole speciali per studenti<br />
immigrati o <strong>di</strong> lingua straniera create negli anni ’70 per incoraggiare il rientro in patria degli<br />
immigrati.<br />
In generale, Svizzera e Germania sono nazioni con parecchi punti in comune. Con<strong>di</strong>vidono,<br />
tra le altre cose, la lingua, un sistema corporativo in economia e l’istituzione dell’appren<strong>di</strong>stato.<br />
Ma soprattutto, entrambe hanno adottato politiche <strong>di</strong> accesso fortemente limitanti per gli<br />
immigrati basandosi sulla politica del lavoratore ospite (gastarbeit) in una tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non<br />
naturalizzazione. In Svizzera, il <strong>di</strong>battito sulla naturalizzazione è tuttora in corso ma i risultati<br />
dei referendum proposti per agevolare il proce<strong>di</strong>mento (<strong>di</strong> cui l’ultimo nel 2004), quantomeno<br />
per le <strong>seconde</strong> e le terze <strong>generazioni</strong>, hanno sempre avuto esiti negativi. Oggigiorno, in Svizzera<br />
occorrono 12 anni <strong>di</strong> residenza per poter presentare domanda <strong>di</strong> naturalizzazione, sebbene ai fini<br />
del computo le età comprese tra 10 e 19 anni contano doppi (Wanner e Piquet , 2002). Da<br />
segnalare la possibilità della doppia citta<strong>di</strong>nanza, introdotta senza limitazioni dal 1° Gennaio<br />
1992. Pertanto lo straniero naturalizzato non deve più, com'era il caso in precedenza, rinunciare<br />
alla sua citta<strong>di</strong>nanza d'<strong>origine</strong>. Lo Stato italiano è tra quelli che permettono <strong>di</strong> avere una doppia<br />
citta<strong>di</strong>nanza 33<br />
4.2 Il sistema scolastico in Svizzera<br />
La scuola svizzera è fortemente <strong>di</strong>fferenziata al suo interno e la scelta dei percorsi è alquanto<br />
precoce. Le caratteristiche del sistema educativo in Svizzera variano tra i 26 cantoni ma la<br />
struttura è sufficientemente simile tanto da giustificare una descrizione generale. Grosso modo,<br />
è possibile identificare tre gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> istruzione: obbligatorio, secondario superiore e terziario.<br />
1) Livello obbligatorio<br />
La scuola inizia a sei anni e la frequenza, gratuita per tutti gli studenti, è obbligatoria<br />
fino ai 15 anni. La scuola primaria dura dai quattro ai sei anni in base al cantone e la<br />
scuola secondaria inferiore dura tra i 3 e i 5 anni, in base alla durata della primaria. In<br />
tutto, gli anni obbligatori sono comunque 9. La scelta della secondaria inferiore è già<br />
con<strong>di</strong>zionante sul percorso futuro. Si può scegliere tra Realschule, Sekundarschule e<br />
Gymnasium. Le prime due scuole preparano per l’appren<strong>di</strong>stato e il loro completamento<br />
porta all’ottenimento <strong>di</strong> un certificato ufficiale; la terza scuola conduce all’ingresso<br />
nell’università e solo una piccola proporzione, al suo completamento, si <strong>di</strong>rige verso<br />
scuole professionalizzanti (Hong li et al, 1998, pag. 50).<br />
33 Si veda: Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione. Dipartimento<br />
federale <strong>di</strong> giustizia e polizia. http://www.auslaender.ch/einbuergerung/informationen/information_i.asp.<br />
110
2) Livello secondario superiore<br />
Terminata la scuola dell’obbligo, gli stu<strong>di</strong> possono proseguire in una Scuola secondaria<br />
superiore a in<strong>di</strong>rizzo generale che dura solitamente tre o quattro anni, prepara agli stu<strong>di</strong><br />
universitari e porta all’ottenimento della maturità generale (Matura, maturité),.<br />
Tuttavia, la grande maggioranza degli studenti in Svizzera segue un appren<strong>di</strong>stato<br />
(Berufslehren, apprentissage), che prepara alla carriera professionale e che dura tre o<br />
quattro anni. Solitamente l’attività <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato prevede alcuni giorni <strong>di</strong> lavoro<br />
presso una azienda (3 o 4 giorni a settimana) e altri nei quali si tengono lezioni teoriche<br />
presso una scuola professionale (1-1,5 giorni a settimana). Per molte professioni sono<br />
previsti anche dei corsi introduttivi prima che inizi la pratica. Gli studenti possono<br />
scegliere tra circa 300 professioni.<br />
In alternativa, ci sono <strong>delle</strong> scuole me<strong>di</strong>e professionali e centri <strong>di</strong> formazione a tempo<br />
pieno (Lehrwerkstätten e Handellschule ) come, ad esempio, la scuola infermieristica, la<br />
scuola commerciale ecc.. Questo tipo <strong>di</strong> scuola è particolarmente <strong>di</strong>ffuso nell’Ovest<br />
della Svizzera e nel Ticino.<br />
Negli anni più recenti, si è data la possibilità a chi frequenta un appren<strong>di</strong>stato <strong>di</strong> ottenere<br />
la Maturità professionale presso una scuola me<strong>di</strong>a professionale. Questo titolo può<br />
essere ottenuto anche alla fine dell’appren<strong>di</strong>stato frequentando un anno <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o a<br />
tempo pieno o tre semestri a tempo parziale.<br />
Anche i possessori della maturità generale possono ottenere quella professionale dopo<br />
almeno un anno <strong>di</strong> esperienza pratica. Uno dei vantaggi <strong>di</strong> questo titolo è quello <strong>di</strong><br />
semplificare l’ingresso nell’istruzione terziaria permettendo <strong>di</strong> evitare l’esame <strong>di</strong><br />
ammissione.<br />
3) Livello terziario<br />
L’istruzione più elevata si tiene nelle Università, nell’Istituto <strong>di</strong> Tecnologia, nei Collegi<br />
<strong>di</strong> Istruzione Superiore. I corsi universitari sono <strong>di</strong> durata variabile e, una volta<br />
completati, forniscono il titolo <strong>di</strong> Doktor (dottore). Chi completa con successo l’Istituto<br />
<strong>di</strong> Tecnologia <strong>di</strong>venta invece Ingenieur ETH (ingegnere ETH). Ci sono in Svizzera 10<br />
università cantonali e due Istituti Federali <strong>di</strong> Tecnologia .<br />
Dopo un appren<strong>di</strong>stato, è possibile continuare gli stu<strong>di</strong> nelle Scuole professionali<br />
superiori. L’espletamento <strong>di</strong> queste scuole fornisce il titolo <strong>di</strong> Ingenieur HTL, dove<br />
l’abbreviazione HTL serve per <strong>di</strong>stinguere dall’Ingenieur ETH. La <strong>di</strong>fferenza tra queste<br />
due figure sta nel fatto che l’ingegnere ETH ha un background più orientato alla teoria<br />
mentre l’ingegnere HTL ha una impostazione più pratica, anche perché ha alle sue<br />
spalle un appren<strong>di</strong>stato. Ci sono circa settanta collegi <strong>di</strong> istruzione superiore in Svizzera<br />
che nel complesso offrono circa trecento corsi <strong>di</strong>versi (ingegneria, amministrazione,<br />
musica, design, assistenza sociale e sanitaria, ecc.). Fino agli anni ’90, molti <strong>di</strong> questi<br />
corsi, offerti da scuole professionali, non erano considerati allo stesso livello dei corsi<br />
universitari e solo successivamente si è stabilita una sostanziale parità <strong>di</strong> status,<br />
permettendo, dunque, anche agli in<strong>di</strong>vidui con preparazione scolastica <strong>di</strong> tipo<br />
professionale <strong>di</strong> raggiungere un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> livello terziario. Restano tuttavia<br />
111
ancora presenti <strong>delle</strong> scuole professionali <strong>di</strong> livello interme<strong>di</strong>o dove si stu<strong>di</strong>a per<br />
migliorare le proprie competenze nel mondo del lavoro, per rinfrescare la conoscenza <strong>di</strong><br />
pratiche e tecniche professionali e per acquisire capacità organizzative e <strong>di</strong>rigenziali.<br />
Molte <strong>di</strong> queste scuole interme<strong>di</strong>e sono supportate da aziende private sotto la<br />
supervisione del governo federale 34 .<br />
4.3 Dati e definizioni<br />
I dati utilizzati provengono dalla prima wave della indagine panel a cadenza annuale<br />
denominata SHP (Swiss Household Panel) realizzata dall’Università <strong>di</strong> Neuchâtel 35 . Nel 1999,<br />
utilizzando il metodo CATI, sono stati intervistati 7.799 in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> almeno 14 anni <strong>di</strong> età,<br />
presenti in abitazioni private e residenti in maniera permanente in Svizzera. Pertanto, sono stati<br />
esclusi i lavoratori stagionali, i frontalieri e i turisti stranieri 36 .<br />
A <strong>di</strong>fferenza dei dati francesi e australiani, quelli svizzeri presentano alcuni inconvenienti<br />
che ostacolano la definizione dei sottogruppi <strong>di</strong> popolazione in base alla storia migratoria<br />
familiare. Innanzitutto, per coloro i quali <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong> possedere la sola citta<strong>di</strong>nanza svizzera<br />
all’intervista non <strong>di</strong>sponiamo né del luogo <strong>di</strong> nascita né della eventuale data <strong>di</strong> arrivo in<br />
Svizzera. Ci è pertanto impossibile <strong>di</strong>stinguere tra G2, G1,5 e G1. Si conviene allora <strong>di</strong> operare<br />
tale <strong>di</strong>stinzione solo su chi all’intervista conserva ancora la citta<strong>di</strong>nanza italiana (anche se<br />
unitamente a quella svizzera), mentre i figli <strong>di</strong> immigrati italiani che hanno la sola citta<strong>di</strong>nanza<br />
svizzera verranno considerato come un unico gruppo denominato Citt. svizzera. Di fatto, questo<br />
gruppo è costituito per lo più da in<strong>di</strong>vidui con un genitore italiano e uno svizzero, cioè dalle<br />
G2mix, che possiedono nella quasi totalità come unica citta<strong>di</strong>nanza quella svizzera.<br />
In secondo luogo, non è <strong>di</strong>sponibile il luogo <strong>di</strong> nascita dei genitori ma solo la loro<br />
citta<strong>di</strong>nanza alla nascita. Questo aspetto, che non appare come particolarmente problematico 37 ,<br />
impone però <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare leggermente le definizioni:<br />
- Autoctoni: in<strong>di</strong>vidui figli <strong>di</strong> genitori entrambi con citta<strong>di</strong>nanza svizzera alla nascita.<br />
- Seconda generazione (stricto sensu) (G2): in<strong>di</strong>vidui con citta<strong>di</strong>nanza italiana<br />
all’intervista, nati in Svizzera da genitori entrambi con la sola citta<strong>di</strong>nanza italiana alla<br />
nascita.<br />
34<br />
Le informazioni sul sistema scolastico svizzero sono tratte dal portale dell’istruzione<br />
http://www.educa.ch/dyn/67528.htm<br />
35<br />
Il progetto è finanziato dal Swiss National Science Foundation (Grants 5004-53205 / 5004-57894 /<br />
5004-67304 / 10FI11-103293 / 10FI13-108500/1).<br />
36<br />
Maggiori informazioni sul sito http://www.swisspanel.ch/.<br />
37<br />
Dato che storicamente la Svizzera si è sempre avvalsa dello ius sanguinis per l’acquisizione della<br />
citta<strong>di</strong>nanza, è esclusa la possibilità <strong>di</strong> avere la citta<strong>di</strong>nanza svizzera alla nascita per un figlio <strong>di</strong><br />
immigrato. Dunque, un genitore con nazionalità italiana alla nascita sarà un immigrato o, al più, un<br />
appartenente alla seconda generazione. Dato che il grosso dei flussi verso la Svizzera si è avuto nella<br />
seconda metà del XX secolo, è molto più probabile che ci si trovi nel primo caso.<br />
112
- Generazione 1,5 (G1,5): in<strong>di</strong>vidui con citta<strong>di</strong>nanza italiana all’intervista con genitori<br />
entrambi con la sola citta<strong>di</strong>nanza italiana alla nascita, nati fuori dalla Svizzera e ivi<br />
giunti prima del decimo compleanno<br />
- Generazione 1 (G1): in<strong>di</strong>vidui con citta<strong>di</strong>nanza italiana all’intervista con genitori<br />
entrambi italiani alla nascita, nati fuori dalla Svizzera e ivi giunti dopo il decimo<br />
compleanno<br />
- Figli <strong>di</strong> italiani con citta<strong>di</strong>nanza svizzera (Citt. Svizzera): in<strong>di</strong>vidui in possesso della<br />
sola citta<strong>di</strong>nanza svizzera all’intervista con almeno un genitore avente citta<strong>di</strong>nanza<br />
italiana alla nascita. All’interno <strong>di</strong> questo gruppo non è possibile <strong>di</strong>stinguere tra chi<br />
appartiene alla seconda generazione (nato in Svizzera), chi alla prima (immigrato dopo i<br />
10 anni) o a quella 1,5 (giunto entro i primi 10 anni <strong>di</strong> vita) 38 .<br />
.<br />
Il campione analizzato è stato limitato agli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età compresa tra 25 e 49 anni<br />
all’intervista. Il limite <strong>di</strong> età minimo è stato innalzato a 25 anni dato che la pratica <strong>di</strong>ffusa <strong>di</strong><br />
alternare perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> lavoro con perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o fa crescere l’età me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> ottenimento <strong>di</strong> un<br />
titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o secondario superiore a oltre 20 anni 39 . D’altra parte, oltre i 50 anni i figli <strong>di</strong><br />
italiani del campione sono praticamente assenti o confluiscono nella categoria Citt. svizzera. La<br />
ridotta finestra <strong>di</strong> età <strong>di</strong>sponibili non ci permette <strong>di</strong> fare un confronto tra “vecchie” e “nuove”<br />
<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> così come avveniva per gli altri paesi.<br />
Tavola 4.2. Il campione SHP (dati pesati, 25-49 anni).<br />
Autoctoni 2.101 57,9%<br />
G2 105 2,9%<br />
G1,5 51 1,4%<br />
G1 130 3,6%<br />
Citt. svizzera 72 2,0%<br />
Altro o mancante 1170 32,2%<br />
Totale 3630 100%<br />
In tavola 4.2 possiamo leggere le numerosità dei sottogruppi ottenuti con le definizioni<br />
specificate 40 . Analogamente a quanto visto nel caso australiano, la ridotta numerosità dei<br />
38 In quanto citta<strong>di</strong>no svizzeri dalla nascita, chi ha un genitore italiano e uno svizzero ricade<br />
interamente in questo gruppo. Sebbene sia possibile <strong>di</strong>stinguere chi ha entrambi i genitori italiani da chi<br />
ne ha uno solo, non possiamo definire il gruppo G2mix come fatto nei capitoli precedenti. Infatti, in tale<br />
gruppo ricadevano coloro i quali, figli <strong>di</strong> un genitore italiano e uno autoctono, erano nati nel paese <strong>di</strong><br />
destinazione. Non <strong>di</strong>sponendo dell’informazione sul luogo <strong>di</strong> nascita, tale <strong>di</strong>stinzione non è realizzabile.<br />
39 In particolare abbiamo che per il totale del campione l’età me<strong>di</strong>a al conseguimento <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong><br />
scuola secondaria superiore è <strong>di</strong> 21,5 anni (età me<strong>di</strong>ana 20 anni), mentre per un titolo terziario sale a 27,8<br />
anni (età me<strong>di</strong>ana 27 anni).<br />
40 La categoria “altro o mancante” si riferisce a:<br />
8) in<strong>di</strong>vidui con almeno un genitore con una citta<strong>di</strong>nanza alla nascita <strong>di</strong>versa da quella svizzera o<br />
italiana (ad esempio, chi ha almeno un genitore tedesco o turco) (1100 casi);<br />
113
sottogruppi oggetto d’indagine, ci invita a procedere con <strong>delle</strong> riaggregazioni. La prima strada è<br />
quella <strong>di</strong> considerare congiuntamente i figli <strong>di</strong> immigrati dal Sud Europa (Italia, Spagna,<br />
Portogallo e Grecia). Tuttavia, le numerosità non crescono <strong>di</strong> molto (le G2 salgono a 130<br />
in<strong>di</strong>vidui e le G1,5 a 77), a <strong>di</strong>mostrazione dell’importanza della componente <strong>di</strong> seconda<br />
generazione <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana in Svizzera. Più considerevole è invece l’aumento del numero<br />
degli immigrati <strong>di</strong>retti (le G1 salgono a 240). A <strong>di</strong>fferenza del caso australiano, non possiamo<br />
utilizzare la definizione estesa <strong>di</strong> seconda generazione (in<strong>di</strong>vidui nati in Svizzera da almeno un<br />
genitore nato in Italia) restando cruciale il luogo <strong>di</strong> nascita che, lo ripetiamo, ci sfugge per<br />
alcuni in<strong>di</strong>vidui tra i quali, in primo luogo, i figli <strong>di</strong> genitori <strong>di</strong> <strong>origine</strong> mista Un modo<br />
alternativo <strong>di</strong> procedere è <strong>di</strong> mettere insieme le categorie G2 e G1,5.<br />
Figura 4.1. Distribuzione percentuale dei titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (almeno un titolo secondario superiore e almeno<br />
un titolo terziario) all’interno dei sottogruppi <strong>di</strong> popolazione definiti in base alla storia migratoria<br />
familiare. Svizzera, SHP, 1999.<br />
100,0<br />
80,0<br />
60,0<br />
40,0<br />
20,0<br />
0,0<br />
Autoctoni G2 Italia G1,5 Italia G1 Italia Cittad.<br />
Svizzera<br />
Almeno titolo sec. sup. Titolo terziario o iscritto<br />
4.4 Una descrizione del campione<br />
La nostra attenzione ricade, ancora una volta, sulla probabilità <strong>di</strong> ottenere<br />
a) almeno un livello d’istruzione secondaria superiore (maturità generale e<br />
professionale, appren<strong>di</strong>stato, centri <strong>di</strong> formazione a tempo pieno e scuole me<strong>di</strong>e<br />
professionali; sono esclusi i corsi professionali <strong>di</strong> durata non superiore a un anno);<br />
b) un livello terziario (titolo ottenuto in Università, Istituto <strong>di</strong> Tecnologia, Collegi <strong>di</strong><br />
Istruzione Superiore, Scuole professionali superiori).<br />
Bisogna però precisare che essendo l’età me<strong>di</strong>a e me<strong>di</strong>ana al conseguimento <strong>di</strong> un livello<br />
terziario superiore ai 25 anni (si veda nota 7), la probabilità <strong>di</strong> conseguire il solo livello terziario<br />
9) in<strong>di</strong>vidui nati all’estero da entrambi i genitori svizzeri o da un genitore italiano e uno svizzero<br />
(12 casi).<br />
10) in<strong>di</strong>vidui per i quali l’in<strong>di</strong>cazione del paese <strong>di</strong> nascita <strong>di</strong> almeno un genitore è mancante (58<br />
casi).<br />
114
ichiederebbe la limitazione alle classi <strong>di</strong> età 30-49 anni, con una conseguente ulteriore<br />
<strong>di</strong>minuzione <strong>delle</strong> numerosità. Per evitare questo effetto, si considera alla stessa stregua <strong>di</strong> chi<br />
ha raggiunto un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> livello terziario anche chi all’intervista sta ancora<br />
frequentando un corso che da accesso a un tale titolo. In altri termini, si pone come variabile<br />
<strong>di</strong>pendente la dummy “ probabilità <strong>di</strong> possedere un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o o <strong>di</strong> frequentare un corso che<br />
da accesso a un titolo <strong>di</strong> livello terziario all’intervista (sì/no)”.<br />
Così come appariva per l’Australia, anche in Svizzera, paese caratterizzato da una elevata<br />
scolarizzazione, i figli <strong>di</strong> immigrati italiani possono vantare quote elevate <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in<br />
possesso almeno <strong>di</strong> un titolo secondario superiore (figura 4.1), mostrando <strong>di</strong> essere competitivi<br />
rispetto agli autoctoni, mentre la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> livello terziario (o <strong>di</strong> iscritti a corsi <strong>di</strong> tale<br />
livello) è maggiore tra questi ultimi.<br />
Seguendo lo stesso schema <strong>di</strong> ipotesi e la stessa letteratura vista nel caso francese, le variabili <strong>di</strong><br />
controllo incluse nel modello sono le seguenti:<br />
a) età all’intervista (tre classi: 25-29; 30-39; 40-49);<br />
b) genere;<br />
c) Classe sociale <strong>di</strong> appartenenza. Si è scelto <strong>di</strong> utilizzare la classificazione socio-<br />
occupazionale dei genitori ai 14 anni dell’intervistato, già <strong>di</strong>sponibile nel database SHF<br />
(Joye, Bergman e Bukowski, 2002). Si tratta <strong>di</strong> un adattamento operato da Ganzeboom 41<br />
dello schema classificator io <strong>di</strong> Goldhtorpe (1987). Nella sua versione a 10 categorie,<br />
viene determinato integrando <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>mensioni, tra le quali il titolo occupazionale<br />
basato sulla classificazione ISCO-88, il grado <strong>di</strong> autonomia del lavoro, il numero <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>pendenti 42 . Riaggregando alcune <strong>delle</strong> categorie previste, otteniamo, per ogni<br />
genitore, una variabile con le seguenti modalità:<br />
1) Classe <strong>di</strong> servizio (amministratori, <strong>di</strong>rigenti e quadri superiori e inferiori);<br />
2) Classe me<strong>di</strong>a impiegatizia (impiegati esecutivi);<br />
3) Lavoratori autonomi (lavoratori in<strong>di</strong>pendenti con e senza addetti);<br />
4) Piccola borghesia agricola (agricoltori in<strong>di</strong>pendenti);<br />
5) Lavoratori manuali (capomastri, operai qualificati, operai semi e non qualificati,<br />
operai agricoli).<br />
La classe sociale per l’intero nucleo familiare si ottiene seguendo il “principio <strong>di</strong><br />
dominanza” 43 (Erikson, 1984).<br />
d) Livello d’istruzione del padre e della madre. Uno dei vantaggi del database SHP è<br />
quello <strong>di</strong> fornire il livello d’istruzione dei genitori, spesso usato come proxy per<br />
determinare l’ammontare <strong>di</strong> capitale umano posseduto dai genitori e capace <strong>di</strong><br />
influenzare fortemente le scelte nel campo dell’istruzione da parte dei figli. Per ogni<br />
genitore si raggruppa il titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o più elevato posseduto nelle tre modalità:<br />
- titolo basso (scuola dell’obbligo o inferiore);<br />
41 Si veda http://www.fss.uu.nl/soc/hg/isko88/ ma anche Gamzeboom e Luijkx (2001).<br />
42 Si veda Bergman e Joye (2001) per una presentazione più dettagliata.<br />
43 Ve<strong>di</strong> paragrafo 2.4.<br />
115
- titolo me<strong>di</strong>o (maturità generale e professionale, appren<strong>di</strong>stato, centri <strong>di</strong><br />
formazione a tempo pieno e scuole me<strong>di</strong>e professionali);<br />
- titolo alto (titolo ottenuto in Università, Istituto <strong>di</strong> Tecnologia, Collegi <strong>di</strong><br />
Istruzione Superiore, Scuole professionali superiori).<br />
Nei modelli si considererà il livello d’istruzione dei genitori in maniera congiunta<br />
(entrambi basso, uno me<strong>di</strong> e uno basso, entrambi me<strong>di</strong>o, almeno uno alto).<br />
e) Viveva con entrambi i genitori a 15 anni <strong>di</strong> età 44 ;<br />
Tavola 4.3. Caratteristiche del campione (dati pesati; 25-49 anni d’età). Svizzera, SHF 1999.<br />
Età all'intervista<br />
Genere<br />
%<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
Campione nel complesso % <strong>di</strong>stribuzione nei sottogruppi:<br />
% almeno un<br />
titolo <strong>di</strong> scuola<br />
secondaria<br />
116<br />
superiore<br />
% in possesso<br />
<strong>di</strong> titolo<br />
terziario o<br />
iscritto<br />
Autoc. G2 Italia G1,5 Italia<br />
(1) (2) (3) (4) (5) (6)<br />
25-29 17,4 90,6 35,4 16,3 35,2 15,4<br />
30-39 44,3 86,5 32,8 41,4 56,2 53,8<br />
40-49 38,3 84,0 28,8 42,3 8,6 30,8<br />
100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Uomo 50,0 91,3 42,3 49,7 57,1 71,2<br />
Donna 50,0 81,2 21,2 50,3 42,9 28,8<br />
100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Classe socioeconomica<br />
Classe <strong>di</strong> servizio 36,1 93,2 46,8 38,0 10,4 7,7<br />
Lavoratori autonomi 13,7 87,1 28,4 13,3 13,2 1,9<br />
Classe me<strong>di</strong>a impiegatizia 11,0 87,5 27,7 11,8 8,5 9,6<br />
Piccola borghesia agricola 9,4 71,8 21,7 12,1 0,0 0,0<br />
Lavoratori manuali 28,3 82,3 19,3 23,9 67,9 80,8<br />
Mancante 1,5 66,7 24,1 0,8 0,0 0,0<br />
100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Livello d'istruzione dei genitori<br />
Entrambi basso 29,8 71,8 16,1 21,2 72,6 64,7<br />
Uno me<strong>di</strong>o e uno basso 24,3 89,0 26,7 29,0 19,8 15,7<br />
Entrambi me<strong>di</strong>o 25,7 94,3 35,6 30,0 7,5 17,6<br />
Almeno uno alto 20,1 94,0 56,1 19,8 0,0 2,0<br />
100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Viveva con entrambi i genitori a 15 anni<br />
Sì 85,0 87,6 32,3 88,6 88,7 98,0<br />
Solo con un genitore 11,8 80,2 29,5 9,6 9,4 2<br />
No 3,1 74,6 24,6 1,8 1,9 0,0<br />
100,0 100,0 100,0 100,0<br />
44 A <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto visto per la Francia e l’Australia, nel database svizzero manca<br />
completamente l’in<strong>di</strong>cazione del numero <strong>di</strong> fratelli/sorelle e l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> nascita. L’unica informazione a<br />
riguardo è fornita dalla risposta al quesito “Viveva nella stessa casa con fratelli o sorelle a 15 anni?”, che<br />
però, se introdotta nei modelli multivariati, non fornis ce risultati significativi degni <strong>di</strong> nota.
La tavola 4.3 contiene per le modalità <strong>delle</strong> variabili appena enunciate, le <strong>di</strong>stribuzioni<br />
percentuali nel campione (colonna 1), la percentuale <strong>di</strong> persone in possesso almeno <strong>di</strong> un titolo<br />
<strong>di</strong> scuola secondaria superiore (colonna 2), la percentuale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in possesso <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong><br />
livello terziario o iscritto a un corso <strong>di</strong> tale livello (colonne 3) e la <strong>di</strong>stribuzione nei sottogruppi<br />
degli autoctoni, <strong>delle</strong> G2 e <strong>delle</strong> G1,5 <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana (colonne 4-6).<br />
La piccola finestra <strong>delle</strong> età considerate non ci permette <strong>di</strong> delineare un quadro storico<br />
dell’evoluzione della scolarità in Svizzera nonché <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze tra autoctoni e <strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong>. Ad ogni modo, sebbene si parta già da livelli elevati per chi all’intervista ha tra i 40<br />
e i 50 anni, la presenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui con alti titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è andata crescendo nel tempo, sia<br />
relativamente all’istruzione secondaria superiore, sia a quella terziaria, dove, lo ricor<strong>di</strong>amo, le<br />
percentuali tengono conto anche <strong>di</strong> chi sta partecipando a questo grado d’istruzione senza aver<br />
ancora raggiunto il titolo.<br />
Come ci si poteva attendere in un paese come la Svizzera ancora le gato a forti <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong><br />
genere, sono gli uomini a mostrare i risultati migliori: ben il 42% degli uomini ha un titolo<br />
terziario o partecipa a un corso <strong>di</strong> tale livello all’intervista, la metà tra le donne.<br />
In linea con le attese è anche l’influenza della categoria socio-professionale e dell’istruzione<br />
dei genitori: avere dei genitori con bassa istruzione e con lavori meno prestigiosi non facilita il<br />
proseguimento degli stu<strong>di</strong> dei figli. Infine, una situazione <strong>di</strong> svantaggio è costituita anche dal<br />
non aver vissuto con entrambi i genitori nell’adolescenza.<br />
Sempre sulla tavola 4.2, passando alle colonne 4-6, notiamo la <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>stribuzione dei<br />
caratteri evidenziati tra i sottogruppi degli autoctoni e <strong>delle</strong> G2 e G1,5 dall’Italia. Innanzitutto, il<br />
profilo per età è più giovane tra i figli <strong>di</strong> immigrati italiani (soprattutto per le G2) e la presenza<br />
<strong>di</strong> uomini è decisamente più elevata nelle G2 e soprattutto nelle G1,5. Ma ciò che colpisce <strong>di</strong><br />
più è la straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong>fferenza nel background familiare: se per gli autoctoni la classe dei<br />
lavoratori manuali incide per il 24%, per i figli <strong>di</strong> immigrati si arriva al 68% per le G2 e<br />
ad<strong>di</strong>rittura all’81% per la G1,5 45 . E’ però opportuno sottolineare che per i genitori italiani<br />
immigrati l’incidenza dei specializzati nella classe dei lavoratori manuali è superiore a quella<br />
degli autoctoni, essendo del 56% per i primi e del 49% per i secon<strong>di</strong>.<br />
Parallelamente alla caratterizzazione socio-economica, si segnala anche la bassissima<br />
incidenza <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati (secondari superiori o terziari) dei genitori provenienti<br />
dall’Italia. Quasi l’80 degli autoctoni ha almeno un genitore con un titolo superiore all’obbligo<br />
scolastico, la stessa percentuale scende al 27% per le G2 e al 35% per la G1,5.<br />
Le minori risorse familiari dei figli <strong>di</strong> immigrati italiani, si in termini <strong>di</strong> status sociale che <strong>di</strong><br />
capitale umano, danno maggior rilievo alla elevata incidenza <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati che<br />
avevamo osservato in figura 4.1. Ma approfon<strong>di</strong>amo questo aspetto sviluppando una analisi<br />
multivariata.<br />
45 L’insieme <strong>delle</strong> G2 provenienti dal Sud Europa mostra una <strong>di</strong>stribuzione <strong>delle</strong> classi socioeconomiche<br />
quasi coincidente con quella <strong>delle</strong> G2 dalla sola Italia<br />
117
Tavola 4.4. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno a)<br />
un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore; b) un titolo <strong>di</strong> livello terziario o essere iscritto a un corso <strong>di</strong> tale<br />
livello all’intervista. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong> massima verosimiglianza dei parametri e relativa<br />
significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-49 anni all’intervista. Svizzera, SHF 1999.<br />
Almeno livello sec. sup. Livello terziario raggiunto o in corso<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 2608 1 1 1 1<br />
G2 Italia 77 1,08 1,92 * 0,56 ** 1,39<br />
G1,5 Italia 36 1,66 2,56 0,53 * 1,15<br />
G1 Italia 92 0,05 *** 0,10 *** 0,23 *** 0,48 **<br />
Citt. Svizzera 91 0,84 0,91 0,63 0,79<br />
Altro o mancante 1098 0,49 *** 0,54 *** 1,33 *** 1,42 ***<br />
Età all'intervista<br />
25-29 anni 608 1 1 1 1<br />
30-39 anni 1802 0,68 ** 0,76 0,93 1,06<br />
40-49 anni 1592 0,54 *** 0,66 ** 0,75 *** 0,93<br />
Genere<br />
Uomo 1724 1 1 1 1<br />
Donna 2278 0,36 *** 0,35 *** 0,35 *** 0,32 ***<br />
Classe socio -economica<br />
Classe <strong>di</strong> servizio 1473 1 1<br />
Classe me<strong>di</strong>a impiegatizia 559 0,71 * 0,63 ***<br />
Lavoratori autonomi 452 0,73 0,55 ***<br />
Piccola borghesia agricola 389 0,34 *** 0,61 ***<br />
Lavoratori manuali 1073 0,67 ** 0,45 ***<br />
Mancante 56 0,44 ** 0,70<br />
Livello d’istruzione dei genitori<br />
Entrambi basso 1083 1 1<br />
Uno me<strong>di</strong>o e uno basso 1031 2,14 *** 1,81 ***<br />
Entrambi me<strong>di</strong>o 1076 3,95 *** 2,33 ***<br />
Almeno uno alto<br />
Viveva con i genitori a 15 anni<br />
812 3,58 *** 4,79 ***<br />
Sì 3420 1 1<br />
Solo con un genitore 460 0,63 *** 0,90<br />
No<br />
Costante<br />
122 0,69 0,84<br />
27,34 18,21 *** 0,84 0,50 ***<br />
Casi totali 4002<br />
-2 loglikelihood 2579 2357 4268 3901<br />
R2 Cox and Snell 0,086 0,140 0,071 0,161<br />
R2 Nagelkerk 0,156 0,254 0,100 0,225<br />
(numerosità non pesate)<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%;<br />
118
Tavola 4.5. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere 1) almeno<br />
un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore; 2) un titolo <strong>di</strong> livello terziario o essere iscritto a un corso <strong>di</strong> tale<br />
livello all’intervista. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong> massima verosimiglianza dei parametri e relativa<br />
significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-49 anni all’intervista. Svizzera, SHF 1999.<br />
a.<br />
1. Almeno livello sec. sup.<br />
119<br />
2.Livello terziario raggiunto o in<br />
corso<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 2608 1 1<br />
G2 + G1,5 Italia 113 2,08 ** 1,30<br />
G1 Italia 92 0,10 *** 0,48 **<br />
Citt. Svizzera 91 0,91 0,79<br />
Altro o mancante 1098 0,54 *** 1,42 ***<br />
b.<br />
1. Almeno livello sec. sup.<br />
2. Livello terziario raggiunto o in<br />
corso<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 2608 1 1<br />
G2 Sud Europa 93 2,21 ** 1,38<br />
G1.5 Sud Europa 54 0,64 0,60<br />
G1 Sud Europa 171 0,11 *** 0,49 ***<br />
Citt. Svizzera 105 0,80 0,82<br />
Altro o mancante 971 0,73 ** 1,57 ***<br />
NOTE: gli effetti <strong>delle</strong> altre covariate inserite nei modelli non sono mostrati poiché restano identici a quelli presenti nella tavola 4.3.<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%;<br />
Sud Europa: Italia, Spagna, Portogallo e Grecia.<br />
4.5 Analisi multivariata<br />
Come era lecito attendersi dopo la descrizione del campione realizzata nel pre<strong>di</strong>cente paragrafo,<br />
i modelli logit confermano e mettono in risalto le buone performance dei figli degli immigrati<br />
italiani. Nella tavola 4.4, è possibile vedere come la probabilità <strong>di</strong> raggiungere almeno un titolo<br />
secondario superiore è quasi doppia per un in<strong>di</strong>viduo appartenente alla G2 <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana<br />
rispetto a un autoctono svizzero. La significatività statistica non molto elevata (maggiore del<br />
90%) associata a questo risultato è molto probabilmente dovuta alla scarsa numerosità del<br />
sottogruppo in questione. Ne è prova l’incremento <strong>di</strong> significatività che si assiste osservando lo<br />
stesso risultato per le G2 e G1,5 considerate congiuntamente nella tavola 4.5a (odds ratio pari a<br />
2 con significatività statistica maggiore del 95%) e per le G2 dal Sud Europa in tavola 4.5b<br />
(odds ratio pari a 2,21 e significatività maggiore del 95%). Non si palesano, invece, <strong>di</strong>fferenze<br />
significative relativamente alla probabilità <strong>di</strong> possedere un titolo terziario o essere iscritto a un<br />
corso che conduce a tale livello, qualunque sia la classificazione considerata. In altri termini, a<br />
parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni familiari <strong>di</strong> partenza, anche nei livelli più elevati <strong>di</strong> istruzione, le <strong>seconde</strong><br />
<strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana non mostrano <strong>di</strong>fficoltà particolari rispetto ai pari età figli <strong>di</strong><br />
citta<strong>di</strong>ni svizzeri dalla nascita.
I figli <strong>di</strong> italiani in possesso della sola citta<strong>di</strong>nanza svizzera, se da un lato non palesano<br />
particolari <strong>di</strong>fferenze rispetto agli autoctoni, dall’altro non sembrano stare al passo con gli altri<br />
figli <strong>di</strong> immigrati. Infine, segnaliamo la scarsissima <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati negli<br />
immigrati italiani (G1).<br />
Tavola 4.6. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno a)<br />
un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore; b) un titolo <strong>di</strong> livello terziario o essere iscritto a un corso <strong>di</strong> tale<br />
livello all’intervista. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong> massima verosimiglianza dei parametri e relativa<br />
significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-49 anni all’intervista appartenenti a classi sociali me<strong>di</strong>o-basse<br />
(si escludono le classi <strong>di</strong> servizio). Svizzera, SHF 1999.<br />
Almeno livello sec. sup.<br />
Livello terziario raggiunto o in<br />
corso<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni 1602 1 1<br />
G2 Italia 70 2,33 * 1,72 **<br />
G1,5 Italia 33 2,44 1,25<br />
G1 Italia 80 0,08 *** 0,37 ***<br />
Citt. Svizzera 71 0,83 0,85<br />
Altro o mancante 617 0,49 *** 1,21<br />
Età all'intervista<br />
25-29 anni 333 1 1<br />
30-39 anni 1096 0,78 1,43 **<br />
40-49 anni 1044 0,72 1,26<br />
Genere<br />
Uomo 1078 1 1<br />
Donna 1395 0,35 *** 0,32 ***<br />
Classe socio -economica<br />
Classe me<strong>di</strong>a impiegatizia 559 1 1<br />
Lavoratori autonomi 452 1,05 0,88<br />
Piccola borghesia agricola 389 0,49 *** 0,93<br />
Lavoratori manuali<br />
Livello d’istruzione dei genitori<br />
1073 0,96 0,67 ***<br />
Entrambi basso 922 1 1<br />
Uno me<strong>di</strong>o e uno basso 744 2,24 *** 1,78 ***<br />
Entrambi me<strong>di</strong>o 600 4,36 *** 2,37 ***<br />
Almeno uno alto<br />
Viveva con i genitori a 15 anni<br />
207 3,50 *** 4,01 ***<br />
Sì 2102 1 1<br />
Solo con un genitore 296 0,72 * 0,87<br />
No<br />
Costante<br />
75 0,83 1,29<br />
12,18 *** 0,26 ***<br />
Casi totali 1462<br />
-2 loglikelihood 1684 2224<br />
R2 Cox and Snell 0,163 0,095<br />
R2 Nagelkerk 0,270 0,144<br />
(numerosità non pesate)<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%;<br />
120
Tavola 4.7. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno 1)<br />
un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore; 2) un titolo <strong>di</strong> livello terziario o essere iscritto a un corso <strong>di</strong> tale<br />
livello all’intervista. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong> massima verosimiglianza dei parametri e relativa<br />
significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-49 anni all’intervista appartenenti a classi sociali me<strong>di</strong>o-basse<br />
(si escludono le classi <strong>di</strong> servizio). Svizzera, SHF 1999.<br />
a.<br />
1.Almeno livello sec. sup.<br />
121<br />
2. Livello terziario raggiunto o in<br />
corso<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 1602 1 1<br />
G2 + G1,5 Italia 103 2,36 ** 1,54 *<br />
G1 Italia 80 0,08 *** 0,37 ***<br />
Citt. Svizzera 71 0,83 0,85<br />
Altro o mancante 617 0,49 *** 1,21<br />
b.<br />
1.Almeno livello sec. sup.<br />
2. Livello terziario raggiunto o in<br />
corso<br />
n Exp(B) sig. Exp(B) sig.<br />
Autoctoni 1602 1 1<br />
G2 Sud Europa 86 2,86 ** 1,74 **<br />
G1.5 Sud Europa 48 0,85 0,77<br />
G1 Sud Europa 148 0,09 *** 0,40 ***<br />
Citt. Svizzera 81 0,81 0,94<br />
Altro o mancante 508 0,70 ** 1,38 **<br />
NOTA: gli effetti <strong>delle</strong> altre covariate inserite nei modelli non sono mostrati poiché restano identici a quelli presenti nelle tavole 4.5.<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%<br />
Gli effetti <strong>delle</strong> altre covariate incluse nei modelli confermano quanto visto nella parte<br />
descrittiva: essere donna con più <strong>di</strong> 40 anni, figlia <strong>di</strong> genitori operai con bassi titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
identifica la situazione associata alla minore propensione a proseguire gli stu<strong>di</strong> oltre l’obbligo<br />
scolastico (tavola 4.4).<br />
Limitando l’attenzione alle classi sociali me<strong>di</strong>o-basse (si escludono le classi <strong>di</strong> servizio), a<br />
parità <strong>di</strong> altre con<strong>di</strong>zioni, le migliori performance <strong>delle</strong> G2 dall’Italia rispetto agli autoctoni,<br />
appaiono ancora più evidenti. Rispetto alle precedenti stime, aumentano i rischi relativi <strong>di</strong><br />
raggiungere almeno un livello secondario superiore (tavola 4.6), che passano da 1,92 a 2,33, e<br />
acquista significatività anche il vantaggio relativamente al livello terziario: le probabilità <strong>di</strong><br />
avere o <strong>di</strong> frequentare un corso che da <strong>di</strong>ritto un tale titolo, risultano superiori del 72% per le G2<br />
rispetto agli autoctoni. La maggior tendenza a ottenere titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> si conferma anche per le<br />
G2 e le G1,5 prese congiuntamente (tavola 4.7a) e per le G2 dal Sud Europa (tavola 4.7b).<br />
Anche in Svizzera, dunque, per le famiglie immigrate è proprio tra i segmenti sociali meno<br />
privilegiati che la spinta all’istruzione risulta particolarmente intensa, tanto che la capacità <strong>di</strong><br />
innescare processi <strong>di</strong> mobilità ascendente attraverso lo strumento istruzione in presenza risorse<br />
ridotte, risulta superiore a quella <strong>delle</strong> famiglie autoctone.
4.6 Conclusioni<br />
Anche il caso svizzero conferma che le con<strong>di</strong>zioni dei genitori influenzano il percorso scolastico<br />
dei figli con un effetto <strong>di</strong> trascinamento positivo da una generazione all’altra a favore <strong>di</strong> chi<br />
proviene da famiglie con status e cultura più elevati. Tuttavia, già da una semplice osservazione<br />
<strong>delle</strong> percentuali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in possesso <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati, si evince che, pur possedendo<br />
un background familiare me<strong>di</strong>ante meno prestigioso rispetto agli autoctoni, i figli degli<br />
immigrati italiani ben figurano nel sistema scolastico elvetico. Se poi il confronto avviene a<br />
parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partenza, le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana nate dopo il 1950<br />
mostrano performance migliori dei figli degli svizzeri specialmente nelle classi sociali meno<br />
privilegiate.<br />
Così come per la Francia e l’Australia, anche in Svizzera, dove l’integrazione degli italiani<br />
è stata particolarmente <strong>di</strong>fficoltosa, emergono <strong>delle</strong> in<strong>di</strong>cazioni molto positive sull’istruzione<br />
dei figli degli immigrati italiani nati nel secondo dopoguerra.<br />
In generale, i risultati ottenuti sono in linea con i risultati <strong>di</strong> altre ricerche. Nella sostanza<br />
ciò che emerge in letteratura e che trova conferma nella presente analisi, è che le maggiori<br />
<strong>di</strong>fficoltà un tempo incontrate in ambito scolastico sembrano oggi sostanzialmente superate.<br />
Negli anni più recenti, da un ampio numero <strong>di</strong> voci ufficiali, sia italiane che svizzere, si tende ad<br />
affermare che la comunità italiana in Svizzera sia sostanzialmente integrata, quanto meno a<br />
livello socio-economico, soprattutto in confronto ai decenni passati, e che notevoli progressi<br />
siano stati registrati nel passaggio dalla prima alla seconda generazione. Nella stessa <strong>di</strong>rezione<br />
sembra esprimersi anche l’opinione pubblica a giu<strong>di</strong>car dalla frequenza con cui capita <strong>di</strong> sentire<br />
affermare che gli italiani non sono più un problema e che non si <strong>di</strong>stinguono più dagli svizzeri 46<br />
(Cesari Lusso, 1997, pag. 42). Ciò nonostante, la sensazione <strong>di</strong> essere <strong>di</strong>scriminati non è ancora<br />
del tutto cancellata e figli degli italiani probabilmente non si sentono ancora <strong>di</strong> appartenere<br />
pienamente al paese che li ospita. La reazione a questa con<strong>di</strong>zione è allora quella <strong>di</strong> fondare la<br />
propria identità migratoria su due pilastri: la riven<strong>di</strong>cazione della propria <strong>origine</strong> e al tempo<br />
stesso, sui risultati conseguiti nella scuola, senza per questo sentirsi vulnerabili nei confronti dei<br />
valori della società svizzera o a rischio <strong>di</strong> marginalizzazione sociale (ECAP, 2002, pag. 9).<br />
Viene il dubbio che in Svizzera più che altrove, il carattere temporaneo della emigrazione<br />
italiana e l’ingente numero <strong>di</strong> rientri in Italia abbiamo innescato una profonda selezione<br />
lasciando sul territorio svizzero solo gli immigrati più motivati e integrati. Secondo quest’ottica,<br />
che ricalca le idee <strong>di</strong> Chiswick (1999) già trattate nel primo capitolo, coloro i quali hanno deciso<br />
<strong>di</strong> emigrare in Svizzera e ivi sono rimasti, a causa <strong>delle</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> adattamento,<br />
sarebbero positivamente selezionati in termini <strong>di</strong> maggiori abilità nel lavoro e motivazioni sopra<br />
la me<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> ciò gioverebbe anche i loro figli. Infatti, se accettiamo l’ipotesi che i valori appresi<br />
46 Tuttavia, la <strong>di</strong>ffusione dell’idea dell’avvenuta integrazione degli immigrati italiani potrebbe aver<br />
fatto <strong>di</strong>minuire la vigilanza <strong>delle</strong> autorità e degli insegnanti nelle scuole tanto da spingere taluni a<br />
sostenere un rialzo degli insuccessi scolastici e della presenza nelle scuole speciali da parte dei figli <strong>di</strong><br />
italiani. In generale, sembra che la collettività italiana in Svizzera pare <strong>di</strong>vidersi tra chi ha effettivamente<br />
trovato un modo <strong>di</strong> vita sod<strong>di</strong>sfacente sul piano sociale e chi continua a restare in una situazione <strong>di</strong> forte<br />
isolamento in uno stato <strong>di</strong> provvisorietà continua (Cesari Lusso, 1997).<br />
122
in famiglia come la determinazione o il senso <strong>di</strong> sfida, permettono <strong>di</strong> affrontare con successo il<br />
percorso <strong>di</strong> integrazione in chiave sociale, scolastica e lavorativa, come una sfida alla ricerca <strong>di</strong><br />
una propria e vincente identità, ecco che la selezione dei genitori può riflettersi sui figli e sui<br />
loro risultati scolastici. In base a tale prospettiva l’integrazione raggiunta dai genitori si<br />
configura come variabile decisiva.<br />
Alla luce dei risultati ottenuti e <strong>delle</strong> considerazioni fatte, sembra ancora più ingiustificata la<br />
reticenza decennale e la eccessiva prudenza con cui ancora oggi le istituzioni svizzere spinte<br />
dall’opinione pubblica stanno affrontando la questione della citta<strong>di</strong>nanza <strong>delle</strong> prime e<br />
soprattutto <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> immigrati. Un atteggiamento che ha come paradossale<br />
risultato quello <strong>di</strong> far crescere l’antagonismo, il senso <strong>di</strong> appartenenza nazionale e il rifiuto della<br />
naturalizzazione anche tra gli appartenenti a comunità da tutti giu<strong>di</strong>cate e percepite come<br />
integrate, come quella <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana.<br />
Riferimenti bibliografici<br />
Bergman M. M. e Joye D., 2001, Comparing Social Stratifications Schemas: CAMSIS, CSP-<br />
CH, Goldthorpe, ISCO-88, Treiman, and Wright, Cambridge Stu<strong>di</strong>es in Social Research<br />
9:1-37.<br />
Bevilacqua P., De Clementi A. e Franzina E. (a cura <strong>di</strong>), 2002, Storia dell’emigrazione italiana,<br />
Roma, Donzelli E<strong>di</strong>tore.<br />
Cesari Lusso V., 1997, Quando la sfida viene chiamata integrazione. Percorsi <strong>di</strong><br />
socializzazione e <strong>di</strong> personalizzazione <strong>di</strong> giovani "figli <strong>di</strong> emigrati", Roma, NIS.<br />
Chiswick B.R, 1999, Are immigrants favorably self selected?, American economic review<br />
89(2).<br />
ECAP, 2002, I giovani italiani nel mondo tra integrazione e ricerca <strong>delle</strong> ra<strong>di</strong>ci storiche: il<br />
modello svizzero. Rapporto finale, Ufficio Stu<strong>di</strong> Fondazione ECAP e Federazione <strong>delle</strong><br />
colonie libere italiane in Svizzera, http://www.ecap.ch/usr/it/ricerche_progetti.htm.<br />
Ganzeboom H.B.G. e Luijkx R., 2001, Recent Trends in Intergenerational Occupational Class<br />
Mobility: Men in the Netherlands 1970-1999, RC-28, Mannheim.<br />
Goldthorpe J.H., 1987, Social Mobility and Class Structure in Modern Britain , Oxford:<br />
Clarendon Press.<br />
Goldthorpe J. e Keith H., 1974, The social gra<strong>di</strong>ng of occupations, Oxford: Clarendon Press.<br />
Hong Li J., Buchmann M., Konig M. e Sacchi S., 1998, Patterns of mobility for women in<br />
female-dominated occupations: an event-history analysis of two birth cohorts of swiss<br />
women, European sociological review 14 (1): 49-67.<br />
Joye D., Bergman M.M. e Budowski M., 2002, Technical report of the Swiss Household panel:<br />
reco<strong>di</strong>fication of variables for five social stratification schemas, Neuchatel, SHP online<br />
http://www.swisspanel.ch/file/methods/Technical_descrip_strat_en.pdf<br />
Meyer Sabino G., 1997, La generazione della sfida quoti<strong>di</strong>ana, Milano.<br />
Meyer Sabino G., In Svizzera in Bevilacqua et al. (2002).<br />
123
Wanner Ph. e Piquet E., 2002, La pratique de la naturalisation en Suisse: un aperçu statistique.<br />
Population-F, 57 (6).<br />
124
125<br />
CAPITOLO V<br />
L’istruzione dei figli dei meri<strong>di</strong>onali emigrati<br />
5.1. Le gran<strong>di</strong> migrazioni interne in Italia nell’ultimo secolo.<br />
nel Centro-Nord Italia<br />
In Italia per quasi un secolo ci sono state successive e intense ondate <strong>di</strong> popolazione in uscita<br />
verso l’America, l’Australia e le aree più ricche d’Europa. Ma questa è solo una parte della<br />
storia dell’emigrazione italiana. Dopo l’unità d’Italia, ma soprattutto nel secondo dopoguerra, si<br />
affianca ai movimenti verso l’estero, una intensa migrazione interna <strong>di</strong> lungo raggio con una<br />
portata che supererà, nel corso della seconda metà del secolo scorso, quella dei flussi <strong>di</strong>retti<br />
verso gli altri paesi: nel periodo 1951-71, l’Italia meri<strong>di</strong>onale e insulare presenta un saldo<br />
migratorio negativo con l’interno <strong>di</strong> 2,25 milioni e con l’estero <strong>di</strong> 1,77 milioni (Golini, 1974,<br />
pag. 23). In generale, più <strong>di</strong> nove milioni <strong>di</strong> italiani furono coinvolti nelle migrazioni interne tra<br />
la metà degli anni ’50 e gli inizi degli anni ’70. Bastano queste poche cifre per rendersi conto<br />
che uno stu<strong>di</strong>o multi-generazionale sugli effetti <strong>delle</strong> migrazioni non possa tralasciare la<br />
componente interna, sia per la portata del fenomeno sia per la l’importanza che ha rivestito per<br />
la storia dell’intero paese. Le migrazioni interne sono state un fenomeno sociale che ha<br />
contribuito in maniera determinante ai cambiamenti sociali e alla modernizzazione dell’Italia.<br />
Nel bene e nel male, l’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> quei massicci movimenti è tuttora forte e visibile nella società<br />
italiana. A volte si <strong>di</strong>mentica che una parte cospicua del nostro paese continua ad essere da più<br />
<strong>di</strong> un secolo terra emigrazione, mentre altre aree ricevono popolazione da almeno sessant’anni.<br />
Fintanto che alcune zone del paese hanno avuto ridotte o nulle capacità attrattive, le forze<br />
espulsive dalle zone meno sviluppate hanno spinto gli emigranti all’estero. Alle regioni più<br />
progre<strong>di</strong>te bastavano le forze <strong>di</strong> lavoro locali alimentate da un incremento naturale non troppo<br />
ridotto. Ma, nel secondo dopoguerra, l’accentuato sviluppo <strong>delle</strong> regioni industrializzate, unito a<br />
un incremento naturale ridottissimo, ha costituito una forza attrattiva enorme per gli emigranti<br />
<strong>delle</strong> altre regioni italiane. L’importanza strategica <strong>delle</strong> migrazioni per lo sviluppo <strong>delle</strong> aree<br />
sia <strong>di</strong> arrivo che <strong>di</strong> partenza è stata ampiamente sottolineata dagli stu<strong>di</strong>osi negli anni passati (si<br />
veda, tra gli altri, Bonifazi, 1999). Tuttavia, a partire dall’inizio degli anni ‘80 l’interesse per le<br />
migrazioni interne è andato scemando a causa del riassorbimento del fenomeno. Solo
ecentemente il <strong>di</strong>battito sulle migrazioni dal Sud al Nord del paese sta riprendendo corpo a<br />
causa <strong>di</strong> una decisa ripresa della mobilità <strong>delle</strong> popolazioni del Meri<strong>di</strong>one 47 .<br />
A <strong>di</strong>fferenza <strong>delle</strong> emigrazioni all’estero del secondo dopoguerra, il progetto migratorio<br />
della grande maggioranza degli immigrati al Nord comprendeva il trasferimento definitivo.<br />
Molti emigrati dal Mezzogiorno verso il Nord Ovest prima, il Nord Est poi non hanno fatto<br />
ritorno al luogo d’<strong>origine</strong>. Si sono inse<strong>di</strong>ati stabilmente, hanno formato una famiglia e hanno<br />
messo al mondo dei figli, creando, a tutti gli effetti, una seconda generazione <strong>di</strong> immigrati. E<br />
questa non è certo una parte trascurabile dell’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> cui si parlava. Questo lavoro vuole<br />
gettare qualche luce sul loro destino, in particolare sulle possibilità <strong>di</strong> successo scolastico dei<br />
figli <strong>di</strong> immigrati meri<strong>di</strong>onali nel Nord Italia. In via preliminare, ci sembra però in<strong>di</strong>spensabile<br />
ripercorrere brevemente le principali tappe del fenomeno migratorio interno, per delineare un<br />
quadro <strong>di</strong> riferimento entro cui collocare la nostra analisi.<br />
5.1.1 Prima della seconda guerra mon<strong>di</strong>ale.<br />
Sebbene con livelli non paragonabili al secondo dopoguerra, la struttura della mobilità<br />
interregionale si definisce nelle sue linee essenziali nel periodo tra le due guerre (Sori, 1979),<br />
quando si innescano processi <strong>di</strong> mobilità territoriale sull’onda dell’affermazione nelle varie parti<br />
del paese <strong>di</strong> sottomercati a <strong>di</strong>versa struttura produttiva. La mobilità stagionale tende a<br />
trasformarsi in migrazione definitiva e iniziano a configurarsi come bacini d’accoglienza le<br />
regioni del Nord Ovest, grazie alla forte industrializzazione, e soprattutto il Lazio, nel quale la<br />
crescita terziaria e burocratica <strong>di</strong> Roma costituisce una forte attrazione. Negli anni ’30, il saldo<br />
migratorio annuo per il complesso <strong>delle</strong> regioni nord-occidentali ha un’eccedenza positiva <strong>di</strong><br />
circa 25 mila unità l’anno e <strong>di</strong> 27 mila per il solo Lazio (tavola 1). La capacità attrattiva <strong>delle</strong><br />
regioni più industrializzate era ancora limitata e in grado <strong>di</strong> assorbire soltanto la corrente<br />
migratoria proveniente dall’area nord-orientale e dal Veneto in particolare. Il meri<strong>di</strong>one fornisce<br />
un contributo relativamente modesto essendo la maggior parte degli emigranti da tale zona<br />
ancora <strong>di</strong>retta nel resto d’Europa e oltre oceano (Golini, 1974).<br />
A conferma della presenza <strong>di</strong> flussi migratori interni già prima del secondo conflitto<br />
mon<strong>di</strong>ale, si consideri che nel 1925 la Fiat assunse 5.850 operai <strong>di</strong> provenienza per lo più<br />
meri<strong>di</strong>onale (Sori, 1975); la popolazione <strong>di</strong> Venaria Reale in provincia <strong>di</strong> Torino passò da 6.379<br />
a 11.663 abitanti grazie all'immigrazione <strong>di</strong> operai veneti e pugliesi che erano reclutati dalla<br />
Snia-Viscosa; a Milano, una inchiesta sugli abitanti <strong>delle</strong> baracche sorte nella periferia della<br />
città svolta nel 1927, accertava la presenza <strong>di</strong> immigrati meri<strong>di</strong>onali e, in misura minore, dal<br />
Veneto (Sori, 1979); gli e<strong>di</strong>li torinesi <strong>di</strong>soccupati lamentavano la concorrenza “indebita” della<br />
manodopera meri<strong>di</strong>onale nei cantieri (Treves, 1976). Iniziano, dunque, a riprodursi anche nel<br />
47 Si veda Pugliese (2002), pagg. 117-134 ma anche Livi Bacci nel Dossier pubblicato sul quoti<strong>di</strong>ano<br />
“la Repubblica” del 6 Agosto 2003. La funzione <strong>delle</strong> migrazioni interne come strumento <strong>di</strong> riequilibrio<br />
dei sistemi regionali, pur ri<strong>di</strong>mensionato rispetto ai decenni, e con modalità <strong>di</strong>verse rispetto al passato, è<br />
tutt’altro che scomparso.<br />
126
quadro interno le gran<strong>di</strong> problematiche dell’assimilazione sociale, della segregazione e, più in<br />
generale, <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>fficoltà della grande emigrazione <strong>di</strong> massa italiana all’estero (Sori, 1979).<br />
È pensabile che la politica antiurbana e <strong>di</strong> controllo degli spostamenti interni <strong>di</strong> popolazione<br />
intraprese in epoca fascista abbia limitato i movimenti <strong>di</strong> popolazione ma, altrettanto verosimile<br />
è che queste politiche più che arginare il fenomeno, abbiamo semplicemente portato a una<br />
sottostima dei movimenti interni. Le leggi fasciste, emanate nel 1928, nel 1931 e nel 1939, che<br />
ponevano fortissime limitazioni alla mobilità interna e all’inurbamento tramite controlli e<br />
<strong>di</strong>vieti 48 , furono in larga misura inefficaci (Sori, 1975). La decisione <strong>di</strong> eliminare dal<br />
questionario del censimento la domanda sul luogo d’<strong>origine</strong> probabilmente servì proprio per<br />
non evidenziare l’insuccesso della linea politica intrapresa. Se gli obiettivi <strong>di</strong>chiarati erano<br />
troppo ambiziosi alla luce della concreta capacità del regime <strong>di</strong> controllare minuziosamente gli<br />
spostamenti e le occupazioni lavorative <strong>delle</strong> masse italiane, certamente la politica adottata<br />
funzionò come deterrente: il bracciante agricolo che decideva <strong>di</strong> partire per il Nord<br />
industrializzato a tutti gli effetti era un illegale e pertanto soggetto a maggiori ricatti. Acquarone<br />
(1965) ci racconta che i <strong>di</strong>soccupati che nel 1930 a Torino chiedevano “Pane e lavoro”, furono<br />
restituiti ai luoghi d’<strong>origine</strong> con il foglio <strong>di</strong> via. Chi proveniva da lontano e lavorava in una<br />
fabbrica o nei cantieri e<strong>di</strong>li sapeva <strong>di</strong> essere un “clandestino” in città, <strong>di</strong> avere un rapporto <strong>di</strong><br />
connivenza con il datore <strong>di</strong> lavoro e dovette comportarsi <strong>di</strong> conseguenza, dato che la per<strong>di</strong>ta del<br />
lavoro voleva <strong>di</strong>re il ritorno forzato verso le campagne della zona <strong>di</strong> provenienza (Sori, 1979).<br />
Nel frattempo, gli industriali del Nord Ovest alla ricerca <strong>di</strong> manodopera a buon mercato e<br />
scarsamente organizzata a livello sindacale, non videro interferire tali leggi con le loro esigenze<br />
produttive (Treves, 1976).<br />
Questo stato <strong>di</strong> cose andò ben oltre la durata del regime fascista. La legge del 1939, che<br />
rafforzava ulteriormente i limiti all’inurbamento e allo spostamento <strong>di</strong> famiglie, continuò a<br />
essere valida per gran parte del miracolo economico italiano post-bellico. Questa legge<br />
intrappolava i possibili emigranti in una situazione paradossale: si richiedeva <strong>di</strong> provare d’avere<br />
una occupazione nel luogo della nuova <strong>di</strong>mora, ma per ottenere una simile occupazione<br />
bisognava avere un nuovo certificato <strong>di</strong> residenza. Quantunque ignorata, più ancora <strong>di</strong> altre<br />
leggi italiane, aveva causato angoscia a migliaia <strong>di</strong> emigranti, aveva indebolito la loro posizione<br />
nei confronti dei loro datori <strong>di</strong> lavoro e padroni <strong>di</strong> casa, li aveva posti un una ingiustificata<br />
situazione <strong>di</strong> illegalità (Ginsborg, 1989). Le gran<strong>di</strong> fabbriche del Nord continuarono a sfruttare<br />
il vantaggio contingente fornito da tale legge utilizzandola come uno dei principali freni<br />
repressivi contro l’insubor<strong>di</strong>nazione della classe operaia. Fu abolita solo nel 1961, se<strong>di</strong>ci anni<br />
dopo la fine della seconda guerra mon<strong>di</strong>ale.<br />
48 Un decreto del 1933 sanciva che in caso <strong>di</strong> trasferimenti <strong>di</strong> operai e famiglie senza l’autorizzazione<br />
del commissariato per le migrazioni interne, «le famiglie coloniche e i lavoratori potranno essere<br />
restituiti d’autorità ai luoghi <strong>di</strong> provenienza e i datori <strong>di</strong> lavoro saranno passibili <strong>di</strong> ammende […] da<br />
applicarsi nella misura massima ove si tratti <strong>di</strong> spostamenti <strong>di</strong> famiglie coloniche» [cit. in Sori (1979)].<br />
127
Tavola 5.1 Sal<strong>di</strong> migratori anagrafici <strong>delle</strong> ripartizioni in Italia dal 1931 al 1972.<br />
Sal<strong>di</strong> migratori anagrafici (migliaia <strong>di</strong> unità, valori me<strong>di</strong> annui)<br />
1931-40 1941-50 1951-65 1966-72<br />
Nord Ovest 25,1 15,7 113 91,1<br />
Centro Nord Est -34,6 -8 -31,2 12,8<br />
Lazio 27,1 14,2 31,4 20,5<br />
Sud e Isole -7,4 -19 -101,5 -124,4<br />
Fonte: Golini (1974)<br />
5.1.2 Il secondo dopoguerra.<br />
L’Italia a metà degli anni ’50 era ancora un paese poco sviluppato. L’espansione industriale era<br />
concentrata in pochi settori – acciaio, automobile, energia elettrica – confinati quasi<br />
esclusivamente nelle regioni nord-occidentali. L’agricoltura coinvolgeva al censimento del 1951<br />
ancora il 42% dei lavoratori, che <strong>di</strong>ventavano il 57% al Sud. La legge del febbraio 1948, che<br />
aveva istituito il sistema <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ipotecari rurali rimborsabili in quarant’anni, non portò a<br />
sensibili miglioramenti <strong>delle</strong> con<strong>di</strong>zioni socio-economiche, soprattutto nelle zone collinari e<br />
montane del Centro e del Sud. In queste aree era in atto già da tempo la polverizzazione e la<br />
frammentazione <strong>delle</strong> proprietà terriere, che si aggiungeva alla scarsa fertilità <strong>di</strong> molti suoli<br />
agricoli, senza contare che in tanti non avevano neppure un piccolo terreno. La natura assai<br />
limitata della riforma agraria, la graduale liberalizzazione dei mercati cerealicoli, che dal 1955<br />
in poi provocò un ribasso del prezzo del grano, finivano <strong>di</strong> completare il quadro <strong>di</strong> generale<br />
in<strong>di</strong>genza. La realtà meri<strong>di</strong>onale era caratterizzata da una persistente sottoccupazione e negli<br />
anni ’50 un vasto esercito <strong>di</strong> persone riusciva solo parzialmente a sod<strong>di</strong>sfare la sua necessità <strong>di</strong><br />
lavorare.<br />
Con una situazione del genere, l’emigrazione era una valvola <strong>di</strong> sfogo e, accanto alle<br />
esperienze migratorie d’oltreoceano e d’oltralpe, iniziano a consolidarsi movimenti inter-<br />
regionali <strong>di</strong> un certo peso. Ai consistenti motivi che spingevano fuori dalle campagne si<br />
aggiunsero anche dei potenti fattori <strong>di</strong> attrazione da parte <strong>delle</strong> città. Di decisiva importanza era<br />
la prospettiva <strong>di</strong> un migliore salario, ma non solo. «Soprattutto tra i più giovani il desiderio<br />
<strong>delle</strong> attrattive offerte da una città <strong>di</strong>venne <strong>di</strong>lagante quando dalla televisione del bar <strong>di</strong> paese<br />
apparirono le immagini <strong>di</strong> un nuovo mondo consumistico fatto <strong>di</strong> vita mondana, <strong>di</strong> campioni<br />
sportivi, <strong>di</strong> attrici famose, case piene <strong>di</strong> elettrodomestici, gite domenicali nella Fiat <strong>di</strong> famiglia»<br />
(Fofi, 1964). In tal senso può aver giocato un ruolo importante l’effetto detto <strong>di</strong> “socializzazione<br />
anticipatoria” proposto da Alberoni e Baglioni nel 1966 49 .<br />
49 La socializzazione anticipatoria è un processo che si attua in chi si appresta a emigrare: quando<br />
ancora si è nella zona d’<strong>origine</strong>, i futuri emigranti farebbero proprie non solo certe mete della società<br />
ospitante, ma anche certe procedure e sarebbero già consci del fatto che per vivere nella nuova società e<br />
ottenere il successo dovranno adottare specifiche modalità <strong>di</strong> vita. Ciò sarebbe il frutto <strong>di</strong> un costante ma<br />
in<strong>di</strong>retto contatto con la società d’arrivo (mass-me<strong>di</strong>a, altri emigranti, ecc.). Ai loro occhi, il sistema che<br />
lasciano <strong>di</strong>viene culturalmente inferiore a quello cui si <strong>di</strong>rigono. Il modello Nord, più efficiente,<br />
<strong>di</strong>venterebbe un riferimento da imitare: con l’intensificarsi degli scambi si <strong>di</strong>ffonde l’idea che il sistema<br />
128
Gli anni dal 1951 al 1965 sono quelli della grande migrazione interna: il triangolo industriale<br />
assorbe un saldo migratorio positivo <strong>di</strong> ben 113 mila persone l’anno, il Lazio 31 mila (tavola 1).<br />
Dai dati <strong>di</strong> censimento risulta che nel 1961 ben l’11% della popolazione, 6 milioni <strong>di</strong> persone,<br />
risiedeva in una regione <strong>di</strong>versa da quella <strong>di</strong> nascita. All’inizio del secolo questo valore era solo<br />
del 4%. Nel periodo 1955-1961, dal Veneto emigrarono 1.237.000 persone, <strong>di</strong>rette soprattutto<br />
verso le città industriali della Lombar<strong>di</strong>a e del Piemonte. Nello stesso periodo Marche ed<br />
Umbria persero insieme oltre centomila abitanti, la popolazione dell’Emilia Romagna rimase<br />
stabile e la Toscana conobbe un saldo positivo <strong>di</strong> 47.300 unità (Ginsborg, 1989). Ma le forze<br />
d’attrazione, che continuano a esercitarsi sulle regioni del Centro-Nord Est, si estendono<br />
gradualmente al Mezzogiorno che scopre il Nord Ovest come alternativa migratoria (Golini,<br />
1974). Il “miracolo economico”, che caratterizzò il nostro paese negli anni a cavallo tra la fine<br />
degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, accrebbe in modo drammatico il già serio squilibrio tra<br />
Nord e Sud. Come già detto, tutti i settori dell’economia in rapida espansione erano situati, con<br />
pochissime eccezioni, nel Nord Ovest e in alcune aree centrali e nord-orientali del paese.<br />
Sono soprattutto le gran<strong>di</strong> città ad attrarre gran parte del flusso migratorio: Roma e le città<br />
del Nord videro gonfiare la propria popolazione ma il caso più impressionante fu quello <strong>di</strong><br />
Torino che assorbì una quota molto alta dell’immigrazione meri<strong>di</strong>onale. Nel 1958 i comuni del<br />
triangolo industriale registrarono 69.000 nuovi residenti provenienti dal Mezzogiorno e questo<br />
numero balzò a più <strong>di</strong> 200.000 nel 1962 dopo l’abrogazione della legge contro l’urbanizzazione;<br />
nel 1963 si ebbero 183.000 nuove unità 50 (Ginsborg, 1989).<br />
Chi scelse <strong>di</strong> partire proveniva in primo luogo dalle zone rurali più povere e dai paesi<br />
collinari e montani. Gli spostamenti <strong>di</strong> popolazione si accompagnano a profon<strong>di</strong> cambiamenti<br />
nella struttura professionale: esodo agricolo e abbandono della terra; industrializzazione e<br />
crescita dell’occupazione industriale; terziarizzazione. Il flusso migratorio interno si caratterizza<br />
per una composizione della forza lavoro più giovane e competitiva rispetto a quella <strong>di</strong>retta<br />
all’estero. La grande richiesta <strong>di</strong> forza lavoro all’estero si rivolgeva, infatti, alla manodopera<br />
non qualificata e chiunque poteva tentare <strong>di</strong> espatria re per trovare in tempi brevi un lavoro <strong>di</strong><br />
manovalanza generica nell’e<strong>di</strong>lizia, nei lavori pubblici o nelle ferrovie (Pugliese, 2002).<br />
La tendenza migratoria rallentò brevemente a metà degli anni ’60 per poi riprendere, con<br />
ritrovato vigore, negli anni 1966-72, nei quali si assiste a una mo<strong>di</strong>ficazione dell’entità, della<br />
composizione e <strong>delle</strong> destinazioni dei flussi migratori rispetto al ventennio precedente.<br />
All’interno della ripartizione Centro-Nord Est il Veneto ribalta completamente la situazione<br />
negativa dei decenni precedenti passando da un saldo negativo annuo <strong>di</strong> 26 mila unità nel<br />
periodo 1951-65 a un sostanziale equilibrio migratorio; l’Emilia -Romagna e la Toscana<br />
proseguono nella loro tendenza positiva, configurandosi ad<strong>di</strong>rittura come regioni <strong>di</strong> attrazione<br />
soprattutto per le regioni meri<strong>di</strong>onali; le Marche riducono a meno <strong>di</strong> un terzo il loro deficit<br />
del Nord ha più successo in quanto gli uomini hanno un certo modo <strong>di</strong> vivere e <strong>di</strong> pensare (Alberoni e<br />
Baglioni, 1966).<br />
50 Per gli anni ’50 non esistono statistiche affidabili per descrivere le ondate migratorie. La già citata<br />
legge fascista del 1939 ebbe tra i vari effetti anche quello <strong>di</strong> falsare le statistiche sull’emigrazione dato<br />
che mo lti emigrati regolarizzarono la loro con<strong>di</strong>zione solo dopo il 1961.<br />
129
migratorio. Dal meri<strong>di</strong>one il deficit migratorio verso l’interno arriva a ben 124 mila unità<br />
l’anno, il che delinea ormai una chiara traiettoria Sud-Nord nelle migrazioni interne. Nel<br />
frattempo aumenta il peso degli in<strong>di</strong>vidui con grado d’istruzione elevato, dei tecnici e<br />
professionisti nella composizione dei flussi migratori. Tali cambiamenti sono anche il risultato<br />
<strong>delle</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni intervenute nella realtà sociale italiana: emigra gente <strong>di</strong>versa perché <strong>di</strong>versa<br />
è la struttura sociale del Mezzogiorno, perché è <strong>di</strong>minuita la popolazione conta<strong>di</strong>na e cresciuta<br />
la scolarizzazione (Pugliese, 1983).<br />
5.1.3 Accoglienza e integrazione degli immigrati meri<strong>di</strong>onali<br />
Il fatto che al giorno d’oggi i timori e i risentimenti <strong>di</strong> una società che si sente invasa e<br />
minacciata, siano <strong>di</strong>retti per lo più all’arrivo <strong>di</strong> immigrati islamici e balcanici, non ci deve far<br />
<strong>di</strong>menticare quanto nel recente passato nel Nord Italia fossero forti i pregiu<strong>di</strong>zi e l’ostilità verso<br />
i connazionali meri<strong>di</strong>onali. I conta<strong>di</strong>ni del Sud dovettero accettare il loro intensivo sfruttamento<br />
in con<strong>di</strong>zioni sociali e <strong>di</strong> lavoro spesso molto ardue. Ci racconta Fofi (1975) nella sua indagine<br />
sulle immigrazioni meri<strong>di</strong>onali a Torino che negli anni del boom economico le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
lavoro nelle piccole e me<strong>di</strong>e aziende erano molto dure: l’orario <strong>di</strong> lavoro, compresi gli<br />
straor<strong>di</strong>nari, durava raramente meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci o do<strong>di</strong>ci ore; i contratti erano sempre brevi, da tre a<br />
sei mesi; si cercava lavoro tramite le “cooperative”, forme <strong>di</strong> subappalto gangeristico della<br />
mano d’opera immigrata che aveva tra i suoi scopi quello <strong>di</strong> far <strong>di</strong>videre la forza-lavoro nel suo<br />
interno facendo sentire negli operai settentrionali minacciato il loro potere contrattuale a causa<br />
della flessibilità degli immigrati (Fofi, 1975). A Torino, i nuovi abitanti della città trovarono<br />
alloggio negli scantinati e nei solai del centro città, negli e<strong>di</strong>fici destinati a demolizione, in<br />
cascine abbandonate all’estrema periferia. Ovunque si verificarono atteggiamenti razzisti, e<br />
spesso gli appartamenti non venivano dati in affitto ai meri<strong>di</strong>onali (Ginsborg, 1989). Era l’epoca<br />
<strong>delle</strong> “coree”: gruppi <strong>di</strong> case abusive realizzate <strong>di</strong> notte dagli stessi immigrati su piccoli<br />
appezzamenti <strong>di</strong> terra comprati con i loro risparmi (Alasia e Montal<strong>di</strong>, 1975).<br />
Dopo aver superato le prime grosse <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> ambientamento e aver risparmiato un po’ <strong>di</strong><br />
denaro, il passo successivo era quello <strong>di</strong> chiamare la propria famiglia. Ma c’era il problema<br />
dell’abitazione e dell’assistenza sanitaria insufficientemente attrezzata per far fronte all’afflusso<br />
degli immigrati. La scuola fungeva da forte strumento <strong>di</strong> integrazione per i figli degli immigrati<br />
ma spesso le strutture erano insufficienti. «Ci si iscriveva a scuola durante tutto l’anno<br />
scolastico: all’inizio essi capivano ben poco <strong>di</strong> quello che veniva loro detto, molti parlavano in<br />
<strong>di</strong>aletto strettissimo e spesso rispondevano con muta ostilità ai tentativi <strong>di</strong> integrazione. La<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> livello tra Nord e Sud era tale che perfino i ragazzi che avevano regolarmente<br />
frequentato la scuola in meri<strong>di</strong>one, una volta giunti in settentrione dovevano retrocedere <strong>di</strong> una<br />
o due classi. Molti conta<strong>di</strong>ni meri<strong>di</strong>onali ritennero inutile mandare le loro figlie a scuola»<br />
(Ginsborg, 1989).<br />
Nel corso degli anni, la con<strong>di</strong>zione <strong>delle</strong> famiglie degli immigrati migliorò<br />
progressivamente, anche se rimasero alcune forme <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione. Molti degli stereotipi<br />
130
attribuiti oggigiorno agli immigrati in Italia provenienti dall’estero (dalla primitività e mancanza<br />
<strong>di</strong> educazione, alla sporcizia, alla violenza e alla tendenza a delinquere) erano in quegli anni<br />
attribuiti ai meri<strong>di</strong>onali (Pugliese, 2002). Fattori come la scolarizzazione <strong>di</strong> massa, che ha fatto<br />
accorciare le <strong>di</strong>stanze culturali e linguistiche, i sindacati – decisivi nel limitare le fratture tra<br />
immigrati e non all’interno dei movimenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> interessi comuni – il già citato effetto <strong>di</strong><br />
“socializzazione anticipatoria”, l’accumularsi <strong>di</strong> esperienze ripetute negli anni che permisero<br />
agli ultimi immigrati <strong>di</strong> trovare la strada già tracciata, hanno facilitato il progressivo inserimento<br />
degli immigrati.<br />
La valutazione dell’integrazione degli immigrati meri<strong>di</strong>onali nel Nord Italia è stata<br />
considerata per lo più a livello locale limitandosi alle principali aree urbane del Nord Ovest tra<br />
cui Torino. Il capoluogo piemontese è la città che in percentuale ha accolto più immigrati, in<br />
particolare meri<strong>di</strong>onali, ed è facile immaginare quanto questi abbiano inciso profondamente sul<br />
tessuto sociale e politico. Nell’ambito dello stu<strong>di</strong>o denominato progetto Torino (Martinotti,<br />
1982), Negri (1982) ha cercato <strong>di</strong> delineare le <strong>di</strong>fferenze nei processi <strong>di</strong> mobilità sociale tra<br />
piemontesi e immigrati meri<strong>di</strong>onali, evidenziando l’importanza dell’<strong>origine</strong> territoriale. Secondo<br />
questo contributo, si è configurata per le famiglie meri<strong>di</strong>onali nella realtà torinese un processo<br />
<strong>di</strong> emarginazione che non ha permesso <strong>di</strong> seguire il generale processo <strong>di</strong> mobilità ascendente<br />
<strong>di</strong>ffuso in Italia negli anni ’60 e ’70. I piemontesi hanno avuto accesso a lavori <strong>di</strong> tipo<br />
impiegatizio, cui sono pervenuti sia i figli <strong>delle</strong> famiglie operaie sia i figli dei lavoratori<br />
autonomi. Agli immigrati meri<strong>di</strong>onali, invece, la città ha offerto il lavoro operaio con<br />
conseguente mobilità <strong>di</strong>scendente per parecchi immigrati figli <strong>di</strong> commercianti e artigiani. Nella<br />
realtà milanese, l’integrazione dei meri<strong>di</strong>onali sembra essere stata più favorevole, quantomeno<br />
su un piano socio-culturale (Alberoni e Baglioni, 1965), e, sebbene non sono mancate <strong>di</strong>fficoltà<br />
oggettive, gli immigrati tendono ad essere più simili alla popolazione autoctona rispetto a<br />
quanto accada a Torino (Martinotti, 1982).<br />
5.2 Dati e ipotesi specifiche<br />
Negli anni più recenti, la ricerca socio-demografica ha prestato scarsa attenzione al destino degli<br />
immigrati dal meri<strong>di</strong>one al Nord Italia e soprattutto ai loro figli (Pugliese, 2002). Lo <strong>di</strong>mostra il<br />
fatto che non sono ancora state svolte in Italia indagini a livello nazionale o <strong>di</strong> macro-area nelle<br />
quali venga riportata la provenienza geografica dei genitori e il percorso migratorio seguito,<br />
informazioni fondamentali per realizzare uno stu<strong>di</strong>o sulle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> in ambito<br />
interno.<br />
In questa analisi si è cercato <strong>di</strong> aggirare questa mancanza <strong>di</strong> dati ad hoc. Utilizzando i dati<br />
dell’Indagine Multiscopo dell’Istat “Famiglia, soggetti sociali e con<strong>di</strong>zioni dell’infanzia” del<br />
1998, si è riusciti a ricostruire, almeno parzialmente, la storia migratoria dei nuclei familiari,<br />
ottenendo una accettabile approssimazione dell’informazione necessaria alla definizione <strong>delle</strong><br />
<strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>. Siccome, in tale indagine sono stati intervistati tutti i componenti del<br />
nucleo familiare, si è proceduto a incollare al record <strong>di</strong> ogni figlio, alcune caratteristiche dei<br />
131
ispettivi genitori, tra cui il luogo <strong>di</strong> nascita. Unendo tale informazione alla zona <strong>di</strong> residenza del<br />
nucleo familiare e alla zona <strong>di</strong> nascita del figlio, si è riusciti non solo a <strong>di</strong>stinguere i figli <strong>di</strong><br />
genitori stabili sul territorio dai figli <strong>di</strong> immigrati, ma anche a <strong>di</strong>fferenziare all’interno <strong>di</strong><br />
quest’ultimo gruppo tra nati nella zona <strong>di</strong> provenienza e nati nella zona d’arrivo.<br />
Uno degli svantaggi <strong>di</strong> questa operazione è quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un sottocampione <strong>di</strong><br />
riferimento costituito esclusivamente da in<strong>di</strong>vidui ancora coabitanti con almeno un genitore. Al<br />
crescere dell’età, restare in casa con i genitori può essere associato ad alcuni specifici caratteri.<br />
È allora necessario limitare questo effetto <strong>di</strong> selezione includendo nell’analisi solo i giovani <strong>di</strong><br />
età compresa tra i 20 e i 29 anni al momento dell’intervista. Inoltre, nel paragrafo 5.6 si valuterà<br />
l’impatto <strong>di</strong> questa selezione sui risultati dell’analisi attraverso l’applicazione dei modelli<br />
simultanei <strong>di</strong> heckman (1979).<br />
Trattandosi <strong>di</strong> persone nate tra il 1968 e il 1978 da genitori immigrati, ci si riferisce grosso<br />
modo alle ultime fasi <strong>delle</strong> gran<strong>di</strong> migrazioni interne caratterizzate dalla prevalenza dei flussi<br />
dal Mezzogiorno verso il Centro-Nord. Un secondo svantaggio è legato all’assenza <strong>di</strong><br />
informazioni sulla data <strong>di</strong> arrivo degli immigrati nella zona <strong>di</strong> residenza e, in generale, su<br />
eventuali percorsi migratori interme<strong>di</strong> tra la nascita e l’intervista.<br />
D’altro canto però, l’utilizzo dell’Indagine multiscopo ISTAT del 1998 presuppone degli<br />
innegabili vantaggi. Si tratta <strong>di</strong> un campione numeroso (20.153 famiglie, 59.050 in<strong>di</strong>vidui); vi<br />
sono in<strong>di</strong>cazioni sul percorso scolastico seguito da tutti i membri del nucleo familiare; le<br />
numerose informazioni sulla situazione socio-economica della famiglia ci permettono <strong>di</strong> tenere<br />
sotto controllo le caratteristiche <strong>di</strong> base dei genitori, limitando in tal modo l’effetto selettivo<br />
intrinseco nel processo migratorio. Il valore aggiunto nell’utilizzo <strong>di</strong> questi dati è nella<br />
possibilità <strong>di</strong> confrontare i figli degli immigrati non solo con i coetanei autoctoni del Centro-<br />
Nord ma anche con quelli figli <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui rimasti nell’area <strong>di</strong> <strong>origine</strong>. Questa comparazione,<br />
solitamente preclusa alle analisi sui migranti e sui loro <strong>di</strong>scendenti, ci dà uno strumento in più<br />
per valutare la selezione del processo migratorio.<br />
Nel presente lavoro, seguendo le in<strong>di</strong>cazioni specificate paragrafo 1.6, ci chie<strong>di</strong>amo se<br />
l’<strong>origine</strong> territoriale sia in grado <strong>di</strong> influire sui percorsi educativi, valutando il successo<br />
scolastico in chiave <strong>di</strong>fferenziale tra i figli degli immigrati e i figli <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui stabili sul<br />
territorio, sia nel luogo <strong>di</strong> partenza che <strong>di</strong> destinazione, a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni familiari <strong>di</strong><br />
partenza.<br />
Riba<strong>di</strong>ta l’importanza <strong>delle</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partenza, cioè dall’ammontare <strong>di</strong> risorse che i<br />
genitori riescono a mettere a <strong>di</strong>sposizione dei figli per permetter loro <strong>di</strong> accedere alle varie<br />
posizioni sociali <strong>di</strong>sponibili, l’immigrazione può avere un ruolo importante e in<strong>di</strong>pendente.<br />
Nello specifico della situazione italiana, tenendo sotto controllo il background familiare, essere<br />
figlio <strong>di</strong> immigrati meri<strong>di</strong>onali nel Centro-Nord Italia può costituire una con<strong>di</strong>zione negativa<br />
caratterizzata da minori possibilità <strong>di</strong> affermazione sociale. Questa ipotesi prende spunto dal<br />
contributo <strong>di</strong> Ceravolo et al. (2001) i quali, nell’analizzare gli immigrati <strong>di</strong> <strong>origine</strong> meri<strong>di</strong>onale<br />
nella città <strong>di</strong> Torino, per lo più <strong>di</strong> seconda generazione, sostengono l’idea che l’immigrazione ha<br />
un effetto autonomo sull’acquisizione <strong>di</strong> una posizione sociale, in<strong>di</strong>pendentemente dalla classe<br />
sociale <strong>di</strong> partenza. Ancora oggi, nel capoluogo piemontese così come accadeva negli anni ’60,<br />
132
la <strong>di</strong>visione tra famiglie d’<strong>origine</strong> meri<strong>di</strong>onale e piemontesi è evidente e la considerevole<br />
sovrapposizione tra la struttura gerarchica socio-occupazionale e la struttura <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze<br />
“etniche” legate ai flussi migratori lo <strong>di</strong>mostrerebbe: essere operaio a Torino equivale in gran<br />
parte a essere <strong>di</strong> or igine meri<strong>di</strong>onale, così come i ceti me<strong>di</strong>o-alti sono occupati in misura<br />
largamente prevalente dagli autoctoni. La frattura basata sull’<strong>origine</strong> territoriale permane anche<br />
per la seconda generazione tanto che, anche a parità <strong>di</strong> classe sociale d’<strong>origine</strong>, i figli <strong>di</strong><br />
meri<strong>di</strong>onali, soprattutto quelli nati al Sud e giunti a Torino successivamente, hanno intrapreso<br />
percorsi educativi <strong>di</strong> più basso profilo (Ceravolo et al. 2001). Risulta evidente come si<br />
attribuisca un ruolo fondamentale non solo all’<strong>origine</strong> dei genitori ma anche al luogo <strong>di</strong> nascita<br />
del figlio <strong>di</strong> immigrati (<strong>di</strong>fferenziando tra i nati nella zona d’arrivo e quelli che in tale zona vi<br />
sono giunti dopo la nascita) e più in generale, al momento <strong>di</strong> arrivo del nucleo familiare del<br />
soggetto nell’ambiente sociale <strong>di</strong> destinazione.<br />
Possono questi risultati essere estesi al <strong>di</strong> fuori della realtà torinese? Nella presente analisi,<br />
l’attenzione verrà concentrata sui figli dei meri<strong>di</strong>onali emigrati nel Centro-Nord Italia,<br />
<strong>di</strong>stinguendo anche tra Nord Ovest e Centro-Nord Est come possibili zone <strong>di</strong> destinazione. Non<br />
verrà tralasciata l’analisi del comportamento <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> figlie <strong>di</strong> genitori<br />
immigrati nel Nord Ovest dal Centro-Nord Est, sebbene la scarsa numerosità <strong>di</strong> questo gruppo<br />
(nelle coorti qui stu<strong>di</strong>ate) ci permetta <strong>di</strong> sviluppare l’analisi solo in maniera marginale. Il<br />
successo scolastico <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> sarà valutato anche in relazione a quello dei<br />
meri<strong>di</strong>onali rimasti nella loro zona d’<strong>origine</strong>.<br />
5.3 Definizioni <strong>delle</strong> variabili <strong>di</strong> interesse<br />
La variabile (politomica) <strong>di</strong> interesse è il titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o posseduto all’intervista, che nei modelli<br />
verrà <strong>di</strong>stinta in due variabili <strong>di</strong>cotomiche atte a considerare la probabilità <strong>di</strong>:<br />
1) aver conseguito un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore o universitario;<br />
2) possedere un titolo universitario o essere iscritti in un corso universitario.<br />
Sotto l’ipotesi <strong>di</strong> un minor investimento in istruzione da parte dei figli <strong>di</strong> immigrati, ci<br />
aspettiamo che tanto più elevato è il livello d’istruzione considerato, maggiori siano le<br />
<strong>di</strong>fferenze con gli autoctoni. I risultati dei modelli sono presentati come odds ratio (o rischi<br />
relativi) e sono atti a rappresentare la variazione relativa tra la probabilità <strong>di</strong> ottenere un certo<br />
titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per la categoria considerata e la stessa probabilità relativamente a un’altra<br />
categoria presa come riferimento.<br />
Grazie alle in<strong>di</strong>cazioni presenti nei primi due paragrafi, ci è possibile <strong>di</strong>videre il territorio<br />
nazionale in 4 macro-aree 51 (Nord Ovest, Centro-Nord Est, Lazio, Sud), ognuna caratterizzata<br />
51 Il Sud Italia comprende le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia<br />
e Sardegna; il Centro-Nord Est (considerata nella sua duplice funzione <strong>di</strong> are <strong>di</strong> emigrazione e <strong>di</strong><br />
133
da uno specifico ruolo nell’ambito <strong>delle</strong> migrazioni interne (figura 1). Considerando,<br />
inizia lmente il Centro-Nord Est e Nord Ovest come area unica <strong>di</strong> arrivo (che chiameremo<br />
Centro-Nord), inten<strong>di</strong>amo come immigrato quell’in<strong>di</strong>viduo nato nel Sud e giunto<br />
successivamente al Centro-Nord, tanto da acquisirne la residenza. In maniera analoga si ragiona<br />
se ci si vuole concentrare solo sul Centro-Nord Est (NEC) o sul Nord Ovest (NO) come area<br />
d’arrivo. In quest’ultimo caso, si cercherà, laddove la bassa numerosità lo permette, <strong>di</strong> indagare<br />
anche sui flussi dal NEC in arrivo al NO.<br />
Il campione <strong>di</strong> riferimento per l’analisi è stato formato selezionando dal campione ISTAT<br />
1998 l’insieme dei figli coabitanti con almeno un genitore. La variabile in<strong>di</strong>pendente chiave<br />
nell’analisi è la storia migratoria familiare atta a <strong>di</strong>stinguere gli autoctoni dai figli <strong>di</strong> immigrati,<br />
cioè dall’insieme <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui nati o giunti nel Centro-Nord Italia con almeno un genitore<br />
immigrato dal Meri<strong>di</strong>one. Nello specifico, considerando come area <strong>di</strong> destinazione l’intero<br />
Centro-Nord, le definizioni adottate per le <strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> tale variabile sono le seguenti 52 :<br />
- autoctoni Centro-Nord: entrambi i genitori nati e residenti al Centro-Nord;<br />
- G2mix Sud: nati nel Centro Nord da un genitore autoctono e uno immigrato dal Sud;<br />
- G2 Sud: nati nel Centro Nord, figli <strong>di</strong> meri<strong>di</strong>onali immigrati al Centro-Nord;<br />
- G1,5 Sud: giunti nel Centro Nord dopo la nascita, figli <strong>di</strong> meri<strong>di</strong>onali immigrati al<br />
Centro Nord;<br />
- autoctoni Sud: in<strong>di</strong>vidui residenti al Sud con entrambi i genitori nati e residenti al Sud.<br />
La mancanza <strong>di</strong> informazioni sulla data della migrazione ci obbliga a una definizione del gruppo<br />
G1,5 meno rigorosa <strong>di</strong> quella adottata nei capitoli precedenti. Infatti, non sappiamo se gli<br />
appartenenti a questo gruppo siano giunti prima del decimo compleanno o successivamente. E’<br />
però facilmente immaginabile che tali in<strong>di</strong>vidui, vivendo ancora con i loro genitori (entrambi<br />
immigrati), non siano emigrati da soli ma unitamente alla loro famiglia d’<strong>origine</strong>. Inoltre, dato<br />
che stiamo considerando persone <strong>di</strong> 20-29 anni al 1998 e che i movimenti migratori interni sono<br />
particolarmente bassi negli anni ottanta, è plausibile che la grande maggioranza <strong>di</strong> questi<br />
in<strong>di</strong>vidui abbia compiuto la migrazione durante l’infanzia 53 .<br />
immigrazione) le regioni Umbria, Marche,Toscana, Emilia -Romagna, Veneto, Friuli V.G. e Trentino-Alto<br />
A<strong>di</strong>ge; il Nord-Ovest la Lombar<strong>di</strong>a, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Per quanto riguarda il Lazio,<br />
l’intensa immigrazione che ha caratterizzato la città <strong>di</strong> Roma e la presenza <strong>di</strong> una emigrazione fuori<br />
regione <strong>di</strong> scarsa entità, pongono tale regione tra quelle <strong>di</strong> immigrazione. Tuttavia, le caratteristiche della<br />
regione non giustificano un accorpamento né con l’area del Nord -Ovest, né con il Centro-Nord Est, tanto<br />
più che, sebbene le numerosità non siano tali da poter giungere a precise conclusioni, analisi realizzate<br />
solo sulla regione Lazio (qui non mostrate) non hanno mostrato risultati in linea con quelli <strong>delle</strong> altre due<br />
aree <strong>di</strong> immigrazione.<br />
52 Il 12% dei nuclei familiari con figli presenti nel campione prevede la presenza <strong>di</strong> un solo genitore a<br />
causa <strong>di</strong> separazione, <strong>di</strong>vorzio o vedovanza. Purtroppo, in tale situazione non si hanno informazioni sul<br />
coniuge mancante il che ci obbliga a tener conto esclusivamente <strong>delle</strong> informazioni relative al solo<br />
genitore presente. Ne segue che la storia migratoria familiare sarà la storia migratoria <strong>di</strong> un solo genitore.<br />
Prove empiriche (qui non mostrate) hanno mostrato che l’esclusione <strong>di</strong> questi casi dall’analisi non<br />
mo<strong>di</strong>fica nella sostanza i risultati ottenuti. Al fine <strong>di</strong> non ridurre ulteriormente la numerosità del<br />
sottocampione considerato si è pertanto preferito continuare a considerare questi casi.<br />
53 Vale la pena <strong>di</strong> rimarcare che tra le G1,5 potrebbe esserci qualche in<strong>di</strong>viduo i cui genitori, già<br />
emigrati e stabilizzati nella zona <strong>di</strong> destinazione al momento della sua nascita, decidano <strong>di</strong> tornare nel<br />
134
Quando l’analisi si focalizza solo sul Nord Ovest o sul Centro-Nord Est, le categorie G2mix, G2<br />
e G1,5 saranno formate da in<strong>di</strong>vidui figli <strong>di</strong> immigrati nell’area specific ata, in partenza dal<br />
meri<strong>di</strong>one o dal NEC (quando si considera come area d’arrivo il NO). Infine, la categoria<br />
“Altro” contiene tutti i figli <strong>di</strong> genitori sono nati o residenti nel Lazio o che hanno seguito<br />
traiettorie migratorie non altrimenti specificate (si pensi a chi è emigrato dal Nord Ovest verso il<br />
Sud o verso il Nord Est se si focalizza su quest’ultima come area d’arrivo).<br />
Figura 5.1 Traiettorie migratorie. Sud<strong>di</strong>visione del territorio nazionale in macroaree.<br />
La tavola 5.2 contiene una prima descrizione del campione in relazione alla numerosità de lle<br />
possibili modalità della variabile storia migratoria familiare, <strong>di</strong>saggregando anche in base<br />
all’area <strong>di</strong> destinazione. L’esigenza <strong>di</strong> limitare il campione ai soli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> 20-29 anni,<br />
comporta che alcuni sottogruppi siano composti solo da poche decine <strong>di</strong> unità. Quantunque i<br />
flussi migratori dal meri<strong>di</strong>one al NEC non siano stati trascurabili, la loro traccia non è<br />
paragonabile a quella impressa nel triangolo industriale: i figli <strong>di</strong> meri<strong>di</strong>onali costituiscono il<br />
25% del campione residente nel Nord Ovest e solo il 9% <strong>di</strong> quello residente nel Centro-Nord<br />
Est. Nella prima area, gli in<strong>di</strong>vidui nati nell’area <strong>di</strong> destinazione figli <strong>di</strong> genitori entrambi<br />
immigrati dal meri<strong>di</strong>one (G2 Sud) rappresentano la quota più consistente all’interno dei figli <strong>di</strong><br />
immigrati dal Sud (62%) seguiti dalle G2mix (25%) e dalle G1,5 (13%), mentre nel NEC le più<br />
rappresentate sono le G2mix, figlie <strong>di</strong> un solo genitore immigrato (55%), seguite dalle G1,5<br />
(23%) e dalle G2 (22%). I figli <strong>di</strong> immigrati dal Centro-Nord Est al Nord Ovest sono in numero<br />
luogo d’<strong>origine</strong> solo per un breve periodo a ridosso del parto, magari per avvalersi del sostegno dei<br />
familiari e <strong>di</strong> tornare imme<strong>di</strong>atamente dopo la nascita del figlio al luogo <strong>di</strong> emigrazione. Questo aspetto<br />
comporta l’inserimento nel gruppo G1,5 (nato nella zona <strong>di</strong> <strong>origine</strong>) <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui che sostanzialmente<br />
appartengono al gruppo G2. Nei precedenti capitoli si ovviava a questo inconveniente includendo nel<br />
gruppo G2 anche chi, nato nel luogo <strong>di</strong> <strong>origine</strong>, giunge nel paese <strong>di</strong> arrivo entro i primi sei mesi <strong>di</strong> vita.<br />
135
nettamente inferiore, trattandosi <strong>di</strong> percorsi migratori più antichi ma <strong>di</strong>venuti <strong>di</strong> scarsa entità<br />
negli ultimi 30-35 anni. Grazie all’intenso sviluppo <strong>delle</strong> regioni del Centro-Nord Est, le<br />
emigrazioni da tale area verso il Nord Ovest sono dovute più alla prossimità geografica che non<br />
all’effetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziali <strong>di</strong> crescita economica 54 .<br />
Tavola 5.2 Campione tratto dall’indagine multiscopo ISTAT “Famiglie, soggetti sociali e con<strong>di</strong>zione<br />
dell’infanzia” del 1998 e percentuali <strong>di</strong> successo scolastico all’interno dei sottogruppi definiti dalla<br />
variabile storia migratoria familiare. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni coabitanti con almeno un genitore.<br />
136<br />
Numerosità<br />
% in possesso<br />
almeno <strong>di</strong> un titolo<br />
sec. sup.<br />
% in possesso <strong>di</strong><br />
laurea o iscritto<br />
all’università<br />
Autoctoni Centro-Nord 2296 64,4 28,4<br />
<strong>di</strong> cui: Aut. Nord Ovest 724 64,2 29,6<br />
Aut. Centro-Nord Est 1572 64,4 27,9<br />
Autoctoni Sud 2062 63,2 30,0<br />
G2 mix Sud (nel Centro-Nord) 178 62,9 27,5<br />
<strong>di</strong> cui: nel Nord Ovest 78 59,0 21,8<br />
nel Centro-Nord Est 100 66,0 32,0<br />
G2 Sud (nel Centro-Nord) 234 55,1 17,1<br />
<strong>di</strong> cui: nel Nord Ovest 193 53,9 14,0<br />
nel Centro-Nord Est 41 61,0 31,7<br />
G1,5 Sud (nel Centro-Nord) 84 50,0 27,4<br />
<strong>di</strong> cui: nel Nord Ovest 42 45,2 26,2<br />
nel Centro-Nord Est 42 54,8 28,6<br />
G2mix NEC nel Nord Ovest 103 76,7 35,9<br />
G2 NEC nel Nord Ovest 40 57,5 30,0<br />
Totale 5791 35,8 29,9<br />
Nella tavola 5.2 è riportata anche l’incidenza dei titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati nei sottogruppi<br />
identificati. Sono le G2 e soprattutto le G1,5 <strong>di</strong> <strong>origine</strong> meri<strong>di</strong>onale a mostrare le più basse<br />
percentuali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in possesso <strong>di</strong> un titolo secondario superiore. Le <strong>di</strong>fficoltà dei figli <strong>di</strong><br />
immigrati dal Sud Italia sono valide per tutto il Centro Nord ma risultano più evidenti nel Nord<br />
Ovest dove solo il 54% <strong>delle</strong> G2 e il 45% <strong>delle</strong> G1,5 ha un <strong>di</strong>ploma a fronte <strong>di</strong> un 64% per gli<br />
autoctoni. Nell’università il gap negativo <strong>delle</strong> G2 Sud nel Nord Ovest rimane abbondante (14%<br />
<strong>di</strong> casi in possesso <strong>di</strong> laurea o iscritti all’università contro il 30% degli autoctoni) mentre si<br />
riduce sostanzialmente la <strong>di</strong>stanza tra G1,5 e figli <strong>di</strong> nativi.<br />
Sviluppare una analisi multivariata introducendo, oltre alla storia migratoria familiare, tutte<br />
le variabili osservate che, mo<strong>di</strong>ficando l’ammontare <strong>di</strong> risorse <strong>di</strong> partenza, influiscono sui<br />
percorsi scolastici, è una strada obbligata al fine <strong>di</strong> valutare la riuscita scolastica al netto<br />
dell’effetto <strong>di</strong> selezione del processo migratorio. Le covariate <strong>di</strong> controllo inserite nell’analisi<br />
sono nel dettaglio:<br />
54 Non è riportata la categoria G1,5 NEC poiché è praticamente assente (solo 6 casi nel campione<br />
considerato).
a) Genere. Se un tempo gli uomini avevano maggiore accesso all’istruzione, negli ultimi<br />
anni la situazione si è invertita, con le donne che si iscrivono alla scuola me<strong>di</strong>a<br />
superiore, si <strong>di</strong>plomano e vanno all’università più frequentemente dei loro coetanei<br />
maschi (Pisati, 2002). Data la giovane età del nostro campione, ci si attende dunque,<br />
probabilità più elevate per le donne.<br />
b) Età all’intervista. Per tener conto della <strong>di</strong>versa struttura per età dei sottogruppi <strong>di</strong><br />
popolazione a confronto, si introduce una variabile continua. L’odds ratio esprimerà la<br />
variazione me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere il titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o specificato al passare<br />
dall’età x all’età x+1.<br />
c) Numero <strong>di</strong> fratelli e sorelle . La <strong>di</strong>mensione della famiglia d’<strong>origine</strong> può essere<br />
considerata un in<strong>di</strong>catore <strong>di</strong> “<strong>di</strong>luizione” <strong>delle</strong> risorse per l’istruzione presenti in<br />
famiglia (Blake, 1989). Nel questionario ISTAT tale informazione si riferisce al numero<br />
<strong>di</strong> fratelli e sorelle viventi all’intervista. Sebbene la misura più appropriata consista<br />
nella numerosità familiare ai 14 anni, la giovane età del sotto-campione considerato e la<br />
scarsa mortalità rendono le due informazioni praticamente equivalenti. Ci si attende che<br />
al crescere della <strong>di</strong>mensione familiare decresca la probabilità <strong>di</strong> proseguire gli stu<strong>di</strong>.<br />
d) classe socio-economica d’<strong>origine</strong>: si costruisce partendo dall’informazione relativa al<br />
lavoro svolto dai due genitori quando il figlio aveva 14 anni. A tale età, infatti, il figlio è<br />
quasi certamente presente all’interno della famiglia d’<strong>origine</strong> e le risorse familiari sono<br />
fondamentali per decidere il futuro investimento in istruzione. La classificazione<br />
adottata è quella proposta da Goldthorpe negli anni ’70 e successivamente rivista ed<br />
adattata alla situazione italiana da alcuni gruppi <strong>di</strong> ricerca facenti capo all’Università <strong>di</strong><br />
Trento (Barbagli, Capecchi e Cobalti, 1988; Cobalti e Schizzerotto, 1994):<br />
- Classe <strong>di</strong> servizio: Impren<strong>di</strong>tori, liberi professionisti, <strong>di</strong>rigenti, quadri;<br />
- Impiegati esecutivi: lavoratori <strong>di</strong>pendenti non manuali a me<strong>di</strong>o-alto livello <strong>di</strong><br />
qualificazione (tecnici specializzati, impiegati <strong>di</strong> concetto, insegnanti);<br />
- Piccola borghesia urbana: lavoratori autonomi e coa<strong>di</strong>uvanti familiari<br />
operanti nel settore secondario e terziario (commercianti e artigiani);<br />
- Lavoratori manuali (industria e servizi): impiegati esecutivi a basso livello <strong>di</strong><br />
qualificazione e lavoratori manuali occupati in posizione <strong>di</strong>pendente nei<br />
settori <strong>delle</strong> costruzioni, dell’industria, commercio e servizi;<br />
- Lavoratori manuali (agricoltura): lavoratori manuali occupati in posizione<br />
<strong>di</strong>pendente nel settore primario.<br />
Tuttavia, al fine <strong>di</strong> riuscire a definire la classe sociale d’<strong>origine</strong> è necessario in<strong>di</strong>viduare<br />
una classe sociale familiare e non più in<strong>di</strong>viduale. L’approccio tra<strong>di</strong>zionale (Goldthorpe<br />
1980 e 1983) prevede la scelta dell’occupazione del padre come identificativo della<br />
classe sociale dell’intero nucleo familiare. Un approccio più rigoroso deve tener conto<br />
anche dell’occupazione svolta dalla madre. Infatti, negli ultimi anni le donne coniugate<br />
e con figli hanno esteso i loro perio<strong>di</strong> lavorativi e sono spesso impiegate a tempo pieno<br />
(Cobalti e Schizzerotto, 1994). Inoltre, seppur non frequenti, vi sono casi per i quali<br />
l’occupazione femminile si colloca in una classe sociale superiore rispetto a quella del<br />
137
marito. Per non moltiplicare le categorie sociali, date dalla combinazione <strong>delle</strong><br />
occupazioni dei due coniugi, analogamente a quanto fatto nei capitoli precedenti, si<br />
ricorre al “principio <strong>di</strong> dominanza” (Erikson, 1984): si assegna ai componenti del<br />
nucleo familiare la posizione <strong>di</strong> classe più elevata tra quelle alle quali afferiscono le<br />
occupazioni esercitate dai due coniugi. A tal proposito, si considera la sud<strong>di</strong>visione in<br />
tre macro classi<br />
- classi <strong>di</strong> servizio ;<br />
- classi me<strong>di</strong>e (classe impiegatizia, piccola borghesia urbana e agricola);<br />
- classi operaie (urbane e agricole)<br />
che presentano chiare gerarchie <strong>di</strong> dominio tra loro. Se le classi occupazionali dei due<br />
coniugi sono <strong>di</strong>stinte e appartengono a classi <strong>di</strong> dominio <strong>di</strong>verse, la classe familiare è<br />
quella più elevata tra i due coniugi, se invece le classi occupazionali sono <strong>di</strong>verse ma<br />
inserite nella stessa classe <strong>di</strong> dominio, si prende comunque quella maschile. Questa<br />
decisione si basa sulla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> superiorità sociale ancora oggi ricoperta dagli<br />
uomini rispetto alle donne.<br />
e) titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o dei genitori: ci si attende una netta e forte relazione positiva tra il titolo<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o dei genitori e quello dei figli. Avendo definito come:<br />
titolo basso: nessun titolo o licenza elementare;<br />
titolo me<strong>di</strong>o: licenza me<strong>di</strong>a inferiore;<br />
titolo alto : <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola secondaria superiore o titolo più elevato;<br />
si è voluto inserire nei modelli il livello d’istruzione congiunto dei due genitori<br />
ottenendo una variabile con 6 modalità: entrambi titolo basso, uno basso e uno me<strong>di</strong>o,<br />
uno basso e uno alto, entrambi me<strong>di</strong>o, uno me<strong>di</strong>o e uno alto, entrambi alto 55 .<br />
f) mobilità sociale intergenerazionale dal padre al nonno in termini <strong>di</strong> livello d’istruzione.<br />
L’ipotesi è che un percorso ascendente possa spingere a convogliare maggiori risorse<br />
verso l’accumulazione <strong>di</strong> capitale umano per i figli. Confrontando i titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o del<br />
padre e del nonno è possibile in<strong>di</strong>viduare traiettorie ascendenti, <strong>di</strong>scendenti o nulle 56 .<br />
5.4 Un quadro descrittivo: le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partenza.<br />
La tavola 5.3 riporta tutte le modalità <strong>delle</strong> variabili <strong>di</strong> controllo appena definite, la <strong>di</strong>stribuzione<br />
percentuale sull’intero campione considerato (colonna 1), la percentuale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui all’interno<br />
<strong>di</strong> ogni categoria in possesso almeno <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore (colonna 2), la<br />
percentuale <strong>di</strong> laureati o iscritti all’università (colonna 3), e le <strong>di</strong>stribuzioni percentuali<br />
all’interno dei sottogruppi definiti in base alla storia migratoria familiare considerando come<br />
55 In presenza <strong>di</strong> nuclei familiari che prevedono la presenza <strong>di</strong> un solo genitore (ve<strong>di</strong> nota 7), la<br />
classe sociale del nucleo familiare e il titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o congiunto dei genitori, sono stati calcolati in base<br />
alle informazioni del solo genitore presente. Nel caso in cui l’unico genitore presente sia la madre, la<br />
mobilità sociale intergenerazionale nonno paterno-padre è da intendersi nonno materno – madre.<br />
56 Il caso in cui il nonno ha nessun titolo e il padre licenza elementare e passaggio da licenza<br />
elementare a me<strong>di</strong>a inferiore, non sono stati considerati come mobilità ascendente bensì nulla.<br />
138
zona <strong>di</strong> destinazione il Centro-Nord nel complesso (colonne 4-7) o specificando per il Nord<br />
Ovest (colonne 9-14) o il solo Centro-Nord Est (colonne 15-18). In colonna (8) sono invece<br />
riportate le <strong>di</strong>stribuzioni per gli in<strong>di</strong>vidui inse<strong>di</strong>ati stabilmente nel Sud Italia (autoctoni Sud).<br />
Tavola 5.3 Caratteristiche del campione. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni coabitanti con almeno un genitore.<br />
Genere<br />
Italia, ISTAT 1998.<br />
Età all'intervista<br />
%<br />
<strong>di</strong>stribuzione<br />
Campione nel complesso % <strong>di</strong>stribuzione nei sottogruppi:<br />
% almeno<br />
un titolo <strong>di</strong><br />
scuola<br />
secondaria<br />
inferiore<br />
139<br />
% laureati o<br />
iscritti alla<br />
università<br />
Autoctoni<br />
Centro-<br />
Nord<br />
G2mix<br />
Sud<br />
G2<br />
Sud<br />
G1,5<br />
Sud<br />
Autoctoni<br />
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)<br />
Uomo 55,5 58,3 24,2 55,7 57,3 59,0 54,8 55,3<br />
Donna 44,5 71,6 37,1 44,3 42,7 41,0 45,2 44,7<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
20-24 anni 58,9 65,4 31,9 57,0 68,0 62,4 60,7 59,7<br />
25-29 anni 41,1 62,5 27,0 43,0 32,0 37,6 39,3 40,3<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Livello d'istruzione dei genitori<br />
Entrambi basso 36,2 43,7 14,0 34,1 27,0 42,7 26,2 42,4<br />
Uno basso e uno me<strong>di</strong>o 19,9 62,4 21,5 20,9 24,2 20,9 22,6 18,5<br />
Uno basso e uno alto 3,5 78,0 34,0 4,1 1,7 3,8 2,4 3,3<br />
Entrambi me<strong>di</strong>o 16,3 71,2 30,4 18,4 21,9 15,4 17,9 13,1<br />
Uno me<strong>di</strong>o e uno alto 11,7 85,4 50,1 12,2 15,7 8,5 14,3 9,5<br />
Entrambi alto 12,4 94,0 69,2 10,2 9,6 8,5 16,7 13,2<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Classe socio -economica d’<strong>origine</strong><br />
Classe <strong>di</strong> servizio 14,0 81,9 52,5 17,2 15,7 11,1 20,2 8,3<br />
Impiegati esecutivi 25,1 80,4 42,9 22,3 29,2 20,1 22,6 27,9<br />
Piccola borghesia urbana 17,2 63,8 28,0 19,2 11,2 13,2 15,5 15,7<br />
Piccola borghesia agricola 5,0 49,0 20,7 4,6 2,2 0,9 3,6 7,6<br />
Lav. manuali (industria e servizi) 35,2 51,4 16,0 35,1 39,3 53,4 32,1 33,8<br />
Lav. manuali (agricoltura) 3,6 32,2 10,1 1,7 2,2 1,3 6,0 6,7<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Mobilità sociale nonno-padre<br />
Nulla 67,3 56,3 22,6 72,1 67,4 68,4 58,3 64,7<br />
Ascendente 30,4 82,5 46,9 26,1 28,1 26,5 39,3 33,5<br />
Discendente 2,2 54,6 20,8 1,8 4,5 5,1 2,4 1,7<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Numero <strong>di</strong> fratelli e sorelle<br />
(continua)<br />
0-1 59,0 70,7 34,3 71,7 70,8 59,0 53,6 42,4<br />
2 25,8 64,0 29,1 20,1 16,3 24,4 21,4 32,1<br />
3 o più 15,2 39,4 14,4 8,2 12,9 16,7 25,0 25,5<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Sud
Tavola 5.3 (segue). Caratteristiche del campione. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni coabitanti con almeno un<br />
Genere<br />
genitore. Italia, ISTAT 1998.<br />
Età all'intervista<br />
Autoctoni<br />
NordOvest<br />
Zona <strong>di</strong> destinazione NORDOVEST<br />
G2mix<br />
Sud<br />
G2<br />
Sud<br />
140<br />
% <strong>di</strong>stribuzione nei sottogruppi:<br />
G1,5<br />
Sud<br />
G2mix<br />
NEC<br />
G2<br />
NEC<br />
Zona <strong>di</strong> destinazione CENTRO-<br />
Autoctoni<br />
NEC<br />
NORDEST<br />
G2mix<br />
Sud<br />
G2<br />
Sud<br />
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)<br />
Uomo 55,8 62,8 58,0 52,4 52,4 60,0 55,7 53,0 63,4 57,1<br />
Donna 44,2 37,2 42,0 47,6 47,6 40,0 44,3 47,0 36,6 42,9<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
20-24 57,0 64,1 66,8 61,9 60,2 47,5 57,0 71,0 41,5 59,5<br />
25-29 43,0 35,9 33,2 38,1 39,8 52,5 43,0 29,0 58,5 40,5<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Livello d'istruzione dei genitori<br />
Entrambi basso 29,6 24,4 45,1 33,3 24,3 37,5 36,2 29,0 31,7 19,0<br />
Uno basso e uno me<strong>di</strong>o 21,1 21,8 22,3 19,0 24,3 25,0 20,9 26,0 14,6 26,2<br />
Uno basso e uno alto 3,6 2,6 3,6 2,4 1,9 4,3 1,0 4,9 2,4<br />
Entrambi me<strong>di</strong>o 19,9 29,5 16,1 11,9 17,5 10,0 17,7 16,0 12,2 23,8<br />
Uno me<strong>di</strong>o e uno alto 14,5 16,7 8,3 11,9 18,4 12,5 11,2 15,0 9,8 16,7<br />
Entrambi alto 11,3 5,1 4,7 21,4 13,6 15,0 9,7 13,0 26,8 11,9<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Classe socio -economica d’<strong>origine</strong><br />
Classe <strong>di</strong> servizio 20,3 15,4 6,7 23,8 16,5 30,0 15,7 16,0 31,7 16,7<br />
Impiegati esecutivi 21,0 24,4 19,2 21,4 26,2 17,5 22,8 33,0 24,4 23,8<br />
Piccola borghesia urbana 19,9 14,1 15,5 16,7 21,4 7,5 18,9 9,0 2,4 14,3<br />
Piccola borghesia agricola 3,3 2,6 0,5 - 1,9 2,5 5,2 2,0 2,4 7,1<br />
Lav. manuali (industria e servizi) 35,5 42,3 56,5 26,2 33,0 40,0 34,9 37,0 39,0 38,1<br />
Lav. manuali (agricoltura) - 1,3 1,6 11,9 1,0 2,5 2,5 3,0 - -<br />
G1,5<br />
Sud<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Mobilità sociale nonno-padre<br />
Nulla 73,2 67,9 70,5 61,9 63,1 55,0 71,6 67,0 58,5 54,8<br />
Ascendente 24,7 25,6 23,8 35,7 35,0 42,5 26,8 30,0 39,0 42,9<br />
Discendente 2,1 6,4 5,7 2,4 1,9 2,5 1,7 3,0 2,4 2,4<br />
Numero <strong>di</strong> fratelli e sorelle<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
0-1 73,9 67,9 64,2 54,8 71,8 77,5 70,7 73,0 34,1 52,4<br />
2 18,6 19,2 19,7 11,9 26,2 12,5 20,8 14,0 46,3 31,0<br />
3 o più 7,5 12,8 16,1 33,3 1,9 10,0 8,5 13,0 19,5 16,7<br />
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Il background familiare (in termini <strong>di</strong> istruzione, classe socio-economica dei genitori e<br />
<strong>di</strong>mensione familiare) risulta determinante nel determinare le percentuali <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui in<br />
possesso <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o elevati. Osservando la composizione per classe sociale d’<strong>origine</strong><br />
(tavola 5.3: colonne 4-7 e figura 5.2a), si evidenzia una parziale sovrapposizione tra struttura<br />
socio-occupazionale e status migratorio familiare. Il gruppo G2 Sud è fortemente caratterizzato<br />
dalla presenza operaia. Non così per le G2mix Sud, con una <strong>di</strong>stribuzione simile a quella degli
autoctoni, e per le G1,5 Sud, per le quali l’incidenza della classe <strong>di</strong> servizio è ad<strong>di</strong>rittura<br />
superiore rispetto agli autoctoni. Vale però la pena precisare che la polarizzazione <strong>delle</strong> G2 Sud<br />
verso le classi operaie non è prerogativa <strong>di</strong> tutto il Centro-Nord, ma solo della sua parte<br />
occidentale dove più <strong>di</strong> metà in<strong>di</strong>vidui appartenenti alle G2 Sud ha un padre operaio (tavola 5.3:<br />
colonne 9-14 e fig. 2b). Nel Nord Ovest, le G1,5, nate da genitori che hanno compiuto la<br />
migrazione più <strong>di</strong> recente, si mostrano più eterogenee al loro interno, a <strong>di</strong>mostrazione del<br />
moltiplicarsi negli ultimi anni <strong>delle</strong> gran<strong>di</strong> migrazioni interne dei percorsi professionali degli<br />
immigrati. L’elevata incidenza <strong>delle</strong> classi più elevate nei nuclei familiari giunti dal NEC palesa<br />
la <strong>di</strong>versa natura dei flussi migratori all’interno del centro-nord rispetto a quelli dal meri<strong>di</strong>one.<br />
Infine, solo tra le G1,5 Sud resta traccia della maggiore presenza <strong>di</strong> occupazioni legate<br />
all’agricoltura tra gli autoctoni del Sud. Nel Centro-Nord Est le <strong>di</strong>stribuzioni nei vari gruppi<br />
sono decisamente più livellate ed è il gruppo G2 Sud quello nel quale la classe <strong>di</strong> servizio ha il<br />
peso maggiore (tavola 3: colonne 15-18 e fig.2c), a riprova <strong>delle</strong> presenza <strong>di</strong> ampie fasce <strong>di</strong><br />
immigrati ad alta qualificazione provenienti dal Sud Italia verso quest’area.<br />
La composizione del campione in base al livello d’istruzione dei genitori ripropone le stesse<br />
gerarchie. Nel Nord Ovest, le G2 Sud hanno le più basse percentuali <strong>di</strong> genitori con titolo alto;<br />
le G2mix hanno una <strong>di</strong>stribuzione molto simile a quella degli autoctoni mentre sono le G1,5<br />
Sud ad avere i genitori con i titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o più elevato, anche rispetto agli autoctoni. Nel Centro<br />
Nord-Est, le <strong>di</strong>fferenze tra i sottogruppi sono meno nette e non necessariamente vanno nella<br />
stessa <strong>di</strong>rezione, ad esempio, sono le G2 Sud che hanno la percentuale maggiore <strong>di</strong> genitori<br />
entrambi in possesso <strong>di</strong> titoli elevati.<br />
La <strong>di</strong>mensione familiare è generalmente maggiore nel Sud Italia e, resta elevata anche nei<br />
nuclei familiari emigrati dal Sud al Centro-Nord: la percentuale <strong>di</strong> famiglie con 3 o più figli<br />
passa dall’8% degli autoctoni del Centro-Nord al 16,7% per le G2 Sud, salendo al 25% per le<br />
G1,5 Sud. Questo aspetto resta valido anche nelle sue aree del Centro-Nord prese<br />
separatamente.<br />
Infine, percorsi <strong>di</strong> mobilità ascendente tra la generazione dei nonni e quella dei padri sono più<br />
frequenti al Sud, tra le G1,5 nel Nord Ovest ma soprattutto nel Nord Est e tra i figli <strong>di</strong> emigrati<br />
dal NEC al NO.<br />
Tirando le somme, appare chiara la specifica connotazione operaia e a bassa istruzione dei<br />
genitori del gruppo G2 Sud nel Nord Ovest. Emigrati in massa verso il triangolo industriale<br />
meno <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> capitale umano ed economico da investire nell’istruzione dei loro<br />
figli. Le migrazioni più recenti verso il Nord Ovest, dalle quali provengono in misura maggiore<br />
le G1,5, quelle dal meri<strong>di</strong>one verso il Centro-Nord Est, e le migrazioni da questa ultima area<br />
verso il Nord Ovest, hanno invece coinvolto lavoratori più qualificati, con un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e<br />
<strong>origine</strong> sociale più elevati, che sono andati ad occupare nell’area <strong>di</strong> arrivo posizioni<br />
professionali anche <strong>di</strong> elevata qualificazione e responsabilità e che hanno spesso vissuto<br />
percorsi <strong>di</strong> mobilità ascendente rispetto ai loro padri. Data la relazione tra risorse <strong>di</strong> partenza e<br />
successo scolastico, nel Nord Ovest le G2 Sud mostrano dunque un notevole han<strong>di</strong>cap <strong>di</strong><br />
partenza anche rispetto alle G1,5 Sud e alle G2mix Sud. Infine, altro fattore <strong>di</strong> svantaggio nella<br />
141
corsa all’istruzione, comune a tutti i gruppi <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> immigrati, sia nel NEC che nel NO è la<br />
più elevata <strong>di</strong>mensione familiare.<br />
Figura 5.2 Distribuzione <strong>delle</strong> classi sociali all’interno dei sottogruppi <strong>di</strong> popolazione identificati in base<br />
alla storia migratoria familiare per zona <strong>di</strong> destinazione. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni coabitanti con<br />
almeno un genitore. ISTAT 1998.<br />
a. Zona <strong>di</strong> destinazione Centro-Nord nel complesso<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Autoctoni<br />
Centro-<br />
Nord<br />
G2mix<br />
Sud<br />
b. zona <strong>di</strong> destinazione Nord Ovest<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Autoctoni<br />
NordOvest<br />
G2 Sud G1,5 Sud Autoctoni<br />
Sud<br />
G2 Sud G2mix<br />
NEC<br />
c. zona <strong>di</strong> destinazione Centro-Nord Ovest<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
Autoctoni<br />
NEC<br />
G2mix Sud G2 Sud G1,5 Sud<br />
classi operaie<br />
classi me<strong>di</strong>e<br />
Classe <strong>di</strong> servizio<br />
classi operaie<br />
classi me<strong>di</strong>e<br />
Classe <strong>di</strong> servizio<br />
classi operaie<br />
classi me<strong>di</strong>e<br />
Classe <strong>di</strong> servizio<br />
142
5.5 Analisi multivariata.<br />
Le stime dei modelli logistici binomiali per l’area Centro-Nord sono fornite in tavola 5.4.<br />
Accanto ai modelli completi che includono tutte le covariate descritte in precedenza (colonne 3<br />
e 5), sono stati stimati anche due modelli parziali (colonne 2 e 4) che includono oltre alla<br />
variabile status migratorio familiare solo le due variabili <strong>di</strong> struttura età e sesso.<br />
Soffermiamoci per ora sulla probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria<br />
superiore. Senza tener conto del background familiare (tavola 5.4, colonna 2), gli in<strong>di</strong>vidui con<br />
entrambi i genitori immigrati dal meri<strong>di</strong>one hanno una minore probabilità <strong>di</strong> raggiungere un<br />
<strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a superiore rispetto agli autoctoni, e questo è vero non solo per le G2<br />
Sud, <strong>di</strong> estrazione sociale me<strong>di</strong>amente inferiore, ma anche per le G1,5 Sud: la probabilità <strong>di</strong><br />
ottenere un <strong>di</strong>ploma per gli autoctoni è superiore del 47% rispetto alle G2 Sud e del 85%<br />
rispetto alle G1,5 Sud. Questi risultati sono rinforzati da un’elevata significatività statistica. Gli<br />
in<strong>di</strong>vidui con un solo genitore immigrato e gli autoctoni del Sud, non mostrano particolari<br />
<strong>di</strong>fferenze con gli autoctoni del Centro-Nord.<br />
Quanto appena rilevato risente, tuttavia, della <strong>di</strong>versa composizione dei sottogruppi messi a<br />
confronto. NE è prova il fatto che nel modello completo (tavola 5.4, colonna 3), lo svantaggio<br />
<strong>delle</strong> G2 Sud <strong>di</strong>minuisce in entità e perde signific atività statistica. Evidentemente, la situazione<br />
sociale svantaggiata è alla base della minore riuscita scolastica <strong>di</strong> questo sottogruppo. In altre<br />
parole, non sembra realizzarsi una <strong>di</strong>fferenza sistematica con gli autoctoni del Centro-Nord da<br />
imputarsi a fattori “altri” rispetto alle <strong>di</strong>fferenti dotazioni <strong>di</strong> base. Restano invece confermati i<br />
problemi per le G1,5 Sud il cui rischio relativo, posto uguale a 1 quello degli autoctoni del<br />
Centro-Nord, resta vicino a 0,5.<br />
Un altro risultato interessante è che, ceteris paribus, gli autoctoni del Sud mostrano un<br />
maggiore successo scolastico. A fronte <strong>di</strong> percentuali <strong>di</strong> successo scolastico simili nel Sud e<br />
Nord del paese (la percentuale <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> 20-29 anni nel campione complessivo ISTAT<br />
1998 in possesso <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ploma all’intervista è del 57,8% per i residenti nel Centro-Nord e del<br />
56,9% per i residenti nel Sud), vi è una <strong>di</strong>fferente <strong>di</strong>stribuzione <strong>delle</strong> classi sociali d’<strong>origine</strong>, per<br />
il titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o dei genitori e per la numerosità familiare tra le due zone del paese. Tenendo<br />
sotto controllo l’effetto <strong>di</strong> questi fattori, gli abitanti del Sud Italia giungono ad avere probabilità<br />
più elevate <strong>di</strong> proseguire i loro stu<strong>di</strong>. Tuttavia, il risultato che a noi interessa <strong>di</strong> più è fornito dal<br />
confronto tra la riuscita dei figli <strong>di</strong> immigrati al Centro-Nord e i figli <strong>di</strong> chi è rimasto al Sud. In<br />
linea <strong>di</strong> massima, questi ultimi hanno fornito ai propri figli probabilità maggiori <strong>di</strong> <strong>di</strong>plomarsi<br />
rispetto a chi è emigrato: considerando pari a 1 questa probabilità per gli autoctoni Sud, il<br />
rischio relativo per le G2mix Sud è 0,67 (sign.>95%), per le G2 Sud è 0,65 (sign.>99%) e per le<br />
G1,5 Sud è ad<strong>di</strong>rittura pari a 0,38 (sign. >99%).<br />
Gli odds ratio relativi agli effetti <strong>delle</strong> altre covariate inserite nel modello concordano con le<br />
aspettative. Tenendo costanti le altre variabili, al crescere della classe sociale <strong>di</strong> appartenenza<br />
aumenta la possibilità <strong>di</strong> allungare i propri stu<strong>di</strong>: il figlio <strong>di</strong> genitori appartenenti alla borghesia<br />
ha una probabilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>plomarsi pari 3,2 volte quella del figlio <strong>di</strong> una coppia della classe operaia<br />
agricola e 1,7 volte quella del figlio <strong>di</strong> genitori della classe operaia urbana. Ma ancora più<br />
143
importante della classe sociale è il livello d’istruzione dei genitori. A parità <strong>di</strong> altre con<strong>di</strong>zioni,<br />
se i genitori hanno entrambi un titolo elevato, il loro figlio ha quasi 12 volte più possibilità <strong>di</strong><br />
proseguire con successo gli stu<strong>di</strong> oltre la scuola dell’obbligo rispetto al figlio <strong>di</strong> genitori<br />
entrambi con titolo basso. Il maggior accesso all’istruzione superiore <strong>delle</strong> donne è ben evidente<br />
dal odds ratio relativo alla variabile sesso mentre l’effetto dell’età all’intervista, che perde<br />
significatività passando al modello completo, in<strong>di</strong>ca una leggera <strong>di</strong>minuzione nella probabilità<br />
<strong>di</strong> raggiungere un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore al crescere dell’età. In linea con le attese<br />
è anche l’effetto <strong>di</strong> una famiglia numerosa: maggiore è il numero <strong>di</strong> fratelli e sorelle, minori le<br />
risorse a <strong>di</strong>sposizione per la propria istruzione. Infine, i percorsi <strong>di</strong> mobilità sociale<br />
intergenerazionale vissuto dal padre rivelano la loro importanza ma senza essere sostenuti da<br />
una elevata significatività statistica.<br />
Consideriamo ora le probabilità <strong>di</strong> proseguire gli stu<strong>di</strong> dopo la maturità o il <strong>di</strong>ploma. Le<br />
G1,5 Sud recuperano buona parte dell’han<strong>di</strong>cap accusato rispetto agli autoctoni: nel modello<br />
completo (tavola 5.4, colonna 5), gli autoctoni hanno solo il 15% <strong>di</strong> probabilità in più <strong>di</strong><br />
iscriversi all’università, dove tale <strong>di</strong>fferenza non è neppure supportata da una adeguata<br />
significatività statistica. Così come era già apparso nella parte descrittiva, per le G1,5 vi sono<br />
dei problemi a raggiungere un titolo d’istruzione secondaria superiore, ma chi raggiunge questo<br />
obiettivo molto spesso prosegue i propri stu<strong>di</strong> iscrivendosi all’università e colmando, a questo<br />
livello, il gap con la popolazione autoctona. Sembra che in questo gruppo vi sia una selezione<br />
nella scuola molto più forte <strong>di</strong> quando accade per il resto della popolazione, che porta a far<br />
proseguire gli stu<strong>di</strong> solo ai più motivati. Chi invece, appare deficitario è il gruppo <strong>delle</strong> G2 Sud:<br />
se la minore probabilità nell’ottenere un <strong>di</strong>ploma rispetto agli autoctoni era dovuta<br />
principalmente alla <strong>di</strong>fferente struttura sociale dei due gruppi, in ambito universitario lo<br />
svantaggio <strong>di</strong> questo gruppo <strong>di</strong>venta più intenso, più significativo e trascende da questioni<br />
legate alle <strong>di</strong>verse risorse <strong>di</strong> partenza. Una possibile lettura <strong>di</strong> questo risultato è che i figli <strong>di</strong><br />
immigrati meri<strong>di</strong>onali, pur proseguendo gli stu<strong>di</strong> oltre l’obbligo, si in<strong>di</strong>rizzano più spesso<br />
rispetto agli autoctoni verso istituti tecnici e scuole superiori professionalizzanti, puntando a un<br />
ingresso più rapido nel mercato del lavoro e rinunciando a iscriversi all’università.<br />
Gli effetti <strong>delle</strong> altre covariate presenti nel modello in colonna 4 non si <strong>di</strong>scostano da quelli<br />
visti in precedenza.<br />
Vale inoltre far presente che, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto accade per i figli <strong>di</strong> immigrati all’estero,<br />
la stima dei modelli limitatamente agli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> <strong>origine</strong> sociale me<strong>di</strong>o-bassa (qui non<br />
mostrati) non mostra risultati <strong>di</strong>versi da quelli appena mostrati.<br />
L’analisi prosegue focalizzando l’attenzione sui movimenti migratori verso le due aree<br />
Nord Ovest e Centro-Nord Est considerate separatamente. Le modalità della variabile storia<br />
migratoria cambiano leggermente rispetto a quelle viste finora ma sia chiaro che il campione <strong>di</strong><br />
riferimento resta sempre quello nazionale, essendo interessati a valutare anche il comportamento<br />
degli autoctoni del Sud. Gli effetti <strong>delle</strong> covariate <strong>di</strong> controllo non verranno mostrate poiché<br />
coincidono con quelli visti nei modelli precedenti.<br />
144
Tavola 5.4. Zona <strong>di</strong> destinazione Centro-Nord in complesso. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale<br />
per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere 1) un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore o universitario; 2) <strong>di</strong><br />
essere iscritto all’università o <strong>di</strong> avere già un titolo universitario. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong> massima<br />
verosimiglianza dei parametri e relativa significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni coabitanti con<br />
almeno un genitore. Italia, ISTAT, 1998.<br />
1. Livello secondario superiore o<br />
titolo più elevato (sì/no)<br />
145<br />
2. Iscritto all’università o laurea già<br />
ottenuta (sì/no)<br />
n Exp (B) Sig. Exp (B) Sig. Exp (B) Sig. Exp (B) Sig.<br />
(1) (2) (3) (4) (5)<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni Centro-Nord (rif.) 2.296 1 1 1 1<br />
G2mix Sud 178 0,93 0,93 0,93 0,95<br />
G2 Sud 234 0,68 *** 0,86 0,52 *** 0,62 **<br />
G1,5 Sud 84 0,54 *** 0,47 *** 0,94 0,81<br />
Autoctoni Sud 2.062 0,94 1,34 *** 1,06 1,37 ***<br />
Altro 937 1,27 *** 1,17 * 1,49 *** 1,36 ***<br />
Genere<br />
Maschio (rif.) 3.215 1 1 1 1<br />
Femmina 2.576 1,79 *** 1,92 *** 1,82 *** 1,95 ***<br />
Età all'intervista (categoriale annuale)<br />
0,97 *** 1,02 * 0,96 *** 0,98<br />
Livello d'istruzione congiunto dei<br />
genitori<br />
Entrambi basso (rif.) 2.098 1 1<br />
Uno basso e uno me<strong>di</strong>o 1.151 1,80 *** 1,50 ***<br />
Uno basso e uno alto 200 2,85 *** 2,34 ***<br />
Entrambi me<strong>di</strong>o 945 2,29 *** 2,08 ***<br />
Uno me<strong>di</strong>o e uno alto 677 4,21 *** 4,10 ***<br />
Entrambi alto 720 10,48 *** 8,79 ***<br />
Classe socio -economica d’<strong>origine</strong><br />
Classe <strong>di</strong> servizio (rif.) 808 1 1<br />
Impiegati esecutivi 1.451 0,95 0,70 ***<br />
Piccola borghesia urbana 996 0,73 ** 0,64 ***<br />
Piccola borghesia agricola 290 0,57 *** 0,63 ***<br />
Lav. manuali (industria e servizi) 2.038 0,55 *** 0,41 ***<br />
Lav. manuali (agricoltura) 208 0,32 *** 0,31 ***<br />
Mobilità nonno-padre<br />
Nulla (rif.) 3.898 1 1<br />
Ascendente 1.763 1,19 * 0,92<br />
Discendente 130 0,75 0,67 *<br />
Numero <strong>di</strong> fratelli e sorelle<br />
0-1 (rif.) 3.414 1 1<br />
2 1.496 0,75 *** 0,78 ***<br />
3 o più 881 0,36 *** 0,45 ***<br />
Costante<br />
2,62 *** 0,72 0,35 ***<br />
Totale casi 5.791<br />
-2 loglikelihood 7.407 6.286 6.892 5.873<br />
R2 Cox and Snell 0,02 0,20 0,03 0,19<br />
R2 Nagelkerk 0,03 0,27 0,04 0,26<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%
5.5.1 Zona <strong>di</strong> destinazione Nord Ovest<br />
Rispetto a quanto visto per il Centro-Nord in generale, lo svantaggio <strong>delle</strong> G1,5 Sud nella<br />
probabilità <strong>di</strong> raggiungere un livello d’istruzione secondaria superiore, tende a essere ancora più<br />
evidente rispetto agli autoctoni del Nord Ovest mostrando, nel modello completo (tavola 5.5:<br />
colonna 3) un odds ratio pari a 0,40. Inoltre, rispetto agli autoctoni del Sud le cose non vanno<br />
meglio per nessuno dei tre gruppi <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> immigrati: posto uguale a 1 il rischio relativo per<br />
autoctoni Sud, abbiamo i valori 0,59 (sign.>95%), 0,66 (sign.>95%) e 0,28% (sign.>99%)<br />
rispettivamente per G2mix Sud, G2 Sud e G1,5 Sud.<br />
Per i figli <strong>di</strong> immigrati provenienti dal Centro-Nord Est, si segnala solo una più alta<br />
propensione all’istruzione prolungata (maggiore anche rispetto agli autoctoni del NEC), per le<br />
G2Mix NEC.<br />
Anche relativamente alla probabilità <strong>di</strong> proseguire gli stu<strong>di</strong> dopo il <strong>di</strong>ploma o la maturità,<br />
resta valido quanto detto per il Centro-Nord in generale, sebbene le relazioni suggerite in<br />
precedenza siano più nette. A mostrare maggiori <strong>di</strong>fficoltà sono le G2 Sud, anche al netto degli<br />
effetti <strong>di</strong> tutte le covariate considerate nell’analisi. Per le G1,5 Sud e per le G2mix Sud, il minor<br />
ricorso all’istruzione universitaria non da luogo a <strong>di</strong>fferenze statisticamente significative.<br />
Tavola 5.5. Zona <strong>di</strong> destinazione Nord Ovest. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi<br />
<strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere 1) un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore o universitario; 2) <strong>di</strong> essere iscritto<br />
all’università o <strong>di</strong> avere già un titolo universitario. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong> massima verosimiglianza<br />
dei parametri e relativa significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni coabitanti con almeno un<br />
genitore. Italia. ISTAT, 1998.<br />
1. Livello secondario superiore o titolo<br />
più elevato<br />
146<br />
2. Iscritto all’università o laurea già<br />
ottenuta<br />
n Exp (B) Sig. Exp (B) Sig. Exp (B) Sig. Exp (B) Sig.<br />
(1) (2) (3) (4) (5)<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni Nord Ovest (rif.) 724 1 1 1 1<br />
G2mix Sud 78 0,82 0,92 0,67 0,75<br />
G2 Sud 193 0,65 *** 0,99 0,38 *** 0,56 **<br />
G1,5 Sud 42 0,44 *** 0,40 ** 0,82 0,71<br />
Aut. Sud 2.062 0,95 1,52 *** 1,00 1,41 ***<br />
G2mix NEC 103 1,80 ** 1,78 ** 1,30 1,23<br />
G2 NEC 40 0,77 0,76 1,06 1,08<br />
Autoctoni NEC 1.572 1,01 1,18 * 0,92 1,04<br />
Altro 977 1,18 1,23 ** 1,36 *** 1,38 ***<br />
Note:<br />
- colonne (2) e (4) modelli parziali (aggiunta <strong>delle</strong> covariate sesso e età all'intervista)<br />
- colonne (3) e (5) modello completo (comprendente tutte le covariate)<br />
Si rimanda alla tavola 4 per le stime degli effetti <strong>delle</strong> covariate non presenti in questa tavola,<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%
Tavola 5.6. Zona <strong>di</strong> destinazione Centro-Nord Est. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi<br />
<strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere a) un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore o universitario; b) <strong>di</strong> essere iscritto<br />
all’università o <strong>di</strong> avere già un titolo universitario. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong> massima verosimiglianza<br />
dei parametri e relativa significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni coabitanti con almeno un<br />
genitore. Italia. ISTAT, 1998<br />
Livello secondario superiore o titolo<br />
più elevato (si/no)<br />
147<br />
Iscritto all’università o laurea già<br />
ottenuta (si/no)<br />
n Exp (B) Sig. Exp (B) Sig. Exp (B) Sig. Exp (B) Sig.<br />
(1) (2) (3) (4) (5)<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni NEC (rif.) 1.572 1 1 1 1<br />
G2mix Sud 100 1,04 0,97 1,16 1,11<br />
G2 Sud 41 0,90 0,75 1,27 0,97<br />
G1,5 Sud 42 0,66 0,56 1,03 0,93<br />
Autoctoni Sud 2.062 0,94 1,27 *** 1,09 1,35 ***<br />
Altro 1.974 1,03 0,93 1,17 ** 1,07<br />
Note:<br />
- colonne (2) e (4) modelli parziali (aggiunta <strong>delle</strong> covariate sesso e età all'intervista)<br />
- colonne (3) e (5) modello completo (comprendente tutte le covariate) .<br />
Si rimanda alla tavola 4 per le stime degli effetti <strong>delle</strong> covariate non presenti in questa tavola.<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%.<br />
5.5.2 Zona <strong>di</strong> destinazione Centro-Nord Est<br />
Essere figlio <strong>di</strong> immigrati meri<strong>di</strong>onali nel Centro e nel Nord Est risulta nettamente meno<br />
caratterizzante, quantomeno a livello <strong>di</strong> risultato scolastico, rispetto a quanto accade nel Nord<br />
Ovest (tavola 5.6). Sebbene i rischi relativi <strong>di</strong> ottenere un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore<br />
siano inferiori all’unità sia per le G2 che per le G1,5, manca una significatività statistica tale da<br />
poter dar forza al risultato, sia nel modello parziale (colonna 2) che in quello completo (colonna<br />
3). Se poi consideriamo le probabilità <strong>di</strong> essere iscritto all’università o <strong>di</strong> essere già laureato,<br />
allora le <strong>di</strong>fferenze pratic amente spariscono del tutto.<br />
5.6 Il problema della selezione nel campione analizzato: presentazione e applicazione del<br />
modello <strong>di</strong> Heckman.<br />
Una lecita obiezione che è possibile addurre all’analisi presentata in questo capitolo<br />
riguarda il fatto che il sotto-campione analizzato è composto esclusivamente da in<strong>di</strong>vidui ancora<br />
coabitanti con almeno un genitore 57 poiché non è possibile definire la storia migratoria familiare<br />
per chi non vive più con il nucleo familiare <strong>di</strong> <strong>origine</strong> (manca l’informazione sul luogo <strong>di</strong><br />
nascita dei genitori e non esiste il record del genitore cui collegare quello dell’in<strong>di</strong>viduo). Vi<br />
57 Di fatto, nel sottocampione selezionato, vi sono anche alcuni in<strong>di</strong>vidui che hanno vissuto l’uscita<br />
<strong>di</strong> casa ma che poi sono rientrati in un secondo momento, risultando, all’intervista, coabitanti con i<br />
genitori (circa 300 casi su 8173). Ne segue che formalmente il fattore <strong>di</strong> selezione non è l’aver mai<br />
vissuto l’uscita <strong>di</strong> casa ma la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> coabitante con i genitori all’intervista.
sono, in pratica, dei dati mancanti legati alla scelta <strong>di</strong> essere usciti dalla famiglia <strong>di</strong> <strong>origine</strong> cui<br />
bisogna tener conto poiché la presenza <strong>di</strong> un effetto selezione porterebbe inevitabilmente a <strong>delle</strong><br />
stime <strong>di</strong>storte. Quantunque il campione complessivo proveniente dall’indagine Multiscopo<br />
ISTAT “Famiglie, soggetti sociali e con<strong>di</strong>zione dell’infanzia” del 1998 è rappresentativo della<br />
popolazione italiana, il sottocampione considerato potrebbe non esserlo, qualora la sua<br />
estrazione non avvenga in maniera casuale. Finora abbiamo ipotizzato che l’uscita dalla casa dei<br />
genitori costituisca una sorta <strong>di</strong> “trattamento” che interviene in maniera causale sulla<br />
popolazione relativamente all’aspetto istruzione. Essendo questa una ipotesi forte, è necessario<br />
fornire degli elementi che la sostengano.<br />
A tal proposito, ci giunge in aiuto Heckman (1979) che propone un modello capace sia <strong>di</strong><br />
valutare quanto influente è la selezione sia <strong>di</strong> ottenere <strong>delle</strong> stime degli effetti <strong>delle</strong> covariate al<br />
netto <strong>di</strong> tale processo selettivo. Questo modello prevede l’osservazione <strong>di</strong> una variabile<br />
(continua, or<strong>di</strong>nale o categoriale) su un singolo in<strong>di</strong>viduo solo a con<strong>di</strong>zione che una equazione<br />
ausiliaria <strong>di</strong> selezione abbia esito positivo.<br />
L’applicazione <strong>di</strong> un tale modello risulta utile ogni qualvolta la variabile <strong>di</strong> interesse non è<br />
stata osservata su una parte del campione e ci si vuole accertare che la mancanza <strong>di</strong><br />
informazioni, dunque la selezione nei dati, non influisca sull’analisi poiché in<strong>di</strong>pendente dal<br />
fenomeno stu<strong>di</strong>ato Le possibili applicazioni <strong>di</strong> un tale modello sono davvero numerose. Ad<br />
esempio, è possibile valutare l’effetto sul salario dato da una serie <strong>di</strong> variabili solo sugli<br />
in<strong>di</strong>vidui che hanno lavorato. Chi non ha mai lavorato, sebbene sia presente nel database, ha un<br />
red<strong>di</strong>to nullo o irrilevante e dunque non rientra nell’analisi. Tuttavia, il gruppo dei lavoratori<br />
potrebbe non essere casuale ma costituire un sottocampione selezionato.<br />
Nello specifico si considerano sue equazioni simultanee:<br />
a) equazione <strong>di</strong> interesse Y1 i = X1iβ<br />
1 + U1i<br />
b) equazione <strong>di</strong> selezione Y2 i = X 2iβ<br />
2 + U2i<br />
dove ji X è un vettore j K × 1 <strong>di</strong> regressori esogeni, β j è un vettore 1 × K j <strong>di</strong> parametri. La<br />
variabile i Y1 è osservata (cioè l’in<strong>di</strong>viduo è inserito nella prima equazione) solo se Y 0 .<br />
Dunque, la prima equazione è limitata al sottocampione identificato dal valore <strong>di</strong> i Y2 seconda equazione agisce su tutto il campione.<br />
Nella popolazione complessiva risulta che:<br />
1 i<br />
1i<br />
1i<br />
1<br />
148<br />
2 > i<br />
, mentre la<br />
E ( Y | X ) = X β per i = 1,.....<br />
I<br />
(1)<br />
mentre nel sottocampione con i dati <strong>di</strong>sponibili è
Tavola 5.7 Zona <strong>di</strong> destinazione Centro-Nord in complesso. Stime ottenute dall’applicazione del modello<br />
<strong>di</strong> Heckman e confronto con le stime ottenute da un modello <strong>di</strong> regressione multivariato applicato su chi<br />
vive ancora in casa dei genitori. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni. Italia. ISTAT 1998.<br />
Livello d'istruzione congiunto dei genitori<br />
Genere<br />
Età all'intervista<br />
Numero <strong>di</strong> fratelli e sorelle<br />
Area <strong>di</strong> nascita<br />
Regressione multivariata Modello <strong>di</strong> Heckman<br />
n ß Sig ß Sig<br />
EQUAZIONE DI SELEZIONE (probit)<br />
Entrambi basso 3402 1<br />
Uno basso e uno me<strong>di</strong>o 1470 0,28 ***<br />
Uno basso e uno alto 253 0,41 ***<br />
Entrambi me<strong>di</strong>o 1356 -0,05<br />
Uno me<strong>di</strong>o e uno alto 818 0,40<br />
Entrambi alto 874 0,41 ***<br />
Maschio 4054 1<br />
Femmina 4119 -0,53 ***<br />
149<br />
8173 -0,19 ***<br />
0-1 4511 1<br />
2 2130 -0,07 *<br />
3 o più 1532 -0,31 ***<br />
Nord Ovest 1732 1<br />
Nord Est 2455 0,10 ***<br />
Sud 397 -0,06<br />
Lazio 3211 0,02<br />
Estero 378 0,51 ***<br />
Costante 5,69 ***<br />
EQUAZIONE DI INTERESSE (regressione)<br />
Storia migratoria familiare<br />
Autoctoni Centro-Nord 2296 1 1<br />
G2mix Sud 178 -0,23 -0,23<br />
G2 Sud 234 -0,33 0,33<br />
G1,5 Sud 84 -0,82 *** -0,81 ***<br />
Autoctoni Sud 2062 0,23 ** 0,23 **<br />
Altro 937 0,23 * 0,23 *<br />
Genere<br />
Maschio 3215 1 1<br />
Femmina 2576 0,94 *** 0,98 ***<br />
Età all'intervista<br />
5791 0,05 *** 0,06<br />
Livello d'istruzione congiunto dei genitori<br />
Entrambi basso 2098 1 1<br />
Uno basso e uno me<strong>di</strong>o 1151 1,05 *** 1,03 ***<br />
Uno basso e uno alto 200 1,70 *** 1,66 ***<br />
Entrambi me<strong>di</strong>o 945 1,47 *** 1,47 ***<br />
Uno me<strong>di</strong>o e uno alto 677 2,37 *** 2,35 ***<br />
Entrambi alto 720 3,22 *** 3,19 ***<br />
Classe socio -economica d’<strong>origine</strong><br />
Classe <strong>di</strong> servizio 808 1 1<br />
Impiegati esecutivi 1451 -0,34 ** -0,34 **<br />
Piccola borghesia urbana 996 -0,59 *** -0,59 ***<br />
Piccola borghesia agricola 290 -0,89 *** -0,89 ***<br />
Lav. manuali (industria e servizi) 2038 -1,16 *** -1,16 ***<br />
Lav. manuali (agricoltura) 208 -1,84 *** -1,83 ***<br />
Mobilità nonno-padre<br />
Nulla 3898 1 1<br />
Ascendente 1763 0,11 0,11<br />
Discendente 130 -0,35 -0,35<br />
Numero <strong>di</strong> fratelli e sorelle<br />
0-1 3414 1 1<br />
2 1496 -0,39 *** -0,39 ***<br />
3 o più 881 -1,51 *** -1,48 ***<br />
Costante 10,47 *** 10,19 ***<br />
Residui<br />
delta (Equazione <strong>di</strong> selezione) 1,00<br />
Theta (equazione <strong>di</strong> interesse) 2,92 *** 2,92 ***<br />
rho (Correlazione dei residui) -0,06<br />
log Likelihood -14414,00 -18414,00<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%.
E(<br />
Y<br />
1i<br />
| X<br />
1i<br />
, Y<br />
2i<br />
≥<br />
0)<br />
= X<br />
= X<br />
1i<br />
1i<br />
β<br />
β<br />
1<br />
1<br />
+ E(<br />
U<br />
+ E(<br />
U<br />
1i<br />
1i<br />
| Y<br />
2i<br />
| U<br />
2i<br />
150<br />
≥ 0)<br />
≥ −<br />
X<br />
2i<br />
β<br />
2<br />
)<br />
per i = 1,.....<br />
I (2)<br />
Se i due residui i U1 e i U2 sono in<strong>di</strong>pendenti, cioè se gli elementi sono selezionati in maniera<br />
casuale, il valore atteso con<strong>di</strong>zionato <strong>di</strong> i U1 è zero e la funzione <strong>di</strong> regressione per il<br />
sottocampione selezionato tende a quella valida per l’intera popolazione. Se invece la selezione<br />
non è casuale, allora l’equazione <strong>di</strong> regressione <strong>di</strong>pende sia da i X1 che da X 2i e l’equazione a)<br />
omette l’ultimo termine della (2). L’esistenza <strong>di</strong> una correlazione tra i residui vuol <strong>di</strong>re che<br />
esiste un fattore non osservato capace <strong>di</strong> influenzare sia la selezione dei casi, sia la variabile <strong>di</strong><br />
interesse i Y1 . Ad esempio, una maggiore abilità nel lavoro (aspetto non osservato) spinge sia<br />
verso salari più elevati, sia a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro. Analogamente, vi può<br />
essere un fattore non osservato che influenza contemporaneamente sia la permanenza nella casa<br />
dei genitori sia il risultato scolastico.<br />
Il modello a due equazioni simultanee può essere stimato attraverso il software aML (Lilard<br />
e Panis, 2000).<br />
Nella presente analisi, la fonte <strong>di</strong> selezione è l’uscita dalla casa dei genitori e l’effetto<br />
sull’istruzione della storia migratoria familiare è valutata solo sugli in<strong>di</strong>vidui ancora coabitanti<br />
con i genitori, dato che solo per costoro è possibile conoscere i percorsi migratori dei genitori. Il<br />
livello d’istruzione è formalmente una informazione <strong>di</strong>sponibile per tutti gli in<strong>di</strong>vidui del<br />
campione, ma se poniamo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> tale variabile solo per chi vive con i genitori, è<br />
possibile ricadere nella situazione propria del modello <strong>di</strong> Heckman 58 . In tal modo, sebbene le<br />
determinanti del livello d’istruzione sono valutate solo su una parte del campione, sarà possibile<br />
valutare l’effetto dei regressori (e dunque della storia migratoria familiare) sull’istruzione<br />
tenendo conto <strong>delle</strong> <strong>di</strong>storsioni legate alla selezione.<br />
Per poter sviluppare un modello <strong>di</strong> Heckman in aML, è necessario che le due equazioni <strong>di</strong><br />
regressione abbiano i residui <strong>di</strong>stribuiti come una normale bi<strong>di</strong>mensionale. In particolare:<br />
⎛U<br />
⎜<br />
⎝U<br />
2<br />
1<br />
⎞ ⎛ ⎛ 1<br />
⎜ ⎜<br />
⎟ ≈ N 0,<br />
⎜ ⎜<br />
⎠ ⎝ ⎝<br />
ρσ<br />
U1<br />
σ<br />
U1<br />
⎞⎞<br />
⎟⎟<br />
⎟⎟<br />
⎠⎠<br />
Pertanto, l’equazione <strong>di</strong> selezione richiede obbligatoriamente una regressione probit (permette<br />
<strong>di</strong> considerare come variabile <strong>di</strong>pendente la dummy “uscito <strong>di</strong> casa sì/no” e ha il residuo che si<br />
<strong>di</strong>stribuisce come una normale standar<strong>di</strong>zzata). Per l’equazione <strong>di</strong> interesse, non possiamo<br />
utilizzare una regressione logit (il residuo non è normo-<strong>di</strong>stribuito), ma neanche una seconda<br />
probit, poiché la deviazione standard del residuo deve poter essere <strong>di</strong>versa da 1. Si può invece<br />
58 Lo stesso autore nel suo contributo del 1979 parla <strong>di</strong> possibilità <strong>di</strong> selezione legata alle peculiarità<br />
della variabile oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (come nel caso dell’analisi del salario che non può che essere limitata<br />
solo a chi ha mai lavorato) o a decisioni prese dall’analisti (selezionando alcuni casi e tralasciandone altri<br />
in funzione <strong>delle</strong> finalità dello stu<strong>di</strong>o), sottolineando l’analogia <strong>delle</strong> due situazioni.
utilizzare una regressione lineare multivariata che però richiede la specificazione <strong>di</strong> una<br />
variabile <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong>versa da quella utilizzata finora nell’analisi. Invece <strong>delle</strong> variabili<br />
dummies ha il <strong>di</strong>ploma (sì/no), ha la laurea o è iscritto all’università (sì/no), si costruisce una<br />
nuova variabile atta a misurare il livello d’istruzione in base al numero <strong>di</strong> anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o,<br />
tenendo conto dei titoli posseduti e alle esperienze in corso 59 .<br />
La specificazione del modello <strong>di</strong> Heckman è allora la seguente:<br />
a) equazione <strong>di</strong> interesse (regressione lineare multivariata 60 );<br />
variabile <strong>di</strong>pendente: anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o;<br />
regressori: storia migratoria familiare; livello d’istruzione dei genitori; classe<br />
sociale familiare; mobilità sociale padre-nonno; numero <strong>di</strong> fratelli e<br />
sorelle; età all’intervista; genere;<br />
residuo: normo-<strong>di</strong>stribuito con me<strong>di</strong>a nulla e varianza theta.<br />
b) equazione <strong>di</strong> selezione (regressione probit).<br />
variabile <strong>di</strong>pendente: vive in casa con i genitori all’intervista (rif.=no);<br />
regressori: livello d’istruzione dei genitori; numero <strong>di</strong> fratelli/sorelle; età<br />
all’intervista; genere; zona geografica <strong>di</strong> nascita;<br />
residuo: normo-<strong>di</strong>stribuito con me<strong>di</strong>a nulla e varianza unitaria.<br />
Nella tavola 5.7 è possibile leggere le stime ottenute dall’applicazione <strong>di</strong> un modello <strong>di</strong><br />
regressione sul numero <strong>di</strong> anni vissuti su chi vive ancora con i genitori. Relativamente alla<br />
storia migratoria familiare, considerare il numero <strong>di</strong> anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o invece <strong>di</strong> variabili<br />
<strong>di</strong>cotomiche conferma le <strong>di</strong>fficoltà per la G1,5 rispetto agli autoctoni (coefficiente pari a -0,82 e<br />
altamente significativo) mentre non appare significativo lo svantaggio <strong>delle</strong> G2. Infatti,<br />
considerare gli anni stu<strong>di</strong>o nel complesso comporta una spalmatura <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze tra i<br />
sottogruppi su tutto il percorso dell’istruzione tanto da non permetterci più <strong>di</strong> apprezzare le<br />
59<br />
In base al sistema scolastico e universitario italiano valido negli anni Novanta, si pongono le<br />
seguenti corrispondenze:<br />
Anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o (se iscritto a corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o all’intervista)<br />
Nessun titolo, analfabeta 0<br />
Nessun titolo, alfabeta 2 (+1 anno)<br />
Licenza elementare 5 (+1 anno)<br />
Licenza me<strong>di</strong>a 8 (+1 anno)<br />
Diploma (2-3 anni) 10 (+1 anno)<br />
Diploma (4-5) 13 (+1 anno se <strong>di</strong>ploma univ.; +2 anni se corso <strong>di</strong> laurea)<br />
Diploma universitario 15 (+1 se corso <strong>di</strong> laurea)<br />
Laurea 18 (+1 se corso post-laurea)<br />
Titolo post-laurea 20<br />
60<br />
Una soluzione alternativa alla regressione lineare semplice per l’equazione a) è quella <strong>di</strong> utilizzare<br />
un ordered probit cioè un probit con variabile <strong>di</strong>pendente categoriale che potrebbe essere costruita come<br />
segue:<br />
Livello d’istruzione basso: anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o
<strong>di</strong>fferenze tra G2 e autoctoni, che come abbiamo avuto modo <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>re, si concentrano<br />
nel livello terziario. Gli effetti <strong>delle</strong> altre covariate incluse nella equazione <strong>di</strong> interesse<br />
confermano le in<strong>di</strong>cazioni presentate nei paragrafi precedenti.<br />
Lo sviluppo del modello <strong>di</strong> Heckman ci permette <strong>di</strong> osservare sia l’intenso effetto <strong>delle</strong><br />
covariate scelte sulla con<strong>di</strong>zione “vivere in casa dei genitori” (equazione <strong>di</strong> selezione, tavola<br />
5.7), sia l’invarianza <strong>delle</strong> stime nell’equazione <strong>di</strong> interesse. Se a questo aggiungiamo che la<br />
correlazione dei residui (rho pari a -0,06) è non significativa, possiamo affermare che, in base<br />
agli elementi considerati, la <strong>di</strong>storsione dell’effetto selezione è trascurabile: non vi è evidenza<br />
empirica dell’esistenza <strong>di</strong> un fattore non osservato capace <strong>di</strong> influenzare sia il livello<br />
d’istruzione che la propensione a restare in casa dei genitori. In altri termini, non essendoci una<br />
stretta relazione tra i due aspetti, l’analisi dell’istruzione sul sottocampione degli in<strong>di</strong>vidui<br />
coabitanti con i genitori non è <strong>di</strong>storta fornendo risultati che corrispondono a quelli che si<br />
otterrebbe sull’intero campione 61 . Pertanto, ci sentiamo <strong>di</strong> avvalorare i risultati presentati in<br />
questo capitolo 62 .<br />
5.7 Conclusioni e <strong>di</strong>scussione<br />
Le gran<strong>di</strong> migrazioni interne sono state uno degli eventi più importanti nella storia del<br />
nostro paese nell’ultimo mezzo secolo, le cui ripercussioni continuano a manifestarsi ancora<br />
oggi. Nel Nord Ovest, dove l’immigrazione è stata più intensa e spesso drammatica, le<br />
conseguenze del fenomeno migratorio si perpetuano anche nella seconda generazione. In questa<br />
area, le <strong>di</strong>fferenze in termini <strong>di</strong> risorse familiari non sempre bastano a spiegare le <strong>di</strong>fformità<br />
riscontrate nel successo scolastico tra figli <strong>di</strong> immigrati e non, lasciando presagire la presenza<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà intrinseche nel processo migratorio stesso, che esplicano la loro funzione nel lungo<br />
periodo e che possono ostacolare la scolarizzazione dei figli degli immigrati, privando questi <strong>di</strong><br />
un importante mezzo <strong>di</strong> affermazione sociale.<br />
Sostanzialmente possiamo riassumere i risultati ottenuti dall’analisi in tre punti principali.<br />
Innanzitutto, si sottolinea l’essenzialità della <strong>di</strong>stinzione all’interno del gruppo dei figli <strong>di</strong><br />
immigrati nelle tre sottocategorie: G2mix, G2 e G1,5. Il primo <strong>di</strong> questi tre gruppi, che vede un<br />
solo genitore immigrato e uno autoctono, seppur con probabilità più basse <strong>di</strong> proseguire negli<br />
stu<strong>di</strong> universitari rispetto agli autoctoni nel Nord Ovest, non presenta mai <strong>di</strong>fferenze<br />
significative, a <strong>di</strong>mostrazione che la presenza <strong>di</strong> almeno un genitore stabile sul territorio porta a<br />
performance scolastiche non <strong>di</strong>ssimili da quelli della popolazione autoctona. Per gli altri due<br />
gruppi i risultati cambiano a seconda <strong>di</strong> quale livello d’istruzione si consideri. Nell’ambito della<br />
scuola secondaria superiore, un significativo gap negativo nei risultati scolastici è proprio solo<br />
61 Questo risultato si conferma anche se si utilizza un modello ordered probit al posto <strong>di</strong> una<br />
regressione e se mo<strong>di</strong>fica la definizione della variabile in<strong>di</strong>pendente relativa al livello d’istruzione.<br />
62 Le stime ottenute con il modello <strong>di</strong> Heckman sono formalmente più corrette <strong>di</strong> quelli esposti nei<br />
paragrafi precedenti. Tuttavia, constata l’invariabilità dei risultati, si è preferito preservare le stime dei<br />
modelli logit (come appaiono nel resto del capitolo) in quanto permettono un dettaglio <strong>di</strong> analisi non<br />
raggiungibile con i modelli a equazioni simultanee.<br />
152
<strong>di</strong> chi ha vissuto la migrazione dopo la nascita (G1,5): aver vissuto <strong>di</strong>rettamente il percorso<br />
migratorio, aver probabilmente interrotto gli stu<strong>di</strong> in un luogo e averli ripresi in un altro, vivere<br />
una seconda socializzazione nel luogo d’arrivo, sono eventi che lasciano il segno e che<br />
selezionano più duramente durante il percorso scolastico. Per le G2, nate nella zona d’arrivo, le<br />
<strong>di</strong>fferenze con gli autoctoni sono <strong>di</strong> minore entità, in ogni caso non significative: per tale gruppo<br />
l’accesso all’istruzione sembra essere regolato dagli stessi meccanismi <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza dalle<br />
risorse familiari <strong>di</strong> partenza non mostrando specifici svantaggi legati al fenomeno migratorio.<br />
Ma se si focalizza l’attenzione sull’istruzione terziaria, valutando la probabilità <strong>di</strong> avere già<br />
una laurea o quantomeno <strong>di</strong> essere iscritto ad un corso universitario, il quadro cambia,<br />
mostrando un forte recupero per le G1,5 Sud, capaci <strong>di</strong> colmare gran parte del gap con gli<br />
autoctoni. Per le G2, invece, lo svantaggio è netto, sintomo <strong>di</strong> una più scarsa pre<strong>di</strong>sposizione<br />
verso l’istruzione prolungata a vantaggio <strong>di</strong> un più rapido inserimento nel mercato del lavoro.<br />
Il secondo punto è relativo alla <strong>di</strong>versa area <strong>di</strong> arrivo. I risultati appena riassunti sono<br />
evidenti per il Nord Ovest italiano, ma sembrano molto meno netti per l’area del Centro-Nord<br />
Est, dove le <strong>di</strong>fferenze tra autoctoni e figli <strong>di</strong> immigrati tendono a ridursi e perdono<br />
significatività statistica. Non abbiamo abbastanza elementi per <strong>di</strong>re se si tratta semplicemente <strong>di</strong><br />
un effetto dovuto alla scarsa numerosità dei figli <strong>di</strong> immigrati nel Centro-Nord Est, o se le<br />
<strong>di</strong>fferenze nei tempi e nelle caratteristiche dei flussi migratori dal Sud verso le due aree centro-<br />
settentrionali, si traducano in <strong>di</strong>verse modalità <strong>di</strong> inserimento nel tessuto sociale per i figli degli<br />
immigrati.<br />
Infine, come terzo punto va sottolineato il più frequente ricorso nelle regione meri<strong>di</strong>onali<br />
all’istruzione superiore e universitaria, a parità <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> partenza, rispetto sia agli<br />
autoctoni del Centro-Nord, sia, soprattutto, ai figli <strong>di</strong> quei meri<strong>di</strong>onali che hanno lasciato le loro<br />
regioni d’<strong>origine</strong>. Siccome in generale l’incidenza <strong>di</strong> titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o è molto simili nelle due aree<br />
del paese, ne segue che al Sud è minore l’influenza <strong>delle</strong> caratteristiche dei genitori. In altri<br />
termini, lo svantaggio dei figli <strong>di</strong> genitori con titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o più basso e appartenenti alle classi<br />
sociali meno abbienti tende a essere più limitato al Sud rispetto a quanto accade al Centro Nord.<br />
Questo aspetto appare evidente se si sviluppano dei modelli logistici sul campione complessivo<br />
ISTAT 1998, separatamente per i residenti al Centro-Nord e quelli al Sud, le cui stime si<br />
possono osservare nella tabella 5.8.<br />
Questo risultato potrebbe essere interpretato come una maggiore uguaglianza <strong>di</strong> opportunità<br />
tra le classi socio-economiche nel Meri<strong>di</strong>one ma, più verosimilmente, è l’effetto del perdurare <strong>di</strong><br />
forti contingenti <strong>di</strong> forza lavoro giovanile <strong>di</strong>soccupata (Barbagli, 1974). E’ da sottolineare,<br />
infatti, che l’istruzione nel Mezzogiorno sembra avere una importanza inferiore rispetto alle<br />
altre zone d’Italia. Fabbri e Rossi (1997), sostengono che il livello educativo ha un impatto<br />
maggiore sulle scelte occupazionali al Nord rispetto al Sud. Non a caso al Sud, è storicamente<br />
più alto il tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione “intellettuale” (Meldolesi, 1997), cioè è più bassa la<br />
probabilità <strong>di</strong> trovare una occupazione corrispondente al titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o posseduto. Questo<br />
effetto riduce il beneficio atteso dall’investimento in istruzione e può spingere a considerare<br />
l’istruzione superiore, e soprattutto quella universitaria, un’area <strong>di</strong> parcheggio (Pugliese, 1982,<br />
pag. 36). Di più: Barbagli (1974) sostiene che sarebbero state proprio le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong><br />
153
occupazione <strong>di</strong> fronte a cui si sono trovati i giovani usciti dalla scuola dell’obbligo nel<br />
Mezzogiorno a favorire l’espansione dell’istruzione secondaria e universitaria. In breve, dal<br />
secondo dopoguerra in poi, e dunque anche per le <strong>generazioni</strong> oggetto <strong>di</strong> indagine, la scolarità<br />
nel Mezzogiorno tende ad essere gonfiata dalle maggiori <strong>di</strong>fficoltà nell’ingresso nel mercato del<br />
lavoro più che da un effettiva fiducia nell’istruzione come mezzo <strong>di</strong> ascesa sociale.<br />
Tavola 5.8. Modelli <strong>di</strong> regressione logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere 1) un<br />
titolo <strong>di</strong> scuola secondaria superiore o universitario; 2) <strong>di</strong> essere iscritto all’università o <strong>di</strong> avere già un<br />
titolo universitario. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong> massima verosimiglianza dei parametri e relativa<br />
significatività statistica. In<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> età 20-29 anni coabitanti con almeno un genitore. Italia. ISTAT,<br />
1998<br />
1. Diploma sec. sup. 2. Laurea o iscritto all'università<br />
CENTRO NORD SUD CENTRO NORD SUD<br />
n Exp(B) Sig n Exp(B) Sig n Exp(B) Sig n Exp(B) Sig<br />
Livello d'istruzione dei genitori<br />
Entrambi basso 1051 1 974 1 1051 1 974 1<br />
Uno basso e uno me<strong>di</strong>o 670 1.82 *** 431 1.81 *** 670 1.48 *** 431 1.69 ***<br />
Uno basso e uno alto 123 2.72 *** 72 3.01 *** 123 2.29 *** 72 2.26 ***<br />
Entrambi me<strong>di</strong>o 596 2.19 *** 304 2.80 *** 596 2.27 *** 304 2.14 ***<br />
Uno me<strong>di</strong>o e uno alto 409 4.00 *** 230 5.43 *** 409 4.49 *** 230 3.76 ***<br />
Entrambi alto<br />
Classe socio-economica<br />
340 10.34 *** 328 9.69 *** 340 9.09 *** 328 8.71 ***<br />
Classe <strong>di</strong> servizio 560 1 207 1 560 1 207 1<br />
Classe me<strong>di</strong>a impiegatizia 720 0.91 647 1.09 720 0.64 *** 647 0.88<br />
Piccola borghesia urbana 573 0.68 *** 377 0.93 573 0.60 *** 377 0.78<br />
Piccola borghesia agricola 117 0.63 ** 164 0.60 * 117 0.83 164 0.54 **<br />
Classe operaria urbana 1162 0.50 *** 799 0.66 * 1162 0.34 *** 799 0.48 ***<br />
Altre covariate inserite nei modelli: età all’intervista, genere, numero <strong>di</strong> fratelli/sorelle, mobilità padre-nonno.<br />
Significatività: ‘***’ =99%; ‘**’=95%; ‘*’ = 90%.<br />
In conclusione, le in<strong>di</strong>cazioni tracciate da Ceravolo et al. (2001) relative alle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong><br />
accesso all’istruzione superiore per i figli <strong>di</strong> immigrati meri<strong>di</strong>onali a Torino, sono solo<br />
parzia lmente confermate dalla presente analisi estesa a tutto il Centro-Nord. Solo nell’ambito<br />
universitario la con<strong>di</strong>zione figlio <strong>di</strong> immigrato è associata a un minor ricorso al prolungamento<br />
dell’istruzione a favore <strong>di</strong> un più rapido accesso nel mondo del lavoro e, probabilmente, <strong>di</strong> un<br />
maggior ricorso a stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> tipo tecnico o professionalizzanti. Nella scuola secondaria superiore,<br />
invece, l’effetto penalizzante è maggiormente legato alla doppia socializzazione e<br />
all’interruzione del percorso scolastico (vissuti dalle G1,5) che alla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> figlio <strong>di</strong><br />
immigrato in sé. In tal senso, la scuola pubblica può aver svolto un ruolo importante nel favorire<br />
l’integrazione <strong>delle</strong> seconda generazione mentre, sembrerebbe essere stata meno pronta<br />
nell’integrare studenti che avevano già avviato i loro stu<strong>di</strong> in un’altra regione. Ad ogni modo, si<br />
conferma pienamente l’importanza data al momento della migrazione (nato nel luogo d’arrivo o<br />
giunto dopo la nascita) quale fattore <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione all’interno della categoria figlio <strong>di</strong><br />
immigrato.<br />
154
5.7.1 Storia migratoria familiare e investimento nell’istruzione: qualche spunto <strong>di</strong> riflessione<br />
sui possibili meccanismi.<br />
Riferendoci in particolare alla realtà del Nord Ovest, come possiamo interpretare le <strong>di</strong>fferenze<br />
riscontrate tra i figli <strong>di</strong> immigrati e autoctoni, che spesso evidenziano un minor investimento<br />
nell’istruzione da parte dei primi? Trattandosi <strong>di</strong> migrazioni interne all’Italia, sono meno valide<br />
le spiegazioni spesso invocate per gli immigrati stranieri e per i loro figli: <strong>di</strong>stanza culturale,<br />
problemi linguistici, clandestinità e in generale problemi legati alla regolarizzazione. Solo il<br />
problema della lingua potrebbe avere qualche rilevanza, specialmente per le <strong>generazioni</strong> 1,5 se<br />
hanno vissuto i primi anni in un contesto dove si parlava quasi esclusivamente <strong>di</strong>aletto. Ma<br />
questo problema <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento linguistico, ceteris paribus, poteva essere rilevante anche per<br />
gli autoctoni <strong>di</strong> umili origini. Inoltre, non sembra plausibile supporre l’esistenza <strong>di</strong> un senso <strong>di</strong><br />
appartenenza a uno specifico gruppo, a una coscienza <strong>di</strong> essere “altri” rispetto agli autoctoni,<br />
che potrebbe facilitare l’insorgere <strong>di</strong> processi <strong>di</strong> segregazione. Proprio l’assenza <strong>di</strong> tali fattori ci<br />
spinge alla ricerca <strong>di</strong> altri possibili meccanismi.<br />
Innanzitutto, si potrebbe considerare la presenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà reali o percepite <strong>di</strong><br />
affermazione sociale atte a ridurre l’accesso all’istruzione. In alcuni contesti, chi percepisce se<br />
stesso come appartenente a una minoranza svantaggiata può essere sfiduciato anche verso<br />
l’istruzione scolastica (Ogbu, 1991). Dunque, i figli degli immigrati potrebbero avere la<br />
percezione che i pochi percorsi <strong>di</strong> mobilità sociale a loro <strong>di</strong>sponibili non richiedano credenziali<br />
educative (Valverde e Vila, 2003). È intrinseca in una tale visione la presenza <strong>di</strong> forme nette <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>visione sociale fondata sull’<strong>origine</strong> geografica dell’in<strong>di</strong>viduo. Si tratta <strong>di</strong> una situazione molto<br />
simile a quella che agisce nelle inner cities negli USA, dove operano processi <strong>di</strong> mobilità verso<br />
il basso (Portes, 1995). Questo meccanismo però richiede una forte concentrazione “etnica” sul<br />
territorio (ipotizzabile solo per le gran<strong>di</strong> aree urbane) e l’esistenza, o quanto meno la percezione,<br />
<strong>di</strong> comportamenti <strong>di</strong>scriminanti da parte dei locali. Tuttavia, un certo tipo <strong>di</strong> meccanismo<br />
agirebbe nella scuola più che nell’università e nel nostro caso non sembrano palesarsi evidenze<br />
empiriche in tal senso. In generale, è <strong>di</strong>fficile ipotizzare nella realtà italiana la presenza <strong>di</strong> un<br />
senso <strong>di</strong> “<strong>di</strong>fferenza” e <strong>di</strong> una chiara coscienza <strong>di</strong> sé all’interno del gruppo composto da figli <strong>di</strong><br />
immigrati meri<strong>di</strong>onali, tale da rafforzarne i confini rispetto ai figli degli autoctoni (Ceravolo et<br />
al., 2001).<br />
Un secondo possibile meccanismo riguarda la natura stessa <strong>delle</strong> variabili utilizzate per<br />
tener sotto controllo la struttura occupazionale dei genitori. Anche a parità <strong>di</strong> livello socio-<br />
professionale, i genitori immigrati potrebbero essersi inseriti in circuiti <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>versi rispetto<br />
a quelli degli autoctoni (si pensi, ad esempio, alla massiccia presenza degli immigrati<br />
nell’e<strong>di</strong>lizia nel Nord Ovest) associati a <strong>di</strong>fferenti propensioni nell’investimento in istruzione.<br />
Un maggior dettaglio <strong>delle</strong> caratteristiche socio-professionali dei genitori sarebbe allora in<br />
grado <strong>di</strong> spiegare tutte le <strong>di</strong>fferenze tra figli <strong>di</strong> immigrati e non, facendole rientrare nel più<br />
generale quadro <strong>di</strong> influenza della classe sociale d’<strong>origine</strong>. Tuttavia, in tal caso non si fa altro<br />
che sostenere un legame tra status migratorio e posizione socio-occupazionale ben più forte <strong>di</strong><br />
quello evidenziato nell’analisi. Ma, in tal caso, l’effetto dato dalla con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> figlio <strong>di</strong><br />
155
immigrati sull’istruzione conserverebbe la sua importanza, ancorché esso si esplichi attraverso<br />
la posizione socio-professionale dei genitori.<br />
È inoltre ipotizzabile l’azione <strong>di</strong> un effetto <strong>di</strong> selezione insito nel processo migratorio stesso<br />
che va oltre ai fattori socio-demografici <strong>di</strong> cui si è tenuto conto nell’analisi. E veniamo così alla<br />
terza possibile interpretazione <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fferenze. I genitori immigrati durante il boom economico,<br />
potrebbero presentare in me<strong>di</strong>a, rispetto al resto della popolazione italiana e a parità <strong>di</strong> <strong>origine</strong><br />
sociale, un atteggiamento più orientato verso la cultura del lavoro che verso la cultura<br />
dell’investimento educativo. Questa specificità dei genitori immigrati si tradurrebbe, in una<br />
maggiore spinta verso una più rapida remunerazione nel mondo del lavoro (magari dopo aver<br />
ottenuto un <strong>di</strong>ploma tecnico o professionalizzante) piuttosto che verso la prosecuzione negli<br />
stu<strong>di</strong> universitari. In questo caso, sugli attori della migrazione agirebbero meccanismi sociali<br />
complessi, strettamente legati alla cerchia sociale <strong>di</strong> appartenenza e capaci <strong>di</strong> influenzare sia i<br />
progetti migratori sia la costruzione dei percorsi educativi e occupazionali propri e della<br />
<strong>di</strong>scendenza (Ceravolo et al. 2001). Tali meccanismi potrebbero aver avuto luogo tra i genitori<br />
<strong>delle</strong> G2 Sud nel Nord Ovest, cioè tra i genitori con più bassi livelli d’istruzione e una forte<br />
componente operaia al loro interno. Non a caso i loro figli, terminata la scuola secondaria<br />
superiore subiscono un crollo rispetto agli altri gruppi nella frequenza all’università.<br />
Nell’analisi abbiamo visto come nella scuola superiore l’han<strong>di</strong>cap più significativo è<br />
vissuto dalle G1,5 Sud. Abbiamo già accennato alla possibile influenza negativa data dall’aver<br />
interrotto il percorso scolastico e dalla forzata doppia socializzazione cui questi in<strong>di</strong>vidui vanno<br />
incontro spostandosi con il nucleo familiare durante l’infanzia. Soffermiamoci brevemente su<br />
questo punto. Per le G1,5 può contare l’impatto negativo dato dall’aver interrotto la propria<br />
carriera scolastica (Valverde e Vila, 2003): da un lato vi è il maggior carico <strong>di</strong> lavoro richiesto<br />
per integrarsi con i programmi scolastici della nuova scuola, dall’altro l’inserimento nel nuovo<br />
ambiente richiede lo sforzo per una seconda socializzazione, cioè per l’appren<strong>di</strong>mento della<br />
realtà sociale circostante e dei suoi meccanismi. Questi fattori possono facilitare la<br />
sperimentazione <strong>di</strong> insuccessi capaci <strong>di</strong> creare momenti <strong>di</strong> emarginazione e produrre i<br />
presupposti per l’insorgere <strong>di</strong> catene <strong>di</strong> svantaggi futuri (Ceravolo et al., 2001). In altre parole, i<br />
nuovi arrivati possono entrare con maggior frequenza nel circolo degli studenti me<strong>di</strong>ocri<br />
rimanendovi involontariamente coinvolti. Nella sua ricerca sugli immigrati meri<strong>di</strong>onali a<br />
Torino, Fofi (1975) interrogando insegnanti scolastici rileva le maggiori <strong>di</strong>fficoltà riscontrate da<br />
chi, arrivando da altre regioni, cerca <strong>di</strong> inserirsi nella nuova realtà scolastica. Dice uno <strong>di</strong> questi<br />
insegnanti: «con i bambini già scolarizzati bisogna ricominciare tutto daccapo con <strong>di</strong>fficoltà<br />
enormi. Va invece molto meglio con i non scolarizzati. Bisogna declassare la più parte dei<br />
ragazzi scolarizzati perché pur avendo, ad esempio, una licenza <strong>di</strong> quinta è già molto se li si può<br />
mettere vicini quanto a preparazione a ragazzi piemontesi <strong>di</strong> terza». Nuove <strong>di</strong>fficoltà sono date<br />
dall’arrivo degli immigrati che portano a scuola i figli a febbraio o marzo. I genitori, d’altro<br />
canto, spesso rinunciano a sostenere lo sforzo supplementare che i figli devono sostenere nel<br />
processo <strong>di</strong> adattamento: «se aveva cominciato a stu<strong>di</strong>are qui era un’altra cosa, adesso è già in<br />
ritardo e non è svelto <strong>di</strong> sviluppo come se avesse stu<strong>di</strong>ato qui» (Fofi, 1975).<br />
156
Un nucleo familiare che vive una migrazione durante l’infanzia o l’adolescenza del figlio si<br />
trova ad affrontare problemi <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento e integrazione proprio durante la formazione<br />
scolastica del figlio. I nuovi arrivati si troveranno sicuramente nella situazione <strong>di</strong> doversi<br />
ambientare nel nuovo lavoro, se non cercarsene uno nuovo, procurarsi una abitazione e far<br />
fronte, in generale, a spese supplementari in misura me<strong>di</strong>amente maggiore rispetto a chi risiede<br />
sul territorio da più tempo. Se queste spese aggiuntive sopraggiungono durante gli anni della<br />
scuola primaria e secondaria inferiore del figlio (situazione questa <strong>di</strong> certo più probabile per le<br />
famiglie <strong>delle</strong> G1,5 che per quelle <strong>delle</strong> G2) allora potrebbero bloccare risorse economiche<br />
altrimenti destinate all’istruzione dei figli. Inoltre, essere nuovi in un territorio vuol <strong>di</strong>re<br />
<strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> minori risorse mancando, o essendo limitato, il supporto parentale e quello fornito<br />
dalle reti <strong>di</strong> amicizie e conoscenze e, <strong>di</strong> nuovo, le G1,5 sono la categoria più a rischio in tal<br />
senso 63 .<br />
Riferimenti bibliografici<br />
Acquarone A., 1965, L’organizzazione dello Stato totalitario , Torino, Einau<strong>di</strong>.<br />
Alasia F. e Montal<strong>di</strong> D., 1975, Milano, Corea: inchiesta sugli immigrati, nuova e<strong>di</strong>zione<br />
accresciuta, Milano, Feltrinelli.<br />
Alberoni F., Baglioni G., 1965, L’integrazione dell’immigrato nella società industriale,<br />
Bologna, Il Mulino.<br />
Amendola A., Autiero G. e Nese A., 2002, Mobilità intergenerazionale nel livello d’istruzione<br />
in Italia: un’analisi comparativa tra Centro-Nord e Sud, Economia e Lavoro 36(2), pp.131-<br />
51.<br />
Ballarino G. e Cobalti A., 2003, Mobilità sociale , Roma, Carocci.<br />
Barbagli M., 1974, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia (1859-1973),<br />
Bologna, Il Mulino.<br />
Barbagli M., Capecchi V. e Cobalti A., 1988, La mobilità sociale in Emilia Romagna, Bologna,<br />
Il Mulino.<br />
Bianco M.L. (a cura <strong>di</strong>), 2001, L’Italia <strong>delle</strong> <strong>di</strong>suguaglianze, Roma, Carocci.<br />
Blake J., 1989 Family size and achievement, Los Angeles, CA, University of California.<br />
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6489p0rr/<br />
Bonifazi C., 1999, Mezzogiorno e migrazioni interne, Roma, Irp-Cnr.<br />
Ceravolo F., Eve M. e Meraviglia C., 2001, Migrazioni e integrazione sociale: un percorso a<br />
sta<strong>di</strong> in Bianco ( 2001).<br />
63 Come abbiamo già ampiamente sottolineato, lo svantaggio <strong>delle</strong> G1,5 nella scuola rispetto agli<br />
autoctoni, tende a sparire nell’ambito universitario. A tal proposito, abbiamo ipotizzato la presenza <strong>di</strong> una<br />
più forte selezione all’interno <strong>di</strong> questo gruppo. L’accentuata eterogeneità all’interno <strong>di</strong> tale gruppo, si a<br />
in termini <strong>di</strong> <strong>origine</strong> sociale che <strong>di</strong> risultato scolastico, potrebbe lasciar presagire la presenza <strong>di</strong><br />
meccanismi <strong>di</strong> assimilazione segmentata (Portes and Zhou, 1993). Tuttavia, gli elementi a <strong>di</strong>sposizione<br />
non permettono <strong>di</strong> testare una tale ipotesi.<br />
157
Checchi D., 1997, L'efficacia del sistema scolastico italiano in prospettiva storica, in Rossi<br />
(1997).<br />
Checchi D., 1998, Povertà e istruzione: alcune riflessioni e una proposta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori, Politica<br />
Economica, XIV (2).<br />
Cobalti A. e Schizzerotto A., 1994, La mobilità sociale in Italia, Bologna, Il Mulino.<br />
Dei M., 1993 Cambiamento senza riforma: la scuola secondaria superiore negli ultimi<br />
trent’anni, in Soldani S. e Turi G. (a cura <strong>di</strong>), Fare gli italiani, Bologna, Il Mulino.<br />
Erikson R., 1984, Social class of men, women and families, Sociology, 4, pp 500-14.<br />
Fabbri F. e Rossi N., 1997, Caste non classi, in Rossi (1997).<br />
Fofi G., 1975, L’immigrazione meri<strong>di</strong>onale a Torino, E<strong>di</strong>zione ampliata, Milano, Feltrinelli.<br />
Frigessi Castelnuovo D., 1983, Immigrati in una città <strong>di</strong>fficile, Inchiesta, 62.<br />
Ginsborg P, 1989, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-1988, Torino,<br />
Einau<strong>di</strong>.<br />
Goldthorpe J.H., 1980, Social Mobility and class structure in modern Britain , Oxford,<br />
Clarendon Press.<br />
Goldthorpe J.H., 1983, Women and class analysis: in defence of the conventional view,<br />
Sociology, 4, pp. 465-88.<br />
Goldthorpe J.H., Payne C., Llewellyn C., 1987. Social mobility and Class Structure in Modern<br />
Britain, Oxford, Clarendon Press.<br />
Golini A., 1974, Distribuzione della popolazione, migrazioni interne e urbanizzazione in Italia ,<br />
Istituto <strong>di</strong> Demografia, Roma, Università degli stu<strong>di</strong> “La <strong>Sapienza</strong>”.<br />
Ichino A., Rustichini A.., Checchi D., 1997, Scuola e mobilità sociale: un analisi comparata, in<br />
Rossi (1997).<br />
Lillard, L.A. e Panis, C.W.A.,2000, aML multilevel multiprocess statistical software, Release<br />
1.0. Los Angeles, Econware.<br />
Martinotti G. (a cura <strong>di</strong>), 1982, La città <strong>di</strong>fficile. Equilibri e <strong>di</strong>suguaglianze nel mercato urbano<br />
(progetto Torino: sette ricerche per una città), Milano, Franco Angeli.<br />
Meldolesi, 1997, L’elevata mobilità del lavoro nel Mezzogiorno della speranza, in Galli G. (a<br />
cura <strong>di</strong>) La mobilità della società italiana I, Roma, SIPI.<br />
Negri N., 1982, I nuovi torinesi: immigrazione, mobilità e struttura sociale, in Martinotti<br />
(1982).<br />
Ogbu J., 1991, Minority coping responses and school achievement, Journal of Psychohistory,<br />
18, 433-56.<br />
Pisati M., 2002, La mobilità sociale , Bologna, Il Mulino.<br />
Portes A. (a cura <strong>di</strong>), 1995, The economic sociology of immigration: essays in network,<br />
ethnicity, and entrepreneurship, New York, Russel Sage Foundation.<br />
Portes A. e Zhou M., 1993, The new second generation: segmented assimilation and its<br />
variants, in Annali of the American Academy of political and social science, n.530,<br />
novembre, pp. 74-96.<br />
Pugliese E. (a cura <strong>di</strong>), 1982, I giovani tra scuola e lavoro nel Mezzogiorno. Un’indagine su<br />
Napoli, Milano, Franco Angeli.<br />
158
Pugliese E., 1983, Continuità e innovazioni nell’emigrazione italiana, Inchiesta, 62.<br />
Pugliese E., 2002 L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Bologna, Il<br />
Mulino.<br />
Rossi N. (a cura <strong>di</strong>), 1997, L’istruzione in Italia: solo un pezzo <strong>di</strong> carta?, Bologna, Il Mulino.<br />
Shavit Y., Blossfeld H.P. (a cura <strong>di</strong>) 1993. Persistent inequality. Changing educational<br />
attainment in thirteen countries, Boulder (CO), Westview press.<br />
Shavit, Y. e Müller W. (a cura <strong>di</strong>), 1998, From school to work , Oxford, Oxford University<br />
Press.<br />
Sori E., 1975, Emigrazione all’estero e migrazioni interne in Italia tra le due guerre, Quaderni<br />
Storici, 29-30.<br />
Sori E., 1979, L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mon<strong>di</strong>ale, Bologna, Il<br />
Mulino.<br />
Treves A., 1976, Le migrazioni interne nell'Italia fascista , Torino, Einau<strong>di</strong>.<br />
Valverde J.R. e Vila M.R., 2003, Internal migration and inequalities. The influence of migrant<br />
origin on educational attainment in Spain, European sociological review, 19(3).<br />
Warner, W. e Srole, L., 1945, The social system of American ethnic groups, Yankee city series,<br />
3, New Haven and London, Yale university press.<br />
159
160
6.1 Riepilogo dei risultati ottenuti<br />
161<br />
CAPITOLO VI<br />
Conclusioni e spunti <strong>di</strong> riflessione<br />
Il livello d’istruzione <strong>di</strong> un in<strong>di</strong>viduo è un aspetto fortemente legato alle caratteristiche della<br />
famiglia <strong>di</strong> appartenenza. La classe sociale e il titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o dei genitori influiscono sulle<br />
scelte relative all’istruzione, sulle ambizioni e sui risultati dei figli nel mondo della scuola e<br />
dell’università. Tuttavia, pur tenendo conto <strong>di</strong> questo meccanismo, l’esperienza migratoria<br />
propria e dei genitori si configura come un fattore tutt’altro che trascurabile nel definire le<br />
ambizioni e le possibilità <strong>di</strong> mobilità sociale.<br />
Nella tavola 6.1 sono riepilogati alcuni dei principali risultati visti nei capitoli precedenti in<br />
termini <strong>di</strong> odds ratio atti a esprimere la probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
secondario superiore per la categoria precisata rispetto alla stessa probabilità valutata per gli<br />
autoctoni.<br />
Tavola 6.1 Riepilogo <strong>di</strong> alcuni dei risultati ottenuti nei capitoli precedenti. Modelli <strong>di</strong> regressione<br />
logistica binomiale per l’analisi <strong>delle</strong> probabilità <strong>di</strong> ottenere almeno un titolo <strong>di</strong> scuola secondaria<br />
superiore in base alla coorte <strong>di</strong> nascita. Anti-logaritmo <strong>delle</strong> stime <strong>di</strong> massima verosimiglianza dei<br />
parametri e relativa significatività statistica.<br />
In Francia In Australia In Svizzera<br />
Nel Centro-<br />
Nord Italia<br />
-1949 1950-79 1930-59 1960-79 1950-79 1969-78<br />
Autoctoni<br />
Figli <strong>di</strong> immigrati italiani:<br />
1 1 1 1 1 1<br />
Nati nel luogo d'arrivo / un solo genitore immigrato<br />
Nati nel luogo d'arrivo / entrambi i genitori immigrati<br />
0,70*** 0,93<br />
0,81** 1,17***<br />
0,64** 1,91*** 1,78*<br />
0,93<br />
0,86<br />
Giunti dopo la nascita / entrambi i genitori immigrati 0,60** 0,98 --- --- --- 0,47***<br />
Significatività statistica: *** =99%; **=95%; * = 90%<br />
I risultati ottenuti nella presenta analisi ci invitano a concludere che nonostante la storia<br />
dell’emigrazione italiana sia costellata <strong>di</strong> trage<strong>di</strong>e e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà, il desiderio degli emigrati<br />
<strong>di</strong>venuti genitori <strong>di</strong> fornire ai loro figli tutti gli strumenti necessari per realizzare quel processo<br />
<strong>di</strong> ascesa sociale che molto <strong>di</strong>fficilmente hanno potuto compiere <strong>di</strong> prima persona, è stato spesso<br />
sod<strong>di</strong>sfatto. Non è una eccezione, infatti, che le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana all’estero
abbiano ottenuto una istruzione elevata, spesso superiore anche a quella dei loro coetanei figli<br />
dei nativi, a parità <strong>di</strong> background familiare.<br />
La buona riuscita scolastica e università dei figli degli italiani all’estero si evidenzia<br />
soprattutto nelle classi sociali me<strong>di</strong>o-basse. Questo risultato è particolarmente interessante<br />
poiché emerge in tutti i tre paesi considerati ed evidenzia la maggiore capacità <strong>delle</strong> famiglie<br />
immigrate dall’Italia <strong>di</strong> far fronte a risorse limitate pur non rinunciando a offrire ai propri figli<br />
quanto possibile per garantire il proseguimento degli stu<strong>di</strong>. Come già sottolineato da Portes e<br />
MacLeod (1996), i futuri benefici per i propri figli sono spesso la motivazione che spinge alla<br />
migrazione. Sotto questa forte spinte motivazionale, non sorprende che le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
riescano meglio rispetto agli autoctoni, permettendo <strong>di</strong> sopperire anche a situazioni <strong>di</strong> partenza<br />
meno vantaggiose.<br />
Ma il quadro appena delineato è relativo alla storia più recente, quella degli ultimi decenni.<br />
Le <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> meno giovani, quelle nate in Australia più <strong>di</strong> 40 anni fa e in Francia più<br />
<strong>di</strong> 50, la situazione non è altrettanto rosea: essere figlio <strong>di</strong> italiani per queste <strong>generazioni</strong> ha<br />
costituito un significativo svantaggio nella corsa verso una istruzione me<strong>di</strong>o-alta. Dunque, due<br />
situazioni opposte, una evoluzione temporale che permette un cambiamento sostanziale <strong>delle</strong><br />
relazioni in atto quantomeno nei contesti considerati.<br />
Abbiamo già fatto cenno ad alcune mo<strong>di</strong>ficazioni nei paesi d’accoglienza <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong> tipo<br />
legislativo, nel potenziamento <strong>di</strong> mezzi <strong>di</strong> integrazione <strong>delle</strong> famiglie immigrate,<br />
nell’attenuazione o scomparsa della <strong>di</strong>scriminazione contro gli italiani, nella tendenza al<br />
multiculturalismo e così via. Colpisce, tuttavia, la tendenza comune dei risultati ottenuti. Questo<br />
aspetto ci invoglia a cercare <strong>di</strong> delineare una lettura unitaria <strong>di</strong> più ampia portata. Pertanto,<br />
vengono proposte qui <strong>di</strong> seguito degli spunti <strong>di</strong> riflessione che, partendo dalla letteratura<br />
esistente sull’argomento, non vogliono essere <strong>delle</strong> interpretazioni del fenomeno ma<br />
semplicemente <strong>delle</strong> ipotesi <strong>di</strong> lavoro su cui poter estendere lo stu<strong>di</strong>o <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana.<br />
Un <strong>di</strong>scorso a parte va fatto sui figli degli immigrati dal Meri<strong>di</strong>one al Centro-Nord Italia.<br />
Quantunque la migrazione interna non presenti gli ostacoli legati alle migrazioni internazionali,<br />
si pensi ad esempio all’acquisizione della citta<strong>di</strong>nanza e alla lingua, è stata spesso una<br />
esperienza drammatica e ha presentato <strong>delle</strong> <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> inserimento talvolta non minori<br />
rispetto a quelle vissute dai connazionali all’estero. Difficoltà che si riflettono sui figli che non<br />
brillano nel sistema scolastico e universitario rispetto ai coetanei autoctoni, anzi, talvolta non<br />
riescono a tenere il loro passo.<br />
Alla luce <strong>di</strong> quanto appena detto, c’è quasi la tentazione <strong>di</strong> concludere che sia andata meglio<br />
alle famiglie meri<strong>di</strong>onali emigrate all’estero rispetto a quelle emigrate al Centro-Nord Italia.<br />
Tuttavia, ricusiamo tale tentazione sia perché i contesti sono talmente <strong>di</strong>versi da esigere una<br />
trattazione propria e specifica sia perché le fonti <strong>di</strong> dati sono troppo <strong>di</strong>verse per poter ragionare<br />
in un ottica comparativa. Il problema dei dati è particolarmente calzante nel caso <strong>delle</strong><br />
migrazioni interne dove la natura dei dati ha richiesto specifiche ipotesi e adattamenti che<br />
invece non sono stati necessari per la Francia, l’Australia e la Svizzera. Lo sforzo compiuto in<br />
tal senso deriva da una forte carenza <strong>di</strong> fonti per lo stu<strong>di</strong>o <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> <strong>origine</strong><br />
162
estera in Italia e una totale mancanza nel caso dei figli degli emigrati dal Meri<strong>di</strong>one. Non a caso,<br />
dunque, l’analisi presentata nel capitolo 6 rappresenta uno dei primi tentativi in assoluto <strong>di</strong><br />
misurare l’integrazione <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> nell’ottica interna in Italia. Data l’importanza,<br />
spesso sottovalutata, soprattutto <strong>di</strong> recente, <strong>delle</strong> migrazioni interne nell’evoluzione storica,<br />
economica e sociale del nostro paese, non possiamo che auspicarci ulteriori e più approfon<strong>di</strong>ti<br />
stu<strong>di</strong> sull’argomento e lo sviluppo <strong>di</strong> rilevazioni maggiormente focalizzate sugli spostamenti<br />
migratori interni al paese.<br />
Nel complesso dei <strong>di</strong>versi contesti analizzati, lo forzo compiuto nel <strong>di</strong>stinguere all’interno<br />
del gruppo figli <strong>di</strong> immigrati tra chi nato è nato o meno nel luogo <strong>di</strong> destinazione e tra chi ha<br />
uno solo o entrambi i genitori immigrati, non si è rivelato vano. Laddove le numerosità lo hanno<br />
permesso, si è potuto notare che le G1,5 hanno generalmente maggiori <strong>di</strong>fficoltà nel percorso<br />
scolastico rispetto alle altre categorie <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> immigrati: ribadendo quanto già appare in<br />
letteratura, l’eventuale interruzione degli stu<strong>di</strong> e la necessità <strong>di</strong> esperire una doppia<br />
socializzazione, possono rappresentare <strong>delle</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> svantaggio relativo <strong>di</strong> cui bisogna<br />
tener conto in ambito politico. La scuola, unanimemente riconosciuta come uno dei principali<br />
mezzi <strong>di</strong> integrazione, deve farsi carico anche <strong>di</strong> chi compie l’immigrazione in età molto<br />
giovane. Infine, si è anche notato, non senza sorpresa, che nella carriera scolastica dei figli <strong>di</strong><br />
italiani all’estero, avere un genitore autoctono non costituisce un vantaggio rispetto a chi ha<br />
entrambi i genitori immigrati.<br />
6.2 Spunti <strong>di</strong> riflessione<br />
Focalizziamo per ora l’attenzione solo sulle coorti più giovani <strong>di</strong> figli <strong>di</strong> immigrati. Cosa può<br />
aver spinto i figli degli emigrati italiani a una elevata propensione a raggiungere titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
elevati? La relazione genitore-figli rappresenta <strong>di</strong> certo un aspetto cruciale.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista del genitore, l’appartenenza al gruppo degli immigrati, in perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> flussi<br />
intensi, è stata, ed è tuttora, percepita come meno valorizzante. Ma, dato che l’in<strong>di</strong>viduo aspira a<br />
una identità sociale positiva, cioè ha desiderio <strong>di</strong> far parte <strong>di</strong> gruppi socialmente valorizzati, chi<br />
si sente coinvolto in questo meccanismo può adottare particolari strategie <strong>di</strong> compensazione. Se<br />
queste sono <strong>di</strong>fficilmente attuabili su se stesso, possono essere in<strong>di</strong>rizzate sui propri figli ad<br />
esempio, garantendo un investimento sulla loro istruzione superiore alla me<strong>di</strong>a della<br />
popolazione. Il sostegno dato all’istruzione dei figli non è da intendersi solo in termini<br />
economici ma anche affettivi e progettuali che si traducono nell’incoraggiamento, nella<br />
protezione e nella formazione <strong>di</strong> uno scudo alle <strong>di</strong>fficoltà incontrate nel percorso formativo 64<br />
(Cesari Lusso, 1997).<br />
64 Nelle parole dei giovani <strong>di</strong> età 20-30 anni figli <strong>di</strong> immigrati italiani in Svizzera intervistati da<br />
Cesari Lusso (1997), si evince chiaramente l’importanza del sostegno fornito a favore della propria<br />
istruzione dai genitori per i quali la scolarità dei figli costituisce l’investimento prioritario al quale<br />
destinare le risorse familiari.<br />
163
Dal punto <strong>di</strong> vista dell’attore, cioè del figlio dell’immigrato, le <strong>di</strong>fficili esperienze vissute dai<br />
genitori possono far generare un senso <strong>di</strong> rivalsa e il contatto costante con due realtà parallele,<br />
quella familiare e quella del mondo esterno, possono far generare nell’in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong> seconda<br />
generazione un forte senso <strong>di</strong> concorrenzialità capace <strong>di</strong> condurre a risultati scolastici migliori<br />
della me<strong>di</strong>a. Inoltre, l’appartenenza al gruppo sociale degli immigrati può comportare nel paese<br />
d’accoglimento un han<strong>di</strong>cap <strong>di</strong> immagine e <strong>di</strong> autostima. Ad esempio, anche senza esplicite<br />
<strong>di</strong>scriminazioni da parte degli autoctoni, può svilupparsi nei figli degli immigrati la percezione<br />
<strong>di</strong> sentirsi fuori posto. Le parole <strong>di</strong> un ragazzo <strong>di</strong> 27 anni figlio <strong>di</strong> immigrati italiani in Svizzera<br />
rendono chiaro questo aspetto:<br />
« [...] Mi hanno sempre fatto capire non solo <strong>di</strong> essere uno straniero, ma anche,<br />
come si <strong>di</strong>ce in tedesco, “fehl am Plazt” (fuori posto). […] E te lo facevano<br />
capire in<strong>di</strong>rettamente, cioè non ti <strong>di</strong>cevano in faccia ecc. ecc. che sei un italiano<br />
emigrato vattene a casa» (Cesari Lusso, 1997, pag. 274).<br />
Per sopperire a questa percezione il successo scolastico, quale elemento riconosciuto <strong>di</strong><br />
affermazione sociale, può contribuire a sostenere la costruzione <strong>di</strong> una percezione <strong>di</strong> sé come<br />
persona competente, malgrado gli ostacoli, rassicurando l’in<strong>di</strong>viduo del suo valore (Cesari<br />
Lusso, 1997).<br />
L’ipotesi <strong>di</strong> Chiswick (1999) secondo cui i migliori risultati <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong><br />
sarebbero il frutto dell’influenza positiva data da genitori positivamente selezionati tra gli<br />
in<strong>di</strong>vidui con maggior abilità nel lavoro e motivazioni sopra la me<strong>di</strong>a, sembrerebbe trovare<br />
qualche supporto dall’analisi relativamente alle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> nate dopo il 1950. Come fa<br />
notare Sori (2001, pag. 285), malgrado il carattere spontaneo, in<strong>di</strong>viduale e spesso non<br />
organizzato dell’emigrazione italiana all’estero, si avverte la sensazione che le scelte <strong>delle</strong><br />
destinazioni si siano realizzate seguendo una qualche razionalità implicita basata oltre che su<br />
elementi congiunturali (i tassi <strong>di</strong> cambio, la congiuntura economica, la presenza <strong>di</strong> una comunità<br />
italiana già inse<strong>di</strong>ata) anche su fattori quali la durata prevista dell’espatrio, il guadagno<br />
ottenibile in base ai livelli salariali, la quota <strong>di</strong> risparmio realizzabile in base al costo della vita, i<br />
costi <strong>di</strong> trasporto, le prospettive <strong>di</strong> stabile inserimento. Questi fattori <strong>di</strong> scelta possono aver<br />
innescato processi <strong>di</strong> selezione legati sia alla raggiungibilità della destinazione sia alle<br />
potenzialità dell’in<strong>di</strong>viduo. Dunque, una prima selezione si verificava alla partenza: solo chi<br />
aveva maggiori probabilità <strong>di</strong> successo nel mercato del lavoro poteva correre il rischio <strong>di</strong><br />
spingersi più lontano affrontando più incognite. Chi invece aveva aspettative me<strong>di</strong>ocri sarebbe<br />
stato più propenso a provare in un paese vicino o in un'altra regione d’Italia verso il quale la<br />
migrazione era meno onerosa sia in senso economico che personale. Un secondo processo <strong>di</strong><br />
selezione si realizzava naturalmente nel luogo d’arrivo: chi incontrava particolari problemi <strong>di</strong><br />
inserimento, chi non riusciva a collocarsi stabilmente nel mercato del lavoro, tornava a casa con<br />
la conseguenza che a trovare una collocazione stabile nel territorio d’arrivo è generalmente chi<br />
ce l’ha fatta, chi ha compiuto il suo processo <strong>di</strong> integrazione. Solo costoro hanno avuto la<br />
possibilità <strong>di</strong> formare una famiglia e dar vita alle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong>.<br />
164
Il numero contenuto <strong>di</strong> rimpatri dall’Australia a seguito della grande ondata migratoria del<br />
secondo dopoguerra, la grande <strong>di</strong>stanza e l’onerosità del viaggio unitamente al buon livello <strong>di</strong><br />
integrazione della popola zione <strong>di</strong> <strong>origine</strong> italiana in questo paese, lascia presagire una forte<br />
selezione dei migranti alla partenza. Viceversa, il numero più elevato <strong>di</strong> rimpatri dalla Francia e<br />
soprattutto dalla Svizzera, dove ha dominato il carattere temporaneo dell’emigrazione italiana, e<br />
la prossimità geografica <strong>di</strong> questi due paesi al territorio italiano, ci inducono a pensare a un<br />
processo <strong>di</strong> selezione che si è attuato in loco e che quin<strong>di</strong> più che l’emigrazione ha con<strong>di</strong>zionato<br />
la permanenza sul territorio. Infine, la migrazione interna, essendo la meno onerosa sotto ogni<br />
punto <strong>di</strong> vista con una selezione in entrata meno stringente e caratterizzata da un numero<br />
inferiore <strong>di</strong> ritorni al luogo d’<strong>origine</strong>, è probabilmente legata a una minore rigi<strong>di</strong>tà del processo<br />
selettivo sia alla partenza che nella permanenza.<br />
Ma l’effetto positivo <strong>di</strong> selezione dei migranti è molto probabilmente capace <strong>di</strong> esplicarsi<br />
solo in un contesto legislativo e <strong>di</strong> accoglienza favorevole <strong>delle</strong> famiglie italiane. E qui<br />
esten<strong>di</strong>amo le nostre riflessioni anche alle <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> meno giovani, figlie <strong>di</strong> flussi<br />
migratori più lontani nel tempo e, in ogni caso antecedenti gli anni del miracolo italiano. In tutti<br />
i tre paesi considerati (Francia, Australia e Svizzera), i risultati migliori sono stati raggiunti dai<br />
figli <strong>delle</strong> ultime gran<strong>di</strong> ondate migratorie cioè solo quando le comunità italiane erano ormai<br />
stabilmente inse<strong>di</strong>ate nel territorio. Non si può allora escludere la possibilità che avere a<br />
<strong>di</strong>sposizione una comunità <strong>di</strong> italiani possa significare un enorme vantaggio in termini <strong>di</strong> risorse<br />
a <strong>di</strong>sposizione, dove tali risorse sono da intendere nel senso <strong>di</strong> un più elevato capitale sociale.<br />
Quantunque non vi siano forti in<strong>di</strong>cazioni in proposito, non si può tuttavia trascurare<br />
completamente una ulteriore ipotesi: i risultati scolastici dei figli degli italiani raggiungono e<br />
talvolta superano quelli degli autoctoni solo quando l’immigrazione italiana viene affiancata da<br />
altri flussi in entrata meno desiderabili. Si pensi all’ingresso degli algerini in Francia nel<br />
secondo dopoguerra, all’arrivo dei maghrebini in Svizzera e degli asiatici del Sud-Est in<br />
Australia e a quello degli extracomunitari nel Nord Italia. Come <strong>di</strong>re che quando la<br />
<strong>di</strong>scriminazione e l’aggressività della popolazione locale si orienta verso i nuovi immigrati,<br />
identificandoli loro come “<strong>di</strong>versi”, gli immigrati italiani acquisiscono una sorta <strong>di</strong> immunità<br />
dalla <strong>di</strong>scriminazione, facendoli apparire come più familiari. Questa ipotesi, parte dal<br />
presupposto che vi sia una tendenza alla <strong>di</strong>scriminazione verso gli immigrati che, pur<br />
cambiando obiettivo, resti un carattere intrinseco <strong>delle</strong> popolazioni. Che la storia <strong>delle</strong><br />
migrazioni, italiane e non, sia piena <strong>di</strong> episo<strong>di</strong> <strong>di</strong> intolleranza, <strong>di</strong>ffidenza se non <strong>di</strong> vero e<br />
proprio razzismo, è fuori <strong>di</strong>scussione ma, almeno fino a prova contraria, non ce la sentiamo <strong>di</strong><br />
avallare una ipotesi del genere continuando a pensare che si tratti <strong>di</strong> episo<strong>di</strong>, <strong>di</strong> sentimenti e<br />
comportamenti attinenti solo ad alcune porzioni <strong>delle</strong> popolazioni e capaci <strong>di</strong> generarsi con<br />
particolare enfasi solo in alcuni momenti storici particolari.<br />
Concludendo, cre<strong>di</strong>amo che non basti guardare ai luoghi d’arrivo per spiegare quanto<br />
accaduto. La scelta <strong>di</strong> investire in modo massiccio sull’istruzione dei figli può <strong>di</strong>pendere da<br />
aspetti culturali appresi nel paese d’<strong>origine</strong>. Tuttavia, il valore dato all’istruzione non è rimasto<br />
costante in Italia ma si è progressivamente accresciuto nella prima metà del Novecento. Negli<br />
anni dell’espansione economica le migliorate con<strong>di</strong>zioni economiche, la necessaria adattabilità<br />
165
e mobilità della forza <strong>di</strong> lavoro, l’esigenza <strong>di</strong> integrazione sociale fanno comprendere<br />
l’importanza <strong>di</strong> un’istruzione <strong>di</strong> base almeno fino al 14° anno <strong>di</strong> età. Ma, più in generale, si<br />
rafforza e si <strong>di</strong>ffonde nei ceti me<strong>di</strong>o-bassi l’immagine dell’istruzione come veicolo <strong>di</strong><br />
promozione sociale in<strong>di</strong>viduale (Dei, 1993). Come sottolinea Barbagli in apertura del suo<br />
famoso saggio sulla <strong>di</strong>soccupazione intellettuale in Italia (Barbagli, 1974),<br />
«Mai forse la fiducia nell’istruzione fu forte e incontrastata come alla fine degli<br />
anni ’50. Sacerdoti moderni ne pre<strong>di</strong>carono allora la virtù. Sostenuti e finanziati<br />
dai governi e dalle fondazioni, sociologi ed economisti investirono le loro<br />
migliori energie in questa impresa affascinante […] i più riuscirono a intendere<br />
quali fossero le virtù dell’istruzione, compresero che bastava che questa venisse<br />
piantata, attecchisse, crescesse sana e robusta perché tutti i mali dell’uomo<br />
sarebbero finiti, le tiranni<strong>di</strong> crollate, la <strong>di</strong>soccupazione e il sottosviluppo<br />
scomparsi» (Barbagli, 1974, pag. 11).<br />
Sorge allora l’idea che, rispetto a coloro i quali hanno lasciato l’Italia negli anni precedenti, gli<br />
emigrati nel ventennio successivo alla fine della seconda guerra mon<strong>di</strong>ale portassero con loro<br />
una fiducia particolarmente forte verso lo strumento “istruzione” come mezzo <strong>di</strong> mobilità<br />
sociale. Date le spesso scarse possibilità <strong>di</strong> ascesa personale, il genitore immigrato, credendo<br />
nelle possibilità offerte dall’istruzione, sarebbe stato fortemente propenso a favorire l’istruzione<br />
dei figli, per permetter loro le migliori possibilità <strong>di</strong> ascesa sociale. Questo potrebbe aver spinto<br />
verso l’alto l’istruzione <strong>delle</strong> <strong>seconde</strong> <strong>generazioni</strong> <strong>di</strong> italiani negli altri paesi. Dunque, se per i<br />
genitori italiani emigrati all’estero nel secondo dopoguerra, la scolarità dei figli sembra essere<br />
l’investimento prioritario al quale destinare le risorse familiari (Cesari Lusso, 1997), per gli<br />
emigrati <strong>di</strong> più antica data, potrebbe aver influito la mancanza <strong>di</strong> conoscenza del ventaglio <strong>delle</strong><br />
possibilità esistenti date dall’istruzione e <strong>delle</strong> possibilità che questa offre in campo lavorativo e<br />
come mezzo <strong>di</strong> affermazione sociale. Non è <strong>di</strong>fficile immaginare una situazione del genere se si<br />
pensa che gli italiani emigrati all’estero prima degli anni ’50 hanno lasciato un paese con un<br />
livello <strong>di</strong> alfabetizzazione tra i più bassi in Europa.<br />
Riferimenti bibliografici<br />
Barbagli M., 1974, Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia , Bologna: Il<br />
Mulino.<br />
Cesari Lusso V., 1997, Quando la sfida viene chiamata integrazione. Percorsi <strong>di</strong><br />
socializzazione e <strong>di</strong> personalizzazione <strong>di</strong> giovani "figli <strong>di</strong> emigrati", Roma, NIS.<br />
Dei M., 1993 Cambiamento senza riforma: la scuola secondaria superiore negli ultimi<br />
trent’anni, in Soldani S. e Turi G. (a cura <strong>di</strong>), Fare gli italiani, Bologna, Il Mulino.<br />
Portes A. e MacLeod, 1996, Educational progress of children of immigrants: the role of class,<br />
ethnicity and school context, Sociology of education, 69(Ottobre): 255-75<br />
166
167
168
169<br />
RINGRAZIAMENTI<br />
Precisando che mi ritengo l’unico responsabile <strong>delle</strong> eventuali lacune ed errori <strong>di</strong> questo lavoro,<br />
vorrei ringraziare i miei supervisori per il fondamentale contributo che hanno fornito. Un grazie<br />
a Gianpiero Dalla Zuanna, per aver suggerito l’argomento della ricerca, per avermi spinto con<br />
grande entusiasmo in un nuovo ambito, per aver appoggiato il mio lavoro in ogni sua fase e per<br />
avermi fortemente aiutato a impostare e sviluppare il capitolo quinto; ad Antonio Golini per<br />
aver sostenuto e avvalorato dall’alto della sua esperienza il progetto e le idee presentate; a<br />
Rosella Rettaroli per l’irrinunciabile sostegno che mi ha fornito negli ultimi anni, per avermi<br />
incoraggiato a intraprendere la strada della ricerca, per il continuo e fondamentale scambio <strong>di</strong><br />
idee e opinioni e per avermi aiutato a reperire i dati australiani; a Laurent Toulemon il quale,<br />
oltre all’accesso ai dati francesi, mi ha concesso la possibilità <strong>di</strong> trascorrere alcuni mesi<br />
all’INED <strong>di</strong> Parigi, durante il quale ho sviluppato una parte fondamentale della tesi<br />
avvalendomi del suo quoti<strong>di</strong>ano supporto e interessamento.<br />
Vorrei ringraziare anche Francesco Billari per avermi aiutato nel prendere contatti con<br />
l’INED e tutte le persone che mi hanno concesso <strong>di</strong> soggiornare a Parigi partecipando al<br />
programma Research Training Network (RTN) nell’ambito Demographic Sustainability and<br />
European Integration (DEMOG), a partire dall’allora coor<strong>di</strong>natore Heiner Maier.<br />
Sono riconoscente verso il Dipartimento <strong>di</strong> Scienze Demografiche <strong>di</strong> Roma e in particolare<br />
verso il suo <strong>di</strong>rettore Graziella Caselli e il coor<strong>di</strong>natore del dottorato <strong>di</strong> ricerca Marcello Natale<br />
che, nell’arco <strong>di</strong> oltre tre anni mi hanno permesso <strong>di</strong> compiere importanti passi nel mondo della<br />
ricerca, <strong>di</strong> seguire il mio percorso professionale in totale autonomia e <strong>di</strong> perfezionare la mia<br />
formazione al Max Planck Institute for Demographic Research <strong>di</strong> Rostock.<br />
Un grazie anche a Stefano Molina per i preziosi consigli e per il grande interesse che ha<br />
mostrato verso la mia ricerca.<br />
E grazie a chi mi è stato più vicino negli ultimi anni, ai miei genitori che tanto hanno fatto<br />
affinché io potessi realizzare i miei desideri, ad Angela Romano che ha sempre caldeggiato e<br />
incoraggiato le mie scelte professionali anche a costo della lontananza, ad Alessio Cangiano,<br />
collega e amico insostituibile con il quale ho con<strong>di</strong>viso l’esperienza romana e parigina.<br />
Roberto Impicciatore
170