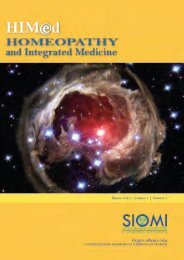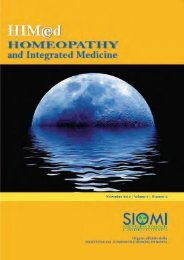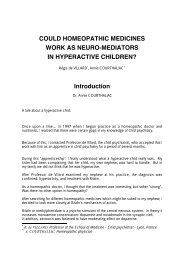HIMed - Anno 3, numero 1 - Maggio 2012 - SIOMI
HIMed - Anno 3, numero 1 - Maggio 2012 - SIOMI
HIMed - Anno 3, numero 1 - Maggio 2012 - SIOMI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CONTRIBUTI ORIGINALI<br />
Tutte le cellule dell’organismo possono subire lesioni radioindotte,<br />
ma esiste una scala di sensibilità relativa (specie<br />
per i danni acuti) per le differenti tipologie cellulari.<br />
Di seguito riportiamo in ordine di sensibilità decrescente<br />
i vari gruppi cellulari: a) spermatogoni; b) linfociti, eritroblasti,<br />
granulociti, mieloblasti; c) cellule basali e cripte<br />
intestinali, stomaco, colon; d) cellule ovariche, cutanee,<br />
delle ghiandole, alveolari polmonari, dotti biliari; e) cellule<br />
endoteliali; f) cellule connettivali; g) cellule tubulari<br />
renali; h) cellule ossee; i) cellule nervose; l) cellule muscolari.<br />
Esistono poi per ogni citologia effetti graduati di entità<br />
crescente all’aumentare della dose radiante, che può essere<br />
in unica dose o frazionata nel tempo. La patogenesi<br />
comune a tutte le lesioni da raggi è stata dimostrata essere<br />
il danno vascolare 4, 7, 8 .<br />
Effetti graduati<br />
delle radiazioni ionizzanti sulla cute<br />
La cute è il tessuto che rientra più frequentemente nel<br />
campo d’irradiazione della radioterapia (ad eccezione<br />
delle forme di brachiterapia), ed è coinvolta sempre, qualunqe<br />
sia l’organo da trattare. E’ pertanto importante valutarne<br />
specificatamente gli effetti lesivi. L’epidermide è<br />
un tessuto particolarmente radiosensibile, riparabile e<br />
non subisce un effetto cumulativo dell’esposizione a radiazioni.<br />
Il derma e l’ipoderma, invece, sono strutture a<br />
rinnovamento lento, sono relativamente più radioresistenti,<br />
hanno meno possibilità di riparazione e subiscono<br />
l’effetto cumulativo dell’irradiazione.<br />
Lesioni cutanee precoci di un’irradiazione cutanea focale<br />
sono rappresentati da: a) eritema, edema e vasodilatazione<br />
per una dose di 5 Gy; b) epidermide secca, seguita<br />
da depilazione, desquamazione per almeno due settimane,<br />
per una dose di 10 Gy; c) radiodermite essudativa<br />
con flittene per una dose di 15 Gy gg; d) radiodermite<br />
acuta con necrosi per una dose di 2-30 Gy.<br />
Lesioni cutanee tardive, determinate da sequele riparative,<br />
si osservano per dosi superiori ai 10 Gy. Al di sotto<br />
di tale esposizione la guarigione è usualmente senza sequele.<br />
Oltre tale esposizione, invece, si hanno alterazioni<br />
minime quali alterazioni della pigmentazione. In un<br />
tempo variabile da 1 a 5 anni si osservano quadri di dermite<br />
cronica, che si manifesta con atrofia cutanea, secchezza,<br />
alterazioni delle unghie, teleangectasie, fibrosi e<br />
cheratosi.<br />
Gli effetti acuti della radioterapia su cute e mucose consistono<br />
quindi, usualmente, in una risposta infiammatoria:<br />
a) eritema; b) edema; c) pigmentazione; d)<br />
mucositi. Queste reazioni più frequentemente si osservano<br />
nei caso di radioterapie palliative, perché richiedono<br />
elevati dosi giornaliere ravvicinate nel tempo, una<br />
o due settimane. Le radiolesioni cutanee presentano,<br />
come alterazione anatomo-patologica caratteristica, le alterazioni<br />
vasali: vasodilatazione, alterata permeabilità endoteliale,<br />
riduzione del letto e del flusso capillare.<br />
Si tratta di fenomeni patologici locali che possono persistere<br />
anche a lungo, come stanno a dimostrare la lenta<br />
regressione del danno e talvolta la loro non completa<br />
scomparsa, oltre alla possibile insorgenza e persistenza di<br />
teleangectasie.<br />
HOMEOPATHY AND INTEGRATED MEDICINE | maggio <strong>2012</strong> | vol. 3 | n. 1<br />
La radiodermite eritematosa è caratterizzata dalla comparsa<br />
di chiazze eritematose con tendenza alla confluenza,<br />
fino ad invadere tutto il campo cutaneo<br />
irradiato. La cute è arrossata, edematosa, spesso pruriginosa.<br />
Successivamente il colorito si fa più intenso, rosso<br />
rame, l’edema si attenua; a distanza si osserva caduta di<br />
annessi e desquamazione dell’epidermide, residuando<br />
una pigmentazione cutanea variabile. Talvolta l’edema<br />
può coinvolgere il connettivo pervasale del derma.<br />
La radiodermite eritemato-bollosa viene distinta istologicamente<br />
dal quadro di eritema per la scomparsa quasi<br />
totale, per citolisi, degli elementi dello strato germinativo<br />
basale dell’epidermide, già pochi giorni dopo l’irradiazione.<br />
La formazione delle bolle è correlata alla comparsa<br />
di versamento sieroso che si forma tra derma ed epidermide<br />
nella stessa sede occupata dallo strato germinativo<br />
distrutto. La cute alla periferia della lesione si pigmenta<br />
intensamente, formando un alone scuro che contrasta<br />
con la cute sana circostante. La rigenerazione spontanea<br />
dell’epidermide, data la scomparsa dello strato germinativo<br />
basale, usualmente avviene per proliferazione dei<br />
bordi della lesione ed impiega parecchi giorni (anche 20<br />
giorni e più) seguendo i principi di rigenerazione cutanea<br />
per seconda intenzione descritti per la prima volta nella<br />
metà dell’800 da Ranvier. In entrambi i casi l’eritema è<br />
sostenuto dalla vasodilatazione.<br />
La dermite cronica è caratterizzata da comparsa di ispessimento<br />
ed indurimento cutaneo, iperpigmentazione, caduta<br />
degli annessi, atrofia del connettivo, con sclerosi.<br />
Perché ciò si verifichi sono necessari almeno tre eventi<br />
contemporanei: l’ipovascolarizzazione (per danno subito<br />
dai vasi arteriosi), l’ipossia tessutale (cioè l’assenza di ossigeno),<br />
l’ipocellularità (per la morte cellulare). In queste<br />
situazioni il rischio di complicanze, quali ulcere, fistole,<br />
infezioni croniche specie ad opera di staphilococcus 4,5 è<br />
abbastanza frequente.<br />
Campi elettromagnetici e terapia<br />
Gli atomi, come sappiamo, sono formati da nuclei e da<br />
nubi elettroniche; nei nuclei si trovano i protoni, particelle<br />
dotate di carica elettrica positiva. Essi ruotano attorno<br />
al loro asse. La carica elettrica connessa al protone<br />
quindi gira insieme ad esso. Una carica elettrica in movimento<br />
crea una corrente elettrica e una corrente elettrica<br />
crea un campo magnetico. Da un punto di vista<br />
fisico, le diverse cellule dell’organismo caratterizzate da<br />
una forma differente a seconda del tessuto biologico al<br />
quale appartengono, possono essere considerate dei dipoli<br />
elettromagnetici. Tale diversità di forma provoca una<br />
differenza della polarità di membrana a cui consegue una<br />
differenza della corrente endogena che le attraversa,<br />
quindi una differente densità del campo magnetico che<br />
è ad esse associato. Il campo magnetico cellulare è, dunque,<br />
strettamente legato alla massa-forma della cellula in<br />
esame.<br />
Un esempio pratico è rappresentato dalla Risonanza Magnetica<br />
Nucleare che riesce a creare immagini dei tessuti<br />
in esame discriminando il diverso campo magnetico endogeno<br />
della cellula stessa, sfruttando un campo magnetico<br />
statico e la contemporanea presenza di impulsi di<br />
radiofrequenza non costanti 9 .<br />
13