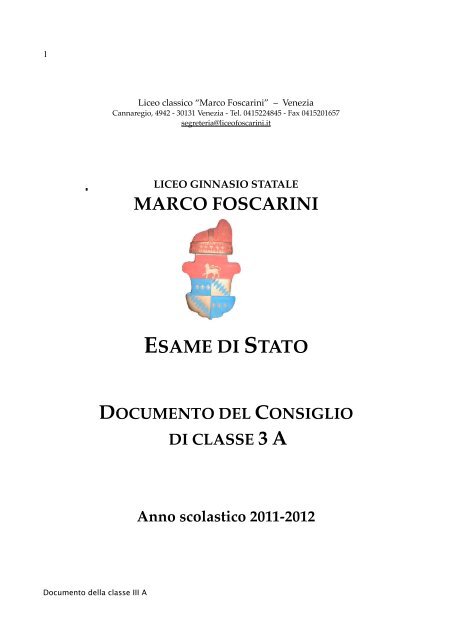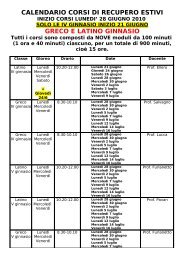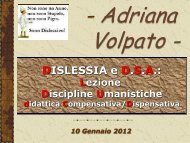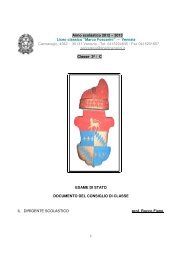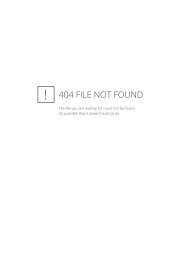3A - Liceo Foscarini
3A - Liceo Foscarini
3A - Liceo Foscarini
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1<br />
Documento della classe III A<br />
<strong>Liceo</strong> classico “Marco <strong>Foscarini</strong>” – Venezia<br />
Cannaregio, 4942 - 30131 Venezia - Tel. 0415224845 - Fax 0415201657<br />
segreteria@liceofoscarini.it<br />
LICEO GINNASIO STATALE<br />
MARCO FOSCARINI<br />
ESAME DI STATO<br />
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO<br />
DI CLASSE 3 A<br />
Anno scolastico 2011-2012
2<br />
INDICE<br />
Parte prima- L’istituto e la classe <strong>3A</strong><br />
Presentazione dell’Istituto! ! ! ! ! ! ! 3<br />
Presentazione della classe <strong>3A</strong>! ! ! ! ! ! 5<br />
Il percorso formativo 9<br />
Obiettivi! ! ! ! ! ! ! ! 10<br />
Griglie di valutazione 11<br />
Generale! ! ! ! ! ! ! 11<br />
Prima prova scritta! ! ! ! ! ! 12<br />
Seconda prova scritta! ! ! ! ! ! 13<br />
Terza prova scritta! ! ! ! ! ! 14<br />
Attività di informazione e preparazione all’esame ! ! ! 15<br />
! ! ! ! ! ! ! ! !<br />
Parte seconda – Relazioni disciplinari<br />
Italiano ! 18!! !<br />
Latino 25<br />
Greco!! ! ! ! ! ! ! ! 28<br />
Storia! ! ! ! ! ! ! 32!! !<br />
Filosofia! ! ! ! ! ! ! ! 35!!<br />
Inglese! ! ! ! ! ! ! ! 40!<br />
Matematica! ! ! ! ! ! ! ! 43<br />
Fisica 44<br />
Scienze 45<br />
Arte 48<br />
Educazione fisica! ! ! ! ! ! ! 50<br />
Religione 52<br />
Allegato – Esercitazioni di terza prova! ! ! ! 55!<br />
Documento della classe III A
3<br />
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO<br />
Il <strong>Liceo</strong> Ginnasio statale “Marco <strong>Foscarini</strong>” è una delle più antiche istituzioni scolastiche<br />
pubbliche di tutta Italia. La sua origine risale infatti al 1807, per iniziativa napoleonica.<br />
Inizialmente funzionante nelle tre classi liceali, ma dotato di convitto per alloggiare gli<br />
studenti, fu arricchito nel 1851 dei corsi ginnasiali. Subito dopo l’annessione del Veneto al<br />
Regno d’Italia, nel 1867, assunse l’attuale denominazione (precedentemente si chiamava<br />
semplicemente <strong>Liceo</strong> di Santa Caterina, dal nome dell’ex-convento in cui è tuttora<br />
ospitato). Dalla fondazione a oggi ha sempre funzionato ininterrottamente, con una<br />
dimensione variabile fra le due e tre sezioni, che recentemente sono divenute quattro. Nel<br />
1995 il <strong>Liceo</strong> è stato annesso all’omonimo Convitto Nazionale (le due realtà erano state<br />
separate dall’amministrazione austriaca nel 1850), recuperando così l’assetto originario. Al<br />
giorno d’oggi il “<strong>Foscarini</strong>” costituisce pertanto uno dei rari esempi italiani di struttura<br />
scolastica estesa su tutti i tre diversi livelli d’istruzione, riunendo scuola primaria,<br />
secondaria di I grado e liceo.<br />
! Il “<strong>Foscarini</strong>” ha conservato le caratteristiche tradizionali del piano di studi proprio<br />
del liceo classico, ritenuto un valido strumento sia per la preparazione degli studenti<br />
destinati alla prosecuzione degli studi universitari, sia per la possibilità offerta ai suoi<br />
allievi di elaborare una equilibrata cultura personale, tale da consentire non solo la<br />
conoscenza del passato, ma anche un accostamento critico alla complessità del presente.<br />
! Naturalmente l’impianto del liceo classico, nella sua conformazione gentiliana,<br />
privilegia i saperi umanistici, a cui viene riservata la consueta cura nell’insegnamento. Una<br />
sottolineatura particolare, all’interno di questo impianto, è stata conferita allo strumento<br />
linguistico, privilegiato non solo come fondamento della comunicazione umana, ma<br />
ritenuto anche e soprattutto strumento di analisi, dominio e organizzazione del pensiero<br />
nei vari ambiti della comunicazione umana. La consapevolezza di ciò ha indotto il nostro<br />
liceo non solo a estendere, già da parecchi anni, lo studio della lingua straniera anche al<br />
triennio (seguendo un indirizzo che ormai caratterizza la grande maggioranza dei licei<br />
classici), ma anche a introdurre il supporto del lettore di lingua inglese al triennio e a<br />
svolgere attività di preparazione degli studenti agli esami di certificazione, sempre di<br />
lingua inglese. Oltre a ciò, sono presenti diversi corsi extracurricolari di lingua straniera.<br />
Quella linguistica, d’altra parte, non è l’unica sperimentazione che caratterizza la nostra<br />
scuola. Tutto l’insegnamento della matematica viene infatti impartito secondo i<br />
programmi e il monte-ore previsti dal Piano Nazionale Informatica per i licei classici, e si<br />
Documento della classe III A
4<br />
affianca una terza sperimentazione, consistente nell’estensione a tutto il corso di studi e<br />
nel potenziamento dell’insegnamento di storia dell’arte.<br />
! Peculiarità del “<strong>Foscarini</strong>”, peraltro, è sempre stata, fin dalla sua fondazione, una<br />
particolare attenzione agli insegnamenti dell’area scientifica, proposti innanzitutto nella<br />
loro valenza culturale e formativa. Se la storia dell’istituto è stata contrassegnata dalla<br />
presenza di insegnanti di notevole spessore, anche negli anni più recenti motivo di<br />
notevole soddisfazione è stato dato dai buoni, spesso ottimi risultati che i nostri studenti<br />
hanno conseguito nei loro studi presso facoltà scientifiche<br />
! Se fino a qualche anno fa l’utenza del liceo proveniva quasi interamente dal centro<br />
storico veneziano e dal Lido, nel corso degli ultimi anni il bacino della scuola si è<br />
decisamente allargato, con un consistente e crescente numero di studenti di Mestre e della<br />
terraferma veneziana, alcuni dei quali risiedono anche in comuni non collocati<br />
nell’immediata cintura della conurbazione mestrina, ma a una certa distanza da essa e<br />
compiono quindi un percorso casa-scuola non breve. La crescita degli iscritti non residenti<br />
nell’ambito strettamente lagunare testimonia lo sforzo che la nostra scuola effettua per<br />
garantire una offerta formativa di qualità e attenta alle esigenze dell’utenza. Bisogna<br />
comunque sottolineare, in generale, che, trattandosi di un liceo classico di tradizione, la<br />
composizione degli iscritti inevitabilmente riflette in una certa misura un processo di<br />
selezione, o meglio autoselezione, verificatosi a monte, dato che quasi sempre gli studenti<br />
che scelgono la nostra scuola sono fortemente motivati da un percorso scolastico che ha<br />
già dato buoni risultati. Spesso, inoltre, nella scelta dell’istituto giocano tradizioni<br />
familiari. Anche questo dà ragione della buona stabilità del corpo studentesco, in cui il<br />
numero di insuccessi e abbandoni risulta decisamente limitato.<br />
! L’offerta formativa del “<strong>Foscarini</strong>” si completa con la proposizione agli studenti di<br />
una serie di attività extrascolastiche nei settori sportivo e culturale. Come già accennato,<br />
assai significativa è la consolidata presenza di corsi di lingua straniera diversa da quella<br />
presente nel curricolo, in orario pomeridiano e a cura di insegnanti madrelingua (sono<br />
attivati i corsi di francese, spagnolo, tedesco, cinese, neogreco), così come la notevole<br />
presenza di corsi e attività sportive, sia a livello di avviamento alla pratica sportiva, sia di<br />
natura agonistica. Assolutamente degne di menzione, fra l’altro, l’attività scacchistica del<br />
<strong>Liceo</strong>, di assoluto rilievo fra le scuole a livello regionale e nazionale, e quella teatrale,<br />
ripetutamente premiata a diversi livelli. Naturalmente a tutto questo si affianca la regolare<br />
organizzazione di viaggi d’istruzione e visite guidate, a cui ultimamente si sono aggiunti<br />
rapporti di collaborazione e scambio culturale con realtà scolastiche europee ed<br />
extraeuropee (Russia, Cina, Australia, India fra l’altro).<br />
Da quest'anno scolastico tre sezioni del <strong>Liceo</strong> Classico Europeo si affiancano alle<br />
sezioni di <strong>Liceo</strong> Classico curricolari.<br />
Documento della classe III A
5<br />
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE<br />
Elenco degli alunni<br />
1 Flavia Allegretto!<br />
2 Alberta Benedetti!<br />
3 Gaia Bernardinello !<br />
4 Eleonora Di Cataldo!<br />
5 Camilla Ferrari!<br />
6 Jacopo Ferrari<br />
7 Francesca Franzoi!<br />
8 Alice Fuin!<br />
9 Alessandro Gasparotti!<br />
10 Matteo La Torre<br />
11 Giulia Lodi!<br />
12 Anna Mariani<br />
13 Fosca Parisi!<br />
14 Lorenzo Pasqualetto<br />
15 Pierandrea Ravanello!<br />
16 Anna Ruggieri!<br />
17 Matteo Scarpa<br />
18 Federico Toppan!<br />
19 Giulia Tricoli<br />
20 Rebecca Vitale<br />
21 Luca Voltolina<br />
Studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: 10.<br />
Documento della classe III A
6<br />
Elenco dei docenti<br />
Antonella ANTONELLI! ! inglese<br />
Emanuela CRISPILLI! ! greco!<br />
Susanna FORT! ! ! storia e filosofia<br />
Gilberto GHERARDI ! storia dell’arte<br />
Roberto MAGNI !! religione<br />
Michela MAZZONI ! italiano e latino<br />
Simone MORANDINI ! matematica e fisica<br />
Savatore RICCIARDI! ! educazione fisica<br />
Caterina ROSSI! ! ! scienze<br />
Docenti commissari interni<br />
Il Consiglio di classe ha designato i seguenti docenti commissari d’esame:<br />
Antonella ANTONELLI! ! inglese<br />
Emanuela CRISPILLI ! ! ! greco!<br />
Gilberto GHERARDI! ! ! storia dell'arte<br />
Il coordinatore di classe è la prof.ssa Michela MAZZONI.<br />
Storia della classe<br />
Variazioni nel Consiglio di classe nel corso del triennio<br />
MATERIE<br />
CURRICOLO<br />
ANNI CORSO CLASSE I CLASSE II CLASSE III<br />
ITALIANO I – II – III BOLZAN/ ASSANTE/ MAZZONI*<br />
MORIELLO* MAZZONI*<br />
LATINO I – II – III BOLZAN* PIANTINI* MAZZONI*<br />
GRECO I – II – III BOLZAN* CRISPILLI* CRISPILLI*<br />
STORIA I - II – III FORT FORT FORT<br />
FILOSOFIA I – II – III FORT FORT FORT<br />
MATEMATICA I – II – III MORANDINI MORANDINI MORANDINI<br />
FISICA II – III -------------<br />
---------<br />
MORANDINI MORANDINI<br />
SCIENZE I – II – III ROSSI ROSSI ROSSI<br />
INGLESE I – II – III ANTONELLI ANTONELLI ANTONELLI<br />
ARTE I – II – III GHERARDI GHERARDI GHERARDI<br />
Documento della classe III A
7<br />
ED. FISICA I – II – III TREVISAN GALVAN CECCHI/RICCIARDI<br />
RELIGIONE I – II - III MAGNI MAGNI MAGNI<br />
*l’asterisco sta ad evidenziare le materie in cui la classe ha avuto una certa discontinuità<br />
didattica durante il triennio (soprattutto il latino).<br />
Flussi degli studenti della classe<br />
CLASSE ISCRITTI<br />
DALLA<br />
STESSA<br />
CLASSE<br />
ISCRITTI DA<br />
ALTRA<br />
CLASSE<br />
PROMOSSI<br />
SENZA<br />
DEBITI<br />
PROMOSSI<br />
CON DEBITO/<br />
SOSPENSIONE<br />
NON<br />
PROMOSSI<br />
PRIMA 22* 0 17 2 2<br />
SECONDA 19 2 15 6<br />
TERZA 21 0<br />
*Un alunno nei primi giorni di lezione del I <strong>Liceo</strong> si è trasferito presso un altro Istituto<br />
Presentazione sintetica della classe<br />
La classe è costituita da 21 alunni. La composizione della classe, come si può evincere<br />
dalle tabelle sopraindicate, ha subito alcune variazioni durante gli anni del triennio: un<br />
alunno all’inizio del I <strong>Liceo</strong> si è trasferito presso un altro Istituto, mentre due alunni al<br />
termine del I <strong>Liceo</strong> non sono stati promossi alla classe successiva; infine due alunne<br />
all’inizio del II <strong>Liceo</strong> si sono iscritte alla classe dopo essersi trasferite da un altro Istituto.<br />
La classe è composta in prevalenza da alunni vivaci, caratterizzati da molteplici curiosità<br />
nelle varie discipline e ha spesso offerto spunti che hanno reso le lezioni approfondite e<br />
proficue, specie quando l’argomento riusciva a coinvolgere tutti. La classe ha raggiunto<br />
livelli differenziati che si possono così riassumere : oltre la metà degli alunni ha<br />
dimostrato di possedere buone capacità logiche di sintesi ed analisi ed ha sempre seguito<br />
con attenzione, serietà ed impegno l’attività didattica, dimostrando continuità<br />
nell’applicazione e riportando risultati buoni con punte di eccellenza; il comportamento è<br />
stato serio e corretto e sono stati puntuali nel rispetto delle scadenze. L’altra parte della<br />
classe, pur dimostrando la stessa serietà per quanto riguarda il comportamento in classe,<br />
la correttezza ed il rispetto delle scadenze, ha presentato alcune discontinuità nel metodo<br />
di lavoro, nelle capacità rielaborative ed espressive nelle varie discipline. Solo per un<br />
limitato numero di studenti si rileva una certa selettività nell’impegno che li porta ad<br />
avere risultati meno soddisfacenti in alcune discipline.Nel complesso il rapporto<br />
Documento della classe III A
8<br />
relazionale che si è stabilito tra docenti e alunni ed il clima relazionale tra gli alunni stessi<br />
possono considerarsi più che buoni.<br />
Attività curricolari ed extracurricolari dell’a.s. 2011-2012<br />
Nell’ambito del progetto di Istituto, la classe ha partecipato alle seguenti attività:<br />
· Lezione-conferenza del Prof. Carlo Franco sul tema “gli effetti dei terremoti descritti<br />
nelle orazioni di Elio Aristide e la ricostruzione di una grande città”<br />
· Due incontri-dibattito con il Prof. Vincenzo Balzani e con il Prof. Arturo Lorenzoni sul<br />
tema delle energie rinnovabili<br />
· Itinerario educativo “Venezia tra '800 e '900”<br />
· Incontro organizzato dall’Associazione Amici del <strong>Foscarini</strong> di orientamento in visione<br />
degli studi universitari e di informazione sui vari ambiti professionali (professioni<br />
mediche, ingegneristiche, giuridiche, economiche, di architettura).<br />
· Visione della tragedia “Le troiane” di Euripide presso le Carceri femminili di Venezia<br />
· Lettorato con insegnante madrelingua inglese<br />
· Visione della rappresentazione teatrale in lingua inglese “L’importanza di chiamarsi<br />
Ernesto” di Oscar Wilde.<br />
· Visione della mostra di Sorolla a Ferrara accompagnati dal Prof. Gherardi<br />
Alcuni studenti hanno partecipato con successo alle seguenti attività:<br />
· corsi di seconda lingua straniera<br />
· esami per le certificazioni FCE e CAE (inglese)<br />
· attività sportive extracurricolari e gare interistituti (pallavolo, basket, atletica leggera,<br />
calcio maschile e femminile, sci e arrampicata sportiva)<br />
· Conferenze scientifiche in orario extra-scolastico presso l’Istituto Veneto di Scienze,<br />
Lettere ed Arti di Venezia<br />
· attività teatrali (di pratica teatrale)<br />
· alcuni studenti hanno frequentato un corso curato dalla Prof.ssa Rossi sugli Alphatest<br />
in preparazione agli esami di ammissione alle facoltà universitarie<br />
. Due studenti hanno partecipato al corso di astronomia “Il cielo in laboratorio” presso<br />
il liceo scientifico G.B. Benedetti e uno dei due è stato selezionato per un’attività di stage<br />
all’Osservatorio Astronomico di Asiago.<br />
Attività di orientamento<br />
La classe è stata interessata da un’opera di informazione sull’offerta universitaria,<br />
organizzata dalla scuola in collaborazione con diversi soggetti istituzionali.<br />
Documento della classe III A
9<br />
Gli studenti della classe hanno inoltre partecipato individualmente, ciascuno secondo i<br />
propri interessi, a visite di orientamento presso vari atenei.<br />
PERCORSO FORMATIVO<br />
Obiettivi generali trasversali<br />
! Alla luce delle finalità proprie del liceo classico, della tradizione di questo istituto e<br />
di quanto individuato dal Piano dell’Offerta Formativa, nel corso del triennio gli<br />
insegnanti del Consiglio di classe hanno fatto propri i seguenti obiettivi generali:<br />
Acquisizione di un metodo di studio;<br />
! ! di un metodo di ricerca;<br />
! ! di capacità critiche;<br />
! ! di capacità di autonoma progettazione dello studio;<br />
! ! di informazioni organicamente inquadrate in discipline;<br />
! ! di capacità argomentative interdisciplinari;<br />
di capacità di dialogo, di ascolto e di risposta coerente e motivata nell’ambito<br />
delle discipline di studio, affini o estranee al curricolo;<br />
! ! di capacità di esposizione argomentata per scritto.<br />
Obiettivi per l’area linguistico-umanistica<br />
! I docenti dell’area linguistico-umanistica hanno riconosciuto comunanza di intenti<br />
sui seguenti obiettivi relativi all’acquisizione di conoscenze, competenze e capacità:<br />
·CONOSCENZE! ! ! Conoscere le strutture e le funzioni della lingua;<br />
Conoscere i registri linguistici;<br />
Conoscere le strategie comunicative di testi in prosa e di<br />
poesia;<br />
Conoscere le strategie di elaborazione scritta.<br />
·COMPETENZE! ! ! Saper attuare un’analisi linguistica in termini di<br />
morfologia e sintassi;<br />
Saper attuare confronti tra lessici diversi;<br />
Saper identificare e sequenzializzare concetti comunicati.<br />
·CAPACITA’! ! ! Saper attuare un’analisi argomentata di un testo sia<br />
letterario sia non letterario;<br />
Saper produrre una sintesi scritta e orale;<br />
Saper riconoscere i nuclei concettuali di un testo scritto;<br />
Saper attuare un confronto tra contenuti e strutture;<br />
Documento della classe III A
10<br />
Saper elaborare contenuti e idee personali;<br />
Saper studiare autonomamente;<br />
Saper attuare un’autovalutazione.<br />
Obiettivi per l’area scientifica<br />
I docenti dell’area scientifica hanno riconosciuto comunanza di intenti sui seguenti<br />
obiettivi:<br />
·Contribuire all’educazione al pensiero razionale nella sua forma consequenziale e<br />
logico-deduttiva;<br />
·Acquisire le nozioni e i concetti di base delle discipline;<br />
·Acquisire i linguaggi propri delle discipline;<br />
·Acquisire la capacità di attuare una corretta relazione tra dimensione sperimentale,<br />
comprensione teorica ed espressione matematica;<br />
·Acquisire la capacità di applicare i metodi propri delle discipline anche a problemi<br />
esterni a esse;<br />
·Acquisire la capacità di cogliere i collegamenti con altre discipline.<br />
Metodi, mezzi, spazi e tempi<br />
Si rimanda alle diverse schede disciplinari per la precisa indicazione di questi<br />
elementi. In generale si può indicare nella lezione frontale lo strumento didattico più<br />
largamente praticato, senza dimenticare peraltro che la classe ha potuto usufruire<br />
regolarmente degli spazi e dei mezzi presenti nell’istituto, come il laboratorio di<br />
informatica, quelli di scienze e di fisica, gli strumenti multimediali. In particolare,<br />
peculiarità dell’istituto è il normale utilizzo dell’aula multimediale per l’insegnamento di<br />
arte.<br />
Griglia di valutazione generale<br />
! Il Collegio dei docenti ha adottato la seguente griglia di valutazione generale per<br />
l’istituto, a cui il Consiglio di classe si è attenuto.<br />
GIUDIZIO VOT<br />
O<br />
Prova nulla 1~2<br />
Documento della classe III A<br />
MOTIVAZIONE<br />
Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione
11<br />
Molto<br />
negativo<br />
Gravemente<br />
insufficiente<br />
3<br />
4<br />
Insufficiente 5<br />
Sufficiente 6<br />
Discreto 7<br />
Buono/<br />
ottimo<br />
8~9<br />
Eccellente 10<br />
L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa<br />
usare in maniera integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi<br />
saperi pregressi con le nuove conoscenze.<br />
L'allievo svolge le attività di apprendimento in maniera frazionata,<br />
mostrando di possedere conoscenze frammentarie e superficiali e di<br />
saper fare in modo impreciso e approssimato. Ha una forte difficoltà di<br />
organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici.<br />
L'allievo è impreciso rispetto a quanto sa e sa fare, necessita di<br />
sollecitazioni e di indicazioni dell'insegnante per perseguire l'obiettivo di<br />
apprendimento, non è capace di ricostruire l'intero percorso seguito, ma<br />
solo parte di esso. Comunica i risultati dell'apprendimento con limitata<br />
puntualità e poca proprietà lessicale.<br />
L'allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere<br />
l'obiettivo. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce situazioni che<br />
già conosce, necessita di indicazioni per affrontare situazioni<br />
parzialmente variate. Comunica i risultati dell'apprendimento in modo<br />
semplice, con un linguaggio corretto e comprensibile.<br />
L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in<br />
modo adeguato allorché affronta situazioni d'apprendimento simili tra<br />
loro o solo parzialmente variate; è capace di spiegare e rivedere il proprio<br />
percorso d'apprendimento, comunicandone i risultati con un linguaggio<br />
specifico e corretto. Procede con sufficiente autonomia<br />
nell'organizzazione dello studio.<br />
L'allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali<br />
affronta variamente situazioni nuove, procede con autonomia; è capace di<br />
spiegare con un linguaggio specifico e appropriato processo e prodotto<br />
dell'apprendimento e di prefigurarne l'utilizzazione in altre situazioni<br />
formative.<br />
L'allievo sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e perché<br />
ha scelto un determinato percorso, perciò verifica e valuta anche il<br />
proprio operato. Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto<br />
ha appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente per<br />
raggiungere nuove mete formative.<br />
Griglia di valutazione della prima prova scritta<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA<br />
La griglia, collaudata e utilizzata negli ultimi sette anni da tutti gli insegnanti di Italiano del Triennio, ha subito<br />
fin dall’inizio del presente a.s. una modifica nella modalità del calcolo del punteggio. Per evitare la presenza di<br />
numeri decimali (1,5; 2,5 ecc.) ogni descrittore prevede l’assegnazione di un punteggio da 1 a 15; il totale va poi<br />
diviso per 5.<br />
Saggio breve/ Articolo (valutazione in quindicesimi)<br />
Documento della classe III A
12<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA<br />
La griglia, collaudata e utilizzata negli ultimi sette anni da tutti gli insegnanti di Italiano del Triennio, ha subito<br />
fin dall’inizio del presente a.s. una modifica nella modalità del calcolo del punteggio. Per evitare la presenza di<br />
numeri decimali (1,5; 2,5 ecc.) ogni descrittore prevede l’assegnazione di un punteggio da 1 a 15; il totale va poi<br />
diviso per 5.<br />
Saggio breve/ Articolo (valutazione in quindicesimi)<br />
A Aderenza al tema,<br />
utilizzo delle fonti rispetto alla<br />
comprensione, selezione, interpretazione<br />
(competenze rispetto al genere testuale)<br />
B Organicità, coerenza e completezza della<br />
trattazione<br />
(capacità espressive e logico-<br />
argomentative)<br />
C Correttezza formale (orto-morfo-sintattica)<br />
(competenze linguistiche)<br />
D Rispetto dei vincoli comunicativi:<br />
destinatario, scopo, collocazione editoriale,<br />
misura, titolo; proprietà nell’uso del lessico<br />
anche specialistico. (competenze rispetto al<br />
genere testuale)<br />
Sviluppo critico, rielaborazione personale.<br />
E Integrazione dei dati forniti con<br />
informazioni congruenti. (capacità critiche<br />
e conoscenze disciplinari)<br />
Scarsa<br />
1-4<br />
Scarsa<br />
1-4<br />
Scarsa<br />
1-4<br />
Scarso<br />
1-4<br />
Scarso<br />
1-4<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Analisi del testo / tema (valutazione in quindicesimi)<br />
A Aderenza al tema, Conoscenza<br />
dell’argomento e del quadro di riferimento,<br />
della natura del testo eventualmente proposto<br />
B<br />
e delle sue strutture formali<br />
Scarsa<br />
1-4<br />
Organicità, coerenza e completezza della<br />
trattazione Scarsa<br />
1-4<br />
Correttezza formale (orto-morfo-sintattica)<br />
C<br />
Scarsa<br />
1-4<br />
D Proprietà nell’uso del lessico anche<br />
specialistico. Adeguatezza del registro Scarso<br />
E<br />
1-4<br />
Sviluppo critico, rielaborazione personale. Se<br />
richiesta, creatività Scarso<br />
1-4<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Grav. ins.<br />
5-7<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Insufficiente<br />
8-9<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Sufficiente<br />
10-11<br />
Discreta/buona<br />
12-13<br />
Discreta/buona<br />
12-13<br />
Discreta/buona<br />
12-13<br />
Discreto/buono<br />
12-13<br />
Discreto/buono<br />
12-13<br />
Ottima<br />
14-15<br />
Ottima<br />
14-15<br />
Ottima<br />
14-15<br />
Ottima<br />
14-15<br />
Ottima<br />
14-15<br />
Discreta/buona<br />
12-13<br />
Discreta/buona<br />
12-13<br />
Discreta/buona<br />
12-13<br />
Discreto/buono<br />
12-13<br />
Discreto/buono<br />
12-13<br />
GIUDIZIO QUINDICESIMI DECIMI<br />
Nullo o scarso 1-3 1-2<br />
Gravemente insufficiente 4-5 3<br />
6-7 4<br />
Insufficiente 8-9 5<br />
Sufficiente 10-11 6<br />
Discreto 12 7<br />
Documento della classe III A<br />
Ottima<br />
14-15<br />
Ottima<br />
14-15<br />
Ottima<br />
14-15<br />
Ottima<br />
14-15<br />
Ottima<br />
14-15
13<br />
Buono 13 8<br />
Ottimo 14 9<br />
Eccellente 15 10<br />
Indicatori<br />
A:<br />
1<br />
Individuazi Lavoro nullo,<br />
one delle non svolto o<br />
strutture comunque<br />
morfosintat scarso<br />
tiche<br />
B:<br />
Interpretazi<br />
one e<br />
comprensio<br />
ne globale<br />
del testo<br />
C:<br />
Ricodificazi<br />
one in<br />
lingua<br />
italiana<br />
D:<br />
Completez<br />
za<br />
1<br />
Lavoro nullo,<br />
non svolto o<br />
comunque<br />
scarso<br />
Griglia di valutazione della seconda prova scritta<br />
2<br />
Lavoro che si profila<br />
insufficiente, pur se<br />
in modo non grave<br />
2<br />
Più o meno<br />
gravemente<br />
insufficient<br />
e<br />
1<br />
Non sufficiente<br />
3<br />
Mediocre<br />
Nessun punteggio<br />
Testo che risulta affrontato in<br />
modo molto lacunoso<br />
3<br />
Sufficiente<br />
4<br />
Sufficiente<br />
2<br />
Sufficiente<br />
1<br />
Testo che<br />
presenta un<br />
certo numero<br />
di lacune, non<br />
superiori al 30<br />
% del testo<br />
Totale punteggio in quindicesimi = …..../15<br />
4<br />
Da discreto a<br />
buono<br />
5<br />
Ottimo/<br />
Eccellente<br />
5<br />
Lavoro che presenta una<br />
comprensione soddisfacente, fino<br />
all'ottimo<br />
3<br />
Più che sufficiente, fino all'ottimo<br />
2<br />
Testo completo o quasi completo<br />
Griglia di valutazione delle esercitazioni di terza prova<br />
DESCRITTORI INDICATORI<br />
Documento della classe III A
14<br />
QUINDICESIMI GIUDIZIO ADERENZA<br />
AL QUESITO<br />
CONOSCENZA<br />
DELL’ARGOMENTO<br />
LINGUAGGIO<br />
SPECIFICO<br />
1-4 scarso nulla nulla nullo<br />
5-7<br />
8-9 insufficiente<br />
10 sufficiente<br />
ESPOSIZIONE<br />
nulla o molto confusa<br />
gravemente<br />
insufficiente approssimativa molto limitata scorretto poco chiara<br />
parziale frammentaria/lacunosa<br />
sufficiente<br />
limitata alle linee<br />
essenziali<br />
non del tutto adeguato<br />
corretto anche se<br />
limitato<br />
poco organizzata<br />
11-12 discreto completa discreta corretto chiara<br />
13-14 buono completa buona<br />
15 ottimo completa ampia e ben organizzata<br />
VOTO<br />
/30<br />
1-9<br />
10-15<br />
16-19<br />
20-22<br />
sufficientemente chiara<br />
corretto e abbastanza<br />
ricco chiara e corretta<br />
corretto e ricco<br />
Griglia di valutazione del colloquio<br />
chiara/corretta<br />
elegante/originale<br />
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’<br />
Da nessuna a frammen- Si esprime in modo scorretto e Si orienta con difficoltà<br />
tarie e gravemente compie analisi errate<br />
rispetto alle sollecitazioni<br />
lacunose, per cui non<br />
proposte<br />
riesce ad orientarsi<br />
anche se guidato<br />
Lacunose e parziali Applica le conoscenze minime Compie sintesi scorrette<br />
se guidato, ma con errori. Si<br />
esprime in modo scorretto ed<br />
improprio, compie analisi<br />
lacunose e con errori<br />
Limitate e superficiali Applica le conoscenze con Gestisce con difficoltà<br />
imperfezioni. Si esprime in situazioni nuove,anche se<br />
modo impreciso. Compie analisi semplici<br />
parziali<br />
Di ordine generale, ma Applica le conoscenze senza Riproduce informazione<br />
con qualche lacuna e commettere errori, sostanziali, preconfezionate, non sa<br />
disorganicità<br />
almeno in alcune discipline. muoversi autonomamente<br />
Riferisce contenuti senza<br />
applicare una logica autonoma<br />
Documento della classe III A
15<br />
23-25<br />
26-27<br />
28-29<br />
30<br />
Se guidato sa estendere Espone in modo corretto anche Rielabora in modo corretto<br />
l’argomentazione, che ha se non ricco e non sempre le informazioni e situazioni<br />
discreta ampiezza in utilizza il lessico specifico. predefinite<br />
numerose discipline Domina situazioni note in quasi<br />
tutte le discipline, si esprime con<br />
un lessico appropriato<br />
Sicure nella maggior Applica autonomamente le Rielabora in modo corretto<br />
parte delle discipline conoscenze anche a problemi facendo interagire le<br />
complessi. Espone in modo informazioni con una certa<br />
corretto e con proprietà lin- autonomia<br />
guistica. Individua relazioni in<br />
modo completo nella maggior<br />
parte delle discipline<br />
Sicure in tutte le Applica le conoscenze in modo Rielabora in modo corretto,<br />
discipline, organiche corretto ed autonomo anche a completo ed autonomo<br />
nella maggior parte problemi complessi. Espone in<br />
modo fluido ed utilizza i<br />
linguaggi specifici. Compie<br />
analisi approfondite, individua<br />
correlazioni precise<br />
Organiche, approfondite Applica le conoscenze in modo Sa rielaborare correttamente<br />
ed ampliate in modo corretto ed autonomo anche a ed approfondire in modo<br />
autonomo<br />
problemi complessi e trova da autonomo e critico situazioni<br />
solo le soluzioni migliori. complesse<br />
E s p o n e i n m o d o<br />
fluido,utilizzando un lessico<br />
ricco ed appropriato<br />
Documento della classe III A
16<br />
ATTIVITÀ D’ INFORMAZIONE E PREPARAZIONE ALL’ESAME<br />
Informazione<br />
! Gli studenti sono stati adeguatamente informati sin dagli anni scorsi sulla struttura<br />
del nuovo Esame di Stato. !In particolare, nel corso di quest’anno hanno partecipato a una<br />
apposita lezione sull’Esame a cura della Presidenza 16 marzo .<br />
Esercitazione<br />
Prova di italiano<br />
! Fin dagli scorsi anni scolastici la classe è stata addestrata ad affrontare le diverse<br />
tipologie della prova scritta di italiano; tali tipologie sono state regolarmente<br />
somministrate in occasione delle consuete prove in itinere (che nel corso dell’ultimo anno<br />
sono state somministrate nello stesso giorno in tutte le classi del liceo con tracce almeno in<br />
parte comuni). 17 maggio 2012: simulazione della prova d’esame comune a tutte le classi<br />
terze dell’istituto (durata: cinque ore).<br />
Simulazione della seconda prova<br />
Il giorno 23 maggio sarà effettuata la simulazione della seconda prova dell'esame di Stato<br />
(prova di greco).<br />
Terza prova<br />
! Fin dalla prima liceo la classe si era esercitata in simulazioni della terza prova.<br />
Quest’anno, concordemente a quanto stabilito a inizio anno dal Collegio dei docenti, la<br />
classe ha effettuato due esercitazioni.<br />
! Criteri seguiti per la progettazione: il Consiglio di classe non ha ritenuto opportuno<br />
attivare progetti interdisciplinari. Di conseguenza, neppure le esercitazioni di terza prova<br />
sono state costruite come prova interdisciplinare, ma sono state progettate su argomenti<br />
disciplinari autonomi. A sostegno di questa scelta ha giocato anche il fatto che le<br />
esercitazioni sono state utilizzate dai docenti come elementi di verifica disciplinare. Nel<br />
corso dell’anno si è cercato di interessare tutte le discipline curricolari.! Fra le tipologie<br />
delle terza prova, nell’ultimo anno la scelta del Consiglio di classe è caduta sulla tipologia<br />
B (cinque materie, dieci quesiti in totale, con risposte di massimo dieci righe).<br />
Documento della classe III A
17<br />
Le esercitazioni di terza prova sono state tutte effettuate in orario di lezione nelle<br />
seguenti date:<br />
19 / 11 / 2011 Greco Inglese Filosofia Fisica Scienze<br />
12 / 4 / 2012 Latino Filosofia Matematica Inglese Arte<br />
!<br />
Queste esercitazioni hanno avuto la durata di tre ore. I testi delle esercitazioni sono<br />
allegati al presente Documento.<br />
La correzione e la valutazione delle esercitazioni di terza prova sono state condotte<br />
dai singoli docenti.<br />
Si provvederà, inoltre, a compiere una simulazione dell'orale, il primo giugno, con<br />
le seguenti modalità: i membri interni per le loro materie , con , in aggiunta , insegnanti di<br />
altre sezioni per le materie oggetto di esaminatori esterni. La simulazione verterà sul<br />
programma del secondo quadrimestre , ed avverrà alla presenza di tutta la classe ,<br />
scegliendo gli studenti con un sorteggio effettuato la mattina stessa.<br />
Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella<br />
seduta di Mercoledì 3 Maggio 2012.<br />
Venezia, 3 Maggio 2012<br />
IL COORDINATORE! ! ! ! ! IL DIRIGENTE SCOLASTICO<br />
Michela Mazzoni<br />
Documento della classe III A
18<br />
Parte seconda<br />
RELAZIONI DISCIPLINARI<br />
CON I PROGRAMMI SVOLTI<br />
CLASSE 3 A<br />
Anno scolastico 2011-2012<br />
Documento della classe III A
19<br />
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE<br />
A.S. 2011/2012<br />
DOCENTE: MAZZONI MICHELA!<br />
MATERIA: ITALIANO<br />
CLASSE: III A<br />
CONOSCENZE<br />
A seguito dello svolgimento del programma curricolare della terza liceale a.s. 2011/2012 lo<br />
studente conosce:<br />
a) la biografia essenziale degli autori oggetto di studio;<br />
b) la periodizzazione storica generale relativa alla porzione di storia della letteratura studiata<br />
( dalla fine ‘700 alla metà del ‘900)<br />
c)il contenuto generale della produzione letteraria degli autori studiati ed il contenuto<br />
approfondito delle opere delle quali sono stati analizzati i testi;<br />
d)le linee generali di sviluppo della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento<br />
e)le linee generali dei principali movimenti e correnti letterarie italiane ed europee tra<br />
Ottocento e Novecento;<br />
f)lineamenti generali di metrica<br />
COMPETENZE E CAPACITA’<br />
A seguito dello svolgimento del programma curricolare della terza liceale a.s. 2011/2012 lo<br />
studente sa/è capace di:<br />
a) analizzare un testo poetico partendo dalla comprensione del suo significato e arrivando<br />
all’analisi connotativa e denotativa dei singoli elementi presenti nel testo, avvalendosi<br />
dell’analisi retorica, metrica e stilistica;<br />
Documento della classe III A
20<br />
b) analizzare un testo di prosa comprendendone il contenuto ed evidenziando la<br />
caratterizzazione dei personaggi, lo svolgersi della trama, l’analisi delle voci narranti.<br />
c) istituire collegamenti tra testi diversi dello stesso autore e tra testi di autori differenti,<br />
evidenziando analogie e differenze, tracciando linee di continuità e sviluppo tra<br />
movimenti e correnti letterarie diverse e lontane nel tempo;<br />
d) rapportare ciascuna corrente o movimento letterario al contesto storico di nascita e<br />
sviluppo, individuando le linee di continuità o di rottura di questi ultimi con lo spirito<br />
del tempo.<br />
METODI<br />
Il programma curricolare di italiano ha mirato a mettere in evidenza le peculiarità dei<br />
singoli autori della letteratura all’interno dei movimenti letterari di appartenenza.<br />
In particolare la centralità del testo ha fatto sì che spesso gli alunni fossero guidati alla<br />
conoscenza di un autore, un’opera o una corrente letteraria partendo dalla lettura dei testi<br />
e arrivando in seguito alla presentazione bio-bibliografica e critica di riferimento.<br />
Il metodo di lavoro è stato un metodo “aperto” alle sollecitazioni provenienti dalla classe,<br />
composta da alunni caratterizzati da esuberanza e vivacità intellettuale con alcune punte<br />
di eccellenza.<br />
L’interesse di gran parte degli alunni per le tematiche della più recente attualità ha fatto<br />
orientare il mio lavoro verso un approccio precoce e marcato alla letteratura del<br />
Novecento, in particolare alla produzione lirica, per cui un modulo sul Novecento è<br />
partito già all’inizio dell’anno snodandosi tra primo e secondo quadrimestre nelle ore del<br />
sabato (anche il modulo sul Paradiso dantesco è stato interquadrimestrale).<br />
Il metodo è stato “aperto” anche in riferimento al rapporto docente- studenti: spesso gli<br />
alunni sono stati chiamati a lavorare personalmente sui testi avendo spazio per proporre il<br />
proprio approccio all’interpretazione e alla critica testuale.<br />
MEZZI<br />
E’ stato ampiamente utilizzato il libro di testo adottato nella classe (Baldi, Giusso et alii,<br />
Letteratura italiana) unitamente a testi forniti in fotocopia dal Docente.<br />
Sono stati utilizzati anche occasionalmente gli strumenti multimediali a disposizione della<br />
classe e della scuola (LIM, lettore cd e dvd).<br />
OSSERVAZIONI<br />
La classe è composta da alunni vivaci e si è dimostrata corretta nel comportamento e<br />
puntuale nel rispetto delle scadenze. I risultati di profitto sono mediamente buoni con<br />
punte di eccellenza e da parte di tutti gli studenti sono stati raggiunti gli obbiettivi<br />
minimi.<br />
Il clima relazionale tra docente e alunni nel complesso è stato più che buono.<br />
Documento della classe III A
21<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI<br />
Il programma curricolare di italiano ha svolto i seguenti percorsi didattici:<br />
1)Percorso- autore: Ugo Foscolo.<br />
L’amore per il mondo classico e per Venezia: i primi segni della nuova sensibilità<br />
romantica.<br />
Esame approfondito della biografia di Foscolo ed esame del contenuto delle opere<br />
principali (Ultime lettere di Jacopo Ortis, Sonetti, Dei Sepolcri)<br />
Lettura, analisi e commento stilistico retorico dei seguenti testi:<br />
dai Sonetti<br />
Alla sera<br />
A Zacinto<br />
In morte del fratello Giovanni<br />
Carme Dei Sepolcri (lettura integrale)<br />
2)Percorso- autore: Giacomo Leopardi.<br />
La riflessione esistenziale ed il suo legame con il paesaggio.<br />
La sensibilità e la poetica di Leopardi come basi della lirica “moderna”.<br />
Esame approfondito della biografia di Leopardi e analisi del legame tra la sua vicenda<br />
biografica e le fasi di composizione delle sue opere.<br />
La riflessione teorica è stata approfondita su alcuni temi “forti” della poetica dell’autore:<br />
l’importanza del ricordo; il ruolo della natura e del paesaggio ed il loro rapporto con<br />
l’uomo; il pessimismo leopardiano nella sua evoluzione storica (dai primi Idilli alla<br />
Ginestra).<br />
Lettura integrale e analisi dei seguenti testi:<br />
dai Canti<br />
Ultimo canto di Saffo<br />
Alla luna<br />
Infinito<br />
La sera del dì di festa<br />
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia<br />
dalle Operette morali<br />
Dialogo della Natura e di un Islandese<br />
3) Percorso- autore: Alessandro Manzoni<br />
Il “realismo moderato” dei Promessi Sposi, il cattolicesimo liberale e l’interesse per il<br />
romanzo storico.<br />
Esame approfondito della biografia di Manzoni e del contenuto delle sue opere principali<br />
(I Promessi Sposi,le Odi e le tragedie).<br />
Documento della classe III A
22<br />
La riflessione teorica ha messo in evidenza gli elementi cardine della biografia e della<br />
poetica manzoniana: l’importanza della sua formazione laica e illuministica, la svolta della<br />
conversione al cattolicesimo, la visione provvidenziale della storia, l’importanza della fede<br />
nella vita degli uomini)<br />
Lettura, analisi e commento stilistico- retorico dei seguenti testi:<br />
Il cinque maggio;<br />
da I Promessi Sposi capitolo I, capitolo IV.<br />
4)Percorso- autore: Giovanni Verga<br />
Il Verismo italiano: peculiarità, legami e innovazioni rispetto al Naturalismo francese.<br />
Esame della biografia di Verga e del contenuto delle opere principali (raccolta di novelle<br />
Vita dei campi; romanzi I Malavoglia, Mastro don Gesualdo).<br />
La riflessione teorica ha messo in evidenza gli elementi cardine della poetica del Verismo:<br />
l’attenzione per i fatti di cronaca e di attualità; la regressione dell’autore come tecnica<br />
narrativa; l’osservazione “sociologica” dei vari strati della società; il pessimismo radicale e<br />
l’opposizione all’idea di progresso.<br />
Lettura, analisi e commento stilistico retorico dei seguenti testi:<br />
Prefazione alla novella L’amante di Gramigna.<br />
Rosso Malpelo (lettura integrale).<br />
La Lupa (lettura integrale)<br />
Da I Malavoglia (capitolo I).<br />
5)Percorso- autore: Giovanni Pascoli.<br />
La sensibilità nuova, “decadente” e simbolista nella poesia italiana.<br />
Esame approfondito della biografia di Pascoli e del suo legame con il “nido” familiare. I<br />
temi chiave e la poetica di Pascoli in Myricae: l’importanza del “nido”; il ruolo del<br />
paesaggio; la poetica degli oggetti e l’adesione istintiva e originale al simbolismo; le novità<br />
formali (disgregazione della sintassi; ricorso al linguaggio pre-verbale e post- verbale; uso<br />
della sinestesia e dei colori).<br />
Lettura, analisi e commento stilistico retorico dei seguenti testi:<br />
Alcuni brani presenti nella loro antologia dal saggio Il fanciullino.<br />
da Myricae<br />
Arano<br />
Novembre<br />
X Agosto<br />
da I canti di Castelvecchio<br />
Il gelsomino notturno<br />
6)Percorso- autore: Charles Baudelaire.<br />
Le radici della poesia decadente e simbolista.<br />
Esame della biografia dell’autore e dei temi cardine della sua poetica nuova: l’importanza<br />
della sua influenza sulla poesia italiana tra ottocento e novecento.<br />
Lettura, analisi e commento stilistico retorico:<br />
da I fiori del male<br />
Corrispondenze<br />
L’albatro<br />
Documento della classe III A
23<br />
7)Percorso- autore: Gabriele D’Annunzio.<br />
La concezione della vita come “opera d’arte” e la figura dell’esteta ovvero del dandy.<br />
D’Annunzio: lo sperimentalismo dei generi; il vitalismo panico; la corrispondenza vitaarte;<br />
l’originalità del Notturno e l’adesione al simbolismo francese in Alcyone.<br />
Lettura, analisi e commento stilistico- retorico dei seguenti testi:<br />
da Alcyone<br />
La sera fiesolana<br />
Nella belletta<br />
Il vento scrive<br />
Brani tratti dal Notturno ().<br />
8) Percorso -autore: Luigi Pirandello<br />
La relatività dei punti di vista e la disgregazione delle certezze nella narrativa e nel<br />
teatro di Pirandello.<br />
Esame approfondito della biografia dell’autore.<br />
Esame del contenuto delle opere principali (novelle: Novelle per un anno, romanzi: Il fu<br />
Mattia Pascal e Uno, nessuno, centomila; teatro: Il berretto a sonagli, Così è se vi pare).<br />
La riflessione teorica è stata approfondita su alcuni temi forti: l’affermazione della<br />
molteplicità dei punti di vista, l’ironia come “sentimento del contrario”(Pirandello);la<br />
critica al perbenismo e all’ipocrisia della società borghese del suo tempo; il tema della<br />
follia come unico spazio di libertà e di affermazione della verità.<br />
Lettura, analisi e commento stilistico- retorico dei seguenti testi:<br />
dal saggio L’Umorismo (alcuni brani presenti nella loro antologia)<br />
da Novelle per un anno<br />
Il treno ha fischiato<br />
da Uno, nessuno, centomila<br />
da Il fu Mattia Pascal (alcuni brani presenti nella loro antologia).<br />
9)Percorso-autore: Italo Svevo<br />
L’approfondimento psicologico del personaggio e l’importanza della psicoanalisi<br />
Esame approfondito della biografia dell’autore.<br />
Esame del contenuto delle opere principali ( La coscienza di Zeno, Senilità, Una vita): il<br />
dubbio e l’incertezza come caratteristiche dell’uomo contemporaneo, l’ingresso della<br />
psicanalisi nel romanzo, Zeno Cosini e l’anti-eroe.<br />
Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:<br />
da La coscienza di Zeno<br />
da Senilità (alcuni brani presenti nella loro antologia)<br />
10)Percorso- autore: Eugenio Montale<br />
La poesia italiana del Primo Novecento: il male di vivere e l’ermetismo.<br />
Esame dettagliato della biografia dell’autore<br />
Individuazione dei temi “forti” e dei punti cardine della poetica dell’essenzialità e del<br />
paesaggio nella raccolta Ossi di seppia: l’aridità del paesaggio come simbolo<br />
dell’inquietudine esistenziale; l’importanza del “muro” come metafora della vita.<br />
Documento della classe III A
24<br />
Lettura, analisi e commento stilistico retorico dei seguenti testi:<br />
da Ossi di seppia<br />
Non chiederci la parola<br />
Mia vita a te non chiedo<br />
Gloria del disteso mezzogiorno<br />
Meriggiare pallido e assorto<br />
Spesso il male di vivere ho incontrato<br />
Cigola la carrucola<br />
11)Percorso- autore: Giuseppe Ungaretti<br />
La poesia ermetica de L’allegria ed il suo legame con l’esperienza della prima guerra<br />
mondiale.<br />
Esame approfondito della biografia dell’autore.<br />
La poesia come espressione di se stessi anche all’interno della crudele e disumana<br />
esperienza della guerra: la condensazione della lingua, la rarefazione del verso, la<br />
complessità semantica della singola parola nella tecnica poetica di Ungaretti.<br />
Lettura, analisi e commento stilistico retorico dei seguenti testi:<br />
Commiato<br />
I fiumi<br />
Il porto sepolto<br />
Veglia<br />
Vanità<br />
Mattina San Martino del Carso<br />
Soldati<br />
Stasera<br />
Natale<br />
12)Percorso- autore: Umberto Saba.<br />
La poesia essenziale, semplice e quotidiana come risposta all’ermetismo.<br />
Presentazione della biografia dell’autore.<br />
La poetica della semplicità di Saba, il Canzoniere come storia della sua vita.<br />
Lettura, analisi e commento retorico-stilistico dei seguenti testi:<br />
dal Canzoniere<br />
Trieste<br />
Città vecchia<br />
Amai<br />
Confronto tematico della lirica di Saba Città vecchia con la omonima canzoneCittà vecchia<br />
di Fabrizio De Andrè.<br />
13) Percorso tematico: la poesia italiana del Secondo Novecento<br />
Temi e forme nella poesia di Sandro Penna e Alda Merini.<br />
Breve esame della biografia degli autori: la poesia come espressione di un talento naturale,<br />
la propria vita come fonte di ispirazione.<br />
La semplicità ed il colore nella poesia giocosa di Sandro Penna a confronto con la<br />
sensualità ed il misticismo e l’inquietudine esistenziale della poesia della Merini.<br />
Documento della classe III A
25<br />
Riflessione teorica sulle costanti della poesia contemporanea: l’eco forte di Ungaretti, Saba<br />
e Montale, la scrittura poetica come espressione di una forte urgenza interiore.<br />
Lettura, analisi e commento retorico-stilistico dei seguenti testi:<br />
di Sandro Penna<br />
La vita è ricordarsi di un risveglio<br />
Il sentimento della vita<br />
di Alda Merini<br />
Il gobbo<br />
I versi sono polvere chiusa<br />
Ogni mattina il mio stelo vorrebbe levarsi nel vento<br />
Confronto tematico e stilistico delle liriche di Penna e Merini con poesie di altri importanti<br />
scrittori appartenenti alla stagione poetica del secondo dopoguerra.<br />
Lettura e commento di:<br />
Mario Luzi, Vita fedele alla vita<br />
Giorgio Caproni Anch’io<br />
Attilio Bertolucci Ora il giorno è sereno (per questa lirica sono state messe in evidenza le<br />
matrici pascoliane).<br />
14)Percorso -autore: Pierpaolo Pasolini<br />
L’amore per la spontaneità e la vitalità del “popolo” ed il realismo nelle opere di<br />
Pasolini.<br />
Esame approfondito della biografia dell’autore e breve esposizione delle tappe più<br />
importanti della sua carriera di intellettuale. Conoscenza del contenuto di alcune sue<br />
opere principali (poesia: Le ceneri di Gramsci; romanzi: Ragazzi di vita e Una vita violenta;<br />
cinema: La trilogia della vita, Comizi d’amore).<br />
La profetica analisi sociologica della società italiana in trasformazione: la critica della<br />
società del benessere, l’omologazione culturale della popolazione italiana.<br />
Lettura, analisi e commento retorico-stilistico della poesia<br />
Le ceneri di Gramsci<br />
Visione della prima parte del docu-film Comizi d’amore (in particolare l’intervista al poeta<br />
Giuseppe Ungaretti sul concetto di “normalità sessuale”).<br />
15) Percorso-opera: il Paradiso dantesco (modulo interquadrimestrale).<br />
Lettura integrale e analisi stilistico- retorica dei seguenti canti:<br />
I- III- VI- XI- XV- XVII- XXXIII.<br />
In particolare l’attenzione si è soffermata sulla rilevanza svolta dal tema politico e da<br />
quello autobiografico all’interno della cantica (canti sesto e quindicesimo). Sono stati messi<br />
in rilievo i procedimenti stilistici (innalzamento del linguaggio, densità e complessità<br />
semantica e filosofica, ricorso a suoni, luci e figure geometriche) attuati da Dante per dare<br />
degna forma al “soprannaturale” e al “sovrumano” scelti come materia del suo canto.<br />
VENEZIA,! 3 maggio 2012! ! ! ! ! ! !<br />
Michela Mazzoni<br />
Documento della classe III A
26<br />
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE<br />
! ! ! ! ! ! ! A.S. 2011/2012<br />
DOCENTE: MAZZONI MICHELA!<br />
MATERIA: LATINO<br />
CLASSE: III A<br />
CONOSCENZE<br />
A seguito dello svolgimento del programma curricolare della terza liceale a.s. 2011/2012 lo<br />
studente conosce:<br />
a) la biografia essenziale degli autori oggetto di studio;<br />
b) la periodizzazione storica generale relativa alla porzione di storia della letteratura studiata<br />
(tra I e II secolo d.C.)<br />
c)il contenuto generale della produzione letteraria degli autori studiati ed il contenuto<br />
approfondito delle opere delle quali sono stati analizzati i testi;<br />
d)le linee generali di sviluppo della letteratura latina tra I e II secolo d.C.<br />
e)la lingua latina, la sua grammatica, la sua morfologia e sintassi.<br />
COMPETENZE E CAPACITA’<br />
Nell´esercizio di traduzione gli alunni sanno comprendere il contenuto informativo del<br />
testo proposto rispettandone la correttezza grammaticale e sintattica e ricodificando<br />
opportunamente il testo in lingua italiana.<br />
Nella conoscenza dei testi di classico latino gli alunni sanno rielaborare i contenuti della<br />
storia della letteratura latina sapendo tracciare linee di continuità e sviluppo o di<br />
opposizione tra generi letterari o tra singoli autori.<br />
Documento della classe III A
27<br />
OBBIETTIVI DELLA DISCIPLINA<br />
Obiettivi generali:<br />
• Prendere consapevolezza che la civiltà letteraria latina unitamente a quella greca è base e<br />
fondamento della cultura occidentale.<br />
• Diventare piu´ consapevoli delle strutture grammaticali e sintattiche della lingua italiana<br />
e della loro derivazione dalla lingua latina.<br />
• Accrescere attraverso lo studio di poeti e prosatori latini la sensibilità letteraria, il senso<br />
critico ed estetico, la riflessione storica, filosofica ed esistenziale.<br />
Obiettivi trasversali:<br />
• accrescere ed implementare la capacità di sintesi, di schematizzazione dei concetti, di<br />
costruzione di mappe concettuali e scalette utili alla memorizzazione e alla<br />
preparazione di un colloquio orale<br />
METODI<br />
Dal punto di vista della ripartizione delle ore settimanali di insegnamento esse sono state<br />
così suddivise:<br />
a) ore di studio della storia della letteratura latina nelle sue linee generali e nella sua<br />
periodizzazione storica;<br />
b) ore di traduzione dei testi e di ripasso delle nozioni grammaticali;<br />
c) ore di lettura, traduzione e analisi stilistica dei testi degli autori fondamentali del<br />
periodo (per quest´anno Seneca e Tacito).<br />
Il programma curricolare di latino ha mirato a mettere in evidenza le peculiarità dei<br />
singoli autori della letteratura all´interno dei generi letterari di appartenenza.<br />
Il metodo di lavoro è stato un metodo “aperto” alle sollecitazioni provenienti dalla classe,<br />
composta da alunni caratterizzati da esuberanza e vivacità intellettuale con punte di<br />
eccellenza.<br />
Il metodo è stato “aperto” anche in riferimento al rapporto docente- studenti: spesso gli<br />
alunni sono stati chiamati a lavorare personalmente sui testi avendo spazio per proporre il<br />
proprio approccio personale all´analisi e all´interpretazione testuale.<br />
E’ stato ampiamente utilizzato il libro di testo adottato nella classe (Bettini M. Limina vol<br />
II) unitamente a testi forniti in fotocopia dal Docente.<br />
VALUTAZIONI E STRUMENTI DI VERIFICA<br />
Strumenti di verifica (natura e tempi delle prove): tre compiti scritti per ciascun<br />
quadrimestre, la cui durata e i cui tempi sono stati concordati tra i docenti del<br />
Dipartimento di Lettere del triennio; verifiche scritte con valore di voto orale (risposta a<br />
domande concettuali); verifiche orali tradizionali.<br />
Documento della classe III A
28<br />
Criteri di valutazione delle prove orali e scritte<br />
Per lo scritto di latino è stata accolta la griglia di valutazione delle prove scritte concordata<br />
con i docenti di Dipartimento; i medesimi parametri di valutazione (correttezza delle<br />
informazioni, uso del lessico, grado di rielaborazione personale dei contenuti) valgono<br />
anche per la valutazione delle verifiche orali.<br />
OSSERVAZIONI<br />
La classe è composta da alunni vivaci e si è dimostrata corretta nel comportamento e<br />
puntuale nel rispetto delle scadenze. I risultati di profitto sono mediamente buoni con<br />
punte di eccellenza e da parte di tutti gli studenti sono stati raggiunti gli obbiettivi<br />
minimi.<br />
Il clima relazionale tra docente e alunni nel complesso è stato più che buono.<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
1)Seneca ed il suo tempo: i Dialogi, le Epistulae, le tragedie. In particolare sono stati<br />
oggetto di approfondimento, attraverso lo studio dei passi di classico, la riflessione sul<br />
rapporto intellettuale/potere, la visione stoica dell’esistenza e la concezione del tempo.<br />
2)Il Satyricon di Petronio<br />
3)Il Bellum civile di Lucano<br />
4)La vis polemica nelle Satire di Persio e Giovenale: la riflessione amara sulla<br />
decadenza e corruzione morale della Roma imperiale<br />
5)Tacito ed il suo tempo: la storiografia degli Annales e delle Historiae, le opere<br />
biografiche ed etnografiche (l’Agricola e la Germania). In particolare è stata approfondita,<br />
attraverso lo studio dei passi di classico, la concezione tacitiana del buon cives servitore<br />
dello Stato(ritratto di Germanico e di Agricola) opposta agli eccessi e alle stravaganze<br />
degli imperatori di età giulio- claudia (ritratto di Nerone, ritratto di Claudio).<br />
6)Marziale: natura, temi e forme dell’epigramma a Roma<br />
7)L’institutio oratoria di Quintiliano<br />
8)Stazio e l’epica di età imperiale<br />
9) Plinio il vecchio e la Naturalis historia<br />
10)Plinio il giovane: le Epistulae<br />
11) Le opere biografiche di Svetonio (De viris illustribus De vita Caesarum)<br />
12) Le Metamorfosi di Apuleio e La favola di Amore e Psiche<br />
Elenco passi di classico<br />
Oggetto di lavoro di traduzione, analisi e commento guidata dal Docente<br />
da Seneca<br />
Epistulae morales ad Lucilium<br />
libro III 23 1-3<br />
libro I 12 1-2<br />
libro I 3 1<br />
libro IV, 31 10-11<br />
Documento della classe III A
29<br />
libro V 48 2-3<br />
De consolatione ad Helviam<br />
8. 2-4<br />
9. 3-5<br />
De Beneficiis, 5, 24<br />
De brevitate vitae 1-2<br />
De tranquillitate animi 2<br />
De consolatione ad Marciam<br />
6. 1-3<br />
20. 4-6<br />
da Tacito<br />
Annales<br />
I libro cap. I- II.4 (proemio dell’opera)<br />
I libro cap. XLI.3 (la pietas familiare di Germanico)<br />
XV libro cap. XXXVIII- XXXIX- XL- XLI- XLII (l’incendio di Roma del 65 d.C.)<br />
XVI libro cap. VI (morte grottesca di Poppea)<br />
XVI libro cap. XVIII- XIX ( notizie sulla vita e sulla morte di Petronio)<br />
Historiae<br />
I libro cap. I<br />
IV libro cap. XIV<br />
Venezia,3 maggio 2012<br />
Michela Mazzoni<br />
DOCENTE: Crispilli Emanuela<br />
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE<br />
La classe composta da 21 allievi possiede una conoscenza basilare delle norme<br />
morfosintattiche greche. Avendo avuto diversi insegnanti nel corso dei cinque anni ha<br />
difficoltà ad acquisire sensibilità letteraria pertanto gli obiettivi raggiunti sono da<br />
intendersi ad un livello base<br />
OBIETTIVI GENERALI<br />
CONOSCENZE<br />
Conoscere le nozioni di morfologia e di sintassi a completamento dello studio del sistema<br />
linguistico latino/greco.<br />
Documento della classe III A
30<br />
Conoscere gli elementi sintattici e lessicali della connessione testuale.<br />
Conoscere il quadro storico di riferimento per lo sviluppo della civiltà e della letteratura<br />
greca.<br />
Conoscere l'evoluzione della produzione letteraria greca .<br />
Conoscere l'evoluzione dei diversi generi letterari e il loro sviluppo nelle letterature<br />
moderne.<br />
Conoscere le tematiche esistenziali e civili del mondo classico e la loro contiguità con<br />
l'attualità.<br />
COMPETENZE<br />
Saper identificare e spiegare fenomeni di livello morfosintattico.<br />
Saper individuare gli elementi sintattici e lessicali della connessione testuale.<br />
Saper individuare il quadro storico di riferimento in cui è inserito un testo letterario<br />
classico.<br />
Saper collocare un'opera letteraria classica nell'evoluzione della produzione letteraria<br />
greca.<br />
Saper riconoscere in un'opera moderna la persistenza degli influssi classici.<br />
Saper cogliere in un'opera classica le tematiche esistenziali e civili fondamentali e la loro<br />
contiguità<br />
con l'attualità.<br />
Individuare campi semantici ricorrenti in alcune tipologie testuali.<br />
CAPACITA'<br />
Essere in grado di individuare le categorie estetiche dei testi, saper leggere<br />
diacronicamente le<br />
categorie del gusto; saper motivare e coltivare il gusto personale.<br />
Essere in grado di sintetizzare e rielaborare in modo personale i contenuti curricolari<br />
affrontati.<br />
Essere in grado di istituire collegamenti interdisciplinari allo scopo di illustrare un nucleo<br />
tematico<br />
Lettura in metrica: trimetro giambico<br />
METODOLOGIA:lezione frontale e dialogata, lavori di gruppo.<br />
MATERIALE: libro di teso, fotocopie a cura della docente.<br />
VALUTAZIONE: Prove d’ingresso ed in itinere. Tre prove scritte e 2 orali per<br />
quadrimestre.<br />
I criteri di valutazione contemplano l’uso di apposite griglie in comune a tutte le sezioni<br />
del liceo.<br />
PROGRAMMA DI GRECO<br />
Modulo 1: Ottobre-novembre<br />
1. ATENE FRA V E IV SECOLO<br />
Documento della classe III A
31<br />
Il regime dei Trenta Tiranni e il ripristino della democrazia. Il contesto socio-politico del IV<br />
secolo:<br />
il ruolo di Atene all’interno del mondo greco; i rapporti con la Persia; la crescita della<br />
potenza<br />
macedone.<br />
L'ORATORIA<br />
Il genere dell’oratoria e riflessione sulla retorica antica e moderna (le fallacie retoriche).<br />
Lisia. Le scuole in Atene e la cultura del libro.<br />
Lettura e traduzione dell’Apologia per l’uccisione di Eratostene.<br />
Isocrate: vita e opere. Il metodo della scuola isocratea. Il primato di Atene e l'ideologia<br />
panellenica. I rapporti con Filippo di Macedonia.<br />
Lettura documenti:T 1,2,3.<br />
L'ATENE DI DEMO STE NE<br />
La vita di Demostene. Il corpus demostenico. Il contesto storico-politico dell’Atene di IV<br />
secolo: il<br />
dibattito politico interno; il rapporto con la Macedonia di Filippo. La battaglia di Cheronea<br />
e la<br />
koiné eiréne. Atene e la Macedonia nell’epoca di Licurgo. La politica ateniese successiva alla<br />
morte<br />
di Licurgo. La guerra di Lamia.<br />
Letture: T1, 2, 3, 4.<br />
Modulo 2: dicembre- marzo<br />
4. IL TEATRO INNOVATIVO DI EURIPIDE<br />
Vita dell’autore. La produzione letteraria. I grandi temi del teatro euripideo: la nuova<br />
caratterizzazione del personaggio tragico; il femminile e l'amore; lo straniero; la guerra. La<br />
tecnica<br />
drammatica. Il rapporto con la pólis.<br />
5. Le Baccanti DI EURIPIDE<br />
Introduzione all’opera. Traduzione, analisi e commento dei seguenti versi:<br />
vv.1-66; 215-262; 450-509; 680-774; 922-976;1115-1124; 1264-1299.<br />
Modulo 3: Dicembre<br />
6. LA COMMEDIA DI MENANDRO<br />
L’evoluzione del genere comico a partire dalla commedia archáia di Aristofane. La<br />
commedia<br />
mése. Vita di Menandro. La riscoperta dell’opera dell’autore. Cronologia e trame. La<br />
tecnica<br />
drammatica e gli intrecci. I personaggi. Il messaggio morale. Lingua e stile.<br />
Documento della classe III A
32<br />
Letture: T 1, 2, 3.<br />
Modulo 4: Dicembre-Febbraio<br />
7. L’ELLENISMO: CARATTERI GENERALI<br />
La definizione di “Ellenismo”. La vicenda di Alessandro Magno e il suo significato storicopolitico.<br />
La costituzione dei regni ellenistici: caratteristiche fondamentali. La città di Alessandria: Il<br />
Museo e<br />
la Biblioteca; filologia ed erudizione letteraria; le scienze. Lo sviluppo urbano.<br />
L'evergetismo.<br />
8. LA POESIA ELLENISTICA: CALLIMACO<br />
Callimaco: la vita e la produzione letteraria. La poesia alessandrina e il ruolo di Callimaco.<br />
La<br />
poesia erudita degli Aitia. Gli I nni. L’E cale. Lingua e stile. La fortuna di Callimaco.<br />
Letture: T 1, 2, 3, 4, 5.<br />
9. LA POESIA ELLENISTICA: APOLLONIO RODIO<br />
Vita e opere dell’autore. La rivisitazione del poema epico e il rapporto con la tradizione<br />
omerica. Le<br />
tecniche narrative. La nuova caratterizzazione dei personaggi.<br />
1.Letture: T1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.<br />
2..Il mimo di Eronda; T 1.<br />
1.Il genere bucolico:<br />
2.<br />
TEOCRITO<br />
Vita e opere dell’autore. Gli idilli bucolici e i mimi urbani. La poetica.<br />
Letture: T1,2, 4.<br />
Modulo 5.:febbraio marzo<br />
11. L’EPIGRAMMA<br />
Origini ed evoluzione dell’epigramma. Caratteristiche formali e tematiche dell’epigramma<br />
ellenistico. L'epigramma a Roma. Lettura di tutti i brani antologizzati.<br />
Modulo 6: marzo-aprile<br />
13. LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA<br />
POLIBIO<br />
I diversi orientamenti della storiografia ellenistica. Gli storici di Alessandro. La storiografia<br />
tragica.<br />
La storiografia retorica. Polibio di Megalopoli. Vita e opere. Il metodo storiografico di<br />
Polibio. La<br />
Documento della classe III A
33<br />
teoria costituzionale.<br />
Letture T 1, 2, 3, 4, 5.<br />
15. PLUTARCO E LA BIOGRAFIA<br />
Le origini della biografia greca. Plutarco: i B ioi paralleloi e i Moralia. Letture: T 1, 2, 3, 4, 7,<br />
8, 9.<br />
Lettura del saggio: B.Snell, La cultura greca e le origini del pensiero Europeo,<br />
Einaudi,Torino,<br />
1963.<br />
docente: Susanna Fort<br />
materia: Storia<br />
Relazione Finale del Docente<br />
Programma svolto<br />
a. s. 2011-2012<br />
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti<br />
obiettivi;!<br />
CONOSCENZE<br />
Conoscenza delle problematiche della storia novecentesca; conoscenza delle posizioni politiche e<br />
diplomatiche dei principali protagonisti del periodo; conoscenza delle dinamiche della società di<br />
massa in relazione alla produzione, al consumo, alla produzione culurale, alle ideologie;<br />
conoscenza delle dinamiche dei due conflitti mondiali; conoscenza della nascita, con la<br />
rivoluzione russa, di un mondo diviso, fino alla cortina di ferro del secondo dopoguerra;<br />
conoscenza degli orrori del nazismo fino alla tragedia della Shoah; conoscenza della svolta<br />
rappresentata dalla decolonizzazione in relazione al mondo bipolare, della coesistenza pacifica ;<br />
conoscenza delle principali tematiche economiche, politiche e culturali che caratterizzano la<br />
storia degli anni Cinquanta e degli anni Sessanta.<br />
COMPETENZE E CAPACITA'<br />
Saper decodificare e comprendere documenti storici, come base di una interpretazione corretta ma<br />
autonoma delle problematiche e delle metodologie proprie della disciplina.<br />
Saper esprimere con correttezza e pertinenza le fondamentali problematiche, utilizzando i<br />
linguaggi specifici.<br />
Saper individuare i nessi storici e le concatenazioni, e saperli riprodurre autonomamente<br />
nell’esposizione.<br />
Saper svolgere correttamente le attività di analisi e di sintesi, e conseguentemente trarre dei<br />
giudizi personali.<br />
Saper collegare nei vari periodi gli eventi correlati e coglierne lo sviluppo fino alle conseguenze.<br />
Documento della classe III A
34<br />
Sapersi orientare nelle principali correnti storiografiche in relazione ai programmi svolti e al<br />
contesto storico economico in cui si sviluppano<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI- UNITA' DIDATTICHE- MODULO - PERCORSO-<br />
ARGOMENTI<br />
METODI<br />
Si rimanda all’allegato<br />
Lezioni frontali, per introdurre un modo sistematico l’argomento;<br />
Lezioni interattive , per favorire la partecipazione dell’intera classe;<br />
Lavoro di gruppo, per sviluppare negli studenti l’attitudine ad affrontare e risolvere<br />
problemi in collaborazione con altri ed autonomamente dalla figura del docente;<br />
Lavoro a feed back e problem solving per sviluppare la capacità di trovare anche dei<br />
propri percorsi personali nell’affrontare e risolvere i problemi e per incentivare la curiosità<br />
puntando sugli interessi culturali autonomi.<br />
OSSERVAZIONI<br />
La classe, anche se non del tutto omogenea, ha ben lavorato nel corso del triennio,<br />
raggiungendo, sia pur con qualche sfumatura, dei risultati buoni sia in relazione alle<br />
conoscenze disciplinari, sia in relazione allo sviluppo di capacità critiche e alla capacità di<br />
costruirsi un proprio percorso culturale. Quasi sempre gli studenti hanno partecipato con<br />
vivo interesse, interagendo proficuamente con l’insegnante e proponendo propri punti di<br />
vista e proprie proposte di sviluppo dei contenuti disciplinari. Talvolta, per alcuni<br />
studenti, ciò è avvenuto con coerente e lucida esposizione delle proprie posizioni in merito<br />
alle tematiche affrontate.<br />
! ! ! ! ! Programma svolto<br />
Libro di testo: De Luna, Storia al presente , Paravia.<br />
Sezione A:<br />
Passaggio verso il nuovo secolo<br />
Documento della classe III A
35<br />
Unità 1<br />
Verso il futuro. Colonialismo e imperialismo.Masse e democrazia; il nazionalismo; la Destra<br />
nazionalista; il Movimento operaio; la rerum Novarum; il darwinismo sociale e il razzismo.<br />
Unità 2<br />
L’età giolittiana. Lo sviluppo industriale.Il problema del Sud. La guerra di Libia. I movimenti in<br />
Italia: socialisti, cattolici, i nazionalisti<br />
Sezione B<br />
La Grande guerra e il primo dopoguerra<br />
:<br />
Unità 3<br />
La prima guerra mondiale. La guerra di massa , la vita di trincea:La conclusione : la sconfitta degli<br />
Imperi . LaRussia inizia la Rivoluzione. Il massacro degli Armeni. La Guerra italiana.Le paci<br />
imposte. Il risentimento per Versailles<br />
Unità 4<br />
Le inquietudini del dopoguerra. La Società delle Nazioni.La Rivoluzione bolscevica. L'assetto<br />
dell'Europa centro-orientale. La situazione dei vincitoriItalia: il biennio rosso.<br />
Sezione C<br />
L’età dei totalitarismi<br />
Unità 5<br />
Le origini del fascismo. Fasci di combattimento, fascismo agrario e squadrismo. La presa del<br />
potere: dalla marcia su Roma aldelitto Matteotti.<br />
Unità 6<br />
Dall’Europa al mondo. Gli Stati Uniti: masse, proibizionismo isolazionismo.Uno sguardo a<br />
Giappone, Cina, India, Turchia e Medio Oriente.<br />
Unità 7<br />
Verso una nuova guerra mondiale. La crisi del '29: cause e conseguenze.Il New Deal.L'avvento del<br />
nazismo in Germania. Lo Stato totalitario nazista. Le leggi di Norimberga.La politica sociale<br />
economica e culturale del nazismo. Lo stalinismo: le purghe; i piani quinquennali, i Gulag<br />
Unità 8<br />
Il fascismo in Italia. I patti Lateranensi, le strutture repressive, la cultura e la società: dalla scuola al<br />
MINICULPOP, La politica economica: il corporativismo e l'autarchia: La politica estera: la guerra<br />
d'Etiopia, l'avvicinamento alla Germania, le leggi razziali.<br />
Unità 9<br />
Vigilia di guerra. .Il Giappone militarista. La Cina e la Lunga Marcia.La guerra di Spagna.<br />
L'Anschluss, , il patto d'acciaio, la conferenza di Monaco, il patto Von Ribbentrop-Molotov<br />
Sezione D<br />
Il più grande conflitto<br />
Documento della classe III A
36<br />
Unità 10<br />
La seconda guerra mondiale (1939- 1942). Dall'attacco nazista alla Polonia alla guerra totale.<br />
Auscwitz e la soluzione finale.La guerra nel Pacifico.<br />
Unità 11<br />
La seconda guerra mondiale (1942-1945). Le prime sconfitte dell'Asse. Il crollo del Fascismo e la<br />
Resistenza in Italia.La RSI. Lo sbarco in Normandia. La sconfitta in Europa di Hitler. La bomba<br />
atomica.Il processo di Norimberga.<br />
Sezione E<br />
Il secondo dopoguerra.<br />
Unità 12<br />
La guerra fredda. L'Europa distrutta e divisa in due blocchi dopo Yalta. L'ONU.L'anticomunismo<br />
negli USA. Bretton Woods.Il piano Marshall. Le due Germanie.I primi passi dell'europa unita.La<br />
Yugoslavia.La vittoria di Mao. La guerra di Corea<br />
Unità 13<br />
L’Italia dalla ricostruzione al boom. La questione di Trieste. Il Referendum. La<br />
Costituente.Le elezioni del 1948.i partiti di massa. Il centrismo. Il miracolo economico. Il<br />
centro-sinistra.<br />
docente: Susanna Fort<br />
materia: Filosofia<br />
Relazione Finale del Docente<br />
Programma svolto<br />
a. s. 2011-2012<br />
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi;<br />
CONOSCENZE<br />
Conoscenza delle problematiche insite nell’impostazione criticistica;<br />
conoscenza delle posizioni romantiche in relazione all’infinito , alla trascendenza, allo Spirito;<br />
conoscenza delle soluzioni proposte dall’Idealismo riguardo alla conoscenza, alla posizione<br />
dell’uomo nella storia; conoscenza della reazione materialistica all’idealismo e a quella<br />
irrazionalistica;<br />
conoscenza delle motivazioni dell’evoluzionismo darwiniano e della sua impostazione ;<br />
conoscenza della corrente positivistica;<br />
conoscenza della rilettura del mondo classico operata da Nietzsche;<br />
Documento della classe III A
37<br />
conoscenza della svolta nella psicologia rappresentata dalla psicoanalisi, con lettura della Gradiva<br />
di Freud<br />
COMPETENZE E CAPACITA'<br />
Saper decodificare e comprendere testi filosofici, come base di una interpretazione corretta ma<br />
autonoma delle problematiche e delle strategie espositive proprie della disciplina.<br />
Saper esprimere con correttezza e pertinenza le fondamentali tesi degli autori considerati,<br />
utilizzando i linguaggi specifici.<br />
Saper individuare i nessi logici e le concatenazioni, e saperli riprodurre autonomamente<br />
nell’esposizione.<br />
Saper svolgere correttamente le attività di analisi e di sintesi, e conseguentemente trarre dei<br />
giudizi personali.<br />
Saper collegare negli autori le tematiche correlate e coglierne lo sviluppo fino alle conseguenze.<br />
Sapersi orientare nelle principali correnti filosofiche in relazione ai programmi svolti e al contesto<br />
storico culturale in cui si sviluppano.<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI-UNITA' DIDATTICHE -MODULO - PERCORSO-<br />
ARGOMENTI<br />
!<br />
Si rimanda all’allegato<br />
METODI<br />
Lezioni frontali, per introdurre un modo sistematico l’argomento;<br />
Lezioni interattive , per favorire la partecipazione dell’intera classe;<br />
Lavoro di gruppo, per sviluppare negli studenti l’attitudine ad affrontare e risolvere<br />
problemi in collaborazione con altri ed autonomamente dalla figura del docente;<br />
Lavoro a feed back e problem solving per sviluppare la capacità di trovare anche dei<br />
propri percorsi personali nell’affrontare e risolvere i problemi e per incentivare la curiosità<br />
puntando sugli interessi culturali autonomi.<br />
Documento della classe III A
38<br />
OSSERVAZIONI<br />
La classe, anche se non del tutto omogenea, ha ben lavorato nel corso del triennio,<br />
raggiungendo, sia pur con qualche sfumatura, dei risultati buoni sia in relazione alle<br />
conoscenze disciplinari, sia in relazione allo sviluppo di capacità critiche e alla capacità di<br />
costruirsi un proprio percorso culturale. Spesso gli studenti hanno partecipato con vivo<br />
interesse, interagendo proficuamente con l’insegnante e proponendo propri punti di vista<br />
e proprie proposte di sviluppo dei contenuti disciplinari. Talvolta, per alcuni studenti, ciò<br />
è avvenuto con coerente e lucida esposizione delle proprie posizioni in merito alle<br />
tematiche affrontate.<br />
Volume 2°<br />
Kant:<br />
Programma svolto<br />
Libro di testo: Abbagnano, Fornero, Le basi del pensiero,voll. 2° e 3°, Paravia<br />
La Critica della Ragion pura . I giudizi; Spazio e tempo sono apriori; fenomeno e cosa in<br />
sé; le categorie e l'io penso. La dilalettica trascendentale. Intelletto e ragione.<br />
La Critica della Ragion Pratica. I tre postulati e le tre formulazioni del “tu devi”.<br />
Rigorismo e formalismo<br />
La Critica del Giudizio. Il giudizio riflettente; il bello e il sublime; il giudizio teleologico<br />
I caratteri generali del Romanticismo tedesco ed europeo.<br />
Streben , Sehnsucht, Titanismo. Il cattivo infinito. Il sentimento e le vie alogiche per<br />
l'Assoluto. La concezione della Storia . Il concetto di Popolo. L'arte.<br />
Dal kantismo all’ hegelismo .Fichte.<br />
L'idealismo: i tre principi della Dottrina della Scienza. Io Puro e non Io. “Omnis<br />
determinatio est negatio”: l'uso di questo assunto spinoziano per giustificare il non-Io e<br />
poi, rovesciato, gli io empirici.<br />
I discorsi alla nazione tedesca.<br />
Schelling.<br />
Documento della classe III A
39<br />
La filosofia della Natura<br />
(Da pag. 437 a pag.441).<br />
Hegel.<br />
Le critiche a Schelling e Fichte. Gli scritti religiosi giovanili. Il buon infinito. La realtà come<br />
Spirito. Il reale è razionale, il razionale è reale. ” Ogni finito ha questo di proprio, che<br />
sopprime se medesimo”. La dialettica e l'aufheben. Intelletto e ragione .<br />
La Fenomenologia dello Spirito ( nell'autocoscienza: le figure di servo e signore, lo<br />
stoicismo, lo scetticismo, la coscienza infelice).<br />
La Logica (essere , non essere, divenire) .<br />
La Filosofia della Natura – la concezione idealistica di evoluzione.<br />
La filosofia dello Spirito ( in particolare spirito oggettivo e assoluto).<br />
La filosofia della Storia: il logos, le astuzie della ragione.<br />
Volume 3°<br />
Schopenhauer.<br />
Il mondo come volontà e come rappresentazione. Il velo di Maya. Le oggettivazioni della<br />
volontà. La vita oscilla tra dolore e noia. Il pensiero orientale riletto da Schopenhauer.<br />
Differenze con Leopardi. La noluntas: ascesi e arte. Volontà e libido freudiana<br />
Kierkegaard.<br />
L'antihegelismo.Il singolo. L'angoscia del singolo. La vita estetica, la vita etica, la vita<br />
religiosa. La fede come paradosso e scandalo.<br />
Feuerbach.<br />
Il rovesciamento materialistico di Hegel. La religione come alienazione. Un nuovo<br />
umanesimo.<br />
Documento della classe III A
40<br />
Marx.<br />
Critiche a Hegel, Sinistra Hegeliana, Feuerbach. Il materialismo storico. La dialettica. Il<br />
sistema capitalistico e la centralità dell'analisi della merce ; il lavoro salariato, il<br />
plusvalore. L'alienazione.<br />
Il Positivismo.<br />
Comte : La classificazione delle scienze. La sociologia. La centralità del fatto.<br />
Cenni ad Hard Times di Dickens<br />
Nietzsche.<br />
La nascita della tragedia. Una nuova immagine del mondo classico. Il dionisiaco e<br />
l'apollineo. Il rimedio è peggiore del male. Critiche al pensiero occidentale: scienza,<br />
morale, storia. La trasmutazione dei valori, l'annuncio della morte di Dio. L'oltreuomo.<br />
L'eterno ritorno. La volontà di potenza ( cenni alle interpolazioni della sorella).<br />
Freud<br />
.La formazione. La nevrosi. Il metodo psicoanalitico. L'inconscio. Il sogno . La<br />
psicopatologia della vita quotidiana. Le due topiche. La sessualità infantile: il bambino<br />
come “perverso polimorfo”. Fase orale, anale, fallico genitale. Il complesso di Edipo come<br />
complesso nucleare. Freud e la psicologia delle masse. La religione come nevrosi collettiva.<br />
Inoltre la classe ha letto :<br />
Bulgakov, Cuore di cane<br />
Freud , Il delirio e i sogni nella Gradiva di Jensen<br />
Documento della classe III A
41<br />
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE<br />
MATERIA: Inglese<br />
CLASSE: III A<br />
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:<br />
CONOSCENZE<br />
Dei testi affrontati gli studenti conoscono il contenuto letterale, un sintetico riassunto<br />
dell’opera da cui sono tratti, il genere letterario cui tale opera appartiene, le sue<br />
caratteristiche formali e in quale rapporto essa si pone con il tema del modulo in cui è<br />
inserita.<br />
COMPETENZE E CAPACITÀ<br />
Gli studenti sono in grado di<br />
·analizzare e commentare i testi in modo semplice in inglese dal punto di vista sia<br />
contenutistico sia formale;<br />
·contestualizzare il brano all'interno dell'opera, l'opera all'interno del periodo e del<br />
modulo tematico di appartenenza;<br />
·quando il brano e/o l'autore ne offrono lo spunto, stabilire gli opportuni collegamenti<br />
con altri autori all’interno del programma disciplinare;<br />
·esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e comprensibile;<br />
·comprendere globalmente messaggi orali autentici in L2 ;<br />
·interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti preparati in<br />
precedenza.<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI<br />
UNITÀ DIDATTICHE – MODULI – PERCORSO – ARGOMENTI<br />
· REVISIONE-PERFEZIONAMENTO LINGUISTICO<br />
Da materiali presentati dalla docente madrelingua Veronica Harkins<br />
· LETTERATURA<br />
Dal testo Making Waves, di G. Mistrulli, voll. 1 e 2, ed. Zanichelli, e da fotocopie fornite<br />
dalla docente, lettura e analisi di brani dai seguenti testi:<br />
Romantic Poetry<br />
1.J. Keats, La Belle Dame Sans Merci<br />
2.L’Eroe Byroniano (cenni)<br />
The Victorian Novel<br />
C. Dickens, Oliver Twist, Oliver Asks for More(visione di parte del film di R. Polanski)<br />
C. Dickens, Hard Times, Murdering the Innocents, Coketown<br />
Documento della classe III A
42<br />
E. Bronte, Wuthering Heights, I am Heathcliff!<br />
Victorian Drama<br />
1.O. Wilde, The Importance of Being Earnest (lettura dell’intero testo, visione del film<br />
di O. Parker)<br />
Modernism in Poetry:<br />
1.W. B. Yeats, The Second Coming<br />
2.E. L. Pound, In a Station of the Metro<br />
3.T. S. Eliot, The waste Land, part I, The Burial of the Dead<br />
Modernist Prose<br />
1.J. Joyce, Dubliners , Eveline, The Dead<br />
2. J. Joyce, Ulysses, Molly Bloom’s monologue<br />
3.V.Woolf, Mrs. Dalloway, Incipit (visione del film The Hours di S. Daldry, dal romanzo<br />
di M. Cunningham)<br />
The 30s in America<br />
1.J. Steinbeck, Of Mice and Men (lettura dell’intero testo, visione del film di G. Sinise)<br />
Post-War Literature<br />
1.G. Orwell, 1984, incipit<br />
Modern Drama<br />
1.S. Beckett, Waiting for Godot<br />
METODI<br />
Il metodo didattico si è ispirato all’approccio che parte dal testo per arrivare al contesto<br />
che lo ha prodotto. Le attività sono state finalizzate a mettere in grado lo studente di fare<br />
inferenze anche complesse sul testo. Si sono proposti testi di vario tipo e passi di autori<br />
che, per le tematiche analizzate, fossero significativi del periodo in cui operano.<br />
MEZZI<br />
Sono stati utilizzati documenti audio e video in lingua originale, e la lezione frontale ha<br />
avuto, di norma, carattere "interattivo", si è cercato cioè di costruirla attraverso le risposte<br />
degli allievi alle domande proposte dal testo o dalla docente dopo la lettura e l'analisi dei<br />
materiali (fatte in classe e/o a casa).<br />
OSSERVAZIONI<br />
La classe ha collaborato alle attività didattiche, offrendo talvolta spunti interessanti e<br />
applicandosi allo studio con sufficiente costanza, presentandosi puntualmente alle<br />
verifiche e alle lezioni e raggiungendo un profitto generalmente discreto.<br />
Venezia, 3 maggio 2012<br />
Antonella Antonelli<br />
Documento della classe III A
43<br />
<strong>Liceo</strong> Ginnasio “M.<strong>Foscarini</strong>”<br />
Anno Scolastico 2011-12<br />
Relazione finale sull’andamento della classe IIIA<br />
Discipline: Matematica e Fisica<br />
Prof. S.Morandini<br />
Metodo di lavoro:<br />
alla tradizionale lezione frontale si è intrecciato l’analisi di problemi e – per la matematica<br />
– lo svolgimento di esercizi, come pure l’attività di laboratorio (esperienze dimostrative<br />
per la fisica; attività degli studenti per informatica).<br />
Metodologie di verifica:<br />
·per la matematica sono state svolte tre verifiche scritte per quadrimestre, finalizzate<br />
soprattutto alla verifica della abilità applicative<br />
·le verifiche della conoscenza e della comprensione sono state affidate a verifiche orali<br />
come pure a test scritti<br />
·si è pure tenuto conto di quanto elaborato nelle simulazioni di III prova<br />
Livelli raggiunti<br />
Lo svolgimento del programma è stato regolare, anche se per la fisica sarebbe piaciuto<br />
poter approfondire meglio alcune aree; si è però preferito lavorare più ampiamente in<br />
matematica, per la quale la grande maggioranza gli studenti hanno mostrato maggiore<br />
interesse. La classe ha progressivamente maturato nel corso del triennio una sua positiva<br />
fisionomia di lavoro, caratterizzata da una positiva disponibilità all’interazione didattica e<br />
– per la gran parte degli studenti - ad uno studio serio e sistematico. Anche quell’irruenza<br />
un po’ infantile che caratterizzava alcuni studenti si è progressivamente trasformata in<br />
una simpatica curiosità nei confronti delle discipline, che per parecchi di essi si affianca ad<br />
una buona capacità di riflessione.<br />
I livelli raggiunti sono ovviamente differenziati, ma occorre in primo luogo segnalare la<br />
presenza di un consistente gruppo di studenti che ha raggiunto, specie per la matematica,<br />
un livello di competenza davvero notevole, che in alcuni casi raggiunge punte di<br />
eccellenza. Le buone capacità di base, coltivate con una seria applicazione, hanno portato<br />
tali studenti a livelli di conoscenza, di comprensione e di applicazione assai significativi.<br />
La presenza di tale primo gruppo ha avuto un effetto di traino e di supporto anche su altri<br />
studenti, meno dotati sul piano della capacità di base, ma disponibili ad uno studio serio e<br />
continuo, che ha permesso loro di raggiungere livelli sufficienti, discreti o anche più che<br />
discreti. Assai limitato è invece il numero degli studenti nei quali la discontinuità<br />
Documento della classe III A
44<br />
dell’impegno e la poca affezione alle discipline non hanno permesso il raggiungimento di<br />
una base di conoscenze pienamente adeguata.<br />
LICEO CLASSICO "M.FOSCARINI"<br />
Anno Scolastico 2010-2011<br />
Programma svolto di Matematica IIIA<br />
Prof. Simone Morandini<br />
1) Richiamo della nozione di funzione: dominio e codominio di una funzione; proprietà,<br />
grafici e valori notevoli delle funzioni elementari (polinomiali, algebriche, irrazionali,<br />
trigonometriche e trigonometriche inverse, esponenziale e logaritmo). Funzioni pari e<br />
dispari, limitate ed illimitate. Composizione di funzioni.<br />
2) Definizione di limite (vari casi), teoremi sui limiti: dei carabinieri, di una somma, di un<br />
prodotto, di un rapporto (gli ultimi due senza dimostrazione); risoluzione di forme<br />
indeterminate (∞-∞;∞/∞; 0/0). Limiti notevoli: sin(x)/x ; (ex – 1) /x; ln(1+x) /x; calcolo di<br />
limiti vari. Esercizi.<br />
3) Funzioni continue e tipi di discontinuità. Asintoti delle funzioni e relativi esercizi.<br />
4) Rapporto incrementale e definizione di derivata; derivata come coefficiente angolare<br />
della tangente al grafico. Derivate delle funzioni elementari. Derivata di una somma, di un<br />
prodotto, di un rapporto. Derivata di funzione composta e di funzione inversa.<br />
Derivazione di funzioni generiche. Teoremi di Rolle e Lagrange.<br />
5) Applicazioni del calcolo differenziale allo studio del grafico delle funzioni: minimi,<br />
massimi, flessi orizzontali e obliqui; crescenza e decrescenza; concavità e convessità.<br />
Cuspidi e flessi a tangente verticale. Tracciamento del grafico di una funzione e relativi<br />
esercizi.<br />
6) Nozioni di calcolo integrale: definizione di integrale definito, teorema fondamentale del<br />
calcolo integrale, integrali elementari. Integrazione per sostituzione, per parti, per<br />
scomposizione (semplici esempi ed esercizi). Integrali impropri.<br />
7) Geometria non-euclidea: il problema del V postulato in Euclide e negli autori successivi<br />
fino a Saccheri. La geometria di Lobacevskij e il modello di Klein. La geometria ellittica ed<br />
il modello di Riemann. Il rapporto tra geometria e fisica.<br />
Informatica<br />
1)Uso del programma Derive per Windows per lo studio delle funzioni e delle loro<br />
proprietà<br />
Documento della classe III A
45<br />
LICEO CLASSICO "M.<strong>Foscarini</strong>"<br />
Anno Scolastico 2011-2012<br />
Programma svolto di Fisica IIIA<br />
Prof.Simone Morandini<br />
1) Termodinamica: la nozione di temperatura e la sua misura attraverso la dilatazione<br />
termica. Scala Celsius e scala Kelvin. Nozione di calore e sua misura; caloria; capacità<br />
termiche e calori specifici; forme di propagazione del calore. L’effetto serra come<br />
problema termodinamico.<br />
Equazione di stato dei gas perfetti. Teoria cinetica dei gas e relazione tra temperatura ed<br />
energia cinetica; distribuzione di Maxwell-Boltzmann delle velocità molecolari in un gas<br />
(cenni).<br />
Dalla teoria del calorico all'equivalenza di calore ed energia: esperimento di Joule e I<br />
Principio della Termodinamica. Lavoro e flussi di calore nelle trasformazioni quasi<br />
statiche di un gas perfetto (diagramma p-v): isocore ed isobare; analisi qualitativa di<br />
isoterme e adiabatiche. L’espansione libera come esempio di trasformazione non quasi<br />
statica.<br />
Trasformazioni reversibili ed irreversibili; il II principio della termodinamica nelle sue<br />
due formulazioni con dimostrazione della loro equivalenza. Il ciclo di Carnot ed il<br />
rendimento delle macchine termiche. I tre tipi di moto perpetuo.<br />
Gli stati della materia e le loro proprietà; diagramma di stato di un gas reale,<br />
cambiamenti di stato e loro interpretazione in termini energetici: l'ebollizione dell'acqua.<br />
2) Onde e luce: definizioni e classificazioni. Onde sinusoidali: periodo, frequenza,<br />
lunghezza d'onda, velocità di propagazione. Principio di sovrapposizione. Fenomeni<br />
fondamentali di propagazione delle onde: riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza.<br />
Teoria corpuscolare e teoria ondulatoria nell'interpretazione della luce. Il problema del<br />
corpo nero e l’effetto fotoelettrico. Cenni al dualismo onda-corpuscolo nella fisica<br />
contemporanea.<br />
3) Elettrostatica: fenomeni elettrici elementari e forme di elettrizzazione; corpi isolanti e<br />
conduttori. Forza elettrica e legge di Coulomb. Principio di sovrapposizione. Unità di<br />
carica nel Sistema Internazionale.<br />
Definizione di campo elettrico; linee di campo: proprietà generali; immagine delle linee<br />
per alcuni semplici sistemi di cariche. Teorema di Gauss; campo all’esterno di una sera<br />
carica; campo di una lastra carica e di un condensatore a facce piane e parallele. Lavoro<br />
fatto dal campo elettrico e nozione di circuitazione; potenziale elettrico. Campo elettrico<br />
nei conduttori e negli isolanti.<br />
Documento della classe III A
46<br />
4) Corrente elettrica. Definizione; leggi di Ohm; resistenze in serie e in parallelo. Effetto<br />
Joule.<br />
5) Fenomeni magnetici Campo magnetico generato da correnti costanti e forze<br />
magnetiche. Cenni alle equazioni di Maxwell ed all’elettrodinamica; onde<br />
elettromagnetiche.<br />
docente: Caterina Rossi<br />
materia: Scienze<br />
classe: III A<br />
Relazione Finale<br />
a. s. 2011-2012<br />
Ho seguito la classe <strong>3A</strong> durante l’intero percorso della disciplina dalla prima alla<br />
terza liceo. Gli studenti si sono dimostrati interessati all’attività didattica, seguendo le<br />
lezioni con una partecipazione poco interattività, ad eccezione di alcuni studenti con<br />
vivace interesse per le scienze. Sollecitati a volgere attività di didattica sperimentale, ove<br />
viene richiesta una loro attiva partecipazione e un lavoro di gruppo, hanno, però,<br />
risposto bene con buoni-ottimi risultati, dimostrando buone capacità di organizzarsi e una<br />
buona creatività. Nel primo anno abbiamo progettato assieme alla docente d’inglese<br />
prof.ssa Antonella Antonelli un modulo CLIL “Chemical Bonding” trattando i legami<br />
chimici in inglese. Nella classe seconda abbiamo ripetuto l’esperienza trattando un<br />
modulo di biologia “Evolution from Monkey to Man”, trattando l’evoluzione degli<br />
organismi da un punto di vista storico con collegamenti con la letteratura inglese, Mary<br />
Shelley.<br />
Hanno tutti raggiunto gli obiettivi minimi della disciplina, un buon gruppo di<br />
studenti ha ottime capacità d’analisi e sintesi si è applicato con costanza dimostrando<br />
buon interesse per la disciplina. Per questi studenti lo studio è stato regolare e<br />
approfondito e i risultati raggiunti sono buoni-ottimi, per i primi,invece, lo studio<br />
incostante la scarsa motivazione la poca partecipazione ha consentito di raggiungere<br />
risultati solo sufficienti, pur se dotati di buone potenzialità.<br />
Un alunno ha evidenziato particolare interesse per la disciplina astronomia<br />
partecipando all’attività “Il cielo in laboratorio” presso il liceo Benedetti ed è stato<br />
selezionato per un’attività di stage all’Osservatorio Astronomico di Asiago.<br />
In prima e seconda abbiamo svolto anche un discreto numero di esperienze di<br />
laboratorio per sviluppare negli studenti la manualità, abituarli all’osservazione dei<br />
fenomeni, alla raccolta dei dati sperimentali e alla discussione dei risultati.<br />
Ho svolto l’intero programma preventivo.<br />
Documento della classe III A
47<br />
Programma svolto<br />
a. s. 2011-2012<br />
docente: Caterina Rossi classe: III A<br />
materia: Scienze testo: “Corso di Scienze del Cielo e della Terra” vol. A: T. Cavattoni :”Il<br />
cielo sopra di noi”, vol. B: A. Bosellini “La Terra dinamica” ed. Italo Bovolenta 2009.<br />
CAPITOLO 1A: Una messaggera dal cielo : la luce<br />
1.1 Un primo sguardo. 1.2 I colori della luce. 1.4 Misura della luce. 1.5 Analisi della luce. 1.6 Il<br />
modello del corpo nero (leggere). 1.7 I quanti di luce. 1.8 Il modello di Bohr. 1.10 Effetto Doppler.<br />
CAPITOLO 2A : La sfera celeste<br />
2.1 Un primo sguardo. 2.2 Circoli di riferimento. 2.3 Coordinate altazimutali (solo definizione di<br />
azimut e di altezza pag.28). 2.5 Coordinate equatoriali celesti. 2.8 Costellazioni e zodiaco.<br />
CAPITOLO 4A: Elementi di meccanica celeste<br />
4.4 Keplero e le sue leggi. 4.5 La legge di gravitazione universale. 4.10 La velocità di fuga (solo<br />
definizione). 4.11 Un sistema di tre corpi. 4.12 La precessione luni-solare. 4.13 La nutazione. 4.14 Le<br />
maree.<br />
CAPITOLO 5A: I moti del pianeta Terra<br />
5.1 La rotazione e le sue conseguenze. 5.2 Prove della rotazione della Terra (escluso le formule). 5.3<br />
La rivoluzione. 5.4 Stagioni astronomiche, solstizi ed equinozi. 5.8 Zone astronomiche. 5.10<br />
Parallasse annua e misura di distanze. 5.11 Moto della linea degli apsidi (cenni). 5.12 La<br />
precessione degli equinozi (cenni). 5.13 Moti millenari secondari (cenni). 5.14 Le glaciazioni.<br />
CAPITOLO 6A: La Luna<br />
6.1 Parametri principali. 6.5 Moto di rivoluzione. 6.6 Moto di traslazione. 6.7 Moto di rotazione.<br />
6.10 Le fasi lunari. 6.12 Le eclissi.<br />
CAPITOLO 7A: Il Sole<br />
7.1 Principali caratteristiche. 7.2 La struttura del Sole. 7.4 La fonte di energia del Sole. 7.5 L’attività<br />
del Sole (cenni). 7.6 Il ciclo del Sole (cenni).<br />
CAPITOLO 8A: La corte del Sole<br />
8.1 Un primo sguardo. 8.2 Nascita del sistema solare. 8.10 Asteroidi. 8.11 Pianeti nani e fascia di<br />
Kuiper. 8.12 Comete e nube di Oort. 8.13 Meteore, meteoroidi, meteoriti (cenni).<br />
CAPITOLO 9A: L’universo vicino<br />
9.1 Un primo sguardo alla Galassia. 9.2 Classificazione delle stelle. 9.3 Parametri fisici delle stelle:<br />
massa, luminosità, dimensione (escluso le formule). 9.4 Il diagramma H-R. 9.5 Evoluzione stellare.<br />
9.6 Ciò che resta di una stella. 9.8 Gli ammassi stellari.<br />
CAPITOLO 10A:L’universo lontano<br />
10.1 Solo pag.195 Struttura della Galassia e la materia mancante. 10.2 Galassie oltre la nostra. 10.3<br />
Gruppi di galassie. 10.5 La legge di Hubble e l’espansione dell’universo (escluso le formule). 10.6<br />
Documento della classe III A
48<br />
Origine dell’universo. 10.7 Conferme della teoria del big bang. 10.8 Ipotesi sul futuro (cenni).<br />
CAPITOLO 1B: La Terra: uno sguardo introduttivo<br />
1.3 Le scienze della Terra e il tempo geologico. 1.4 La Terra primordiale. 1.5 “Catastrofe del ferro” e<br />
differenziazione. 1.6 Zonazione chimica della Terra<br />
CAPITOLO 2B: La Terra solida: atomi, elementi, minerali e rocce<br />
2.1 Elementi e composti naturali. 2.2 i minerali. 2.3 La struttura cristallina dei minerali. 2.4 Fattori<br />
che influenzano la struttura dei cristalli. 2.5 Proprietà fisiche dei minerali (cenni). 2.6 Polimorfismo.<br />
2.7 Isomorfismo. 2.8 Criteri di classificazione dei minerali. 2.9 Classificazione dei silicati. 2.10<br />
silicati mafici e felsici. 2.11 Minerali non silicati (cenni). 2.12 Le rocce della crosta terrestre.2.13<br />
Come riconoscere le rocce. 2.14 Il ciclo litogenetico.<br />
CAPITOLO 3B: La Terra deformata: faglie, pieghe e altre strutture<br />
3.1 Le deformazioni delle rocce. 3.3 Come si deformano le rocce. 3.4 Fattori che influenzano le<br />
deformazioni delle rocce. 3.5 Deformazioni delle rocce e tempo. 3.6 Movimenti regionali della<br />
crosta terrestre. 3.7 Diaclasi e faglie (escluso pag.47). 3.8 Pieghe (escluso terminazioni periclinali,<br />
brachianticlinali e brachisinclinali)<br />
CAPITOLO 4B: I terremoti<br />
4.1 Il terremoto. 4.2 Comportamento elastico delle rocce. 4.3 Ciclicità statistica dei fenomeni<br />
sismici. 4.4 Onde sismiche. 4.5 La misura delle vibrazioni sismiche. 4.6 Determinazione<br />
dell’epicentro di un terremoto. 4.7 Dove avvengono i terremoti. 4.8 Energia dei terremoti (solo<br />
definizione di magnitudo) 4.9 Intensità dei terremoti. 4.12 La sismicità in Italia.<br />
CAPITOLO 5B: L’interno delle Terra<br />
5.1 La struttura stratificata della Terra. 5.2 Il calore interno della Terra (no meccanismi di<br />
formazione del calore interno). 5.3 Il nucleo. 5.4 Il mantello (escluso composizione del mantello).<br />
5.5 La crosta. 5.6 Campo e anomalie della gravità terrestre. 5.7 II principio dell’isostasia. 5.8 Il<br />
campo magnetico della Terra (escluso declinazione magnetica, inclinazione ed intensità). 5.9 Il<br />
paleomagnetismo. 5.10 Le inversioni di polarità. 5.11 Stratigrafia magnetica.<br />
CAPITOLO 9B: Dalla deriva dei continenti all’espansione dei fondi oceanici<br />
9.1 Catastrofismo e fissismo. 9.2 Mobilismo e deriva dei continenti. 9.3 Pangea. 9.4 Le prove a<br />
sostegno di Pangea. 9.5 Le dorsali medio-oceaniche. 9.6 Enunciazione dell’ipotesi dell’espansione<br />
del fondo oceanico. 9.9 Il meccanismo dell’espansione. 9.10 Le anomalie magnetiche dei fondi<br />
oceanici. 9.11 Il flusso di calore. 9.12 Età dei sedimenti oceanici. 9.14 Le faglie trasformi.<br />
CAPITOLO 10B: Tettonica delle placche e orogenesi<br />
10.1 Concetti generali e storia. 10.2 I margini delle placche. 10.3 Il mosaico globale. 10.4 Moto delle<br />
placche. 10.5 I tre tipi di margine. 10.6 Margini continentali passivi. 10.7 Margini continentali<br />
trasformi. 10.8 Margini continentali attivi. 10.9 Punti caldi. 10.12 Tettonica delle placche e<br />
orogenesi. 10.13 Modelli orogenetici. 10.14 La struttura dei continenti.<br />
Venezia, giugno 2012<br />
Documento della classe III A
49<br />
LICEO CLASSICO FOSCARINI VENEZIA<br />
RELAZIONE FINALE – STORIA DELL’ARTE<br />
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 CLASSE <strong>3A</strong><br />
PROF. GILBERTO GHERARDI<br />
Conoscenze:<br />
Più che discreta acquisizione dei contenuti delle lezioni.<br />
Competenze:<br />
Sono state raggiunte competenze linguistiche buone per leggere le differenze stilisticoformali<br />
delle varie aree artistico-culturali trattate. Nella quasi totalità la classe ha dato<br />
prova di buone capacità di rielaborazione con studi personali con punte ottime<br />
Impegno:<br />
Buono l’interesse per le tematiche proposte, ed altrettanto positiva la partecipazione al<br />
dialogo anche se limitata ad un gruppo di allievi.<br />
Criteri di valutazione:<br />
Considerata comunque positiva la preparazione strettamente scolastica, si è cercato di<br />
cogliere la crescita nelle capacità organizzative, nella ricerca curiosa e personale al di fuori<br />
degli schemi del testo. Una buona e corretta, fluida e pertinente espressività, un linguaggio<br />
tecnico-artistico hanno sicuramente influito nella valutazione finale.<br />
Metodi e strumenti:<br />
Uso di immagini (power point) improntate su schemi di percorsi da sviluppare ed<br />
ampliare ad opera dei singoli allievi. Importante la lettura del periodo artistico esaminato<br />
in un contesto letterario e storico.<br />
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:<br />
Una prova orale nel primo e nel secondo quadrimestre; due prove scritte nel primo e una<br />
nel secondo quadrimestre.<br />
Documento della classe III A
50<br />
Venezia, giugno 2012<br />
Gilberto Gherardi<br />
LICEO CLASSICO MARCO FOSCARINI VENEZIA<br />
PROGRAMMA - STORIA DELL’ARTE<br />
ANNO SCOLASTICO 2011/2012 CLASSE 3°A<br />
PROF. GILBERTO GHERARDI<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
------argomento<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
-------<br />
Neoclassicismo: generalità; Canova.<br />
Romanticismo: generalità; Gericault, Goya, Delacroix, Friedrich.<br />
Il paesaggio nell’arte di: Constable, Turner.<br />
La scuola di Barbizon: Corot.<br />
Il realismo: Courbet.<br />
L’impressionismo: le fonti, la prima mostra del 1874, i soggetti, i grandi protagonisti<br />
(Manet, Monet, Renoir, Degas, Pissarro).<br />
Il post-impressionismo: Seurat, Signac.<br />
Tre grandi personalità: Gauguin, Cezanne, Van Gogh.<br />
Il simbolismo: Munch.<br />
L’art nouveau: Horta, Van de Velde, Gaudì; la secessione viennese: Wagner, Klimt.<br />
I fauves: Matisse.<br />
Espressionismo e astrattismo: .Kirchner, Kandinsky, Mondrian.<br />
Il cubismo: .Picasso, Braque.<br />
Documento della classe III A
51<br />
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
-------<br />
Venezia, maggio 2012<br />
Gilberto Gherardi<br />
Docente: Ricciardi Salvatore<br />
Materia: EDUCAZIONE FISICA<br />
Classe: 3 A<br />
A.S. 2011/2012<br />
RELAZIONE FINALE<br />
CONOSCENZE<br />
•<br />
Conoscenza delle principali posture, di atteggiamenti e di gesti motori in genere e relativa<br />
terminologia specifica<br />
•<br />
Conoscenza di gesti motori complessi subordinati o meno all’uso di piccoli o grandi<br />
attrezzi e relativa terminologia specifica<br />
•<br />
Conoscenza di gesti tecnico-sportivi e relativa terminologia<br />
•<br />
Conoscenza dei principali meccanismi di allenamento in circuit-training<br />
COMPETENZE E CAPACITA’<br />
•<br />
Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori posseduti, integrati dalla<br />
consapevolezza delle proprie c apacità e dei propri limiti ( precisione<br />
nell’autovalutazione)<br />
•<br />
Autonomia nell’elaborazione di lavori individuali su consegne precise<br />
•<br />
Documento della classe III A
52<br />
Consolidamento della socialità e del senso civico espressi nel rispetto dell’altro e nella<br />
disponibilità nei confronti del gruppo (capacità di individuare aree di interesse comuni al<br />
gruppo classe, partecipazione attiva alla lezione con apporti personali)<br />
•<br />
Assimilazione e pratica di gesti sportivi individuali e di squadra<br />
•<br />
Assimilazione di alcuni principi teorici relativi alla fisiologia umana applicata al<br />
movimento (tecnica della respirazione e dinamica dello stretching)<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI<br />
UNITA’ DIDATTICHE – MODULI – PERCORSO- ARGOMENTI<br />
•<br />
Potenziamento generale con preatletica di base e circuit-training – ore 10<br />
•<br />
Corpo libero: esercizi da tutte le stazioni, esercizi individuali ed a coppie, esercizi di<br />
mobilità articolare e di potenziamento muscolare (conoscenza precisa del gesto e<br />
dell’efficacia sul corpo umano) – ore 8<br />
•<br />
Esercizi di stretching mirati dalle varie stazioni – ore 10<br />
•<br />
Uso di piccoli e di grandi attrezzi: spalliera, palla, palla medica, funicella, bacchetta<br />
(esercizi specifici e di riporto, individuali, a coppie ed in piccoli gruppi) – ore 10<br />
•<br />
Esercizi di respirazione controllata dalle stazioni sedute e supini – ore 4<br />
•<br />
Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio (in forma libera e con controllo della<br />
tecnica individuale e di squadra) ore 20<br />
METODI<br />
Tutti gli studenti sono stati sollecitati a verificare con costanza la possibilità di svolgere<br />
attività motoria o sportiva in relazione alle proprie capacità ed abilità. Pertanto i momenti<br />
dedicati al potenziamento generale, al corpo libero ed allo stretching sono sempre stati<br />
proposti a tutti, mentre si è lasciata libertà di scelta nello svolgimento delle pratiche<br />
tecnico-sportive.<br />
ATTIVITA’ SPORTIVE<br />
Molti gli studenti che hanno partecipato attivamente alle iniziative sportive interne ed<br />
esterne quali, calcio sia maschile che femminile,arrampicata sportiva, pallavolo, atletica.<br />
MEZZI<br />
•<br />
Utilizzo di tutti gli attrezzi disponibili<br />
Documento della classe III A
53<br />
•<br />
Utilizzo degli spazi all’aperto disponibili all’interno e nelle vicinanze dell’Istituto (campo<br />
di pallavolo, di calcio, strada circostante l’Istituto)<br />
•<br />
Utilizzo di filmati predisposti dalle case editrici relativi agli argomenti svolti<br />
•<br />
utilizzo di siti internet<br />
OSSERVAZIONI<br />
Classe molto numerosa che addensa alunni dotati di forti personalità. Molti gli studenti<br />
forniti di un bagaglio motorio - sportivo ben definito, a volte plasmato dalla disciplina<br />
praticata, ma disponibili alla continuità di impegno . Nel corso dell'anno la classe ha<br />
evidenziato un interesse e una partecipazione costante verso la materia che ha portato<br />
alcuni di loro ad ottenere buoni risultati a livello sportivo.<br />
Venezia 30 aprile 2012<br />
PROF. Magni Roberto<br />
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE<br />
Salvatore Ricciardi<br />
Classe: III A Materia: Religione Cattolica Anno scolastico 2011/2012<br />
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in<br />
termini di:<br />
LA CLASSE<br />
Gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione Cattolica sono stati dieci.<br />
La partecipazione al dialogo educativo è stata costante e positiva; l’interesse ai temi trattati<br />
è stato sempre lodevole; il dialogo educativo è stato sempre pertinente e rispettoso, sincero<br />
e aperto. Gli allievi hanno mantenuto un comportamento corretto e favorevole all’ascolto,<br />
al dibattito e al confronto.<br />
CONOSCENZE<br />
L’insegnamento della religione cattolica concorre a promuovere il pieno sviluppo della<br />
personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e capacità<br />
Documento della classe III A
54<br />
critiche: concorre a promuovere l’acquisizione della cultura e delle attitudini religiose,<br />
mettendo al centro la capacità della persona di rapportarsi col suo destino, col prossimo,<br />
con il mondo e i suoi problemi e favorisce l’apertura al patrimonio storico del nostro Paese<br />
e alla realtà presente.<br />
Gli allievi hanno acquisito mediamente una buona conoscenza di alcuni contenuti del<br />
Cattolicesimo (in rapporto all’etica e alla dimensione esistenziale, al paragone con<br />
l’immagine di Dio e con l’esperienza pasquale dei discepoli, alla conoscenza di alcuni<br />
elementi presenti nei documenti della Chiesa di oggi), e di alcune tra le espressioni più<br />
significative della sua vita.<br />
COMPETENZE<br />
Gli allievi sono in grado di accostare in maniera adeguata la Bibbia e di coglierne il<br />
messaggio umano e religioso; sanno confrontarsi con alcuni aspetti della dottrina sociale<br />
della Chiesa che si riferiscono al problema della giustizia, della solidarietà e del valore<br />
della vita affettiva e relazionale. Sono in grado di individuare diverse forme di linguaggio<br />
religioso (simboliche, artistiche, letterarie e sociali).<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI<br />
Importanza delle buone relazioni sia a scuola che nel mondo intero.<br />
La storia dei Freedom Writers, le problematiche vissute all’interno delle aule scolastiche e<br />
la classe come laboratorio sociale.<br />
Il problema dell’integrazione razziale e il suo superamento; il problema della difficile<br />
realtà lavorativa che costringe a rivedere le proprie aspettative.<br />
L’importanza di un contesto religioso e sociale in cui affrontare con positività i disagi<br />
personali e sociali.<br />
Gli obiettivi personali di breve e lungo termine; la scoperta di cose, realtà e persone a cui si<br />
è affezionati; ciò che ci rende unici; gli ideali che guidano la propria esistenza.<br />
L’unicità di ogni singola persona. Storie di riscatto sociale e personale attraverso i racconti<br />
dei ragazzi.<br />
L’importanza della solidarietà e l’impegno personale in qualche forma di attività di<br />
volontariato.<br />
Il significato del Natale e la solidarietà.<br />
Il giorno della memoria, del genocidio. La bellezza possibile anche nelle condizioni meno<br />
probabili.<br />
La storia di Martin Luther King. Alcuni discorsi di Martin Luther King, la loro attualità e<br />
la loro importanza storica e religiosa. Il rifiuto di qualunque forma di totalitarismo.<br />
Il significato della Pasqua e il suo messaggio per il nostro presente.<br />
Le povertà di cui soffre il mondo.<br />
Il limite e la diversità come risorsa e non come limite.<br />
Il messaggio di Giovanni Paolo II contenuto nella “Lettera alle donne”.<br />
L’importanza del “genio femminile” per il futuro e la rinascita del mondo intero; il<br />
contributo della donna per l’umanizzazione del mondo e della società, nonostante in molti<br />
casi la donna sia ancora soggetta a condizioni di svantaggio rispetto agli uomini.<br />
Documento della classe III A
55<br />
La “Gudium et Spes” e l’analisi dei problemi del mondo.<br />
Il mistero della vita umana, colta fin dal suo nascere.<br />
Alcuni documenti della Chiesa sulla dottrina sociale della Chiesa.<br />
Bellezza e crescita della dimensione affettiva.<br />
Alcuni dei temi morali maggiormente dibattuti nell’oggi.<br />
METODOLOGIA<br />
La programmazione è stata attuata tenendo presenti le esigenze e le caratteristiche degli<br />
allievi, e degli approcci diversi nonché dei contributi offerti dalle altre discipline di<br />
insegnamento.<br />
Nel rispetto della natura, finalità, obiettivi, contenuti dell’insegnamento della religione<br />
Cattolica, si sono attuati modelli che hanno tenuto conto di prospettive diverse ed insieme<br />
complementari: la prospettiva biblica, teologica, antropologica, storico-artistica e culturale.<br />
I contenuti sono stati svolti prediligendo la forma del “laboratorio” alla lezione frontale e<br />
sono stati approfonditi con attenzione ai processi di crescita, di maturazione e alle<br />
esigenze dei singoli allievi; ai quali è stata offerta, attraverso il dialogo educativo in classe,<br />
la possibilità di confrontarsi, di paragonare le loro conoscenze con la realtà che<br />
incontravano per approfondire le conoscenze personali e discutere eventuali pre-giudizi o<br />
luoghi comuni. Nello sviluppo delle tematiche e dei contenuti sono state particolarmente<br />
sottolineate la sensibilità e l’attenzione verso la bellezza non effimera e verso i più deboli e<br />
gli svantaggiati.<br />
MATERIALI DIDATTICI<br />
Nel processo didattico sono state avviate molteplici attività: abbiamo utilizzato e<br />
predisposto alcune schede tematiche, sono stati usati mezzi audiovisivi e si sono reperiti e<br />
utilizzati vari documenti (biblici, letterari e culturali), per stimolare la partecipazione<br />
attiva degli allievi. Sono state svolte attività pratiche per rendere significativi gli<br />
appuntamenti importanti dell’anno, così da sottrarre il Natale e la Pasqua alla<br />
mercificazione del consumismo moderno e per far crescere il senso di solidarietà che ci<br />
lega al prossimo e ci rende partecipi attivi del destino del mondo.<br />
Grazie a queste attività si è arrivati a confrontare diverse tendenze, atteggiamenti e sistemi<br />
di significato religiosi e non religiosi.<br />
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTULIZZATE<br />
Per verificare il grado di apprendimento degli allievi, le loro capacità di analisi e sintesi<br />
sono stati considerati il dialogo educativo in classe, l’interesse, la partecipazione e la<br />
creatività personale durante l’approfondimento delle tematiche del corso.<br />
Venezia, 30 aprile 2012! IL DOCENTE<br />
! Prof. Magni Roberto<br />
Documento della classe III A
56<br />
ALLEGATO<br />
19 NOVEMBRE 2011<br />
Scienze Fisica Inglese Filosofia Greco<br />
QUESITI DELLE SIMULAZIONI DELLE TERZE PROVE<br />
(risposte di max. 10 righe/quesito)<br />
Scienze<br />
1)Come si determina la posizione di un oggetto sulla sfera celeste?<br />
2)Illustra il fenomeno della precessione luni-solare<br />
Fisica<br />
1)Descrivere il fenomeno della rifrazione in 2 dimensioni (eventuali disegni sul retro)<br />
2) Illustrare il fenomeno dell’effetto fotoelettrico e l’interpretazione offertane da<br />
A.Einstein.<br />
Inglese<br />
1) In Oliver Twist Dickens criticizes the attitude of the Victorian ruling class to the<br />
poor. Refer to the text you read to justify this statement in no more than 10 lines.<br />
2) Comment on the description of Coketown given by Dickens in Chapter V of Hard<br />
Times. Use no more than 10 lines.<br />
Filosofia<br />
1) Il concetto di Volk nel romanticismo<br />
2)“L’uomo è un dio quando sogna, un mendicante quando pensa” (Holderlin)<br />
Greco<br />
1) Le interpretazioni del tragico di Hegel, Schopenhauer, Nietzsche e Freud.<br />
2)Tipologie e modalità di svolgimento dei processi nell’Atene del quinto secolo.<br />
12 APRILE 2012<br />
Latino inglese filosofia arte matematica<br />
Latino<br />
1) Lo stile di Tacito si contraddistingue per l’inconcinnitas: spiega in cosa essa consista sul<br />
piano formale e descrivi gli effetti che essa suscita nel lettore<br />
Documento della classe III A
57<br />
2)Gli epigrammi di Marziale costituiscono un documento prezioso per la ricostruzione<br />
storica dell'età imperiale: descrivine forme e temi.<br />
Inglese<br />
1)Describe the most important elements (literary, musical and artistic trends, discoveries<br />
and historical events) which contributed to the modernist revolution. (10 lines)<br />
2)Comment on modernity and tradition in Pound’s In A Station of the Metro. (10 lines)<br />
Filosofia<br />
1) Intelletto e ragione in Kant<br />
2)Intelletto e ragione in Hegel<br />
Storia dell’arte<br />
1) Il nuovo linguaggio impressionista<br />
2) La ricerca plastico- strutturale in Cezanne<br />
Matematica<br />
1)Presentare criticamente i risultati di Saccheri nella dimostrazione del V postulato di<br />
Euclide.<br />
2)Presentare le linee fondamentali della geometria di Lobacevskji soffermandosi<br />
sull’angolo di parallelismo e le sue proprietà<br />
Documento della classe III A
58<br />
Firma dei docenti<br />
Antonella ANTONELLI inglese _______________________<br />
Emanuela CRISPILLI greco! _______________________<br />
Susanna! FORT!! storia-filosofia _______________________<br />
Gilberto GHERARDI ! storia dell’arte _______________________<br />
Roberto ! MAGNI !religione _______________________<br />
Michela MAZZONI italiano- latino _______________________<br />
Simone MORANDINI matematica-fisica _______________________<br />
Caterina! ROSSI scienze _______________________<br />
Salvatore! RICCIARDI! educazione fisica _______________________<br />
Documento della classe III A
59<br />
Documento della classe III A
60<br />
! ! ! ! ! ! !<br />
Documento della classe III A<br />
I