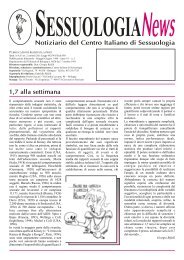Uno scandalo dell'alto medioevo - CIS
Uno scandalo dell'alto medioevo - CIS
Uno scandalo dell'alto medioevo - CIS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Riv. Sessuol. - Vol. 34 - n. 1/2<br />
Gennaio/Giugno 2010<br />
<strong>Uno</strong> <strong>scandalo</strong> <strong>dell'alto</strong> medio evo: la papessa Giovanna.<br />
Problematiche sessuologiche, storiografiche e simbologia<br />
tra realtà e leggenda<br />
F. MASELLIS*<br />
Premessa<br />
Il presente contributo, che nella parte «storica» sostanzialmente<br />
rispolvera fatti, scritti, studi già noti di altri (per<br />
i più recenti AA. italiani v. D’Onofrio 1979, Rendina 1994,<br />
Spadanuda 1996, et al.) 1 potrebbe sembrare apparentemente<br />
non essere di grande interesse per chi si occupa di sessuologia.<br />
Tuttavia esso può anzitutto evidenziare cosa possa comportare<br />
un approccio ses suologico multidisciplinare (ed esemplificare<br />
quindi tutta l’ampiezza della sessuologia, non restringibile<br />
alla sola sessuologia clinica) ed anche sotto l’aspetto<br />
clinico può offrire spunti notevoli nel momento in cui sono<br />
all’ordine del giorno le ambiguità di genere, i mutamenti di<br />
sesso - anagrafici e non. In definitiva, al di là di una opportuna<br />
rivisitazione con gli strumenti tecnici degli storici, ci si<br />
chiede se e come una problematica riconducibile ad una qualche<br />
«anomalia» biopsicologica potrebbe contribuire a chiarire<br />
l’evento di un pontefice uomo-donna. Se tale persona<br />
è (o fosse?) veramente esistita.<br />
La «narrazione del fatto»<br />
Si narra che nel secolo IX d.C. nacque in terra tedesca,<br />
a Magonza, una bambina di stirpe inglese e che una<br />
volta raggiunta la giovinezza essa, sedotta da un giovane<br />
amante, fuggisse con lui, vestita da uomo, in Grecia dove<br />
sog giornò a lungo in Atene frequentando, sempre in abiti<br />
maschili, circoli culturali tanto da diventare straordinariamente<br />
dotta (primo dato «anomalo», in ottica storica:<br />
all’epoca il centro culturale era a Bisanzio non ad Atene).<br />
Dopo qualche anno, abbandonato l’amante (o morto<br />
questi) e sempre ritenuta uomo (sarebbe stata conosciuta<br />
con il nome di Giovanni Anglico), si trasferì a Roma presso<br />
la corte pontificia. Qui fece carriera (forse notaio di curia,<br />
forse cardinale) per la sua «vita esemplare» e per la sua<br />
«scienza», tanto che tenendo lezioni nelle «arti del Trivio»<br />
perfino maestri ben noti come tali si fecero suoi «allievi».<br />
Per tale fama e doti nell’anno 855, morto papa Leone IV,<br />
Giovanni Anglico venne eletto papa.<br />
Il papato di tale Giovanni, che secondo la maggioranza<br />
dei narratori avrebbe assunto il nome di Giovanni VIII (secondo<br />
pochi altri Giovanni VII 2 ), durò brevemente: 3 anni<br />
e 5 mesi per qualcuno, 2 anni l mese e 4 giorni secondo<br />
la versione più frequente (altre cronache minoritarie<br />
portano cifre ancora diverse: 2 anni e 6 mesi, 2 anni 7 mesi<br />
e 4 giorni ... ). La ragione della brusca fine del pontificato<br />
fu che il papa-papessa dette alla luce un figlio con grande<br />
meraviglia, <strong>scandalo</strong>, ed esecrazione, nel bel mezzo di<br />
un corteo a cavallo, o processione, lungo il tratto di strada<br />
- tuttora esistente nella Roma di oggi - compreso tra la<br />
zona della basilica di S. Giovanni in Laterano ed il Colosseo,<br />
* Centro Italiano di Sessuologia - Scuola C.I.S. per l'educazione, la consulenza e la terapia sessuale - Roma<br />
1 La bibliografia relativa alle fonti e comunque alle opere risalenti al Medioevo ed epoche successive, non è citata per esteso nelle «note<br />
bibliografiche» del presente lavoro; per i dati relativi fare riferimento ai seguenti AA. (ivi citati): D'Onofrio (1979), Rendina (1994) e Spadanuda<br />
(1996)<br />
2 Il numero ordinale VIII accanto al supposto papa-papessa Giovanni compare per la prima volta nel 1313 nella Historia Ecclesiastica del<br />
domenicano lucchese Domenico Fidoni; esso non deve essere confuso con la denominazione del pontefice «ufficiale» Giovanni VIII registrato come<br />
tale nella serie dei pontefici romani in epoca posteriore a quella qui considerata, e regnante per 10 anni dal dicembre 872 al dicembre 882 (cfr., «I<br />
Papi e gli Antipapi» 1984). Il numero ordinale VII, in relazione alla papessa Giovanna, è riferito dal Platina; il pontefice «ufficialmente» annoverato<br />
con tale nome regnò invece dal 705 al 707 d.C.; per 2 anni, 7 mesi, e 17 giorni; ed era un greco. Banali coincidenze?<br />
© Copyright 2010<br />
CIC Edizioni Internazionali, Roma<br />
C.I.S. - Centro Italiano di Sessuologia<br />
93
più precisamente nei pressi della basilica di S. Clemente.<br />
Ovviamente la gravidanza e lo stesso sesso femminile<br />
della papessa erano del tutto ignoti al popolo, alla Chiesa,<br />
alla curia, ma di fatto costei aveva trovato un nuovo<br />
amante tra i «famigli» della sua corte con cui si dice avesse<br />
continui «scambi carnali». Difficilmente la gravidanza<br />
poteva essere ignota alla stessa papessa ma il parto stesso<br />
dovette essere almeno imprevisto e «precipitoso» per verificarsi<br />
in simili circostanze. Su quello che accadde immediatamente<br />
dopo a madre e figlio si narrano versioni diverse,<br />
dalla morte in loco di entrambi poi sepolti senza onoranze<br />
(Platina), alla lapidazione della papessa, sia in loco<br />
(Giovanni di Mailly) che poco fuori Roma (Stefano di Borbone),<br />
alla segregazione monacale della stessa che poi visse<br />
abbastanza a lungo da vedere il figlio addirittura vescovo<br />
di Ostia (Martino Polono in una IIa versione).<br />
La narrazione prosegue allargandosi alle conseguenze<br />
che si produssero nella prassi curiale a causa del trauma<br />
e dello scalpore, sia del parto sacrilego che del fatto stesso<br />
che sul soglio di Pietro fosse stata posta una donna. Una<br />
prima conseguenza fu che, da quel momento in poi, il tratto<br />
di strada ove era accaduto l’evento, fu interdetto al percorso<br />
delle processioni e dei cortei papali. Nel secolo IX<br />
questo era un percorso di grande importanza, la cosiddetta<br />
Fig. 1 - Il parto della Papessa in una antica stampa.<br />
94<br />
F. Masellis<br />
«via pontificalis», che il pontefice, il clero e la corte percorrevano<br />
in forma solenne quando il papa doveva recarsi<br />
al Laterano in occasioni importanti e specialmente per la<br />
«presa di possesso» della Basilica (a quell’epoca ancora centro<br />
della cristianità). Narrano dunque le cronache, che da<br />
quel momento in poi processioni e cortei nei pressi della<br />
basilica di S. Clemente venivano fatti deviare per evitare<br />
il «vicus papisse», sede del misfatto. Una seconda conseguenza<br />
avrebbe portato (sempre secondo la narrazione)<br />
all’adozione di misure di accertamento del sesso maschile<br />
nel pontefice neo-elet to volte ad evitare che si ripetesse<br />
l’evento di un papa-femmina. Tradizional mente nota,<br />
tale prassi è tutt’oggi ancor più popolare della stessa conoscenza<br />
che vi sia stata una papessa Giovanna: prima della<br />
definitiva consacrazione pontificale il neo eletto doveva<br />
sedersi su di una sedia forata ed appunto attraverso tale<br />
foro un apposito incaricato doveva accertare, palpatoriamente,<br />
l’esistenza di testicoli. Il minuzioso rituale sembra<br />
che prescrivesse che l’ope razione dovesse essere compiuta<br />
«dal più giovane» (perché tale requisito?) dei cardinali diaconi<br />
il quale poi doveva annunciare a voce alta: «Habet<br />
testiculos!» (oppure, secondo altri, «Habet! Habet!»<br />
oppure ancora «Duos sunt et bene pendentes!»; a cui seguiva<br />
un rituale e corale «Deo gratias»).
<strong>Uno</strong> <strong>scandalo</strong> <strong>dell'alto</strong> medio evo: la papessa giovanna. Problematiche sessuologiche, storiografiche e simbologia tra realtà e leggenda<br />
Fin qui la «narrazione» nei suoi elementi essenziali. Vi<br />
sono inoltre parti colari accessori di vario tipo: esoterici relativamente<br />
a misteriose iscrizioni; artistici ed archeologici<br />
e riferiti a una «memoria»-«sacello» o edicola posta nel luogo<br />
del parto 3 . Essi sono di poco significato in questa sede<br />
e per i nostri interessi.<br />
La costruzione della narrazione<br />
tra storia e leggenda<br />
Riferimenti ad una critica storica relativa alla autenticità<br />
degli eventi sopra descritti e che finora abbiamo detto<br />
essere stati «narrati» saranno fatti più avanti. Ma prima<br />
di procedere oltre è necessaria, comunque, una ricostruzione<br />
quanto meno cronologica di come l’intera narrazione<br />
si sia strutturata. In quanto la stessa, nel suo complesso<br />
totale, è soprattutto una «costruzione derivante da<br />
più narrazioni».<br />
La prima cosa da tenere presente è che si tratta di avvenimenti<br />
narrati come avvenuti intorno alla metà dell’anno<br />
800 d.C. Tuttavia la più antica notizia relativa ai fatti narrati<br />
è databile soltanto 200 anni più tardi, nel 1080 nel Chronicon<br />
ad opera di un teologo benedettino Mariano (detto<br />
Mariano Scoto, dal suo paese di origine); sono soltanto<br />
due righe per dire che al papa Leone IV «successe una<br />
donna per due anni, cinque mesi, e quattro giorni». Seguono,<br />
cronologicamente, altri due benedettini, il francese<br />
Sigeberto di Gembloux (Chronographia, circa 1100) e Goffredo<br />
da Viter bo (Pantheon, circa 1185), poi un domenicano<br />
francese Jean de Mailly (Chronica universalis, circa<br />
1225), che scrive che il dato è da verificare, ed ancora altri<br />
domenicani (Etienne - cioè Stefano - de Bourbon, circa<br />
1260 e Martino Polono, 1277, cardinale curiale); i quali<br />
tutti, di volta in volta, aggiungono qualche dato o frase<br />
alla «narrazione». Martino Polono è tappa storica di rilievo<br />
(ma siamo già a 400 anni dal «fatto»), sia per la sua «posizione<br />
curiale», sia perché è la fonte più antica che localizza<br />
precisamente il luogo dell’«evento» ed il primo a dire<br />
delle successive deviazioni di percorso dei cortei pontifici.<br />
Lo sovrasta poi, per importanza storica e di posizione,<br />
un bibliotecario vaticano detto «il Platina», che parla della<br />
papessa con l’«ufficialità» delle sue Vitae pontificum romanorum<br />
scritte per incarico di Sisto IV(Venezia 1475);<br />
e siamo ormai quasi a 700 anni dal fatto. Da notare, tuttavia,<br />
che questi «storici» (o meglio, redattori di cronache)<br />
fin qui citati usano ancora e sempre nel loro linguaggio mol-<br />
ta cautela, con espressioni costanti del tipo: «a quanto si<br />
dice ... o si narra ... » «alcuni scrivono ... » «da autori incerti<br />
si ... » ecc.<br />
Nel frattempo si sono aggiunte altre narrazioni. Ad<br />
esempio Petrarca nomina un Giovanni d’Anglia papa come<br />
presente a Roma a metà 800 con un suo amatore (poi scoperto<br />
con grande scalpore); si noti: Giovanni e non Giovanna,<br />
e soprattutto Boccaccio parla della papessa Giovanna<br />
È il Boccac cio non novellistico ma serioso (De Mulieribus<br />
Claris della metà del 1300); egli fornisce a tale «equivoca»<br />
persona il nome personale originario, ed è un nome<br />
maschile, Gilberto; non la fa passare dalla Grecia bensì dall’Inghilterra<br />
ove le fa morire il primo amante e da lì a Roma;<br />
inoltre dice che successe a Leone V 4 . La narrazione del Boccaccio<br />
non va oltre al «fatto» e non contiene nessun accenno<br />
ai suoi «postumi» (deviazioni dell’itinerario percorso<br />
dai papi, sedie ecc.). ma all’epoca compaiono anche iconografie<br />
della papessa e la sua descrizione appare in «guide<br />
turistiche» (cioè libretti per pellegrini ... ) dell’epoca.<br />
La prima menzione della sedia forata per «indagare se il<br />
papa sia maschio» ed anche la sua connessione con la vicenda<br />
della papessa appare nel 1295 ad opera di un benedettino<br />
francese, Goffredo di Courlon (ma anche qui con<br />
la cautela del «si narra» o simile espressione). Delle sedie<br />
par lano anche i Mirabilia trecenteschi (le «guide turistiche<br />
dei pellegrini a Roma») ma c’è anche con una certa confusione<br />
a causa dell’esistenza anche di tutt’altro tipo di «sedia»,<br />
una rituale sedia stercoraria (per la funzione della quale<br />
nel rituale pontificale medievale v. D’Onofrio, 1979).<br />
È comunque evidente che l’intera narrazione può essere<br />
considerata com pletata in tutti i suoi elementi, così<br />
come sopra riportata, solo nel secolo che va dalla metà del<br />
‘300 alla metà del ‘400. Dopo di che si seguita a parlarne<br />
e scriverne successivamente; finché dopo ancora un secolo<br />
la materia diviene rovente polemica ad opera dei luterani<br />
transfughi dalla chiesa cattolica e viene usata contro di<br />
questa. La chiesa romana, allora, si difende e non accettando<br />
più quanto, bene o male, i suoi stessi cronisti avevano<br />
«riportato», dà inizio a quella critica storica che solo<br />
oggi sembra aver lasciato la polemica per farsi documentale.<br />
Ma ciò non ci interessa.<br />
Resta invece interessante l’ipotesi che si sia trattato non<br />
di un fatto avvenuto, così come completamente descritto<br />
dal Platina, dal Boccaccio, e da Martino Polono ma di una<br />
progressiva costruzione di esso per apposizione di elementi,<br />
in parte anche realmente e storicamente avvenuti, su di un<br />
primo nucleo originario di «si dice» attorno ad una donna,<br />
una femmina maschil mente usurpatrice di poteri (in-<br />
3 Una edicola medioevale mal conservata e di dubbia interpretazione è tuttora presente in loco e precisamente all'incrocio tra v. dei Querceti e v.<br />
dei Santi Quattro, di fronte a S. Clemente.<br />
4 Errore evidente perché non solo ci si sposterebbe di almeno 50 anni più tardi ma perché tale pontificato è ben altrimenti noto per vicende truci<br />
a tre tra lo stesso Leone V, tale Cristoforo e papa Sergio III; che a quanto pare, il Leone V fece uccidere entrambi.<br />
95
teressante è la rilettura in chiave di «potere» anziché di «sacrilegio»)<br />
fantasticata in una sorta di saga o leggenda popolaresca.<br />
Allora una papessa Giovanna che nasce come<br />
(e non si sa quanto per) leggenda? Oppure si tratta di un<br />
consistente nucleo di fatti realmente accaduti? Ed allora<br />
fatti di qual genere? Indubbia connotazione «sessuologica»<br />
di tipo «patologico», bio-psicologico; o di tipo sociopolitico-culturale?<br />
E ci si può anche chiedere allora quale<br />
idea della donna in qualche modo «sessuologicamente<br />
rivoluzionaria» potesse essere possibile nell’Alto Medioevo,<br />
in modo tale da rendere possibile ed alimentare<br />
il sorgere di una «leggenda», rivendicativa o dissacrante<br />
che fosse. Ed anche tale argomento sarebbe certamente di<br />
un certo interesse sessuologico.<br />
Le possibili ipotesi di una «patologia»<br />
sessuale: fènotipo e comportamento<br />
della «papessa»<br />
Le moderne conoscenze scientifiche nell’ambito della<br />
sessuologia clinica rendono possibile un approccio alla<br />
specifica fattispecie dell’argomento qui considerato. I fatti<br />
narrati potrebbero perciò essere leggibili in termini diversi<br />
da quanto la ricerca storica, quella religiosa e l’ecclesiologia,<br />
o la enciclopedica cultura dei c.d. «romanisti»,<br />
hanno già fatto. E senza nulla togliere alle loro rispettive<br />
competenze che anzi, nell’ambito di un approccio<br />
multidisciplinare, potrebbero risultare tuttavia prioritarie<br />
poiché la fattispecie evidentemente non può giovarsi,<br />
a distanza di tanti secoli, di «accertamenti sessuologici<br />
oggettivi», in senso proprio, ma solo di «ricostruzioni<br />
critiche» 5 .<br />
È evidente che nella materia qui considerata è indispensabile<br />
allo studioso della sessualità umana un presupposto<br />
di partenza: «in una data epoca storica vi fu una<br />
donna che fu ritenuta un uomo e come tale si comportò<br />
in base ai codici socio-culturali-religiosi allora ammessi,<br />
fino ad assurgere ad essere eletta pontefice della Chiesa<br />
Cattolica, ma che poi - essendo biologicamente donna -<br />
partorì un figlio. e tutto ciò è veramente accaduto così».<br />
La non scientifica «presunzione di realtà» del fatto fa dunque<br />
parte della premessa «scientifica» della sua discussione.<br />
Ciò posto possiamo passare alle ipotesi possibili relative<br />
al caso di una donna erroneamente ritenuta uomo fino<br />
ad essere proclamata «papa».<br />
96<br />
F. Masellis<br />
a) Ipotesi relative ad una anomalia organico-biologica<br />
Possono riassumersi nell’enunciato generale di una anomalia<br />
o anatomica o funzionale secondo cui un «aspetto»<br />
(fenotipo) somatico potrebbe aver indotto in errore chi doveva<br />
valutare l’appartenenza di genere di un soggetto.<br />
a 1) In termini anatomici genitali si potrebbe trattare<br />
di un ermafroditismo vero (compresenza di gonadi miste<br />
e/o ambigue maschili/femminili) o di pseudoermafroditismo<br />
(in cui un sesso gonadica mente inequivocabile, viene<br />
presunto di sesso opposto in base a caratteri accessori<br />
(struttura di geni tali esterni, eccetera).<br />
a 2) In termini anatomofunzionali più complessi oggi<br />
si conoscono anche altre situazioni in cui pur non essendovi<br />
una fondamentale alterazione strutturale degli organi<br />
genitali, ad essere alterato per una precisa ano malia biologica<br />
è il complesso giuoco biochimico in cui essi (e la loro<br />
funzione) vengono coinvolti. Si tratta di alterazioni nella<br />
increzione degli ormoni sessuali, o nella loro recezione a<br />
carico di effettori periferici (come nel c.d. «testicolo femminilizzante»<br />
- sindrome di Morris), o in una alterazione<br />
del loro utilizzo neurologico encefalico (ad. es. per deficit<br />
di enzimi, quale la aromatasi indispensabile in sede cerebrale<br />
al metabolismo testoste ronico) che potrebbe avere<br />
effetti anche a livello comportamentale, o ancora in alterazioni<br />
di neuromodulatori più che di ormoni, e questi<br />
ad impatto certamente più comportamentale che somatico.<br />
A quanto si sa tutte queste varie patologie nel loro complesso<br />
e prevalenza sembrano modificare più la mascolinità<br />
in senso femminilizzante che non viceversa, e quindi<br />
non si adatterebbero affatto al nostro caso. Con l’unica eccezione<br />
di sindromi altamente virilizzanti un soma biologicamente<br />
femminile. Ad esempio la sindrome surrenogenitale,<br />
in cui vi è un’iperincrezione di androgeni, la sindrome<br />
surreno-ipofisaria di Cushing (che ha ben altra dimensione<br />
di patologia fisica a tutto campo), i tumori ovarici<br />
testosterone-secernenti. Tutte queste patologie «serie/gravi»<br />
non sono peraltro confondibili con il semplice<br />
irsutismo-virilismo pilare in cui è pur sempre evidente il<br />
soma di tipo femminile.<br />
E per finire, tuttavia come argomento cardine, ogni grave<br />
patologia orga nica di tipo sessuale, vuoi strettamente<br />
anatomica che biochimico-funzionale, anche quando permettesse<br />
una attività copulatoria (anzi ne esaltasse per effetto<br />
erotizzante biochimico i relativi impulsi e comportamenti)<br />
implica ben presto anche la soppressione della attività<br />
ovarica-riproduttiva fisiologicamente espletabile.<br />
Non si vede quindi come tutto il capitolo di anomalie<br />
5 In termini popperiani il nostro tentativo di approccio interdisciplinate sarebbe quindi del tutto «invalido» in quando mancano addirittura i presupposti<br />
di una possibile «invalidabilità scientifica» di quadro prospettato. Ma proprio perché Popper insegna che più che una ipotetica certezza<br />
«scientifìca» vale un qualche rigore metodologico, non si vede perché la metodologia di un approccio (ad es. quello oggettivo delle scienze c.d. esatte<br />
e/o sperimentali) debba prevalere su quella di un altro (ad es. quello delle c.d. scienze storiche e/o morali), e autenticarlo. O viceversa!
<strong>Uno</strong> <strong>scandalo</strong> <strong>dell'alto</strong> medio evo: la papessa giovanna. Problematiche sessuologiche, storiografiche e simbologia tra realtà e leggenda<br />
organicistiche della sessualità possa adattarsi ad un uomo<br />
«falso» e donna tanto «vera», biologicamente parlando,<br />
da condurre una gravidanza a termine. A meno di considerare<br />
«vera» la narrazione della presunta papessa fino alla<br />
sua vicenda ostetrica mentre questa soltanto sarebbe viceversa<br />
un falso. Ma evidentemente ciò non sembra metodologicamente<br />
giustificabile. Non si vede cioè perché solo<br />
sull’evento gravidico, ed in base a quali argomentazioni e<br />
prove storiche (non biologiche), possa sostenersi la dicotomica<br />
valutazione di parte vero/parte falso in ciò che viene<br />
narrato.<br />
b) Ipotesi relative ad una problematica di tipo psico-sessuale<br />
e comportamentale.<br />
Il campo relativo sembra restringibile soltanto all’ambito<br />
della identità di genere e dei comportamenti sessuali di genere<br />
poiché riguarda non le modalità sessuali di esercizio<br />
della pulsione libidica o di individuazione del suo «oggetto»<br />
durante tale esercizio (aspetti di cui la narrazione non si<br />
meraviglia affatto, anzi che fa intendere come del tutto<br />
«consueti» pur non parlandone specificamente) ma la confusione<br />
dell’uomo/donna quale appartenenza.<br />
Non sembrano esservi agganci logici nel comportamento<br />
della «papessa» (e sue conseguenze) né con l’omosessualità<br />
né con il transessualismo, quali oggi li possiamo<br />
conoscere, riconoscere e valutare.<br />
Indipendentemente da ogni giudizio, opinione e/o catalogazione<br />
relativi a tali stati - che qui non ci interessano<br />
- un omosessuale maschio, ovviamente, non avrebbe avuto<br />
gra vidanza e parto; una omosessuale femmina in abiti<br />
maschili difficilmente avrebbe avuta la variegata attività eterosessuale<br />
narrata.<br />
Ci si può chiedere, invece, se il presunto Giovanni VIII<br />
della narrazione fosse in realtà un «caso» clamoroso di travestitismo<br />
in persona di genere femmi nile. Il dubbio, occorre<br />
riconoscerlo, ha una certa evidenza immediata, e forse<br />
consistenza: già dall‘inizio della sua storia Giovanna/Giovanni<br />
ci viene presentato in fuga da Magonza col<br />
suo amante vestita da uomo, e se l’abito poteva essere inizialmente<br />
un utile espediente per fuggire, esso poi verrà<br />
sem pre mantenuto. Della papessa si dice che sempre tutti<br />
la ritennero un uomo ovunque andasse e si trovasse: comportamento<br />
ed abito dovettero per forza essere del tutto<br />
coerenti tra loro.<br />
Va anche detto che la sessuologia ha studiato il travestitismo<br />
molto meno di quanto non si sia occupata di omo-<br />
sessuali o transessuali; e forse c’è ancora qualche confusione<br />
in merito. 6<br />
Il primo ad usare il termine «transvestiti» (si sottolinea:<br />
«trans»-vestiti) si ritiene sia stato Magnus Hirschfeld<br />
in alcune pubblicazioni del periodo 1912-1925. A seguito<br />
dei suoi studi un’altra delle figure «storiche» della moderna<br />
sessuologia, Havelock Hellis, introdusse per il<br />
comportamento dei travestiti il termine di «eonismo» 7 ? Negli<br />
studi di Hirschfeld, era già chiara la distinzione tra transvestiti<br />
ed omosessuali, alcuni dei quali possono anche adottare<br />
abiti del sesso opposto al loro ma ciò non equivale al<br />
travestitismo come qui inteso; ma in Hirschfeld, tuttavia,<br />
non si faceva affatto distinzione tra travestitismo e transessualismo.<br />
Confusione questa che è perdurata fino ai giorni<br />
nostri tanto da essere presente ancora nel 1972 in uno<br />
studioso atten to ed aggiornato come G. Santori.<br />
In realtà si intende per travestito (in termini psicosessuali<br />
pulsionali) l’in dividuo che generalmente ha rapporti<br />
con partner di tipo eterosessuale, rispetto a sé, ma che<br />
indossa abiti del sesso opposto a quello proprio, con una<br />
inclinazione in qualche modo di tipo feticistico. Non si tratta<br />
quindi di attività omosessuale ma solo di cambiamento<br />
di abiti ed è peraltro un atteg giamento molto meno radicale<br />
di quello del transessuale che non si limita all’abito<br />
ma tenta di diventare in qualche modo persona del sesso<br />
opposto (riassegnazione di sesso).<br />
Il travestitismo si situa dunque in una specie di incrocio<br />
tra la parafilia (feticismo) e il disturbo dell’identità di genere,<br />
tanto che da parte J. Money (1977) è stato proposto<br />
una specie di continuum in sei punti per quella che egli<br />
chiama la «trasposizione nell’identificazione e nella complementarietà<br />
di genere» che va da una forma massima<br />
(qualificata come «cronica» e «totale»), il transessualismo,<br />
ad una minima (qualificata come «episodica» e «parzia -<br />
le»), il travestitismo, passando attraverso la bisessualità, l’omosessualità<br />
maschile effeminata e il lesbismo maschileggiante.<br />
Il Money peraltro è cate gorico: il travestitismo<br />
si manifesta solo nei maschi, (cosa che non si inquadra con<br />
la supposizione avanzata per la papessa); il dato non è condiviso<br />
da tutti, in ambito scientifico. Al di fuori dell’ambito<br />
scientifico sessuologico il con cetto del «travestirsi» quale<br />
impulso e modalità esistenziale, si allarga ulte riormente.<br />
Si veda ad es. la docente di letteratura Marjorie Garber<br />
(1992) che dedica un capitolo addirittura alle «Sante travestite)<br />
8 . Per la Garber il disturbo di quelli da lei chiamati<br />
«giuochi di travestimento» è evidentemente polimorfo, so-<br />
6 Ovviamente ci si riferisce al travestitismo di tipo pulsionale che ha ben poco a che vedere sia con il fenomeno di tipo culturale (eventualmente<br />
rituale) non raramente segnalato dagli antropologi in popolazioni e culture «altre» rispetto alla nostra (cfr. Gregersen 1982), sia con il travestimento<br />
a scopo adescatorio-commerciale di certa prostituzione così diffuso anche nella nostra società<br />
7 Le Chevalier d'Eòn (1728-1810) fu agente segreto e poi segretario dell'ambasciata di Francia presso la corte degli zar di Russia noto per essere<br />
indubbiamente di sesso maschile ma abilissimo nel vestirsi e vivere da donna, cosa che fece per un lungo periodo di tempo.<br />
8 Interessante in tal senso la ricostruzione del processo a Giovanna D'Arco legalmente impostato più sull'«abuso d'abito» che su eresie religiose.<br />
97
ciologico, politico, artistico, ideologico senza distinzione<br />
fra scelte personali e determinismi da patologia clinica.<br />
In sessuologia clinica infine l’idea di travestitismo quale<br />
sindrome unisessuale maschile ricompare tuttavia nel<br />
DSM IV - non esplicitata per definizione ma di fatto - nella<br />
descrizione, probabilmente la più corretta oggi esistente,<br />
dei suoi criteri diagnostici.<br />
In essa sono compresi i seguenti elementi: - il fatto centrale<br />
è la funzione erotica dell’abbigliamento (non quindi,<br />
ad esempio, funzione ed utilizzo sociale dello stesso);<br />
- l’indagine anamnestica dimostra frequentemente un inizio<br />
o dei «prodromi significativi» in età preadolescenziale;<br />
- frequentemente il soggetto è indistinguibile dalle persone<br />
del suo stesso genere, al di fuori di «episodi» e della<br />
condizione di «intimità» degli stessi; - i travestimenti inizialmente<br />
«intermittenti» possono però diventare «abituali»;<br />
- un piccolo numero di soggetti può evolvere in transessuali.<br />
c) Le ipotesi di tipo «misto» psico-somatico<br />
Resta infine da considerare, per completezza di ipotesi<br />
«patogenetiche», l’eventualità che una qualche anomalia<br />
a livello di mediatori biochimici per lo sviluppo e la funzione<br />
sessuale (ormoni, neuromediatori, enzimi - eventualmente<br />
anche a codificazione genetica) abbia agito sul<br />
doppio livello psicosomatico, creando prima delle ambiguità<br />
somatiche responsabili di ambiguità nel riconoscimento<br />
del fenotipo maschile/femminile e poi, proprio per<br />
tale ambiguità, agevolando lo svilupparsi di una qualche<br />
problematica psicologica-sociale-educativa a livello di<br />
una giusta evoluzione dell’identità di genere. Anche in questo<br />
caso comunque l’anomalia psicosessuale dovrebbe essere<br />
stata prevalente e quella biologica meno incisiva, come<br />
dimostrato non solo dalla possibilità di una vita erotica ma<br />
anche di quella riproduttiva, con concepimento e gravidanza<br />
giunta a termine.<br />
Sulla base di tutto quanto detto finora possiamo allora<br />
concludere che nei confronti della c.d. «papessa Giovanna»,<br />
il travestitismo potrebbe essere forse l’unica<br />
«patologia» di tipo sessuologico ipotizzabile a spiegazione<br />
dell’accaduto; ma ipotizzabile significa anche che non<br />
la si può né dimostrare né escludere con certezza. Permangono<br />
comunque forti elementi di perplessità che nella<br />
fattispecie possono così riassumersi:<br />
- manifestazione del disturbo in soggetto di sesso femminile<br />
(da escludere? di rarità estrema?)<br />
- perduranza inalterata della manifestazione per tutta<br />
la vita ab initio dall’adolescenza<br />
- eccezionalità sociale (a prescindere dagli aspetti religiosi)<br />
del personag gio «pubblico» così in vista che pur<br />
tuttavia inganna facilmente tutti fino all’evento fatale.<br />
Quest’ultimo aspetto è talmente vistoso da spostare<br />
radicalmente l’an golatura di indagine. Più che chiedersi<br />
98<br />
F. Masellis<br />
se sia trattato di una colossale e blasfema truffa (vera donna<br />
e falso papa) o di una qualche forma di anomalia rara<br />
e in sé non truffaldina (vera patologia) ci si può chiedere,<br />
in termini di critica storica, cosa ci fosse di «vero» e<br />
cosa di «falso» nella narrazione riportata (falso e vero variamente<br />
ripartiti tra «fatti» e «leggende metropolitane»…).<br />
Le possibili ipotesi della critica storica<br />
Si riportano qui soltanto per sommi capi, non essendo<br />
questa la sede e la competenza per approfondirle. Anzitutto<br />
molti hanno notato il rilievo da dare già al buonsenso,<br />
che non pretende certamente una considerazione<br />
di scientificità, come riconosce Spadanuda (1996) dalla citazione<br />
sintetica del quale trascriviamo: «Come poteva una<br />
femmina ... tenere nascosto il suo ses so in Vaticano, per<br />
anni addirittura, laddove vigeva il cerimoniale bizantino?<br />
Nel palazzo i papi erano serviti da chierici e camerieri che<br />
li accompagnavano in ogni fase della loro vita intima: li aiutavano<br />
a vestirsi, a spogliarsi, a infilarsi sotto le coltri e persino<br />
ad adempiere alle loro necessità corporali. E poi, durante<br />
la gestazione, come aveva potuto la Papessa celare<br />
alla servitù il ventre che le si gonfiava di mese in mese? Non<br />
sembra infine plausibile che nel clima di accese lotte per<br />
il potere, nel secolo IX, i cardinali potessero pensare di consacrare<br />
papa un dotto, estraneo agli schieramenti romani…<br />
»<br />
La vera critica storica muove anche da considerazioni<br />
consimili ma va oltre secondo i propri modelli di approccio<br />
«scientifico» e, come fa il D’O nofrio (1979), si<br />
preoccupa di ricostruire in ogni sua fase liturgie e cerimoniali,<br />
di confrontare date ed eventi, tenta di analizzare<br />
in base allo stile ed alla metodologia seguiti dalla storiografia<br />
medievale il tipo di linguaggio usato (in altre parole:<br />
perché citare fatti e persone per poi avvertire che<br />
comun que si tratta di opinioni non accertate, i «si dice<br />
... », «quasi tutti raccontano ... » «raccontano autori incerti<br />
e oscuri» .... ) e si estende perfino a ricostruire, tramite<br />
una documentazione urbanistica che abbraccia i secoli,<br />
la struttura viaria dei luoghi romani coinvolti nei fatti<br />
e, attraverso una indagine congiunta medico-archeologica,<br />
le possibili interpretazioni della famosa sedia forata.<br />
Occorre allora dire che ad un esame critico serrato la<br />
«narrazione» non regge, e difficilmente può essere considerata<br />
oggi credibile quale fatto storico accaduto certamente<br />
o almeno probabilmente. Tutto falso dunque? Forse<br />
no, dicono i critici; basta scomporre l’insieme che lega<br />
i fatti ed esaminare questi uno alla volta per vedere se offrono<br />
altre spiegazioni. Enunciamo qui alcune spiegazioni<br />
di singoli elementi della narrazione presi isolatamente,<br />
ma inter pretabili diversamente e che comunque non au-
<strong>Uno</strong> <strong>scandalo</strong> <strong>dell'alto</strong> medio evo: la papessa giovanna. Problematiche sessuologiche, storiografiche e simbologia tra realtà e leggenda<br />
tenticano il tutto. Ancora una volta soltanto ipotesi; anche<br />
perché non è questa la sede di competenza per prendere<br />
posizione rispetto ad esse.<br />
(A) Anzitutto nomi e date. Chi ne fa fede è un Bibliotecario<br />
vaticano non ché cardinale, di nome Anastasio documentatissimo<br />
sull’epoca in cui lui stes so visse ed operò<br />
in curia sotto ben sei papi diversi, il quale vide di persona<br />
la stretta successione di questa serie di pontefici con<br />
una datazione precisa:<br />
Sergio II (844-47), Leone IV (847-55), Benedetto III<br />
(855-58), Nicola (o Niccolò) I (858-67), Adriano II (867-<br />
72), Giovanni VIII (872-82), è il Gio vanni VIII «ufficiale»<br />
da non confondere con la papessa data come per sua omonima<br />
ed anteriore di circa 30 anni). La presunta papessa<br />
sarebbe stata eletta papa nell’anno 855, morto Leone<br />
IV, ma quella sede vacante durò sol tanto 15 giorni e si<br />
concluse con l’elezione del Benedetto III; non è quindi<br />
assolutamente possibile ritenere per veritiere le date riportate<br />
nella storia della papessa (un po’ variabili quanto<br />
a durata di pontificato ma tutte concordi quanto ad<br />
anno di elezione), e quindi del tutto improbabile l’esistenza<br />
di un simile «papa» omesso dagli elenchi «ufficiali»<br />
solo per inopportunità o inde gnità. Vi è di più: lo stesso<br />
bibliotecario Anastasio sarebbe stato un concorrente<br />
di Benedetto III (il successore del Leone IV) ed anzi<br />
creato lui stesso papa in opposizione al Benedetto fu antipapa<br />
sia pure per pochissimi giorni (poi si sottomise e<br />
fu reintegrato in tutte le sue precedenti prerogative). <strong>Uno</strong>,<br />
dunque, che sul periodo la sapeva lunga; e mai nominò<br />
la papessa. Le date bocciano inequivocabilmente la papessa.<br />
Ma invece…… il nome Giovanni è molto sospetto, perché<br />
tra i numerosi Giovanni che furono papa in alto <strong>medioevo</strong><br />
molti sembrarono essere quantomeno «criticabili».<br />
All’inizio del 700 (centocinquanta anni «prima») un<br />
Giovanni VII fu pubblicamente definito «femmina»<br />
non per sesso ma per la sua «viltà» nel fare gli interessi<br />
della Chiesa (ed era arrivato a Roma essendo di origine<br />
greca .... vedi caso). Ancor peggio andò 50 anni «dopo»<br />
la presunta papessa, perché il pontificato di uno storico<br />
Giovanni IX sarebbe finito per mano omicida ad opera<br />
di un marito a cui tale papa aveva rubato la moglie. E siamo<br />
già arrivati agli anni in cui il pontificato romano era<br />
in mano alle donne, papesse non in senso ecclesiale-liturgico,<br />
ma di fatto e per fatti di alcova. Sono le famigerate<br />
Teodora e sua figlia Marozia. E il turno dell’a mante<br />
della prima, il prete Giovanni che costei face eleggere papa<br />
nel 914 (e fu Giovanni X, peraltro un buon capo e statista<br />
in quei tempi tempestosi), e del figlio della seconda<br />
(che costei, Marozia, avrebbe avuto da un altro papa, Sergio<br />
III); ed anche tale figlio ebbe nome Giovanni ed anche<br />
tale Giovanni divenne papa nel 931 (il debole e gio-<br />
vane Giovanni XI a mezzo del quale Marozia regnò di fatto).<br />
Si confrontino le date rispetto sia alla ipotetica papessa<br />
Giovanna che al lasso di tempo che passerà ancora per arrivare<br />
alla prima menzione di lei solo nel 1080 d. C.: le confusioni<br />
di nomi, date, even ti, tanto più se frammiste a dicerie<br />
popolari, possono risultare più che ovvie. Non una<br />
donna fatta papa e supposta uomo a nome Giovanni, ma<br />
molti indegni papa Giovanni e molte donne, papesse di<br />
fatto non avendo mai cinta la tiara.<br />
(B) La topografia. Se non vi fu mai una papessa Giovanna,<br />
come è che spunta dalle cronache una località ove<br />
sarebbe accaduto «il fattaccio» il cui toponimo, «vicus Papisse»,<br />
sembra essere toponomasticamente reale? Si accenna<br />
solo a due ipotesi che quanto a verosimiglianza sembrano<br />
essere più «realistiche» di quella narrata dai cronisti<br />
medievali. Anzitutto sembra documentato da alcuni antichi<br />
rendiconti curiali ed amministrativi che, almeno in<br />
epoca posteriore al 1000, proprio nella detta zona abitasse<br />
una famiglia di nome Papa; potrebbe la «papissa» che dette<br />
nome ad un vicus del posto esse re stata, anni prima, una<br />
donna in qualche modo importante di tale famiglia o nota<br />
per qualche sua caratterialità o caratteristica segnaletica<br />
... tanto da dare nome alla strada? La seconda ipotesi, ancor<br />
più specifica benché meno storicamente determinata,<br />
sostiene che come oggi esistono i «boss» di quartiere o di<br />
zona (anticamente a Roma a capo di ogni rione vi era appunto<br />
un «capo-rione»; onde l’odierno «caporione»,<br />
epiteto per facinoroso), uno dei modi medievali per indicarli<br />
fosse appunto la qualifica di «papa» di quel tal posto, non<br />
in senso ecclesiale ma in senso di «colui che comanda»; e<br />
ancora una volta, perché no un boss donna, o la donna del<br />
boss, una «papissa», e un vicus papisse?<br />
(C) La sedia «forata» e il rito ad essa connesso. Che la<br />
sedia esista è indiscu tibile; anzi ve ne sono due, di marmo<br />
rosso (e pertanto erroneamente ritenu te di porfido). Entrambe<br />
originariamente erano situate nel Laterano, poi a<br />
fine ‘700 una fu portata ai musei vaticani e l’altra poco dopo<br />
fu portata da Napoleone al Louvre (sono tuttora visibili;<br />
quella del Vaticano è nel «Gabi netto delle Maschere», Museo<br />
Pio-Clementino a fra compagnia<br />
... alla Venere di Cnido). Tutto sta ad indicare che<br />
siano due reperti archeologici di epoca romana, forse trovati<br />
in situ, provenienti dalla stessa zona ove anticamente<br />
erano palazzi imperiali e dei Laterani. Variamente interpretate<br />
in epoca moderna (oggetti di uso igienico?) sembra<br />
veramente che esse altro non siano che sellae obstetricae,<br />
cioè «sedie da parto» (!) e ..... il pontefice doveva esservi<br />
posto a sedere in fasi diverse del cerimoniale/rituale che<br />
anzi comprendeva passaggi diversi tra vari tipi di sedie, ivi<br />
compresa anche la già citata sedia «stercoraria» di diverso<br />
significato e ben differenziata perfino nel nome.<br />
99
Ad essere discutibile è dunque non la sedia «forata»<br />
ma il suo uso, nel rito riferito dalla narrazione; e il D’Onofrio<br />
(1979) ribalta addirittura le ipotesi precedenti: non<br />
è la realtà della papessa Giovanna che ha reso necessario<br />
il successivo uso della sedia forata per accertare il sesso papale,<br />
ma è la realtà di un rito pontificale del tutto simbolico,<br />
comportante la detta seggiola, mal compreso dal volgo<br />
incolto e probabilmente obsoleto con gli anni nei suoi<br />
significati perfino ai dotti, che ha «confermato» una leggendaria<br />
storia di papesse. Quale rito? Rito «ostetrico» ???<br />
L’ipotesi del D’Onofrio, ancora una volta ricostruita attraverso<br />
studi di dettaglio fino alla misurazione di dimensioni<br />
ed eccentricità del foro ed alla precisazione della<br />
particolare posizione che il neoeletto pontefice doveva<br />
assumere su quella particolare sedia, è suggestiva: si trattava<br />
appunto, valendosi di una suppellettile di uso già noto,<br />
di «mimare» mediante uno strumento ed una posizione del<br />
tutto allegorici, una allegoria della «Ecclesia Mater»; il capo<br />
della Chiesa «che è madre dei suoi figli», rinnova egli stesso,<br />
a sua volta «simboleggiando la Chiesa», il parto di figli,<br />
all’inizio del suo pontificato. L’ipotesi è suggestiva e<br />
100<br />
F. Masellis<br />
Fig. 2 - Le sedie forate. A) Foto dell’esemplare in Vaticano. B) Disegno dell’esemplare al Louvre.<br />
l’A. citato la sviluppa ampiamente con supporti storici ed<br />
iconografici di vario genere ed estensione; resta, probabilmente,<br />
da chiedersi come mai nel breve corso di soli 4<br />
o 5 secoli una struttura particolarmente attenta ai simboli,<br />
come tutte le religioni, abbia perso il significato di un<br />
simbolo proprio così particolare fino a lasciarlo stravolgere<br />
del tutto.<br />
Giunti al limite della simbologia è comunque singolare<br />
che con un approccio multidisciplinare ci si ritrovi ancora<br />
una volta nel dominio di una delle discipline sessuologiche;<br />
quella che riguarda la sessualità nella sua dimensione<br />
generativa e per suo tramite si incontri uno dei grandi interrogativi<br />
religiosi di sempre. Il mistero della vita e della<br />
morte, del perpetuarsi oltre la morte che è anche mistero<br />
dello spirito.<br />
Ma spirito, simboli, sono bene al di là degli spunti sessuologici<br />
da cui sia mo partiti; e nella presente occasione<br />
costituiscono il limite «serio» su cui arrestarsi. Mentre altri<br />
forse potranno preferire il limite «satirico» di Giuseppe<br />
Gioacchino Belli 9 , sorvolando su tutte le considerazioni<br />
critiche fin qui fatte:<br />
9 «La papessa Giuvanna», sonetto N° 278 del 26 novembre 1831, G.G. Belli I sonetti. Feltrinelli', Milano 1965; IV ed. vol. I pg. 305.
<strong>Uno</strong> <strong>scandalo</strong> <strong>dell'alto</strong> medio evo: la papessa giovanna. Problematiche sessuologiche, storiografiche e simbologia tra realtà e leggenda<br />
Fu proprio donna. Buttò via ‘r zinale<br />
prima de tutto s’ingaggiò sordato;<br />
doppo se fece prete, poi prelato,<br />
e poi vescovo, e arfine cardinale.<br />
E quanno er Papa maschio stiede male,<br />
e morze 10 , c’è chi dice, avvelenato,<br />
fu fatto Papa lei, e straportato<br />
a San Giuvanni su in zedia papale.<br />
Ma qua se sciorze er nodo a la commedia;<br />
ché sanbruto 11 je preseno le doje,<br />
e sficò 12 un pupo lì sopra la sedia.<br />
D’allora st’antra sedia ce fu messa<br />
Pe tastà sotto ar zito de le voje<br />
Si er Pontefice sii Papa o Papessa.<br />
(Riv. Sessuol. 1998, vol. 22 (2), 125-138)<br />
Riferimenti bibliografici<br />
A.P.A. (1996): D.S.M. IV Manuale diagnostico e statistico dei dis-<br />
10 «morì».<br />
11 «ex abrupto».<br />
12 «fece uscire da ... ».<br />
turbi mentali, Washington D.C. (trad. ital. Masson, Milano).<br />
AA.V.V. (1984-1993): I papi e gli antipapi, TEA Editori Associati,<br />
Torino.<br />
D’Onofrio C. (1979): La papessa Giovanna - Roma e papato tra<br />
storia e leggenda, Romana Soc. Edit, Roma.<br />
Garber M. (1992): Vested Interests. Cross-Dressing & Cultural<br />
Anxiety, Chapman & Hall, Routledge (trad. ital. «Interessi<br />
truccati - Giochi di travestimento ed angoscia culturale” R.<br />
Cortina Ed., Milano 1994).<br />
Gregersen E. (1982): Sexual practices, Mitchell Beazley Publ, London<br />
(trad. ital. «Pratiche sessuali”, Lyra Libri, Como 1987).<br />
Money G. (1977): Le determinanti del ruolo - identità di genere<br />
maschile e femminile; in:<br />
Money G. & Musaph H (a cura di) «Handbook of Sexology”,<br />
Elsever (trad. ital. Sessuologia; voI. I pg. 132; Boria, Roma,<br />
1978).<br />
Rendina C. (1994): La papessa Giovanna - Il mistero della donna<br />
papa “Meretrice e Strega” tra cronache, novelle e storie<br />
diaboliche, Edizioni della Città, Roma.<br />
Santori G. (1972, IV ed.): Compendio di sessuologia, Minerva<br />
Medica, Torino.<br />
Spadanuda L. (1996): La papessa Giovanna - La misteriosa donna<br />
Papa nella cronaca e nei libelli dell’epoca, Scipioni<br />
Edir., Valentano.<br />
101