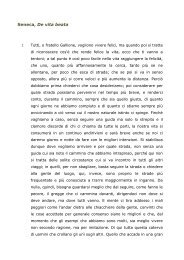«Cicerone e l'epicureismo» di Luciano Albanese
«Cicerone e l'epicureismo» di Luciano Albanese
«Cicerone e l'epicureismo» di Luciano Albanese
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
filosofico latino, destinato a lasciare una impronta decisiva nella storia della cultura occidentale. Le<br />
opere filosofiche <strong>di</strong> Cicerone furono un punto <strong>di</strong> riferimento costante sia per il pensiero tardo<br />
antico e me<strong>di</strong>evale – esse costituivano nel secondo caso una delle poche fonti a <strong>di</strong>sposizione –<br />
che per quello umanistico e rinascimentale, e anche per la cultura europea in generale fino a tutto il<br />
Settecento. Si pensi solo a David Hume, che scrive il suo capolavoro postumo, i Dialoghi sulla<br />
religione naturale, ispirandosi <strong>di</strong>rettamente al De natura deorum, e riutilizzandone massicciamente<br />
gli argomenti principali, in particolare quelli contro il finalismo e il <strong>di</strong>segno intelligente.<br />
La sfortuna <strong>di</strong> Cicerone come filosofo è un fenomeno moderno, ed inizia nell’Ottocento.<br />
Probabilmente con<strong>di</strong>zionata dal pesante giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Madvig, la cultura moderna cominciò a<br />
<strong>di</strong>sinteressarsi del Cicerone filosofo, formulando la nota accusa <strong>di</strong> eclettismo. In realtà la posizione<br />
filosofica <strong>di</strong> Cicerone è assolutamente coerente: egli fu sempre un accademico, vale a <strong>di</strong>re un<br />
seguace <strong>di</strong> quella tendenza scettica dell’Accademia platonica che, iniziata da Arcesilao, sviluppata<br />
al massimo grado da Carneade e terminata con Filone <strong>di</strong> Larissa, rappresenta il primo grande<br />
esempio <strong>di</strong> filosofia critica nel senso kantiano dell’espressione, e – al <strong>di</strong> là delle <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong><br />
impostazione – il precedente imme<strong>di</strong>ato del neoscetticismo o neopirronismo <strong>di</strong> Enesidemo e Sesto<br />
Empirico.<br />
Da questo punto <strong>di</strong> vista gli Academici possono essere considerati un manifesto programmatico.<br />
Lo scopo che si prefigge Cicerone in quell’opera è infatti quello <strong>di</strong> sottoporre ad esame le tre<br />
branche della filosofia (logica, fisica ed etica) e <strong>di</strong> evidenziare per ciascuna <strong>di</strong> essa la mai raggiunta<br />
né raggiungibile univocità <strong>di</strong> posizioni delle scuole <strong>di</strong> pensiero, che impone quin<strong>di</strong> cautela e<br />
sospensione del giu<strong>di</strong>zio, ovvero – dal momento che bisogna pur vivere, vale a <strong>di</strong>re prendere<br />
qualche decisione – un assenso tiepido e provvisorio.<br />
Questa impostazione degli Academici trova un puntuale riscontro nelle conclusioni aporetiche dei<br />
principali <strong>di</strong>aloghi filosofici, come il De natura deorum, il De <strong>di</strong>vinatione, il De finibus ecc., dove si<br />
incontrano e si scontrano le principali scuole filosofiche del mondo antico senza trovare mai un<br />
comune terreno <strong>di</strong> intesa. È vero che in questi <strong>di</strong>aloghi il pensiero <strong>di</strong> Cicerone sembra subire delle<br />
oscillazioni, ma ciò è dovuto essenzialmente al fatto che Cicerone assume <strong>di</strong> volta in volta parti<br />
<strong>di</strong>verse, e quin<strong>di</strong> può essere una volta scettico e un’altra dogmatico, senza per questo aderire<br />
intimamente alle idee esposte dal personaggio che sceglie <strong>di</strong> interpretare.<br />
***<br />
Il programma filosofico <strong>di</strong> Cicerone, soprattutto per l’aspetto <strong>di</strong>vulgativo, incontrava a Roma,<br />
tuttavia, un forte ostacolo. Esso era rappresentato dall’epicureismo e dalla sua forte capacità <strong>di</strong><br />
penetrazione soprattutto fra l’aristocrazia e le classi colte. Pensiamo subito a Lucrezio,<br />
naturalmente, che aveva intrapreso un analogo tentativo <strong>di</strong> coniare un vocabolario atomistico<br />
latino, riversando negli esametri del De rerum natura l’intero Peri physeos <strong>di</strong> Epicuro, che egli<br />
teneva costantemente sott’occhio.