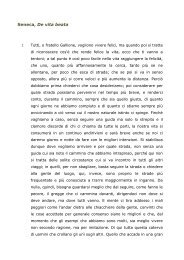«Cicerone e l'epicureismo» di Luciano Albanese
«Cicerone e l'epicureismo» di Luciano Albanese
«Cicerone e l'epicureismo» di Luciano Albanese
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’esame dell’etica epicurea si svolge nel II libro del De finibus. La strategia <strong>di</strong> Cicerone – la stessa<br />
seguita nel III libro delle Tusculanae – consiste essenzialmente: 1) nel ri<strong>di</strong>segnare il concetto <strong>di</strong><br />
piacere epicureo a proprio uso e consumo, facendolo <strong>di</strong>ventare quello che in Epicuro non è – come<br />
risulta a chiare lettere dall’epistola a Meneceo (utilizzata peraltro da Cicerone per costruire il<br />
<strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Torquato), vale a <strong>di</strong>re quello, privo <strong>di</strong> phronesis, degli smodati e dei crapuloni; 2) nel<br />
presentare come pure e semplici contrad<strong>di</strong>zioni rispetto a questo concetto <strong>di</strong> piacere tutte le<br />
affermazioni <strong>di</strong> segno contrario che si ritrovano in Epicuro (la mancanza <strong>di</strong> rigore e <strong>di</strong> coerenza <strong>di</strong><br />
Epicuro è un vero e proprio ritornello). La tesi <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> Cicerone, in sostanza, è che se metti il<br />
piacere al centro dei tuoi comportamenti pratici non puoi fare l’asceta, perché il piacere è una forza<br />
incontrollabile, e prima o poi ti travolgerà (un argomento, questo, che viene adoperato anche<br />
contro il principio peripatetico della metriopatheia: cfr. Tusc. IV 17, 38 sgg.). Subor<strong>di</strong>natamente, i<br />
beni del corpo e i beni esterni, che costituiscono la base materiale del piacere, non sono sotto il<br />
tuo controllo, perché non hai reali poteri né sul tuo corpo né sui tuoi beni, che sono preda della<br />
fortuna. Anche su queste affermazioni dovremo tornare.<br />
Il I libro del De natura deorum è interamente de<strong>di</strong>cato all’esposizione della dottrina epicurea da<br />
parte <strong>di</strong> Velleio e alla replica <strong>di</strong> Cotta/Cicerone. L’esposizione <strong>di</strong> Velleio si <strong>di</strong>vide nettamente in due<br />
parti. Una pars destruens, la cosiddetta «dossografia <strong>di</strong> Velleio», nella quale vengono rapidamente<br />
esaminate e <strong>di</strong>strutte tutte le teorie filosofiche sulla natura degli dèi, da Talete agli Stoici<br />
contemporanei, passando per due grossi calibri come Platone e Aristotele, ai quali non è riservato<br />
un trattamento migliore. Da evidenziare in questa rassegna, <strong>di</strong> nuovo, la critica della geometria,<br />
cioè dei cinque soli<strong>di</strong> del Timeo, i cristalli dei cinque elementi, che conferma l’atteggiamento<br />
negativo <strong>di</strong> Epicuro in materia, già sottolineato da Varrone e da Cicerone stesso. Qui bisogna<br />
osservare – l’ha fatto recentemente Stefano Maso – che questo quadro fortemente critico verso<br />
la tra<strong>di</strong>zione filosofica è in realtà opera dello stesso Cicerone, ed è perfettamente in linea con le<br />
sue vedute scettico-accademiche. È quin<strong>di</strong> già possibile parlare <strong>di</strong> un primo caso <strong>di</strong> concordanza<br />
oggettiva tra Cicerone e l’epicureismo.<br />
Segue poi la pars construens, nella quale vengono date tre prove dell’esistenza degli dèi, e<br />
descritta la loro forma e la loro natura. Gli dèi hanno forma umana, con un corpo che è un quasi<br />
corpo e un sangue che è un quasi sangue, e soprattutto, non intervengono nella creazione del<br />
cosmo (possono anzi essere considerati parti del cosmo stesso), né nelle vicende umane. Il cosmo<br />
è opera della natura, che sine fabrica e sine consilio, grazie unicamente all’incontro fortuito <strong>di</strong><br />
atomi, ha formato, forma e formerà innumerevoli mon<strong>di</strong> come questo. Se il mondo fosse opera <strong>di</strong><br />
un <strong>di</strong>segno razionale, del resto, non avremmo moltissime regioni della terra incolte o inabitabili,<br />
perché o troppo calde o troppo fredde, né tutta una serie <strong>di</strong> eventi e <strong>di</strong> fenomeni che parlano<br />
contro l’esistenza <strong>di</strong> un progetto razionale.<br />
La replica <strong>di</strong> Cotta contesta punto per punto le tesi epicuree. Innanzitutto la cornice fisico-<br />
filosofica, negando l’esistenza <strong>di</strong> atomi, cioè <strong>di</strong> in<strong>di</strong>visibili (torna il tema del <strong>di</strong>sinteresse epicureo<br />
per i fondamenti della geometria), e <strong>di</strong> vuoto, quin<strong>di</strong> contestando i due car<strong>di</strong>ni della fisica