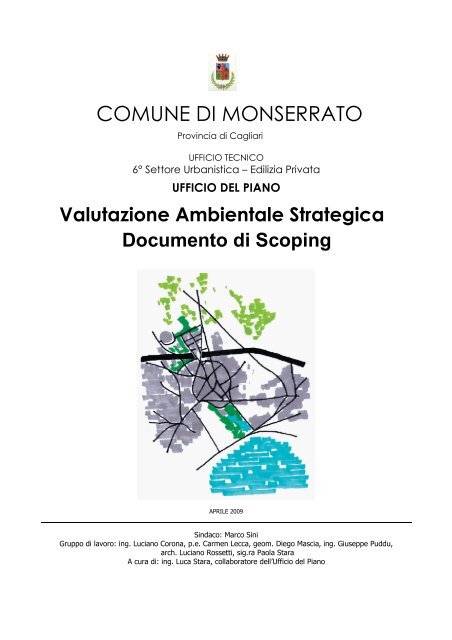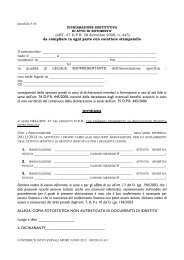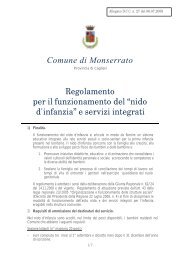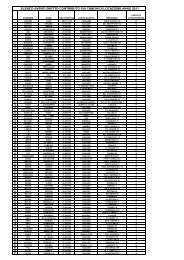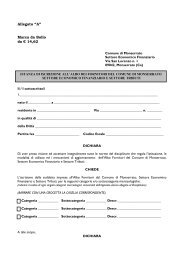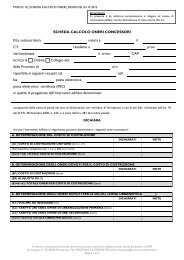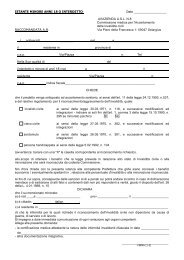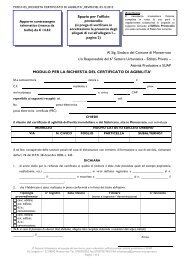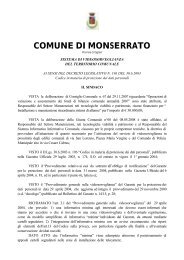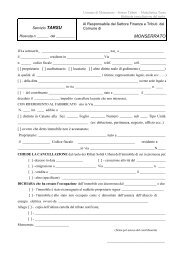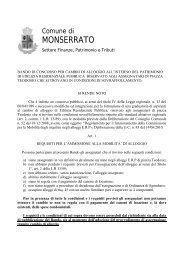VAS documento di scoping - Comune di Monserrato
VAS documento di scoping - Comune di Monserrato
VAS documento di scoping - Comune di Monserrato
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
COMUNE DI MONSERRATO<br />
Provincia <strong>di</strong> Cagliari<br />
UFFICIO TECNICO<br />
6° Settore Urbanistica – E<strong>di</strong>lizia Privata<br />
UFFICIO DEL PIANO<br />
Valutazione Ambientale Strategica<br />
Documento <strong>di</strong> Scoping<br />
APRILE 2009<br />
Sindaco: Marco Sini<br />
Gruppo <strong>di</strong> lavoro: ing. Luciano Corona, p.e. Carmen Lecca, geom. Diego Mascia, ing. Giuseppe Puddu,<br />
arch. Luciano Rossetti, sig.ra Paola Stara<br />
A cura <strong>di</strong>: ing. Luca Stara, collaboratore dell’Ufficio del Piano
INDICE<br />
Valutazione Ambientale Strategica<br />
del Piano Urbanistico Comunale<br />
<strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
Documento <strong>di</strong> Scoping<br />
1 Valutazione Ambientale Strategica (pag.4)<br />
1.1 Quadro normativo in materia <strong>di</strong> V.A.S.<br />
1.2 Procedure e contenuti della V.A.S.<br />
2 Organizzazione del processo della Valutazione Ambientale<br />
Strategica (pag.9)<br />
2.1 Preparazione<br />
2.2 Scoping<br />
2.3 Elaborazione relazione<br />
2.4 Adozione del P.U.C.<br />
2.5 Informazione<br />
2.6 Consultazione<br />
2.7 Esame e valutazione<br />
2.8 Parere motivato<br />
2.9 Approvazione del Piano<br />
2.10 Verifica <strong>di</strong> coerenza<br />
2.11 Informazione sulla decisione<br />
2.12 Attuazione e gestione<br />
3 Processo <strong>di</strong> adeguamento del P.U.C. al P.P.R. (pag.13)<br />
3.1 Adeguamento del P.U.C. al P.P.R.<br />
3.2 Principali riferimenti<br />
3.3 Efficacia e ambito <strong>di</strong> applicazione<br />
3.4 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico Regionale<br />
1
3.5 Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale<br />
3.6 Principi e obiettivi<br />
3.7 Contenuti del P.U.C. adeguati al P.P.R.<br />
4 Proposta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ce del Rapporto Ambientale (pag.19)<br />
5 Rapporto Ambientale (pag.21)<br />
6 Sostenibilità ambientale (pag.23)<br />
6.1 Analisi del quadro ambientale e territoriale<br />
6.2 Caratterizzazione delle aree<br />
6.3 Valutazione degli scenari e in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> criticità e vantaggi <strong>di</strong> ognuno <strong>di</strong><br />
essi<br />
6.4 Definizione degli obiettivi <strong>di</strong> piano<br />
6.5 Valutazione della sostenibilità degli obiettivi<br />
6.6 Definizione delle azioni <strong>di</strong> piano<br />
6.6.1 Valutazione della compatibilità delle azioni del Piano con le componenti<br />
ambientali<br />
6.6.2 Misure <strong>di</strong> mitigazione/compensazione, alternative, effetti/impatti delle<br />
azioni del piano<br />
6.6.3 Rimodulazione degli obiettivi del P.U.C. e in<strong>di</strong>viduazione delle azioni<br />
progettuali<br />
7 Piani e Programmi pertinenti al P.U.C. <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> (pag.31)<br />
8 Elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (pag.33)<br />
9 Schede (pag.37)<br />
SCHEDA N. 1 - QUALITA’ DELL’ARIA<br />
SCHEDA N. 2 - ACQUA<br />
SCHEDA N. 3 - RIFIUTI<br />
SCHEDA N. 4 - SUOLO<br />
SCHEDA N. 5 - FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’<br />
SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE<br />
SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO DEMOGRAFICO<br />
SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO<br />
SCHEDA N. 9 - MOBILITÀ E TRASPORTI<br />
2
SCHEDA N. 10 - QUALITA’ AMBIENTALE E SOCIALE<br />
10 Sintesi <strong>di</strong> Piano (pag.81)<br />
10.1 Introduzione<br />
10.2 Demografia<br />
10.3 Dotazione abitativa<br />
10.4 Tessuto produttivo<br />
10.5 Servizi<br />
10.6 Territorio<br />
10.7 Sviluppo urbano<br />
3
1 Valutazione Ambientale Strategica<br />
1.1 Quadro normativo in materia <strong>di</strong> V.A.S.<br />
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un “processo sistematico inteso a valutare le<br />
conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte politiche, piani o iniziative nell’ambito<br />
<strong>di</strong> programmi ai fini <strong>di</strong> garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate<br />
in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle<br />
considerazioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico e sociale” 1 .<br />
Dagli anni ’70, a livello comunitario, si prevede la possibilità <strong>di</strong> emanare una Direttiva<br />
specifica concernente la valutazione <strong>di</strong> piani, politiche e programmi.<br />
Nel 1973, infatti, il Primo Programma <strong>di</strong> Azione Ambientale, rileva l’esigenza <strong>di</strong> ricorrere ad<br />
una valutazione ambientale comprendente i piani, così da prevenire i danni ambientali, con la<br />
valutazione d’impatto delle opere a monte nel processo <strong>di</strong> pianificazione.<br />
E’ tuttavia con il Quarto Programma <strong>di</strong> Azione Ambientale (1987) che si concretizza l’impegno<br />
ad estendere la procedura <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale anche alle politiche e ai piani,<br />
definendo il processo come destinato a sod<strong>di</strong>sfare le necessità del presente, senza<br />
compromettere la capacità per le future generazioni <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare a loro volta le proprie<br />
necessità. Nel 1992 con la Direttiva 92/43/CE (concernente la conservazione degli habitat<br />
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica) è stata inoltre prevista la<br />
valutazione ambientale <strong>di</strong> piani e progetti che presentino significativi impatti, anche in<strong>di</strong>retti e<br />
cumulativi, sugli habitat tutelati. La Commissione Europea formula nel 1993 un rapporto<br />
riguardante la possibile efficacia <strong>di</strong> una specifica Direttiva sulla Valutazione Ambientale<br />
Strategica (V.A.S.) e tre anni dopo, successivamente alla sua stesura, essa viene adottata<br />
dalla Commissione Europea (04/12/1996).<br />
Nel 2001 viene emanata la Direttiva 2001/42/CE, che garantisce “un elevato livello <strong>di</strong><br />
protezione dell’ambiente e <strong>di</strong> contribuire all’integrazione <strong>di</strong> considerazioni ambientali all’atto<br />
dell’elaborazione e dell’adozione <strong>di</strong> piani e programmi al fine <strong>di</strong> promuovere lo sviluppo<br />
sostenibile”. La <strong>di</strong>rettiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, che introduce l’obbligo <strong>di</strong><br />
valutazione ambientale per tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi<br />
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, ha cominciato ad affermarsi solo negli ultimi anni.<br />
1 Da Formez – Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri<br />
4
La <strong>di</strong>rettiva è stata recepita a livello nazionale dalla parte II del D. Lgs. n. 152 del 2006,<br />
recentemente mo<strong>di</strong>ficato dal DLgs. 16 gennaio 2008, n°4.<br />
Il 3 aprile 2006 è stato approvato con Decreto Legislativo n. 152, il “Testo Unico in materia<br />
ambientale” che tratta le procedure dei piani e programmi <strong>di</strong> intervento sul territorio, andando<br />
a mo<strong>di</strong>ficare la legislazione quadro vigente in materia <strong>di</strong> rifiuti e bonifica dei siti contaminati,<br />
procedure <strong>di</strong> V.I.A. 2 e V.A.S. e I.P.P.C 3 , <strong>di</strong>fesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela<br />
delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche, tutela dell’aria e riduzione delle<br />
emissioni in atmosfera e, infine, <strong>di</strong> tutela preveniva contro i danni all’ambiente.<br />
La Regione Sardegna non si è ancora dotata <strong>di</strong> una regolamentazione sulle procedure in<br />
materia <strong>di</strong> Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ma, con il D.P.G.R. n. 66 del<br />
28/04/2001, ha assegnato la competenza in materia al Servizio Sostenibilità Ambientale e<br />
Valutazione Impatti (S.A.V.I.) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.<br />
Con la Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 sono state attribuite alla Regione le funzioni<br />
amministrative, non ritenute <strong>di</strong> livello nazionale, relative alla valutazione <strong>di</strong> piani e programmi<br />
<strong>di</strong> livello regionale o provinciale (art. 48), e alle Province quelle relative alla valutazione <strong>di</strong><br />
piani e programmi <strong>di</strong> livello comunale e sub-provinciale (art. 49).<br />
L’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ha previsto che i Comuni<br />
provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici comunali alle <strong>di</strong>sposizioni del P.P.R.<br />
coerentemente con i principi che stanno alla base dello stesso.<br />
I nuovi P.U.C, dall’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), dovranno<br />
essere sottoposti a V.A.S. Il servizio S.A.V.I. dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della<br />
Regione Sardegna ha preparato, a ottobre del 2007, le Linee Guida per la Valutazione<br />
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali che forniscono gli in<strong>di</strong>rizzi per una<br />
corretta applicazione delle <strong>di</strong>verse fasi della procedura <strong>di</strong> V.A.S, in adeguamento degli<br />
strumenti urbanistici al P.P.R.<br />
2 Valutazione d’Impatto Ambientale<br />
3 Integrated Pollution Prevention and Control (Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento): fa<br />
riferimento alla Direttiva 96/61/Cee sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, e impone il<br />
rilascio <strong>di</strong> un’autorizzazione (autorizzazione integrata ambientale) per tutte le attività industriali e agricole che<br />
presentano un notevole potenziale inquinante; essa è stata recepita dapprima con i Decreti legislativi 372/99,<br />
59/2005 e regolata dal Dm 23/11/2001.<br />
5
1.2 Procedure e contenuti della V.A.S.<br />
La finalità della V.A.S. è la verifica della coerenza dei Piani <strong>di</strong> Sviluppo e dei Programmi<br />
Operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, tenendo conto dell’influenza dei piani sulla<br />
qualità dell'ambiente e dei vincoli ambientali.<br />
A livello europeo nasce l’esigenza della promozione <strong>di</strong> politiche, piani e programmi, assieme<br />
agli aspetti sociali ed economici, in cui venga dato risalto anche agli impatti ambientali.<br />
La valutazione non si riferisce alle opere, come nella Valutazione d’Impatto Ambientale<br />
(V.I.A.), ma a piani e programmi, assumendo per queste caratteristiche più generali la<br />
denominazione “strategica”. Il tema dell’Ambiente <strong>di</strong>venta carattere trasversale nei <strong>di</strong>versi<br />
settori oggetto dei Piani, capace <strong>di</strong> promuovere uno sviluppo realmente sostenibile, con il<br />
preciso intento <strong>di</strong> definire strategie settoriali e territoriali; quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> uno strumento <strong>di</strong> aiuto alla<br />
decisione (D.S.S.-Decision Support System 4 ), più che un processo decisionale in se.<br />
La V.A.S. è uno strumento e non il fine ultimo del processo.<br />
Si è finalmente consapevoli che l’analisi delle ripercussioni ambientali deve intervenire a<br />
monte del programma, tenendo conto in anticipo <strong>di</strong> tutte le alternative possibili.<br />
La valutazione ambientale prevede l’elaborazione <strong>di</strong> un Rapporto <strong>di</strong> Impatto Ambientale, lo<br />
svolgimento <strong>di</strong> consultazioni, la valutazione del Rapporto Ambientale e dei risultati delle<br />
consultazioni e la messa a <strong>di</strong>sposizione, del pubblico e delle autorità interessate, delle<br />
informazioni sulle decisioni prese. L’autorità procedente (la pubblica amministrazione che<br />
recepisce, adotta o approva il piano o programma), contestualmente al processo <strong>di</strong><br />
formazione del piano o programma, avvia la Valutazione Ambientale Strategica che<br />
comprende:<br />
• lo svolgimento <strong>di</strong> una verifica <strong>di</strong> assoggettabilità;<br />
• l’elaborazione del Rapporto Ambientale;<br />
• lo svolgimento <strong>di</strong> consultazioni;<br />
• la valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni;<br />
• la decisione;<br />
• l’informazione della decisione;<br />
• il monitoraggio.<br />
I principali aspetti innovativi introdotti dalla Direttiva 2001/42/CE, sono:<br />
4 supporti <strong>di</strong> analisi per elaborare: simulazioni, verifica della congruità delle decisioni, stime, calcolo delle<br />
probabilità, etc..<br />
6
1) la fase <strong>di</strong> monitoraggio, finalizzato a controllare gli effetti dovuti all’attuazione <strong>di</strong> un piano<br />
o programma, e adottare misure correttive del processo in atto;<br />
2) la fase che prevede la partecipazione, attraverso la trasparenza nel processo <strong>di</strong><br />
valutazione, sia da parte delle autorità che possano essere interessate agli effetti<br />
sull’ambiente dovuti all’applicazione <strong>di</strong> piani e programmi, sia del pubblico che in<br />
qualche modo risulta interessato all’iter decisionale. Deve essere garantita, al pubblico e<br />
alle autorità interessate, la possibilità <strong>di</strong> esprimere il proprio parere prima dell’adozione o<br />
dell’avvio del piano.<br />
La V.A.S., inoltre, prevede <strong>di</strong>verse soluzioni attraverso la valutazione delle <strong>di</strong>verse opzioni<br />
d’intervento per dare risposte alle <strong>di</strong>verse compatibilità ambientali.<br />
L’in<strong>di</strong>viduazione e la valutazione delle alternative del piano/programma ha lo scopo, inoltre, <strong>di</strong><br />
fornire trasparenza al percorso decisionale che porta all’adozione delle misure da<br />
intraprendere.<br />
Sono sottoposti al processo <strong>di</strong> assoggettabilità <strong>di</strong> V.A.S. tutti i piani che possono avere effetti<br />
significativi sull’ambiente.<br />
Secondo l’art.6 del D. Lgs. n. 4 del 2008 viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i<br />
programmi:<br />
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i<br />
settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della<br />
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione<br />
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro <strong>di</strong> riferimento per<br />
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area <strong>di</strong> localizzazione o comunque la realizzazione dei<br />
progetti elencati negli allegati II, III e IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 ;<br />
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità <strong>di</strong> conservazione dei siti<br />
designati come zone <strong>di</strong> protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e<br />
quelli classificati come siti <strong>di</strong> importanza comunitaria per la protezione degli habitat<br />
naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione<br />
d’incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />
c) per i piani e i programmi [] che determinano l’uso <strong>di</strong> piccole aree a livello locale e per le<br />
mo<strong>di</strong>fiche minori dei piani e dei programmi [], la valutazione ambientale è necessaria<br />
7
qualora l’autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull’ambiente<br />
[]. L’autorità competente valuta [] se i piani e i programmi [] che definiscono il quadro <strong>di</strong><br />
riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi<br />
sull’ambiente.<br />
Sono comunque esclusi dal campo <strong>di</strong> applicazione:<br />
• i piani e programmi “destinati esclusivamente a scopi <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa nazionale caratterizzati<br />
da somma urgenza o coperti dal segreto <strong>di</strong> Stato”;<br />
• i piani e programmi “finanziari o <strong>di</strong> bilancio”;<br />
• i piani <strong>di</strong> protezione civile in caso <strong>di</strong> pericolo per l’incolumità pubblica.<br />
Il Piano Urbanistico Comunale <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong>, dovrà essere sottoposto al parere<br />
sull’assoggettabilità da parte dei soggetti competenti.<br />
8
2 Organizzazione del processo della Valutazione Ambientale<br />
Strategica<br />
Il processo <strong>di</strong> V.A.S. comprende l’elaborazione <strong>di</strong> un Rapporto Ambientale, lo svolgimento <strong>di</strong><br />
consultazioni, la valutazione del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione <strong>di</strong> un<br />
parere motivato e l’informazione sulla decisione e il monitoraggio.<br />
Il Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti dell’Assessorato della Difesa<br />
dell’Ambiente della Regione Sardegna prevede, in base alle “Linee Guida per la Valutazione<br />
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali (Bozza Ottobre 2007)”, le fasi <strong>di</strong>:<br />
2.1 Preparazione<br />
Il primo atto è la verifica <strong>di</strong> assoggettabilità: per valutare se un piano o programma può<br />
avere un impatto significativo sull’ambiente e/o sul patrimonio culturale e, quin<strong>di</strong>, se lo stesso<br />
debba essere sottoposto o meno a V.A.S.<br />
Il D. Lgs. 152/2006 stabilisce, infatti, l’obbligatorietà <strong>di</strong> sottoporre un piano o programma a<br />
V.A.S. è subor<strong>di</strong>nata ad un esame preliminare, finalizzato a verificare se l’attuazione del<br />
Piano possa determinare effetti significativi sull’ambiente.<br />
Il processo <strong>di</strong> V.A.S, contestuale a quello <strong>di</strong> formazione del piano e contenente la prima<br />
definizione degli obiettivi è avviato dall’Amministrazione Comunale, con pubblicazione <strong>di</strong><br />
apposito avviso sull’Albo comunale e sul sito internet.<br />
L’Amministrazione Comunale, inoltre, informa l’Autorità Competente dell’avvio della<br />
procedura per la redazione del P.U.C.<br />
2.2 Scoping 5<br />
Stabilisce la fase in cui si definiscono le informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse,<br />
e il loro livello <strong>di</strong> dettaglio, da riportare nel Rapporto Ambientale.<br />
Durante tale fase devono essere coinvolti i soggetti competenti in materia ambientale, ovvero<br />
le pubbliche amministrazioni e/o gli altri enti (l’Assessorato agli Enti Locali, Finanze e<br />
Urbanistica, l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio S.A.V.I., Province, A.R.P.A.S.,<br />
Sovrintendenze ai beni culturali e archeologiche e i soggetti competenti in materia<br />
ambientale).<br />
5 determinazione della portata<br />
9
Si procederà ad:<br />
• in<strong>di</strong>viduare l’ambito d’influenza del P.U.C, coerenza con i piani con i quali si relaziona e<br />
la coerenza con i principi <strong>di</strong> sostenibilità ambientale;<br />
• definire le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;<br />
• definire la portata delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale e il loro livello<br />
<strong>di</strong> dettaglio;<br />
• definire le modalità <strong>di</strong> svolgimento delle consultazioni con il pubblico e con i soggetti con<br />
competenze ambientali.<br />
2.3 Elaborazione relazione<br />
In questa fase devono essere precisati gli obiettivi specifici e le linee d’azione attraverso<br />
cui dare attuazione al P.U.C.<br />
Si in<strong>di</strong>vidueranno le linee <strong>di</strong> azione e gli interventi che possano far raggiungere gli obiettivi<br />
specifici prefissati, stimando gli effetti che queste azioni potranno determinare sull’ambiente,<br />
per poter adeguare il Piano sulla base dei risultati ottenuti.<br />
La valutazione degli effetti sull’ambiente dovrà essere garantita per tutte le possibili<br />
alternative, al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare quella che risulti <strong>di</strong> minor impatto, per permettere il<br />
raggiungimento degli obiettivi prefissi dall’Amministrazione Comunale.<br />
Saranno inoltre in<strong>di</strong>viduati in<strong>di</strong>catori ambientali e <strong>di</strong> sviluppo sostenibile intesi a qualificare e<br />
semplificare le informazioni in modo da agevolare, sia da parte dei responsabili delle decisioni<br />
che da parte del pubblico, la comprensione delle interazioni tra l’ambiente e i problemi chiave<br />
del settore. Tali in<strong>di</strong>catori dovranno essere quantificati per contribuire ad in<strong>di</strong>viduare e a<br />
spiegare i mutamenti nel tempo.<br />
In questo senso dovrà essere inoltre definito un adeguato sistema <strong>di</strong> monitoraggio,<br />
finalizzato a tenere sotto controllo gli effetti che l’attuazione del Piano potrà determinare<br />
sull’ambiente.<br />
In fase <strong>di</strong> attuazione del P.U.C, infatti, dovrà essere possibile confrontare le stime e le<br />
valutazioni ipotizzate con gli effetti reali derivanti dall’effettiva attuazione del Piano, in modo<br />
da poter intervenire imme<strong>di</strong>atamente nel caso in cui si rilevino significativi scostamenti<br />
rispetto a quanto previsto in fase <strong>di</strong> valutazione.<br />
Nell’ambito della valutazione del P.U.C. si dovrà procedere, inoltre, all’analisi della sua<br />
coerenza esterna, finalizzata a verificare se gli obiettivi <strong>di</strong> un piano/programma sono coerenti<br />
10
con quelli previsti dalla pianificazione esistente <strong>di</strong> pari livello o <strong>di</strong> livello superiore, e coerenza<br />
interna finalizzata a verificare se gli obiettivi del piano/programma sono coerenti tra loro.<br />
Tale analisi valuta la coerenza tra la strategia in<strong>di</strong>viduata dal piano/programma, i relativi<br />
obiettivi, le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi e per l’attuazione della<br />
strategia.<br />
L’elaborato e la redazione sono rappresentati dal Rapporto Ambientale e della Sintesi Non<br />
Tecnica, in forma comprensibile anche per i “non addetti ai lavori”.<br />
Nel Rapporto Ambientale, in particolare, devono essere in<strong>di</strong>viduati, descritti e valutati:<br />
• la situazione ambientale <strong>di</strong> partenza attraverso opportuni in<strong>di</strong>catori;<br />
• gli obiettivi <strong>di</strong> sostenibilità ambientale;<br />
• criteri per l’integrazione della componente ambientale;<br />
• effetti significativi che l’attuazione del P.U.C. potrebbe avere sull’ambiente;<br />
• ragionevoli alternative sulla base degli obiettivi e dell’ambito territoriale del P.U.C;<br />
• sistema <strong>di</strong> monitoraggio.<br />
Dovranno essere illustrate, inoltre, le misure ritenute più opportune per la mitigazione degli<br />
effetti che l’attuazione del P.U.C. potrà comportare. Tali azioni potranno assumere la forma <strong>di</strong><br />
piani attuativi specifici o <strong>di</strong>sposizioni all’interno <strong>di</strong> regolamenti attuativi del P.U.C. o altri<br />
regolamenti comunali.<br />
2.4 Adozione del P.U.C.<br />
Esso viene adottato dal Consiglio Comunale (come previsto dalla L.R. 45/89 e dal D. Lgs.<br />
152/2006), poi messo a <strong>di</strong>sposizione del pubblico unitamente al Rapporto Ambientale e alla<br />
Sintesi Non Tecnica per permettere eventuali osservazioni.<br />
2.5 Informazione<br />
Prevede che l’Amministrazione informi la citta<strong>di</strong>nanza in<strong>di</strong>cando le se<strong>di</strong> in cui è possibile<br />
prendere visione della documentazione.<br />
2.6 Consultazione<br />
L’Amministrazione può organizzare degli incontri con la partecipazione del pubblico per<br />
raccogliere eventuali osservazioni e suggerimenti.<br />
11
2.7 Esame e valutazione<br />
Valutazione delle eventuali osservazioni e suggerimenti con un’eventuale revisione del P.U.C.<br />
adottato.<br />
2.8 Parere motivato<br />
Per un parere ambientale ed un’eventuale revisione del P.U.C sono consultati i soggetti<br />
competenti in materia ambientale.<br />
2.9 Approvazione del Piano<br />
Comprende l’approvazione del P.U.C. e la redazione <strong>di</strong> una Dichiarazione <strong>di</strong> Sintesi che<br />
illustri in che modo sono state integrate le considerazioni ambientali.<br />
2.10 Verifica <strong>di</strong> coerenza<br />
La Regione valuta la coerenza del P.U.C. con i piani sovraor<strong>di</strong>nati.<br />
2.11 Informazione sulla decisione<br />
Pubblicazione sul B.U.R.A.S. e sul sito internet del <strong>Comune</strong> con l’in<strong>di</strong>cazione delle se<strong>di</strong> in cui<br />
è possibile prendere visione del P.U.C. approvato con tutta la documentazione oggetto<br />
dell’istruttoria, della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio.<br />
2.12 Attuazione e gestione<br />
Monitoraggio sugli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del Piano e valutazioni<br />
perio<strong>di</strong>che con rapporti <strong>di</strong> monitoraggio.<br />
12
3 Processo <strong>di</strong> adeguamento del P.U.C. al P.P.R.<br />
3.1 Adeguamento del P.U.C. al P.P.R.<br />
Il principale riferimento normativo per l’elaborazione del Piano Urbanistico Comunale è<br />
ancora rappresentato dalla cornice normativa della Legge Regionale 22 <strong>di</strong>cembre 1989, n.<br />
45, con le sue mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni. Il P.P.R. ha il compito <strong>di</strong> ristabilire un quadro <strong>di</strong> regole<br />
certe ed uniformi, eliminando qualsiasi ambito <strong>di</strong> arbitrio e <strong>di</strong> eccessiva <strong>di</strong>screzionalità sia per<br />
la Regione, nei suoi vari livelli <strong>di</strong> istruttoria ed amministrazione, sia per gli Enti locali<br />
territoriali.<br />
Il P.P.R. conferisce alla pianificazione urbanistica comunale contenuti <strong>di</strong> valenza<br />
paesaggistica, che dovrà essere verificata e articolata nella pianificazione provinciale e<br />
comunale, nel quadro dei caratteri connotativi della propria identità e peculiarità<br />
paesaggistiche.<br />
I comuni in sede <strong>di</strong> adeguamento dei P.U.C, con gli strumenti urbanistici <strong>di</strong> propria<br />
competenza, provvedono a in<strong>di</strong>viduare sulla base delle conoscenze territoriali l’insieme dei<br />
valori ambientali, paesaggistici e storico-culturali e <strong>di</strong> valorizzazione del proprio territorio.<br />
3.2 Principali riferimenti<br />
• Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze 20 ottobre 2000;<br />
• Principi <strong>di</strong>rettivi per lo sviluppo territoriale duraturo del continente europeo, Conferenza<br />
Europea dei Ministri responsabili dell’assetto del territorio (C.E.M.A.T.), Hanover 7-8<br />
settembre 2000;<br />
• Accordo 19 aprile 2001 tra il Ministero dei Beni Culturali e le Regioni e le Province<br />
Autonome sull’esercizio dei poteri in materia <strong>di</strong> paesaggio (G.U. 18.05.2001, n.114);<br />
• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Co<strong>di</strong>ce dei Beni Culturali e del Paesaggio);<br />
• Legge regionale 22 <strong>di</strong>cembre 1989 n. 45 e successive mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni;<br />
• Legge regionale 25 novembre 2004 n. 8;<br />
• Deliberazione Giunta regionale 10 agosto 2004 n. 33/27.<br />
Altri riferimenti complementari sono:<br />
• Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale<br />
d’Europa, Berna 19 settembre 1979;<br />
13
• Convenzione per la salvaguar<strong>di</strong>a del patrimonio architettonico d’Europa, Granata 3<br />
ottobre 1985;<br />
• Convenzione Europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista), La Valletta 16<br />
gennaio 1992;<br />
• Convenzione-Quadro Europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o<br />
autorità territoriali, Madrid 21 maggio 1980 e i suoi protocolli ad<strong>di</strong>zionali;<br />
• Convenzione sulla bio<strong>di</strong>versità, Rio 5 giugno 1992;<br />
• Convenzione sulla tutela del patrimonio mon<strong>di</strong>ale, culturale e naturale, Parigi 16<br />
novembre 1972;<br />
• Convenzione relativa all’accesso all’informazione, alla partecipazione del pubblico al<br />
processo decisionale e all’accesso alla giustizia in materia ambientale, Aarhus 25<br />
giugno 1998;<br />
• Strategia europea per lo sviluppo sostenibile del Consiglio Europeo, Goteborg 12 aprile<br />
2000;<br />
• Delibera C.I.P.E. su Strategia <strong>di</strong> Azione Ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, n.<br />
159 del 2 agosto 2001.<br />
3.3 Efficacia e ambito <strong>di</strong> applicazione<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni del P.P.R. sono imme<strong>di</strong>atamente prevalenti sulle <strong>di</strong>sposizioni contenute negli<br />
strumenti urbanistici dei Comuni e delle Province in tutto o in parte ricompresi negli ambiti <strong>di</strong><br />
paesaggio costiero.<br />
3.4 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico Regionale<br />
Il P.P.R, ai sensi del Co<strong>di</strong>ce dei Beni Culturali e del Paesaggio, in<strong>di</strong>vidua le categorie <strong>di</strong> beni<br />
paesaggistici o beni identitari da sottoporre a specifiche misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a.<br />
Il Piano prevede le misure necessarie per la conservazione, tutela, mantenimento,<br />
miglioramento e ripristino dei valori paesaggistici riconosciuti all’interno degli ambiti <strong>di</strong><br />
paesaggio:<br />
a) conservazione, che comprende il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi<br />
costitutivi e delle morfologie, nonché gli interventi finalizzati al miglioramento strutturale e<br />
funzionale delle componenti <strong>di</strong> paesaggio;<br />
14
) trasformazione ambientale, agroforestale, urbanistica ed e<strong>di</strong>lizia subor<strong>di</strong>nata alla verifica<br />
della loro compatibilità in armonia con i valori paesaggistici riconosciuti;<br />
c) recupero, ricostruzione e rinaturalizzazione, volti a reintegrare i valori paesaggistici<br />
preesistenti ovvero ad attuare nuovi valori paesaggistici, compatibili con le finalità del<br />
P.P.R.<br />
Il P.P.R. sud<strong>di</strong>vide il territorio nei seguenti assetti territoriali, in<strong>di</strong>viduando per ogni assetto i<br />
beni paesaggistici, i beni identitari e le componenti <strong>di</strong> paesaggio e la relativa <strong>di</strong>sciplina<br />
generale costituita da in<strong>di</strong>rizzi e prescrizioni.<br />
• Assetto Ambientale;<br />
• Assetto Storico Culturale;<br />
• Assetto Inse<strong>di</strong>ativo.<br />
3.5 Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale<br />
Le previsioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale si attuano attraverso:<br />
• la pianificazione provinciale e comunale;<br />
• i Piani delle aree protette <strong>di</strong> cui all’articolo 145 del D.Lgs. n°42 del 2004 e s.m.i;<br />
• le intese tra Regione, Province e Comuni interessati.<br />
L’adeguamento della <strong>di</strong>sciplina urbanistica comunale al Piano Paesaggistico Regionale è<br />
regolato ai sensi dell’art. 107, delle N.T.A. del P.P.R.<br />
3.6 Principi e obiettivi<br />
Si assume quin<strong>di</strong>, come obiettivo fondamentale del Piano, <strong>di</strong> mettere il paesaggio a<br />
riferimento <strong>di</strong> una nuova idea <strong>di</strong> Sardegna, <strong>di</strong> una nuova rinascita fondata appunto<br />
sull’identità del territorio. In questo senso, ambiente e storia costituiscono il punto <strong>di</strong> forza del<br />
nuovo modello <strong>di</strong> sviluppo.<br />
Coerentemente con questo presupposto, il P.P.R. sarà formulato sulla base <strong>di</strong> due<br />
orientamenti essenziali:<br />
• identificare le gran<strong>di</strong> invarianti del paesaggio regionale, i luoghi sostanzialmente intatti<br />
dell’identità e della lunga durata, naturale e storica, i valori irrinunciabili e non negoziabili<br />
sui quali fondare il progetto <strong>di</strong> qualità del territorio della Sardegna per il terzo millennio,<br />
costruendo un consenso <strong>di</strong>ffuso sull’esigenza della salvaguar<strong>di</strong>a (“non toccare il territorio<br />
intatto”);<br />
15
• ricostruire, risanare i luoghi delle gran<strong>di</strong> e piccole trasformazioni in atto, recuperare il<br />
degrado che ne è conseguito, sia per abbandono, sia per sovrautilizzo, con una<br />
costruzione partecipata del progetto per le nuove “regole” dei paesaggi locali, in<br />
coerenza con quanto stabilisce la Convenzione Europea sul Paesaggio, che “...concerne<br />
sia i paesaggi che possono esser considerati eccezionali, che i paesaggi della vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana e degradati” 6 .<br />
Si dovrà controllare l’espansione dei centri abitati e la gestione dell’ecosistema urbano<br />
secondo il principio <strong>di</strong> precauzione, conservando e sviluppando il patrimonio naturale e<br />
culturale, alleggerendo la pressione urbanistica eccessiva (in particolare nelle zone costiere).<br />
Dovranno essere attivate politiche settoriali nel rispetto della conservazione della <strong>di</strong>versità<br />
biologica e le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili, adeguando la<br />
compatibilità delle misure <strong>di</strong> sviluppo che incidono sul paesaggio:<br />
• proteggendo il suolo con la riduzione <strong>di</strong> erosioni;<br />
• conservando e recuperando le gran<strong>di</strong> zone umide;<br />
• gestendo e recuperando gli ecosistemi marini;<br />
• conservando e gestendo i paesaggi d’interesse culturale, storico, estetico ed ecologico;<br />
• recuperando i paesaggi degradati dalle attività umane.<br />
Nell’adeguamento del P.U.C. al P.P.R. (art. 107) i Comuni provvedono a:<br />
• in<strong>di</strong>viduare i caratteri connotativi della propria identità e delle peculiarità paesaggistiche;<br />
• definire le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> assetto per realizzare un sistema <strong>di</strong> sviluppo sostenibile;<br />
• determinare le proposte <strong>di</strong> sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche<br />
in considerazione dei valori paesaggistici riconosciuti nel territorio comunale;<br />
• in<strong>di</strong>viduare, sulla base della tipizzazione del P.P.R., gli elementi areali e puntuali del<br />
territorio sottoposti a vincolo in quanto beni paesaggistici e beni identitari;<br />
• stabilire le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica del proprio<br />
territorio;<br />
• in<strong>di</strong>viduare i fattori <strong>di</strong> rischio e gli elementi <strong>di</strong> vulnerabilità del paesaggio;<br />
6 Linee Guida per il lavoro <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposizione del Piano Paesaggistico Regionale (R.A.S.)<br />
16
• regolare e ottimizzare la pressione del sistema inse<strong>di</strong>ativo sull’ambiente naturale,<br />
migliorando la salubrità dell’ambiente urbano e i valori paesaggistici;<br />
• identificare cartograficamente in maniera puntuale gli elementi dell’assetto inse<strong>di</strong>ativo, le<br />
componenti <strong>di</strong> paesaggio, i beni paesaggistici e i beni identitari;<br />
• segnalare le opere incongrue e le opere <strong>di</strong> qualità esistenti nel proprio territorio.<br />
Nell’adeguamento del P.U.C. al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) i<br />
Comuni provvedono a:<br />
• riportare la perimetrazione del P.A.I, relativamente alle aree pericolose H4, H3, H2 e a<br />
rischio R4, R3, R2, alla scala grafica dello strumento urbanistico vigente, adeguando<br />
contestualmente le relative norme;<br />
• quando la traslazione della perimetrazione del P.A.I. nello strumento urbanistico<br />
generale, effettuata dall’Ente interessato, comporti apprezzabili mo<strong>di</strong>fiche dei perimetri <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduazione delle aree pericolose e a rischio, l’Ente locale dovrà richiedere apposito<br />
parere all’Assessorato Regionale dei LL.PP, Servizio Genio Civile, che valuterà<br />
esprimendosi sulle analisi <strong>di</strong> maggiore dettaglio presentate dal <strong>Comune</strong> e redatte in<br />
conformità alle Linee Guida del P.A.I.<br />
3.7 Contenuti dei P.U.C. adeguati al P.P.R.<br />
Il P.U.C. in adeguamento al P.P.R:<br />
• recepisce le prescrizioni del P.P.R. e del Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.);<br />
• completa, verifica e precisa, arricchisce i dati e le informazioni territoriali necessarie alla<br />
costituzione del quadro conoscitivo dettagliato (desunte da quelle elaborate dal P.P.R. e<br />
dal P.U.P.), in coerenza con le specifiche del Sistema Informativo Territoriale Regionale<br />
(S.I.T.R.), fornite allo scopo <strong>di</strong> con<strong>di</strong>videre le conoscenze e unificare le legende <strong>di</strong><br />
restituzione dei tematismi così come previsto dall’art.108 delle Norme Tecniche <strong>di</strong><br />
Attuazione (N.T.A.) del P.P.R;<br />
• caratterizza e precisa le aree della naturalità e seminaturalità e <strong>di</strong> quelle utilizzate a<br />
scopo agroforestale;<br />
• contiene l’in<strong>di</strong>viduazione cartografica delle aree, degli e<strong>di</strong>fici e dei manufatti <strong>di</strong> interesse<br />
storico-monumentale, architettonico e paesaggistico <strong>di</strong> cui all’art.135 del D.Lgs. 22<br />
gennaio 2004, n. 42, e successive mo<strong>di</strong>fiche, svolta previa intesa con le competenti<br />
Soprintendenze;<br />
17
• in<strong>di</strong>vidua in modo dettagliato tessuti <strong>di</strong> antica e prima formazione in funzione dei ruoli<br />
delle reti inse<strong>di</strong>ative territoriali, riconoscendo: assi, poli urbani, margini (eventualmente<br />
fortificati), caratteri dell’e<strong>di</strong>ficato, tessuti e tipologie e<strong>di</strong>lizie, presenza <strong>di</strong> complessi e<br />
manufatti <strong>di</strong> carattere emergente e monumentale, presenza <strong>di</strong> verde storico, parchi,<br />
giar<strong>di</strong>ni e ville, slarghi e piazze, determinando le fasce <strong>di</strong> rispetto dei beni paesaggistici<br />
riconosciuti e <strong>di</strong> quelli identitari;<br />
• recepisce i siti interessati da habitat naturali <strong>di</strong> interesse comunitario, definendo le<br />
misure atte a evitare o ridurre gli effetti negativi sugli stessi, e in<strong>di</strong>vidua eventuali ulteriori<br />
siti <strong>di</strong> elevate caratteristiche naturalistiche;<br />
• delimita le porzioni <strong>di</strong> territorio da sottoporre a speciali norme <strong>di</strong> tutela e <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a.<br />
18
4 Proposta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ce del Rapporto Ambientale<br />
1. Premessa<br />
2. Valutazione Ambientale Strategica<br />
2.1 Quadro normativo <strong>di</strong> riferimento<br />
2.2 Processo <strong>di</strong> Valutazione Ambientale Strategica<br />
2.3 Fasi del processo della Valutazione Ambientale Strategica<br />
2.3.1 Preparazione<br />
2.3.2 Scoping<br />
2.3.3 Elaborazione relazione<br />
2.3.4 Adozione del P.U.C.<br />
2.3.5 Informazione<br />
2.3.6 Consultazione<br />
2.3.7 Esame e valutazione<br />
2.3.8 Parere motivato<br />
2.3.9 Approvazione del Piano<br />
2.3.10 Verifica <strong>di</strong> coerenza<br />
2.3.11 Informazione sulla decisione<br />
2.3.12 Attuazione e gestione<br />
2.4 Consultazione e Partecipazione<br />
3 Adeguamento del P.U.C. al P.P.R.<br />
3.1 Principali riferimenti<br />
3.2 Efficacia e ambito <strong>di</strong> applicazione<br />
3.3 Struttura e contenuti del Piano Paesaggistico Regionale<br />
3.4 Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale<br />
3.5 Principi e obiettivi<br />
3.6 Contenuti del P.U.C. adeguati al P.P.R.<br />
4. Analisi dello stato dell’ambiente<br />
4.1 Lo stato dell’ambiente nel territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
4.2 Analisi S.W.O.T.<br />
4.3 Criticità ambientali<br />
5. In<strong>di</strong>viduazione dei Piani e Programmi <strong>di</strong> riferimento per il P.U.C. <strong>di</strong><br />
<strong>Monserrato</strong><br />
6. Contenuto del P.U.C. <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
6.1 Analisi <strong>di</strong> coerenza esterna del P.U.C. <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> rispetto a Piani e Programmi<br />
pertinenti<br />
6.2 Obiettivi del P.U.C.<br />
6.2.1 Obiettivi generali del P.U.C. <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
6.2.2 Obiettivi specifici del P.U.C. <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
7. Alternative in<strong>di</strong>viduate per il P.U.C. <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
8. Sostenibilità ambientale del Piano<br />
8.1 Criteri <strong>di</strong> sostenibilità ambientale<br />
8.2 Contestualizzazione dei criteri <strong>di</strong> sostenibilità ambientale per il P.U.C. <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
19
8.3 Analisi della sostenibilità ambientale del P.U.C.<br />
8.4 Analisi della coerenza delle azioni del P.U.C. rispetto agli obiettivi <strong>di</strong> sostenibilità<br />
ambientale<br />
9. Analisi degli effetti significativi del P.U.C. sull’ambiente<br />
9.1 Valutazione degli effetti delle azioni del Piano sul territorio <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
9.2 Problemi specifici rispetto alle aree <strong>di</strong> particolare rilevanza ambientale<br />
potenzialmente interessate dal Piano<br />
9.3 Quadro <strong>di</strong> sintesi degli effetti ambientali<br />
9.3.1 Effetti <strong>di</strong>retti<br />
9.3.2 Effetti <strong>di</strong>retti, cumulativi e sinergici<br />
10. Misure <strong>di</strong> mitigazione e compensazione<br />
11. Il sistema <strong>di</strong> monitoraggio<br />
11.1 Gli in<strong>di</strong>catori<br />
11.2 Le relazioni <strong>di</strong> monitoraggio<br />
12. Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale<br />
20
5 Rapporto Ambientale<br />
Il Rapporto Ambientale è il <strong>documento</strong> che, come stabilito dall’art.5 del D.Lgs 152 del 2006,<br />
deve essere redatto ogni qualvolta si attui una procedura <strong>di</strong> Valutazione Ambientale<br />
Strategica.<br />
L’art.9 del D.Lgs 152 del 2006 regola la redazione del Rapporto Ambientale:<br />
• “Sulla base <strong>di</strong> un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi<br />
dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in<br />
consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività <strong>di</strong> elaborazione <strong>di</strong> piani e<br />
programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia<br />
ambientale, al fine <strong>di</strong> definire la portata ed il livello <strong>di</strong> dettaglio delle informazioni da<br />
includere nel rapporto ambientale”;<br />
• “Nel rapporto ambientale debbono essere in<strong>di</strong>viduati, descritti e valutati gli impatti<br />
significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere<br />
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono<br />
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del<br />
programma stesso”.<br />
INFORMAZIONI AMBIENTALI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE<br />
(All. VI della Direttiva V.A.S.)<br />
• illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto<br />
con altri pertinenti piani o programmi;<br />
• aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza<br />
l’attuazione del piano del programma;<br />
• caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere<br />
significativamente interessate;<br />
• qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi<br />
in particolare quelli relativi ad aree <strong>di</strong> particolare rilevanza ambientale, culturale e<br />
paesaggistica, quali le zone designate come Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale per la<br />
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti <strong>di</strong> importanza<br />
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica,<br />
nonché i territori con produzioni agricole <strong>di</strong> particolare qualità e tipicità, <strong>di</strong> cui all’articolo<br />
21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.<br />
• obiettivi <strong>di</strong> protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati<br />
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua<br />
preparazione, si è tenuto conto <strong>di</strong> detti obiettivi e <strong>di</strong> ogni considerazione ambientale;<br />
21
• possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la bio<strong>di</strong>versità, la<br />
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici,<br />
i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio<br />
e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti<br />
significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, me<strong>di</strong>o e lungo<br />
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;<br />
• misure previste per impe<strong>di</strong>re, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli<br />
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del<br />
programma;<br />
• sintesi delle ragioni della scelta delle alternative in<strong>di</strong>viduate e una descrizione <strong>di</strong> come è<br />
stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali <strong>di</strong>fficoltà incontrate (ad esempio<br />
carenze tecniche o <strong>di</strong>fficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per<br />
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;<br />
• descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti<br />
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto<br />
definendo, in particolare, le modalità <strong>di</strong> raccolta dei dati e <strong>di</strong> elaborazione degli in<strong>di</strong>catori<br />
necessari alla valutazione degli impatti, la perio<strong>di</strong>cità della produzione <strong>di</strong> un rapporto<br />
illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;<br />
• sintesi non tecnica delle informazioni <strong>di</strong> cui alle lettere precedenti.<br />
22
6 Sostenibilità ambientale<br />
La Direttiva V.A.S. fa richiamo ad “un elevato livello <strong>di</strong> protezione dell’ambiente e contribuire<br />
all’integrazione <strong>di</strong> considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e<br />
approvazione <strong>di</strong> detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle<br />
con<strong>di</strong>zioni per uno sviluppo sostenibile” (art.4 del D.Lgs 152 del 2006).<br />
La V.A.S. ha la finalità <strong>di</strong> proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente<br />
alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità <strong>di</strong><br />
riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa<br />
in<strong>di</strong>vidua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le<br />
<strong>di</strong>sposizioni del presente decreto, gli impatti <strong>di</strong>retti e in<strong>di</strong>retti <strong>di</strong> un progetto sui seguenti fattori:<br />
1) l’uomo, la fauna e la flora;<br />
2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;<br />
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;<br />
4) l’interazione tra i fattori <strong>di</strong> cui sopra.<br />
L’analisi ambientale deve inquadrare quale sia lo stato attuale del territorio e in<strong>di</strong>viduare gli<br />
impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere<br />
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono<br />
adottarsi, in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del Piano o del Programma<br />
stesso.<br />
Per l’analisi ambientale sarà fondamentale:<br />
• l’in<strong>di</strong>viduazione degli obiettivi;<br />
• l’in<strong>di</strong>viduazione degli impatti ambientali potenziali;<br />
• l’in<strong>di</strong>viduazione degli in<strong>di</strong>catori più opportuni per rappresentare i processi ambientali,<br />
inse<strong>di</strong>ativi e socio-economici del territorio <strong>di</strong> riferimento.<br />
Gli obiettivi <strong>di</strong> sostenibilità del Piano dovranno essere raggiungibili entro un tempo<br />
ragionevolmente compatibile con i tempi <strong>di</strong> aggiornamento decennale del Piano stesso.<br />
Gli effetti e gli impatti ambientali, <strong>di</strong>retti ed in<strong>di</strong>retti del Piano, dovranno essere considerati in<br />
tutto il territorio comunale, con particolare attenzione verso quelle zone dove possano esserci<br />
delle sovrapposizioni degli effetti e verso quelle zone che presentino sostanziali mo<strong>di</strong>fiche per<br />
quanto riguarda la parte antropica e naturale.<br />
23
Gli in<strong>di</strong>catori dovranno descrivere le componenti ambientali attraverso la scelta tra gli<br />
in<strong>di</strong>catori riconosciuti a livello internazionale (E.E.A, Eurostat, O.C.S.E.), nazionale (I.S.T.A.T,<br />
A.P.A.T.) e regionale (A.R.P.A. Sardegna).<br />
6.1 Analisi del quadro ambientale e territoriale<br />
Le informazioni <strong>di</strong>sponibili sullo stato e sulle tendenze ambientali a livello locale sono<br />
finalizzate a costruire un quadro <strong>di</strong> sintesi delle specificità territoriali, ambientali e socio-<br />
economiche, che vengono reperite e messe a sistema per qualificare e quantificare le<br />
principali criticità e valenze con le quali il nuovo piano è chiamato a confrontarsi.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una analisi per ricavare le principali Criticità/Opportunità a cui si da risposta con<br />
gli Obiettivi <strong>di</strong> Piano.<br />
Questa fase prevede anche la creazione <strong>di</strong> un catalogo dei dati <strong>di</strong>sponibili presso il <strong>Comune</strong> e<br />
altre fonti.<br />
Il monitoraggio comincia attraverso questo quadro conoscitivo iniziale che, attraverso l’uso <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>catori, <strong>di</strong>venta parte integrante del sistema <strong>di</strong> monitoraggio stesso.<br />
I <strong>di</strong>versi aspetti ambientali e territoriali in ambito comunale vengono sud<strong>di</strong>visi in varie<br />
tematiche (Es. aria, acqua, suolo, sottosuolo, rumore, flora, fauna, bio<strong>di</strong>versità, paesaggio,<br />
qualità urbana, patrimonio storico-architettonico, rischi tecnologici, caratteristiche economico-<br />
sociali, ecc..), e completati da una sintetica scheda informativa che evidenzi:<br />
• fonti dei dati;<br />
• livello e qualità delle informazioni <strong>di</strong>sponibili, loro aggiornamento e aggiornabilità;<br />
• descrizione della tematica;<br />
• principali elementi quantitativi (es. aree interessate, numero specie, veicoli/ora, ecc.);<br />
• stato <strong>di</strong> fatto e tendenze manifeste;<br />
• politiche in atto, criticità attuali o potenziali future,e le priorità ad esse legate;<br />
• opportunità <strong>di</strong> sviluppo, salvaguar<strong>di</strong>a, recupero, ecc.<br />
Sulla base dei risultati derivanti dalle analisi territoriali sarà possibile costruire un quadro <strong>di</strong><br />
sintesi tramite lo strumento dell’analisi S.W.O.T. 7 , in grado <strong>di</strong> descrivere lo stato<br />
dell’ambiente, che permetta con il rior<strong>di</strong>no delle conoscenze dell’assetto ambientale,<br />
7 Forza (Strengths), Debolezza (Weaknesses), Opportunità (Opportunities), Minacce (Threats)<br />
24
inse<strong>di</strong>ativo e storico-culturale degli ambiti <strong>di</strong> paesaggio locale, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare azioni coerenti<br />
con il contesto territoriale e <strong>di</strong> definire in<strong>di</strong>catori in grado <strong>di</strong> descrivere i processi territoriali<br />
scelti sulla base <strong>di</strong> quanto evidenziato dall’analisi ambientale.<br />
Viene costruita una tabella riassuntiva contenente le tematiche e le principali criticità e/o<br />
opportunità relative ad ognuna <strong>di</strong> esse.<br />
Al termine vengono descritte le questioni principali cui il Piano deve dare risposta e la loro<br />
influenza sulle alternative strategiche dello stesso.<br />
6.2 Caratterizzazione delle aree<br />
A supporto della Valutazione Ambientale Strategica si possono elaborare delle specifiche<br />
cartografie <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento, ad esempio, relative al quadro conoscitivo (carta delle<br />
criticità), in cui è rappresentato sinteticamente lo stato del territorio e in cui sono riportate tutte<br />
le informazioni <strong>di</strong>sponibili. L’approfon<strong>di</strong>mento ha la finalità <strong>di</strong> comprendere, quanto prima, le<br />
maggiori limitazioni derivanti da criticità ambientali o da elementi <strong>di</strong> pregio da salvaguardare e<br />
relative alla sintesi valutativa dei gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> idoneità del territorio ad essere trasformato (carta<br />
dell’idoneità alla trasformazione del territorio).<br />
6.3 Valutazione degli scenari e in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> criticità e vantaggi <strong>di</strong> ognuno <strong>di</strong> essi<br />
Si possono in<strong>di</strong>viduare alcune possibili linee <strong>di</strong> sviluppo, tra le quali anche il mantenimento<br />
dello stato attuale (opzione zero).<br />
Il confronto e la valutazione <strong>di</strong> tutte le macro-alternative avviene attraverso una tabella<br />
“good&bad” che permette <strong>di</strong> evidenziare le positività e le negatività <strong>di</strong> ogni scenario.<br />
6.4 Definizione degli obiettivi <strong>di</strong> piano<br />
Le opzioni strategiche del piano vengono poi scomposte in una serie <strong>di</strong> obiettivi.<br />
L’in<strong>di</strong>viduazione degli obiettivi <strong>di</strong>pende quin<strong>di</strong> dai risultati del Quadro Conoscitivo, al termine<br />
del quale vengono descritte le questioni principali (criticità/opportunità) a cui il Piano deve<br />
dare risposta e la loro influenza sulle alternative strategiche dello stesso:<br />
Criticità/Opportunità Obiettivi<br />
Infatti ai fini della valutazione è necessario evidenziare gli obiettivi che si vogliono<br />
raggiungere attraverso il Piano.<br />
25
6.5 Valutazione della sostenibilità degli obiettivi<br />
Si passa quin<strong>di</strong> a valutare tutti gli obiettivi del Piano, incrociando tali obiettivi con una serie <strong>di</strong><br />
accre<strong>di</strong>tati criteri <strong>di</strong> sostenibilità, selezionati in funzione della rilevanza nel contesto in esame.<br />
Come afferma anche la Commissione Europea (1998, Manuale per la valutazione ambientale<br />
dei Piani <strong>di</strong> Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fon<strong>di</strong> strutturali) occorre notare che tali<br />
criteri devono essere adattati alla realtà locale, risultando in questo modo più dettagliati e<br />
maggiormente ancorati a singole attività, pressioni e componenti ambientali, e per questo più<br />
utili nella fase <strong>di</strong> valutazione. Si origina così la prima Matrice <strong>di</strong> Valutazione.<br />
Essa consente una verifica <strong>di</strong> carattere strategico: il Piano, essendo ancora in fase iniziale,<br />
può infatti avvalersi delle in<strong>di</strong>cazioni che emergono dall’attività <strong>di</strong> valutazione.<br />
Per questo, una volta in<strong>di</strong>viduate le “con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> crisi”, vengono fornite puntuali in<strong>di</strong>cazioni<br />
per la definizione degli interventi strategici o per la fase <strong>di</strong> attuazione del Piano o, ancora,<br />
introdotte misure <strong>di</strong> mitigazione e/o <strong>di</strong> compensazione per attenuare il potenziale impatto<br />
della criticità in<strong>di</strong>viduata.<br />
Nel caso in cui scaturisca, dall’incrocio degli elementi, un’interazione negativa o<br />
presumibilmente tale si procede agli opportuni approfon<strong>di</strong>menti.<br />
6.6 Definizione delle azioni <strong>di</strong> piano<br />
Si procede poi a dettagliare ogni singolo Obiettivo (verificato dalla prima matrice) in Azioni,<br />
che permettono <strong>di</strong> descriverne e circostanziarne gli elementi fondamentali.<br />
Il processo logico è quin<strong>di</strong> il seguente:<br />
Criticità/Opportunità Obiettivi Azioni<br />
Il processo logico è poi riportato in una tabella apposita, secondo il seguente schema:<br />
26
Questa attività muove dall’in<strong>di</strong>viduazione e dall’analisi degli interventi <strong>di</strong> carattere strategico,<br />
quelli cioè più rilevanti per conseguire gli obiettivi del Piano.<br />
6.6.1 Valutazione della compatibilità delle azioni del piano con le componenti<br />
ambientali<br />
Gli esiti del confronto sono rappresentati da una matrice <strong>di</strong> valutazione che permetta una<br />
valutazione del grado <strong>di</strong> compatibilità dei singoli interventi.<br />
Si procede ad approfon<strong>di</strong>re i casi <strong>di</strong> interazione negativa o potenzialmente tale, per<br />
evidenziare le misure <strong>di</strong> mitigazione e/o compensazione degli impatti.<br />
La valutazione degli effetti delle azioni <strong>di</strong> Piano sull’ambiente privilegerà l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong><br />
alternative, con riferimento alla localizzazione e alla tipologia dell’azione progettuale,<br />
attraverso un approccio valutativo <strong>di</strong> tipo multicriteriale.<br />
Il modello più largamente adottato è il D.P.S.I.R. 8 elaborato dell'Agenzia Europea per<br />
l’Ambiente, nel quale le componenti sono connesse tra loro da relazioni <strong>di</strong> tipo causale.<br />
Il modello D.P.S.I.R. mette in relazione i <strong>di</strong>versi in<strong>di</strong>catori che sono in nostro possesso e<br />
permette <strong>di</strong> ricercare <strong>di</strong>rettamente le cause determinanti e <strong>di</strong> pressione <strong>di</strong> ogni criticità.<br />
8 Determinante, Pressione, Stato, Impatto, Risposta<br />
27
6.6.2 Misure <strong>di</strong> mitigazione/compensazione, alternative, effetti/impatti delle azioni del<br />
Piano<br />
La valutazione prende in esame i seguenti elementi:<br />
• l’in<strong>di</strong>viduazione degli impatti potenziali. Questo punto è costituito dalla matrice che<br />
incrocia le componenti ambientali con le attività potenzialmente impattanti. È questa una<br />
matrice <strong>di</strong> “screening”, in<strong>di</strong>spensabile per i successivi approfon<strong>di</strong>menti. Quando infatti si<br />
evidenzia un impatto negativo o potenzialmente tale, si arriva alla fase successiva.<br />
• la valutazione su rilevanza, reversibilità degli impatti, le ulteriori alternative, le misure <strong>di</strong><br />
mitigazione, le misure <strong>di</strong> compensazione, quale ulteriore contributo.<br />
Questa parte valutativa si fonda su una metodologia procedurale basata su 4 livelli principali:<br />
1) approfon<strong>di</strong>mento dello screening dove viene esplicitata parte della matrice con<br />
l’evidenziazione degli impatti negativi o potenzialmente tali.<br />
2) valutazione della significatività si basa su fattori in base a:<br />
• le caratteristiche e il valore percepito dell’ambiente colpito;<br />
• la significatività, la <strong>di</strong>ffusione spaziale e la durata del cambiamento previsto;<br />
• la capacità dell’ambiente <strong>di</strong> resistere al cambiamento;<br />
• l’affidabilità delle previsioni relative ai possibili cambiamenti;<br />
• la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> politiche, programmi, piani ecc, utilizzabili come criteri;<br />
• l’esistenza <strong>di</strong> standard ambientali in base ai quali valutare una proposta<br />
(p.es.norme per la qualità dell’aria o dell’acqua);<br />
• il grado d’interesse e <strong>di</strong> relazione dell’opinione pubblica con le risorse<br />
ambientali in causa e le problematiche associate alla proposta <strong>di</strong> progetto;<br />
• le possibilità <strong>di</strong> mitigazione, sostenibilità e reversibilità.<br />
3) valutazione degli impatti significativi, analisi dell’impatto preso in maniera<br />
singola o in maniera cumulativa, e in<strong>di</strong>viduazione delle misure <strong>di</strong> mitigazione<br />
eventualmente necessarie. Se le misure <strong>di</strong> mitigazione non appaiono sufficienti si<br />
rimanda ad ulteriori valutazioni.<br />
Occorre in<strong>di</strong>viduare i tipi <strong>di</strong> impatto, che si identificano con effetti:<br />
• <strong>di</strong>retti e in<strong>di</strong>retti;<br />
• a breve e a lungo termine;<br />
28
• legati alla costruzione, all’operatività e allo smantellamento;<br />
• isolati, interattivi e cumulativi.<br />
Per valutare le misure <strong>di</strong> mitigazione è necessario elencare e spiegare in che modo le<br />
misure consentiranno <strong>di</strong> scongiurare gli effetti negativi sull’area e in che modo le misure<br />
consentiranno <strong>di</strong> ridurre gli effetti negativi sull’area stessa.<br />
Le misure <strong>di</strong> mitigazione vanno valutate a seconda degli effetti negativi e comunque sarebbe<br />
sempre meglio evitare gli effetti alla fonte.<br />
Occorre in<strong>di</strong>viduare le misure <strong>di</strong> mitigazione analizzando:<br />
• eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi, evitando, se possibile, impatti<br />
negativi;<br />
• alternative strategiche, che consistono nella in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> misure per prevenire la<br />
domanda e/o in misure <strong>di</strong>verse per realizzare lo stesso obiettivo;<br />
• alternative localizzative ;<br />
• alternative strutturali, in cui si analizzano le possibili destinazioni d’uso inse<strong>di</strong>abili;<br />
• alternative <strong>di</strong> processo, che consistono nell’esame <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti tipologie e<strong>di</strong>lizie, <strong>di</strong><br />
tecnologie e processi e <strong>di</strong> materie prime da utilizzare;<br />
• alternative <strong>di</strong> compensazione o <strong>di</strong> mitigazione degli effetti negativi per limitare gli impatti<br />
negativi non eliminabili;<br />
• l’alternativa zero, che consiste nella non realizzazione del progetto;<br />
• definizione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> compensazione nel caso che le considerazioni sulle mitigazioni e<br />
sulle alternative non abbiano portato agli effetti voluti.<br />
Le misure compensative devono essere valutate per accertare che siano appropriate per il<br />
sito e che siano in grado <strong>di</strong> mantenere la coerenza ambientale globale del Piano.<br />
Nel caso in cui dall’incrocio degli elementi della Matrice <strong>di</strong> Valutazione scaturisse<br />
un’interazione negativa o presumibilmente tale si dovrà procedere agli opportuni<br />
approfon<strong>di</strong>menti per determinare se l’impatto sia:<br />
1) assente dopo l’approfon<strong>di</strong>mento o impatto eliminabile;<br />
2) non eliminabile, ma con la possibilità <strong>di</strong> misure che portino alla mitigazione dell’impatto;<br />
3) non mitigabile, con l’unica scelta <strong>di</strong> proporre soluzioni alternative;<br />
4) senza misure mitigative e alternative praticabili con il conseguente abbandono<br />
dell’azione.<br />
29
L’analisi dei Piani e Programmi sovralocali e <strong>di</strong> pari livello, rivolta ad esplicitare obiettivi e<br />
in<strong>di</strong>rizzi che potrebbero avere relazioni <strong>di</strong>rette con il P.U.C, è finalizzata:<br />
• a costruire un quadro d’insieme strutturato, contenente gli obiettivi ambientali fissati dalle<br />
politiche e dagli altri Piani e Programmi territoriali o settoriali, comunque utili alla<br />
definizione <strong>di</strong> azioni progettuali per la pianificazione attuativa coerente con quanto<br />
previsto alla scala intercomunale, provinciale e regionale.<br />
6.6.3 Rimodulazione degli obiettivi del P.U.C. e in<strong>di</strong>viduazione delle azioni progettuali<br />
In questa fase potrà essere verificata l’esistenza <strong>di</strong> contrad<strong>di</strong>zioni all’interno del Piano e<br />
mo<strong>di</strong>ficati gli obiettivi del P.U.C. Attraverso una griglia <strong>di</strong> relazioni è possibile in<strong>di</strong>viduare<br />
obiettivi non <strong>di</strong>chiarati, non perseguiti, oppure ancora obiettivi e in<strong>di</strong>catori conflittuali.<br />
30
7 Piani e Programmi pertinenti al P.U.C. <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
Si fornisce, <strong>di</strong> seguito, un primo elenco dei Piani e Programmi pertinenti con il Piano<br />
Urbanistico Comunale <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong>, rispetto ai quali, nel Rapporto Ambientale, sarà svolta<br />
l’analisi <strong>di</strong> coerenza esterna dello stesso P.U.C., approfondendo e specificando eventuali<br />
relazioni e interferenze.<br />
PIANO O PROGRAMMA RIFERIMENTO NORMATIVO STATO DI AVANZAMENTO<br />
Piano Paesaggistico<br />
Regionale<br />
Piano <strong>di</strong> Assetto<br />
Idrogeologico<br />
Piano Territoriale <strong>di</strong><br />
Coor<strong>di</strong>namento ed<br />
Urbanistico Provinciale<br />
Piano Strategico<br />
Intercomunale<br />
Piano Forestale Ambientale<br />
Regionale<br />
Piano <strong>di</strong> Gestione dei Rifiuti<br />
della Regione Sardegna<br />
Piano <strong>di</strong> Tutela delle Acque<br />
Piano <strong>di</strong> prevenzione,<br />
conservazione e risanamento<br />
della qualità dell’aria ambiente<br />
in Sardegna<br />
Piano Energetico Ambientale<br />
Regionale<br />
Piano regionale <strong>di</strong> previsione,<br />
prevenzione e lotta attiva<br />
contro gli incen<strong>di</strong> boschivi<br />
2008/2010 - Revisione anno<br />
2008<br />
L.R. n. 8 del 25.11.2004<br />
Legge 183/89, art. 17, comma<br />
6, ter - D.L. 180/98 e Legge<br />
267/1998<br />
art. 15 della L. n. 142/1990 (e<br />
successivi aggiornamenti) e<br />
dall’art. 16 della L.R. n.<br />
45/1989<br />
D.Lgs. 227/2001, art. 3,<br />
comma 1<br />
D.Lgs. 152/2006, art. 199<br />
D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e<br />
dell'art. 2 della L.R. luglio<br />
2000, n. 14<br />
D.Lgs. n. 351/1999, art. 6<br />
D.Lgs. n. 112 del 31 marzo<br />
1998<br />
Legge n. 353 del 21.11.2000<br />
Approvato con D.G.R. n. 36/7<br />
del 5.9.2006<br />
Approvato con Delibera<br />
R.A.S. n. 54/33 del<br />
30/12/2004 e con s.m.i. con<br />
D.G.R. n. 17/14 del 26.4.2006<br />
Approvato con Deliberazione<br />
C.P. n. 133 del 19.12.2002, è<br />
vigente dal 19.02.2004; la<br />
variante al PUP in<br />
adeguamento al PPR è stata<br />
approvata con Deliberazione<br />
C.P. n. 81 del 10.12.2007<br />
in via <strong>di</strong> approvazione<br />
Approvato con Delibera 53/9<br />
del 27.12.2007<br />
Approvato con D.G.R. n. 73/7<br />
del 20.12.2008<br />
Approvato con D.G.R. n.<br />
14/16 del 4.4.2006<br />
Approvato con D.G.R. n. 55/6<br />
del 29.11.2005<br />
Adottato con D.G.R. n. 34/13<br />
del 2.8.2006<br />
Revisione 2008 approvata<br />
deliberazione n° 33/17 del<br />
10.6.2008<br />
31
P.O.R. Sardegna<br />
“Competitività Regionale e<br />
Occupazione" Fondo Sociale<br />
Europeo 2007-2013<br />
Piano dei Trasporti<br />
Programma <strong>di</strong> Sviluppo<br />
Rurale per la Sardegna<br />
2007/2013<br />
Piano <strong>di</strong> Bonifica dei siti<br />
inquinati<br />
Adottato con Decisione<br />
Comunitaria C (2007) 6081<br />
del 30.11.2007<br />
L.R. n. 21/2005 art. 14,<br />
comma 3.<br />
Regolamento CE n.<br />
1698/2005, art. 18<br />
D. Lgs. n. 22/1997, art. 22<br />
Deliberazione n. 4/24 del<br />
22.01.2008<br />
Adottato con deliberazione n°.<br />
66/23 del 27.11.2008<br />
Approvato con D.G.R. n. 24/1<br />
del 28.6.2007<br />
Pre<strong>di</strong>sposto<br />
dall'Amministrazione<br />
Regionale in tre sezioni:<br />
Sezione rifiuti urbani,<br />
approvato con D.G.R. del<br />
17/12/1998, n. 57/2;<br />
Sezione del Piano dei rifiuti<br />
speciali approvato con D.G.R.<br />
del 30/04/2002, n. 13/34;<br />
Piano Regionale <strong>di</strong> gestione<br />
degli imballaggi e dei rifiuti <strong>di</strong><br />
imballaggio approvato con<br />
D.G.R. del 29/08/2002, n.<br />
29/13.<br />
32
8 Elenco dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale<br />
I Soggetti competenti in materia ambientale che saranno coinvolti nel processo <strong>di</strong> Valutazione<br />
Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> sono i seguenti:<br />
A.R.P.A.S.<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Cagliari<br />
Viale Ciusa, 6 - 09131 Cagliari<br />
Fax 070/6092638<br />
Azienda Usl n°8 - Dipartimento <strong>di</strong> Prevenzione<br />
Via Romagna, 16 - 09127 Cagliari<br />
Fax 070/47443656<br />
Regione Autonoma della Sardegna<br />
Assessorato della Difesa dell’Ambiente<br />
Direzione Generale del Corpo Forestale e <strong>di</strong> Vigilanza Ambientale<br />
Via Biasi, 7 - 09131 Cagliari<br />
Fax 070/6066568<br />
Regione Autonoma della Sardegna<br />
Assessorato della Difesa dell’Ambiente<br />
Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente<br />
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari<br />
Fax 070/6066697<br />
Regione Autonoma della Sardegna<br />
Assessorato della Difesa dell’Ambiente<br />
Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente<br />
Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazione Impatti e Sistemi Informativi Ambientali<br />
Via Roma, 80 - 09123 Cagliari<br />
Fax 070/6067578<br />
33
Regione Autonoma della Sardegna<br />
Assessorati Enti Locali, Finanze e Urbanistica<br />
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza E<strong>di</strong>lizia<br />
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari<br />
Fax 070/6064319<br />
Regione Autonoma della Sardegna<br />
Assessorati Enti Locali, Finanze e Urbanistica<br />
Direzione Generale Enti Locali e Finanze<br />
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari<br />
Fax 070/6064179<br />
Regione Autonoma della Sardegna<br />
Assessorato Lavori Pubblici<br />
Direzione Generale dei Lavori Pubblici<br />
Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari<br />
Fax 070/6062438<br />
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la provincia <strong>di</strong> Cagliari<br />
Piazza In<strong>di</strong>pendenza, 7 - 09124 Cagliari<br />
Fax 070/658871<br />
Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed<br />
Etnoantropologico per la provincia <strong>di</strong> Cagliari<br />
Via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari<br />
Fax 070/2010352<br />
Provincia <strong>di</strong> Cagliari<br />
Assessorato Programmazione e Pianificazione Territoriale<br />
Via Cadello, 9/b - 09121 Cagliari<br />
Fax 070/4092823<br />
34
Regione Autonoma della Sardegna<br />
Servizio del Genio Civile <strong>di</strong> Cagliari<br />
Via San Simone, 60 - 09123 Cagliari<br />
Fax 070/6066979 - 6934<br />
Regione Autonoma della Sardegna<br />
Direzione Generale dei Trasporti<br />
Fax 070/6067309<br />
Direzione Generale per il trasporto pubblico locale<br />
Fax 070/6067333<br />
Via Caprera, 15 - 09123 Cagliari<br />
Provincia <strong>di</strong> Cagliari<br />
Assessorato Lavori Pubblici, Viabilità, Patrimonio e Sicurezza<br />
Via Cadello, 9 - 09121 Cagliari<br />
Fax. 070/4092290<br />
Ente Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline<br />
E<strong>di</strong>ficio Sali Scelti<br />
Via la Palma s/n - 09129 Cagliari<br />
Fax. 07037919300<br />
Università <strong>di</strong> Cagliari<br />
Direzione Amministrativa<br />
Via Università, 40 - 09124 Cagliari<br />
Fax: 070 658895<br />
TERNA<br />
ENEL Servizio Elettrico SpA – Sardegna<br />
P.zza Deffenu 1 - 09125 Cagliari<br />
tel: 070 3522162<br />
35
Sardegna Ricerche<br />
Sede Centrale<br />
E<strong>di</strong>ficio 2 Loc. Piscinamanna - 09010 Pula (CA)<br />
Fax 070 9243.2203<br />
Sindaco On. Dott. Emilio Floris<br />
Ufficio <strong>di</strong> Gabinetto del Sindaco<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Cagliari<br />
Via Roma 145 – 09124 Cagliari<br />
Fax: 070 6777011<br />
Sindaco Gian Franco Cappai.<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Selargius<br />
Piazza Cellarium 09047 Selargius (CA)<br />
Telefono 07085921.<br />
e-mail sindaco@comune.selargius.ca.it<br />
Sindaco Aldo Pili<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Sestu<br />
Via Scipione, 1 – 09028 Sestu (CA)<br />
Fax 2360331<br />
sindaco@comune.sestu.ca.it<br />
Ciascun soggetto può apportare al processo complessivo un contributo <strong>di</strong> conoscenza e <strong>di</strong><br />
identificazione dei problemi e delle potenzialità, al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare ambiti comuni <strong>di</strong><br />
operatività per progetti <strong>di</strong> valenza intercomunale.<br />
36
9 Schede<br />
SCHEDA N. 1 – QUALITA’ DELL’ARIA<br />
La <strong>di</strong>rettiva madre 1996/62/EC è stata recepita dall’Italia attraverso il D.Lgs. 351/1999; le<br />
<strong>di</strong>rettive tecniche per l’elaborazione preliminare della qualità dell’aria 9 in<strong>di</strong>cata in alcuni articoli<br />
del D.Lgs. sono contenute del DM 261/2002.<br />
Il Decreto legislativo 4 Agosto 1999, n.351:<br />
• all’art. 7 prevede che le regioni provvedano, in conseguenza delle attività <strong>di</strong> valutazione<br />
della qualità dell’aria, ad in<strong>di</strong>viduare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli <strong>di</strong> uno<br />
o più inquinanti 10 comportino il rischio <strong>di</strong> superamento dei valori limite e delle soglie <strong>di</strong><br />
allarme e in<strong>di</strong>viduino l’autorità competente alla gestione <strong>di</strong> tali situazioni <strong>di</strong> rischio.<br />
• all’art. 8 prescrive alle regioni <strong>di</strong> provvedere alla definizione <strong>di</strong> una lista <strong>di</strong> zone e <strong>di</strong><br />
agglomerati nei quali:<br />
1) i livelli <strong>di</strong> uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine <strong>di</strong><br />
tolleranza (o se non definito il margine <strong>di</strong> tolleranza per uno specifico inquinante,<br />
eccedano il valore limite);<br />
2) i livelli <strong>di</strong> uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite<br />
aumentato del margine <strong>di</strong> tolleranza.<br />
• all’art. 9 prescrive alle regioni <strong>di</strong> provvedere alla definizione delle zone e degli<br />
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non<br />
comportare il rischio <strong>di</strong> superamento degli stessi.<br />
Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 fissa all’Articolo 4 e all’allegato VII, sezione II i<br />
criteri per la classificazione.<br />
Ai fini della verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati, i superamenti delle<br />
soglie <strong>di</strong> valutazione, superiore e inferiore, vanno determinati in base alle concentrazioni 11 del<br />
quinquennio precedente laddove siano <strong>di</strong>sponibili dati sufficienti. Si considera superata una<br />
soglia <strong>di</strong> valutazione se essa, nel quinquennio precedente, è stata superata, per almeno tre<br />
anni, anche se non consecutivi.<br />
9 insieme dei gas, vapori, polveri, microorganismi e residui biologici presenti nell’atmosfera terrestre<br />
10 “ogni mo<strong>di</strong>ficazione della normale composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella<br />
stessa <strong>di</strong> uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali con<strong>di</strong>zioni ambientali e<br />
<strong>di</strong> salubrità dell’aria”- Dpr del 24 maggio 1988, n. 203, art. 2, comma 4<br />
11 quantità <strong>di</strong> sostanza inquinante presente in atmosfera per unità <strong>di</strong> volume<br />
37
Se i dati relativi al quinquennio non sono interamente <strong>di</strong>sponibili, per determinare i<br />
superamenti delle soglie <strong>di</strong> valutazione superiore e inferiore, attraverso i risultati ottenuti dalle<br />
informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni 12 e dalla modellizzazione, si possono<br />
combinare campagne <strong>di</strong> misurazione <strong>di</strong> breve durata nel periodo dell’anno e nei siti<br />
rappresentativi dei massimi livelli <strong>di</strong> inquinamento.<br />
La classificazione è riesaminata almeno ogni 5 anni. Il riesame è anticipato nel caso <strong>di</strong><br />
cambiamenti significativi delle attività che influenzino i livelli nell’ambiente <strong>di</strong> biossido <strong>di</strong> zolfo,<br />
<strong>di</strong> biossido <strong>di</strong> azoto, <strong>di</strong> benzene o <strong>di</strong> monossido <strong>di</strong> carbonio, oppure, nel caso, <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
azoto, <strong>di</strong> materiale particolato o <strong>di</strong> piombo.<br />
Inquinanti<br />
Sono stati presi in considerazione i seguenti principali inquinanti dell’aria:<br />
• ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> zolfo (SOx: SO2+SO3);<br />
• ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> azoto (NOx: NO+NO2);<br />
• composti organici volatili, con l’esclusione del metano, (COVNM);<br />
• monossido <strong>di</strong> carbonio (CO);<br />
• particelle sospese con <strong>di</strong>ametro inferiore a 10 micron (PM10);<br />
• ammoniaca (NH3);<br />
• metalli pesanti: arsenico, cadmio, nichel, piombo, cromo, mercurio, rame, selenio, zinco;<br />
• gas serra: anidride carbonica, metano, protossido <strong>di</strong> azoto.<br />
Sono state inoltre registrate le emissioni <strong>di</strong> eventuali altri inquinanti documentati dalle aziende<br />
nell’ambito degli adempimenti al D.P.R. 203/88.<br />
Oltre alle misure da stazioni fisse, possono essere utilizzate altre tecniche <strong>di</strong> misura come<br />
campionatori passivi, laboratori mobili, modelli <strong>di</strong> simulazione e altre tecniche <strong>di</strong> stima dei<br />
livelli <strong>di</strong> concentrazione. Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> non è dotato <strong>di</strong> rete <strong>di</strong> rilevamento della<br />
qualità dell’aria ed il monitoraggio è stato effettuato attraverso una stazione mobile.<br />
12 “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa, proveniente da un impianto, che produce inquinamento se<br />
introdotta in atmosfera”- DM del 1 ottobre 2002, n. 261, art. 4, comma 1, lettera b.<br />
38
Il monitoraggio ha identificato il traffico urbano come principale fonte <strong>di</strong> inquinamento<br />
aggravato da altre fonti d’inquinamento urbano (impianti <strong>di</strong> riscaldamento, attività artigianali,<br />
ecc).<br />
<strong>Monserrato</strong> non è a rischio, né per quanto riguarda il superamento dei Valori Limite per la<br />
protezione della salute umana, né per quanto riguarda la protezione della vegetazione,<br />
poichè i valori <strong>di</strong> concentrazione dei principali inquinanti atmosferici risultano al <strong>di</strong> sotto dei<br />
limiti stabiliti dalla normativa. Il monitoraggio, che è stato effettuato attraverso una stazione<br />
mobile nell’ambito urbano, ha messo però in evidenza la vulnerabilità della popolazione a<br />
causa <strong>di</strong> inquinamento dovuto ai trasporti urbani.<br />
Per quanto riguarda gli ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> azoto (NO; NO2; NOX), i valori tra le tre misure sono anomali<br />
per Villasalto e lo stesso risultato si ottiene esaminando le me<strong>di</strong>e orarie (non riportate in<br />
questo <strong>documento</strong>). Escludendo Villasalto, i valori più elevati si riscontrano ad Alghero,<br />
<strong>Monserrato</strong> e Selargius, cioè nei siti più esposti al traffico autoveicolare, e ad Arborea,<br />
quest’ultimo sito per motivi da appurare.<br />
L’analisi fa riferimento ai risultati del monitoraggio effettuato dal Servizio Atmosferico per la<br />
pubblicazione del “Piano <strong>di</strong> prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria<br />
ambiente” della regione Sardegna, approvato con D.G.R. n. 55/6 del 29.11.2005.<br />
Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, non sono presenti inse<strong>di</strong>amenti industriali <strong>di</strong><br />
interesse nell’area comunale 13 .<br />
Il territorio <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> non ha bisogno <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> risanamento ma solo <strong>di</strong> monitoraggio<br />
continuo per garantire il mantenimento <strong>di</strong> una buona qualità dell’aria.<br />
STATO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. FONTI<br />
Inquinamento da ossi<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> zolfo [SO2]<br />
Inquinamento da ossi<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> azoto [NOx]<br />
Concentrazione SO2<br />
Emissioni <strong>di</strong> SO2 10-100 t/a<br />
Concentrazione <strong>di</strong> NO2<br />
2.2 µg/m 3<br />
Inquinamento da<br />
particolato [PM10]<br />
Inquinamento da<br />
monossido <strong>di</strong> carbonio<br />
[CO]<br />
Inquinamento da ozono<br />
[O3]<br />
Inquinamento da<br />
benzene [C6H6]<br />
Superamenti dei limiti <strong>di</strong><br />
legge dei parametri <strong>di</strong><br />
qualità dell’aria, ai sensi<br />
della normativa vigente<br />
Concentrazione <strong>di</strong> PM10<br />
7 µg/m3<br />
Con<strong>di</strong>zioni anemometriche: Rosa dei venti<br />
41
SCHEDA N. 2 – ACQUA<br />
La Regione Sardegna, in attuazione dell’art. 44 del D.L.gs 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i. e<br />
dell’art. 2 della L.R. luglio 2000, n. 14, ha approvato, su proposta dell’Assessore della Difesa<br />
dell’Ambiente, il Piano <strong>di</strong> Tutela delle Acque (P.T.A.) con Deliberazione della Giunta<br />
Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006. Il Piano <strong>di</strong> Tutela delle Acque (P.T.A.), ha in<strong>di</strong>viduato un<br />
bacino unico regionale ai sensi della L. 183/89 e l’Ambito Territoriale Ottimale ai sensi della L.<br />
36/94. L’intero territorio Regionale è stato sud<strong>di</strong>viso poi in 16 Unità Idrografiche Omogenee<br />
(U.I.O.), costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi, a cui sono state convenzionalmente<br />
assegnate le rispettive acque superficiali interne nonché le relative acque sotterranee e<br />
marino-costiere.<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> rientra nella U.I.O. 1 Flumini<br />
Mannu - Cixerri. Il bacino idrografico delle Saline <strong>di</strong><br />
Cagliari con una superficie pari a 67,77 Km 2 è compreso<br />
nel sistema del Molentargius, costituito da una serie <strong>di</strong><br />
corpi idrici <strong>di</strong> piccola estensione aventi notevole<br />
rilevanza paesaggistico-ambientale.<br />
Per quanto concerne le aree sensibili, in<strong>di</strong>viduate ai<br />
sensi della Direttiva 271/91/CE e dell’Allegato 6 del<br />
D.Lgs. 152/99, sono state evidenziate, in una prima<br />
fase, i corpi idrici destinati ad uso potabile e le zone<br />
umide inserite nella convenzione <strong>di</strong> Ramsar.<br />
Sulla base <strong>di</strong> questi parametri il <strong>Comune</strong> non rientra tra<br />
le aree sensibili in<strong>di</strong>viduate dal P.T.A.<br />
Dotazione idrica<br />
Il servizio <strong>di</strong> approvvigionamento idropotabile della Città<br />
<strong>di</strong> Cagliari avviene attraverso gli acquedotti comunali <strong>di</strong><br />
San Lorenzo e <strong>di</strong> Corongiu, attualmente gestiti dalla<br />
società Abbanoa, e attraverso quelli del Simbirizzi<br />
(Settimo San Pietro) e <strong>di</strong> Donori, gestiti dall’E.N.A.S. (Ente acque della Sardegna).<br />
42
TUTELA DELLA RISORSA IDRICA<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Consumo idrico Fabbisogno idrico<br />
Consumo idrico<br />
QUALITA’ DELLE ACQUE<br />
Fabbisogno idrico per<br />
uso civile e industriale<br />
(anno 2007)<br />
Fabbisogno idrico per<br />
uso irriguo<br />
Fabbisogno idrico per<br />
uso industriale<br />
3,43 Mm 3 /a per 6711<br />
utenze<br />
Mm 3 /a<br />
Mm 3 /a<br />
Mm 3 /a<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Qualità delle acque <strong>di</strong><br />
balneazione<br />
Tratto <strong>di</strong> costa interdetta<br />
temporaneamente alla<br />
balneazione<br />
% <strong>di</strong> costa interdetta<br />
temporaneamente alla<br />
balneazione<br />
INQUINAMENTO DELLE ACQUE<br />
Tratto <strong>di</strong> costa interdetta<br />
permanentemente alla<br />
balneazione per motivi<br />
d’inquinamento<br />
% <strong>di</strong> costa interdetta<br />
permanentemente alla<br />
balneazione per motivi<br />
d’inquinamento<br />
Non presente<br />
Non presente<br />
Non presente<br />
Non presente<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Carico inquinante<br />
potenziale<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
BOD da attività civili<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
BOD da attività<br />
industriali<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
COD da attività civili<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
COD da attività<br />
industriali<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
azoto da attività civili<br />
456,16 t/a<br />
208,52 t/a<br />
836,28 t/a<br />
517,02 t/a<br />
91,23 t/a (P.T.A. parteA)<br />
72,98 t/a (U.I.O.)<br />
Piano d’Ambito della<br />
Regione Autonoma<br />
della Sardegna 30<br />
Settembre 2002<br />
Abbanoa Spa<br />
Piano <strong>di</strong> Tutela delle<br />
Acque (PTA) 2006.<br />
I dati riportati sono<br />
contenuti all’interno<br />
della monografia<br />
dell’Unità Idrografica<br />
Omogenea 1 Flumini<br />
Mannu - Cixerri<br />
43
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
azoto da attività<br />
industriali<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
fosforo da attività civili<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
fosforo da attività<br />
industriali<br />
52,88 t/a<br />
11,40 t/a<br />
0,88 t/a<br />
DATI AGGIUNTIVI SULL’INQUINAMENTO DELLE ACQUE<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Carico inquinante<br />
potenziale<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
azoto da attività agricole<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
fosforo da attività<br />
agricole<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
BOD 14 da attività<br />
zootecniche<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
COD 15 da attività<br />
zootecniche<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
azoto da attività<br />
zootecniche<br />
Carichi potenziali <strong>di</strong><br />
fosforo da attività<br />
zootecniche<br />
SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE<br />
0,53 t/a<br />
0,15 t/a<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Trattamento delle acque<br />
reflue<br />
Efficienza del sistema <strong>di</strong><br />
gestione delle acque reflue<br />
Tipologie <strong>di</strong> trattamenti<br />
previsti degli impianti <strong>di</strong><br />
depurazione 16<br />
Popolazione servita<br />
dall’impianto <strong>di</strong><br />
depurazione<br />
0 t/a<br />
0 t/a<br />
0 t/a<br />
0 t/a<br />
Piano <strong>di</strong> Tutela delle<br />
Acque (PTA) 2006.<br />
I dati riportati sono<br />
contenuti all’interno<br />
della monografia<br />
dell’Unità Idrografica<br />
Omogenea 1 Flumini<br />
Mannu - Cixerri<br />
affinamento 17 Piano d’Ambito della<br />
Regione Autonoma<br />
della Sardegna<br />
90%<br />
30 Settembre 2002<br />
14<br />
Domanda Biochimica <strong>di</strong> Ossigeno: il saggio <strong>di</strong> BOD esprime la quantità <strong>di</strong> ossigeno necessaria per<br />
l’ossidazione biochimica <strong>di</strong> composti organici.<br />
15<br />
Domanda Chimica <strong>di</strong> Ossigeno: in<strong>di</strong>ce utilizzato insieme al BOD5 per la valutazione del carico inquinante <strong>di</strong><br />
un’acqua o <strong>di</strong> un effluente. Il saggio <strong>di</strong> COD esprime la quantità <strong>di</strong> ossigeno necessaria per l’ossidazione<br />
chimica <strong>di</strong> sostanze organiche e inorganiche contenuta nelle acque.<br />
16<br />
si intende una installazione a<strong>di</strong>bita alla depurazione <strong>di</strong> acque reflue provenienti da inse<strong>di</strong>amenti civili e da<br />
inse<strong>di</strong>amenti produttivi, in cui possono mescolarsi le acque meteoriche e quelle <strong>di</strong> lavaggio delle superfici<br />
stradali.<br />
17<br />
può essere costituito da <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> trattamenti (raggi UV, fitodepurazione etc.) che consentono<br />
abbattimento delle cariche batteriche e delle sostanze potenzialmente inquinanti presenti negli effluenti in<br />
uscita dai trattamenti primari. I parametri qualitativi per l’affinamento sono stabiliti D.M. n.185/2003<br />
44
Popolazione servita<br />
dalla rete fognaria 18<br />
Capacità <strong>di</strong> trattamento<br />
dell’impianto <strong>di</strong><br />
depurazione:<br />
potenzialità impianto (in<br />
ab. equivalenti) 19<br />
rispetto a popolazione<br />
servita (in ab.<br />
equivalenti) della zona<br />
servita, compresa la<br />
popolazione fluttuante<br />
Acque destinate al consumo potabile<br />
Nei corpi idrici destinati alla produzione <strong>di</strong> acqua potabile della U.I.O. del Flumini Mannu-<br />
90 %<br />
90 %<br />
Cixerri è presente una situazione generale abbastanza sod<strong>di</strong>sfacente.<br />
Per <strong>Monserrato</strong> il gestore attuale <strong>di</strong> adduzione è l’E.N.A.S. La rete <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione 20 è dotata<br />
<strong>di</strong> un serbatoio seminterrato da 15000 m 3 e lo stato <strong>di</strong> conservazione delle fognature è <strong>di</strong><br />
“buono stato <strong>di</strong> conservazione”. Per la depurazione delle acque, in fase <strong>di</strong> affinamento,<br />
l’incarico è affidato al Consorzio Is Arenas. A <strong>Monserrato</strong> è presente un punto <strong>di</strong><br />
campionamento per le acque trattate e <strong>di</strong>stribuite.<br />
18 si tratta del sistema <strong>di</strong> condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche o acque<br />
reflue industriali, assimilabili alle acque reflue urbane, e/o acque meteoriche <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento.<br />
19 rappresentano l’unità <strong>di</strong> misura con cui viene convenzionalmente espresso il carico inquinante organico<br />
biodegradabile in arrivo all’impianto <strong>di</strong> depurazione, secondo l’equivalenza: 1 abitante equivalente = 60<br />
grammi/giorno <strong>di</strong> BOD5<br />
20 è il complesso <strong>di</strong> opere (tubazioni, serbatoi, impianti <strong>di</strong> pompaggio, eccetera), relativo all’intero territorio<br />
comunale, che partendo dalle vasche <strong>di</strong> accumulo (serbatoi, vasche <strong>di</strong> carico) adduce l’acqua ai singoli punti<br />
<strong>di</strong> utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, uffici eccetera).<br />
45
SCHEDA N. 3 – RIFIUTI<br />
La pianificazione regionale in materia <strong>di</strong> rifiuti<br />
I dati più recenti <strong>di</strong> produzione dei rifiuti urbani, a livello regionale, si riferiscono alla situazione<br />
monitorata al 31.12.2006. La produzione complessiva dei rifiuti urbani su base regionale<br />
ammonta a circa 861.000 t/a <strong>di</strong> cui circa l’80% costituita dalla frazione avviata allo<br />
smaltimento, per lo più rappresentata da rifiuti misti in<strong>di</strong>fferenziati.<br />
Nell’ultimo biennio si è riscontrato un sostanziale aumento della raccolta <strong>di</strong>fferenziata che<br />
incomincia ad avere un ruolo significativo nel panorama della gestione dei rifiuti urbani in<br />
Sardegna. L’andamento storico della destinazione dei rifiuti urbani è descritto dalla figura in<br />
cui sono riportate le percentuali <strong>di</strong> conferimento del R.U. quale in <strong>di</strong>scarica, agli impianti <strong>di</strong><br />
trattamento (<strong>di</strong> selezione-stabilizzazione-termovalorizzazione) e <strong>di</strong> avvio al recupero a valle <strong>di</strong><br />
raccolta <strong>di</strong>fferenziata.<br />
46
Organizzazione del sistema rifiuti<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> appartiene all’ambito territoriale a1.<br />
Fino all’anno 2007, ultimo anno <strong>di</strong> cui si hanno dati completi <strong>di</strong>sponibili, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Monserrato</strong> ha gestito i rifiuti attraverso cassonetti per l’in<strong>di</strong>fferenziata e con l’installazione <strong>di</strong><br />
campane per la raccolta del vetro, plastica, carta, con la possibilità dello smaltimento anche<br />
dei me<strong>di</strong>cinali e delle batterie.<br />
GESTIONE DEI RIFIUTI<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Produzione <strong>di</strong> rifiuti<br />
Raccolta dei rifiuti<br />
Produzione rifiuti urbani<br />
(su base mensile)<br />
Sistema <strong>di</strong> raccolta<br />
Presenza <strong>di</strong> isole<br />
ecologiche<br />
Quantità <strong>di</strong> rifiuti<br />
<strong>di</strong>fferenziati per frazione<br />
merceologica<br />
(Anno 2007)<br />
980,837 t/a <strong>Comune</strong> 2007<br />
Differenziata con<br />
raccolta porta a porta<br />
Ecocentri non presenti<br />
Rifiuti biodegradabili<br />
2175,097 t/a<br />
Rifiuti soli<strong>di</strong> urbani<br />
8776,180 t/a<br />
Imballaggi <strong>di</strong> cartone<br />
104,510 t/a<br />
Carta/cartone 273,90 t/a<br />
Vetro 171,300 t/a<br />
<strong>Comune</strong> 2007<br />
47
Trattamento dei rifiuti<br />
CARTOGRAFIA<br />
Ubicazione isole<br />
ecologiche e impianti <strong>di</strong><br />
smaltimento e/o<br />
recupero<br />
Rifiuti destinati a impianti<br />
<strong>di</strong> recupero 21<br />
Rifiuti destinati a impianti<br />
<strong>di</strong> smaltimento<br />
Impianti <strong>di</strong><br />
trattamento/smaltimento 22<br />
dei rifiuti<br />
Imballaggi in plastica<br />
75,440 t/a<br />
Metallo 84,295 t/a<br />
Beni durevoli 84,295 t/a<br />
Batterie e pile 0 t/a<br />
Accumulatori al piombo<br />
2 t/a<br />
Altri rifiuti urbani non<br />
pericolosi 22,28 t/a<br />
Altri rifiuti urbani<br />
pericolosi 71,18 t/a<br />
2955,457 t/a<br />
8814,583 t/a<br />
Non presenti<br />
Non sono presenti isole ecologiche e impianti <strong>di</strong> smaltimento e/o recupero<br />
21<br />
le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili, o prodotti, attraverso<br />
trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici<br />
22<br />
operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito<br />
economico e/o <strong>di</strong> raccolta<br />
48
Andamento raccolta <strong>di</strong>fferenziata<br />
La raccolta <strong>di</strong>fferenziata (come evidenzia anche il grafico) ha avuto una buona risposta da<br />
parte della citta<strong>di</strong>nanza, passando dal 5,46 % dell’anno 2005 al 17,06 % del 2006, fino al<br />
25,11 % del 2007, quin<strong>di</strong> con miglioramenti sensibili in tempi brevi.<br />
49
Frazioni merceologiche e produzione totale<br />
La produzione complessiva dei rifiuti urbani nel <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong>, riferita al 2007, risulta<br />
complessivamente pari a 11.770 t <strong>di</strong> cui il 74% costituito da rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, il 18,44 % da<br />
biodegradabili, il 2,32 % da carta/cartone, l’1,45 % da vetro, 0,89 % da imballaggi <strong>di</strong> cartone,<br />
lo 0,71 % da metallo, 0,64 da imballaggi <strong>di</strong> plastica, 0,6 % <strong>di</strong> rifiuti urbani pericolosi, lo 0,18 da<br />
altri rifiuti urbani non pericolosi, lo 0,02 da accumulatori al piombo, e circa lo 0% <strong>di</strong> batterie e<br />
pile.<br />
50
SCHEDA N. 4 – SUOLO<br />
Nell’analisi dell’elemento suolo la “Carta delle unità delle terre” alla scala 1:10.000, e la “Carta<br />
<strong>di</strong> uso del suolo” alla scala 1:10.000, sono essenziali per il completamento dei dati richiesti<br />
nella presente scheda.<br />
USO DEL SUOLO<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Capacità d’uso dei suoli<br />
Rapporto tra la<br />
superficie appartenente<br />
alla classe I (secondo la<br />
classificazione della<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
delle zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la<br />
superficie appartenente<br />
alla classe II (secondo la<br />
classificazione della<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
delle zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la<br />
superficie appartenente<br />
alla classe III (secondo<br />
la classificazione della<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
delle zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la<br />
superficie appartenente<br />
alla classe IV (secondo<br />
la classificazione della<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
delle zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la<br />
superficie appartenente<br />
alla classe V (secondo la<br />
classificazione della<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
delle zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
Carta dei Suoli della<br />
Sardegna RAS-<br />
Università <strong>di</strong> Cagliari<br />
51
Uso del suolo<br />
Consumo <strong>di</strong> suolo:<br />
suolo occupato<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
relativamente alle<br />
<strong>di</strong>verse classi d’uso dei<br />
suoli<br />
Rapporto tra la<br />
superficie appartenente<br />
alla classe VI (secondo<br />
la classificazione della<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
delle zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Rapporto tra la<br />
superficie appartenente<br />
alla classe VII (secondo<br />
la classificazione della<br />
capacità d’uso dei suoli<br />
delle zone agricole –<br />
zone E) e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie urbanizzata:<br />
rapporto tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
1 (aree artificiali) e la<br />
superficie comunale<br />
Superficie destinata a<br />
uso agricolo: rapporto<br />
tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
2 (aree agricole) e la<br />
superficie comunale<br />
Superficie occupata da<br />
boschi 23 e aree<br />
seminaturali: rapporto<br />
tra la superficie<br />
appartenente alla classe<br />
3 (aree boschive e<br />
seminaturali) e la<br />
superficie comunale<br />
Superficie destinata a<br />
verde urbano: rapporto<br />
tra la superficie a verde<br />
urbano esistente e la<br />
popolazione residente<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla<br />
classe I: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
I e la superficie<br />
comunale<br />
%<br />
%<br />
46,50 %<br />
50,70 %<br />
2,70 %<br />
m 2 /ab<br />
<strong>Comune</strong>/ Database<br />
cartografico GIS<br />
regionale (2006)<br />
23 copertura del suolo superiore al 10 %, con un’altezza delle piante a maturità superiore ai 5 m e una superficie<br />
continua minima <strong>di</strong> mezzo ettaro.<br />
%<br />
52
Consumo <strong>di</strong> suolo:<br />
suolo occupato<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
relativamente alle<br />
<strong>di</strong>verse classi d’uso dei<br />
suoli<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla<br />
classe II: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
II e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla<br />
classe III: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
III e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla<br />
classe IV: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
IV e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla<br />
classe V: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
V e la superficie<br />
comunale<br />
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla<br />
classe VI: rapporto tra la<br />
superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
VI e la superficie<br />
comunale<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
<strong>Comune</strong><br />
53
Superficie occupata<br />
nell’espansione dagli<br />
anni ’50 a oggi<br />
appartenente alla<br />
classe VII: rapporto tra<br />
la superficie interessata<br />
dall’espansione e<br />
appartenente alla classe<br />
VII e la superficie<br />
comunale<br />
Relativamente al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> è stata programmata una campagna <strong>di</strong> indagini e<br />
analisi delle risorse pedologiche comunali, al fine <strong>di</strong> procedere alla valutazione della capacità<br />
e della suscettività d'uso dei suoli e <strong>di</strong> perseguire gli obiettivi della pianificazione regionale.<br />
Con la realizzazione della Carta delle Unità <strong>di</strong> Terre e con la Land Capability Classification è<br />
possibile in<strong>di</strong>viduare la potenzialità <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> territorio omogenea nei vari caratteri e<br />
caratterizzare degli areali circoscritti, per i quali definire quali priorità e tipologie <strong>di</strong> intervento<br />
sono idonee per la tutela e l’uso sostenibile delle risorse naturali, approntando una<br />
pianificazione razionale.<br />
Attualmente dai dati in possesso è stato possibile completare solo in parte le informazioni<br />
richieste.<br />
EROSIONE E DESERTIFICAZIONE<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Rischio <strong>di</strong> erosione<br />
costiera<br />
Rischio <strong>di</strong><br />
desertificazione<br />
Pericolosità da frana<br />
Lunghezza dei litorali a<br />
rischio erosione<br />
Aree potenziali (In<strong>di</strong>ce<br />
ESAs 10= 1.17 – 1.22)<br />
Aree fragili (In<strong>di</strong>ce ESAs<br />
= 1.23 – 1.37)<br />
Aree critiche (In<strong>di</strong>ce<br />
ESAs = 1.38 – 1.41)<br />
Aree a pericolosità da<br />
frana ricadenti in classe<br />
Hg1<br />
Aree a pericolosità da<br />
frana ricadenti in classe<br />
Hg2<br />
%<br />
Non presente<br />
Nessuna<br />
Nessuna<br />
2,628 Km 2<br />
Nessuna<br />
Nessuna<br />
Carta del Rischio<br />
Geoambientale nelle<br />
Coste della Sardegna<br />
Carta delle Aree<br />
Sensibili alla<br />
Desertificazione” redatta<br />
dal S.A.R.<br />
Piano Stralcio per<br />
l’assetto idrogeologico<br />
Dicembre 2002<br />
Il P.A.I. è attualmente in<br />
adeguamento<br />
54
Pericolosità idraulica<br />
Aree a pericolosità da<br />
frana ricadenti in classe<br />
Hg3<br />
Aree a pericolosità da<br />
frana ricadenti in classe<br />
Hg4<br />
Aree a pericolosità<br />
idraulica ricadenti in<br />
classe Hi1<br />
Aree a pericolosità<br />
idraulica ricadenti in<br />
classe Hi2<br />
Aree a pericolosità<br />
idraulica ricadenti in<br />
classe Hi3<br />
Aree a pericolosità<br />
idraulica ricadenti in<br />
classe Hi4<br />
PRESENZA DI CAVE E MINIERE<br />
Cave e miniere<br />
Tipologia <strong>di</strong><br />
cave/miniere<br />
Aree occupate da<br />
cave/miniere attive<br />
Aree occupate da<br />
cave/miniere <strong>di</strong>smesse<br />
CONTAMINAZIONE DEL SUOLO<br />
Siti contaminati<br />
Bonifica dei siti<br />
contaminati<br />
Siti contaminati da<br />
<strong>di</strong>scariche non<br />
controllate<br />
Siti contaminati da<br />
attività industriali<br />
Siti contaminati da<br />
amianto<br />
Progetti <strong>di</strong> bonifica 48<br />
Interventi <strong>di</strong> bonifica<br />
avviati<br />
Interventi <strong>di</strong> messa in<br />
sicurezza d’emergenza<br />
Nessuna<br />
Nessuna<br />
In fase <strong>di</strong> adeguamento<br />
In fase <strong>di</strong> adeguamento<br />
In fase <strong>di</strong> adeguamento<br />
In fase <strong>di</strong> adeguamento<br />
Non presenti<br />
Non presenti<br />
Non presenti<br />
48 siti<br />
m 2 non reperiti<br />
1 sito<br />
2000 m 2<br />
2 siti<br />
350 m 2<br />
18<br />
Siti bonificati 29<br />
0<br />
Piano Stralcio per<br />
l’Assetto Idrogeologico<br />
(luglio 2004)<br />
Il P.A.I. è attualmente in<br />
adeguamento<br />
<strong>Comune</strong> (2008)<br />
55
CARTOGRAFIA<br />
RELAZIONI CON PPR<br />
Tav 1: Carta geo-litologica (Dati giaciturali, coperture detritiche, presenza <strong>di</strong><br />
geositi secondo meto<strong>di</strong> e legende standar<strong>di</strong>zzati – scala 1:10.000)<br />
Tav.2: Carta geomorfologia (Rilevamento delle forme del territorio, processi <strong>di</strong><br />
morfogenesi, acclività, esposizione, presenza <strong>di</strong> morfositi - scala<br />
1:10.000)<br />
Tav.3: Carta idrogeologica (Permeabilità, altezza falda, grado <strong>di</strong> fatturazione -<br />
scala 1:10.000)<br />
Tav.4: Carta geologico-tecnica (scala 1:10.000)<br />
Tav.5: Carta pedologica o Carta delle Unità delle Terre (acquisizione <strong>di</strong><br />
parametri relativi ai suoli - granulometria, porosità, contenuto <strong>di</strong><br />
sostanza organica, fertilità, presenza <strong>di</strong> strati impermeabili, attitu<strong>di</strong>ne<br />
dei suoli ad usi <strong>di</strong>versi, in<strong>di</strong>viduazione dei processi <strong>di</strong> pedogenesi,<br />
processi <strong>di</strong> degradazione, presenza <strong>di</strong> pedositi - scala 1:10.000)<br />
Tav.8: Carta dell’uso del suolo (scala 1:10.000)<br />
P.A.I. E’ attualmente in fase <strong>di</strong> adeguamento<br />
Desertificazione<br />
Il valore del suolo è dato dal patrimonio della risorsa suolo che eventualmente si dovesse<br />
compromettere quando determinate azioni,<br />
previste nel Piano Urbanistico, dovessero<br />
richiedere destinazioni d’uso <strong>di</strong>verse da quelle<br />
agricolo-forestali.<br />
I valori assoluti vengono a loro volta utilizzati per<br />
la determinazione del valore finale dell’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
sensibilità alla desertificazione o E.S.A.I.<br />
(Enviromentally Sensitive Area Index).<br />
Il colore rosso nella carta identifica una classe<br />
critica C3, il colore grigio un’area urbanizzata.<br />
Fonte: Servizio Agrometereologico Regionale<br />
56
Fonte: Servizio Agrometereologico Regionale<br />
<strong>Monserrato</strong> ha una parte pari a 2,63 km 2 <strong>di</strong> area critica, pari al 41% del territorio comunale,<br />
ricadente nella classe peggiore (in<strong>di</strong>ce ESAs C3)<br />
57
SCHEDA N. 5 - FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’<br />
FLORA FAUNA E BIODIVERSITA’<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Aree sottoposte a tutela<br />
Misure <strong>di</strong> gestione per la<br />
tutela <strong>di</strong> flora fauna e<br />
habitat<br />
Aree protette nazionali<br />
Aree protette regionali<br />
Aree SIC<br />
Aree ZPS<br />
Zone umide<br />
d’importanza<br />
internazionale (Ramsar)<br />
Oasi <strong>di</strong> protezione<br />
faunistica<br />
Nessuna<br />
Interventi attivi Nessuno<br />
Misure Regolamentari ed<br />
Amministrative<br />
Nessuna<br />
Incentivazioni Nessuna<br />
Monitoraggi e Ricerche Nessuno<br />
Programmi Didattici, <strong>di</strong><br />
Educazione e<br />
Comunicazione<br />
Valorizzazione<br />
economica e fruizione<br />
sostenibile<br />
Nessuno<br />
Nessuna<br />
0 Km 2<br />
Nessuna<br />
0 Km 2<br />
Nessuna<br />
0 Km 2<br />
Nessuna<br />
0 Km 2<br />
Nessuna<br />
0 Km 2<br />
1 “Stagni <strong>di</strong> Quartu e<br />
Molentargius”<br />
6996 Ha <strong>di</strong> cui 3,17 Km 2<br />
compresi nel territorio<br />
comunale<br />
Piano Paesaggistico<br />
Regionale della Regione<br />
Autonoma della<br />
Sardegna;<br />
Piano <strong>di</strong> Gestione del<br />
PSIC;<br />
schede PSIC e ZPS<br />
Natura 2000<br />
<strong>Comune</strong> (in quanto<br />
promotore dei piani)<br />
Partecipazione al Progetto Integrato “Molentargius – Saline”, presentato dal<br />
consorzio del Parco Naturale Regionale, per la realizzazione <strong>di</strong> un sistema<br />
integrato <strong>di</strong> accessibilità <strong>di</strong>ffusa per la fruizione della centrale ambientale <strong>di</strong><br />
Molentargius, delle Saline e del Poetto, attraverso la creazione <strong>di</strong> una rete<br />
ecologica polivalente<br />
64
Presenza <strong>di</strong> specie<br />
floro-faunistiche<br />
Non sono presenti siti appartenenti alla Rete<br />
Natura 2000<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> <strong>di</strong>sta 15m dal “Limite<br />
Zona a Protezione Speciale Z.P.S. e del S.I.C. -<br />
I.T.B. - 040022”<br />
Stu<strong>di</strong> in possesso del<br />
<strong>Comune</strong> oppure da<br />
affidare ad un<br />
consulente Piano<br />
Paesaggistico Regionale<br />
della Regione Autonoma<br />
della Sardegna;<br />
Piano <strong>di</strong> Gestione del<br />
PSIC;<br />
schede pSIC e ZPS<br />
Natura 2000<br />
S.I.T.R.<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE<br />
Foreste 24 Superficie forestale 5 ha R.A.S.<br />
Minaccia delle specie<br />
animali e vegetali<br />
Accessibilità relativa alle<br />
zone protette<br />
CARTOGRAFIA<br />
Specie <strong>di</strong> fauna<br />
minacciate<br />
Specie <strong>di</strong> flora<br />
minacciate<br />
Habitat particolarmente<br />
sensibili presenti<br />
In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
frammentazione da<br />
strade (km <strong>di</strong> strada 25<br />
che attraversano le<br />
superfici sottoposte a<br />
tutela)<br />
Livello <strong>di</strong><br />
impermeabilizzazione<br />
(% <strong>di</strong> strade<br />
impermeabilizzate 26<br />
rispetto al totale delle<br />
strade presenti<br />
all’interno della zona<br />
protetta)<br />
Nessuna<br />
Nessuna<br />
Nessuno<br />
0<br />
0<br />
Tav.7: Carta della copertura vegetale in scala 1:10.000<br />
Carta <strong>di</strong> sovrapposizione dei vincoli<br />
<strong>Comune</strong> (informazioni<br />
deducibili dai piani <strong>di</strong><br />
gestione o, in assenza<br />
dei piani, dalle schede<br />
esistenti presso il<br />
servizio conservazione<br />
natura)<br />
Dato deducibile dalla<br />
cartografia dell’area<br />
sottoposta a tutela<br />
Dato deducibile dalla<br />
cartografia relativa<br />
all’area sottoposta a<br />
tutela e dalle<br />
informazioni in<br />
possesso del comune<br />
relativamente allo stato<br />
delle strade<br />
24<br />
aree chiuse con superficie minima continua <strong>di</strong> mezzo ettaro, sulle quali sono presenti piante forestali legnose,<br />
arboree e/o arbustive con proiezione delle chiome sul terreno superiore al 50 %<br />
25<br />
per strada si intendono carreggiate, sentieri e percorsi <strong>di</strong> qualsiasi natura percorribili da autoveicoli sia asfaltati<br />
che non asfaltati<br />
26<br />
per strada impermeabilizzata si intende qualsiasi copertura che mo<strong>di</strong>fichi le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> permeabilità del<br />
suolo<br />
65
Fonte:Ingra<strong>di</strong>mento dalla Carta dei “Perimetri Forestali Gestiti e Oasi Permanenti <strong>di</strong> Protezione Faunistica (Ente<br />
Foreste della Sardegna - R.A.S.)<br />
67
SCHEDA N. 6 - PAESAGGIO E ASSETTO STORICO CULTURALE<br />
PAESAGGIO<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE<br />
Caratteristiche del<br />
paesaggio<br />
% <strong>di</strong> area antropizzata<br />
rispetto all’estensione<br />
totale del territorio<br />
comunale<br />
% <strong>di</strong> aree naturali e<br />
subnaturali rispetto<br />
all’estensione totale del<br />
territorio comunale<br />
% <strong>di</strong> aree seminaturali<br />
rispetto all’estensione<br />
totale del territorio<br />
comunale<br />
% <strong>di</strong> area ad uso<br />
agroforestale rispetto<br />
all’estensione totale del<br />
territorio comunale<br />
BENI DI INTERESSE STORICO-CULTURALE<br />
Beni paesaggistici e<br />
identitari<br />
Viabilità storica<br />
Centri <strong>di</strong> antica e prima<br />
formazione<br />
Inse<strong>di</strong>amenti sparsi<br />
CARTOGRAFIA<br />
46,50 %<br />
0 %<br />
2,70 %<br />
50,70 %<br />
Database cartografico<br />
GIS regionale (2006)<br />
rappresentazione su base cartografica (carta <strong>di</strong>gitale 1:10000) (regione)<br />
Viabilità <strong>di</strong> epoca:<br />
- romana<br />
- me<strong>di</strong>oevale<br />
- moderna e contemporanea<br />
riportate su base cartografica (in eleb.)<br />
Tav.A2 e Tav.A5: Perimetrazione del centro storico relativo all’abitato del<br />
comune<br />
Abaco contenente le tipologie e<strong>di</strong>lizie, le tecniche e i materiali costruttivi<br />
dell’abitato sparso storico, le aree recintate e i fon<strong>di</strong> agricoli <strong>di</strong> riferimento<br />
Carta <strong>di</strong>gitale 1:10.000 per l’intero territorio comunale con l’in<strong>di</strong>viduazione dei<br />
beni paesaggistici e identitari regionale (georef.)<br />
Carta 1:2.000 per la rappresentazione dell’inse<strong>di</strong>amento urbano e delle<br />
frazioni (georef)<br />
Carta 1:5.000 per la rappresentazione del centro storico (Georef.)<br />
68
Centro Storico<br />
71
SCHEDA N. 7 - ASSETTO INSEDIATIVO DEMOGRAFICO<br />
ASPETTO DA ESAMINARE<br />
E<strong>di</strong>ficato urbano<br />
Centro <strong>di</strong> antica e prima formazione<br />
Espansione fino agli anni ’50<br />
Aree e<strong>di</strong>ficate relative a espansioni recenti (successive agli anni ’50)<br />
E<strong>di</strong>ficato <strong>di</strong>ffuso In<strong>di</strong>viduare le aree relative all’e<strong>di</strong>ficato urbano <strong>di</strong>ffuso<br />
E<strong>di</strong>ficato in zona extra<br />
Urbana<br />
DEMOGRAFIA<br />
In<strong>di</strong>viduare le aree relative all’e<strong>di</strong>ficato urbano <strong>di</strong>ffuso<br />
In<strong>di</strong>viduare le aree relative all’e<strong>di</strong>ficato in zona agricola (e<strong>di</strong>ficato sparso)<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE<br />
Struttura demografica<br />
Popolazione appartenete<br />
alla fascia <strong>di</strong> età “meno<br />
<strong>di</strong> 1 anno”<br />
Popolazione maschile<br />
appartenente alla fascia<br />
<strong>di</strong> età 1 - 4 anni<br />
Popolazione femminile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 1 – 4 anni<br />
Popolazione maschile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 5 – 9 anni<br />
Popolazione femminile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 5 – 9 anni<br />
Popolazione maschile<br />
appartenente alla fascia<br />
<strong>di</strong> età 10 – 14 anni<br />
Popolazione femminile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 10 - 14<br />
Popolazione maschile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 15 - 24<br />
Popolazione femminile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 15 - 24<br />
Popolazione maschile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 25 - 44<br />
Popolazione femminile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 25 - 44<br />
0,69 %<br />
1,64 %<br />
1,36 %<br />
1,74 %<br />
1,79 %<br />
2,13 %<br />
1,92 %<br />
5,97 %<br />
5,35 %<br />
15,59 %<br />
16,11 %<br />
ISTAT<br />
72
Tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza<br />
degli anziani<br />
Tasso <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza<br />
strutturale<br />
Popolazione maschile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 45 - 64<br />
Popolazione femminile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età 45 - 64<br />
Popolazione maschile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età “65 e più”<br />
Popolazione femminile<br />
appartenete alla fascia <strong>di</strong><br />
età “65 e più”<br />
Densità demografica<br />
Rapporto tra anziani<br />
(popolazione<br />
appartenente alla fascia<br />
<strong>di</strong> età “65 e più”) e<br />
popolazione attiva<br />
(popolazione<br />
appartenente alla fascia<br />
<strong>di</strong> età 15 – 64 anni)<br />
Rapporto popolazione<br />
inattiva (popolazione<br />
appartenente alla fascia<br />
<strong>di</strong> età “65 e più” +<br />
popolazione<br />
appartenente alla fascia<br />
<strong>di</strong> età “fino a 14 anni)<br />
rispetto alla popolazione<br />
attiva (popolazione<br />
appartenente alla fascia<br />
15 – 64 anni)<br />
14,02 %<br />
15,11 %<br />
6,92 %<br />
9,67 %<br />
0,33 ab./m 2<br />
22,99 %<br />
38,60 %<br />
73
Perimetro del Centro Matrice<br />
Aerofotogrammetria<br />
Centro Matrice<br />
74
Canapina catastale<br />
In rosso la perimetrazione del centro matrice R.A.S. del 2006; in blu la riperimetrazione del<br />
centro matrice prodotta dagli Uffici Tecnici del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong>.<br />
75
Sviluppo urbano<br />
Inse<strong>di</strong>amento fino al 1958: espansioni fino agli anni '50.<br />
76
Inse<strong>di</strong>amenti fino al 1989: espansioni recenti.<br />
77
Inse<strong>di</strong>amenti realizzati fino al 2003.…<br />
78
SCHEDA N. 8 - SISTEMA ECONOMICO PRODUTTIVO<br />
ATTIVITA’ TURISTICHE<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE<br />
Infrastrutture turistiche<br />
3 esercizi ricettivi 21 posti letto<br />
B & B 21 posti letto<br />
Popolazione fluttuante 0 abitanti RAS<br />
<strong>Comune</strong> (2007)<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. FONTE<br />
Presenza <strong>di</strong> aree<br />
produttive (PIP, NI, ASI,<br />
ZIR)<br />
Rischio industriale<br />
Gestione ambientale<br />
PIP: Tipologia <strong>di</strong> attività<br />
presenti<br />
NI: Tipologia <strong>di</strong> attività<br />
presenti<br />
ASI: Tipologia <strong>di</strong> attività<br />
presenti<br />
ZIR: Tipologia <strong>di</strong> attività<br />
presenti<br />
Impianti a rischio <strong>di</strong><br />
incidente rilevante 27<br />
(stabilimenti soggetti<br />
agli obblighi previsti<br />
dagli artt. 6/7 e 8 del<br />
D.Lgs 334/99 sud<strong>di</strong>visi<br />
per tipologia <strong>di</strong> attività)<br />
Autorizzazione Integrata<br />
Ambientale (impianti<br />
soggetti ad<br />
autorizzazione integrata<br />
ambientale<br />
(D.Lgs.59/05), sud<strong>di</strong>visi<br />
per tipologia <strong>di</strong> attività)<br />
N. imprese dotate <strong>di</strong><br />
sistema <strong>di</strong> gestione<br />
ambientale certificato<br />
(EMAS e/o ISO 14001)<br />
Nessuna<br />
Nessuna<br />
Nessuna<br />
Nessuna<br />
0<br />
<strong>Comune</strong> (2007);<br />
RAS;<br />
APAT – Annuario dei<br />
dati ambientali 2005<br />
0 <strong>Comune</strong> (2007)<br />
0<br />
APAT Sincert (siti<br />
internet)<br />
CARTOGRAFIA Non sono presenti aree produttive (PIP, NI. ASI, ZIR) nel territorio comunale<br />
27 avvenimento quale un’emissione, un incen<strong>di</strong>o o un’esplosione <strong>di</strong> rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato<br />
<strong>di</strong> una attività industriale che <strong>di</strong>a luogo ad un pericolo grave, imme<strong>di</strong>ato o <strong>di</strong>fferito, per l’uomo, all’interno o<br />
all’esterno dello stabilimento, e per l’ambiente e che comporti l’uso <strong>di</strong> una o più sostanze pericolose.<br />
79
SCHEDA N. 9 - MOBILITÀ E TRASPORTI<br />
ASPETTO INDICATORE U.M. Fonte<br />
Utilizzo del mezzo<br />
privato<br />
Alternative all’utilizzo<br />
del mezzo pubblico<br />
Strumenti <strong>di</strong><br />
Pianificazione dei<br />
trasporti<br />
Tasso <strong>di</strong> motorizzazione<br />
totale<br />
Tasso <strong>di</strong> motorizzazione<br />
auto<br />
Sviluppo <strong>di</strong> piste<br />
ciclabili<br />
45,4 vetture / 100 ab.<br />
0,45<br />
1,2 km<br />
Aree chiuse al traffico nessuna<br />
Tasso <strong>di</strong> utilizzo del<br />
mezzo pubblico<br />
Piano urbano del traffico<br />
e/o della mobilità<br />
29315765<br />
passeggeri/anno 28<br />
CARTOGRAFIA E’ presente il Piano urbano dei trasporti<br />
ACI 1999<br />
<strong>Comune</strong> (2007)<br />
ACI e ISTAT 1999<br />
presente <strong>Comune</strong> (2007)<br />
28 Il dato si riferisce al circuito urbano ed extra urbano <strong>di</strong> Cagliari, comprendente oltre a Cagliari, Quartu S.Elena,<br />
<strong>Monserrato</strong>, Selargius e Assemini, anche i Comuni <strong>di</strong> Decimomannu, Elmas, e Quartucciu, per un bacino<br />
complessivo servito <strong>di</strong> oltre 330.000 abitanti.<br />
80
11 Sintesi <strong>di</strong> Piano<br />
11.1 Introduzione<br />
La ridotta estensione del territorio evidenzia come <strong>Monserrato</strong> sia compresso tra Cagliari e i<br />
comuni limitrofi ed in particolare modo con Selargius che lo contorna quasi totalmente.<br />
Le politiche urbanistiche attivate dal P.U.C. mirano a conferire un’unità paesistica ed<br />
ambientale all’intero territorio comunale, ritrovando una propria identità attraverso una<br />
riqualificazione dell’esistente e la valorizzazione delle potenzialità in atto, al fine <strong>di</strong> favorire lo<br />
sviluppo <strong>di</strong> un nuovo policentrismo funzionale all’interno dell’area metropolitana cagliaritana.<br />
Il Piano affronta temi come il rapporto con l’Università, la qualità urbana e i servizi culturali e<br />
sociali (con particolare attenzione alla popolazione anziana e giovanile e con particolari<br />
problematiche sociali), la qualità urbana del centro storico e del suo imme<strong>di</strong>ato intorno, le<br />
potenzialità delle zone agricole e le problematiche legate alla mobilità e traffico.<br />
Inquadramento territoriale<br />
81
11.2 Demografia<br />
La presenza dell’Università potrebbe rappresentare un’opportunità per la popolazione<br />
monserrattina, soprattutto all’esterno dei confini comunali: l’immagine <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> si<br />
identifica nella presenza della Cittadella Universitaria.<br />
I rapporti tra il <strong>Comune</strong> e la Cittadella dovranno essere certamente rafforzati per dare valore<br />
in termini <strong>di</strong> dotazione <strong>di</strong> servizi, migliorandone l’accessibilità e la mobilità.<br />
I flussi che giornalmente gravitano su <strong>Monserrato</strong>, proprio grazie alla presenza dell’Università,<br />
rappresentano un bacino <strong>di</strong> utenza da non trascurare ma, al contrario, da intercettare e nel<br />
lungo periodo da consolidare. Anche per la popolazione locale, e non solo per quella in<br />
transito, i temi dell’accoglienza, dei servizi, della fruizione <strong>di</strong> spazi de<strong>di</strong>cati al tempo libero e<br />
alla cultura, risultano <strong>di</strong> grande interesse e rappresentano esigenze <strong>di</strong>versificate riferite agli<br />
stakeholders territoriali. Le iniziative progettuali, dunque, dovranno mirare al sod<strong>di</strong>sfacimento<br />
<strong>di</strong> tali esigenze in modo da dare nuovo impulso in termini <strong>di</strong> crescita demografica con evidenti<br />
ricadute positive per tutta la comunità coinvolta.<br />
11.3 Dotazione abitativa<br />
La città manifesta un’esigenza <strong>di</strong> accoglienza e <strong>di</strong> ricettività che deve essere accompagnata<br />
da una dotazione <strong>di</strong> servizi per la popolazione e <strong>di</strong> occasioni <strong>di</strong> incontro e scambio con i<br />
territori dell’Area Vasta.<br />
I dati esaminati hanno evidenziato come il trasferimento da Cagliari a <strong>Monserrato</strong> delle facoltà<br />
del polo scientifico dell’Università e dello stesso Policlinico Universitario, abbia generato un<br />
flusso <strong>di</strong> persone in entrata importante.<br />
Tuttavia l’insieme delle funzioni e dei servizi a favore delle nuove popolazioni non è cresciuta<br />
allo stesso ritmo.<br />
L’integrazione tra Cittadella e Città <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> costituisce uno dei percorsi progettuali<br />
primari nell’ambito della pianificazione. Il soggetto Università, infatti, deve essere visto come<br />
fattore strategico per l’innalzamento del capitale umano, sia in termini <strong>di</strong> formazione<br />
accademica sia in relazione alla capacità <strong>di</strong> mettere a <strong>di</strong>sposizione competenze e<br />
professionalità, per stimolare un fermento culturale <strong>di</strong>ffuso capace <strong>di</strong> catalizzare eventi e<br />
occasioni <strong>di</strong> scambio culturale.<br />
82
11.4 Tessuto produttivo<br />
L’economia era storicamente basata su attività padronali e conta<strong>di</strong>ne, <strong>di</strong> deposito e <strong>di</strong> servizi<br />
legati <strong>di</strong>rettamente alla produzione agro-silvo-pastorale.<br />
Attualmente, nel complesso, il tessuto produttivo <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> è caratterizzato dalla<br />
presenza <strong>di</strong> piccole e piccolissime imprese (con una <strong>di</strong>mensione me<strong>di</strong>a pari a 3 addetti), per<br />
lo più appartenenti al settore dei servizi prevalentemente commerciali, mentre si registra una<br />
scarsità e frammentarietà <strong>di</strong> servizi avanzati alla persona e alle imprese.<br />
In relazione alla presenza della Cittadella Universitaria, il sistema produttivo <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong><br />
non sempre adeguato al bacino <strong>di</strong> utenza sviluppatosi in questi anni ha causato così una<br />
scarsa visibilità delle imprese locali nell’ambito dell’Area Vasta.<br />
Da un’analisi settoriale, inoltre, risulta che il sistema produttivo monserratino abbia una certa<br />
propensione alla trasformazione dei prodotti agricoli: il settore manifatturiero<br />
dell’agroalimentare infatti mostra segnali positivi, in particolare per quel che riguarda il<br />
comparto vitivinicolo con la presenza della Cantina Sociale.<br />
11.5 Servizi<br />
In un’ottica <strong>di</strong> accoglienza e <strong>di</strong> servizi alla città, resta ancora molto da fare per incrementare i<br />
livelli <strong>di</strong> qualità della vita, le occasioni <strong>di</strong> svago, la valorizzazione degli spazi aperti, la<br />
dotazione <strong>di</strong> servizi sociali.<br />
Infine, per quel che riguarda i servizi per il tempo libero, <strong>Monserrato</strong> vanta una dotazione <strong>di</strong><br />
impianti sportivi che certamente può rappresentare un’importante risorsa capace <strong>di</strong><br />
sod<strong>di</strong>sfare le esigenze <strong>di</strong> flussi <strong>di</strong> popolazione che quoti<strong>di</strong>anamente transitano in città, in<br />
particolare studenti universitari.<br />
Sarebbe auspicabile, in tal senso, la realizzazione <strong>di</strong> una rete <strong>di</strong> impianti sportivi, anche<br />
annessi a spazi aperti (parco <strong>di</strong> Terramaini, ecc), gestita in modo integrato anche al fine <strong>di</strong><br />
organizzare manifestazioni sportive e culturali.<br />
11.6 Territorio<br />
Il primo passo per realizzare la pianificazione è la verifica, da parte della Regione, della<br />
conformità del P.U.C. al Piano Paesaggistico.<br />
L’adeguamento al P.P.R. del P.U.C. <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong>, comune incluso nell’ambito costiero che<br />
ha approvato a livello comunale il 22/12/2005 il proprio strumento <strong>di</strong> pianificazione, si<br />
83
configura come un processo complesso <strong>di</strong> adattamenti e specificazioni ai contenuti e agli<br />
in<strong>di</strong>rizzi definiti dal P.P.R.<br />
Il territorio comunale è ancora regolamentato dal Piano Regolatore Generale <strong>di</strong> Cagliari e<br />
dalle Norme <strong>di</strong> Salvaguar<strong>di</strong>a, che accompagneranno la gestione pianificatoria fino al<br />
momento in cui il <strong>Comune</strong> lo approverà in via definitiva, una volta recepiti gli elementi e le<br />
valutazioni del Piano Paesaggistico.<br />
La fascia costiera in<strong>di</strong>viduata dal P.P.R., comprende la parte a sud del territorio ed esclude<br />
quella oltre la S.S. 554 29 .<br />
L’area a monte della statale 554 comprende storicamente la grande area agricola del<br />
territorio monserratino nella quale prevaleva la coltivazione dei vigneti, mentre la parte a sud<br />
include il centro storico e lo sviluppo urbano saturo con le recenti espansioni.<br />
Il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong>, frazione <strong>di</strong> Cagliari, dal 1928 fino al 1991, ha con il Capoluogo<br />
intensi rapporti per motivi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, lavoro, commerciali e infrastrutturali <strong>di</strong> livello territoriale;<br />
inoltre ha profon<strong>di</strong> rapporti con il resto dell’Area Vasta soprattutto per quanto riguarda la<br />
mobilità legata alla <strong>di</strong>namica residenziale, fortemente strutturatasi negli ultimi decenni.<br />
Sono <strong>di</strong> particolare rilevanza i due no<strong>di</strong> presenti ai margini dell’area urbana: quello <strong>di</strong> “Is<br />
Pontis Paris” a sud, oggetto <strong>di</strong> un’importante trasformazione, e l’incrocio tra la S.S. 554 e la<br />
S.P. 8 verso Sestu, attualmente in fase <strong>di</strong> trasformazione per migliorare l’accessibilità<br />
veicolare verso la Cittadella Universitaria.<br />
11.7 Sviluppo urbano<br />
La Città <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> si può sud<strong>di</strong>videre in tre zone principali:<br />
• il centro storico, caratterizzato da stra<strong>di</strong>ne strette e tortuose su cui si affacciano tipiche<br />
case campidanesi; alcune sono costruzioni fatte ancora <strong>di</strong> “la<strong>di</strong>ni” 30 che si affacciano<br />
sulla pubblica via con ampi portali e portoni, spesso arricchiti da intagli con ampi cortili<br />
interni su cui si affacciano gli ambienti della casa-azienda.<br />
• la zona <strong>di</strong> prima espansione e completamento, unita fisicamente con il centro storico;<br />
• la zona <strong>di</strong> espansione recente, con quartieri <strong>di</strong>stanti sia fisicamente che<br />
architettonicamente dalla tra<strong>di</strong>zione locale, comprendenti il quartiere “Su Mulinu”, della<br />
Coop-Cento e la maggior parte del quartiere “Paluna”.<br />
29 ad eccezione della zona “Su Tremini”<br />
30 mattone crudo <strong>di</strong> terra e paglia tritata, asciugato al sole, e tufo.<br />
84
Evidenziazione dell’utilizzo del suolo <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> nell’Area Vasta (Fonte S.I.R.T.)<br />
Il centro urbano è caratterizzato da rapporti sociali regolati dal “vicinato” e da attività <strong>di</strong> piccole<br />
botteghe artigianali, commerciali e <strong>di</strong> servizi, che consentono una <strong>di</strong>mensione vivibile anche a<br />
scala metropolitana.<br />
Uno degli obiettivi che si pone l’Amministrazione è quello <strong>di</strong> rivitalizzare il centro storico,<br />
me<strong>di</strong>ante la promozione <strong>di</strong> alcune iniziative (alcune attualmente in corso) attraverso l’analisi<br />
delle potenzialità e dei bisogni della popolazione residente. Un ulteriore obiettivo consiste nel<br />
recuperare e risanare la parte antica dell’abitato, favorendo il rientro degli abitanti, attirando<br />
studenti e personale del Polo Universitario-Ospedaliero, così da invertire la tendenza<br />
all’abbandono e allo spopolamento.<br />
Gli antichi fabbricati, potranno essere a<strong>di</strong>biti a residenza e ad attività artigianali, commerciali,<br />
culturali e ricreative o a stu<strong>di</strong> professionali, per stimolare l’economia, la socialità e fornire<br />
servizi rivitalizzando e migliorando il centro storico.<br />
La rete dei percorsi interni all’inse<strong>di</strong>amento urbano e quella dei percorsi <strong>di</strong> collegamento con<br />
gli altri centri urbani più vicini, era improntata ad una razionalità che generalmente rispondeva<br />
85
ai principi della minimizzazione delle lunghezze e dei tempi <strong>di</strong> percorrenza a pie<strong>di</strong> o a dorso <strong>di</strong><br />
animale e dell’aderenza ai caratteri geo-morfologici del territorio.<br />
Allo stato attuale la circolazione del centro citta<strong>di</strong>no dovrebbe essere resa più fluida, attuando<br />
iniziative che non scoraggino la circolazione, <strong>di</strong>minuendo l’afflusso delle automobili inquinanti<br />
e incentivando mezzi <strong>di</strong> trasporto alternativi.<br />
Nella fascia territoriale a nord della S.S. 554, andrà consolidato il tessuto delle aziende<br />
agricole, contribuendo in questo modo alla riqualificazione del paesaggio ed al recupero<br />
agricolo dei terreni attualmente in stato <strong>di</strong> abbandono. Quest’area agricola, fascia <strong>di</strong><br />
transizione tra l’area urbana e la fascia dell’entroterra, dovrà <strong>di</strong>ventare il fulcro della memoria<br />
storica della comunità.<br />
In questo senso risulta fondamentale il recupero a nuova identità e la riqualificazione del<br />
territorio <strong>di</strong> “Su Tremini”, compreso fra la strada per Dolianova ed il confine con Selargius,<br />
ampiamente compromesso dal punto <strong>di</strong> vista paesistico-ambientale a causa degli<br />
“inse<strong>di</strong>amenti spontanei” succedutisi negli anni.<br />
Osservando la situazione <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> in termini urbanistico-territoriali più generali, non c’è<br />
dubbio che la S.S. 554 rappresenti l’ostacolo più evidente e traumatico della storia recente,<br />
avendo irrime<strong>di</strong>abilmente spezzato quella continuità fra centro urbano e aree agricole, che ha<br />
caratterizzato da sempre il paesaggio e le modalità d’uso del suo hinterland.<br />
Il <strong>Comune</strong> dovrà ricucire, tramite il nuovo piano urbanistico, le due parti del suo territorio, per<br />
permettere una crescita urbana organica che sottenda anche una continuità tra parti<br />
storicamente connesse, e ora funzionalmente separate dalla S.S. 554.<br />
Per affrontare i fenomeni <strong>di</strong> abbandono delle campagne, sono necessarie azioni <strong>di</strong> governo<br />
che, anche avendo riguardo delle esigenze <strong>di</strong> tutela idraulica, consentano una continuità fra<br />
la <strong>Monserrato</strong> storica e la zona <strong>di</strong> espansione a nord della S.S. 554. E’ in questa fascia <strong>di</strong><br />
territorio che dovrà realizzarsi una connettività urbana pianificata, in<strong>di</strong>spensabile per<br />
raccordare il centro <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong> alla nuova zona universitaria, <strong>di</strong> espansione residenziale<br />
nonchè <strong>di</strong> servizi a scala metropolitana.<br />
Nel caso <strong>di</strong> <strong>Monserrato</strong>, si aggiunge poi il problema dell’estrema limitatezza del territorio<br />
comunale, ormai compresso su due lati da un’urbanizzazione informe e pervasiva.<br />
La ricerca <strong>di</strong> risposte appropriate a questa complessa problematica quantitativa e qualitativa,<br />
costituisce uno degli aspetti nodali della formazione del piano, dalla risposta che il modello<br />
86
urbanistico dà allo sviluppo della società monserratina, alle potenzialità <strong>di</strong> crescita sociale ed<br />
economico locale nel quadro della più vasta realtà metropolitana.<br />
Queste ultime infatti non possono governarsi solo con i dati statistici, ma considerando anche<br />
gli aspetti <strong>di</strong> compatibilità ambientale, <strong>di</strong> qualità degli inse<strong>di</strong>amenti, e i caratteri morfologici e<br />
le soluzioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno urbano che dovranno riconfigurare i contesti già e<strong>di</strong>ficati.<br />
L’intento progettuale principale che si persegue con il P.U.C. adeguato al P.P.R. consiste<br />
proprio nel tentativo <strong>di</strong> riconferire una “unità paesistica ed ambientale” all’intero territorio<br />
monserratino.<br />
La ricerca <strong>di</strong> risposte appropriate a questi temi, ha costituito uno degli aspetti della<br />
formazione del piano e dell’aderenza delle sue previsioni ai bisogni attuali della popolazione.<br />
L’entità <strong>di</strong> questa tendenza sarà determinata soprattutto dalla qualità dell’offerta residenziale<br />
abitativa, della sua concorrenzalità, dai servizi che si svilupperanno nell’area rispetto al resto<br />
dell’area metropolitana in termini economici, <strong>di</strong> qualità ambientale ed e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> sviluppo<br />
sostenibile.<br />
87