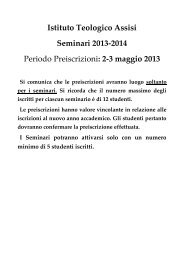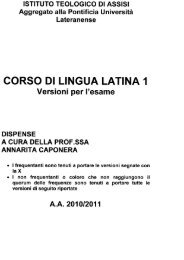Testi scelti Geremia ITA 2013 - Istitutoteologicoassisi.It
Testi scelti Geremia ITA 2013 - Istitutoteologicoassisi.It
Testi scelti Geremia ITA 2013 - Istitutoteologicoassisi.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
ESEGESI DI TESTI SCELTI<br />
GER 1,4-19: VOCAZIONE E MISSIONE<br />
Per questa parte i principali riferimenti, oltre ai commentari, sono:<br />
- BOVATI, P., <strong>Geremia</strong> 1-6. Dispense ad uso degli studenti (Roma 2006).<br />
- BOVATI, P., «Così parla il Signore». Studi sul profetismo biblico (Bologna 2008).<br />
- dispense p. Conroy.<br />
- CUCCA, M., Il corpo e la città. Studio del rapporto di significazione paradigmatica tra la<br />
vicenda di <strong>Geremia</strong> e il destino di Gerusalemme (Studi e Ricerche; Assisi 2010).<br />
1. Il testo nella sua forma finale<br />
Dopo una discussione sulla delimitazione e strutturazione del brano, cercheremo di comprendere<br />
il senso della struttura individuata, ai fini dell’interpretazione. Ciò ci consentirà di cogliere, da<br />
subito, il valore programmatico del testo in esame rispetto all’insieme del libro di Ger.<br />
4 rmoale yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w: Mi fu rivolta questa parola del Signore:<br />
5 ^yTi[.d:y> !j,B,b; ^r>C'a, ~r rm,aYOw e il Signore mi disse:<br />
^ypiB. yr:b'd> yTit;n" hNEhi «Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca.<br />
10 ^yTid>q;p.hi haer> Vedi, oggi ti do autorità<br />
tAkl'm.M;h;-l[;w> ~yIAGh;-l[; hZliw> vAtn>li per sradicare e demolire,<br />
sArh]l;w> dybia]h;l.W per distruggere e abbattere,<br />
p [;Ajn>liw> tAnb.li per edificare e piantare».<br />
11 rmoale yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w: Mi fu rivolta questa parola del Signore:<br />
Why"m.r>yI ha,ro hT'a;-hm' «Che cosa vedi, <strong>Geremia</strong>?».<br />
ha,ro ynIa] dqEv' lQEm; rm;aow" Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo».<br />
12 tAar>li T'b.j;yhe yl;ae hw"hy> rm,aYOw: Il Signore soggiunse: «Hai visto bene,<br />
p Atf{[]l; yrIb'D>-l[; ynIa] dqEvo-yKi poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla».
2<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
13 rmoale tynIve yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w: Quindi mi fu rivolta di nuovo la parola del Signore:<br />
ha,ro hT'a; hm' «Che cosa vedi?».<br />
hn"Apc' ynEP.mi wyn"p'W ha,ro ynIa] x:Wpn" rysi rm;aow Risposi: «Vedo una pentola bollente, la cui bocca è<br />
inclinata verso [dal] settentrione».<br />
14 yl'ae hw"hy> rm,aYOw: Il Signore mi disse:<br />
h['r"h' xt;P'Ti !ApC'mi «Dal settentrione dilagherà la sventura<br />
#rhi yKi Poiché, ecco, io sto per chiamare tutti i regni del<br />
settentrione.<br />
hw"hy>-~aun> Oracolo del Signore.<br />
Essi verranno e ognuno porrà il proprio trono<br />
alle porte di Gerusalemme,<br />
Aas.Ki vyai Wnt.n"w> Wab'W<br />
~ØIl;v'Wry> yrE[]v; xt;P,<br />
bybis' h'yt,moAx-lK' l[;w> contro le sue mura tutt’intorno<br />
hd"Why> yrE['-lK' l[;w> e contro tutte le città di Giuda.<br />
16 ~t'Aa yj;P'v.mi yTir>B;dIw> Allora pronunzierò i miei giudizi contro di loro,<br />
~t'['r"-lK' l[; per tutta la loro malvagità,<br />
ynIWbz"[] rv,a] poiché hanno abbandonato me<br />
~yrIxea] ~yhil{ale WrJ.q;y>w: e hanno sacrificato ad altri dèi<br />
~h,ydEy> yfe[]m;l. Wwx]T;v.YIw: e adorato idoli fatti con le proprie mani.<br />
17 ^yn Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi,<br />
~h,ylea] T'r>B;dIw> T'm.q;w> alzati e dì loro<br />
TUTTO CIÒ CHE TI ORDINERÒ;<br />
&'W hNEhi ynIa]w: Ed ecco, oggi io faccio di te<br />
rc'b.mi ry[il. come una città fortificata,<br />
lzB; dWM[;l.W una colonna di ferro<br />
tv,xon> tAmxol.W e un muro di bronzo<br />
#r ykel.m;l. contro i re di Giuda e i suoi capi,<br />
#r-~aun> ynIa] ^T.ai-yKi perché io sono con te - oracolo del Signore-<br />
^l,yCih;l. per salvarti».<br />
1.1 Delimitazione e struttura<br />
L'inizio del brano nel v. 4 non crea problemi, in quanto i primi tre versetti di Ger 1 sono<br />
chiaramente una sovrascritta per l'intero libro. Inoltre si inizia con la tipica formula: «Mi fu rivolta<br />
questa parola del Signore».<br />
Perché però non delimitare il brano ai vv. 4-10 come fanno diversi commentatori? La<br />
giustificazione viene dall'osservazione di una struttura chiastica (di tipo A B B′ A′) nei vv. 4-19:<br />
A vv. 4-10: missione profetica<br />
B vv. 11-12: visione<br />
B′ vv. 13-16: visione<br />
A′ vv. 17-19: missione profetica
3<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
La corrispondenza fra B e B′ è evidente: si tratta di due piccoli racconti di visioni simboliche con<br />
una struttura simile (nei vv. 11-12 e 13-14), dove l'interpretazione dell'oggetto visto viene data dal<br />
Signore. La seconda unità è ampliata con l'aggiunta di ulteriori interpretazioni nei vv. 15-16.<br />
Tutti gli esegeti parlano appunto di due visioni in Ger 1.<br />
Il punto cruciale della strutturazione sta nella relazione fra i vv. 4-10 da una parte e i vv. 17-19<br />
dall'altra, così da giustificare la corrispondenza A e A′.<br />
Infatti<br />
(1) il contenuto è sostanzialmente identico: si parla della missione profetica a cui è associata<br />
l’assistenza di Dio<br />
(2) vv. 17-19 ritornano all'uso della seconda persona singolare nella parole di YHWH a <strong>Geremia</strong>,<br />
come nei vv. 4-10, e<br />
(3) ci sono anche diversi contatti lessicali fra vv. 17-19 e vv. 4-10, come se il secondo testo fosse<br />
scritto tenendo presente il primo<br />
(cf. vv. 8 e 19 [nell'ebraico il verbo (lcn) è identico, a differenza della versione italiana:<br />
proteggerti/salvarti]; vv. 7 e 17 [tutto quello che io ti ordinerò]; vv. 8 e 17 [la paura di fronte a<br />
loro]).<br />
Se si accetta la strutturazione proposta per vv. 4-19, allora avremmo al centro due brani simbolici<br />
che parlano delle relazioni di YHWH con Israele suo popolo nel presente e nel futuro immediato.<br />
Intorno a queste unità centrali ci sono le due unità (vv. 4-10 e 17-19) che presentano la chiamata<br />
profetica di <strong>Geremia</strong>. La chiamata, cioè, viene vista in funzione della relazione fra YHWH e il<br />
popolo, e non come un'esperienza a sé stante.<br />
1.2 Fenomeno della ripetizione binaria: il senso della struttura<br />
In Ger 1 abbiamo due volte la missione e, al centro, due visioni (tutto è ripetuto): ma perché dire<br />
due volte la stessa cosa?<br />
1. coerenza della Parola, cioè la fedeltà di Dio alla storia dell’uomo > nella varietà e molteplicità di<br />
cui è fatta la storia, vi è la presenza di un Unico, il Dio unico che si rivela fedelmente nella<br />
stessa Parola<br />
2. rivelazione del non-ascolto, cioè la fedeltà di Dio nella resistenza dell’uomo<br />
a) Per quanto riguarda il profeta: <strong>Geremia</strong> stesso è paradigma di colui che continuamente si<br />
oppone alla Parola che lo invia (1,6); le Confessioni ne sono la testimonianza chiara. La<br />
chiamata di Dio interviene tenendo conto di questa resistenza; non soltanto quindi l’obiezione<br />
di 1,7, ma tutta la paura di <strong>Geremia</strong>, la sua voglia di fuggire (come il profeta Giona: Gn 3,1), e<br />
di desistere sono assunti e riscattati dalla «ripetizione» divina (1,7-8).<br />
b) Per quanta riguarda il popolo (destinatario), il suo resistere alla Parola profetica è<br />
annunciato fin dal primo capitolo di <strong>Geremia</strong> (1,18), ed e poi ribadito, quasi come un<br />
leitmotiv, in diversi momenti della predicazione del profeta (3,13.25; 5,21; 6,10; 7,26-27; ecc.).<br />
Al non ascolto da parte di Israele corrisponde la ripetizione del messaggio divino (7,13; 25,4;<br />
26,5; 29,29; ecc.).<br />
3. la parola ultima, cioè la fedeltà di Dio fino alla fine<br />
La ripetizione (te lo dico e te lo ripeto) manifesta la definitività del messaggio, nel quale si<br />
gioca l’ascolto (non c’è altro da dire).<br />
Per quanta riguarda Ger 1, questa vuol dire che nella vocazione e nelle visioni di <strong>Geremia</strong>,<br />
ripetute due volte, c'e dentro tutto: è il messaggio primo e ultimo del profeta. Non si narra
4<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
solo qualcosa di iniziale (secondo la cronologia), ma si rivela qualcosa di originario (il principio<br />
e la fine dell'essere profeta). Anche noi oggi, odierni lettori, non dobbiamo far altro che<br />
riprendere ciò che e stato detto e già letto; non abbiamo una parola diversa da ciò che è<br />
scritto. Questo tipo di operazione (la rilettura del profeta) è quella che apre alla prospettiva del<br />
Nuovo Testamento, come rilettura globale dell' Antico Testamento. Gesù infatti si è<br />
richiamato continuamente a ciò che era stato scritto di Lui.<br />
(BOVATI, Ger. 1-6, pp. 81-83).<br />
Da quanto abbiamo detto sul senso della ripetizione e sul fatto che essa ricorre con così grande<br />
evidenza in Ger 1, appare evidente che questo testo ha una funzione del tutto particolare, sia perché<br />
collocato all’inizio del libro profetico, sia per i temi che esso tratta.<br />
Si tratta di un testo certamente programmatico in cui il messaggio è già detto in modo definitivo.<br />
2. La genesi del testo (studio diacronico)<br />
Lo studio diacronico prende lo spunto da osservazioni fatte sul testo. Certi fatti testuali possono<br />
far sorgere il sospetto che un testo non sia il semplice prodotto di un'unica operazione di scrittura da<br />
parte di un unico autore. Nel caso di Ger 1,4-19 parecchi studiosi pensano che tali indizi siano<br />
effettivamente presenti, e su questa base cercano di elaborare una storia della redazione del testo<br />
che possa rendere intelligibili i dati testuali.<br />
Parlare di critica letteraria significa dunque cercare di tracciare la storia dei vari interventi che<br />
hanno prodotto un determinato testo scritto > per noi: ricostruire le diverse fasi della composizione<br />
di Ger 1.<br />
Vedremo dunque gli indizi testuali, poi alcune proposte di spiegazione di questi dati nei termini<br />
di una storia di redazione del testo, e concluderemo con qualche riflessione sull'utilità tematica e<br />
teologica di tale studio.<br />
2.1 Gli indizi di stratificazione letteraria<br />
Notiamo tre tipi di indizi che fanno pensare ad una certa stratificazione letteraria: l'uso di schemi<br />
letterari, il problema del v. 5, e contatti con altri testi.<br />
2.1.1 La presenza di schemi letterari<br />
2.1.1.1 Uno schema di "chiamata" nei vv. 5-10.<br />
Ci sono paralleli impressionanti fra Ger 1,5-10 da una parte e altri due racconti di chiamata in<br />
altri libri (Mosè in Esod 3,10ss, e Gedeone in Gdc 6,14ss).<br />
Ger 1 Esod 3 Gdc 6<br />
Incarico 5 10 14<br />
Obiezione 6 11 15<br />
Conferma 7-8 12 16<br />
Segno 9(-10) 12 17ss<br />
Si noterà che le tre chiamate non sono identiche quanto al contenuto: nel caso di Ger 1 si tratta<br />
della chiamata al ministero profetico, mentre nel caso di Mosè la chiamata è ad un compito di
5<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
leadership (che comprende però anche una dimensione profetica, come attesta chiaramente Dt<br />
18,15) e nel caso di Gedeone si tratta di una chiamata ad un compito essenzialmente militare<br />
(liberare il popolo dall'oppressione di un nemico). Comune a tutte e tre però è il concetto di una<br />
chiamata da parte del Signore ad un individuo per una missione a beneficio del suo popolo.<br />
Le somiglianze fra i tre racconti di chiamata, secondo molti studiosi, si spiegano meglio<br />
ipotizzando l'esistenza di uno schema convenzionale noto agli scrittori ebrei. Se questo è esatto,<br />
bisogna notare due conseguenze.<br />
(1) Essendo lo schema convenzionale e utilizzabile per diversi casi, allora non possiamo leggere<br />
un tale racconto come una "registrazione dal vivo" dell'esperienza vocazionale del personaggio in<br />
questione; si tratta infatti di uno schema interpretativo-teologico e non di un formulazione<br />
personale. Ciò non mette in questione, evidentemente, la realtà di una esperienza di chiamata da<br />
parte di <strong>Geremia</strong> o degli altri; dice solo che la formulazione letteraria adoperata nei racconti non ci<br />
consente un accesso immediato e completo all'esperienza in termini psicologici.<br />
(2) Se ci domandiamo da chi viene una tale formulazione di Ger 1,5-10, le risposte potrebbero<br />
essere due: (a) <strong>Geremia</strong> stesso (direttamente o indirettamente tramite un suo assistente [Baruc?]),<br />
oppure (b) un discepolo-redattore posteriore che voleva interpretare tutto il ministero di <strong>Geremia</strong> in<br />
linea con il ministero di Mosè.<br />
2.1.1.2 Uno schema di racconto di visioni simboliche nei vv. 11-12 e 13-14<br />
Anche qui si tratta probabilmente dell'uso di uno schema convenzionale (cf. i racconti di Am 7,7-<br />
8 e 8,1-3 per una struttura dialogica simile).<br />
Si noterà qui in particolare l'espressione "una seconda volta" all'inizio della seconda visione (v.<br />
13a): "Quindi mi fu rivolta una seconda volta [תינשׁ: CEI liberamente "di nuovo"] questa parola del<br />
Signore...". La prima volta è evidentemente quella raccontata al v. 11.<br />
Ciò crea un po' di sorpresa per un lettore attento, perché il v. 11 non contiene la prima<br />
comunicazione della parola del Signore a <strong>Geremia</strong> nel testo; la formula di comunicazione della<br />
parola si trova già nel v. 4. L'autore del v. 13 lo ha forse dimenticato? O forse non aveva il testo dei<br />
vv. 4-10 di fronte a sé? In altre parole, potrebbe darsi che i due racconti delle visioni simboliche non<br />
fossero originariamente collegati con il racconto della chiamata nei vv. 4-10. Rimane almeno la<br />
possibilità che il testo di Ger 1,4-13(19) abbia raggiunto la sua forma attuale grazie all'intervento di<br />
più mani e in diversi tempi.<br />
2.1.2 Il problema del v. 5c<br />
Quando il testo del v. 5c dice "ti ho stabilito profeta delle nazioni" (cf. anche v. 10a),<br />
chiaramente intende "nazioni straniere" e non Giuda o Israele. Offrire una tale quasi-definizione del<br />
compito di <strong>Geremia</strong> sembra però non molto coerente con ciò che il libro stesso presenta del<br />
ministero personale del profeta (svolto, in gran parte almeno, a Gerusalemme e indirizzato al popolo<br />
di Giuda e Gerusalemme). Qualche volta <strong>Geremia</strong> ha incontrato rappresentanti di altri popoli (cf.<br />
cap. 27) e forse alcuni degli oracoli contro nazioni straniere (capp. 46ss) possono venire<br />
direttamente da lui, ma tutto questo non sembra sufficiente per poterlo "definire" come "profeta<br />
della nazioni" né per pensare che <strong>Geremia</strong> abbia iniziato il suo ministero sapendo di avere il<br />
compito di "profeta della nazioni".
6<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Sorge dunque la domanda: non sarebbe forse più comprensibile attribuire v. 5c a un redattore<br />
successivo rispetto al ministero di <strong>Geremia</strong>? Nelle generazioni successive infatti si poteva vedere<br />
che il messaggio di <strong>Geremia</strong> per il suo proprio popolo aveva avuto conseguenze anche per altre<br />
nazioni (per es. la caduta di Babilonia).<br />
2.1.3 Contatti letterari con testi di altri ambienti<br />
In diversi punti in Ger 1,4-19 troviamo espressioni che sono più tipiche di altri autori o di altre<br />
scuole teologiche che non di <strong>Geremia</strong> (si considerano di Ger i brani poetici del libro).<br />
Paragonare il v. 5a con Is 44,2 ("servo Israele") e 49,1.5 (il "servo del Signore"). Per i vv. 7c e 9c<br />
vedere Deut 18,18 (sul profeta che il Signore susciterà dopo Mosè). Mentre il linguaggio del v. 16<br />
ha molti contatti con testi deuteronomistici di critica religiosa e cultuale.<br />
Se cerchiamo una spiegazione di questi contatti, diverse sono le possibilità:<br />
(1) puro caso;<br />
(2) gli altri testi si sono ispirati da Ger 1;<br />
(3) Ger 1 si serve della fraseologia di questi testi (che però sono posteriori al tempo del profeta<br />
<strong>Geremia</strong>).<br />
Parecchi studiosi giudicano più probabile la terza spiegazione > ciò significherebbe che Ger 1 è<br />
frutto di un lavoro redazionale successivo al profeta stesso.<br />
2.2 Conclusione<br />
Non entriamo in questo corso nelle varie proposte di storia redazionale, e non discuteremo la<br />
posizione di quegli autori che non vedono la necessità di ipotizzare una qualche stratificazione nel<br />
testo di Ger 1. Conviene invece notare l'interesse interpretativo delle osservazioni che fanno sorgere<br />
la questione redazionale. Infatti gli indizi notati sopra ci aiutano anche a capire meglio il testo a<br />
livello teologico, e questo in due modi: da una parte facendoci capire ciò che è meglio evitare<br />
quando vogliamo formulare un'interpretazione del testo, e dall'altra suggerendoci aspetti utili che a<br />
prima vista forse non si vedevano nel testo.<br />
La presenza di schemi e generi convenzionali in Ger 1 ci invita a non proporre una lettura<br />
puramente autobiografica del testo, come se i versetti che leggiamo ci introducano direttamente<br />
nell'anima di <strong>Geremia</strong>. Al contrario dobbiamo aprirci ad una lettura teologica del testo, accogliendo<br />
i suggerimenti intertestuali che vengono dai contatti con altri testi fuori del libro di <strong>Geremia</strong>:<br />
- vedere <strong>Geremia</strong> in relazione a Mosè (cf. lo schema vocazionale e i contatti con Deut 18)<br />
- con il servo del Signore (collettivo e forse anche individuale: cf. i contatti con Isa 44 e 49)<br />
- forse anche con Samuele (chiamata da giovane: cf. 1 Sam 3).<br />
Poi i contatti fra Ger 1 e Ger 2,1-3 ci invitano ad aprirci alla possibilità di una rilettura<br />
paradigmatica della chiamata di <strong>Geremia</strong> (paradigma della chiamata di Israele fedele con la sua<br />
missione alle nazioni).<br />
Bovati > evidenzia i numerosissimi contatti con altri testi (Deut-Is e figura del Servo; fraseologia<br />
deuteronomista, Is 6 e la mano che tocca la bocca, Am e le visioni, vocazione di Mosè e di<br />
Samuele) e conclude (pp. 49-50):<br />
Dunque, in sintesi, dobbiamo constatare che non vi è nessuna parte del cap. 1 che presenti quegli<br />
elementi di originalità letteraria e di coerenza con il patrimonio geremiano da farla ritenere il nucleo
7<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
autentico. D'altra parte, dobbiamo altresì ammettere che lungi dall'essere un ammasso caotico, il nostro<br />
capitolo è «costruito» con una struttura organica, come un insieme armonico.<br />
Da qui la nostra opinione in merito alla paternità letteraria e alla datazione di Ger 1,4-19: pare<br />
ragionevole supporre che il nostro testa sia stato composto totalmente da un redattore esilico, che ha utilizzato<br />
il materiale proveniente da molteplici tradizioni, proprio allo scopo di suggerire che, nel profeta<br />
<strong>Geremia</strong>, la profezia giunge, in un certo senso, al suo compimento, sia perché conduce fino alla<br />
sventura che si abbatte su Gerusalemme (vv. 13-16), sia perché apre ad un futuro di salvezza di cui la<br />
vicenda personale del profeta è segno anticipatore (vv. 8.19).<br />
In ogni caso, ogni lettore deve confrontarsi con il testo «finale» che la tradizione di Israele ci ha<br />
consegnato e con il messaggio che risulta da questa preciso insieme; certo può talvolta essere utile<br />
scomporre un tutto nelle sue parti costitutive, secondo una qualche cronologia di formazione, ma alla<br />
fine si deve fornire una interpretazione che renda conto del testo nella sua forma canonica.<br />
3. Il genere letterario di Ger 1,4-19<br />
A cosa serve determinare il genere letterario di un testo?<br />
Due scopi principali:<br />
1. Se conosco quello che è tipico, convenzionale di un genere, posso vedere anche ciò che è<br />
particolare, caratteristico, diverso all’interno del testo che sto studiando e che, pure,<br />
appartiene a quel genere > evidenziare ciò che è esclusivo di un determinato scritto può<br />
rappresentare una buona apertura per l’interpretazione.<br />
2. Riconoscere un genere letterario permette di capire la «funzione» di una certa modalità<br />
espressiva: chi non capisce il genere letterario, o chi prende un genere per un altro, commette<br />
gravi errori di interpretazione.<br />
3.1 Il genere letterario del racconto di vocazione profetica<br />
Uno sguardo agli elementi che lo compongono secondo diversi autori:<br />
Kutsch Habel Del Olmo Lete Bretón<br />
Yhwh<br />
compito<br />
chiama a un Dio si presenta teofania introduzione<br />
paura e obiezioni del<br />
candidato<br />
discorso introduttivo missione missione<br />
Yhwh respinge le missione segno investitura<br />
obiezioni, conferma<br />
l’incarico e dà un segno<br />
obiezione visioni<br />
conferma<br />
segno<br />
conferma<br />
Cosa ne emerge?<br />
Una certa arbitrarietà, difficoltà a determinare la struttura.<br />
Ora è indispensabile che vengano chiaramente definiti i precisi elementi della struttura, nella loro<br />
natura propria e nel rapporto che sistematicamente intrattengono con gli altri. Vediamo di chiarire con<br />
qualche esempio. Si dice che appartiene al genere letterario del racconto di vocazione l'elemento
8<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
«segno» che Dio concede a conferma della vocazione; ma c'è il rischio di far entrare forzatamente in<br />
questa categoria tratti narrativi che le sono estranei (come, ad esempio, dire che l'investitura, cioè il<br />
toccare la bocca di <strong>Geremia</strong> sia un «segno»). E ancora, l'elemento «obiezione», da parte del chiamato,<br />
deve essere ritenuto un elemento importante, perché frequentemente attestato nei racconti di<br />
vocazione, ma può avvenire che, in un determinato racconto di vocazione, esso non venga espresso, ed<br />
è allora la sua omissione a diventare significativa. (p. 58)<br />
Pare dunque opportuno rintracciare la struttura fondamentale del genere letterario.<br />
Si tratta di tre momenti che compaiono anche in Ger 1,4-10:<br />
1. il manifestarsi imperativo di Dio<br />
- esperienza del sentirsi interpellato da Dio<br />
- iniziativa da parte del Signore<br />
- i segni teofanici servono a dire che è proprio Dio ad agire, ma possono anche mancare (nel<br />
nostro caso mancano)<br />
- decisivo: percepire una Parola che esige obbedienza («ti ho stabilito profeta delle nazioni»)<br />
- l’uomo è reso capace di rispondere a Dio<br />
2. la resistenza da parte dell’uomo<br />
- la persona umana risponde: in modo consapevole e libero, il chiamato interagisce e parla, in<br />
risposta a quanto ho percepito come appello divino.<br />
- qui va collocata anche l’obiezione: difficoltà acutamente e dolorosamente avvertita dalla<br />
coscienza profetica, di non essere in grado di portare a compimento il compito affidato per<br />
varie ragioni:<br />
> sono indegno perché peccatore<br />
> mi mancano i requisiti indispensabili<br />
> è impossibile adempiere quanto richiesto<br />
> è inutile la mia missione, i destinatari non ascolteranno<br />
La resistenza da parte dell'uomo non va letta (solo) come manifestazione di una coscienza pavida e<br />
indolente; essa è invece elemento indispensabile al rivelarsi autentico della vocazione in quanto<br />
mandato divino. Infatti è componente essenziale della missione profetica la consapevolezza che Dio<br />
comanda ciò che l'uomo non sa fare, ciò che l'uomo non può compiere «naturalmente»; viene da Dio<br />
infatti non solo la chiamata, ma anche la possibilità di adempierla. Dio si rivela proprio in questa<br />
strutturale sproporzione tra le deboli qualità umane e l' atto sublime richiesto al profeta (p. 60).<br />
3. la conferma divina<br />
- Dio ribadisce la missione e chiarisce come risulterà fattibile quel compito che il profeta<br />
reputa difficile o addirittura impossibile<br />
> assicura la sua presenza attiva<br />
> tocca il corpo del profeta: fa sentire, lascia traccia della sua visita<br />
In questa linea si colloca talvolta l’esperienza del segno.<br />
Non va visto come un’oggettiva garanzia per chi dubita... senza la fede, infatti, anche il<br />
segno può sempre essere contestato nella sua veridicità.<br />
In Ger 1 non abbiamo alcun segno miracoloso.
9<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Chi acconsente alla missione si affida in realtà sempre ed esclusivamente alla promessa; al tempo stesso,<br />
ciò che sostiene, incoraggia, conferma la decisione di obbedire al mandato divino è l'esperienza corporea<br />
dell' intervento di Dio, vissuta come accrescimento di forza...<br />
Si tratta di un genere letterario. Colui che si sente chiamato da Dio tenta di dire come la Parola<br />
autorevole del Signore si imponga a lui, vincendo la naturale resistenza della psiche umana. Uno dice di<br />
essere toccato sulla bocca, un altro afferma di sentire le viscere riempite da un nutrimento divino (Ez<br />
3,3), un altro di riacquistare forza nella mano (Es 4,6-8), o di rimettersi in piedi (At 26,16). Ciò che viene<br />
significato dunque è che l’uomo si esperimenta come sottoposto all' azione potente di Dio non solo<br />
nell' essere chiamato, ma anche nella capacita reale di adempiere ciò per cui è stato chiamato (p. 61).<br />
4. Analisi esegetica per parti di Ger 1,4-19<br />
Prima i passi estremi A e A’ (vv. 4-10 e 17-19) che narrano della vocazione; poi i passi centrali<br />
B e B’ che parlano delle due visioni (vv. 11-12 e 13-16).<br />
4.1 La missione profetica (vv. 4-10 e 17-19)<br />
4.1.1 La chiamata (vv. 4-10)<br />
Come leggere un racconto di vocazione?<br />
- genere letterario in cui appaiono due locutori, in un dialogo immaginario > non si tratta della<br />
cronaca di un evento... non va letto così...<br />
- mettere in scena Dio che parla serve a dire la dipendenza obbediente della parola umana da<br />
Colui che legittima tale parola > la parola umana, di Ger, si fonda quindi completamente su un’altra<br />
Parola.<br />
La chiamata, allora, non è un «episodio» della vita profetica, ma ne è, invece, l’intima essenza.<br />
Il passo è strutturato il 3 parti: iniziativa divina (vv. 4-5); obiezione umana e conforto divino (vv.<br />
6-8); conferimento di autorità al profeta (vv. 9-10).<br />
Iniziativa divina (vv. 4-5)<br />
In principio... Dio parla... > una parola che fonda tutte le altre.<br />
Cosa dice?<br />
• conosciuto (^yTi[.d:y> !j,B,b; ^r>C'a, ~r il rapporto padre-figlio sembra essere quello più adeguato a<br />
spiegare questa particolare relazione.<br />
I motivi che sostengono questa interpretazione sono molti (e complessi)<br />
In sintesi estrema:<br />
* il contesto: riferimento al concepimento
10<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
* vb. che esprime il riconoscimento del figlio da parte del padre in alcuni testi (Dt 33,9; Is 63,16)<br />
Dio riconosce Ger come proprio figlio e assume una responsabilità paterna nei suoi<br />
confronti<br />
* prima del concepimento: assoluta gratuità della relazione, provenienza amorosa di Dio (niente<br />
a che vedere con determinismo, problemi relativi alla libertà, ecc.)<br />
* il vb è usato anche per definire il reciproco riconoscimento in un contesto di alleanza > Dio fa<br />
alleanza con... quindi elegge, sceglie... Categoria fondamentale nella Scrittura è proprio quella di<br />
elezione (cfr. Abramo, Mosè, Davide...)<br />
> speciale relazione di alleanza che il Signore stabilisce con il suo profeta<br />
Mediante un’accurata indagine lessicografica, viene chiarito il rapporto esistente tra la missione<br />
profetica («ti ho reso profeta delle nazioni») e il suo fondamento («ti ho conosciuto»): questa consiste<br />
nell'intima relazione (di alleanza, di paternità) tra YHWH e <strong>Geremia</strong>, che ha come manifestazione<br />
significativa sia la comunicazione di parola, sia la protezione contro i nemici.<br />
• consacrato, cioè messo a parte, riservato<br />
Se il soggetto è Dio: egli riserva per se stesso ciò che consacra (cf. Nm 3,11-13; 8,17; 1Re 9,7).<br />
In Nm la questione è quella del figlio primogenito...<br />
Il Signore parlò a Mosè e disse: 12 "Ecco, io ho scelto i leviti tra gli Israeliti al posto di ogni<br />
primogenito che nasce per primo dal seno materno tra gli Israeliti; i leviti saranno miei, 13 perché<br />
ogni primogenito è mio. Quando io colpii tutti i primogeniti in terra d'Egitto, io consacrai a me in<br />
Israele ogni primogenito, sia dell'uomo sia del bestiame; essi mi apparterranno. Io sono il Signore".<br />
a. appartenenza a Dio<br />
b. per essere dato...<br />
c. figura di tutto Israele in quanto tutti figli di Dio<br />
• stabilito profeta delle nazioni<br />
Dio riconosce figlio e consacra per... costituire Ger profeta delle nazioni > è quello che verrà<br />
chiaramente ribadito ai vv. 9-10 e poi 17-19 > si tratta quindi di un elemento centrale!<br />
Come abbiamo visto, il v. 5c crea problemi perché non si riconosce a Ger lo statuto di profeta<br />
delle nazioni da un punto di vista «storico»... ma è tutto il racconto di vocazione che lo descrive<br />
esattamente in questi termini! Forse si tratta piuttosto di comprendere che cosa effettivamente<br />
significhi l’espressione!<br />
Il profeta è l’uomo della parola (Ger 18,18: «non verrà meno la parola ai profeti...»)<br />
Dio parla a Ger dal principio > con questo lo rende capace di parlare (così come ogni figlio<br />
impara a parlare dai suoi genitori)<br />
Dio dona: la possibilità di parlare, la vocazione profetica...<br />
Dio comanda: al profeta di parlare > lo invita ad entrare in un’obbedienza<br />
«delle nazioni»: destinazione universale del ministero profetico di Ger<br />
Quanto di più tipico della tradizione biblica: Dio che sceglie uno solo... a favore di tutti...<br />
Dinamica dell’elezione...<br />
- Ger non sembra che abbia mai predicato al di fuori d’Israele<br />
- questo tipo di ricerca contraddice, peraltro, il senso stesso degli oracoli contro le nazioni > sono<br />
comunque rivolti a Israele<br />
* non ti accada lo stesso<br />
* io punisco i tuoi nemici e, quindi, ti salvo
11<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Cfr i contatti con i canti del Servo: Is 42,1.6; 49,1.7<br />
Se si suppone come appare probabile - una dipendenza letteraria di Ger 1,5 dai testi deutero-isaiani<br />
sopra citati, si dovrebbe allora dedurre che <strong>Geremia</strong> viene visto (dal redattore di Ger 1) come il «servo»<br />
del Signore che apporta la salvezza fino alle estremità della terra. Se, viceversa, si ritiene che il testo di<br />
Ger 1,5 abbia ispirato quelli del Deutero-Isaia, allora , <strong>Geremia</strong> è presentato come la «figura»<br />
anticipatrice di quel «servo» che compirà ciò che in <strong>Geremia</strong> è stato annunciato.<br />
Nell'insieme del libro di <strong>Geremia</strong>, nella sua ultima stesura, la destinazione del profeta <strong>Geremia</strong> «per<br />
le nazioni» ha comunque una sua intrinseca motivazione. II profeta parla infatti della fine di<br />
Gerusalemme (cfr. 1,3 quale delimitazione temporale della sua profezia), evento questo annunciato fin<br />
dall'inizio nella seconda visione (1,13-16: nella cornice del racconto di vocazione), e iscritto poi nel<br />
quadro di un giudizio universale riguardante tutte le genti (cap. 25: alla fine della prima grande sezione<br />
del libro). <strong>Geremia</strong> è stato «preposto» alle nazioni e a tutti i regni per un compito di «distruzione».<br />
Le nazioni sono implicate nella profezia geremiana perché sono chiamate da Dio a giudicare<br />
Gerusalemme, ma anche perché saranno a loro volta giudicate.<br />
Ciò che accade a Gerusalemme è quindi il simbolo di ciò che capita a tutti i popoli: tutti sono<br />
sottoposti all’ira divina, perché tutti sono peccatori (Ger 25,15-29; Rm 1 - 3). Ma il destino di morte<br />
non è l’ultima parola per Gerusalemme: la città verrà riedificata (Ger 30-33), segno anch’esso universale,<br />
principio di speranza per tutte le genti, per le quali pure è annunciata la restaurazione (cf. Ger 1,10).<br />
Non c'è un annuncio universale diverso da quello della morte e della risurrezione; e <strong>Geremia</strong> ne è<br />
portatore non solo in parole, ma anche nella sua storia personale (1,17-19), quale «servo» autentico del<br />
Signore: la storia del suo corpo, calato nella cisterna (38,6) e miracolosamente tirato su vivo (38,13) è<br />
figura di Colui che e morto e risorto, primogenito di coloro che risorgono dai morti (Coli, 18). Non vi è<br />
altro segno che quello di Giona. La predicazione apostolica, esplicitamente rivolta a tutti i popoli, avrà<br />
appunto il suo centro nevralgico nell'annuncio della morte e della risurrezione del Servo (pp. 106-107).<br />
Quando Dio chiama Ger al suo compito di profeta?<br />
Prima... prima di qualunque cosa possibile: prima della nascita, anzi prima del suo stesso<br />
concepimento.. prima...<br />
- non è l’uomo a scegliere... ma è sempre Dio a manifestare la sua iniziativa<br />
- Dio è l’origine assoluta: della vita e della chiamata<br />
Obiezione umana e conforto divino (vv. 6-8)<br />
I vv. 6-8 rappresentano la seconda parte del racconto, nella quale si rende presente il lato umano, non<br />
come pura passività sottoposta alla divina Onnipotenza, ma nel suo aspetto di iniziativa responsabile.<br />
Dal punto di vista letterario infatti lo stesso <strong>Geremia</strong> espone le sue ragioni (v. 6), e la Parola di Dio si<br />
modula tenendo conto del necessario consenso che l'uomo deve manifestare e il concorso che deve<br />
fornire per l'esercizio concreto della profezia (vv. 7-8).<br />
I vv. 6-8 sono quindi di particolare significato, in quanto evidenziano la partecipazione attiva e<br />
responsabile dell'uomo, partecipazione che suscitata e voluta dall’azione originaria, incondizionata,<br />
assoluta di Dio.<br />
a) Obiezione umana<br />
La P/D, invece di suscitare gioia ed entusiasmo... provoca sentimenti del tutto opposti<br />
Le uniche parole di Ger, all’interno del racconto di vocazione strettamente inteso, sono parole di<br />
obiezione e, più radicalmente, di lamento (Hh'a]).
12<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
L’esperienza della chiamata è vissuta come qualcosa di problematico, come l’appello ad entrare<br />
in una condizione di permanente difficoltà e pericolo [cfr. poi i vari testi di lamentazione di Ger, in<br />
particolare 20,14-18]<br />
Non so parlare<br />
... perché giovane (quindi non è un difetto come essere balbuziente di Mosè)<br />
È chiaro che qui si fa riferimento non ad un parlare qualsiasi... ma al parlare in verità: il profeta<br />
parla e dice la verità che è, per sua natura, rivelazione, novità...<br />
II non saper parlare denota invece un non adeguato rapporto alla «parola» stessa, nella sua natura di<br />
parola vera; e questa è certamente una seria difficoltà all'essere profeta, se - come si è visto il profeta e<br />
l'uomo della parola; la motivazione di questa inettitudine viene dal fatto che <strong>Geremia</strong> è «giovane».<br />
... perché sono giovane<br />
dobbiamo evidenziare le connotazioni negative del termine «giovane» (... quasi impossibile nella<br />
nostra società...)<br />
- incapacità e incompetenza motivata dall’immaturità... ancora non sa e non sa fare<br />
- il saper fare poi, diviene un fattore di autorità, riconosciuto dentro una società > in Israele è<br />
l’anziano che ha autorità perché è maturo, gode di prestigio, la sua parola si impone...<br />
A motivo della sua giovane età... la sua parola non ha peso, non sarà riconosciuta.<br />
Proprio per il fatto di essere «giovane», <strong>Geremia</strong> si sente inadatto ad esercitare una funzione<br />
autorevole, a imporre agli altri una parola normativa, a parlare «veramente» in modo che il suo dire<br />
diventi luogo di obbedienza.<br />
b) Risposta divina<br />
Non dire...<br />
Il Signore riprende puntualmente l’obiezione di Ger. Non nega che sia effettivamente così... ma<br />
gli proibisce di dirlo, di dare voce al suo lamento... Gli impone di non dare credito a ciò che sarebbe<br />
logico, deducibile a motivo della sua reale condizione; gli chiede, invece, di obbedire alla missione<br />
che gli è consegnata.<br />
Il riferimento alla propria personale debolezza rende muti (o logorroici... che è lo stesso); il riferirsi a<br />
Dio, in umile obbedienza, rende profeti.<br />
Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò<br />
Movimento... dinamismo della missione: varietà dei luoghi e dei destinatari<br />
Un corpo che si mette in movimento secondo il comando divino...<br />
dirai... tutto...<br />
L’andare del profeta è finalizzato al suo parlare...<br />
In obbedienza al comando divino: fedele alla totalità di quello che gli viene rivelato... senza<br />
selezioni indebite...<br />
L’incompetenza del profeta non viene superata dallo sforzo di risultare adeguati, ma dall’assumere<br />
l’incarico come obbedienza.<br />
non aver paura...<br />
Ger non ha mai detto di avere paura... ma il Signore rivela così il vero motivo delle sue obiezioni<br />
alla vocazione profetica. Nella profezia, ciò che fa resistenza a Dio è la paura. È allora<br />
indispensabile comprendere perché essa si manifesta e come sia possibile farle fronte...<br />
Il profeta fa esperienza della paura
13<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
- esperienza strutturale dell’essere umano, in quanto percezione della propria fragilità, del<br />
proprio corpo come mortale > Ger sa di dover andare incontro a numerose difficoltà... opposizione,<br />
umiliazione, morte.<br />
La parola profetica suscita fatalmente una ostilità (persecuzione), pone anzi il profeta nel rischio<br />
mortale, e quindi ha sempre a che fare con la paura: essa può essere superata (non evitata) ascoltando la<br />
Parola che dice «non temere». La paura non è vinta dai meccanismi psicologici che spingono all'azione,<br />
ma dall'ascolto della Parola.<br />
perché io sono con te per proteggerti (CEI)<br />
Questa traduzione non ci sembra felice: il vb. lcn (nṣl) significa «salvare, tirar fuori da...»<br />
Dio dichiara che la sua presenza porterà soccorso, che il profeta non sarà mai solo.<br />
Dio non promette un avvenire tranquillo (come suggerisce invece il vb. proteggere... evitare ad<br />
un altro le difficoltà), ma promette il soccorso dentro la prova (non il non passare attraverso la<br />
prova!). È questa fede che consente al profeta di affrontare con coraggio la sua missione e il suo<br />
martirio.<br />
Conferimento di autorità (vv. 9-10)<br />
stese la mano... mi toccò la bocca (lett. sua mano.. mia bocca)<br />
La paura paralizza... innanzitutto la lingua: impossibilità di parlare.<br />
L’intervento di Dio che stende la sua mano e tocca la bocca del profeta ha l’effetto di liberare in<br />
questi la parola. Indubbia somiglianza del testo con Is 6,6-7... ma in Ger l’elemento della<br />
purificazione è totalmente assente > qui Dio abilita a parlare, dà la sua autorizzazione al profeta.<br />
In qualche modo questo gesto è anche un segno: il profeta percepisce che il proprio corpo è<br />
salvato dalla paura e reso capace di fare quello che Dio ordina (parlare).<br />
mie parole sulla tua bocca<br />
Dio dona la qualità stessa dell’essere profeta<br />
oggi... della profezia: voluta prima del concepimento... la profezia si realizza nel presente<br />
storico, in un giorno... rappresenta il momento in cui il profeta «sente» la sua chiamata, ne prende<br />
coscienza e vi aderisce.<br />
ti do autorità (lett. «ti costituisco»)<br />
- viene da Dio, è la sua stessa autorità<br />
- ha un’estensione universale<br />
- non ha riconoscimenti esterni.... (nascita). È interamente legata al dono della parola.<br />
sradicare e demolire<br />
II profeta riceve un immenso potere, quello di abbattere e riedificare, come fosse un grande sovrano<br />
dalla cui parola dipende il destino di tutte le genti. Due sono le metafore presenti nella serie verbale.<br />
La prima è desunta dal mondo agricolo (sradicare, piantare); il mondo è visto come un campo, nel<br />
quale Dio (o il suo «servo») impianta la vita e può anche sradicarla (forse sullo sfondo vi è l'immagine<br />
della vigna, a cui Israele è spesso paragonato; cf. Is 5,1-7; Sal 80,9-12.16; ecc.).<br />
La seconda metafora è invece presa dal mondo della abitazione (o, più in generale, della città), di cui<br />
Dio è artefice e di cui può essere demolitore.<br />
Va comunque notato il movimento... innaturale: prima c’è lo sradicamento e la distruzione, poi<br />
l’attività di piantare e costruire: ciò significa che il punto d’arrivo è la vita, mentre l’azione devastatrice è<br />
solo mediazione e passaggio. Nonostante il tono minaccioso della predicazione di Ger, il risultato finale<br />
è quello di stabilire la vita sulla terra. Al ministro di Dio è dato ogni potere, affinché egli, mediante la<br />
parola, operi una specie di nuova creazione (p. 124).
14<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
4.1.2 La conferma della missione (vv. 17-19)<br />
L’ultimo passo riprende, a modo d’inclusione, i temi (vocazione e missione) dei vv. 4-10.<br />
Qui il campo semantico è quello del confronto bellico: siamo in guerra! (preparato anche dalla<br />
seconda visione)<br />
Ci sono connotazioni regali nella descrizione del profeta... ma la metafora bellica non si addice<br />
unicamente al re. Il profeta, peraltro, rivela la sua autorità proprio nel duro contrasto con le altre<br />
autorità (re in particolare).<br />
Tu stringi la veste ai fianchi<br />
Per il lavoro, per la marcia, per la battaglia<br />
- allusione al mettersi in cammino... come gli era stato ordinato... Ger deve anche alzarsi...<br />
- si evoca anche il disporsi al combattimento (cf. Gb 38,3 e 40,7) > rapporto con il v. 19. Si<br />
dichiara esplicitamente che gli faranno guerra.<br />
Con questa locuzione metaforica si invita ad affrontare con coraggio il proprio compito, ad<br />
obbedire alla missione ricevuta.<br />
non spaventarti... sarò io a farti paura<br />
Qui il vb utilizzato è un altro (ttx) rispetto al v. 8 > introduce probabilmente una connotazione<br />
di panico (guerra). Non è solo un’esortazione... è un comando, con conseguenza sanzionatoria. Dio<br />
pone un’alternativa: o il profeta esce dalla paura (mediante la fede in Dio), oppure viene condannato<br />
al panico.<br />
Io faccio di te... (~AYh; ^yTit;n> hNEhi ynIa]w:)<br />
Dio aveva prima assicurato la sua presenza efficace e lo ripete di nuovo al v. 19. In più si<br />
aggiunge qui un suo intervento che riguarda il corpo del profeta: lo rende invulnerabile.<br />
- città fortificata<br />
- colonna di ferro (o sbarra di ferro)<br />
- muro di bronzo<br />
Tali sintagmi hanno funzione sinonimica e l’accumulo serve come superlativo per ribadire<br />
l’assoluta invulnerabilità del profeta di fronte a tutti i possibili attacchi dei suoi avversari.<br />
Chi sono gli avversari? Tutti, a partire dai responsabili: re, capi, sacerdoti e popolo...<br />
Promessa di vittoria: «ti faranno guerra, ma non ti vinceranno»<br />
* Conflitto: tra il profeta e le altre cariche che, tutte, ricevono una loro legittimazione<br />
dall’autorità divina > ma al profeta è conferita un’autorità suprema. Il conflitto è inevitabile:<br />
ognuno accampa i suoi diritti... e il profeta è meno riconoscibile da un punto di vista istituzionale.<br />
* Vittoria: un corpo profetico martoriato ma non ucciso, che ha superato lo scontro bellico<br />
soffrendo, ma senza morire (Ger che riemerge dalla cisterna: 38,13; 39,12).<br />
4.2 Le visioni (vv. 11-12 e 13-16)<br />
Al centro, tra la chiamata e la sua conferma, abbiamo due racconti di visione.<br />
Quale rapporto tra profezia e visione in genere? E in questo caso in particolare?<br />
Profeta = veggente (ha,ro rō’eh) o visionario (hz Is 6; Ez 1-3; in Am<br />
vocazione (7,10-17) tra due visioni; qui in Ger al contrario (visioni in mezzo al racconto di<br />
vocazione).<br />
Perché la visione?
15<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
- aspetto soggettivo: il profeta stesso esprime la certezza della presenza di Dio nella sua<br />
esistenza, nella sua storia<br />
- aspetto oggettivo: nella visione si comunica anche il messaggio (in forma sintetica) che il<br />
profeta deve trasmettere.<br />
La visione non è tanto qualcosa che «facilita» la comprensione... al contrario, essa dev’essere<br />
interpretata, è un segno enigmatico che esige l’intuizione, la capacità di cogliere la coerenza<br />
semantica dell’insieme. Questo aspetto è molto sottolineato in Ger 1, là dove il profeta vede<br />
qualcosa di piuttosto comune, di normale... e deve interpretare il senso non comune di ciò che vede.<br />
Due visioni: ma per dire, insieme, in modo complementare, una sola cosa.<br />
4.2.1 Prima visione (vv. 11-12)<br />
Il Signore rivolge una parola e la parola è: «Che cosa vedi?» > anche la visione assume il valore<br />
di parola...<br />
La risposta di Ger: ha,ro ynIa] dqEv' lQEm; > varie le interpretazioni...<br />
«ramo di mandorlo», «verga, bastone... »<br />
C’è qualcosa che Ger vede e che, secondo alcuni commentatori, tutti possono vedere: è un<br />
oggetto reale, concreto, che si trova sotto gli occhi di tutti... ma al profeta è chiesto di vedere oltre<br />
quello che vedono tutti, di coglierne un significato differente, che il Signore stesso gli rivela.<br />
Interpretazione della visione<br />
Attraverso un gioco di parole: «mandorlo» (dqEv' šāqēd) e «vegliare» (ynIa] dqEvo-yKi šōqēd)<br />
Il rapporto esistente tra due parole - foneticamente simili ma semanticamente diverse serve ad<br />
indicare il rapporto tra due diverse interpretazioni della stessa realtà. Vi è infatti la «vista» degli oggetti e<br />
degli eventi, alla quale tutti possono accedere: si tratta della percezione immediata, espressa dalla parola<br />
di <strong>Geremia</strong> «vedo un bastone di mandorlo». Ma vi è anche la «visione» della realtà, quella di cui YHWH<br />
dice: «hai visto bene»: è quella che rivela un senso nascosto nelle cose, e quella che coglie l'intervento di<br />
Dio nella storia («io veglio sulla mia parola per realizzarla»).<br />
Attraverso lo «scarto linguistico», cioè il leggero divario esistente tra la prima e la seconda parola,<br />
viene mostrato che il profeta non vede delle cose diverse dagli altri (la realtà è una sola, davanti agli<br />
occhi di tutti), ma piuttosto che le vede diversamente; si potrebbe dire forse che la parola dqEv'<br />
rappresenta l'apparenza (ciò che è evidente a tutti, ciò che possono vedere anche i falsi profeti), mentre<br />
la parola dqEvo rappresenta la verità nascosta (percepibile non agli occhi, ma all'orecchio attento del vero<br />
profeta).<br />
La verità nascosta è Dio all'opera laddove gli uomini comuni vedono una realtà mondana, per altro<br />
non particolarmente significativa, il profeta scorge un senso da collegarsi con la natura stessa di Dio;<br />
laddove gli uomini vedono un simbolo del potere (il bastone del comando), il profeta vede l'imperio di<br />
Dio che dirige la storia. Infatti Dio parla, e il profeta vedendo una verga di mandorlo ascolta questa<br />
parola di Dio, Parola che essendo divina è «profetica», e quindi si realizzerà (p. 134).<br />
Ma si tratta di una buona o di una cattiva notizia? è un lieto annuncio o una minaccia?<br />
Il ramo di mandorlo sembra indicare il rifiorire della vita.... ma di fatto non viene detto...<br />
La notizia è cattiva (si annuncia la distruzione di Gerusalemme, il castigo) ma è insieme buona<br />
perché Dio continua a realizzare la sua Parola.<br />
Si potrebbe anzi dire che la prima visione ha solo scopo di ribadire la qualità «divina» della parola del<br />
Signore, cioè il suo potere effettivo (performativo) nella storia umana; come è detto nel Deutero-Isaia,<br />
YHWH parla per dire che egli parla, ed annuncia ciò che si realizzerà affinché, una volta compiutosi,
16<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
tutti riconoscano che Lui è il Signore (Is 41,22-24; 43,12; 44,7; 46,10; ecc.). E questo naturalmente in un<br />
orizzonte di vita e di speranza.<br />
4.2.2 Seconda visione (vv. 13-16)<br />
È solo nella seconda visione che si ha un ampliamento della sezione interpretativa.<br />
Cosa vede questa volta?<br />
Una pentola posta sul fuoco (su questo tutti concordano).<br />
Altri elementi invece non sono molto chiari.<br />
La pentola rappresenterebbe Gerusalemme che è scaldata (attaccata) a partire dal nord.<br />
Cfr Ez 11,3; 24,2<br />
Da questi testi risulta<br />
(a) che la metafora della pentola veniva (all'incirca all'epoca di <strong>Geremia</strong>) applicata a Gerusalemme,<br />
(b) che essa serviva come metafora del giudizio divino,<br />
(c) che la sanzione del male consisteva nell'attaccare la città con il fuoco: qui l'immagine<br />
rappresentava l'assedio della città e il suo incendio dopo la sconfitta. Tutto questo ci sembra possa<br />
applicarsi convenientemente al testo di Ger 1,13-16.<br />
Dal settentrione dilagherà la sventura<br />
- si sperava in un bene dalla sconfitta degli Assiri... invece dal nord, dai Babilonesi, arriverà la<br />
sventura, il male (h['r"h' hārāʽāh)<br />
Per chi? Per tutti!<br />
L’espressione «per tutti gli abitanti della terra/paese» è ambigua.<br />
Certamente indica innanzitutto il regno di Giuda.<br />
Ma si può anche pensare che ci si volga riferire a tutte le nazioni: la fine di Gerusalemme è segno<br />
anticipatore della fine di tutte le nazioni (cf. 45,4-5).<br />
C’è una specie di convocazione universale: tutte le nazioni, tutti i regni sono coinvolti nell’atto<br />
della distruzione di Gerusalemme > sono testimoni del giudizio divino sulla storia.<br />
- giudizio dei re > c’è un processo<br />
v. 16<br />
Allora sarà il Signore stesso a pronunciare la sua sentenza...<br />
In conclusione, la visione della pentola viene dunque interpretata come annuncio della caduta di<br />
Gerusalemme, e questa come azione giudiziaria; in essa vengono coinvolte, a vario livello, tutte le<br />
nazioni della terra.<br />
Necessità di tenere presenti le due visioni di <strong>Geremia</strong>.<br />
La seconda, chiaramente minacciosa, mostra le conseguenze del «fare» umano (v. 16b), che essendo<br />
idolatrico e quindi vano, non può che essere destinato all'annientamento; tuttavia il «fare» divino che è<br />
compimento della sua Parola (v. 12b), non può limitarsi a questo giudizio di condanna; una qualche<br />
apertura positiva pare suggerita dunque proprio dalla prima visione, che, in posizione privilegiata, invita<br />
a leggere tutta la storia secondo il movimento del giudizio che «abbatte» e che « ricostruisce».<br />
È proprio questo il messaggio dei capitoli 2-3 di <strong>Geremia</strong>, rivolti a quell'Israele che ha vissuto la<br />
maledizione dell'esilio e viene ora invitato ad aprirsi alla possibilità del ritorno al Signore e alla<br />
prospettiva di benedizione.
17<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Tematica fondamentale dei vv. 4-19 e loro funzione programmatica nel libro<br />
Da quanto abbiamo detto sulla straordinaria ricchezza di questo testo possiamo cogliere bene il<br />
suo valore programmatico.<br />
La prima visione sottolinea la cura vigilante di YHWH sulla sua parola annunziata dal profeta. Il<br />
Signore porterà a compimento il contenuto della parola profetica. Dietro queste parole c’è la<br />
potenza del Signore che vigila sulle parole del profeta affinché le porti a compimento.<br />
Nella seconda visione viene indicato uno dei maggiori contenuti della parola divina affidata al<br />
profeta, cioè, l'annuncio di una invasione dal nord come castigo per i peccati di idolatria del popolo.<br />
I due brani che riguardano la chiamata (vv. 4-10 + 17-19) sottolineano la fragilità umana del<br />
profeta portatore di questa parola del Signore, annunciano l'opposizione che incontrerà nel suo<br />
ministero (e implicitamente anche la sofferenza che sperimenterà), e promettono l'aiuto divino.<br />
Questi temi di Ger 1,4-19 si rivelano come programmatici per tutto il libro.<br />
Il tema dell'invasione dal nord (cioè dalla direzione della Mesopotamia) verrà trattato con<br />
insistenza nei capp. 4-6 (senza identificare l'invasore) e poi nei capp. 37-45 e 52 (quando ormai è<br />
chiaro che si tratta dei Babilonesi).<br />
La denuncia dei peccati del popolo, soprattutto il culto di altre divinità, è tema dominante già nei<br />
capp. 2-3 e poi in molti brani in tutto il libro.<br />
Il "dramma della parola", come viene espresso nei versetti della chiamata, riapparirà in parecchi<br />
testi dove si parla delle sofferenza del profeta, soprattutto nelle cosiddette "Confessioni di<br />
<strong>Geremia</strong>", e nei brani che presentano il conflitto fra profeti ("profeta contro profeta").<br />
Nel v. 10b troviamo sei verbi che descrivono metaforicamente lo scopo del ministero di<br />
<strong>Geremia</strong>: quattro di essi sono distruttivi (negativi) e due sono costruttivi (positivi). La proporzione<br />
rispecchia ciò che troveremo nel resto del libro, dove i brani di tonalità negativa sono ben più<br />
numerosi dei brani positivi.<br />
Si può dunque senz'altro concludere che Ger 1,4-19 funziona come introduzione programmatica<br />
per tutto il libro.<br />
1.3 Relazione fra Ger 1,4-10 e 2,1-3 e le conseguenze possibili<br />
Ci sono due contatti linguistici interessanti fra il primo brano sulla chiamata di <strong>Geremia</strong> (1,4-10)<br />
e i primi versetti del cap. 2 che parlono della relazione fra YHWH e il suo popolo Israele.<br />
(1) La radice רענ (na‘ar: "giovane, gioventù", ecc.): viene usata a 1,6-7 per parlare della<br />
giovinezza di <strong>Geremia</strong> (come scusa per non accettare la sua vocazione), e poi ritroviamo la radice a<br />
proposito di Israele a 2,2 ("l'affetto della tua giovinezza").<br />
(2) La radice שׁדק (qādaš: "essere santo, consacrato", ecc.), che viene detto di <strong>Geremia</strong> nel 1,5b<br />
("ti ho consacrato"), ritorna a proposito del popolo Israele a 2,3 ("... cosa sacra a YHWH").<br />
Ci si può domandare se questi fatti linguistici non costituiscano un suggerimento testuale a chi<br />
legge, un invito a vedere <strong>Geremia</strong> in qualche modo come rappresentante o emblema del suo popolo,<br />
come uno che incorpora (in certa misura) la sorte del popolo. Il "<strong>Geremia</strong> del testo", in altre parole,<br />
potrebbe avere una dimensione paradigmatica, come "prototipo della comunità postesilica dei fedeli<br />
del Signore" (J. Vermeylen) o come "metafora" per la comunità (R. P. Carroll).
18<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
In ogni caso, appare evidente la volontà di tenere unita la lettura del capitolo 1 e del cap. 2.<br />
Anche per questa ragione, crediamo sia utile e significativo procedere nella nostra esegesi, proprio<br />
con il cap. 2.<br />
GER 2,1-19: IL RIB CONTRO ISRAELE<br />
Per questa parte i principali riferimenti sono:<br />
- BOVATI, P., <strong>Geremia</strong> 1-6. Dispense ad uso degli studenti (Roma 2006).<br />
- BOVATI, P., I Rîb Profetici. Dispense PIB (Roma 2012).<br />
1. Inquadramento<br />
II complesso letterario (che chiamiamo sezione) che va dal cap. 2 al cap. 6 deve essere diviso in due<br />
blocchi (che chiamiamo sotto-sezioni): 2,1 – 4,4 e 4,5 – 6,30. I motivi per una suddivisione possono essere<br />
di natura contenutistica e di natura formale; in questa parte del lavoro ci rifaremo prevalentemente ai<br />
primi.<br />
La nostra «tesi» è che nei capitoli 2-6 abbiamo due gruppi di discorsi, rivolti ciascuno ad un<br />
particolare destinatario, prima l'Israele del Nord (per 2,1-4,4) e successivamente il regno di Giuda (per<br />
4,5-6,30): questi destinatari rappresentano due tipi fondamentali di uditore della parola profetica, e per<br />
questa ragione, esigono due diverse modalità di annuncio della parola del Signore (p. 143).<br />
La questione dei destinatari «originali» è effettivamente piuttosto complessa… per noi è<br />
importante riconoscere che nel testo ci sono tensioni, per cui appare che Israele e Gerusalemme<br />
vengono in qualche modo sovrapposti… ma anche che si hanno toni di annuncio differenti nelle<br />
diverse parti.<br />
1.1 La situazione storica supposta dagli oracoli e il loro intento<br />
Secondo il testo di 2,1-4,4 il destinatario (cioè Israele) si trova in miserevoli condizioni.<br />
Infatti in 2,14-15 si afferma che il popolo è «schiavo», «divenuto preda» dei nemici, con «città<br />
distrutte senza abitanti»; in 2,19 i1 profeta invita il suo uditorio a «riconoscere» quanto sia doloroso<br />
l’aver abbandonato il Signore (quindi sono già avvenute le conseguenze negative del tradimento); in<br />
2,27 si parla del «tempo della sventura» come di una realtà presente; e in 3,24 della perdita di tutti i beni,<br />
divorati dalla «Vergogna». È evidente che ciò non può riferirsi a Gerusalemme prima del 587.<br />
In questa stessa sotto-sezione il profeta non usa un tono minaccioso, che consisterebbe nel predire<br />
una terribile disgrazia qualora non venissero prese adeguate contromisure; egli cerca piuttosto di<br />
convincere il suo destinatario a riconoscere la propria colpa (cfr. specialmente 2,19.23.35; 3,2.13)<br />
quale causa del perdurante male che lo fa soffrire. L'intento profetico non si limita alla denuncia del<br />
peccato, ma, per mezzo di essa, mira alla riconciliazione con Dio nella verità e giustizia (4,1-2).<br />
Finché Israele nega la sua colpevolezza dicendo: «non ho peccato», l'accusa e la collera permangono<br />
(2,35); ma quando Israele confessa di «aver peccato» (3,25) allora i1 Signore promette il perdono (3,22)<br />
e la benedizione (4,2). Nonostante l'insistenza sugli aspetti accusatori, questa parte è orientata quindi<br />
verso un esito positivo, verso la conversione e il rifiorire della vita.
19<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
La situazione invece supposta da 4,5-6,30 è totalmente diversa, come appare già dai primi versetti<br />
(4,5-6): Gerusalemme è una citta indipendente, in condizioni politiche normali (anche se non prospere),<br />
e ad essa viene minacciata come imminente una «grande sventura» (4,6; 6,1)21. Il profeta<br />
stabilisce un collegamento tra la disgrazia annunciata e il peccato di Gerusalemme (cft. 4,14; 5,1-6); ma<br />
questo motivo, invece di svilupparsi come invito alla conversione, tende piuttosto a sottolineare la<br />
fatalità e inderogabilità della sventura (cf. in particolare 4,30-31; e 6,26: «figlia del mio popolo,<br />
vestiti di sacco [ ... ] perché all'improvviso verrà il distruttore contro di noi»).<br />
Il tono negativo di questa sotto-sezione culmina in 6,27-30, brano conclusivo che, dichiara che Dio<br />
«ha rigettato» il suo popolo, perché le parole profetiche non hanno potuto «purificarlo».<br />
All’interno della sotto-sezione 2,1 – 4,4 troviamo due sequenze: 2,1-37 e 3,1 – 4,4.<br />
Da un punto di vista retorico la sequenza costituita da Ger 2,1-37 è formata da due sottosequenze.<br />
La prima è costituita dai vv. 1-19 ed è chiaramente delimitata alla fine dalla solenne conclusione:<br />
«oracolo del Signore degli eserciti».<br />
Contenuto: i misfatti commessi da Israele.<br />
La seconda sotto-sequenza è costituita dai vv. 20-37.<br />
Contenuto: l’accusa di Yhwh contro il «dire» di Israele, le sue parole.<br />
Si ha un’inclusione tematica tra il rifiuto di servire (v. 20) e la condanna alla schiavitù (v. 37).<br />
Cominciamo dalla prima sotto-sequenza.<br />
IL PASSATO vv. 1-8<br />
vv. 1-3 il deserto<br />
1 `rmoale yl;ae hw"hy>-rb;d> yhiy>w: Mi fu rivolta questa parola del Signore<br />
2 rmoale ~ØIl;v'Wry> ynEz>a'b. t'ar"q"w> %l{h' Va’ e grida agli orecchi di Gerusalemme dicendo:<br />
%l' yTir>k:z" hw"hy> rm;a' hKo Così dice il Signore: Mi ricordo di te,<br />
%yIr:W[n> ds,x, dell’affetto della tua giovinezza<br />
%y<strong>It</strong>"l{WlK. tb;h]a; dell’amore del tempo del fidanzamento,<br />
rB'd>MiB; yr:x]a; %Tek.l, quando mi seguivi nel deserto,<br />
`h['Wrz> al{ #r
20<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
rB'd>MiB; Wnt'ao %yliAMh; e ci guidò nel deserto,<br />
hx'Wvw> hb'r"[] #rPi lkoa/l,<br />
ycir>a;-ta, WaM.j;T.w: WaboT'w:<br />
`~v' ~d"a' bv;y"-al{w> e dove nessuno dimora?<br />
hb'[eAtl. ~T,m.f; ytil'x]n:w><br />
8 Wrm.a' al{ ~ynIh]Koh;<br />
hw"hy> hYEa;<br />
ynIW[d"y> al{ hr"ATh; yfep.tow><br />
ybi W[v.P' ~y[iroh'w><br />
l[;B;b; WaB.nI ~yaiybiN>h;w><br />
Wl[iAy-al{ yrEx]a;w> Wkl'h'<br />
IL PRESENTE vv. 9-19<br />
vv. 9-13 stoltezza dell’idolatria<br />
9 ~k,T.ai byrIa' d[o !kel'<br />
byrIa' ~k,ynEb. ynEB.-ta,w> hw"hy>-~aun><br />
10 War>W ~yYITiki yYEai Wrb.[i yKi<br />
daom. Wnn>ABt.hiw> Wxl.vi rd"qew><br />
tazOK' ht'y>h' !he War>W<br />
11 ~yhil{a/ yAG rymiyheh;<br />
~yhil{a/ al{ hM'hew<br />
AdAbK. rymihe yMi[;w> ><br />
ly[iAy aAlB.<br />
12 daom. Wbr>x' Wr[]f;w> tazO-l[; ~yIm:v' WMvo<br />
`hw"hy>-~aun><br />
13 yMi[; hf'[' tA[r" ~yIT;v.-yKi<br />
~yYIx; ~yIm; rAqm. Wbz>[' ytiao<br />
tAraBo ~h,l' bcox.l;<br />
~yIM'h; Wlkiy"-al{ rv,a] ~yrIB'v.nI troaBo<br />
vv. 14-19 conseguenze dell’idolatria<br />
14 aWh tyIB; dyliy>-~ai laer"f.yI db,[,h;<br />
zb;l' hy"h' [:WDm;<br />
15 ~yrIpik. Wga]v.yI wyl'['<br />
~l'Aq Wnt.n"<br />
hM'v;l. Acr>a; WtyviY"w:<br />
bveyO yliB.mi ÎWtC.nIÐ ¿ht'C.nIÀ wyr"['<br />
Io vi ho condotti in una terra da giardino,<br />
perché ne mangiaste i frutti e i prodotti.<br />
Ma voi, appena entrati, avete contaminato la mia terra<br />
e avete reso il mio possesso un abominio<br />
Neppure i sacerdoti si domandarono:<br />
"Dov'è il Signore?".<br />
Gli esperti nella legge non mi hanno conosciuto,<br />
i pastori si sono ribellati contro di me,<br />
i profeti hanno profetato in nome di Baal<br />
e hanno seguito idoli che non aiutano.<br />
Per questo intenterò ancora un processo contro di voi -<br />
oracolo del Signore - e farò causa ai figli dei vostri figli.<br />
Recatevi nelle isole dei Chittìm e osservate,<br />
mandate gente a Kedar e considerate bene,<br />
vedete se è mai accaduta una cosa simile.<br />
Un popolo ha cambiato i suoi dèi?<br />
Eppure quelli non sono dèi!<br />
Ma il mio popolo ha cambiato me, sua gloria,<br />
con un idolo inutile.<br />
O cieli, siatene esterrefatti, inorriditi e spaventati.<br />
Oracolo del Signore.<br />
Due sono le colpe che ha commesso il mio popolo:<br />
ha abbandonato me, sorgente di acqua viva,<br />
e si è scavato cisterne,<br />
cisterne piene di crepe, che non trattengono l'acqua.<br />
Israele è forse uno schiavo, o è nato servo in casa?<br />
Perché è diventato una preda?<br />
Contro di lui ruggiscono leoni<br />
con ruggiti minacciosi.<br />
Hanno ridotto la sua terra a deserto,<br />
le sue città sono state bruciate e nessuno vi abita.<br />
16 dqod>q' %W[r>yI sxen>P;x.t;w> @nO-ynEB.-~G: Persino le genti di Menfi e di Tafni ti hanno umiliata<br />
17 %L'-hf,[]T; tazO-aAlh]<br />
%yIh;l{a/ hw"hy>-ta, %bez>['<br />
%r
21<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
19 %te['r" %rES.y:T.<br />
%xukiAT %y<strong>It</strong>;Abvum.W<br />
rm'w" [r:-yKi yair>W y[id>W<br />
%yIh'l{a/ hw"hy>-ta, %bez>['<br />
%yIl;ae ytiD"x.p; al{w><br />
tAab'c. hwIhy> yn"doa]-~aun><br />
rh'n" yme tATv.li a bere l'acqua dell'Eufrate?<br />
La tua stessa malvagità ti castiga<br />
e le tue ribellioni ti puniscono.<br />
Renditi conto e prova quanto è triste e amaro<br />
abbandonare il Signore, tuo Dio,<br />
e non avere più timore di me.<br />
Oracolo del Signore degli eserciti.<br />
1.2 Destinatario dell’oracolo (l’insieme 2,1 – 4,4)<br />
Abbiamo già detto che la questione del destinatario degli oracoli non è semplice.<br />
Se guardiamo il testo con un po’ più di attenzione ci accorgiamo che alcuni segnali ci indicano la<br />
presenza di lavoro redazionale e, quindi, di una stratificazione letteraria. Il testo finale che è nelle<br />
nostre mani è stato prodotto, infatti, in un periodo piuttosto lungo.<br />
Quali segnali? Il fatto più evidente è che diverse volte l’uditorio è chiamato «Israele» (cf.<br />
2,3.4.14.26.31) anche se, all’inizio, ci si rivolge a Gerusalemme 1 .<br />
Si deve dunque ritenere che il testo, attualmente rivolto a Gerusalemme, doveva avere in origine<br />
un differente destinatario, ovvero il Regno del Nord, Israele, regno scomparso nel 721 ad opera<br />
dell’Assiria.<br />
Riteniamo che questi capitoli siano stati rivolti originariamente alle tribù del Nord, designate con il<br />
nome «Israele», e siano stati poi, in una successiva redazione, applicati a Gerusalemme, quando il Regno<br />
di Giuda, con l’esilio, si era venuto a trovare in situazione identica a quella del Regno di Samaria.<br />
Questa operazione è molto significativa: si dice a qualcuno, con le stesse parole utilizzate per un<br />
altro, che andrà incontro al medesimo destino se non ci sarà nessun ravvedimento!<br />
All’interno della BH la funzione di Israele (= Regno del Nord) è, in questo senso, molto<br />
importante: Israele è sempre l’antecedente, la sorella maggiore che sta lì come «avviso» perché<br />
Giuda possa scegliere un differente destino! (il motivo del confronto tra i due regni sarà peraltro<br />
importantissimo al cap. 3).<br />
1.3 Il tema<br />
Lo abbiamo già indicato brevemente: questi versetti trattano dei misfatti di Israele, cioè mettono<br />
in luce il peccato nelle sue componenti di pertinacia e di stupidità. Come vedremo, una degli<br />
elementi tipici del peccato è infatti la sua irragionevolezza: si tratta di qualcosa di stupido, di folle,<br />
privo di ragioni oggettive. Nello stesso tempo, si tratta di qualcosa da cui Israele non vuole<br />
staccarsi, non molla…<br />
2. Il genere letterario<br />
Il rîb cioè la lite bilaterale.<br />
Di che si tratta?<br />
Un genere letterario di tipo giuridico, equivalente ad un discorso accusatorio. Tale discorso si<br />
colloca in un contesto, per lo più, di tipo familiare. Ci sono, cioè, due persone in lite: un marito e<br />
una moglie, un padre e un figlio, due fratelli...<br />
1 Un altro elemento che segnala lavoro redazionale è la presenza di suffissi pronominali sia al maschile<br />
che al femminile. Inoltre sembrano esserci qui influssi provenienti da Es e Dt.
22<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Evidentemente il tipo di relazione familiare stabilisce il tipo di vincolo che esiste tra queste due<br />
persone e gli obblighi che essa presuppone > è evidente che il vincolo matrimoniale viene tradito in<br />
certe condizioni, mentre quello tra un padre e un figlio in altri modi.<br />
La persona che ritiene di essere stata lesa nei suoi diritti, inizia la sua accusa verso l’altra<br />
imputandole dei crimini.<br />
La lite ha, dunque, una struttura bilaterale: l’offeso accusa l’offensore (senza che vi siano di<br />
mezzo figure di tipo giudiziario > non siamo in tribunale e non c’è il giudice).<br />
Qual è lo scopo della lite?<br />
Ritornare alla pace, riconciliarsi, fare in modo che la relazione possa nuovamente essere definita<br />
giusta.<br />
Ger 2,1-19 si presenta esattamente in questo modo (e così moltissimi testi profetici! potremmo<br />
dire che il rîb è il genere letterario tipico della profezia): Yhwh accusa Israele/Gerusalemme di una<br />
serie di colpe, di peccati. A quale scopo? Perché il popolo possa prendere coscienza del proprio<br />
male, riconoscerlo in verità e ritornare al Signore: lo scopo di Dio non è mai la distruzione, ma il<br />
ravvedimento (cf. Ez 18,32; 33,11; «non godo della morte di chi muore»).<br />
3. Struttura retorica di Ger 2,1-19<br />
Com’è organizzato il discorso di accusa che Yhwh rivolge a Israele?<br />
In due passi:<br />
1. il passato (vv. 1-8)<br />
2. il presente (vv. 9-19)<br />
1. Il passato: vv. 1-8<br />
Due parti:<br />
vv. 1-3 = il tempo del deserto<br />
vv. 4-8 = l’entrata nella terra<br />
2. Il presente: vv. 9-19<br />
Due parti:<br />
vv. 9-13 = la stoltezza dell’idolatria<br />
vv. 14-19 = le sue conseguenze<br />
4. Analisi esegetica per parti<br />
1. Il passato: vv. 1-8<br />
vv. 1-3 = il tempo del deserto: all’origine l’amore<br />
v. 1 - la P/D rivolta al profeta<br />
v. 2 - l’invio: la missione del profeta come obbedienza alla parola ricevuta<br />
Si tratta di un annuncio pubblico: far sapere, gridare alle orecchie....<br />
Che cosa?
23<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Il ricordo dell’incontro d’amore tra Dio e il suo popolo! Israele deve sapere che Dio ricorda! Lui<br />
non ha dimenticato!<br />
Si ricorda di Israele innanzitutto > io mi ricordo di te!<br />
Ma cosa significa che Dio ricorda?<br />
In Dio, Origine assoluta di ogni cosa, il dire «mi ricordo» costituisce un evento creativo. Non esprime<br />
solo la rievocazione del passato, ma apre all'atto di presenza, al gesto di amore, all'opera salvifica. Anche<br />
fra gli umani, se qualcuno dice ad una persona: «mi sono ricordato di te», ciò significa spesso che egli ha<br />
agito in favore dell'altro, a ragione di un legame antecedente. Ora, per Dio, ogni atto di memoria, non<br />
può che essere dono; pur attestando qualcosa di passato, anzi di originario, il ricordo divino è<br />
totalmente orientato al presente, e quindi al futuro.<br />
Questo appare chiaramente nei testi fondatori, come in Es 2,23-25: «Gli Israeliti gemettero per la<br />
loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il<br />
loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio vide la condizione degli Israeliti<br />
e se ne prese cura». La stessa cosa viene ripetuta in Es 6,5-8, in un passo particolarmente significativo,<br />
perché Dio, rivolgendosi a Mose, parla alla prima persona: «Sono proprio io che ho udito il lamento<br />
degli Israeliti asserviti dagli Egiziani e mi sono ricordato della mia alleanza. Pertanto di' agli Israeliti: "Io sono<br />
il Signore! Vi sottrarrò ai lavori forzati degli Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con<br />
braccio teso e con grandi castighi. Vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Saprete che<br />
io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai lavori forzati degli Egiziani. Vi farò entrare nella terra<br />
che ho giurato a mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe; ve la darò in possesso: io sono<br />
il Signore!"".<br />
In questa stessa linea, quella del ricordo di Dio che costituisce il principio e la ragione del suo<br />
intervento salvifico, cfr. anche Gen 19,29; 30,22; Lv 26,42.45; 1 Sam 1,19-20; Ger 14,21; 15,15; Sal 8,5;<br />
106,4; 115,12; ecc.<br />
In Ger 2,2-3 il profeta rievoca questa parola originaria, che, in quanto tale non è solo capace di<br />
spiegare il «principiare» di Israele, ma è esplicativa di tutta la sua storia; il ricordare di Dio è infatti<br />
essenzialmente fedeltà di Dio alla sua alleanza, alleanza che - nei disparati eventi - rivelerà sempre l'amore<br />
di YHWH per il suo popolo.<br />
Mi ricordo di te... mi ricordo per te... in tuo favore!<br />
«Ricordo, in tuo favore, l’affetto della tua giovinezza, l’amore del tempo del tuo fidanzamento».<br />
Abbiamo qui i due sostantivi ds,x, (ḥesed) e hb'h]a; (’ahăḇāh) che appartengono alla terminologia<br />
dell’alleanza.<br />
Come comprendere questo versetto?<br />
Dio ricorda che, all’origine, Israele era fedele, innamorato?<br />
Ma, se è così, la storia tra Israele e Yhwh si fonda allora sui meriti dell’uomo? L’azione divina di<br />
salvezza dipende dall’amore umano?<br />
Alcuni commentatori ritengono che qui si parli piuttosto dell’amore di Dio verso Israele (gen.<br />
oggettivo).<br />
Le due espressioni [%yIr;W[n>] ds,x, e [%y<strong>It</strong>'l{WlK.] tb;h]a; appartengono alla terminologia dell’alleanza (cfr., ad<br />
esempio, Dt 5,10; Ger 31,3) evocata attraverso il linguaggio metaforico della relazione sponsale (cfr.<br />
Ger 2,32; 3,8.20; Ez 16 e 23; Os 2,21; 3,1; ecc.); si possono tradurre come «la tua fedeltà giovanile» e «il<br />
tuo amore di sposa»; e in questa linea, attribuendo cioè fedeltà e amore a Israele (cioè come un genitivo<br />
soggettivo), vanno le antiche versioni (LXX, Targum) e alcuni recenti commentatori, a motivo del<br />
supposto parallelismo con lo stico seguente (rB'd>MiB; yr:x]a; %Tek.l, «quando mi seguivi nel deserto»).<br />
Rosenmüller invece ritiene che il testo parli dell’amore di Dio verso Israele (genitivo oggettivo), quando
24<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
essa – come giovane sposa di YHWH – era guidata e protetta (cfr. v. 3b): ciò è confermato – egli dice –<br />
da testi paralleli, come Os 11,1 ed Ez 16,22; e tale motivo teologico si accorda con la tradizione che<br />
evoca, per il periodo del deserto, la pazienza benevola del Signore malgrado la ribellione del popolo.<br />
L’interpretazione di Rosenmüller, nonostante appaia a prima vista meno evidente, ci sembra più<br />
conforme alla tradizione biblica e risponde meglio d’altronde alla logica dell’accusa divina, così come è<br />
attestata nei testi profetici: infatti i rîb iniziano generalmente con l’elogio di chi parla (Dio accusatore), o<br />
con l’enumerazione delle sue azioni benefiche, o con la dichiarazione generale che Egli è giusto,<br />
essendosi comportato bene e con generosità nel passato.<br />
Ma certamente anche la risposta dell’uomo è fondamentale: Israele, al principio, si mostra<br />
fedele, segue il suo Dio nel deserto.<br />
Poiché l’espressione yrex]a; %lh («andare dietro») è altrove per lo più usata per parlare della idolatria<br />
(avendo naturalmente come complemento «gli dèi», invece di YHWH), viene accentuata nel nostro<br />
versetto la straordinaria particolarità del «momento» delle origini, momento nel quale il popolo di<br />
Israele ha vissuto in un giusto rapporto con il suo Dio. Non sarebbe possibile l’alleanza senza il<br />
consenso esplicito di Israele (cfr. Es 24,3.7; Dt 26,16-19; e anche Gs 24,15-18); e questo è tipico della<br />
metafora sponsale, che suppone una reciprocità di relazioni, a differenza della metafora paterna che<br />
evoca in maniera esclusiva la volontà creatrice del genitore).<br />
Dove si colloca questa fedeltà delle origini? Nel deserto<br />
Il «deserto» è qualificato dall’espressione parallela h['Wrz> al{ #r,a, («terra non seminata», cioè terra «nella<br />
quale non si può seminare»). Si tratta evidentemente di una connotazione negativa, analoga alla lunga<br />
descrizione del v. 6: il deserto è un luogo che non può dare nessun frutto, che non consente alla vita di<br />
alimentarsi. Appare così un netto contrasto tra la situazione «idilliaca» del rapporto tra YHWH e Israele<br />
(relazione vitale), e il contesto materiale in cui tale vicenda si svolse (in un luogo di morte). Questo<br />
elemento esplicita indirettamente la forza creatrice e salvifica del Signore.<br />
v. 3 Israele era cosa sacra, primizia... e quindi riservato esclusivamente al Signore (nessun altro<br />
ne poteva mangiare)<br />
Considerazioni d’insieme su questa parte (vv. 2-3): la sua funzione nel contesto.<br />
La relazione di alleanza tra YHWH e Israele è presentata ai vv. 2-3 mediante due metafore:<br />
- la prima, di natura antropologica, è quella del rapporto sponsale (v. 2);<br />
- la seconda, desunta dal mondo agricolo e cultuale, è quella della primizia (v. 3).<br />
Le due immagini convergono nel significare la medesima realtà: come detto in precedenza, entrambe<br />
qualificano infatti una relazione di tipo esclusivo (sancita dal comando principale, quello di non avere altri<br />
dèi), ed evocano quindi una dimensione essenziale del rapporto di alleanza tra Israele e YHWH. D’altra<br />
parte, le due metafore sono fra loro complementari: la prima sottolinea il dono di Dio e l’adesione<br />
personale di Israele al suo Signore («fedeltà», «amore», «seguire»); la seconda invece illustra piuttosto le<br />
conseguenze che scaturiscono da una tale relazione esclusiva («cosa santa», «primizia»), conseguenze<br />
favorevoli a Israele proprio perché negative nei confronti degli eventuali aggressori («la sventura viene<br />
su di loro»).<br />
Il vincolo di alleanza (vv. 2-3) è ciò che fonda la possibilità stessa del rîb (vv. 4ss); poiché il litigio<br />
è introdotto dal ricordo della «amorosa fedeltà» delle origini, si può sperare che esso non si dispieghi<br />
secondo una logica e con una finalità diverse, ma sia anzi la rivelazione amorosa di colui che vuole<br />
riconquistarsi la donna della giovinezza.<br />
Ciò che conta per noi è chiarire cosa significhi, nella dinamica del rîb, l’evocare questa fase iniziale<br />
(che ha valore fondante).
25<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Perché si comincia dai benefici?<br />
(a) espressione del rîb di difesa.<br />
I primi due versetti del discorso del Signore (vv. 2-3) riassumono quanto il Signore ha da dire a<br />
propria discolpa. Nelle liti di YHWH contro Israele ritorna spesso questo motivo giuridico: per chiarire<br />
il contenzioso, Dio rievoca tutta la storia, fin dal principio, e risale perciò al momento fondatore, nel<br />
quale il suo amore creatore ha prodotto l’alleanza. Questo aspetto è ripreso all’inizio dell’unità seguente,<br />
al v. 5a, sotto forma di domanda: «che cosa di male hanno trovato in me i vostri padri?»; poiché la<br />
condotta del Signore è in tutto «impeccabile», viene così escluso che Israele possa in alcun modo<br />
giustificarsi, accusando il suo Dio (cfr. 2,29) di indifferenza o di tradimento.<br />
(b) fondamento del rîb di accusa<br />
È evidente che questi due versetti iniziali hanno anche la funzione di fondare il discorso di accusa,<br />
nel quale si realizza il rîb stesso. Ci sono, al proposito, due aspetti che meritano di essere notati.<br />
In primo luogo, l’aver presentato il tempo «perfetto» del deserto, quando la giovane sposa andava<br />
dietro al Signore (v. 2), fa risaltare il contrasto con la storia che inizia con l’entrata nella «terra del<br />
Carmelo» (v. 7), quando Israele si è messo a seguire Baal (v. 8). Il cambiamento avvenuto è inspiegabile,<br />
non ha alcuna ragionevole motivazione (v. 5), dato che Dio si è sempre comportato ottimamente in<br />
precedenza. L’origine del peccato è così presentata come un fatto enigmatico, oggetto di stupore (v. 12);<br />
e, nello stesso tempo, qualificato come un atto stupido (vv. 11.13), come una vera pazzia (v. 5).<br />
Ma si deve notare anche il secondo aspetto, quello della responsabilità del popolo nella decisione presa<br />
di allontanarsi dal Signore (v. 5), di abbandonarlo (vv. 13.17.19). Israele non è malvagio di natura, dato<br />
che un tempo ha seguito Dio; ecco allora evidenziato il «male» (h['r') che egli ha commesso (v. 13) e che<br />
deve riconoscere (v. 19). Proprio per questo YHWH dispiega l’accusa (rîb) che si sviluppa anche oltre il<br />
v. 19, poiché l’accusatore, dopo aver elencato i fatti (vv. 5-13), deve smentire i ragionamenti (le parole)<br />
che l’accusato tenta di addurre a propria giustificazione (vv. 20-35).<br />
vv. 4-8 = l’entrata nella terra, cioè la storia di peccato<br />
All’inizio (v. 5) il locutore pone una domanda, che, in generale, intende esprimere come il<br />
manifestarsi della trasgressione sia un enigma, sia cioè un fatto inspiegabile, anzi persino assurdo: non si<br />
capisce perché chi «seguiva» Dio riportandone vantaggi immediati (2,2-3), abbia poi deciso di<br />
«allontanarsi» dal Signore (2,5).<br />
La forma interrogativa (rispetto a quella assertiva) invita l’uditore a «rispondere» in verità, condizione<br />
questa indispensabile per un accordo finale fra i due litiganti.<br />
I colpevoli sono, da una parte, «i padri» (v. 5: inizio dell’unità), dall’altra, le autorità istituzionali<br />
di Israele «sacerdoti», «pastori» e «profeti» (v. 8: fine dell’unità letteraria). Agli uni e agli altri si rivolgono<br />
accuse pressoché identiche:<br />
v. 5: i padri «andarono dietro alla vanità»<br />
«non dissero: dov’è YHWH»<br />
v. 8: i sacerdoti<br />
«non dissero: dov’è YHWH»<br />
i profeti «andarono dietro all’inutile»<br />
Al v. 7: voi.<br />
In questo modo tutto il popolo è coinvolto nell’accusa.
26<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Il crimine commesso da Israele è presentato con una certa varietà di espressioni («allontanarsi dal<br />
Signore», «andar dietro alla vanità», «non riconoscere», «abbandonare», ecc.), tutte allusive del peccato di<br />
idolatria consistente nell’aderire alla religione di Baal (nominato esplicitamente al v. 8).<br />
Accusa globale sembra essere caratteristica dei rîb profetici (specie di quelli programmatici); si<br />
esprime in questo modo il venir meno della relazione nella quale consiste l’alleanza (si tratta della<br />
trasgressione non ad un comandamento, ma alla dichiarazione di base, o, in altri termini, al primo<br />
comandamento).<br />
L’idolatria ha la sua causa nella perdita della memoria (cfr. l’esplicitazione in 2,32 e 3,21). Infatti nei<br />
brani finali delle due sottoparti (v. 6 e v. 8), il medesimo peccato è visto come mancato ricorso al<br />
Signore (mancanza di fede orante), e quindi dimenticanza di ciò che Dio ha operato, che coincide con<br />
l’oblio della propria identità. Il «non dire: dov’è YHWH» significa dimenticare da dove si viene<br />
(l’Egitto), cosa si è attraversato (il deserto), e Chi ha reso possibile il passaggio dalla non-vita (v. 6b) al<br />
godimento del «bene» (v. 7a); dimenticare le proprie origini è perdersi.<br />
Compito della denuncia profetica non è tuttavia solo di dichiarare qual è il reato imputato, ma di<br />
farne apparire l’intrinseco «male», così che l’uditore possa provarne vergogna e sconfessarlo. Qui si<br />
rivela anzi con chiarezza la finalità dell’accusa, che è di convincere l’avversario della stoltezza del suo<br />
comportamento. La critica profetica del peccato si colora quindi di una tonalità sapienziale sferzante,<br />
quando rivela con ironia la stoltezza dell’abbandonare il Signore per inseguire l’insignificante (lb,h,h;) e<br />
l’inutile (Wl[iAy-al{).<br />
Ironico e amaro è pure il constatare come siano state intrinsecamente svuotate, anzi stravolte le<br />
istituzioni autorevoli in Israele: i sacerdoti, cioè gli incaricati del culto al Signore, hanno cessato di<br />
invocarlo, e, in quanto esperti della Tôrah (cioè dell’istruzione religiosa), «non conoscono» l’autore e<br />
l’oggetto del loro stesso insegnamento; i pastori, ai quali si deve obbedienza perché incarnano l’autorità<br />
divina, sono essi i ribelli contro YHWH; e infine i profeti, che si presentano come portavoce del<br />
Signore, profetizzano di fatto nel nome di Baal, e così rendono inutile il loro stesso parlare.<br />
2. Il presente: vv. 9-19<br />
Il secondo passo (vv. 9-19) parla del presente che si apre al futuro («accuso voi e accuso i figli dei vostri<br />
figli»: v. 9). Caratteristica di questo momento è la sua omogeneità negativa:<br />
- c’è il «male» del peccato (tA[r' al v. 13 e %te['r' al v. 19), consistente nel «cambiare il proprio Dio» (v.<br />
11) e nell’«abbandonare il Signore» (vv. 13.17.19);<br />
- e c’è il «male» della sofferenza (rm'w" [r; del v. 19), descritto come uno stato permanente di schiavitù e<br />
di violenza subita (vv. 14-16), che contrasta totalmente con la condizione primigenia di incolumità (v.<br />
3).<br />
vv. 9-13 = la stoltezza dell’idolatria<br />
Questa parte (vv. 9-13) presenta la denuncia del crimine «attuale» di Israele, un crimine continuato,<br />
che dà ragione del perdurare dell’accusa («ancora vi accuso»: v. 9). Tale denuncia è ripetuta due volte,<br />
nei due brani in cui è articolata questa parte:<br />
(1) vv. 10-11: coinvolgimento delle nazioni come «testimoni» (cinque imperativi); accusa di aver<br />
«scambiato» Dio con una cosa inutile;<br />
(2) vv. 12-13: coinvolgimento del cielo come «testimone» (tre imperativi, seguiti da «oracolo del<br />
Signore»); accusa di aver abbandonato la sorgente per delle cisterne screpolate<br />
- Dio continua ad accusare... per la nostra salvezza (v. 9). Non viene meno al suo compito, non<br />
rinuncia al suo popolo
27<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
- il confronto odioso > nessuno mai come voi...<br />
Il reato di Israele è uno solo, quello dell’idolatria; esso però viene presentato due volte. La prima<br />
volta, al v. 11, il profeta denuncia il crimine in forma diretta, definendolo un’azione contro Dio e la sua<br />
«gloria»; la seconda volta, al v. 13, il medesimo atto ha un rivestimento metaforico: <strong>Geremia</strong> infatti parla<br />
del fatto di «abbandonare il pozzo» per «scavarsi delle cisterne» (preferire altro al Signore)<br />
Il confronto odioso<br />
Altro artificio sapienziale – usato frequentemente nei rîb profetici – è quello di introdurre un<br />
paragone tra l’uditore e qualche altro «soggetto spregevole», tale da risultare severamente derisorio<br />
dell’atteggiamento dell’accusato; si noti infatti che le nazioni, invece di essere criticate per la loro<br />
idolatria (anche se si afferma che «i loro dèi non sono Dio»), sono dal Signore riconosciute più giuste di<br />
Israele, perché almeno serbano fedeltà al loro dio.<br />
L’azione stolta<br />
In collegamento con l’aspetto precedente, va sottolineato l’intento sapienziale di mostrare che<br />
l’azione commessa è stupida, segno di scarsa intelligenza: ciò sembra avere una grande efficacia<br />
nell’aiutare l’accusato a cambiare atteggiamento, dato che la stoltezza non porta vantaggio alcuno. Che<br />
l’agire di Israele sia assurdo, lo si vede dai risultati: il popolo ha fatto un baratto veramente insensato,<br />
dato che ha scambiato «la sua gloria» (ciò che gli conferisce dignità e gloria) con qualcosa di vano (2,5) e<br />
di inutile (v. 11); in altre parole, usando una metafora, ha trascurato la fonte vivificante (v. 13)<br />
rimpiazzandola con delle cisterne piene di crepe.<br />
vv. 14-19 = le conseguenze dell’idolatria<br />
La quarta parte (vv. 14-19) espone le conseguenze del crimine di Israele, con le decisioni da prendere<br />
nel presente.<br />
Le domande sul male e le sue cause (vv. 14-17)<br />
La prima domanda (v. 14) introduce il motivo della punizione. «Israele è forse uno schiavo o un<br />
servo nato in casa? Come mai è diventato una preda?»; in altre parole: cosa spiega il fatto che Israele sia<br />
vittima degli attacchi nemici? la ragione sta forse nel fatto che è un popolo schiavo di natura,<br />
impossibilitato a redimersi?<br />
I vv. 15-16 descrivono lo stato del paese; a un linguaggio realistico, che parla di una terra devastata e<br />
di città incendiate, si associano alcune espressioni metaforiche (i «leoni» che ruggiscono; il «cranio» che<br />
viene «brucato»). Viene qui ribaltata la descrizione di Israele data al v. 3, dato che i nemici «divorano» il<br />
popolo di YHWH senza che questi intervenga, quasi non ne fosse il Signore. Ne risulta che Israele vive<br />
una situazione come se non fosse Israele: chi è stato liberato dall’Egitto (v. 6) e chi ha ricevuto una terra<br />
in possesso ereditario (v. 7) è ridotto come se non fosse mai esistito quale soggetto libero, dato che è<br />
come un «servo nato in casa», e dato che la sua terra è posseduta come bottino da altri (vv. 14-16).<br />
La seconda domanda, al v. 17, si rivolge direttamente ad Israele: «non ti capita forse questo perché<br />
tu hai abbandonato il Signore tuo Dio?»; formulata in negativo, essa esige un assenso da parte<br />
dell’uditore.<br />
Le domande sugli inutili rimedi e la decisione opportuna (vv. 18.19)<br />
Al v. 18 abbiamo due domande parallele, introdotte dall’avverbio «e ora» (hT'[;w>), che esplicita il<br />
rapporto con il momento presente; esse pongono in questione l’utilità (%L'-hm;) del ricorso alle due grandi<br />
potenze dell’Egitto e dell’Assiria.
28<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Indirettamente il locutore invita a scartare ciò che non serve; ritorna il tema dell’acqua, centrale nella<br />
sottoparte precedente (v. 13: pozzo di acqua viva; cisterne che non trattengono l’acqua), con la menzione<br />
dei due grandi fiumi, il Nilo e l’Eufrate, che sono simbolo di prosperità e forza (cfr. Is 8,6-8). Il ricorso<br />
alla protezione delle nazioni straniere equivale all’atto dell’idolatria (lo scavarsi cisterne), in quanto fa<br />
perdurare il rifiuto di Dio, sostituito con una realtà umana. È rilevabile forse dell’ironia nel far notare<br />
che Israele va a cercare aiuto in Egitto, mentre è la gente di Menfi (Nof) e Tafni a danneggiarlo<br />
mortalmente (v. 16); qualcosa di simile potrebbe essere detto per Assur, se i «leoni» ruggenti che<br />
portano la devastazione delle città (v. 15) sono la cifra di questa nazione violenta.<br />
Il v. 19 indica quale sia il vero atteggiamento da assumere, che consiste fondamentalmente nel<br />
riconoscimento della verità delle parole dell’accusa. Sono i fatti che dovrebbero insegnare,<br />
secondo la consueta tradizione sapienziale; ora, per il popolo di Dio, sono in particolare gli eventi<br />
dolorosi, causati dagli sbagli, a dover diventare «lezione» e monito per il presente e per il futuro. Anche<br />
il tema del timore di Dio è tipicamente sapienziale; ed è proprio la mancanza di questo atteggiamento<br />
ad aver indotto Israele alla stoltezza dell’abbandonare il Signore.<br />
Finalità dell’accusa: «Riconosci (y[id>W) e constata (yair>W) quanto sia brutto e spiacevole (= amaro)<br />
l’abbandonare il Signore tuo Dio». Per l’accusato ciò equivale ad ammettere la propria colpa, ma con la<br />
sottolineatura particolare di dichiararne la stoltezza. Questa ammissione di colpa, richiesta dal Signore, è di<br />
fatto contrastata dal “dire” auto-giustificatorio del popolo in 2,20-37.<br />
Lo scopo del parlare accusatorio è proprio quello di «far capire», cioè di far prendere coscienza<br />
del male e della sua intrinseca stoltezza. Oltre ad usare diversi accorgimenti di sapienza (metafore e<br />
parabole, ironia, riferimento fittizio a personaggi assenti, minacce, ecc.), il locutore esplicitamente invita<br />
l’uditore a fare un atto di intelligenza, usando talvolta la formula «vedi e capisci», «vedi e riconosci»<br />
([dy)» (cfr., con alcune varianti, 1 Sam 24,12; 25,17; Ger 2,19.23; 3,13; ecc.). Questa finalità del «capire»,<br />
che è riconoscimento del male ma anche riconoscimento del Signore nel suo giusto agire, è<br />
esplicitamente espressa con la radice [dy: cfr. ad esempio Ez 16,1.62; Os 2,22; Mi 6,5; Ml 2,4.<br />
Cosa risponde Israele dopo tutte queste accuse?<br />
È quello che ci fanno sapere i vv. 20-37 (la seconda sotto-sequenza).<br />
Tutto qui si concentra sulle parole, sul dire:<br />
v. 20: «hai detto: “Non voglio essere serva”»<br />
v. 23: «come osi dire: “Non mi sono contaminata, non ho seguito i Baal”?»<br />
v. 25: [all’invito di fermarsi... ]«Ma tu rispondi: “No, è inutile, perché io amo gli stranieri, voglio<br />
andare con loro»<br />
v. 27: «Dicono a un pezzo di legno: “Tu sei mio padre”»<br />
v. 31: «Perché il mio popolo dice: “Siamo liberi, non verremo più da te”?»<br />
v. 35: «Tu protesti: “Io sono innocente”... hai detto: “Non ho peccato”»<br />
vv. 20-25: le giustificazioni per l’idolatria<br />
vv. 26-30: le parole di un’inadeguata preghiera<br />
vv. 31-37: il rifiuto di convertirsi<br />
Dopo l’accusa... il versante positivo del rîb, cioè l’invito al ritorno!<br />
Ger 3,1 – 4,4 > il Signore manifesta così quale fosse la sua intenzione nel denunciare il male<br />
commesso dal suo popolo.<br />
Struttura:
29<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
1. metafora sponsale: vv. 1-13<br />
vv. 1-5 = il caso giuridico > la donna ripudiata: il ritorno è impossibile! Cf. Dt 24,1-4<br />
vv. 6-13 = il confronto tra Giuda e Israele e la possibilità del ritorno<br />
2. metafora paterna: 3,14 - 4,4<br />
vv. 14-18 = promessa del ritorno (in prosa) >Dio garantisce che farà tornare<br />
vv. 3,19 - 4,4 = la confessione della colpa > il ritorno penitente<br />
GER 4,5 -31: IL RIB CONTRO GIUDA<br />
[ne scorriamo solo una piccola parte… continua fino al cap. 6… a voi la lettura]<br />
v. 5 l’annuncio<br />
v. 6 cercare un rifugio<br />
1. cercare un rifugio > Dio che non vuole la distruzione del suo popolo<br />
2. ma è Lui stesso che dichiara: «perché io faccio venire dal settentrione una sventura e una<br />
grande rovina» (`lAdG" rb,v,w> !ApC'mi aybime ykinOa' h['r" yKi).<br />
v. 7 l’immagine del leone<br />
v. 10 l’inganno…<br />
Pace non c’è > rapporto di questo testo con altri… I falsi profeti<br />
v. 12 per mio ordine<br />
v. 14 purificarsi<br />
v. 18 la tua responsabilità<br />
v. 22 la stoltezza (motivi sapienziali all’interno del convincimento)<br />
[r:h'l. hM'he ~ymik'x] hM'he ~ynIAbn> al{w> hM'he ~ylik's. ~ynIB' W[d"y" al{ ytiAa yMi[; lywIa/ yKi<br />
W[d"y" al{ byjiyhel.W<br />
"Stolto è il mio popolo: non mi conosce, sono figli insipienti, senza intelligenza; sono esperti nel<br />
fare il male, ma non sanno compiere il bene".<br />
vv. 23-26 la de-creazione > il peccato che distrugge la creazione<br />
vv. 30-31 «E tu devastata che farai?...» > gli amanti che uccidono Gerusalemme!<br />
WvQEb;y> %vep.n: ~ybig>[o %b'-Wsa]m'<br />
ti disprezzano i tuoi amanti, vogliono la tua vita!
30<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
LE "CONFESSIONI DI GEREMIA"<br />
GER 11,18–12,6; 15,10-21; 17,14-18; 18,18-23; 20,7-18<br />
Per questa parte abbiamo utilizzato, in particolare:<br />
- dispense p. Conroy<br />
- BARBIERO, G., Le Confessioni di <strong>Geremia</strong>. Storia di una vocazione profetica (La Parola e la sua<br />
ricchezza 15; Milano 2012).<br />
I testi elencati sopra presentano il profeta <strong>Geremia</strong> che si lamenta a causa delle sofferenze<br />
sperimentate nel corso del suo ministero profetico. Vengono chiamati di solito "Confessioni di<br />
<strong>Geremia</strong>" in analogia alla "Confessioni" di S. Agostino. Il linguaggio spesso violento e la<br />
drammaticità delle tematiche fa sì che questi brani siano praticamente senza paralleli nella<br />
letteratura profetica della Bibbia.<br />
Nella prima parte di questa lezione leggeremo brevemente uno dei testi e poi nella seconda parte<br />
esamineremo le questioni ermeneutiche dell'intera serie delle Confessioni.<br />
1. Esegesi di Ger 15,10-21<br />
2. Le "Confessioni" in generale: alcune considerazioni di tipo ermeneutico<br />
1. Esegesi di Ger 15,10-21<br />
La delimitazione del brano non presenta difficoltà particolari; gli studiosi infatti concordano sul<br />
fatto che una nuova pericope inizia a 15,10 dopo la fine della sezione dedicata alla siccità e brani<br />
associati (14,1–15,9), e c'è ugualmente accordo sul fatto che il brano finisce a 15,21 (16,1 si apre<br />
infatti con una tipica formula di inizio).<br />
Uno dei principali problemi, in questo caso, è il testo e la relativa traduzione.<br />
Il TM non risulta affatto chiaro soprattutto ai vv. 11-14.<br />
Proponiamo qui la traduzione delle Paoline, Nuovissima Versione della Bibbia dai <strong>Testi</strong><br />
Originali (Roma 1979) che rimane, ad oggi, una delle migliori traduzioni.<br />
<strong>Geremia</strong><br />
10 ynITid>liy> yKi yMiai yli-yAa<br />
#r ytiyvin"-al{<br />
ynIwl;l.q;m. hL{Ku<br />
Yhwh<br />
11** hw"hy> rm;a'<br />
bAjl. ^ytiyrIvE al{-~ai<br />
h['r"-t[eB. ^b. yTi[.G:p.hi aAl-~ai<br />
Ahimè, madre mia, che mi hai generato<br />
quale uomo di litigio e discordia per tutto il paese.<br />
Non do credito né danno credito a me;<br />
tutti mi maledicono.<br />
Dice il Signore:<br />
«Non ti ho, forse, assistito per il meglio?<br />
Non ho, forse, imposto su di te, nel tempo della malvagità<br />
e dell'angustia, l'inimicizia?<br />
byEaoh'-ta, hr"c' t[eb.W<br />
12 tv,xon>W !ApC'mi lzB; lzB; [:roy"h] Spezzerà, forse, il ferro il ferro del nord e il rame?<br />
13 !Tea, zb;l' ^yt,Arc.Aaw> ^l.yxe La tua ricchezza e i tuoi tesori lascerò depredare<br />
ryxim.bi al{ senza compenso,
31<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
^yl,WbG>-lk'b.W ^yt,waJox;-lk'b.W per tutti i tuoi peccati e in tutti i tuoi confini.<br />
14 ^yb,y>ao-ta, yTir>b;[]h;w><br />
T'[.d"y" al{ #r T'[.d:y" hT'a;<br />
ynIdEq.p'W ynIrEk.z"<br />
yp;d>rome yli ~q,N"hiw><br />
ynIxEQ'Ti ^P.a; %r yhiy>w:<br />
ybib'l. tx;m.fil.W<br />
yl;[' ^m.vi ar"q.nI-yKi<br />
tAab'c. yhel{a/ hw"hy><br />
17 ~yqIx]f;m.-dAsb. yTib.v;y"-al{<br />
zl{[.a,w"<br />
yTib.v;y" dd"B' ^d.y" ynEP.mi<br />
yn<strong>It</strong>'aLemi ~[;z:-yKi<br />
18 xc;n< ybiaek. hy"h' hM'l'<br />
aper"hE hn"a]me hv'Wna] ytiK'm;W<br />
bz"k.a; AmK. yli hy<br />
20 hZW<br />
hr"WcB. tv,xon> tm;Axl.<br />
^yl,ae Wmx]l.nIw><br />
%l' Wlk.Wy-al{w><br />
^l,yCih;l.W ^[]yviAhl. ynIa] ^T.ai-yKi<br />
hw"hy>-~aun><br />
21 ~y[ir" dY:mi ^yTil.C;hiw><br />
p ~ycirI[' @K;mi ^ytidIp.W<br />
Io ti farò servire il tuo nemico<br />
in un paese che non conosci,<br />
perché un fuoco s'è acceso nella mia ira:<br />
contro di voi si accenderà».<br />
Tu lo sai, Signore!<br />
Ricordati di me e visitami<br />
e vendicami contro i miei persecutori;<br />
nella lentezza della tua ira non lasciarmi perire;<br />
sappi che ho portato, per causa tua, l'obbrobrio.<br />
Furono trovate le tue parole e le divorai;<br />
una gioia fu per me la tua parola<br />
e una letizia per il mio cuore,<br />
perché il tuo nome veniva invocato su di me,<br />
Signore, Dio degli eserciti!<br />
Non mi son seduto nell'assemblea dei beffardi<br />
per divertirmi.<br />
A causa della tua mano solitario mi son seduto,<br />
perché di sdegno mi avevi riempito.<br />
Perché deve durare il mio dolore per sempre<br />
e la ferita mia è incurabile, senza guarigione?<br />
Vorrai essere per me come un bugiardo,<br />
come acqua inquinata (inaffidabile)?<br />
Per questo dice il Signore:<br />
«Se vuoi ritornare, ti farò ritornare,<br />
al mio cospetto resterai;<br />
e se tu produrrai cose meritevoli, prive di viltà 2 ,<br />
quale bocca mia tu sarai.<br />
Ritorneranno essi a te,<br />
ma tu non tornerai a loro.<br />
Io ti renderò di fronte a questo popolo<br />
qual muro di bronzo fortificato;<br />
combatteranno contro di te,<br />
ma contro di te non prevarranno,<br />
perché io sono con te, per salvarti e liberarti.<br />
Oracolo del Signore!<br />
Io ti libererò dalla mano malvagia (dei malvagi)<br />
e ti strapperò dal pugno dei violenti».<br />
** il v. 11 è particolarmente problematico da tradurre. Si deve però almeno tener presente che qui parla<br />
Yhwh: la CEI fa invece parlare ancora <strong>Geremia</strong>.... (seguendo la LXX)<br />
«Dice il Signore: «Non ti ho, forse, assistito per il meglio? Non ho, forse, imposto su di te, nel tempo<br />
della malvagità e dell'angustia, l'inimicizia?» (IEP)<br />
2 Lett. «farai uscire ciò che è prezioso da ciò che è vile». Può significare «distinguere» oppure «produrre».
32<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
«Dice il Signore: «Ci sarà un futuro migliore per quelli che sopravvivranno, ma ti esporrò all’attacco del<br />
nemico, in un tempo di male e di afflizione» (McKane)<br />
«Dice il Signore: «Certo, ti ho sorteggiato per un bene. Certo, ha fatto sì nel tempo della malvagità e<br />
dell’angoscia che tu incontrassi il nemico» ?? (Fischer)<br />
→ «Dice il Signore: «In verità l’inimicizia nei tuoi riguardi è per il bene. In verità io lascio che il nemico<br />
si abbatta su di te nel tempo della sciagura e nel tempo dell’angoscia» (Barbiero)<br />
1.1 Struttura e temi<br />
La struttura è piuttosto chiara.<br />
Si tratta di un doppio dialogo: due volte Ger si lamenta con Dio (v. 10 e 15-18) e due volte Dio<br />
gli risponde (vv. 11-14 e 19-21).<br />
Due sono anche i temi che ricorrono: l’inimicizia di cui Ger è oggetto da parte dei suoi<br />
concittadini e il ricordo della vocazione profetica a cui sia Yhwh che Ger fanno appello.<br />
1.2 Primo lamento di <strong>Geremia</strong> (v.10)<br />
L'invocazione drammatica alla madre di <strong>Geremia</strong> che apre il brano esprime un lamento di<br />
<strong>Geremia</strong> riguardo alla sua nascita (e implicitamente alla sua vocazione profetica: cf. 1,5).<br />
Schökel fa notare che il testo, da un punto di vista sonoro, sembra imitare una specie di lamento<br />
contratto (monosillabi in i).<br />
La ragione del lamento viene espressa nell'autodescrizione del v. 10: "uomo di litigio e discordia<br />
per tutto il paese", che può essere compresa in due modi:<br />
(1) <strong>Geremia</strong> oggetto dell'ostilità popolare a causa del suo messaggio duro,<br />
(2) <strong>Geremia</strong> come soggetto-annunziatore del litigio di YHWH con il popolo.<br />
In ogni caso, la sua vocazione lo porta a doversi mettere contro i suoi concittadini e, quindi, a<br />
sperimentare la loro ostilità, la loro inimicizia.<br />
<strong>Geremia</strong> insiste sul non aver fatto male a nessuno, non ha commesso torti... eppure... "tutti mi<br />
maledicono" (con un tocco di esagerazione retorica probabilmente, in quanto altri testi del libro<br />
fanno capire che <strong>Geremia</strong> aveva alcuni sostenitori).<br />
1.3 Prima risposta del Signore (vv. 11-14)<br />
È la parte del testo più problematica: non solo le traduzioni divergono immensamente, ma<br />
addirittura molti commentatori “saltano” questi versetti sia nella traduzione che nel commento.<br />
Che fare noi?<br />
- innanzitutto tenere presente che qui a parlare è il Signore (il TM è chiarissimo in questo) ><br />
anche la nuova CEI fa invece continuare a parlare il profeta<br />
- poi cercare di comprendere > difficoltà logica: cosa significano le parole del Signore?<br />
Crediamo si debbano interpretare come un annuncio di compimento: si sta compiendo nella tua<br />
vita esattamente quello che ti avevo annunciato al momento della vocazione, cioè che su di te è<br />
posta l’inimicizia di tutti, come segno dell’inimicizia che il popolo ha nei miei confronti.<br />
- v. 12: eppure, io ribadisco che tu sei invincibile, che non ti potranno spezzare<br />
- ma annuncio anche (vv. 13-14) che il destino del popolo non cambierà. Non ti vuole ascoltare,<br />
ma quello che ho decretato avverrà > la distruzione e la deportazione non potranno essere evitate a<br />
motivo dei «tuoi peccati».<br />
Ger appare così come il profeta solidale con il destino del suo popolo: non ha fatto nulla di male,<br />
ma il piano del Signore si compie e lo coinvolge. L’odio che sperimenta, non è, in realtà indirizzato<br />
a lui, ma al Signore.
33<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
1.4 Secondo lamento di <strong>Geremia</strong> (vv. 15-18)<br />
<strong>Geremia</strong> si rivolge al Signore chiedendo il suo intervento: chiede di essere ricordato (come<br />
dicevamo in Ger 2 il ricordo del Signore è attivo, efficace, opera la salvezza) e quindi aiutato in<br />
questa situazione di rifiuto; ma chiede anche di essere vendicato, chiede che Dio punisca i suoi<br />
persecutori e lo faccia presto: «Nella lentezza della tua ira non lasciarmi perire!». Dio è «lento<br />
all’ira» e il profeta lo sa, ma teme che la sua pazienza diventi, per lui motivo di morte.<br />
È da notare la grande franchezza con cui Ger si rivolge al Signore; una franchezza che parrebbe<br />
sfrontatezza e che testimonia, invece, la grande intimità che esiste tra Dio e il suo profeta. Egli osa<br />
ricordargli che, a causa sua, ha sopportato l’obbrobrio, la vergogna, l’insulto.<br />
Nella persecuzione del profeta è in gioco non solo l’onore del profeta ma, soprattutto, l’onore<br />
stesso di Dio, la sua parola.<br />
In contrasto con questa sua situazione attuale ricorda gli inizi del suo ministero profetico (v. 16),<br />
quando il suo cammino come servo del Signore era un tempo di vera gioia spirituale.<br />
- le tue parole furono trovate: per dire che nessuno può darsi la P/D si usa il passivo<br />
- la reazione del profeta è quella attesa: «le divorai» > il profeta può parlare solo perché è nutrito<br />
dalla parola stessa... perché l’ha fatta sua, assimilata profondamente.<br />
- l’esperienza è quella della gioia<br />
- perché il tuo nome era invocato su di me > segno dell’appartenenza<br />
Dichiara la sua innocenza (v. 17) come Giobbe: quello che mi è accade non è frutto di alcun<br />
peccato, non ho fatto nulla per cui meriti di essere punito. Non ho trascurato la mia missione<br />
profetica, non mi sono «allineato» a quello che gli altri avrebbero voluto che io dicessi. Per questo<br />
sono stato anche isolato...<br />
Isolamento sociale ed esperienza di morte (cf. Lv 13,46 > lebbroso).<br />
Accusa contro Dio (v. 18) sotto forma di domande, di interrogativi > la prima è certamente una<br />
domanda («perché», hM'l')... la seconda parte della frase potrebbe ancora essere parte della domanda<br />
oppure risultare un’affermazione staccata: «Davvero tu sei per me come un bugiardo, acque di cui<br />
non ci si può fidare» (Barbiero). Entrambe le soluzioni sono possibili.<br />
1.5 Seconda risposta del Signore (vv. 19-21)<br />
In realtà il Signore non ha abbandonato il suo profeta; gli si rivolge direttamente con un invito<br />
alla conversione («tornare a YHWH») e la promessa di riprenderlo come suo profeta. Si può<br />
probabilmente parlare qui di una "seconda chiamata", come viene confermato dai molti contatti di<br />
vocabolario fra il v. 20 e il racconto della prima chiamata (cf. 1,18-19).<br />
Di fatto è richiesta anche a Ger una conversione, un ritorno al Signore, alla Sua logica (non a<br />
quella degli uomini). Gli è chiesto di continuare a credere nella promessa del Signore per la sua<br />
vita, anche quando tutto sembra andare contro questa promessa, quando tutto sembra smentirla.<br />
A Ger è chiesto di distinguere tra ciò che è prezioso e ciò che non lo è, ciò che vale e ciò che non<br />
vale. A questa condizione egli potrà essere ancora come la bocca stessa di Dio.<br />
È inoltre chiaro che Ger non deve «tornare» ad allinearsi con il pensiero comune dei suoi<br />
concittadini, ma sono loro che dovranno «tornare a lui»: suo compito profetico è precisamente non<br />
cedere al luogo comune, ma continuare a proporre come preziosa e vitale la Parola del Signore,<br />
anche quando essa parla di dolore e di castigo.<br />
Proprio perché questa parola è dura, al profeta viene di nuovo assicurato l’aiuto di Dio, con le<br />
stesse parole con cui il soccorso gli era stato garantito all’inizio della sua vocazione.
34<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Il testo non presenta alcuna risposta da parte di <strong>Geremia</strong>; viene sottinteso che ha accolto l'invito<br />
divino alla conversione e si è rimesso in cammino come profeta (come il resto del libro dimostra).<br />
Nell'immagine di <strong>Geremia</strong> che emerge da questo brano i lettori possono vedere bene il "vaso di<br />
creta" (cf. 2 Cor 4,7) al quale la chiamata del Signore fedele e misericordioso è rivolta, ma anche la<br />
fedeltà di Dio all’opera: sceglie di nuovo e rimette in cammino il profeta che aveva già scelto.<br />
2. Le "Confessioni" in generale<br />
Dopo una lettura rapida di uno dei testi detti "Confessioni di <strong>Geremia</strong>", esaminiamo adesso un<br />
problema ermeneutico postoci da tutta la serie delle Confessioni. Da quale punto di vista conviene<br />
leggere questi testi? C'è una chiave di lettura particolarmente adatta e fruttuosa? Per cercare una<br />
risposta a queste domande, vediamo prima la problematica esegetica di fondo, poi consideriamo<br />
alcune proposte di lettura globale in vista di questa problematica, e concludiamo con alcuni cenni<br />
attualizzanti.<br />
2.1 La problematica di fondo<br />
La problematica sorge da due osservazioni: (1) nelle Confessioni sembra che abbiamo una<br />
riflessione delle esperienze più personali di <strong>Geremia</strong> durante il suo ministero, e (2) allo stesso<br />
tempo il linguaggio delle Confessioni presenta una quantità notevole di contatti con i Salmi.<br />
Ger Salmi e Giobbe<br />
1 11,21; 12,6 41,10<br />
2 15,17 [16,1-4] 102,8<br />
3 12,3: 15,16-17 26,4.6 [e cf. Giobbe]<br />
4 18,20 35,13<br />
5 18,21-23 55,16; 137,91<br />
6 18,23 69,28-29<br />
7 20,10aα = 31,14°<br />
8 20,14-18 [Giobbe 3]<br />
2.1.1 Parole molto personali<br />
(1) Il <strong>Geremia</strong> del testo parla degli intrighi contro di lui, anche dalla gente di Anatot suo<br />
villaggio di origine (11,21) e dalla propria famiglia (12,6).<br />
(2) Lamenta il suo isolamento dalla società (15,17).<br />
(3) Protesta la sua innocenza e insiste sulla sincerità del suo servizio del Signore (12,3; 15,16-<br />
17).<br />
(4) Ha addirittura interceduto per i suoi persecutori (18,20).<br />
(5) Però si sfoga anche con imprecazioni violente contro i suoi nemici (18,21-23).<br />
(6) Arriva a chiedere al Signore di non perdonare i peccati dei persecutori (18,23).<br />
(7) Descrive la sua situazione con le parole: "...sentivo le insinuazione di molti: Terrore<br />
all'intorno" (20,10a).<br />
(8) Maledice il giorno della sua nascita (20,14-18; cf. già 15,10).<br />
[I punti (5) e (6) pongono il problema più generale di come capire tali imprecazioni nella Bibbia,<br />
anche in vista del NT...]
35<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
2.1.2 Contatti con i Salmi e Giobbe<br />
Questi medesimi argomenti (che sembrano a prima vista così personali) si trovano tutti anche in<br />
testi fuori di <strong>Geremia</strong> (Salmi e Giobbe) e non in rapporto con <strong>Geremia</strong>. Tali testi (soprattutto i<br />
Salmi di lamento [o supplica] individuale) sono testi comunitari, nel senso che qualsiasi orante in<br />
Israel può usarli nella preghiera se si trova nella situazione descritta. In altre parole, il linguaggio è<br />
in buona parte un linguaggio "pubblico".<br />
Ed ecco il problema di fondo: come conciliare queste due serie di osservazioni riguardo alle<br />
"Confessioni di <strong>Geremia</strong>"? Da una parte i testi sembrano aprirci una finestra all'anima di <strong>Geremia</strong>,<br />
alle sue esperienze più personali; dall'altra parte il linguaggio ha molti tratti non unicamente<br />
applicabili alla vicenda personale di <strong>Geremia</strong>.<br />
2.2 Tre proposte di lettura globale<br />
Il problema è stato notato da parecchio tempo e diverse sono le proposte dei commentatori per<br />
offrire una lettura che tenga conto delle due serie di osservazioni sopra. Esaminiamo sinteticamente<br />
tre tipi di lettura qui.<br />
2.2.1 Una lettura autobiografica con cautela<br />
Questo tipo di lettura, ancora oggi comune in molti studi su <strong>Geremia</strong>, ha trovato la sua<br />
formulazione classica nella monografia fondamentale di Baumgartner nel lontano 1917. Dopo un<br />
esame minuzioso del linguaggio delle Confessioni, il Baumgartner arrivò a due conclusioni:<br />
(i) ci sono effettivamente molti contatti con i Salmi (ben più di quelli elencati sopra come<br />
esempi);<br />
(ii) ma ci sono anche nelle Confessioni un buon numero di testi importanti che non hanno<br />
contatti con i Salmi e che esprimono invece situazioni specificamente profetiche (per es.<br />
Ger 11,21 "non profetare"; Ger 15,15-21 ["la crisi vocazionale"]; Ger 17,15 [dove gli<br />
avversari di <strong>Geremia</strong> si servono di termini tipici dell'attività profetica]; Ger 20,7; Ger<br />
20,8-9). Questi ultimi testi provano che le Confessioni erano fondamentalmente testi<br />
profetici di <strong>Geremia</strong>. I contatti con i Salmi si spiegano per il fatto che <strong>Geremia</strong> (di<br />
famiglia sacerdotale!) aveva indubbiamente una buona familiarità con la preghiera dei<br />
Salmi nel Tempio (a livello orale almeno) e spontaneamente si sarebbe servito della<br />
fraseologia dei Salmi orali quando formulava le proprie esperienze.<br />
Conclusione ermeneutica: la lettura autobiografica delle Confessioni è quella più adatta e<br />
corretta. Però ricordando che non possiamo leggere tutti i dettagli come espressione personalissima<br />
dell'anima di <strong>Geremia</strong>, in quanto il linguaggio è in parte convenzionale, pubblico.<br />
2.2.2 Una lettura liturgica comunitaria<br />
Una contestazione radicale della lettura autobiografica è stata formulata da Reventlow nel 1963<br />
in mezzo alla "stagione d'oro" degli studi di generi letterari dell'AT. Per Reventlow i Salmi erano<br />
testi che avevano il loro Sitz im Leben nella liturgia del Tempio. Dunque le Confessioni di <strong>Geremia</strong><br />
a causa dei loro numerosi contatti con i Salmi dovevano, anch'esse, essere testi liturgici, nei quali<br />
<strong>Geremia</strong> parla non come individuo ma come profeta in contesto liturgico, dove si esprime cioè<br />
come "porta-parola" della comunità orante. Così che "l'io" delle Confessioni è in realtà un "io"<br />
comunitario che si riferisce a tutta l'assemblea liturgica del Tempio. Come mediatore liturgico<br />
<strong>Geremia</strong><br />
(1) presenta le sofferenze e le suppliche della comunità al Signore, e<br />
(2) annunzia alla comunità le risposte del Signore.
36<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Conclusione ermeneutica: le Confessioni, in quanto testi liturgici di una profeta mediatore<br />
cultico, non ci dicono assolutamente niente degli stati d'anima personali di <strong>Geremia</strong>. Una lettura<br />
autobiografica è esclusa dal genere letterario dei testi.<br />
Ricezione della tesi del Reventlow: pochissimi studiosi l'hanno accolta per intero (ci sono infatti<br />
vari argomenti di peso contro una lettura esclusivamente liturgica), ma un risultato permanente della<br />
tesi è stato quello di sensibilizzare i lettori alla dimensione comunitaria delle Confessioni.<br />
2.2.3 Vari livelli di senso nelle Confessioni (approccio di storia della redazione)<br />
Il terzo tipo di lettura, sempre più comune negli studi degli ultimi decenni, parte dalla<br />
costatazione che non ci sono soltanto contatti con testi esterni (Salmi e Giobbe) ma anche diverse<br />
tensioni interne nelle Confessioni che si spiegano meglio con l'ipotesi di una composizione<br />
attraverso diversi stadi di redazione. Partendo da uno strato di base (che secondo alcuni potrebbe<br />
anche venire da <strong>Geremia</strong> stesso), i testi sono cresciuti attraverso varie riletture della figura di<br />
<strong>Geremia</strong> in chiave comunitaria da parte di redattori postesilici fino a raggiungere la loro forma<br />
attuale.<br />
Conclusione ermeneutica: "l'io" originale degli strati di base, riferito alla persona di <strong>Geremia</strong>,<br />
diventò negli strati successivi un "io esemplare o paradigmatico", cioè le vicende del "<strong>Geremia</strong> del<br />
testo" venivano lette come una metafora delle vicende della comunità postesilica: le loro sofferenze<br />
e difficoltà nel cercare di vivere secondo la loro vocazione, i loro dubbi, il loro bisogno di una<br />
conversione e di una chiamata rinnovata, ecc.<br />
Per un esempio concreto, si veda Ger 15,13-14 dove il testo parla chiaramente delle sofferenze di<br />
tutto il popolo di Giuda, eppure questi versetti si trovano adesso in mezzo a un brano che presenta la<br />
vicenda personale di <strong>Geremia</strong>. Sembra proprio che chi ha inserito i vv. 13-14 al loro posto attuale<br />
abbia voluto dare una dimensione comunitaria alla tematica di 15,10-21.<br />
2.3 Conclusione<br />
I tre tipi di lettura appena notati implicano diverse posizioni riguardo allo studio diacronico delle<br />
Confessioni. Se ci trasferiamo nell'orizzonte di studio sincronico, possiamo concludere che il<br />
"<strong>Geremia</strong>" del testo finale delle Confessioni combina aspetti propri del profeta e aspetti<br />
interpretativi della comunità dei fedeli del Signore. Il ministero della parola, proprio del profeta,<br />
coinvolge anche la comunità in Israele ... e nella Chiesa. In questo modo le Confessioni di <strong>Geremia</strong><br />
possono accompagnare anche chi oggi viene chiamato al ministero della parola che è la gioia e la<br />
letizia del cuore, un ministero però non esente dall'esperienza amara di opposizione e rifiuto, di<br />
sofferenze e dubbi, ma che viene sorretto dalla presenza del Signore anche nel buio e nell'angoscia.
37<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
LA NUOVA ALLEANZA: GER 31,31-34<br />
- BOVATI, P., «Così parla il Signore». Studi sul profetismo biblico (Bologna 2008).<br />
- BOVATI, P., <strong>Geremia</strong> 30-31. Dispense ad uso degli studenti (Roma 2008).<br />
- dispense p. Conroy<br />
I brani che annunciano un futuro migliore sono in minoranza nel libro di <strong>Geremia</strong> (cf. 1,10). Si<br />
trovano per esempio a 3,6-13; 24; 29,4-14; 32-33, ma la collezione più conosciuta è senz'altro il<br />
"Libro della Consolazione" nei capp. 30-31, dove troviamo il brano della nuova alleanza.<br />
Il breve oracolo di Ger 31,31-34 è certamente uno dei più noti dell’Antico Testamento1, ed è quello<br />
che viene spontaneamente alla mente ogni volta che si parla di «nuova alleanza», a motivo della<br />
terminologia qui utilizzata, non solo per l’espressione hv'd"x] tyrIB. (b e rît ḥădāšāh) unica nella Bibbia<br />
ebraica, che introduce l’oracolo, ma anche per la chiara opposizione alla prima alleanza.<br />
Questo testo viene citato due volte nella Lettera agli Ebrei, in 8,8-12 (per intero) e in 10,16-17<br />
(parzialmente), allo scopo di comprovare – su base profetica – la prospettiva tipica di questo scritto,<br />
che è quella di contrapporre la novità cristologica al sistema religioso dell’antico Israele. Il fatto che la<br />
nostra pericope venga «citata» conferma l’opinione degli esegeti moderni che ritengono, in modo<br />
unanime, che Ger 31,31-34 costituisca una unità letteraria sui generis, isolata e separata dal contesto<br />
immediato in cui è stata inserita.<br />
1. Contesto immediato: il "Libro della Consolazione" (Ger 30-31)<br />
1.1 Delimitazione e strutturazione di Ger 30-31<br />
Quanto alla delimitazione, gli studiosi sono d'accordo nel vedere i due capitoli come un blocco a<br />
parte. Difatti, all'inizio 30,1-2 segnala chiaramente un nuovo inizio, e 32,1 con uguale chiarezza<br />
apre una nuova unità.<br />
I capp. 30-31 si differenziano inoltre dal loro contesto<br />
(1) per la forma poetica della maggior parte dei brani (mentre i capitoli prima e dopo sono per lo<br />
più in prosa), e<br />
(2) per il fatto che non portano una data cronologica specifica (in contrasto con i capitoli intorno<br />
dal cap. 25 al cap. 36).<br />
Per la strutturazione qui si presenta la proposta di Bozak 3 , basata su due criteri formali:<br />
(1) la ricorrenza della formula "così dice il Signore", e<br />
(2) l'alternanza fra destinatari maschili e femminili degli oracoli (un criterio chiaro nell'ebraico,<br />
ma non nelle traduzioni!).<br />
Come introduzione e come conclusione ci sono brani prevalentemente in prosa (30,1-3 e 31,23-<br />
40), mentre il corpo dell'unità è composto da sei brani poetici.<br />
3 BOZAK, B., Life “Anew”. A Literary-Theological Study of Jer. 30-31 (AnBib 122; Roma 1991).
38<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
30,1-4 Introduzione in prosa: Parole di restaurazione del popolo<br />
30,5-11 1. Poesia (masc.): Contrasti (vv. 5-7 / 8-11)<br />
Dalla paura alla salvezza<br />
30,12-17 2. Poesia (fem.): Guarigione della ferita incurabile (vv. 12-15 / 16-17)<br />
Dalla ferita alla guarigione<br />
30,18–31,1 3. Poesia (masc.): YHWH prende cura ma senza escludere i castighi (18-22 /<br />
30,23–31,1)<br />
La ricostruzione del popolo dell’alleanza<br />
31,2-6 4. Poesia (fem.): L'amore di Dio nel passato e nel futuro (vv. 2-3 / 4-6)<br />
La ricostruzione della relazione<br />
31,7-14 5. Poesia (masc.): Il grande raduno dei salvati tornati alla loro terra (vv. 7-9 /<br />
10-14)<br />
Il ritorno alla pienezza della gioia<br />
31,15-22 6. Poesia (fem. / masc. / fem.): Tristezza superata e speranza rinnovata (vv.<br />
15-17 / 18-20 / 21-22)<br />
Il ritorno come nuova creazione<br />
31,23-34 Conclusione in prosa, parte prima: Tutto verrà rinnovato<br />
Benedizione e nuova alleanza<br />
31,35-40 Conclusione in prosa, parte seconda [vv. 35-37 in poesia]: Un futuro garantito<br />
Un’alleanza perenne<br />
1.2 Temi e motivi dominanti in Ger 30-31<br />
Il tema dominante in tutti i brani qui è certamente quello di un grande cambiamento, una<br />
trasformazione della realtà che verrà realizzata con sovrana libertà da YHWH. La novità da venire<br />
però non è senza connessione con il passato; infatti troviamo una certa dialettica fra continuità con<br />
il passato e discontinuità. L'alternanza fra maschile e femminile poi contribuisce a rafforzare anche<br />
la dimensione emotiva dell'annuncio, e a coinvolgere tutti nell'ascolto.<br />
È fondamentale, ai fini di una corretta esegesi di Ger 31,31-34, tenere presente il contesto, cioè<br />
l’insieme dei capitoli 30-31 per evitare di trarre conclusioni teologiche parziali e persino errate,<br />
qualora siano dedotte da un solo breve brano profetico.<br />
Manca, in particolare, al testo che andiamo a commentare, un esplicito accenno alla libera<br />
partecipazione dell’uomo al processo salvifico, che è invece tematizzata in molti altri passi (ad es. Ger<br />
31,17-19); la partecipazione libera e amorosa dell’uomo è infatti indispensabile per comprendere il<br />
concetto di alleanza, in ogni sua forma.<br />
2. Studio di Ger 31,31-34<br />
31 hw"hy>-~aun> ~yaiB' ~ymiy" hNEhi<br />
hd"Why> tyBe-ta,w> laer"f.yI tyBe-ta, yTir:k'w><br />
hv'd"x] tyrIB.<br />
32 yTir:K' rv,a] tyrIB.k; al{<br />
~t'Aba]-ta,<br />
Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore -,<br />
nei quali con la casa d'Israele e con la casa di Giuda<br />
concluderò un'alleanza nuova.<br />
Non sarà come l'alleanza che ho concluso<br />
con i loro padri,
39<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
~d"y"b. yqIyzIx/h, ~AyB.<br />
~yIr"c.mi #r-~aun><br />
~B'r>qiB. ytir"AT-ta, yTit;n"<br />
hN"b Wh[erE-ta, vyai dA[<br />
hw"hy>-ta, W[D> rmoale<br />
ytiAa W[d>yE ~L'Wk-yKi<br />
hw"hy>-~aun> ~l'AdG>-d[;w> ~N"j;q.mil.<br />
~n"wO[]l; xl;s.a, yKi<br />
dA[-rK'z>a, al{ ~t'aJ'x;l.W<br />
quando li presi per mano<br />
per farli uscire dalla terra d'Egitto,<br />
alleanza che essi hanno infranto,<br />
benché io fossi loro Signore 4 . Oracolo del Signore.<br />
Questa sarà l'alleanza che concluderò<br />
con la casa d'Israele dopo quei giorni<br />
- oracolo del Signore -:<br />
porrò la mia legge dentro di loro,<br />
la scriverò sul loro cuore.<br />
Allora io sarò il loro Dio<br />
ed essi saranno il mio popolo.<br />
Non dovranno più istruirsi<br />
l'un l'altro,<br />
dicendo: "Conoscete il Signore",<br />
perché tutti mi conosceranno,<br />
dal più piccolo al più grande - oracolo del Signore -,<br />
poiché io perdonerò la loro iniquità<br />
e non ricorderò più il loro peccato".<br />
2.1 Delimitazione e struttura di Ger 31,31-34<br />
Quanto alla delimitazione, la maggioranza degli studiosi non ha difficoltà di vedere 31,31-34<br />
come una sottounità all'interno della prima parte della conclusione in prosa dei capp. 30-31 (cf.<br />
sopra). Infatti la frase temporale "ecco verranno giorni, oracolo del Signore" (v. 31a-b) viene usata<br />
anche a 31,27 per aprire una sottounità (cf. anche 30,3 e 31,38). E la "formula del messaggero"<br />
("così dice il Signore") che apre 31,35 indica spesso l'inizio di una nuova sottounità nei capp. 30-31<br />
(cf. sopra). In questo modo i vv. 31-34 restano delimitati come brano.<br />
Riteniamo che il testo sia strutturato il due piccole unità:<br />
vv. 31-32 = l’alleanza con i padri<br />
vv. 33-34 = la nuova alleanza<br />
2.2 Critica letteraria<br />
Per quanto concerne 31,29-30 gli autori concordano nel ritenerlo un passo tardivo, composto<br />
probabilmente a partire da Ez 18,2ss<br />
Più dibattuta è invece la questione riguardante 31,31-34. La maggior parte dei commentatori<br />
propende per attribuire Ger 31,31-34 ad un redattore tardivo, influenzato dalla corrente<br />
deuteronomista; lo stile prosaico e ripetitivo, il vocabolario e i temi che sembrano caratteristici della<br />
tradizione dtn-dtr, la collocazione, quasi in appendice, nell’ultima parte del libro della consolazione<br />
vengono giudicati indizi precisi di una mano diversa da quella del profeta stesso.<br />
2.2.1 Gli indizi testuali<br />
La stessa posizione del brano Ger 31,31-34 dentro l'insieme dei capp. 30-31 desta già una certa<br />
sorpresa, in quanto non si trova fra i sei brani poetici centrali che formano il nucleo del blocco ma<br />
insieme con gli altri brani conclusivi (in prosa per lo più) verso la fine del blocco, cioè più ai<br />
margini della composizione.<br />
4 Così la CEI. Noi seguiremo nel commento la proposta di Bovati: «e io ho esercitato la mia autorità su di loro». Qui<br />
la preposizione b- sembra indicare infatti il carattere aggressivo dell’azione, intendendo quindi un atto punitivo.
40<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Ma è soprattutto, uno studio del vocabolario dei vv. 31-34 mostra che diversi sintagmi importanti<br />
per il brano sono rari negli oracoli che probabilmente vengono da <strong>Geremia</strong> e invece sono comuni<br />
nei brani la cui formulazione ha contatti forti con testi deuteronomistici. Un solo esempio: il termine<br />
centrale b e rît, che si trova 23 volte nel libro di Ger, ricorre soprattutto in testi deuteronomistici (e.g.<br />
11,2ss). Lo stesso vale per la "formula dell'alleanza" (31,33e-f), come si può vedere in Ger 7,23;<br />
11,4; 24,7; 32,38.<br />
2.3.2 Valutazione degli indizi<br />
Parecchi studiosi arrivano alla conclusione che il linguaggio di Ger 31,31-34 ci orienta verso la<br />
tesi di un'origine dopo il tempo di <strong>Geremia</strong> fra discepoli sotto l'influsso della teologia e della<br />
fraseologia della scuola deuteronomista.<br />
Altri invece pensano che la situazione sia più complessa, in quanto certi temi in Ger 31,31-34<br />
non sono affatto tipici della teologia deuteronomista, per esempio, il perdono gratuito e<br />
incondizionato concesso da YHWH (di solito, nella teologia deuteronomista, il perdono divino<br />
viene dopo il pentimento umano). Questi autori sostengono, dunque, che almeno le idee essenziali<br />
del brano devono essere attribuite a <strong>Geremia</strong>; la formulazione attuale poi potrebbe in parte essere il<br />
lavoro di discepoli.<br />
Il nostro parere si situa nella linea di coloro che considerano l’intero passo come una rielaborazione<br />
del tempo esilico, posteriore quindi a <strong>Geremia</strong>, ispirata, se non redatta, da un redattore deuteronomista.<br />
Per un’unità letteraria breve, come la nostra, non si possono avere prove dirimenti; tuttavia<br />
(a) il vocabolario di marca geremiana può facilmente essere riconosciuto come prodotto «di<br />
imitazione», frutto di un esplicita volontà di raccordare le nuove parti con il resto del libro;<br />
(b) il riferimento esplicito al lessico e alle tematiche dell’alleanza attestano l’intervento di una<br />
corrente letteraria, come quella deuteronomistica, che intende armonizzare le tradizioni della Tôrah (in<br />
particolare del Deuteronomio) con quelle profetiche.<br />
Questa ipotesi di genesi letteraria, da una parte, spiega perché in questo passo vengano sviluppati<br />
motivi che non abbiamo trovato nella prima sequenza, come l’affermazione di una discontinuità netta<br />
rispetto al passato, la trasformazione interiore dell’uomo operata da Dio, l’esplicita terminologia del<br />
perdono; dall’altra, si capisce meglio sia la natura prosaica del brano, in conformità allo stile<br />
deuteronomistico, sia la sua collocazione nella parte finale, da considerarsi complementare alla serie<br />
ordinata dei poemi precedenti.<br />
Ciò non toglie che il redattore ultimo, attento ai fenomeni di composizione, abbia strutturato il testo<br />
in modo accurato.<br />
2.2 Esegesi per parti<br />
2.2.1 L’alleanza con i padri (vv. 31-32)<br />
L’alleanza annunciata da Ger è detta «nuova» e tale novità è spiegata mediante la<br />
contrapposizione con l’alleanza stipulata con i padri.<br />
Anche se, per plausibili motivi teologici o ideologici, si vuole sostenere che l’alleanza del Sinai non è<br />
stata abolita, ma solo modificata o meglio portata a pieno compimento, resta che il passo di <strong>Geremia</strong><br />
presenta un vistoso contrasto oppositivo tra la prima e la seconda alleanza.<br />
Nella sua storia, Israele ha conosciuto molte riforme religiose, contrassegnate dal rinnovamento<br />
dell’alleanza; la prima di tutte, iscritta negli stessi racconti fondatori, fu quella conseguente al peccato
41<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
del vitello d’oro (Es 34). Ma, dal primo all’ultimo, tutti questi «rinnovamenti» lasciarono l’alleanza<br />
esposta alle sue proprie fragilità, e non fecero altro che ribadire che la storia di Israele costituisce un<br />
susseguirsi di tradimenti, di castighi e di infruttuosi (perché menzogneri) tentativi di cambiamento. La<br />
«nuova alleanza», così come l’annuncia <strong>Geremia</strong> e similmente anche gli altri profeti, non è una riforma<br />
religiosa, ma una trasformazione radicale della relazione tra il Signore e il suo popolo: essa è nuova ed<br />
eterna, una alleanza diversa dalla prima per qualità e quindi durata.<br />
Per far comprendere i tratti della nuova alleanza, Ger la contrappone a quella antica, con i padri<br />
(gli israeliti della prima generazione).<br />
Ger fa dunque riferimento a tre momenti:<br />
1. il tempo delle origini<br />
2. il tempo della storia passata<br />
3. il tempo presente<br />
1. il tempo delle origini, cioè il momento fondatore<br />
Il momento che effettivamente viene evocato non è l’alleanza al Sinai né si parla del deserto, ma<br />
si risale ancora più indietro, alla liberazione dall’Egitto, all’uscita dalla schiavitù.<br />
Cf. Dt 29,24; 1Re 8,9.21; Ger 11,3-4 e soprattutto<br />
«Così dice il Signore, Dio d'Israele: Io ho concluso un patto con i vostri padri quando li ho fatti<br />
uscire dalla terra d'Egitto, liberandoli da quella condizione servile» (Ger 34,13)<br />
Secondo il racconto biblico, «nel giorno» dell’uscita dall’Egitto non avvenne nessuna stipulazione;<br />
eppure fu quello il momento «fondatore» del patto, come afferma anche il Decalogo, documento<br />
originario dell’alleanza sinaitica, nella sua formula introduttiva: «io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho<br />
fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla casa di schiavitù» (Es 20,2; Dt 5,6).<br />
Ger 31,32 descrive l’azione divina del liberare come un prendere per mano.<br />
Varie le possibili interpretazioni del gesto.<br />
Noi riteniamo che qui la simbolica paterna sia da considerare quella più adatta al testo.<br />
Se si attribuisce al gesto del «prendere per la mano» il significato concreto di sostenere, guidare,<br />
sorreggere, il momento fondatore dell’alleanza è contrassegnato, in Dio, dalla paterna sollecitudine, e,<br />
nell’uomo, dalla strutturale debolezza.<br />
Nelle diverse tradizioni si utilizzano vari tipi di metafora: Osea dice che Israele era un bambino, che<br />
necessitava di essere guidato (Os 11,1.3), ed Ezechiele evoca la scena di un neonato abbandonato in<br />
piena campagna (Ez 16,4-5); il Deuteronomio ricorda che il Signore «ha portato» Israele durante il<br />
cammino nel deserto «come un uomo porta il proprio figlio» (Dt 1,31), mentre altrove si ricorre alla<br />
metafora del «trasportare con ali di aquila» (Es 19,4; Dt 32,11). Dio ha fatto tutto, Israele è stato un<br />
semplice beneficiario, come lo è il bambino o il bisognoso. Questa condizione «iniziale» porta in sé una<br />
ambiguità grave: per Israele infatti, il diventare «grande», cioè autonomo e autosufficiente, coinciderà<br />
immaginariamente con il rifiuto del ricevere dal Signore, arrivando persino a farsi artefice – mediante<br />
l’idolatria – del proprio dio.<br />
2. il tempo della storia passata: il patto infranto<br />
Senza mezzi termini il Signore dichiara «ma essi hanno infranto la mia alleanza»<br />
- il sintagma è frequente nella BH (20 occorrenze) > spesso l’alleanza viene rotta!<br />
- è suff. che sia uno dei due contraenti a spezzarla<br />
- non si tratta di una trasgressione occasionale, ma della cessazione di un rapporto<br />
cfr. Ger 11,9-10
42<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
9 Il Signore mi disse: "Si è formata una congiura fra gli uomini di Giuda e gli abitanti di Gerusalemme; 10<br />
sono ritornati alle iniquità dei loro primi padri, che avevano rifiutato di ascoltare le mie parole, e anch'essi<br />
hanno seguito altri dèi per servirli. La casa d'Israele e la casa di Giuda hanno infranto l'alleanza che io avevo<br />
concluso con i loro padri.<br />
Dio dice: «la mia alleanza» (ytiyrIB.); il suffisso pronominale sottolinea il fatto che Dio concepisce<br />
l’alleanza come frutto della sua iniziativa (di amore), e come tale la difende, con gelosia (che si manifesta<br />
come collera, quando vi è di mezzo il male) e con tenacia (che si manifesta nella volontà ripetuta di<br />
ricuperare il rapporto, alterato dal peccato). Nello stesso tempo è reperibile un certo limite in questa<br />
medesima qualifica «possessiva», in quanto sottolinea la unilateralità di questa prima alleanza, alla quale<br />
Israele sembra rimanere quasi estraneo.<br />
3. il tempo presente: la sanzione divina<br />
Il patto è stato rotto e, quindi, si devono manifestare le conseguenze di tale rottura (fa parte del<br />
patto stesso che vi siano conseguenze per chi lo infrange).<br />
La risposta divina alla infrazione del patto da parte di Israele assume, nella tradizione dei testi di<br />
alleanza, diverse conformazioni; a volte viene accentuato l’aspetto di punizione, e si usano qui spesso<br />
termini o immagini simmetriche al crimine perpetrato (in conformità alla regola del taglione); in altri<br />
casi invece si mette in luce l’aspetto sapienziale dell’intervento divino (rivelazione del male,<br />
procedimento correttivo).<br />
Nel nostro testo sembra ragionevole supporre che, di fronte ad una valutazione globalmente<br />
negativa dell’agire di Israele, sia prospettata un’azione sanzionatoria ugualmente globale e definitiva.<br />
Ci sono buone ragioni per sostenere che la frase ~b' yTil.[;B' ykinOa'w> debba preferibilmente essere<br />
tradotta con «e io ho esercitato la mia autorità su di loro», intendendo con ciò un’azione punitiva,<br />
concretamente attuata nell’evento dell’esilio.<br />
L’antica alleanza ha così un andamento tragico, perché mostra il volto del Dio che punisce. In quanto<br />
azione di giustizia, ragionevole e necessaria, la sanzione non costituisce un problema teologico; tutta la<br />
predicazione profetica, ivi compresa quella di <strong>Geremia</strong>, ne è una ripetuta attestazione. Tuttavia, se ciò<br />
fosse l’ultima manifestazione della presenza di YHWH nella storia, la rivelazione di Dio sarebbe lungi<br />
dall’essere perfetta; il fallimento e la morte non possono esaltare il Creatore della vita. Era certamente<br />
necessaria la collera, dice <strong>Geremia</strong>, ma su questa si innesta, in modo inatteso e mirabile, la promessa del<br />
perdono, nel quale il Signore porta a perfetto compimento la sua relazione con Israele e la sua<br />
rivelazione come Origine della vita.<br />
2.2.2 L’alleanza nuova<br />
Considerazioni previe<br />
a) Gli elementi che qui vengono dettagliati sono certamente importanti, anzi decisivi per la nuova<br />
alleanza, ma essi non dicono tutto; vanno integrati con altri elementi disseminati nei capp. 30–31.<br />
b) Per altro verso, ognuno degli elementi (scrittura divina nel cuore dell’Israelita, conoscenza del Signore,<br />
perdono dei peccati) risulta in sé sufficiente per alludere alla nuova alleanza, per dirla in totalità sotto un certo punto<br />
di vista. Non è propriamente l’accumulo di caratteristiche, ma la verità e la perfetta realizzazione di<br />
ognuna di esse a costituire l’evento definitivo, che noi chiamiamo nuova alleanza.
43<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Continuità con il passato<br />
Venendo al testo di Ger 31,33-34, la caratteristica di questo testo è di presentare la nuova alleanza<br />
sotto forma di contrapposizione all’antica, così da illustrarne i tratti di novità (si noti la disposizione<br />
chiastica):<br />
v. 31: concluderò... una alleanza nuova<br />
v. 32: non come l’alleanza che conclusi con i loro padri.<br />
Il concetto stesso di novità tuttavia implica un rapporto intrinseco al vecchio, altrimenti i termini<br />
non sarebbero nemmeno confrontabili. Vecchio e nuovo sono due termini contrari, ma si situano su un<br />
medesimo asse semantico, quello appunto della alleanza. La continuità è assicurata attraverso diversi<br />
fattori:<br />
- vocabolario<br />
Per parlare della nuova alleanza si riprendono di fatto espressioni che appartengono all’universo<br />
terminologico della prima alleanza, con il pericolo quindi di pensare che si tratti di una mera continuità,<br />
di un ripristino del passato, di un ritorno alle condizioni precedenti. <strong>Geremia</strong> usa il sintagma «stipulare<br />
un patto» (tyrIB. trk) (cfr. Dt 5,2-3), parla di «Tôrah» nel cuore (cfr. Dt 6,6), usa la formula «sarò il loro<br />
Dio ed essi saranno il mio popolo» (cfr. Dt 26,17-18), parla di «conoscenza del Signore» (cfr. Dt 4,39;<br />
7,9) e di «perdono» (cfr. Es 34,9), che, evidentemente, non sono nozioni estranee alla prima alleanza,<br />
alla quale essenzialmente competono i caratteri del dono gratuito e della misericordia.<br />
Più a fondo si deve anzi dire che la nuova alleanza non può esprimersi che mediante le «figure»<br />
antiche (modi simbolici, concretamente realizzati nella storia): come la fecondità miracolosa, l’abitare<br />
pacifico dopo la prodigiosa vittoria sui nemici, l’unione sponsale che dà gioia, la messa per iscritto del<br />
patto, e così via. In sostanza, abbiamo la stessa cosa di prima, eppure diversa; detto in altri termini: è<br />
l’alleanza originaria che si realizza perfettamente.<br />
- tempo<br />
La nuova alleanza avviene «dopo quei giorni» (~heh' ~ymiY"h; yrEx]a;). «Quei giorni» non possono essere<br />
che quelli della prima alleanza, e in particolare i giorni della maledizione, il tempo dell’esilio; nei testi di<br />
nuova alleanza, in effetti, il periodo della maledizione viene interpretato come una transizione tra le due<br />
alleanze (cfr. ad esempio Lv 26,39-43; Dt 30,1-3; Ez 36,1-7; ecc.). Le due alleanze non sono dunque<br />
presentate come una alternativa, ma come una successione. Abbiamo accennato al fatto che la nuova<br />
alleanza non può prescindere dall’esperienza della sofferenza, nella quale si rivela un giusto rapportarsi di<br />
Dio nei confronti del peccatore ostinato; senza dolore non c’è cuore spezzato, non c’è quindi<br />
conversione al Signore e possibilità della grazia.<br />
Ma, più generalmente, dobbiamo dire che la nuova alleanza è una seconda alleanza, che non può<br />
avvenire se non dopo la prima, non può realizzarsi cioè senza l’esperienza storica del rifiuto di Dio che<br />
porta alla morte, simbolicamente rappresentata dall’esilio: perché è solo questa esperienza di vissuta e<br />
dolorosa debolezza che consente di riconoscere la potenza creatrice di Dio, che fa all’uomo la grazia di<br />
diventare capace di bene.<br />
C’è la prima e c’è la seconda alleanza; entrambe sono necessarie nel loro rapporto di<br />
successione. Il rischio è di credere che sia possibile una nuova alleanza senza esperienza del<br />
peccato e quindi senza rivelazione del perdono.<br />
- destinatario<br />
«Questa è l’alleanza che concluderò con la casa di Israele» (laer"f.yI tyBe-ta,): Dio non fa alleanza con<br />
altri (cfr. la proposta provocatoria del Signore di sostituire Israele con un popolo diverso, quello<br />
discendente da Mosè in Es 32,10 e Dt 9,14), ma con gli stessi peccatori, con il «popolo di dura cervice» (cfr.<br />
Es 33,3.5; 34,9; Dt 9,6.13; ecc.), con coloro che «non possono servire il Signore» (Gs 24,19). Anche
44<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
questo deve essere sottolineato, specie in ambiente cristiano, perché spesso si sostituisce<br />
inconsciamente l’espressione laer"f.yI tyBe con la Chiesa, come se la nuova alleanza fosse l’alleanza del<br />
Signore con i giusti, dopo il fallimento della alleanza antica con Israele peccatore. In realtà, i cristiani<br />
devono inserirsi in Israele, innestarsi nel tronco della loro storia, riconoscendo che la comunione nel<br />
peccato è mediazione necessaria per il riconoscimento della universale misericordia (Rm 11,32).<br />
Le novità della nuova alleanza: 3 elementi<br />
(1) La scrittura della Tôrah sul cuore (v. 33ab-b)<br />
Volendo fare un raffronto con la prima alleanza, si potrebbe dire che questa frase rappresenta<br />
l’evento fondatore, opposto a quello del prendere per mano per far uscire dal paese d’Egitto. Nella<br />
prima alleanza c’è qualcosa di esteriore (sono presi per la «loro mano», la liberazione è di natura politica)<br />
e si fa uso di una certa violenza (radice qzx, motivo letterario della «mano forte e braccio disteso», dei<br />
segni «grandi e terribili»). Nella nuova alleanza abbiamo invece un evento interiore (~B'r>qiB., ~B'li-l[;); la<br />
modalità con cui Dio interviene («porre» e «scrivere») mette implicitamente in gioco la sua mano (o il<br />
suo dito), ma non è evocato l’aspetto di forza.<br />
Spesso, nella Bibbia, le contrapposizioni sono sghembe, per cui si deve evitare una esegesi che forza i<br />
rapporti, là dove essi non sono né esplicitati, né chiaramente sottintesi. È così interessante constatare<br />
che mentre la prima alleanza è descritta nel momento fondatore dell’Esodo (uscita dall’Egitto), non si<br />
parla di nuova alleanza come nuovo Esodo (cfr. invece in Ger 16,14-15 // 23,7-8; ed altri passi dei<br />
profeti), ma come di un nuovo Sinai / Horeb. È chiara infatti la «figura» evocata: il riferimento alla Tôrah<br />
(chiamata «mia Tôrah» [ytir"AT]), e i due verbi, usati in forma chiastica, ne sono la prova:<br />
ytir"AT-ta, yTit;n" (porrò la mia alleanza)<br />
~B'r>qiB. (dentro di loro)<br />
~B'li-l[;w> (sul loro cuore)<br />
hN"b,T]k.a, (la scriverò)<br />
In Ger 31,33, il verbo !tn (lett. «dare»), a motivo del complemento (~B'r>qiB., «dentro di loro») va di<br />
fatto tradotto con «collocare», «porre», significato questo assai frequente in ebraico; ma, sia per la<br />
generale connotazione del verbo, sia per il globale riferimento alla tradizione sinaitica, non si può non<br />
vedere qui l’atto del dono, della comunicazione della legge, che ha la particolarità di essere intima. La<br />
Tôrah infatti non è fatta udire agli orecchi, non è posta nelle mani o collocata nell’arca, ma è deposta<br />
all’interno del cuore.<br />
Analogamente, in Ger 31,33 il dono della legge nel cuore va inteso come capacità sia di conoscenza<br />
della volontà di Dio, sia di condotta riverente e obbediente. L’altro verbo parallelo, btk, è ancora più<br />
evidentemente evocatore delle tradizioni sinaitiche, che concordemente riportano le parole pronunciate<br />
da Dio sul monte (voce), ma narrano anche della loro messa per iscritto su tavole di pietra (cfr. Es 24,12;<br />
Dt 4,13; 5,22; ecc.).<br />
La messa per iscritto è una prassi tipica nelle stipulazioni di alleanza, uno dei modi per conferirle<br />
valore giuridico, a garanzia per entrambi i partners, essendo il segno certo della norma e prova<br />
dell’impegno di osservarne le clausole. Si noti, tra l’altro, che è Dio a scrivere; si rivela così il carattere<br />
essenzialmente «eteronomo» della legge, cioè il fatto che l’uomo non è principio della norma morale e<br />
religiosa, ma la riceve da un Altro. E si rivela anche che è Dio a impegnarsi nel rapporto, anche se<br />
evidentemente impegna anche il partner umano in un’alleanza bilaterale.<br />
All’Horeb Dio scrisse su tavole di pietra (Es 31,18; 32,15-16; 34,1-4; Dt 4,13; 5,22; 9,9-11; 10,1-4; 1Re<br />
8,9 // 2Cr 5,10)122. Fra i vari supporti di scrittura la pietra evidenziava la durata dell’impegno assunto; la
45<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
roccia infatti aveva una durezza maggiore di tutti gli altri materiali (come la terracotta, il legno, il<br />
papiro)123; basti pensare ad esempio al Codice di Hammurabi inciso su una stele.<br />
Chiara è allora la contrapposizione con la scrittura della Tôrah del Signore sul cuore come elemento<br />
caratteristico della nuova alleanza. Le tavole di pietra erano un simbolo esteriore di ciò che adesso si<br />
realizza; erano una «figura», imperfetta, perché<br />
(a) le tavole si possono «rompere»;<br />
(b) vengono messe nell’arca, e quindi tolte dalla vista, con il rischio di essere dimenticate;<br />
(c) suppongono la lettura, operazione certamente non universale, a causa dell’analfabetismo<br />
pressoché universale, dell’oggettiva difficoltà di decifrazione della grafia e a motivo anche della scarsità<br />
delle copie disponibili.<br />
Inoltre, le tavole della legge non appartengono alla struttura essenziale dell’uomo, sono infatti a lui<br />
esterne, poste davanti; da qui il problema della difficile interiorizzazione di una parola scritta su tavole<br />
di pietra.<br />
La scrittura sul cuore – tatuaggio indelebile – è una operazione definitiva. L’Israelita quindi<br />
(a) non sarà più costretto a scrivere la legge sugli stipiti delle porte, oppure a legarsi sulla mano la<br />
Tôrah scritta o collocarla tra gli occhi (Dt 6,8-9; 11,18-20), perché l’avrà sempre presente: il cuore (ble)<br />
infatti è la sede della memoria, dell’intelligenza, della decisione d’amore;<br />
(b) non ci sarà più bisogno dell’arca (Ger 3,16), perché sarà il cuore a custodire la legge (cfr. Ger<br />
3,17; 24,7; 29,13; cfr. anche Dt 6,6; 11,18; Sal 37,31; 40,8-9; Is 51,7).<br />
<strong>Geremia</strong> si serve dunque di una metafora, desunta dalle tradizioni sinaitiche, per evocare un nuovo<br />
inizio.<br />
La nuova alleanza si realizza quando l’uomo consente pienamente alla legge dell’amore, e quando ciò<br />
avviene è perché Dio lo ha donato. Nel nostro testo, la finalità dell’operazione del Signore nel cuore<br />
dell’uomo è essenzialmente la stessa relazione di alleanza, espressa dalla formula di reciprocità: «io sarò<br />
(diventerò) il loro Dio ed essi saranno (diventeranno) il mio popolo» (v. 33b). La relazione con YHWH<br />
definisce Israele nella sua verità più intima; è di questo che parla il versetto seguente.<br />
(2) La conoscenza del Signore (v. 34a)<br />
«Tutti mi conosceranno» (ytiAa W[d>yE ~L'Wk). Questo secondo aspetto della nuova alleanza sarebbe da<br />
collegarsi strutturalmente con il secondo momento storico della prima alleanza (e cioè con il fatto che<br />
«la mia alleanza essi l’hanno infranta»).<br />
La prima alleanza si realizza perché il Signore conosce Israele e si fa conoscere a lui (elemento di<br />
«rivelazione», il cui momento topico è la comunicazione del nome YHWH: Es 3,13-15). Il verbo [dy<br />
non esprime solo l’esperienza gnoseologica, quella del conoscere e del sapere; è stata infatti riconosciuta<br />
la sua appartenenza al linguaggio tecnico dell’alleanza, di cui esprime la dimensione del mutuo<br />
riconoscimento. In altre parole, l’alleanza si sostanzia nel fatto che due partners si rispettano,<br />
riconoscono cioè l’altro nella sua natura e nel suo ruolo; e questo è particolarmente significativo nelle<br />
alleanze asimmetriche. «Io, YHWH, sono il tuo Dio (questo è ciò che Israele riconosce), e tu Israele, sei<br />
il mio popolo (e questo è quello che il Signore riconosce)»; ciò significa che Israele ha solo YHWH<br />
come Dio (e non altre divinità) e che il Signore tratta Israele come sua proprietà particolare fra tutte le<br />
genti (lo elegge, gli comunica la via del bene, lo difende, ecc.).<br />
Questa prima alleanza, nel suo concreto svolgersi storico, è però la rivelazione del contrario, e cioè<br />
che Israele non riconosce il suo Signore, non ha quel rispetto (timore di Dio) e quell’amore che sono
46<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
equivalenti al «conoscere il Signore». Come emblematicamente dice Isaia: «il bue conosce il suo<br />
proprietario e l’asino la greppia del suo padrone, Israele non conosce ([d:y" al{)» (1,2).<br />
Nasce o si modula così la tradizione che rilegge i rapporti fra Israele e il suo Dio in termini di<br />
stoltezza, di insipienza, di non conoscenza (Os 5,4; per il libro di <strong>Geremia</strong>, cfr. in particolare 2,8; 4,22;<br />
5,1-5; 8,7; 9,5.23 dove è particolarmente sottolineato il rapporto tra la non conoscenza di Dio e la<br />
stoltezza). Questo è tanto più strano e inatteso se si considera che la prima alleanza, specie con la<br />
corrente deuteronomistica (grandemente influente al tempo di <strong>Geremia</strong>), aveva dispiegato in modo<br />
sistematico e capillare la mediazione conoscitiva, rappresentata dalla centralità della Tôrah (che è<br />
istruzione) e dalla organica configurazione dei responsabili dell’insegnamento di questa stessa legge: da<br />
Mosè, che ha in prima persona il compito di «insegnare» (cfr. Es 13,8; e soprattutto Dt 4,1.5.14; 5,31;<br />
6,1), ai suoi successori o sostituti, che, secondo il principio della divisione dei poteri, esercitano una<br />
analoga funzione, in diversi ambiti, nella vita quotidiana di Israele. I sacerdoti hanno il compito di<br />
istruire nella Tôrah (cfr. Dt 17,11; 33,10; Ger 2,8; Ml 2,6-8); i profeti devono trasmetterla (cfr. Ger 5,4-<br />
5) e i rappresentanti della tradizione sapienziale, in specie i genitori, hanno il dovere di curare<br />
l’insegnamento delle norme del Signore (cfr. Dt 4,10; 6,7; 11,19145; si ricordi anche tutta la tradizione<br />
dei Proverbi, specie nei capp. 1-9).<br />
Si può dire dunque che la prima alleanza costituisce un sistema nel quale l’importanza della<br />
conoscenza si traduce nella legge dell’istruzione (Sal 19,12). La conoscenza di Dio – valore supremo<br />
dell’alleanza – è mediata dalla conoscenza della legge, e per conoscere la legge si rendono necessari i<br />
mediatori, gli insegnanti.<br />
Ebbene, tutto questo sistema è dichiarato finito nella prospettiva della nuova alleanza: «non<br />
dovranno più istruirsi l’un l’altro».<br />
Va notato che la formula usata da <strong>Geremia</strong> per parlare dell’insegnamento non presenta il «docente»<br />
con una qualifica specifica di autorevolezza istituzionale, come potrebbe essere quella del «padre», del<br />
«sacerdote» o del «sapiente». Il nostro testo prospetta infatti una relazione per così dire paritetica e<br />
reciproca, quella che intercorre tra «compagni» e «fratelli», poiché alla lettera dice: «non dovranno più<br />
istruirsi ciascuno il suo compagno e ciascuno il suo fratello». Questa precisazione non va comunque<br />
maggiorata, poiché subito dopo, seppure in una formula stereotipa (Gen 19,11; 1 Sam 5,9; 2 Re 23,2;<br />
ecc.), si introduce la categoria del «piccolo» e del «grande» (tutti mi conosceranno, dal piccolo al<br />
grande»). Ciò che il testo vuole quindi sottolineare è il passaggio da un sistema di insegnamento<br />
mediato da uomini, nella esteriorità quindi della relazione, ad una realtà nella quale Dio stesso si fa<br />
conoscere, direttamente e perfettamente.<br />
La fine dell’insegnamento è determinata dal fatto che la finalità dell’insegnare è perfettamente<br />
conseguita: «tutti mi riconosceranno»; è quindi del tutto superfluo, anzi incongruo, il continuare a farlo.<br />
Qualcuno ha detto che l’oracolo della Nuova Alleanza annuncia la sparizione della mediazione<br />
umana, perché infedele alla sua missione: verrebbe così indirettamente denunciato il pessimo<br />
insegnamento dei sacerdoti, colpevoli di «non conoscere» il Signore (Ger 2,8), o la sapienza pervertita<br />
degli scribi, rei di aver falsificato la parola di Dio (Ger 8,8-9). A nostro avviso però il testo non<br />
promette il rimedio ad una cattiva mediazione storica nell’ambito dell’insegnamento, ma annuncia un<br />
tale «compimento» dello stesso processo, che rende ormai impertinente il compito didascalico da parte<br />
di qualsiasi uomo.<br />
Come capire questa novità? Dal punto di vista descrittivo si devono notare due cose:<br />
(1) nell’insegnamento (dml, Pi.), è evidente che la cosa insegnata (Tôrah) è sempre esteriore rispetto<br />
al recettore; il maestro, con la sua stessa presenza, dice che il discepolo non conosce. Finché c’è un<br />
maestro, esteriore, siamo nella struttura della prima alleanza. La nuova alleanza avviene invece quando il<br />
maestro se ne va, quando simbolicamente muore. Essa si realizza quando al maestro esteriore si
47<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
sostituisce – con transizione di continuità – l’esperienza personale, il possesso intimo della verità (alcuni<br />
parlano in questo caso di «maestro interiore», che è da identificarsi con la verità a cui liberamente si<br />
acconsente). Questa è la linea della nuova alleanza che si sviluppa tematicamente mediante il simbolo<br />
del cuore che conosce o dello spirito del Signore che diventa principio di intelligenza e di azione buona.<br />
(2) L’insegnamento esteriore si presenta sempre sotto forma di imperativo: «conosci il Signore».<br />
Forse non si nota abbastanza questo aspetto caratteristico della trasmissione cognitiva: si crede che<br />
insegnare sia semplicemente mettere davanti al discepolo i dati e/o le soluzioni, quando invece il vero<br />
insegnamento è un appello a vivere, e quindi a scegliere, ad aderire al vero. Non si tratta solo<br />
dell’insegnamento proprio alla tradizione etica, ma di ogni insegnamento che è rivelazione di verità, per<br />
la quale si impone una scelta di vita che equivale ad abbandonare l’opinione propria o l’errore per<br />
appropriarsi dell’autentico bene. Il maestro dice in sostanza: «seguimi».<br />
Ora, nella nuova alleanza, questa dimensione «imperativa» lascia il posto all’indicativo; cessa il<br />
comando, non perché adesso si possa fare ciò che si vuole, ma perché si realizza la finalità<br />
dell’insegnamento, il quale non ha più ragione di perdurare perché ha ottenuto il suo scopo. Invece di<br />
«conoscete il Signore», si attua il «mi conosceranno» (cfr. Is 30,20; 54,13; Ger 24,7; 32,39-40; Os 2,22;<br />
Sal 51,8; ecc.). In altre parole, l’esortazione lascia il posto alla pratica consolidata e sicura.<br />
In conclusione, la nuova alleanza non è uno stato che si produce abolendo la mediazione (non è<br />
nella soppressione del maestro che si giunge alla vera conoscenza); ma è il sistema che si realizza<br />
quando la mediazione viene meno, quando il maestro «può morire», lasciando il discepolo (non orfano,<br />
perché confortato dallo Spirito) nella perfetta autonomia del conoscere, in rapporto diretto (faccia a<br />
faccia) con la Verità, cioè con Dio stesso.<br />
Terminiamo con la notazione sulla universalità di questa prospettiva: «tutti... dal più piccolo al più<br />
grande». L’estensione universale della nuova alleanza (non solo alla casa di Israele, ma anche alle genti)<br />
è un tratto poco sottolineato nei testi vetero-testamentari (cfr. tuttavia Is 19,19-25; 56,3.6-7; 66,19-21;<br />
Ger 3,17-18; ecc.); lo sarà invece nella interpretazione evangelica. Nella tradizione profetica si insiste<br />
piuttosto sul fatto che ognuno (senza distinzioni) può accedere al nuovo patto.<br />
Piccoli e grandi: <strong>Geremia</strong> usa una formula consueta per dire la totalità, ma è certo che egli fa<br />
riferimento alla gerarchia (cfr. Dt 29,9-10), che è mediazione della trasmissione autorevole della legge, ed<br />
è anche il segno di un popolo che obbedisce. Si sa che comunque questo sistema gerarchico non ha<br />
funzionato [cfr. Ger 5,4-5: i piccoli (~yLiD:) non sanno, ma i grandi ignorano]. Ora, questa distinzione di<br />
autorevolezza «esteriore» è abolita, perché tutti conoscono, e quindi la stessa funzione di colui che è<br />
chiamato grande è finita. Non si tratta di una democratizzazione sociologica, rivendicata in nome del<br />
diritto, ma di una perfetta eguaglianza spirituale, conseguita per dono divino.<br />
(3) Il perdono (v. 34b)<br />
L’ultima frase del nostro testo («perché perdonerò la loro colpa e del loro peccato non mi ricorderò<br />
più») non appare logicamente inserita fra le componenti essenziali della nuova alleanza: il perdono<br />
sembra infatti un elemento previo al dono della legge nel cuore e a quello della conoscenza del Signore.<br />
Una prima osservazione da fare al proposito è che i testi profetici di nuova alleanza giustappongono<br />
spesso i diversi elementi, senza curare una transizione logica dall’uno all’altro. <strong>Geremia</strong>, ad esempio,<br />
annuncia l’uscita dalla paura (30,5-11) e in seguito parla di guarigione (cioè di perdono: 30,12-17); è<br />
chiaro che non vi è un rapporto di successione tra le due promesse. Questo fenomeno, più volte<br />
riscontrato, che consiste nell’accostare gli elementi senza uno stretto legame di consequenzialità, ha la<br />
funzione di manifestare che nella nuova alleanza tutto è dato assieme, non una cosa dopo l’altra, ma ogni<br />
cosa con l’altra.
48<br />
<strong>Geremia</strong>: corso sul profetismo biblico <strong>2013</strong> – appunti – Esegesi di testi <strong>scelti</strong><br />
Una seconda osservazione: a volte, nei testi profetici, il motivo del perdono viene presentato come<br />
l’ultima affermazione di Dio (cfr., ad esempio, Ez 16,63 o Mi 7,18-20). In Ger 31,34 tuttavia questa<br />
collocazione finale ha una motivazione più specifica. Il testo infatti è introdotto da un yKi, interpretato<br />
da alcuni come enfatico («davvero», «certo»), da altri in rapporto con una delle frasi precedenti: (a) mi<br />
conosceranno «perché» perdonerò (o «quando» perdonerò); per il fatto o nel fatto del perdono si rivela<br />
YHWH come il Dio della nuova alleanza; (b) non è un’alleanza come quella dei padri, «poiché» io<br />
perdonerò. In questo ultimo senso – che è quello che noi condividiamo – lo schema geremiano di<br />
nuova alleanza si contrappone allo schema del rîb della prima alleanza, riassunto dal v. 32.<br />
1. uscita dall’Egitto (IO) 1. dono della legge nel cuore (IO)<br />
2. rottura del patto (ESSI) 2. conoscenza di Dio (ESSI)<br />
3. punizione (IO) 3. perdono (IO)<br />
Se la prima alleanza aveva la sua terribile conclusione storica nella manifestazione della collera<br />
divina, la nuova alleanza ha invece il suo culmine escatologico nella rivelazione del perdono di Dio nei<br />
confronti del peccatore.<br />
Il perdono è un elemento fondamentale della nuova alleanza; può da solo dire la totalità del dono.<br />
Anche se il perdono mette in gioco esclusivamente l’azione divina, esso evoca nondimeno la<br />
riconciliazione come perfetto incontro tra i due soggetti; da qui il carattere permanente della relazione<br />
tra il Signore e il suo popolo.<br />
Il perdono è «offerto» da Dio e può essere richiesto da Israele peccatore (cfr. le tradizioni delle<br />
preghiere penitenziali, che i profeti stessi mettono in bocca al peccatore: Ger 3,21-25; 31,18-19; Os<br />
14,2ss). Ma il perdono ha un aspetto unilaterale, poiché può essere «concesso» solo dall’offeso, quindi,<br />
nella storia dell’alleanza, solo da Dio; non è un atto dovuto, è invece decisione libera di Colui che si<br />
rivela come origine della relazione proprio perché «giustifica» colui che non lo merita. I profeti<br />
annunciano l’evento del perdono per «quel giorno»; è una promessa (non solo una possibilità), una<br />
realtà che si avvererà quando il profeta dirà: «questo è il momento del perdono, questo è il giorno della<br />
redenzione».<br />
La terminologia usata da <strong>Geremia</strong> per qualificare il peccato e il perdono deve essere ritenuta<br />
sinonimica. Il verbo xls è per così dire il termine tecnico del mondo religioso (ha sempre per soggetto<br />
Dio); l’espressione «non ricordare più» (dA[-rK'z>a, al{) appartiene invece al linguaggio metaforico, che<br />
esprime la medesima realtà del perdono mediante l’immagine della amnistia (cioè della non<br />
considerazione della colpa). Questi verbi, a loro volta, sono equivalenti alla terminologia della<br />
misericordia (verso il peccatore), che si trova in altri testi di nuova alleanza. Qui si rivela come un<br />
paradosso, si manifesta cioè come sia «estremo» l’atto del perdono: il Dio della perfetta giustizia compie<br />
un gesto di gratuita compassione, il Dio che tutto ricorda (cfr. 31,20) dimentica per sempre le colpe, il<br />
Dio che aveva minacciato al popolo le conseguenze inevitabile del loro peccato annuncia la definitiva<br />
speranza.<br />
È da notare che, secondo l’Antico Testamento, il perdono viene ritenuto un atto divino, nel senso<br />
che viene ascritto unicamente al Signore; solo la storia di Giuseppe (che si riconcilia con i fratelli che lo<br />
hanno venduto) e solo in qualche episodio della storia di Mosè (cfr. Nm 12) e di Davide (che fa<br />
amnistia ai ribelli) viene attestato che degli uomini sono capaci di perdonare le offese. Questo dovrebbe<br />
aiutare a comprendere come il perdono sia un gesto «creativo», che suppone un amore sublime; e se,<br />
nella nuova alleanza (realizzata nel Cristo), ciò è concesso (e quindi richiesto) ad ogni credente, vi si<br />
deve riconoscere il prodigio di un «potere» inaudito dato da Dio agli uomini (Mt 9,8), quando ciò che è<br />
sciolto sulla terra viene sciolto anche nel cielo (Mt 16,19; 18,18), come segno della perfetta e universale<br />
riconciliazione.