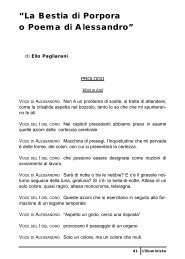Immaginario e ideologia apocalittica nelle rime per la battaglia di ...
Immaginario e ideologia apocalittica nelle rime per la battaglia di ...
Immaginario e ideologia apocalittica nelle rime per la battaglia di ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MATTEO LEFÈVRE<br />
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong><br />
<strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto.<br />
Poeti italiani e spagnoli<br />
Non è semplice orientarsi nel mare delle suggestioni da cui <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> «apocalisse»<br />
è circondata, e tantomeno questa è <strong>la</strong> sede <strong>per</strong> scendere nell’agone definitorio<br />
al<strong>la</strong> ricerca <strong>di</strong> un’accezione <strong>per</strong>entoria, univoca del termine che possa sod<strong>di</strong>sfare<br />
gli ingegni più <strong>di</strong>sparati e soprattutto provenienti dalle formazioni culturali<br />
più <strong>di</strong>fferenti 1 . Esiste all’occorrenza una vasta e ormai seco<strong>la</strong>re bibliografia<br />
sull’argomento che, partendo dai più antichi Padri del<strong>la</strong> Chiesa e sospinta poi<br />
dal respiro profetico <strong>di</strong> Gioachino da Fiore, giunge fino alle interpretazioni culturali,<br />
storiche e sociologiche degli anni a noi più vicini. Eppure, ripeto, non è<br />
questo il luogo in cui proporre un excursus sulle varie interpretazioni 2 ; approfitto<br />
invece <strong>di</strong> queste p<strong>rime</strong> riflessioni <strong>per</strong> sottolineare fin d’ora alcuni punti fermi<br />
– <strong>di</strong> derivazione strettamente biblica ed evangelica – che autorizzano una lettura<br />
degli eventi legati al<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto, sia ante che post factum, all’interno<br />
<strong>di</strong> una prospettiva <strong>apocalittica</strong>.<br />
In primo luogo, al termine «apocalisse» viene attribuito correntemente il<br />
significato <strong>di</strong> «fine del mondo», ma ciò è assolutamente arbitrario e parziale<br />
rispetto al valore originario ed etimologico del<strong>la</strong> paro<strong>la</strong>, nonché in re<strong>la</strong>zione a<br />
uno dei libri più complessi e significativi del<strong>la</strong> letteratura cristiana, e in generale<br />
del<strong>la</strong> cultura occidentale, l’Apocalisse appunto, il cui senso più autentico e<br />
1 Cfr. anche le voci Apocalittica nel Dizionario comparato delle religioni monoteistiche.<br />
Ebraismo, Cristianesimo, Is<strong>la</strong>mismo, Casal Monferrato, Ed. Piemme, 1991; e Apocalisse nel<br />
Dizionario dei miti letterari, Mi<strong>la</strong>no, Bompiani, 1995.<br />
2 Per una bibliografia <strong>di</strong> partenza sull’argomento, soprattutto da un punto <strong>di</strong> vista storicoantropologico,<br />
cfr. <strong>di</strong>rettamente E. TEDESCHI, Per una bibliografia “occulta” sull’Apocalisse,<br />
in M. I. MACIOTI, a cura <strong>di</strong>, Attese apocalittiche alle soglie del millennio, Napoli, Liguori,<br />
1996, pp. 151-158.<br />
97
Matteo Lefèvre<br />
profondo prevede invece i concetti <strong>di</strong> reve<strong>la</strong>tio e renovatio. Il libro <strong>di</strong> San<br />
Giovanni – sia stato il veggente <strong>di</strong> Pathmos o chi <strong>per</strong> lui a re<strong>di</strong>gere o semplicemente<br />
a riorganizzare il testo – è infatti un’o<strong>per</strong>a profetica, che vuole rive<strong>la</strong>re<br />
<strong>di</strong>etro una spessa coltre <strong>di</strong> elementi simbolici il futuro avvento del regno <strong>di</strong> Dio<br />
in seguito al<strong>la</strong> sconfitta definitiva del Male. E <strong>la</strong> rive<strong>la</strong>zione, in questo senso,<br />
annuncia un nuovo mondo dopo <strong>la</strong> «fine del mondo», un’«età novel<strong>la</strong>» in cui si<br />
realizzi appieno il progetto del<strong>la</strong> civitas dei. Sia gli interpreti religiosi che quelli<br />
<strong>la</strong>ici del libro giovanneo fin dalle origini dell’era cristiana non hanno del resto<br />
fatto altro che interrogarsi sul “quando” e “dove” sarebbe concretamente avvenuta<br />
questa apocalisse annunciata con tanto ardore nel Nuovo Testamento: <strong>di</strong><br />
una circostanza comunque nessuno sembra dubitare, e cioè che tutto si compia<br />
all’interno dell’orizzonte storico e intramondano. Non esiste infatti profeta vero<br />
o falso, vestito <strong>di</strong> stracci, del saio o del<strong>la</strong> porpora, che non abbia intravisto e<br />
annunciato i presagi del<strong>la</strong> catastrofe e del<strong>la</strong> conseguente nova aetas entro <strong>la</strong><br />
nebbia del mondo, sul fosco palcoscenico del<strong>la</strong> storia.<br />
In un suo saggio Ernesto De Martino ha analizzato <strong>la</strong> «fine del mondo dell’annuncio<br />
apocalittico cristiano [...] come “dramma storico”, svoltosi e costruitosi<br />
entro un arco determinato <strong>di</strong> tempo» 3 : l’apocalisse sancisce in questo senso<br />
una rive<strong>la</strong>zione e insieme un rinvio del<strong>la</strong> cosiddetta parusía, cioè dell’avvento<br />
del Regno, e «il rinvio del<strong>la</strong> parusía costituirebbe infatti l’o<strong>per</strong>azione tecnica<br />
che consente l’al<strong>la</strong>rgamento dell’orizzonte delle o<strong>per</strong>abilità storiche [...]» 4 . C’è<br />
<strong>per</strong>tanto nel<strong>la</strong> concezione letterale, cristiana, dell’apocalisse «[...] una legittimazione<br />
e qualificazione del<strong>la</strong> o<strong>per</strong>abilità [...], legittimazione e qualificazione ottenute<br />
me<strong>di</strong>ante <strong>la</strong> immagine del<strong>la</strong> repentinità del<strong>la</strong> fine, del suo carattere <strong>di</strong> tribunale<br />
estremo e definitivo dell’o<strong>per</strong>are dei singoli, e del<strong>la</strong> conseguente vigi<strong>la</strong>nza<br />
testimoniante che essa impone al singolo e al<strong>la</strong> comunità dei singoli. [...] Uno<br />
spostarsi <strong>di</strong> accento del qui e dell’ora del decidere o<strong>per</strong>ativo intramondano <strong>per</strong><br />
cui da un qui e da un ora prevalentemente orientati verso <strong>la</strong> s<strong>per</strong>anza futura si<br />
passa ad un qui e ad un ora prevalentemente orientati verso <strong>la</strong> garanzia assoluta<br />
<strong>di</strong> un evento decisivo passato, al centro <strong>di</strong> tutto il <strong>di</strong>venire temporale [...]» 5 . In<br />
effetti, lungi dal voler proporre un’interpretazione troppo “ortodossa”, non<br />
appare esistere conflitto tra l’idea <strong>apocalittica</strong> che si forma nel<strong>la</strong> coscienza e<br />
nel<strong>la</strong> casistica biblico-cristiana e quel<strong>la</strong> che invece si origina al<strong>la</strong> luce dell’ottica<br />
mondana, storica; <strong>la</strong> <strong>di</strong>fferenza semmai risiede negli esiti a cui <strong>la</strong> catastrofe dà<br />
luogo: <strong>la</strong> dottrina religiosa presuppone insomma una renovatio che si incastona<br />
<strong>per</strong>fettamente nel progetto <strong>di</strong>vino; <strong>la</strong> considerazione storica, <strong>la</strong>ica, attende <strong>di</strong><br />
3 E. DE MARTINO, La fine del mondo: contributo all’analisi delle apocalissi culturali,<br />
Torino, Einau<strong>di</strong>, 1977, p. 283.<br />
4 Ibid.<br />
5 Ivi, p. 284.<br />
98
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
conoscere il drammatico riscontro quoti<strong>di</strong>ano dell’età nuova, sorta dopo <strong>la</strong><br />
fine <strong>di</strong> quel<strong>la</strong> precedente. Per delineare ulteriormente lo scenario, come spiega<br />
Lanternari, in base al<strong>la</strong> prospettiva del testo sacro nell’annuncio del<strong>la</strong> rive<strong>la</strong>zione<br />
«[...] si anticipa <strong>per</strong> simboli (7 calici, 7 sigilli o segni, 7 trombe con<br />
re<strong>la</strong>tive pre<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> apparizioni corrispondenti) <strong>la</strong> <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> elementi e<br />
immagini del “male” incombente sul<strong>la</strong> terra: bestie, figure <strong>di</strong> guerra, <strong>di</strong> violenza,<br />
morte, denaro, ecc.: e l’insieme <strong>di</strong> tale nucleo tematico sta a significare<br />
simbolicamente il <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne, il caos, il male da <strong>di</strong>struggere. Contestualmente,<br />
nell’immaginazione simbolica del testo viene rappresentato il tema del riscatto<br />
dal male, tramite altrettante figure dal significato augurale, <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>natori<br />
del caos e demolitori del male: ed ecco gli angeli, gli esseri spirituali, il<br />
“figlio dell’uomo”, ecc. Sono figure antesignane del<strong>la</strong> salvezza, del riscatto,<br />
del reinizio dopo <strong>la</strong> fine. Con esse si annuncia l’avvento finale del regno <strong>di</strong><br />
Dio. [...] L’“apocalisse” dunque originariamente e storicamente è <strong>la</strong> rappresentazione<br />
immaginaria, onirica, simbolica e <strong>la</strong> prefigurazione dello scontro<br />
delle forze del male contro quelle del bene e del<strong>la</strong> salvezza dell’uomo» 6 . Nel<strong>la</strong><br />
prospettiva storico-antropologica, invece, il fenomeno «apocalisse» va indagato<br />
prettamente «[...] come ra<strong>di</strong>cale crisi fattuale, prefigurata e temuta, <strong>di</strong> un<br />
sistema <strong>di</strong> es<strong>per</strong>ienza collettiva, come <strong>per</strong>cezione <strong>di</strong> un irreversibile sconvolgimento<br />
<strong>di</strong> parametri <strong>di</strong> rife<strong>rime</strong>nto culturale e <strong>di</strong> valori comuni, dominanti<br />
del<strong>la</strong> società. Sotto questo profilo, anche in considerazione del fatto che <strong>la</strong><br />
storia procede sovente <strong>per</strong> mutamenti irruenti e travolgenti, si può ben <strong>di</strong>re<br />
che le sue apocalissi possono essere indotte da sconvolgimenti d’or<strong>di</strong>ne religioso,<br />
sociale, culturale o politico [...]» 7 . Nessuna apocalisse comunque, sia<br />
che <strong>la</strong> si intenda nel suo valore squisitamente religioso sia che <strong>la</strong> si consideri<br />
sul piano storico-culturale, appare scorporata dal<strong>la</strong> propria contemporaneità:<br />
nel primo caso, reve<strong>la</strong>tio e renovatio avvengono <strong>per</strong> volere <strong>di</strong> Dio in seguito<br />
ad un ultimo e definitivo (o supposto tale) scontro in cui il Bene trionferà sul<br />
Male, entrambi simboleggiati dai loro rappresentanti mondani; nel secondo,<br />
invece, <strong>la</strong> partita con <strong>la</strong> storia ha un esito molto più incerto, tuttavia, pur<br />
venendo meno questa garanzia provvidenziale, non si può <strong>di</strong>re che manchino<br />
altre forme <strong>la</strong>iche <strong>di</strong> fiducia e s<strong>per</strong>anza in un “futuro migliore”, e magari<br />
teleologicamente orientato, dopo <strong>la</strong> catastrofe: basti pensare al<strong>la</strong> generica<br />
“fede” nell’istituzione politica, nel progresso umano, nel<strong>la</strong> scienza ecc.<br />
I testi apocalittici par<strong>la</strong>no <strong>di</strong> visioni terrificanti e mostruose, <strong>di</strong> temibili<br />
bestie selvagge, <strong>di</strong> guerre nefande e sanguinose, e queste visioni si<br />
6 V. LANTERNARI, Tante apocalissi e <strong>di</strong> vari generi, in M. I. MACIOTI, a cura <strong>di</strong>, Attese<br />
apocalittiche..., cit., pp. 15-27 (<strong>la</strong> citazione è a p. 16).<br />
7 Ivi, p. 17.<br />
99
Matteo Lefèvre<br />
accompagnano in genere a tempi molto <strong>di</strong>fficili: <strong>di</strong> fronte ai momenti <strong>di</strong> crisi<br />
epocale, alle paure <strong>di</strong> un rovescio storico-culturale cresce un sentimento <strong>di</strong><br />
attesa del<strong>la</strong> catastrofe e del<strong>la</strong> successiva rinascita. Come sostiene Maria<br />
Immaco<strong>la</strong>ta Macioti, infatti, dopo questi momenti cruciali, che hanno realmente<br />
determinato o avevano fatto temere il crollo, una cultura «[...] si<br />
aggrappa al<strong>la</strong> s<strong>per</strong>anza, all’ipotesi <strong>di</strong> un <strong>di</strong>sve<strong>la</strong>mento, del<strong>la</strong> nascita <strong>di</strong> un<br />
mondo rinnovato. Di un mondo migliore» 8 . E a questa s<strong>per</strong>anza, nel<strong>la</strong> prospettiva<br />
cristiana, occorre accostare e mettere in evidenza «[...] <strong>la</strong> convinzione<br />
profonda dell’esistenza <strong>di</strong> un futuro che già è realizzato in Dio, al <strong>di</strong> là quin<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> quello che è o che può essere l’agire umano nel concreto sviluppo storico.<br />
[...] L’idea <strong>di</strong> un futuro, migliore assetto in cui i malvagi vedranno infine<br />
punite le loro azioni esecrande, in cui i buoni verranno salvati, ha un evidente<br />
compito <strong>di</strong> rassicurazione» 9 . Il rinnovamento non avviene insomma in una<br />
<strong>di</strong>mensione posta al <strong>di</strong> là del tempo storico, ma al contrario <strong>la</strong> catastrofe è<br />
immersa nell’epoca, cioè nel<strong>la</strong> storia dell’umanità, che in certi frangenti sembra<br />
preparar<strong>la</strong> e annunciar<strong>la</strong>. Emerge così l’idea cristiana che <strong>la</strong> storia sia<br />
attraversata in determinate occasioni da eventi e segni che sembrano pre<strong>di</strong>sporre<br />
il rivolgimento apocalittico 10 .<br />
La <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto, nel<strong>la</strong> coscienza <strong>di</strong> chi <strong>la</strong> visse, rappresentò proprio<br />
uno <strong>di</strong> questi eventi, uno <strong>di</strong> questi segni. Se, in pratica, <strong>la</strong> prospettiva <strong>apocalittica</strong><br />
è <strong>la</strong> forma mentis che assume l’uomo <strong>di</strong> fronte al rischio corso dal<strong>la</strong> propria<br />
cultura, <strong>la</strong> civiltà occidentale ha, sì, assunto nel tempo <strong>la</strong> mentalità del<strong>la</strong> catastrofe<br />
11 , ma quel<strong>la</strong> specificamente cristiana ha saputo affiancarvi <strong>la</strong> s<strong>per</strong>anza, o<br />
meglio il mito, del<strong>la</strong> rinascita, entrambi ra<strong>di</strong>cati nel<strong>la</strong> visione provvidenziale<br />
che è dato <strong>di</strong> scorgere all’uomo – misteriosamente – proprio all’interno del<strong>la</strong><br />
storia. E a Lepanto, il 7 ottobre del 1571, tocca proprio ad una «Armata christiana»<br />
combattere. Non c’è poeta del<strong>la</strong> seconda metà del XVI secolo che abbia<br />
vissuto il clima con cui <strong>la</strong> Santa Lega si preparava allo scontro epocale con i<br />
Turchi, e che poi vi abbia più o meno <strong>di</strong>rettamente partecipato, il quale non<br />
ricor<strong>di</strong>, commemori, celebri i fatti <strong>di</strong> Lepanto con il tono del<strong>la</strong> rive<strong>la</strong>zione e<br />
dell’annuncio <strong>di</strong> una nuova era sorta in seguito al<strong>la</strong> fine <strong>di</strong> un mondo <strong>di</strong> dolore,<br />
peccato e sofferenza. E valgano inizialmente <strong>per</strong> tutti alcuni versi del<strong>la</strong> fa-<br />
8 M. I. MACIOTI, Introduzione a ID., a cura <strong>di</strong>, Attese apocalittiche..., cit., pp. 1-12 (<strong>la</strong><br />
citazione è a p. 6).<br />
9 Ivi, p. 7.<br />
10 Cfr. anche A. PLACANICA, Segni dei tempi. Il modello apocalittico nel<strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione<br />
occidentale, Venezia, Marsilio, 1990.<br />
11 Cfr., tra gli altri, <strong>per</strong> tale “mentalità del<strong>la</strong> catastrofe”, J. DELUMEAU, La paura in occidente<br />
(secoli XIV-XVIII). La città asse<strong>di</strong>ata, Torino, SEI, 1983.<br />
100
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
mosa e più volte imitata Canzone sopra <strong>la</strong> vittoria dell’Armata del<strong>la</strong> Santissima<br />
Lega <strong>di</strong> Celio Magno:<br />
Cominci homai da questo dì giocondo<br />
più che mai bello a rinovarsi il mondo.<br />
Questo è quel dì, che da propitie stelle<br />
con lieto aspetto in ciel n’era promesso,<br />
<strong>di</strong> lui, che le creò, ministre fide.<br />
Questo è quel dì, ch’in voci illustri, e belle<br />
alto spirto <strong>di</strong>vin cantò sì spesso,<br />
mentre l’antica, e nova età’l previde.<br />
Però là verso l’orto il Sol si vide<br />
<strong>di</strong>anzi oscurar d’horribil macchie il volto,<br />
e scorrer <strong>per</strong> lo ciel fiamme, e comete.<br />
(vv. 19-29) 12 .<br />
Dunque, una «Armata christiana». Certamente questa denominazione, poiché<br />
utilizzata negli anni imme<strong>di</strong>atamente successivi al Concilio <strong>di</strong> Trento, poteva<br />
apparire antistorica o quantomeno ambiziosa, visto che proprio l’assemblea<br />
tridentina dopo quasi vent’anni <strong>di</strong> <strong>la</strong>vori aveva in pratica sancito <strong>la</strong> <strong>di</strong>visione<br />
del<strong>la</strong> cristianità e dell’Europa; tuttavia, in quel<strong>la</strong> mattina d’autunno del 1571 le<br />
navi e i soldati che parteciparono al<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> dovettero davvero costituire una<br />
macchina bellica <strong>di</strong> rara forza e unità d’intenti, l’autentico braccio armato del<strong>la</strong><br />
Chiesa militante contro gli «Infedeli». In realtà, sebbene i vari letterati italiani e<br />
spagnoli del tardo Cinquecento raccontarono e cantarono lo scontro con i Turchi<br />
nei termini del<strong>la</strong> lotta tra Bene e Male, ciò che premeva all’Im<strong>per</strong>atore, a<br />
Venezia, al re <strong>di</strong> Spagna e al Papa era più che altro <strong>la</strong> sicurezza dei confini e<br />
delle rotte commerciali. Ma l’occasione <strong>per</strong> una fremente aspettativa e <strong>per</strong> una<br />
tamburel<strong>la</strong>nte propaganda, una volta sistemate le questioni <strong>di</strong>plomatiche più<br />
spinose ed urgenti, si offriva proprio al momento giusto: come ha messo in evidenza<br />
Cohn, da secoli infatti, almeno dal<strong>la</strong> fine dell’XI fino al<strong>la</strong> prima metà –<br />
pretridentina – del XVI, in Europa «[...] una generazione dopo l’altra fu presa,<br />
12 C. MAGNO, La bel<strong>la</strong> et dotta canzone sopra <strong>la</strong> vittoria dell’Armata del<strong>la</strong> Santissima<br />
Lega, nuovamente seguita contra <strong>la</strong> Turchesca, Venezia, [Di Guerra?], 1572, inserita poi<br />
<strong>nelle</strong> Rime <strong>di</strong> Celio Magno et Orsatto Giustiniano, Venezia, Andrea Muschio, 1600. I versi<br />
citati si trovano a p. 22v <strong>di</strong> quest’ultima raccolta. Come nel caso <strong>di</strong> altre composizioni che<br />
cantano <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto, <strong>la</strong> lirica <strong>di</strong> Celio Magno, oltre ad uscire a mo’ <strong>di</strong> foglio sparso,<br />
confluì anche in alcune miscel<strong>la</strong>nee pubblicate nei mesi imme<strong>di</strong>atamente successivi allo<br />
storico scontro: si ricor<strong>di</strong>, tra le altre, almeno <strong>la</strong> celebre Raccolta <strong>di</strong> varii poemi Latini, Greci,<br />
e Volgari. Fatti da <strong>di</strong>versi bellissimi ingegni nel<strong>la</strong> felice Vittoria riportata da Christiani contra<br />
Turchi alli VII. d’Ottobre del MDLXXI. Parte prima. Con <strong>la</strong> Re<strong>la</strong>tione <strong>di</strong> tutto il successo<br />
<strong>di</strong> Famagosta. Et i nomi de i Baßà, & Capitani ch’erano nell’armata Turchesca, Venezia,<br />
Sebastiano Ventura, 1572, pp. 13-15.<br />
101
Matteo Lefèvre<br />
<strong>per</strong>lomeno in modo intermittente, dall’attesa spasmo<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> qualche evento<br />
improvviso e miracoloso in cui il mondo si sarebbe completamente trasformato, <strong>di</strong><br />
un pro<strong>di</strong>gioso conflitto finale fra le schiere <strong>di</strong> Cristo e le schiere dell’Anticristo<br />
attraverso il quale <strong>la</strong> storia avrebbe ottenuto coronamento e giustificazione» 13 . E<br />
questo scontro finale tra Bene e Male, tra popolo <strong>di</strong> Dio e nemici <strong>di</strong> Cristo, tra cristiani<br />
e infedeli, non era nient’altro che il celebre Armageddon, ampiamente profetizzato<br />
nel<strong>la</strong> Bibbia: solo dopo <strong>la</strong> madre <strong>di</strong> tutte le battaglie gli uomini <strong>di</strong> buona<br />
volontà avrebbero conosciuto una nuova era felice, una sorta <strong>di</strong> Para<strong>di</strong>so in terra,<br />
il cui avvento, specialmente da alcuni decenni, <strong>la</strong> propaganda cattolica vinco<strong>la</strong>va<br />
in<strong>di</strong>ssolubilmente al<strong>la</strong> sconfitta totale dell’Im<strong>per</strong>o Ottomano, «crogiuolo <strong>di</strong><br />
empietà», ma soprattutto principale nemico, terra marique, delle potenze cristiane.<br />
In questo modo, <strong>la</strong> campagna “pubblicitaria” <strong>per</strong> <strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong> Santa<br />
Lega, stipu<strong>la</strong>ta nel<strong>la</strong> primavera <strong>di</strong> quello stesso 1571, e il “<strong>la</strong>ncio” del<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong><br />
<strong>di</strong> Lepanto, <strong>la</strong> «Naval», cioè <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> navale <strong>per</strong> eccellenza, si fondarono<br />
espressamente sull’idea che da quello scontro <strong>di</strong>pendesse non solo <strong>la</strong> sorte seco<strong>la</strong>re<br />
dell’Europa cristiana, ma anche il destino ultimo degli uomini timorati <strong>di</strong> Dio:<br />
il sultano Selim II, sia nell’immaginario popo<strong>la</strong>re che nel<strong>la</strong> retorica dei carteggi e<br />
dei resoconti ufficiali, sia <strong>nelle</strong> cronache che nei testi del<strong>la</strong> letteratura coeva, rappresentava<br />
Satana, l’Anticristo, così come, al contrario, i pii combattenti agli or<strong>di</strong>ni<br />
<strong>di</strong> don Juan de Austria, comandante generale delle truppe cristiane, venivano<br />
rego<strong>la</strong>rmente accostati agli angeli del cielo. Si ascoltino ancora, ad esempio, le<br />
parole <strong>di</strong> Celio Magno: l’autore immagina che i valorosi guerrieri cristiani che<br />
hanno <strong>per</strong>duto <strong>la</strong> vita a Lepanto siano accolti in cielo con ogni gloria e che <strong>per</strong><br />
loro si prepari un autentico trionfo in excelsis:<br />
Et novi Angioli a Dio carchi <strong>di</strong> palme<br />
vo<strong>la</strong>r <strong>di</strong> compagnia celeste cinti,<br />
risplendendo <strong>per</strong> l’aria in lunga lista.<br />
(vv. 104-106) 14 .<br />
E su questa falsariga si muovono in molti tra i cantori del<strong>la</strong> «Naval», come<br />
<strong>di</strong>mostrano anche questi versi <strong>di</strong> una delle tante anonime liriche che celebrarono<br />
l’evento:<br />
102<br />
Felici l’Alme son, c’hebbero in sorte<br />
d’esser armate à sì felice impresa;<br />
ma più felice à cui toccò <strong>per</strong> morte<br />
d’haver l’alma à Dio resa,<br />
che questi verso’l ciel spiegando l’ale<br />
13 N. COHN, I fanatici dell’Apocalisse, Treviso, E<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> Comunità, 1965, p. 17.<br />
14 C. MAGNO, La bel<strong>la</strong> et dotta canzone..., cit.
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
hebber forza <strong>di</strong> far morte immortale<br />
(vv. 61-66) 15 .<br />
Bene e Male allora, cristiani-angeli contro musulmani-<strong>di</strong>avoli. Del resto, nel<br />
corso del Cinquecento i Turchi avevano davvero mostrato una certa “empietà”<br />
agli occhi dei vari monarchi del Vecchio Continente: avevano cioè causato non<br />
poche preoccupazioni economiche e politiche alle nazioni dell’Europa centrale<br />
e meri<strong>di</strong>onale. Solo <strong>per</strong> menzionare gli episo<strong>di</strong> più importanti, nel 1522 avevano<br />
occupato Ro<strong>di</strong>, nel ’26 in seguito al vittorioso scontro <strong>di</strong> Mohàcs in Ungheria<br />
avevano saccheggiato Buda ed erano penetrati nel<strong>la</strong> pianura danubiana, nel<br />
1529 erano giunti fino a Vienna. Per non par<strong>la</strong>re delle incursioni marittime sulle<br />
coste italiane, s<strong>la</strong>ve e <strong>per</strong>fino spagnole: da qui le due azioni <strong>di</strong> allegge<strong>rime</strong>nto<br />
tentate da Carlo V, con esiti <strong>di</strong>versi, a Tunisi nel 1535 e ad Algeri nel 1541. Lo<br />
smacco più fresco prima del<strong>la</strong> «Naval» rimaneva comunque <strong>la</strong> presa <strong>di</strong> Cipro<br />
(1570), strappata al<strong>la</strong> Repubblica <strong>di</strong> Venezia dopo quasi un secolo e luogo cruciale<br />
<strong>per</strong> il commercio nel me<strong>di</strong>terraneo orientale.<br />
Non è nostra intenzione ricostruire qui le complesse vicende storiche che<br />
accompagnarono <strong>la</strong> preparazione e lo svolgimento del<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto;<br />
l’obiettivo <strong>di</strong> questo <strong>la</strong>voro consiste infatti nel<strong>la</strong> ricostruzione e nell’analisi dell’es<strong>per</strong>ienza<br />
<strong>di</strong> Lepanto <strong>per</strong> come essa fu <strong>per</strong>cepita dai contemporanei poeti italiani<br />
e spagnoli. L’idea dello scontro apocalittico, definitivo tra Bene e Male<br />
<strong>per</strong>mea infatti le molte liriche composte in seguito al conflitto allo stesso modo<br />
del<strong>la</strong> certezza nell’avvento <strong>di</strong> un’età nuova, in cui finalmente si vada realizzando<br />
il regno <strong>di</strong> Dio; e non c’è poeta, <strong>per</strong>tanto, che non accolga tra i suoi versi<br />
de<strong>di</strong>cati allo scontro e ai suoi protagonisti, accanto alle lo<strong>di</strong> e ai ringraziamenti<br />
<strong>di</strong> rito, rife<strong>rime</strong>nti <strong>di</strong>retti ed emblematici all’immaginario e al tono profetico<br />
dell’Apocalisse <strong>di</strong> Giovanni.<br />
Il linguaggio e le immagini che accompagnano <strong>la</strong> reve<strong>la</strong>tio biblico-cristiana<br />
all’interno dell’o<strong>per</strong>a giovannea integrarono, dunque, e sostanziarono le numerosissime<br />
liriche che i più o meno improvvisati cantori de<strong>di</strong>cano al<strong>la</strong> «Naval» e<br />
che, oltre ad ampliare il re<strong>per</strong>torio del<strong>la</strong> poesia cinquecentesca arricchendolo <strong>di</strong><br />
una prospettiva naturaliter ideologica, dettero soprattutto volume alle molte<br />
miscel<strong>la</strong>nee che ze<strong>la</strong>nti e “interessati” compi<strong>la</strong>tori ed e<strong>di</strong>tori stamparono nel<br />
giro <strong>di</strong> pochi mesi in seguito ai fatti delle isole Curzo<strong>la</strong>ne. Già una prima e<br />
ristretta rassegna dovrebbe fornire un quadro del fenomeno: oltre al<strong>la</strong> Raccolta<br />
<strong>di</strong> varii poemi Latini, Greci, e Volgari. Fatti da <strong>di</strong>versi bellissimi ingegni nel<strong>la</strong><br />
felice Vittoria riportata da Christiani contra Turchi alli VII. d’Ottobre del<br />
MDLXXI (Venezia, Sebastiano Ventura, 1572), già menzionata in nota, si consi-<br />
15 La Vergine, che d’Adria nel mar siede, in Raccolta <strong>di</strong> varii poemi Latini, Greci, e<br />
Volgari..., cit., p. 31v.<br />
103
Matteo Lefèvre<br />
derino almeno, tra le varie, <strong>la</strong> Raccolta <strong>di</strong> varii poemi <strong>la</strong>tini, e volgari: Fatti da<br />
<strong>di</strong>uersi bellissimi ingegni nel<strong>la</strong> felice vittoria reportata da Christiani contra<br />
Turchi (Venezia, Giorgio Angelieri, 1571), nonché il Trofeo del<strong>la</strong> vittoria sacra,<br />
ottenuta dal<strong>la</strong> christianiss. lega contra turchi nell’anno MDLXXI... Con <strong>di</strong>uerse<br />
<strong>rime</strong> raccolte, e tutte insieme <strong>di</strong>sposte da Luigi Groto cieco d’Hadria (Venezia,<br />
Sigismondo Bordogna & Franc. Patriani, [1572]), che si pregiava tra l’altro del<br />
patrocinio e del<strong>la</strong> cura <strong>di</strong> un nome importante del<strong>la</strong> poesia italiana del<strong>la</strong> seconda<br />
metà del secolo quale Luigi Groto.<br />
Ad ogni modo, non bisogna credere che solo <strong>la</strong> tipologia del<strong>la</strong> miscel<strong>la</strong>nea,<br />
del<strong>la</strong> raccolta <strong>di</strong> “<strong>di</strong>versi autori” o <strong>di</strong> “<strong>rime</strong> <strong>di</strong>verse”, che all’altezza del<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong><br />
spopo<strong>la</strong>va nell’ambito del mercato del libro da almeno un quarto <strong>di</strong> secolo,<br />
costituisse l’unico formato e<strong>di</strong>toriale ado<strong>per</strong>ato <strong>per</strong> consacrare <strong>la</strong> vittoria annunciata<br />
<strong>di</strong> Lepanto: accanto a queste antologie, l’urgenza del<strong>la</strong> catastrofe e poi<br />
del<strong>la</strong> celebrazione dette luogo a un’autentica proliferazione <strong>di</strong> fogli sparsi, <strong>di</strong><br />
p<strong>la</strong>quettes, <strong>di</strong> collectanee minime, che <strong>per</strong>misero a rimatori <strong>di</strong> città, statura letteraria<br />
e fama <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong> cimentarsi nel proprio <strong>per</strong>sonale Te Deum e nell’encomio<br />
dei comandanti vittoriosi, i quali avevano saputo garantire <strong>la</strong> veri<strong>di</strong>cità<br />
del<strong>la</strong> profezia <strong>apocalittica</strong>, l’avvento del<strong>la</strong> nova aetas. Generalmente, poi, questi<br />
fogli sparsi, limitati <strong>per</strong> lo più al<strong>la</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> una o al massimo quattro-cinque<br />
liriche e pubblicati subito dopo <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong>, costituirono anche i componenti<br />
<strong>di</strong> base dei successivi e più ampi progetti miscel<strong>la</strong>nei. Oltre alle composizioni<br />
anonime, o <strong>di</strong> cui non è agevole stabilire l’effettiva paternità, esiste un autentico<br />
esercito <strong>di</strong> poeti i quali furono orgogliosi <strong>di</strong> legare il proprio nome al<strong>la</strong> celebrazione<br />
dei fatti e dei protagonisti del<strong>la</strong> «Naval», e così <strong>per</strong>sonaggi più o meno<br />
noti del<strong>la</strong> letteratura italiana dell’epoca tridentina dettero vita a un’esuberanza<br />
poetica collettiva: come spesso accade nell’orizzonte del petrarchismo del<strong>la</strong><br />
seconda metà del secolo, autori <strong>di</strong> un certo rilievo quali Celio Magno, Giro<strong>la</strong>mo<br />
Muzio, Gabriele Fiamma o Giovanbattista Amaltheo 16 con<strong>di</strong>visero <strong>la</strong> scena con<br />
poeti <strong>per</strong> lo più sconosciuti o conosciuti soltanto in ambito locale, Giovanni<br />
Mario Ver<strong>di</strong>zotti 17 , Bartolomeo Malombra 18 , Giovanni Zarotto 19 , Guido e Felice<br />
16 G. AMALTHEO, Canzone <strong>di</strong> M. Giovanbattista Amaltheo. All’Illustriss.mo et<br />
Eccellent.mo Sig. marc’Antonio Colonna General dell’armata <strong>di</strong> Santa Chiesa, sopra <strong>la</strong> vittoria<br />
seguita contra l’armata Turchesca, Venezia, Onofrio Farri, 1572.<br />
17 [G. M. VERDIZOTTI], Nova, & Dotta canzone nel<strong>la</strong> Gloriosa Vittoria contra Turchi,<br />
Venezia, Giorgio Angelieri, 1571.<br />
18 B. MALOMBRA, Nuova Canzone del<strong>la</strong> felicissima vittoria contra infideli; <strong>di</strong> M.<br />
Bartolomeo Malombra, Venezia, s. n., 1571.<br />
19 G. ZAROTTO, Sonetti <strong>di</strong> M. Gio. Zarotto Iustinopolitano, sopra <strong>la</strong> guerra turchesca. In<br />
allegrezza del<strong>la</strong> felicissima vittoria navale. Con l’essortatione fatta all’Imp. Acciò S. Maestà<br />
Cesarea entri in lega, Venezia, Onofrio Farri, 1572.<br />
104
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
Gualtieri 20 , Giovanni Paolo Forzanini 21 , Egi<strong>di</strong>o Gravazzi 22 , Antonio Santonino 23<br />
ecc. E non mancarono autori i quali scrissero ad<strong>di</strong>rittura nel proprio <strong>di</strong>aletto <strong>di</strong><br />
origine e che a volte, indugiando all’ombra del campanile, estesero l’encomio<br />
espressamente a quegli eroi <strong>di</strong> Lepanto che vantavano le medesime origini citta<strong>di</strong>ne<br />
o regionali: è il caso del veneto Giovanni Battista Maganza 24 , ma anche<br />
dell’anonimo autore del<strong>la</strong> Canzone overo Barzelletta sopra <strong>la</strong> vittoria dell’armata<br />
christiana contra <strong>la</strong> turchesca. In Lingua For<strong>la</strong>na (Venezia, Gratioso<br />
Perchacino, 1571) e dell’altro ignoto padre del Discorso sopra il Pater noster in<br />
lingua rustica, <strong>per</strong> <strong>la</strong> vittoria de christiani contra Turchi, <strong>di</strong> cui <strong>la</strong>titano anche i<br />
dati e<strong>di</strong>toriali.<br />
A fianco delle miscel<strong>la</strong>nee e dei fogli sparsi ivi confluiti, come detto, anche<br />
alcuni nomi importanti del<strong>la</strong> poesia del secondo Cinquecento composero un<br />
canzoniere o una silloge <strong>di</strong> <strong>rime</strong> proprio in occasione del<strong>la</strong> «Naval»: è il caso,<br />
ad esempio, <strong>di</strong> Gabriele Fiamma, il quale si cimentò in un c<strong>la</strong>ssico esercizio <strong>di</strong><br />
riscrittura petrarchista proponendo al pubblico <strong>la</strong> sua Parafrasi poetica sopra<br />
alcuni Salmi <strong>di</strong> David Profeta, molto accomodate <strong>per</strong> render gratie à Dio del<strong>la</strong><br />
Vittoria donata al Christianesmo contra Turchi 25 ; nonché quello <strong>di</strong> Giro<strong>la</strong>mo<br />
20 G. GUALTIERI, Canzone <strong>di</strong> M. Guido Gualtieri <strong>per</strong> <strong>la</strong> felicissima vittoria de l’Armata<br />
Christiana contra <strong>la</strong> Turchesca, Ancona, Astolfo de’ Gran<strong>di</strong>, 1571; F. GUALTIERI, Corona <strong>per</strong><br />
<strong>la</strong> Vittoria del<strong>la</strong> santa Lega contra infideli <strong>di</strong> M. Felice Gualtieri, Venezia, Domenico & Gio.<br />
Battista Guerra, fratelli, 1572.<br />
21 G. P. FORZANINI, Canzone nel<strong>la</strong> natiuità <strong>di</strong> nostro signor Giesù Christo. Nel<strong>la</strong> allegrezza<br />
del<strong>la</strong> vittoria hauuta contra i Turchi, Venezia, Domenico Farri, 1572.<br />
22 E. GRAVAZZI, Nuoua canzone del r.p. f. Egi<strong>di</strong>o Grauatio Eremitano nel<strong>la</strong> felicissima<br />
vittoria contra Turchi, Venezia, Gio. Antonio Bindoni, 1572.<br />
23 A. SANTONINO, Canzone nel<strong>la</strong> pubblica letitia, <strong>per</strong> <strong>la</strong> felicissima vittoria nauale ottenuta<br />
contra Turchi, a i Cuzzo<strong>la</strong>ri. Di m. Agostino Santonino. Con due sonetti del medesimo,<br />
Venezia, [Domenico Farri], 1572.<br />
24 G. B. MAGANZA, Froto<strong>la</strong> de Magagnò <strong>per</strong> <strong>la</strong> Vittoria de i nuostri Signuore contra i<br />
Turchi, s.l, s.n., s.a.<br />
25 G. FIAMMA, Parafrasi poetica sopra alcuni Salmi <strong>di</strong> David Profeta, molto accomodate<br />
<strong>per</strong> render gratie à Dio del<strong>la</strong> Vittoria donata al Christianesmo contra Turchi, accioche le<br />
nostre allegrezze sieno veramente Christiane, e grate à Sua Divina Maestà, Venezia, Giorgio<br />
Angelieri, 1571. Vengono in quest’o<strong>per</strong>a «parafrasati» vari salmi, in partico<strong>la</strong>re il salmo<br />
CXLVIII (Laudate Dominum de Caelis); il CXLIX (Cantate Domino Canticum novum: Laus<br />
eius in ecclesia sanctorum); il CL (Laudate Dominum in sanctis eius); il XCV (Cantate<br />
Domino Canticum novum, cantate Domino omnis terra), il CXXIII (Nisi quia Dominus erat<br />
in nobis); e il CXXVIII (Saepe expugnaverunt me).<br />
Un altro esempio <strong>di</strong> riscrittura petrarchista, e che compare in più <strong>di</strong> una miscel<strong>la</strong>nea <strong>di</strong><br />
<strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> vittoria <strong>di</strong> Lepanto, è poi il sonetto Giunta è l’alta Colonna, e’l verde <strong>la</strong>uro rifacimento<br />
del celebre Sonetto del Petrarca (Rotta è l’alta colonna) accomodato leggiadra-<br />
105
Matteo Lefèvre<br />
Muzio, il quale pubblicò quasi in tempo reale le sue Rime <strong>per</strong> <strong>la</strong> gloriosa vittoria<br />
contra Turchi (1571) 26 . In realtà, come accadde nel caso del Muzio e come il<br />
più delle volte già avvisava il frontespizio delle varie e<strong>di</strong>zioni, il “nome grosso”,<br />
l’autore <strong>di</strong> spicco non solo compariva, probabilmente <strong>per</strong> ragioni commerciali,<br />
in quanto “prima firma” <strong>di</strong> una raccolta che poi nel suo interno racchiudeva<br />
liriche <strong>di</strong> altri poeti generalmente meno noti e più o meno occasionali, ma ne<br />
risultava anche il selezionatore e il compi<strong>la</strong>tore. È, quest’ultimo, anche il caso<br />
del già citato Luigi Groto, <strong>di</strong> cui nell’anno successivo ai fatti <strong>di</strong> Lepanto si pubblicò<br />
il Trofeo del<strong>la</strong> vittoria sacra, ottenuta dal<strong>la</strong> christianiss. lega contra turchi<br />
(1572) 27 . Altri autori minori, invece, dovettero affidare esclusivamente al<strong>la</strong> cele-<br />
mente sotto il nome del Senato et popolo Romano in lode del Signor Marcantonio Colonna<br />
mentre in Roma vittorioso entra in modo trionfale, con ingegnosa espositione <strong>di</strong> esso<br />
sonetto.<br />
26 G. MUZIO, Rime del Mutio Iustinopolitano, <strong>per</strong> <strong>la</strong> gloriosa vittoria contra Turchi,<br />
Venezia, s.n., 1571.<br />
La <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto non fu comunque l’unica occasione in cui gli ingegni poetici<br />
italiani e spagnoli cantarono le gesta dei soldati cristiani contro i Turchi. Nei decenni precedenti<br />
ricor<strong>di</strong>amo almeno, sul fronte italiano, i Sonetti... <strong>per</strong> <strong>la</strong> presa d’Africa. E ’l <strong>di</strong>segno<br />
d’una col<strong>la</strong>na d’oro che Napoli dona al sig. D. Garzia <strong>di</strong> Toledo, Napoli, s.n., 1551, e<br />
il Capitolo <strong>per</strong> <strong>la</strong> liberazione <strong>di</strong> Venosa, Napoli, s.n., 1551, entrambi <strong>di</strong> Luigi Tansillo; ma<br />
anche il poemetto in ottave <strong>di</strong> un giovane Lodovico Dolce, le Stanze composte nel<strong>la</strong> vittoria<br />
africana novamente havuta dal sacratissimo im<strong>per</strong>atore Carlo Quinto, Venezia, 1535.<br />
Tra i poeti ispanici, a parte le singole liriche <strong>di</strong> celebrazione delle imprese <strong>di</strong> Carlo V, a cui<br />
<strong>per</strong> altro numerosi poeti cinquecenteschi parteciparono in prima <strong>per</strong>sona (Juan Boscán,<br />
Garci<strong>la</strong>so de <strong>la</strong> Vega, Hernando de Acuña ecc.), è qui opportuno menzionare Gutierre de<br />
Cetina, che de<strong>di</strong>cò due suoi sonetti «A los huesos de los españoles muertos en Castelnovo»<br />
(CCXVII-CCXVIII) proprio in uno scontro contro i Turchi. Queste liriche sono altresì interessanti<br />
poiché testimoniano dei rapporti <strong>di</strong>retti tra Cetina e lo stesso Tansillo: <strong>la</strong> circostanza<br />
biografica è essenziale, infatti entrambi parteciparono al<strong>la</strong> spe<strong>di</strong>zione del biennio 1538-<br />
40; ma soprattutto <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione è letteraria, poiché Tansillo aveva composto proprio nel<br />
1540 tre sonetti de<strong>di</strong>cati «ai tremi<strong>la</strong> soldati spagnuoli morti nel 1539, <strong>di</strong>fendendo<br />
Castelnuovo in Dalmazia contro il pirata Barbarossa, e rimasti insepolti» (Questi, ch’il<br />
mondo in reverenza tiene; Non <strong>per</strong>ché il vento volva e l’aria bagne; Mentre gli alti, sassosi,<br />
orri<strong>di</strong> monti), sonetti inclusi poi nel Sesto libro delle <strong>rime</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>v. eccell. aut., Venezia, A.<br />
Arrivabene, 1553. Fornisce comunque una convincente serie <strong>di</strong> ipotesi sugli incontri e i<br />
rapporti tra Tansillo e Cetina B. LÓPEZ BUENO, Introducción in G. de Cetina, Sonetos y<br />
madrigales completos, e<strong>di</strong>ción de Begoña López Bueno, Madrid, Cátedra, 1990, in partico<strong>la</strong>re<br />
pp. 37-38.<br />
27 L. GROTO, Trofeo del<strong>la</strong> vittoria sacra ottenuta dal<strong>la</strong> Christianissima Lega contra turchi<br />
nell’anno MDLXXI, rizzato dai più dotti spirtiti de’ nostri tempi, <strong>nelle</strong> più famose lingue<br />
d’Italia, con <strong>di</strong>verse <strong>rime</strong>, raccolte e tutte insieme <strong>di</strong>sposte da Luigi Groto, cieco <strong>di</strong> Hadria,<br />
con uno brevissimo <strong>di</strong>scorso del<strong>la</strong> Giornata, Venezia, Sigismondo Bordogna & Franc.<br />
Patriani, 1572.<br />
106
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
brazione del<strong>la</strong> vittoria cristiana e al<strong>la</strong> musa eroica <strong>la</strong> propria fama poetica: nel<strong>la</strong><br />
selva <strong>di</strong> questi rimatori isoliamo qui almeno i nomi <strong>di</strong> Giulio Nuti, con le sue<br />
Pie <strong>rime</strong> sopra <strong>la</strong> felice vittoria de Christiani contra il Turco (1571) 28 ; <strong>di</strong><br />
Jacopo Tiepolo, con le sue Tre sorelle (1572) 29 , a cui concesse una citazione lo<br />
stesso Dionisotti 30 ; e <strong>di</strong> Nico<strong>la</strong> Maria Fazali, con le sue Rime (1577) 31 .<br />
Infine, parteciparono dell’emozione collettiva e del<strong>la</strong> suggestione derivata<br />
dall’avvento del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> età annunciata dall’apocalisse lepantina anche alcuni<br />
letterati che composero poemi narrativi de<strong>di</strong>cati a ricostruire le vicende belliche<br />
<strong>di</strong> quel<strong>la</strong> provvidenziale e fortunata mattinata d’ottobre: a puro titolo d’esempio,<br />
ricor<strong>di</strong>amo il napoletano Gaspare Caffarino e le ottave del suo Naval conflitto <strong>di</strong><br />
christiani con turchi 32 , il suo conterraneo Tommaso Costo 33 e anche l’anonimo<br />
del<strong>la</strong> Narratione del<strong>la</strong> felice vittoria, che ha conseguito l’armata christiana<br />
contra quel<strong>la</strong> del turco, anch’essa in ottava rima 34 .<br />
Dopo aver osservato le tipologie e<strong>di</strong>toriali attraverso le quali nei mesi imme<strong>di</strong>atamente<br />
successivi al<strong>la</strong> vittoria <strong>di</strong> Lepanto ebbero voce alcuni rappresentanti<br />
del<strong>la</strong> poesia italiana del<strong>la</strong> seconda metà del XVI secolo – ma il <strong>di</strong>scorso, come<br />
avremo occasione <strong>di</strong> osservare, vale anche <strong>per</strong> i rimatori iberici –, desideriamo<br />
ora occuparci in modo specifico dell’immaginario apocalittico che <strong>per</strong>mea e<br />
anima dal profondo le liriche dei <strong>di</strong>versi <strong>la</strong>udatores del<strong>la</strong> «Naval». Scorrendo i<br />
numerosi testi che costituiscono l’ampio re<strong>per</strong>torio del<strong>la</strong> poesia commemorativa<br />
dell’epico scontro è infatti possibile stabilire una serie <strong>di</strong> topoi, <strong>di</strong> immagini<br />
ricorrenti che identificano fin da subito e incana<strong>la</strong>no le <strong>di</strong>verse composizioni<br />
all’interno <strong>di</strong> un universo <strong>di</strong> simboli e figure che richiama da vicino, fedelmente,<br />
le visioni dell’Apocalisse biblica.<br />
28 G. NUTI, Pie <strong>rime</strong> sopra <strong>la</strong> felice vittoria de Christiani contra il Turco <strong>di</strong> Giulio da’l Borgo<br />
a S. Sepolcro. All’illustrissimo il Sign. don Pietro Orsino, Perugia, Valente Panizza, 1571.<br />
29 J. TIEPOLO, Tre sorelle: corone <strong>di</strong> sonetti... sopra <strong>la</strong> felicissima vittoria navale,<br />
Venezia, 1572.<br />
30 Cfr. C. DIONISOTTI, La guerra d’Oriente nel<strong>la</strong> letteratura veneziana del Cinquecento,<br />
«Lettere italiane», XVI, 1964, pp. 233-250, poi in ID., Geografia e storia del<strong>la</strong> letteratura<br />
italiana, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1967, pp. 163-182.<br />
31 N. M. FAZALI, Rime del s. Co<strong>la</strong>maria Fazali gentil’huomo del<strong>la</strong> citta <strong>di</strong> Tropea al serenissimo<br />
et inuittissimo sig. don Giouanni d’Austria <strong>per</strong> <strong>la</strong> felice & gloriosa vittoria, Napoli,<br />
Giuseppe Cacchi, 1577.<br />
32 G. CAFFARINO, Il naval conflitto <strong>di</strong> christiani con turchi, e <strong>la</strong> gloriosa vittoria del<strong>la</strong><br />
Santa Lega del sereniss. don Gio. d’Austria generale <strong>di</strong> quel<strong>la</strong>. Scritta in ottaua rima da<br />
Gasparro Caffarino, Napoli, Giuseppe Cacchi, 1571.<br />
33 T. COSTO, Del<strong>la</strong> rotta <strong>di</strong> Lepanto canti cinque <strong>di</strong> Tomaso Costo, Napoli, appresso Gio.<br />
Battista Cappelli, 1573.<br />
34 Narratione del<strong>la</strong> felice vittoria, che ha conseguito l’armata christiana contra quel<strong>la</strong><br />
del turco. Nouamente posta in ottaua rima, s.l., s.n., 1571.<br />
107
Matteo Lefèvre<br />
Uno dei primi elementi comuni, da un <strong>la</strong>to, al<strong>la</strong> propaganda del<strong>la</strong> Santa<br />
Lega e, dall’altro, al<strong>la</strong> <strong>per</strong>cezione che del<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto ebbero i contemporanei,<br />
fossero essi or<strong>di</strong>nari citta<strong>di</strong>ni o mercanti, poeti o soldati – o come<br />
a volte avvenne l’una e l’altra cosa insieme –, fu senza dubbio il fatto <strong>di</strong> considerare<br />
lo scontro tra l’«Armata Christiana» e <strong>la</strong> «flotta turchesca» al<strong>la</strong> stregua<br />
del conflitto definitivo tra il Bene e il Male, che Giovanni aveva annunciato<br />
in Apocalisse 16:16 35 e a seguito del quale si sarebbe dovuto manifestare<br />
il Regno <strong>di</strong> Dio. Lepanto, dunque, non fu so<strong>la</strong>mente lo scontro decisivo <strong>per</strong> le<br />
sorti del Me<strong>di</strong>terraneo e dell’Europa tutta, ma <strong>per</strong> l’impegno ideologico profuso,<br />
<strong>per</strong> il carico <strong>di</strong> aspettativa e <strong>per</strong> l’impegno letterario dei poeti che vi presero<br />
parte, chi in prima <strong>per</strong>sona chi solo emotivamente, quel<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> rappresentò<br />
un momento chiave nel<strong>la</strong> storia dell’umanità: le immagini poetiche convocate<br />
e declinate nei testi ad essa de<strong>di</strong>cati rive<strong>la</strong>no infatti una prospettiva<br />
profondamente religiosa e provvidenziale, che spesso si rifà letteralmente ai<br />
passaggi del libro giovanneo. Il giorno del<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto equivale <strong>per</strong>tanto<br />
a un «giorno del giu<strong>di</strong>zio», e <strong>la</strong> vittoria arrisa al<strong>la</strong> Santa Lega non fece<br />
che evidenziare come il Bene avesse ormai trionfato sul Male, incarnato dagli<br />
Ottomani. In una canzone contenuta in una delle miscel<strong>la</strong>nee precedentemente<br />
menzionate emerge proprio questo sentimento <strong>di</strong> sollievo e <strong>di</strong> fede nel<strong>la</strong><br />
Provvidenza <strong>di</strong>vina, che ha ormai <strong>di</strong>strutto il «Maligno Pianeta», cioè secondo<br />
<strong>la</strong> simbologia del tempo <strong>la</strong> «luna» del<strong>la</strong> ban<strong>di</strong>era turca, il nemico numero uno<br />
del<strong>la</strong> cristianità:<br />
108<br />
O giorno aventuroso; ò giorno lieto,<br />
quanto contento, e quanto ben n’apporti?<br />
Vinto il Barbaro fiero, i legni suoi<br />
condotti furo à più sicuri porti,<br />
e fu quel giorno il mar tranquillo, e queto,<br />
ben chiaro segno ond’hà voluto à noi<br />
dar <strong>la</strong> vittoria Dio, <strong>per</strong>ché <strong>di</strong> poi<br />
non si temesser più futuri oltraggi,<br />
(che più non son <strong>per</strong> noi ceppi, ò cathene).<br />
(vv. 81-89)<br />
[...]<br />
Più non proverem noi de cani il morso,<br />
che <strong>per</strong> <strong>di</strong>vin voler hoggidì è scorso<br />
il Maligno Pianeta e’l miglior regna<br />
35 GIOVANNI DI PATHMOS, Apocalisse, in La Bibbia <strong>di</strong> Gerusalemme, Bologna, E<strong>di</strong>zioni<br />
Dehoniane, 1988 (8a ed.). Tutti i rife<strong>rime</strong>nti ai versetti del libro giovanneo sono tratti da quest’e<strong>di</strong>zione.
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
propitio in tutto à <strong>la</strong> Christiana insegna.<br />
(vv. 97-100) 36 .<br />
E tutte le metafore <strong>di</strong> carattere guerresco, tutte le immagini belliche che<br />
abbondano all’interno delle <strong>rime</strong> <strong>di</strong> cui stiamo par<strong>la</strong>ndo si inquadrano nell’orizzonte<br />
dell’Armageddon, ma non in funzione genericamente simbolica – del<br />
resto, motivi <strong>di</strong> questo tipo rientravano a titolo <strong>di</strong>verso nell’immaginario del<strong>la</strong><br />
poesia occidentale da vari secoli (schermaglie e ferite d’amore, <strong>battaglia</strong> tra vizi<br />
e virtù ecc.): vogliono al contrario testimoniare l’assoluta verità dello scontro<br />
tra Bene e Male, l’hic et nunc del conflitto <strong>di</strong> questi ultimi all’interno del<strong>la</strong> storia<br />
dell’uomo. Nel<strong>la</strong> Canzone nel<strong>la</strong> felicissima vittoria christiana contra infideli<br />
del Guarnello, ad esempio, quest’ultimo, nell’enumeratio che contrad<strong>di</strong>stingue<br />
il secondo verso del<strong>la</strong> strofa riportata <strong>di</strong> seguito, non solo offre un saggio dell’ampio<br />
re<strong>per</strong>torio del<strong>la</strong> terminologia guerresca usata dai poeti che cantarono <strong>la</strong><br />
«Naval», ma mostra, anche nel<strong>la</strong> similitu<strong>di</strong>ne successiva, <strong>la</strong> volontà <strong>di</strong> instaurare<br />
uno stretto legame tra i recenti acca<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> Lepanto e i cruenti scontri<br />
descritti in più luoghi e occasioni dell’Antico Testamento:<br />
et fù quel empio stuol da te repente<br />
vinto, ucciso, sommerso, arso, & troncato;<br />
come già il popol reo <strong>di</strong> Faraone;<br />
(vv. 25-27) 37 .<br />
Il rife<strong>rime</strong>nto a questo e ad altri episo<strong>di</strong> biblici all’interno <strong>di</strong> numerose <strong>di</strong><br />
queste liriche non appare soltanto il corroborante <strong>per</strong> una dotta similitu<strong>di</strong>ne, un<br />
paragone <strong>di</strong> impianto c<strong>la</strong>ssicistico: <strong>di</strong>etro a questi richiami sembra risiedere una<br />
forte interpretazione figurale, a cui già l’Apocalisse <strong>di</strong> Giovanni faceva ampiamente<br />
ricorso. In pratica, ai poeti che celebrano Lepanto interessa stabilire delle<br />
corrispondenze precise tra <strong>la</strong> storia predetta e pre<strong>di</strong>sposta ad Israele dal Dio<br />
dell’Antico Testamento e il corso storico dell’era cristiana inaugurato dal<br />
Messia e sintetizzato dal<strong>la</strong> dottrina dei Vangeli. L’Apocalisse stessa utilizza questa<br />
strategia affiancando <strong>la</strong> condanna del regno del Male, contro cui si schiera<br />
l’esercito degli angeli nel<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> definitiva, al castigo <strong>di</strong> Babilonia, forse <strong>la</strong><br />
più celebre città corrotta del<strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zione veterotestamentaria, allegorizzata nel<br />
libro giovanneo dal<strong>la</strong> «prostituta famosa» (Ap. 17: 1-18). Così, seguendo il<br />
modello, molti rimatori cinquecenteschi paragonano l’im<strong>per</strong>o turco a una novel<strong>la</strong><br />
Babilonia, <strong>la</strong> «grande meretrice» <strong>di</strong> Apocalisse 19: 2, finalmente (o quasi)<br />
36 Perché’l piacer, che vostri cori ingombra, in Raccolta <strong>di</strong> varii poemi Latini, Greci, e<br />
Volgari..., cit., p. 22r.<br />
37 Canzone nel<strong>la</strong> felicissima vittoria christiana contra infideli. Al Sereniss. D. Gio.<br />
d’Austria. Del Cavalier Guarnello, Venezia, Domenico & G. B. Guerra, 1572.<br />
109
Matteo Lefèvre<br />
sconfitta, e accostano <strong>la</strong> vittoria dell’armata cristiana a quel<strong>la</strong> <strong>di</strong> Israele dopo il<br />
seco<strong>la</strong>re conflitto con l’Egitto dei faraoni, risoltosi favorevolmente proprio in<br />
virtù dell’intervento del «Dio degli eserciti» a fianco del suo popolo. Fernando<br />
de Herrera, ad esempio, nel<strong>la</strong> sua famosissima Canción en a<strong>la</strong>bança de <strong>la</strong><br />
Divina Magestad por <strong>la</strong> vetoria del señor Don Juan, adotta proprio questo<br />
duplice richiamo biblico, ricordando appunto i nomi dei due im<strong>per</strong>i pagani storicamente<br />
nemici del “popolo eletto”, <strong>per</strong> sottolineare in senso figurale <strong>la</strong> continuità<br />
dell’eterno scontro tra Bene e Male all’interno del<strong>la</strong> storia, dal<strong>la</strong> notte dei<br />
tempi ai recenti acca<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> Lepanto:<br />
[...] tú solo, Señor, fuiste exaltado:<br />
que tu día es llegado,<br />
Señor de los exércitos armados,<br />
sobre <strong>la</strong> alta cerviz y su dureza,<br />
sobre derechos cedros y esten<strong>di</strong>dos,<br />
sobre empinados montes y crecidos,<br />
sobre torres y muros y <strong>la</strong>s naves<br />
de Tiro, que a los tuyos fueron graves.<br />
Babilonia y Egito, amedrentada,<br />
del fuego y hasta temb<strong>la</strong>rá sangrienta,<br />
y el humo subirá a <strong>la</strong> luz del cielo<br />
[...]<br />
(vv. 142-152) 38 .<br />
La natura inesorabile del conflitto in cui si risolve <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> avvenuta presso<br />
le Isole Curzo<strong>la</strong>ne è evidenziata altresì da Francisco de Aldana <strong>nelle</strong> Octavas<br />
al Serenísimo Señor Don Juan de Austria: qui l’autore ricorre al contrasto tra <strong>la</strong><br />
«grande meretrice» (Babilonia appunto, «el gran Babel») e <strong>la</strong> «sposa mistica» <strong>di</strong><br />
Cristo (<strong>la</strong> Chiesa e, <strong>per</strong> tras<strong>la</strong>to, <strong>la</strong> Santa Lega, da quest’ultima tanto caldeggiata).<br />
Sul piano stilistico, <strong>la</strong> forte caratterizzazione metaforica con cui Aldana<br />
organizza <strong>la</strong> sua strategia e il suo <strong>di</strong>scorso retorico nei confronti del<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong><br />
<strong>di</strong> Lepanto rappresenta anche un esempio concreto e para<strong>di</strong>gmatico del<strong>la</strong> solen-<br />
38 F. de HERRERA, Cantemos al Señor, que en <strong>la</strong> l<strong>la</strong>nura, in ID., Poesía castel<strong>la</strong>na original<br />
completa, ed. de Cristóbal Cuevas, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 257 e sgg. corsivo mio. Da<br />
ricordare, sul piano delle ricostruzioni storico-filologiche, che <strong>la</strong> canzone comparve <strong>per</strong> <strong>la</strong><br />
prima volta al<strong>la</strong> fine del<strong>la</strong> sua Re<strong>la</strong>ción de<strong>la</strong> guerra de Cipre, y sucesso de <strong>la</strong> batal<strong>la</strong> Naval<br />
de Lepanto, Sevil<strong>la</strong>, «por Alonso Escrivano Impressor de Libros», 1572. Herrera esalta <strong>la</strong><br />
figura <strong>di</strong> don Juan de Austria, comandante generale dell’Armata cristiana, anche in occasione<br />
del<strong>la</strong> dura lotta in cui coinvolsero <strong>la</strong> Spagna i moriscos delle Alpujarras, <strong>la</strong> cui ribellione<br />
(1568-1571) fu sedata dallo stesso don Juan. A quest’ultima impresa dell’Asburgo l’autore<br />
de<strong>di</strong>cò infatti <strong>la</strong> canzone Al Señor D. Juan de Austria, vencedor de los moriscos en <strong>la</strong>s<br />
Alpujarras.<br />
110
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
nità che contrad<strong>di</strong>stingue il canto <strong>di</strong> questo evento epocale. Inoltre, sul piano<br />
ideologico, ciò che preme all’autore – come a molti altri poeti-soldati iberici più<br />
o meno celebri – è sottolineare il sodalizio storico tra potere militare spagnolo e<br />
Chiesa militante, rafforzatosi in partico<strong>la</strong>r modo dopo il Concilio <strong>di</strong> Trento:<br />
La evangélica esposa militante<br />
sobre tus fuertes hombros se reclina,<br />
hácete Dios cau<strong>di</strong>llo de su nuera,<br />
¡sus, caiga el gran Babel, sus, caiga y muera!<br />
(vv. 29-32) 39 .<br />
L’immaginario apocalittico dell’Armageddon tiene benissimo anche sul<br />
fronte delle descrizioni dei protagonisti dello scontro. Ovviamente, il più lodato<br />
è don Giovanni d’Austria: se, da una parte, un po’ tutti i poeti gli riconoscono<br />
coraggio, fede e abilità nel comando generale dell’impresa, dall’altra, come<br />
abbiamo appena notato, i rimatori ispanici mettono soprattutto in evidenza <strong>la</strong><br />
sua appartenenza al<strong>la</strong> famiglia reale spagno<strong>la</strong> – era fratello, non amato, <strong>di</strong><br />
Filippo II – e i suoi meriti nel consolidamento dell’asse Roma-Madrid. In più<br />
occasioni don Juan è paragonato al cavaliere dell’Apocalisse, che stermina le<br />
nazioni pagane e affronta senza paura gli eserciti dei re del<strong>la</strong> terra sedotti dal<strong>la</strong><br />
bestia; ma anche all’angelo che al<strong>la</strong> fine dello scontro scende dal cielo con <strong>la</strong><br />
chiave dell’Abisso e una grande catena nel<strong>la</strong> mano, con cui afferra il dragone, il<br />
serpente antico – cioè il <strong>di</strong>avolo, satana – e lo incatena <strong>per</strong> mille anni (Ap. 20: 1-<br />
2). Nell’anonima Canzone in <strong>la</strong>ude et honore del s. don Giouanni d’Austria<br />
l’incipit accosta <strong>di</strong>rettamente <strong>la</strong> figura dell’Asburgo all’invitto cavaliere del<br />
libro giovanneo:<br />
O dal ciel Cavalier <strong>di</strong>sceso, quando<br />
<strong>di</strong> te l’Italia tutta<br />
anzi tutta l’Europa, & l’Occidente<br />
maggior bisogno havea, che in strana lutta<br />
con l’Oriente stando<br />
temea <strong>di</strong> rimaner’ vinto, & <strong>per</strong>dente,<br />
se <strong>la</strong> tua man possente<br />
non fosse stata presta, ar<strong>di</strong>ta, & pronta<br />
a darli aiuto [...]<br />
(vv. 1-9) 40 .<br />
39 F. de ALDANA, La mujer militar que tiene el pecho (LIX), in Poesías castel<strong>la</strong>nas completas,<br />
e<strong>di</strong>ción de José Lara Garrido, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 395-96.<br />
40 Canzone in <strong>la</strong>ude et honore del s. don Giouanni d’Austria, <strong>per</strong> <strong>la</strong> trionfante Vittoria de<br />
l’Armata Christiana, Contra i Turchi. Composta da un gentilissimo spirito. Con vna re<strong>la</strong>tione<br />
de tutto il successo seguito, nel<strong>la</strong> felice giornata, che si hebbe <strong>la</strong> Vittoria, [Venezia, 1571].<br />
Corsivo mio.<br />
111
Matteo Lefèvre<br />
E in un sonetto «Di Gio. Angelo Tirabosco, Aso<strong>la</strong>no» i vari capi del<strong>la</strong> Santa<br />
Lega vengono schierati – e lodati – uno a fianco all’altro nell’intento <strong>di</strong> catturare<br />
e imprigionare, in ortodossia con <strong>la</strong> profezia <strong>apocalittica</strong>, il serpente infernale,<br />
cioè l’armata turca, <strong>per</strong> i “consueti” mille anni:<br />
Pietro, Filippo, e’l buon Marco, & Giovanni,<br />
Giovanni, General <strong>di</strong> questa Impresa,<br />
<strong>la</strong> grande armata d’Oriente han presa,<br />
fatto, che viverà mille, & mill’anni.<br />
(vv. 1-4) 41 .<br />
Ovviamente, in questi versi, se i nomi <strong>di</strong> Filippo e Giovanni richiamano i<br />
due figli <strong>di</strong> Carlo V, Pietro rappresenta il proprio “successore” sul trono papale,<br />
cioè papa Pio V, così come san Marco simboleggia, <strong>per</strong> via del suo illustre<br />
patronato, <strong>la</strong> città <strong>di</strong> Venezia. Significativa è del resto tutta <strong>la</strong> simbologia “c<strong>la</strong>ssica”<br />
che riconduce ai <strong>per</strong>sonaggi <strong>di</strong> spicco che animarono <strong>la</strong> formazione del<strong>la</strong><br />
Lega e che sulle <strong>di</strong>verse navi combatterono il <strong>di</strong>abolico nemico in prima linea:<br />
l’Aqui<strong>la</strong> rappresenta l’Im<strong>per</strong>o e anche <strong>la</strong> Spagna <strong>di</strong> Filippo II, quest’ultima a<br />
volte raffigurata anche attraverso l’apostolo Giacomo, suo patrono; il Leone,<br />
storicamente, Venezia; <strong>la</strong> Croce e il Pastore simboleggiano il Papa; <strong>la</strong> Colonna,<br />
in <strong>per</strong>fetto stile petrarchista, richiama il Colonna, cioè il principe Marc’Antonio,<br />
esaltato in genere sia <strong>per</strong> le sue doti militari sia soprattutto <strong>per</strong> <strong>la</strong> sua grande abilità<br />
<strong>di</strong>plomatica che dette in pratica vita al<strong>la</strong> Santa Lega; il Giglio rappresenta<br />
Firenze ecc. In molte liriche encomiastiche, secondo l’uso c<strong>la</strong>ssicistico, questi<br />
«Gran<strong>di</strong>» del secondo cinquecento vengono dunque raffigurati attraverso<br />
emblemi caratteristici del loro rango e del<strong>la</strong> loro tra<strong>di</strong>zione, tuttavia siffatta c<strong>la</strong>ssificazione<br />
e identificazione simbolica dei protagonisti, specie sul fronte animale,<br />
non risponde so<strong>la</strong>mente al<strong>la</strong> pratica poetica del secolo, bensì si ispira <strong>di</strong>rettamente<br />
al<strong>la</strong> complessa simbologia dell’Apocalisse. L’aqui<strong>la</strong>, ad esempio, è presenza<br />
cruciale tra le pagine del libro giovanneo mentre appare alta nel cielo<br />
dopo <strong>la</strong> quarta tromba, gridando i terrificanti tre «guai» agli abitanti del<strong>la</strong> terra,<br />
scan<strong>di</strong>ti dagli ultimi tre squilli. Una sintesi <strong>di</strong> tutta questa iconografia sia sul<br />
fronte cristiano che su quello ottomano si ha comunque nell’anonima canzone<br />
«Al Santiss. Sig. Papa Pio V», nei cui versi sono appunto elencate e lodate,<br />
attraverso i propri emblemi, le principali potenze dell’Armata cristiana contro i<br />
feroci ed empi turchi, tra<strong>di</strong>zionalmente in<strong>di</strong>cati, questi ultimi, dall’astro lunare:<br />
112<br />
Ma, che poteva un Lupo, un Can feroce,<br />
a l’Aqui<strong>la</strong>, al Leon, a l’Orso incontra?<br />
41 G. A. TIRABOSCO, Pietro, Filippo, e’l buon Marco, & Giovanni, in Raccolta <strong>di</strong> varii<br />
poemi Latini, Greci, e Volgari..., cit., p. 42v.
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
A <strong>la</strong> Colonna? & contra<br />
a Christo? A i Santi, Pier, Iacomo, e Marco<br />
li dei bugiar<strong>di</strong> loro? & come scontra<br />
<strong>la</strong> lor non loro Luna l’alma Croce?<br />
(vv. 81-86) 42 .<br />
L’immaginario che sostiene le rappresentazioni dell’Armageddon apocalittico<br />
e lepantino si definisce ulteriormente <strong>nelle</strong> descrizioni mirabili e terrificanti<br />
del “nemico”. Nell’Apocalisse, e in partico<strong>la</strong>re nel momento dello scontro definitivo,<br />
il re del Male, cioè Satana, è raffigurato al<strong>la</strong> stregua <strong>di</strong> un drago enorme<br />
e rosso con <strong>di</strong>verse teste e corna. Scrive proprio Giovanni: «Scoppiò quin<strong>di</strong> una<br />
guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. [...] Il<br />
grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il <strong>di</strong>avolo [...], fu precipitato<br />
sul<strong>la</strong> terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli» (Ap. 12: 7-9).<br />
Allo stesso modo, dunque, <strong>nelle</strong> liriche composte <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto si<br />
declina un rosario <strong>di</strong> immagini dell’«empio Ottomano», avversario storico dell’Armata<br />
cristiana e nemico universale delle forze del Bene, che hanno una singo<strong>la</strong>re<br />
identità <strong>di</strong> intenti e vedute rispetto al testo giovanneo. Le rappresentazioni<br />
simboliche del Turco generano <strong>nelle</strong> <strong>di</strong>verse <strong>rime</strong> una proliferazione descrittiva<br />
che converge comunque verso <strong>la</strong> caratterizzazione mostruosa <strong>di</strong> quest’ultimo.<br />
Bartolomeo Malombra, nel<strong>la</strong> sua Nuova Canzone del<strong>la</strong> felicissima vittoria<br />
contra infideli, offre un primo e <strong>la</strong>mpante esempio <strong>di</strong> questo atteggiamento<br />
mentre descrive del nemico<br />
[...] il fiero dorso<br />
<strong>di</strong> doppie scaglie horribilmente armato<br />
da spaventar ogni animo più forte:<br />
e d’una testa in loco<br />
quaranta capi havea tutti <strong>di</strong> foco,<br />
folgorando <strong>per</strong> gli occhi empie faville<br />
e fiamme <strong>per</strong> le fauci a mille a mille;<br />
veramente ministro de <strong>la</strong> morte,<br />
parto già delle furie e del peccato,<br />
[...]<br />
(vv. 38-46) 43 .<br />
42 Almo spirto d’Amor, Bontade eterna («Al Santiss. Sig. Papa Pio V»), in Raccolta <strong>di</strong><br />
varii poemi Latini, Greci, e Volgari..., cit., pp. 17r-17v.<br />
43 Nuova Canzone del<strong>la</strong> felicissima vittoria contra infideli; <strong>di</strong> M. Bartolomeo Malombra,<br />
Venezia, s. n., 1571. Ad ulteriore testimonianza dell’analogia fortissima con le descrizioni<br />
presenti nell’Apocalisse, nel sonetto seguente, In fianco antico un giovenil valore («In lode<br />
dell’Invittissimo Generale il Sig. Sebastiano Veniero»), Malombra descrive il nemico sempre<br />
come un «rio Dracon» dalle «corna acute».<br />
113
Matteo Lefèvre<br />
In questo frangente i rife<strong>rime</strong>nti numerici non sembrano preludere ad ulteriori<br />
allusioni simboliche, ma senza dubbio col<strong>la</strong>borano anch’essi all’i<strong>per</strong>bolica<br />
mostruosità nel<strong>la</strong> cui sfera viene raffigurato il «gran Serpe infernale». E Malombra<br />
non è davvero il solo a <strong>la</strong>vorare in questa <strong>di</strong>rezione. Tra i Sonetti <strong>di</strong> M. Gio.<br />
Zarotto Iustinopolitano, sopra <strong>la</strong> guerra turchesca, ad esempio, è efficace l’immagine<br />
ante eventum del «mostro d’Oriente», che non sembra <strong>per</strong> niente <strong>di</strong>sposto<br />
a farsi sopraffare dal<strong>la</strong> flotta cristiana e si prepara a dar <strong>battaglia</strong> scatenando<br />
tutta <strong>la</strong> sua forza:<br />
S’ode muggir il mostro d’Oriente,<br />
e del futuro danno il segno appare,<br />
scuote <strong>la</strong> Terra, e’l Cielo fa turbare<br />
l’Aquilon geme, l’Austro, e l’Occidente.<br />
(vv. 1-4) 44 .<br />
Siamo <strong>di</strong> fronte ad uno scontro <strong>di</strong> civiltà, <strong>di</strong>pinto con i colori originali<br />
dell’Apocalisse e con questi ultimi elevato al rango <strong>di</strong> lotta definitiva tra il Bene<br />
e il Male nel mondo. La vittoria dell’«Armata Christiana» è imminente ma il<br />
prezzo da pagare sarà alto: se, da un <strong>la</strong>to, come afferma Giovanni, il serpente<br />
sarà vinto e il drago sconfitto si potrà osservare «sul<strong>la</strong> spiaggia del mare» – e<br />
qui le corrispondeze geografico-ambientali con <strong>la</strong> «Naval» sono fin troppo evidenti:<br />
lo scontro, com’è noto, si tenne nello specchio d’acqua delimitato dalle<br />
Isole Curzo<strong>la</strong>ne <strong>di</strong> fronte alle coste dalmate –, dall’altro, <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>la</strong>scerà <strong>la</strong><br />
sua macabra scia <strong>di</strong> sangue da una parte e dall’altra e si vedrà «il mar farsi vermiglio»,<br />
secondo il celebre topos dell’Apocalisse che descrive <strong>la</strong> tramutazione<br />
in sangue delle acque marine (Ap. 11: 6 e 16: 3). E <strong>per</strong> quest’ultimo aspetto<br />
recu<strong>per</strong>iamo, tra i molti, ancora dei versi che testimoniano <strong>la</strong> durezza e <strong>la</strong> ferocia<br />
del pur vittorioso scontro:<br />
Tutto fù il mar co<strong>per</strong>to in vista fiera<br />
d’hostil sangue, & <strong>di</strong> corpi, in cui ciascuna<br />
spada stimò pietà l’essere crudele.<br />
(vv. 55-57) 45 .<br />
Come abbiamo evidenziato in precedenza, se i vari principi cristiani sono<br />
rappresentati attraverso le icone più appropriate al<strong>la</strong> loro tra<strong>di</strong>zione e <strong>di</strong>gnità,<br />
44 M. G. ZAROTTO, S’ode muggir il mostro d’Oriente, in Sonetti <strong>di</strong> M. Gio. Zarotto Iustinopolitano,<br />
sopra <strong>la</strong> guerra turchesca. In allegrezza del<strong>la</strong> felicissima vittoria navale. Con<br />
l’essortatione fatta all’Imp. Acciò S. Maestà Cesarea entri in lega, Venezia, Onofrio Farri,<br />
1572.<br />
45 C. MAGNO, La bel<strong>la</strong> et dotta canzone..., cit.<br />
114
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
anche i Turchi nell’immaginario dell’Europa occidentale, e in quello <strong>di</strong> queste<br />
<strong>rime</strong> in partico<strong>la</strong>re, quando non sono accostati a bestie feroci, vengono identificati<br />
<strong>per</strong> mezzo del<strong>la</strong> luna, del «maligno pianeta». E tale simbologia “lunare” si<br />
adatta al<strong>la</strong> <strong>per</strong>fezione alle modalità rappresentative e alle esigenze ideologiche<br />
che animano le composizioni poetiche <strong>per</strong> <strong>la</strong> «Naval». Per prima cosa, <strong>la</strong> luna è<br />
a tutti gli effetti un elemento presente all’interno del libro dell’Apocalisse, e<br />
proprio in re<strong>la</strong>zione alle ragioni profonde del testo l’astro assume una forte connotazione<br />
negativa: <strong>la</strong> donna, che interviene quale figura salvifica dopo le sette<br />
trombe che hanno sconvolto l’or<strong>di</strong>ne del mondo, appare vestita <strong>di</strong> sole e con <strong>la</strong><br />
luna sotto i suoi pie<strong>di</strong>. La «Luna», nell’o<strong>per</strong>a <strong>di</strong> Giovanni <strong>di</strong> Pathmos, allude<br />
<strong>per</strong>ciò ai seguaci del<strong>la</strong> Bestia, ai nemici <strong>di</strong> Dio, generalmente allegorizzato dal<br />
Sole proprio <strong>per</strong>ché immagine che richiama fulgore e potenza. In secondo<br />
luogo, e in termini <strong>di</strong> più imme<strong>di</strong>ata riconoscibilità, <strong>la</strong> (mezza)luna campeggiava<br />
da secoli sul<strong>la</strong> ban<strong>di</strong>era dell’Im<strong>per</strong>o Ottomano, <strong>la</strong> cui mera vista atterriva<br />
ormai da generazioni le regioni che venivano investite <strong>per</strong> terra e <strong>per</strong> mare dalle<br />
incursioni degli «Infedeli». Circostanza, quest’ultima, che confermava purtroppo<br />
<strong>per</strong>fettamente <strong>la</strong> tra<strong>di</strong>zionale equazione biblica «Sole:Bene=Luna:Male».<br />
Pertanto, l’associazione simbolica del<strong>la</strong> luna all’Is<strong>la</strong>m – in questa duplice valenza<br />
militare ed etnico-religiosa – rientrava <strong>per</strong>fettamente <strong>nelle</strong> logiche del<strong>la</strong> propaganda<br />
ufficiale e del<strong>la</strong> celebrazione poetica dei fatti <strong>di</strong> Lepanto. Solo <strong>per</strong><br />
riportare un paio <strong>di</strong> esempi tratti da un panorama piuttosto vasto e <strong>di</strong>fferenziato,<br />
nel<strong>la</strong> già menzionata Canzone in <strong>la</strong>ude et honore del s. don Giouanni d’Austria,<br />
l’anonimo autore loda il supremo comandante dell’impresa motivando l’elogio<br />
in questo modo:<br />
[...]<br />
<strong>per</strong>ché tu sol le corna<br />
<strong>di</strong> sì maligna Luna<br />
ecclisserai dopo tante ruine,<br />
con dar meglior Fortuna<br />
al principio del mondo, al mezzo, e al fine.<br />
(vv. 108-112) 46 .<br />
E a questi versi affianchiamo ancora quelli <strong>di</strong> Celio Magno, il quale senza<br />
dubbio riveste un ruolo para<strong>di</strong>gmatico in quanto alle strategie retoriche e alle<br />
procedure poetiche investite nel<strong>la</strong> consacrazione del<strong>la</strong> «Naval». Questi, secondo<br />
<strong>la</strong> consueta prospettiva simbolica (Luna=Im<strong>per</strong>o Ottomano), così commenta<br />
i meriti dei protagonisti dell’«Armata Christiana» e <strong>la</strong> conseguente sconfitta<br />
dei Turchi:<br />
46 Canzone in <strong>la</strong>ude et honore del s. don Giouanni d’Austria..., cit. Corsivo mio.<br />
115
Matteo Lefèvre<br />
Ma Pietro, & col Leon, l’Aqui<strong>la</strong> Hispana<br />
che contra l’Ottomana<br />
forza sì stretti il ciel pietoso unio;<br />
spinte ver lui l’invitte armate vele;<br />
fiaccaro i corni a <strong>la</strong> su<strong>per</strong>ba Luna,<br />
e strage fer de <strong>la</strong> nemica schiera.<br />
[...]<br />
Così giacque il nemico empio infedele,<br />
et vittoria dal ciel con preste penne<br />
a far d’huomini Dei <strong>per</strong> merto venne.<br />
(vv. 49-60) 47 .<br />
Nel testo giovanneo, dopo <strong>la</strong> drammatica ma necessaria e vittoriosa <strong>battaglia</strong><br />
del Bene contro il Male, il veggente <strong>di</strong> Pathmos ha <strong>la</strong> visione <strong>di</strong> «un nuovo cielo<br />
e una nuova terra», dove non saranno più né morte né affanni (Ap. 21: 1-4).<br />
Giovanni può annunciare l’avvento del Regno <strong>di</strong> Dio, profetizzato in lungo e in<br />
<strong>la</strong>rgo all’interno del Vecchio Testamento, e <strong>la</strong> nuova e santa città che scorge è <strong>la</strong><br />
«Gerusalemme celeste», adornata <strong>di</strong> oro e pietre preziose e in cui scorre «un<br />
fiume d’acqua viva e limpida come cristallo» (Ap. 22: 1) scaturito <strong>di</strong>rettamente<br />
dal trono dell’Altissimo. La visione giovannea contemp<strong>la</strong> infine anche alberi<br />
fruttuosi e rigogliosi e denota un clima <strong>di</strong> profonda e definitiva felicità: insomma,<br />
dopo lo scontro finale, <strong>la</strong> vittoria dell’Onnipotente dà inizio a una nuova era<br />
<strong>di</strong> pace, pienezza e pros<strong>per</strong>ità. Siamo <strong>di</strong> fronte a un altro motivo ricorrente che<br />
contrad<strong>di</strong>stingue in maniera decisiva le <strong>rime</strong> <strong>per</strong> il successo cristiano a Lepanto;<br />
ai cantori del<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong>, così attenti a sfruttare l’immaginario apocalittico <strong>nelle</strong><br />
proprie imprese poetiche, il carico <strong>di</strong> s<strong>per</strong>anza insito nel<strong>la</strong> profezia <strong>di</strong> Giovanni<br />
non può sfuggire: Satana è sconfitto, e con lui tutte le sue pompe, seduzioni e<br />
illusioni, e si annuncia in <strong>per</strong>petuum un’epoca felice, una sorta <strong>di</strong> Para<strong>di</strong>so in<br />
terra. Quasi tutte le liriche, sia sul fronte italiano che spagnolo, riconoscono<br />
infatti un’assoluta centralità tematica proprio all’annuncio-rive<strong>la</strong>zione – all’apocalisse<br />
appunto – <strong>di</strong> un’«età novel<strong>la</strong>», che secondo il volere del<strong>la</strong> Provvidenza<br />
<strong>di</strong>vina succede allo scontro epocale tra Bene e Male. Il che, riportato all’interno<br />
del tempo storico, <strong>per</strong> i poeti che vissero gli avvenimenti o quantomeno il clima<br />
del<strong>la</strong> «Naval» equivaleva a pronosticare, anzi a constatare, nei giorni successivi<br />
a quel fati<strong>di</strong>co 7 ottobre del 1571, l’avvento <strong>di</strong> una nuova epoca <strong>di</strong> pace <strong>per</strong> le<br />
potenze cristiane, epoca che faceva ad<strong>di</strong>rittura rinver<strong>di</strong>re i fasti – <strong>per</strong> <strong>la</strong> verità un<br />
po’ fuori tempo – del sogno universalistico, già <strong>di</strong> Carlo V e ora <strong>di</strong> Filippo II,<br />
47 C. MAGNO, La bel<strong>la</strong> et dotta canzone..., cit. Corsivo mio. Come anche nei versi citati<br />
in precedenza, <strong>la</strong> Luna, proprio in quanto astro maligno e <strong>di</strong>abolico, in analogia con le<br />
descrizioni del Drago e del<strong>la</strong> Bestia nel Libro dell’Apocalisse, è dotata frequentemente <strong>di</strong><br />
corna.<br />
116
che auspicava l’avvento <strong>di</strong> un unico «pastore» che reggesse le sorti del mondo<br />
nel nome <strong>di</strong> Cristo. La cronaca si inserisce nel tessuto misterioso dell’eternità:<br />
un’umanità – e una civiltà – che si vedeva <strong>di</strong> fronte all’abisso dei tempi, allo<br />
scontro più importante <strong>per</strong> <strong>la</strong> sua medesima esistenza, <strong>per</strong>cepisce ora <strong>di</strong> essere<br />
nel mezzo del<strong>la</strong> plenitudo temporis; un’armata <strong>di</strong> nazioni fiaccate dai vizi dei<br />
loro stessi sovrani, dagli o<strong>di</strong> e dalle invi<strong>di</strong>e seco<strong>la</strong>ri si re<strong>di</strong>me – potere del<strong>la</strong><br />
<strong>di</strong>plomazia e del<strong>la</strong> paura... – e ottiene l’appoggio <strong>di</strong> Dio nel conflitto finale contro<br />
gli «Infedeli». Come aveva scritto Giovanni: «[...] <strong>la</strong> bestia fu catturata e con<br />
essa il falso profeta» (Ap. 19: 20); e quale più <strong>per</strong>fetto e preciso rife<strong>rime</strong>nto a<br />
Maometto e alle sue «rie ed empie genti»?<br />
Tra le pagine <strong>di</strong> canzonieri e miscel<strong>la</strong>nee destinati al<strong>la</strong> celebrazione del<strong>la</strong><br />
«Naval» l’annuncio del<strong>la</strong> nascita <strong>di</strong> un’età nuova occupa dunque le energie <strong>di</strong><br />
tutti i rimatori. Soprattutto, si sottolinea il contrasto tra l’oppressione dei tempi<br />
passati e il nuovo clima <strong>di</strong> pace e ottimismo post eventum. Giovan Battista<br />
Amaltheo, ad esempio, nel<strong>la</strong> già ricordata canzone All’Illustriss.mo et<br />
Eccellent.mo Sig. marc’Antonio Colonna, <strong>di</strong> qualità poetica nettamente su<strong>per</strong>iore<br />
a molte <strong>di</strong> queste liriche, al <strong>di</strong> là del<strong>la</strong> ripresa dei consueti topoi generali – in<br />
partico<strong>la</strong>re quelli riservati al<strong>la</strong> figura del Colonna, con <strong>la</strong> sottolineatura del<br />
gioco fonico e simbolico del<strong>la</strong> «colonna» che sostiene il peso dell’impresa –<br />
sembra voler offrire al lettore un quadro analitico del<strong>la</strong> situazione generale<br />
prima e dopo Lepanto:<br />
Prima:<br />
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
Da l’Oriente più non venia’l Sole<br />
né’l pianeta d’amor, né i chiari giorni,<br />
ma <strong>di</strong> turbati venti atra procel<strong>la</strong>,<br />
et havea sgombre l’herbe, e le viole<br />
da i nostri <strong>di</strong>lettosi almi soggiorni,<br />
e tenea fosco il Ciel, chiusa ogni Stel<strong>la</strong><br />
Nebbia gravosa, e fel<strong>la</strong>,<br />
e s’alcuna talhor pur n’apparea,<br />
era importuna e rea,<br />
[...]<br />
e in verno era cangiata primavera.<br />
(vv. 14-26)<br />
Dopo:<br />
[...]<br />
e rivedran le Muse i sacri monti,<br />
e i lor cigni, e i lor fonti,<br />
gli antri, le piaggie, i fior, l’ombre, e gli allori<br />
(vv. 88-90)<br />
Al <strong>per</strong>iodo precedente al<strong>la</strong> vittoria corrisponde <strong>la</strong> descrizione <strong>di</strong> un mondo<br />
buio e cupo, agitato da una tempesta meteorologica e morale in cui anche <strong>la</strong><br />
natura è schiacciata dal<strong>la</strong> presenza del Male nel mondo; al contrario, <strong>la</strong> nova<br />
aetas, con i partico<strong>la</strong>ri del<strong>la</strong> rinascita naturale, propone un universo fresco e rin-<br />
117
Matteo Lefèvre<br />
novato, un clima sereno – anche qui sia in senso “naturalistico” che morale –<br />
che richiama da vicino il topos del locus amoenus. Proprio questo motivo, che<br />
con le sue varie sfumature domina l’universo c<strong>la</strong>ssicistico <strong>per</strong> tutto il secolo,<br />
offre un rife<strong>rime</strong>nto forte ai cantori dell’età nuova e del<strong>la</strong> rinascita del mondo<br />
cristiano in seguito al<strong>la</strong> provvidenziale vittoria. E come Giovanni proc<strong>la</strong>mava<br />
l’avvento del<strong>la</strong> Gerusalemme celeste in quanto luogo <strong>di</strong> eternità felice, così i<br />
poeti spagnoli e italiani cantano <strong>di</strong> un mondo rinnovato e pacificato, in armonia<br />
con <strong>la</strong> natura umana e <strong>di</strong>vina delle cose.<br />
Gabriele Fiamma, ad esempio, nell’intento <strong>di</strong> lodare il Signore a seguito<br />
del<strong>la</strong> vittoria nel<strong>la</strong> «Naval», riscrive vari salmi biblici <strong>di</strong> ringraziamento che<br />
alludono esplicitamente al<strong>la</strong> forza dell’Onnipotente al<strong>la</strong> guida del suo «gregge»<br />
e che si inseriscono in modo <strong>per</strong>fetto all’interno del<strong>la</strong> sfera etico-filosofica del<strong>la</strong><br />
renovatio. In partico<strong>la</strong>re, nel<strong>la</strong> prima delle due ottave del Salmo CL, così scrive<br />
Fiamma:<br />
La Gloria <strong>di</strong> colui che’l mondo regge<br />
cantate nel suo illustre, e santo albergo,<br />
voi, che sete il suo caro amato gregge;<br />
[...]<br />
<strong>di</strong>te <strong>la</strong> forza sua, <strong>la</strong> maestade:<br />
<strong>per</strong>ché l’inunda <strong>la</strong> futura etade.<br />
(vv. 1-3 e 7-8) 48 .<br />
E nel<strong>la</strong> successiva «parafrasi», il poeta delle Rime spirituali annuncia l’avvento<br />
<strong>di</strong> un’età nuova, ricca <strong>di</strong> pace e pros<strong>per</strong>ità e sorvegliata dallo sguardo<br />
<strong>di</strong>vino. Dopo lo scontro tra Bene e Male, tra Cristiani e «Infedeli», il «Re immortale»<br />
118<br />
[...]<br />
darà il suo arbitrio giusto,<br />
al mondo legge e norma;<br />
il Ciel <strong>di</strong> pace onusto,<br />
prenderà lieta forma;<br />
farà festa <strong>la</strong> terra,<br />
il salso regno, e quel ch’ei chiude e serra.<br />
Fiorito e verde il crine,<br />
gli arbori havranno tutti;<br />
le tempeste e le brine,<br />
non torran loro i frutti;<br />
poi ch’ei regnante viene,<br />
48 G. FIAMMA, La Gloria <strong>di</strong> colui che’l mondo regge, in Id., Parafrasi poetica sopra alcuni<br />
Salmi <strong>di</strong> David Profeta..., cit., p. 26r.
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
e già del mondo ormai lo scettro tiene.<br />
Ovunque <strong>la</strong> terrena<br />
gente ha matino e sera;<br />
farà giustitia piena,<br />
con ferma fede intera,<br />
populo alcun non fia,<br />
che così dal Signor retto non sia.<br />
(vv. 55-72) 49 .<br />
Del resto, <strong>la</strong> reve<strong>la</strong>tio, appunto l’annuncio del<strong>la</strong> nascita <strong>di</strong> un’era nuova e<br />
felice – con il pendant già ricordato, e fin troppo abusato sul piano del<strong>la</strong> propaganda<br />
politica, <strong>di</strong> «un pastore e un ovile» – appare come un minimo comun<br />
denominatore <strong>di</strong> tutte le liriche che celebrano <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto: secondo<br />
<strong>la</strong> prospettiva <strong>apocalittica</strong>, lo scontro epocale e definitivo, storico eppure<br />
ultramondano, non può non presupporre successivamente l’avvento del<strong>la</strong> nova<br />
aetas. Giovanni Maria Ver<strong>di</strong>zotti, ad esempio, nel<strong>la</strong> sua Nova, & Dotta canzone<br />
nel<strong>la</strong> Gloriosa Vittoria contra Turchi proc<strong>la</strong>ma ad<strong>di</strong>rittura un ritorno<br />
dell’«età dell’oro»:<br />
Hor ch’i dì tristi, e negri<br />
sen vanno; hor ch’à noi torna<br />
l’età de l’oro, e l’alma pace prima:<br />
porta in questo, e’n quel clima<br />
l’alta nova Vittoria,<br />
i gran<strong>di</strong> honor concessi,<br />
gli ampi Regni promessi<br />
[...]<br />
(vv. 4-10) 50 .<br />
E <strong>la</strong> profezia <strong>apocalittica</strong> dell’avvento del Regnum Dei è riba<strong>di</strong>ta anche nel<strong>la</strong><br />
Canzone al Serenissimo Sig. D. Giovanni d’Austria Generale dell’Armata del<strong>la</strong><br />
Santissima Lega: qui, in partico<strong>la</strong>re, l’autore fonde insieme <strong>di</strong>versi motivi – da<br />
quelli del locus amoenus a quelli dell’ortodossia, culminanti nel<strong>la</strong> visione del<strong>la</strong><br />
Gerusalemme celeste – che comunque col<strong>la</strong>borano tutti al<strong>la</strong> definizione<br />
dell’«età beata» in seguito al<strong>la</strong> vittoria sui Turchi:<br />
[...]<br />
sarà tra noi de l’or l’età beata,<br />
che da tutte le Gratie accompagnata<br />
gioir farà <strong>di</strong> tutti i beni il Mondo.<br />
49 G. FIAMMA, Del gran Fattor’eterno, ivi, p. 26v.<br />
50 [G. M. VERDIZOTTI], Nova, & Dotta canzone nel<strong>la</strong> Gloriosa Vittoria contra Turchi,<br />
Venezia, Giorgio Angelieri, 1571.<br />
119
Matteo Lefèvre<br />
E <strong>la</strong> Vergine Astrea dal Ciel <strong>di</strong>scesa<br />
Caccierà i vitii de l’Inferno al fondo:<br />
e regnerà <strong>la</strong> Pace, e <strong>la</strong> Bontade.<br />
O fortunata etade.<br />
D’haver soverchio allhor cieco appetito<br />
non trarrò l’huomo à <strong>per</strong>igliosa impresa:<br />
né il troppo ardor <strong>la</strong> State, ò’l ghiaccio il Verno<br />
sarà d’oltraggio: correranno i fiumi<br />
<strong>di</strong> nettare, e <strong>di</strong> <strong>la</strong>tte in ogni riva:<br />
stilleran mel le quercie: e i lupi appresso<br />
gli agnelli havranno in pace un nido stesso:<br />
né produrran più l’herbe alcun veleno:<br />
che in buoni cangeransi i rei costumi<br />
d’ogni elemento: e con <strong>per</strong>petuo rito<br />
il Mondo fia senza <strong>di</strong>fetto alcuno,<br />
e, quasi una Città patria d’ognuno.<br />
(vv. 177-195) 51 .<br />
La giornata <strong>di</strong> Lepanto sembra segnare un autentico spartiacque tra un’era <strong>di</strong><br />
dolore, paura e sofferenza e l’inizio <strong>di</strong> una «fortunata etade»: <strong>per</strong> questa ragione<br />
molti poeti insistono nel sottolineare, in <strong>per</strong>fetto stile petrarchista, il giorno,<br />
l’ora, il luogo dello scontro come elementi ormai stabili <strong>di</strong> una data cruciale<br />
sotto il profilo storico e metastorico. Nel<strong>la</strong> già ricordata e adespota canzone «Al<br />
Santiss. Sig. Papa Pio V» il giorno del<strong>la</strong> vittoria inaugura una cesura epocale<br />
che sancisce <strong>la</strong> sconfitta definitiva del male nel mondo:<br />
120<br />
Che più, che più resta à temerne hormai?<br />
O quanto fia questa Vittoria lieta,<br />
<strong>di</strong> cui termine & meta<br />
fia l’Oceano intorno, & quanto il Sole<br />
vede de l’ampia mole<br />
de <strong>la</strong> terra, & de l’onde.<br />
[...]<br />
Nel mille cinquecento e settant’uno,<br />
il dì sette d’Ottobre, a l’hora quinta;<br />
fu l’Idra presa e vinta,<br />
che ne l’Ambracio seno ascosa giacque,<br />
et con mille catene insieme avvinta.<br />
(vv. 104-115) 52 .<br />
51 Dagli antri ascosa hor fuori à l’aria sorgi («Canzone al Serenissimo Sig. D. Giovanni<br />
d’Austria Generale dell’Armata del<strong>la</strong> Santissima Lega»), ivi, pp. 69r-69v.<br />
52 Almo spirto d’Amor, Bontade eterna..., cit., pp. 17v-18r.
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
La precisione del<strong>la</strong> data e <strong>per</strong>fino dell’ora del<strong>la</strong> «Naval», dunque, fa pensare<br />
alle in<strong>di</strong>cazioni profetiche del<strong>la</strong> Bibbia, all’ineluttabilità con cui <strong>la</strong> Provvidenza<br />
<strong>di</strong>vina si manifesta nel<strong>la</strong> storia dell’uomo mo<strong>di</strong>ficando<strong>la</strong> in modo incontrovertibile.<br />
Il giorno del<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto equivale a un giorno del giu<strong>di</strong>zio, il cui<br />
responso positivo promette un’era <strong>di</strong> pace e libertà.<br />
Nel<strong>la</strong> Canzone <strong>di</strong> Andrea Brabante Rho<strong>di</strong>gino, <strong>la</strong> descrizione del<strong>la</strong> nova<br />
aetas seguita al conflitto si attiene invece scrupolosamente ai parametri del<strong>la</strong><br />
rappresentazione c<strong>la</strong>ssica, topica, dell’età dell’oro:<br />
Ride l’Aria, <strong>la</strong> Terra, il Cielo, e i mari;<br />
i fiumi corrono mansueti e chiari<br />
<strong>di</strong> ricche gemme il fondo ornati, e d’oro;<br />
tutti i dumi amorose<br />
hanno viole, acantho, gigli, e rose.<br />
(vv. 103-107) 53 .<br />
E in un’altra canzone <strong>di</strong> questa stessa miscel<strong>la</strong>nea Arca<strong>di</strong>a sembra aver trovato<br />
nuovo spazio sul<strong>la</strong> terra mentre il trionfo <strong>di</strong> una natura rigogliosa annuncia<br />
una «<strong>per</strong>petua primavera» <strong>per</strong> tutta l’Europa cristiana sotto gli auspici <strong>di</strong> papa<br />
Pio V:<br />
Hor, sotto i santi suoi sacrati auspici,<br />
torna il dolce giocondo secol d’oro,<br />
che i dì <strong>rime</strong>na, & le notti felici,<br />
carchi <strong>di</strong> verde alloro,<br />
nel suo mese Natale hai <strong>la</strong> Vittoria,<br />
ond’Illustre sormonti à tanta gloria,<br />
le rose poi, che d’or<strong>di</strong>ne del cielo,<br />
nel suo scudo <strong>di</strong>pinse eterna mano<br />
<strong>di</strong>mostrarono al mondo <strong>di</strong> lontano<br />
quel ch’or le rose, tra <strong>la</strong> neve, e’l gelo,<br />
mostran da presso; & è, che gioia intera<br />
ti promette <strong>per</strong>petua primavera.<br />
(vv. 97-108) 54 .<br />
Sul fronte spagnolo i rimatori che impegnano le proprie energie nel<strong>la</strong> celebrazione<br />
del<strong>la</strong> vittoriosa <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto si soffermano anch’essi sul<strong>la</strong> presa<br />
<strong>di</strong> coscienza del<strong>la</strong> nascita <strong>di</strong> un’«età novel<strong>la</strong>», ma <strong>per</strong> lo più preferiscono mettere<br />
in evidenza i meriti del proprio sovrano, Filippo II, e del suo valoroso fratel-<br />
53 Dive che’l sacro e venerando colle («Canzone <strong>di</strong> Andrea Brabante Rho<strong>di</strong>gino»), in<br />
Raccolta <strong>di</strong> varii poemi Latini, Greci, e Volgari..., cit, p. 30r.<br />
54 La Vergine, che d’Adria nel mar siede, ivi, pp. 32r-32v.<br />
121
Matteo Lefèvre<br />
lo, don Juan de Austria. Se i poeti italiani cantano <strong>di</strong> un mondo rinnovato, <strong>di</strong><br />
una sorta <strong>di</strong> Para<strong>di</strong>so terrestre in cui è Dio stesso a garantire pace e benessere, i<br />
letterati iberici attribuiscono <strong>per</strong> lo più queste virtù <strong>di</strong> sorveglianza e giusta<br />
“amministrazione” – ovviamente sempre su provvidenziale commissione <strong>di</strong>vina<br />
– al proprio monarca, che vantava un curriculum ben assortito in fatto <strong>di</strong> lotta<br />
contro i nemici del<strong>la</strong> cristianità. Se infatti Fernando de Herrera, mantenendo il<br />
consueto tono alto e solenne, inaugura <strong>la</strong> sua Canción 55 con due versi che<br />
appaiono inneggiare <strong>di</strong>rettamente all’Onnipotente e inquadrano <strong>la</strong> canzone in<br />
una prospettiva da salmo <strong>di</strong> ringraziamento:<br />
Cantemos al Señor, que en <strong>la</strong> l<strong>la</strong>nura<br />
venció del mar al enemigo fiero<br />
(vv. 1-2),<br />
dal canto suo e in modo più esplicito Francisco de Aldana conferma tale pre<strong>di</strong>lezione<br />
<strong>per</strong> il proprio sovrano proponendo, in un famoso sonetto <strong>per</strong> <strong>la</strong><br />
«Naval» (Al Rey don Felipe, Nuestro Señor), un elogio <strong>di</strong> Filippo II orientato<br />
sostanzialmente a confermare <strong>la</strong> missione <strong>di</strong> quest’ultimo quale unico e fidato<br />
guar<strong>di</strong>ano del gregge <strong>di</strong> Dio sul<strong>la</strong> terra:<br />
Desde <strong>la</strong> eternidad, antes que el cielo<br />
amaneciese al mundo el p<strong>rime</strong>r día,<br />
nombrado, ¡oh gran Felipe!, Dios te había<br />
por rey universal de todo el suelo;<br />
y así como esparció con tanto celo<br />
Bautista <strong>la</strong> venida del Mesía,<br />
así ora Juan de un polo al otro envía,<br />
tras su fama inmortal, tu cetro a vuelo.<br />
Ha seis mil años casi que camina<br />
el mundo con el tiempo, a consagrarte<br />
<strong>la</strong> grey <strong>di</strong>versa reducida en una.<br />
¡Oh cómo en tí paró <strong>la</strong> edad más <strong>di</strong>na<br />
bien <strong>di</strong>namente, y va tras tu estandarte<br />
<strong>la</strong> gente, el mundo, el tiempo y <strong>la</strong> fortuna 56 .<br />
E tutto questo spiegamento <strong>di</strong> forze retoriche, che continuano organicamente<br />
il <strong>la</strong>voro <strong>di</strong> quelle militari, non fa altro che confermare ancora una volta, sul<br />
piano del<strong>la</strong> propaganda, il tentativo <strong>di</strong> aggiornamento dell’ormai decennale – e<br />
frustrata – tesi politica del<strong>la</strong> riunificazione <strong>di</strong> tutta <strong>la</strong> cristianità – o almeno <strong>di</strong><br />
55 F. de HERRERA, Cantemos al Señor..., cit.<br />
56 F. de ALDANA, Desde <strong>la</strong> eternidad, antes que el cielo (LII), in ID., Poesías castel<strong>la</strong>nas<br />
completas, cit., pp. 381-382.<br />
122
<strong>Immaginario</strong> e <strong>ideologia</strong> <strong>apocalittica</strong> <strong>nelle</strong> <strong>rime</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto<br />
quel<strong>la</strong> <strong>di</strong>sponibile dopo Trento... – sotto un solo monarca che governasse appunto<br />
secondo i principi cristiani.<br />
Nonostante l’apocalisse lepantina e <strong>la</strong> campagna “me<strong>di</strong>atica” intrapresa <strong>per</strong><br />
<strong>la</strong> celebrazione dell’evento, l’auspicato annuncio del<strong>la</strong> «fine dei tempi» e dell’avvento<br />
<strong>di</strong> una nuova epoca felice non sembrò tuttavia ottenere conferma nel<strong>la</strong><br />
realtà. La propaganda, con tutte le sfumature e le parzialità del caso, fece il suo<br />
dovere, ma le nazioni cristiane non si videro presto riunite e custo<strong>di</strong>te sotto<br />
un’unica a<strong>la</strong> protettrice; al contrario, nuovi e consueti <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong> agitarono le<br />
coscienze <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>ti e sovrani e smagliarono rapidamente <strong>la</strong> rete <strong>di</strong>plomatica<br />
così abilmente intessuta nei mesi precedenti <strong>la</strong> «Naval». Inoltre, l’Im<strong>per</strong>o ottomano,<br />
il presunto esercito del Male, lungi dall’essere definitivamente sconfitto,<br />
non tardò a rialzare <strong>la</strong> testa e già negli anni seguenti ricominciò a turbare i sonni<br />
degli umili e dei potenti d’Europa sia lungo le coste che nell’entroterra. Se i<br />
nemici storici del<strong>la</strong> cristianità venivano in<strong>di</strong>viduati fin dagli anni <strong>di</strong> Carlo V, da<br />
un <strong>la</strong>to, nello scisma protestante, dall’altro, nell’Im<strong>per</strong>o turco, gli anni imme<strong>di</strong>atamente<br />
successivi al<strong>la</strong> <strong>battaglia</strong> <strong>di</strong> Lepanto <strong>di</strong>mostrarono come i «Principi christiani»<br />
del secondo cinquecento non solo non avessero risolto i problemi né sull’uno<br />
né sull’altro fronte, ma neppure quelli interni ai propri insicuri confini.<br />
Sorvo<strong>la</strong>ndo sui vari episo<strong>di</strong> del<strong>la</strong> riscossa turca, <strong>la</strong> cattolica Spagna si impe<strong>la</strong>gò<br />
<strong>di</strong> lì a poco in un’altra crociata <strong>di</strong> carattere ideologico – ma che in realtà era<br />
anch’essa, e forse soprattutto, <strong>di</strong> natura economico-strategica – contro <strong>la</strong> scismatica<br />
Inghilterra dell’audace Elisabetta I, crociata dal<strong>la</strong> quale uscì <strong>di</strong>ssanguata<br />
su tutti i fronti, da quello economico a quello del prestigio internazionale. Gli<br />
stati italiani, da Firenze a Venezia allo Stato pontificio, anche se non conobbero<br />
un’autentica destabilizzazione dovuta al<strong>la</strong> <strong>di</strong>ffusione delle idee del<strong>la</strong> Riforma,<br />
mostrando fedeltà al<strong>la</strong> propria tra<strong>di</strong>zione riattizzarono tempestivamente il braciere<br />
del<strong>la</strong> <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>a. La Francia, governata fino a un paio <strong>di</strong> decenni prima <strong>di</strong><br />
Lepanto da un «Re cristianissimo», fu invece investita con violenza inau<strong>di</strong>ta dal<br />
conflitto politico-religioso tra il partito cattolico e quello ugonotto <strong>per</strong> <strong>la</strong> successione<br />
al trono. E i territori tedeschi, che già conoscevano da qualche decennio<br />
vantaggi e svantaggi dell’eterogeneità religiosa e giuri<strong>di</strong>ca, continuarono ognuno<br />
<strong>per</strong> <strong>la</strong> propria strada con una politica a seconda dei casi anti- o filoim<strong>per</strong>iale,<br />
che comunque avrebbe condotto tutti, alcuni decenni dopo, al<strong>la</strong> Guerra dei<br />
Trent’anni.<br />
Un’Europa <strong>di</strong>visa e frammentata, dunque: <strong>la</strong> stessa eco del<strong>la</strong> propaganda <strong>di</strong><br />
Lepanto e dell’«Armata Christiana» si esaurì molto presto. E così bastarono<br />
pochi anni, mesi forse, <strong>per</strong>ché le acque delle Isole Curzo<strong>la</strong>ne che tanto erano<br />
apparse calme dopo <strong>la</strong> «Naval» riprendessero ad agitarsi e a riportare in su<strong>per</strong>ficie<br />
le ataviche debolezze e gli antichi torbi<strong>di</strong> del<strong>la</strong> politica <strong>di</strong> un Vecchio<br />
Continente tutt’altro che pacificato e tutt’altro che “cristiano”.<br />
123