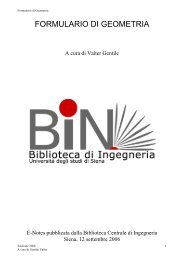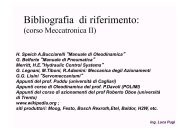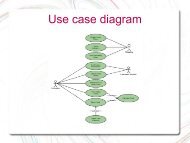discarica - Ingegneria - Università degli Studi di Siena
discarica - Ingegneria - Università degli Studi di Siena
discarica - Ingegneria - Università degli Studi di Siena
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Facoltà <strong>di</strong> <strong>Ingegneria</strong> – <strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Siena</strong><br />
Laurea Magistrale in “<strong>Ingegneria</strong> Gestionale”<br />
Corso <strong>di</strong><br />
Gestione dei Servizi e delle Tecnologie<br />
Ambientali (GS&TA)<br />
TRATTAMENTO A DISCARICA<br />
Prof. Ing. Andrea Corti (corti@<strong>di</strong>i.unisi.it)<br />
Ing. Isabella Pecorini (isabella.pecorini@pin.unifi.it)
Parte 3 - TRATTAMENTO A DISCARICA<br />
Contenuti<br />
1.D.Lgs 152/06 e smi<br />
2.D.Lgs 36/2003 e Criteri realizzativi e<br />
gestionali delle <strong>di</strong>scariche<br />
3.Definizione dei criteri <strong>di</strong><br />
ammissibilità dei rifiuti in <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
4.Piani sorveglianza e controllo –<br />
Biogas e Percolato
Facoltà <strong>di</strong> <strong>Ingegneria</strong> – <strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Siena</strong><br />
Laurea Magistrale in “<strong>Ingegneria</strong> Gestionale”<br />
Sezione 1<br />
D.Lgs 152/06 e smi
SECONDO CORRETTIVO TUA<br />
PRIMO CORRETTIVO TUA<br />
AUTORIZZAZIONI<br />
TUA<br />
CRITERI DI AMMISSIBILITà<br />
DISCARICHE<br />
Pronta dal 1991 è approvata solo del<br />
1999<br />
Quadro normativo<br />
Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59<br />
Attuazione <strong>di</strong> obblighi comunitari ed esecuzione <strong>di</strong> sentenze della<br />
Corte <strong>di</strong> giustizia Ue - Acque - Discariche rifiuti - Raee - Veicoli<br />
fuori uso - Stralcio<br />
Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4<br />
Ulteriori <strong>di</strong>sposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile<br />
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale<br />
Dm Ambiente 29 gennaio 2007<br />
Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'in<strong>di</strong>viduazione e<br />
l'utilizzazione delle migliori tecniche <strong>di</strong>sponibili, in materia <strong>di</strong><br />
gestione dei rifiuti<br />
Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59<br />
Norme in materia <strong>di</strong> autorizzazione integrata ambientale<br />
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152<br />
Norme in materia ambientale - Stralcio - Gestione dei rifiuti e<br />
bonifica dei siti inquinati<br />
Dm Ambiente 3 agosto 2005<br />
Definizione dei criteri <strong>di</strong> ammissibilità dei rifiuti in <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36<br />
Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 1999/31/Ce - Discariche <strong>di</strong> rifiuti<br />
Direttiva Consiglio Ue 1999/31/Ce<br />
Discariche <strong>di</strong> rifiuti<br />
http://www.reteambiente.it/normativa/rifiuti/in<strong>di</strong>ci/vigente/
TESTO UNICO AMBIENTALE E I DECRETI CORRETTIVI<br />
Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4<br />
Ulteriori <strong>di</strong>sposizioni correttive ed integrative del<br />
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in<br />
materia ambientale<br />
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152<br />
Norme in materia ambientale - Stralcio -<br />
Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati<br />
Parte quarta<br />
Norme in materia <strong>di</strong> gestione dei rifiuti e <strong>di</strong><br />
bonifica dei siti inquinati<br />
Mo<strong>di</strong>fiche:<br />
Legge 12 luglio 2006, n. 228 (13-07-2006)<br />
Dl 3 ottobre 2006, n. 262 (03-10-2006)<br />
Dlgs 8 novembre 2006, n. 284 (25-11-2006)<br />
Legge 24 novembre 2006, n. 286 (<strong>di</strong> conversione del Dl<br />
262/2006) (29-11-2006)<br />
Dl 28 <strong>di</strong>cembre 2006, n. 300 (28-12-2006)<br />
Legge 27 <strong>di</strong>cembre 2006, n. 296 (01-01-2007)<br />
Legge 26 febbraio 2007, n. 17 (<strong>di</strong> conversione del Dl 300/2006)<br />
(27-02-2007)<br />
Dpr 14 maggio 2007, n. 90 (25-07-2007)<br />
Dlgs 6 novembre 2007, n. 205 (24-11-2007)<br />
Legge 19 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 243 (<strong>di</strong> conversione del Dl 300/2006)<br />
(28-12-2007)<br />
Dl 31 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 248 (31-12-2007)<br />
Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 (13-02-2008)<br />
Dl 8 aprile 2008, n. 59 (09-04-2008)<br />
Dl 23 maggio 2008, n. 90 (23-05-2008)<br />
Dlgs 30 maggio 2008, n. 117 (22-07-2008)<br />
Dm 16 giugno 2008, n. 131 (26-08-2008)<br />
Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 (18-12-2008)<br />
Dl 30 <strong>di</strong>cembre 2008, n. 208 (31-12-2008)<br />
Legge 30 <strong>di</strong>cembre 2008, n. 205 (<strong>di</strong> conversione del Dl 171/2008)<br />
(31-12-2008)<br />
Legge 30 <strong>di</strong>cembre 2008, n. 210 (<strong>di</strong> conversione del Dl 172/2008)<br />
(04-01-2009)<br />
Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (<strong>di</strong> conversione del Dl 185/2008)<br />
(29-01-2009)<br />
Legge 27 febbraio 2009, n. 13 (02-03-2009)<br />
Dlgs 16 marzo 2009, n. 30 (19-04-2009)<br />
Dm 14 aprile 2009, n. 56 (14-06-2009)<br />
Legge 24 giugno 2009, n. 77 (28-06-2009)<br />
Legge 3 agosto 2009, n. 102 (05-08-2009)<br />
Legge 23 luglio 2009, n. 99 (15-08-2009)<br />
Dl 25 settembre 2009, n. 135 (26-09-2009)
TU - Articolo 183 (Definizioni)<br />
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte<br />
quarta del presente decreto e <strong>di</strong> cui il detentore si <strong>di</strong>sfi o abbia deciso o abbia l'obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sfarsi;<br />
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha<br />
effettuato operazioni <strong>di</strong> pretrattamento, <strong>di</strong> miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la<br />
composizione <strong>di</strong> detti rifiuti;<br />
c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;<br />
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo <strong>di</strong><br />
queste operazioni, nonché il controllo delle <strong>di</strong>scariche dopo la chiusura;<br />
e) raccolta: l'operazione <strong>di</strong> prelievo, <strong>di</strong> cernita o <strong>di</strong> raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;<br />
f) raccolta <strong>di</strong>fferenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche<br />
omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero <strong>di</strong><br />
materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento<br />
riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;<br />
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto;<br />
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto;<br />
omissis<br />
l) stoccaggio: le attività <strong>di</strong> smaltimento consistenti nelle operazioni <strong>di</strong> deposito preliminare <strong>di</strong> rifiuti <strong>di</strong> cui<br />
al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività <strong>di</strong> recupero<br />
consistenti nelle operazioni <strong>di</strong>messa in riserva <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> cui al punto R13 dell'allegato C alla<br />
medesima parte quarta;
Smaltimento - Allegato B - TU<br />
Allegato B<br />
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni <strong>di</strong> smaltimento come avvengono nella<br />
pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare<br />
proce<strong>di</strong>menti o meto<strong>di</strong> che possano recare pregiu<strong>di</strong>zio all'ambiente.<br />
Operazioni <strong>di</strong> smaltimento<br />
D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio <strong><strong>di</strong>scarica</strong>)<br />
D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione <strong>di</strong> rifiuti liqui<strong>di</strong> o fanghi nei suoli)<br />
D3 Iniezioni in profon<strong>di</strong>tà (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie<br />
geologiche naturali)<br />
D4 Lagunaggio (a esempio scarico <strong>di</strong> rifiuti liqui<strong>di</strong> o <strong>di</strong> fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)<br />
D5 Messa in <strong><strong>di</strong>scarica</strong> specialmente allestita (a esempio sistematizzazione in alveoli stagni<br />
separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)<br />
D6 Scarico dei rifiuti soli<strong>di</strong> nell'ambiente idrico eccetto l'immersione<br />
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino<br />
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che <strong>di</strong>a origine a composti o<br />
a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei proce<strong>di</strong>menti elencati nei punti da D1 a D12<br />
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che <strong>di</strong>a origine a<br />
composti o a miscugli eliminati secondo uno dei proce<strong>di</strong>menti elencati nei punti da D1 a D12 (ad<br />
esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)<br />
D10 Incenerimento a terra<br />
D11 Incenerimento in mare<br />
D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione <strong>di</strong> contenitori in una miniera, ecc.)<br />
D13 Raggruppamento preliminare prima <strong>di</strong> una delle operazioni <strong>di</strong> cui ai punti da D1 a D12<br />
D14 Ricon<strong>di</strong>zionamento preliminare prima <strong>di</strong> una delle operazioni <strong>di</strong> cui ai punti da D1 a D13<br />
D15 Deposito preliminare prima <strong>di</strong> una delle operazioni <strong>di</strong> cui ai punti da D1 a D14 (escluso il<br />
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Recupero - Allegato B - TU<br />
Allegato C<br />
Operazioni <strong>di</strong> recupero<br />
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni <strong>di</strong> recupero come avvengono nella<br />
pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza<br />
usare proce<strong>di</strong>menti o meto<strong>di</strong> che possano recare pregiu<strong>di</strong>zio all'ambiente<br />
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia<br />
R2 Rigenerazione/recupero <strong>di</strong> solventi<br />
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le<br />
operazioni <strong>di</strong> compostaggio e altre trasformazioni biologiche)<br />
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici<br />
R5 Riciclo/recupero <strong>di</strong> altre sostanze inorganiche<br />
R6 Rigenerazione <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> o delle basi<br />
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti<br />
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori<br />
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi <strong>degli</strong> oli<br />
R10 Span<strong>di</strong>mento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia<br />
R11 Utilizzazione <strong>di</strong> rifiuti ottenuti da una delle operazioni in<strong>di</strong>cate da R1 a R10<br />
R12 Scambio <strong>di</strong> rifiuti per sottoporli a una delle operazioni in<strong>di</strong>cate da R1 a R11<br />
R13 Messa in riserva <strong>di</strong> rifiuti per sottoporli a una delle operazioni in<strong>di</strong>cate nei punti<br />
da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono<br />
prodotti)
Classificati secondo l'origine<br />
Articolo 184 – Classificazione - TU<br />
1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti<br />
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche <strong>di</strong> pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.<br />
2. Sono rifiuti urbani:<br />
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi a<strong>di</strong>biti ad uso <strong>di</strong> civile abitazione;<br />
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi a<strong>di</strong>biti ad usi <strong>di</strong>versi da quelli <strong>di</strong> cui alla lettera a), assimilati ai<br />
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);<br />
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;<br />
d) i rifiuti <strong>di</strong> qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private<br />
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;<br />
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree ver<strong>di</strong>, quali giar<strong>di</strong>ni, parchi e aree cimiteriali;<br />
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale <strong>di</strong>versi da<br />
quelli <strong>di</strong> cui alle lettere b), c) ed e).<br />
3. Sono rifiuti speciali:<br />
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;<br />
b) i rifiuti derivanti dalle attività <strong>di</strong> demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività <strong>di</strong> scavo,<br />
fermo restando quanto <strong>di</strong>sposto dall'articolo 186;<br />
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);<br />
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;<br />
e) i rifiuti da attività commerciali;<br />
f) i rifiuti da attività <strong>di</strong> servizio;<br />
g) i rifiuti derivanti dalla attività <strong>di</strong> recupero e smaltimento <strong>di</strong> rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri<br />
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento <strong>di</strong> fumi;<br />
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;<br />
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;<br />
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;<br />
m) il combustibile derivato da rifiuti;<br />
n) i rifiuti derivati dalle attività <strong>di</strong> selezione meccanica dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani.
Continua …<br />
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della<br />
tutela del territorio <strong>di</strong> concerto con il Ministro delle<br />
attività produttive si provvede ad istituire l'elenco<br />
dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1,<br />
lettera a), della <strong>di</strong>rettiva 75/442/Ce ed all'articolo<br />
1, paragrafo 4, della <strong>di</strong>rettiva 91/689/Ce, <strong>di</strong> cui<br />
alla decisione della Commissione 2000/532/Ce<br />
del 3 maggio 20007 .<br />
Sino all'emanazione del predetto decreto<br />
continuano ad applicarsi le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui alla<br />
<strong>di</strong>rettiva del Ministro dell'ambiente e della tutela<br />
del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel<br />
Supplemento or<strong>di</strong>nario alla Gazzetta ufficiale n.<br />
108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'allegato D<br />
alla Parte quarta del presente decreto.<br />
5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici in<strong>di</strong>cati<br />
espressamente come tali, con apposito asterisco,<br />
nell'elenco <strong>di</strong> cui all'allegato D alla Parte quarta<br />
del presente decreto, sulla base <strong>degli</strong> Allegati G,<br />
H e I alla medesima parte quarta.<br />
Articolo 184 – Classificazione - TU<br />
CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI (CODICI<br />
C.E.R.)<br />
Il Catalogo Europeo dei Rifiuti è un elenco<br />
armonizzato, non esaustivo, <strong>di</strong> rifiuti, oggetto <strong>di</strong><br />
perio<strong>di</strong>ca revisione. Il CER contiene tutte le<br />
tipologie <strong>di</strong> rifiuti, urbani, speciali pericolosi e<br />
speciali non pericolosi. Ogni rifiuto ricompreso<br />
nell’elenco è classificato con un co<strong>di</strong>ce numerico a<br />
6 cifre (co<strong>di</strong>ce C.E.R.):<br />
- Le prime due cifre in<strong>di</strong>viduano le categorie<br />
industriali o i tipi <strong>di</strong> attività che hanno generato i<br />
rifiuti.<br />
- Le seconde due cifre in<strong>di</strong>viduano i singoli<br />
processi all’interno delle categorie industriali o<br />
attività che hanno generato il rifiuto.<br />
-Le ultime due cifre in<strong>di</strong>viduano la singola<br />
tipologia del rifiuto generato.<br />
-Nel Catalogo europeo dei rifiuti entrato in vigore il<br />
1°gennaio 2002, i rifiuti pericolosi sono in<strong>di</strong>viduati<br />
da un asterisco*.
CODICI CER
Articolo 189 - Catasto dei rifiuti - TU<br />
1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni,<br />
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia<br />
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat) e in Sezioni regionali o delle Province autonome <strong>di</strong> Trento<br />
e <strong>di</strong> Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente e,<br />
ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione. Le norme <strong>di</strong> organizzazione del Catasto sono<br />
emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <strong>di</strong> concerto con il Ministro<br />
delle attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto8 . Sino<br />
all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al decreto del Ministro dell'ambiente<br />
4 agosto 1998, n. 372. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza<br />
pubblica.<br />
2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione<br />
delle attività <strong>di</strong> gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la<br />
nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, <strong>di</strong> cui alla decisione 20 <strong>di</strong>cembre 1993, 94/3/Ce9 .<br />
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività <strong>di</strong> raccolta e <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong> rifiuti, compresi i commercianti e gli<br />
interme<strong>di</strong>ari <strong>di</strong> rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni <strong>di</strong> recupero e <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti, nonché le<br />
imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità <strong>di</strong> recuperare particolari tipologie <strong>di</strong><br />
rifiuto comunicano annualmente alle Camere <strong>di</strong> commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente<br />
competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei<br />
rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli impren<strong>di</strong>tori agricoli <strong>di</strong> cui all'articolo 2135 del<br />
Co<strong>di</strong>ce civile con un volume <strong>di</strong> affari annuo non superiore a euro ottomila.<br />
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività <strong>di</strong> raccolta e trasporto <strong>di</strong> rifiuti, i commercianti e gli interme<strong>di</strong>ari <strong>di</strong><br />
rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni <strong>di</strong> recupero e <strong>di</strong> smaltimento <strong>di</strong> rifiuti, i Consorzi<br />
istituiti per il recupero ed il riciclaggio <strong>di</strong> particolari tipologie <strong>di</strong> rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali <strong>di</strong><br />
rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali <strong>di</strong> rifiuti non pericolosi <strong>di</strong> cui all'articolo 184, comma 3, lettere<br />
c), d) e g), comunicano annualmente alle camere <strong>di</strong> commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente<br />
competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei<br />
rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli impren<strong>di</strong>tori agricoli <strong>di</strong> cui all'articolo 2135 del<br />
Co<strong>di</strong>ce civile10 con un volume <strong>di</strong> affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i<br />
propri rifiuti non pericolosi, <strong>di</strong> cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti<br />
produttori iniziali che non hanno più <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci <strong>di</strong>pendenti.
Articolo 188 - Oneri dei produttori e dei detentori - TU<br />
1. Gli oneri relativi alle attività <strong>di</strong> smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un<br />
raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni <strong>di</strong> smaltimento, nonché dei precedenti<br />
detentori o del produttore dei rifiuti.<br />
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:<br />
a) autosmaltimento dei rifiuti;<br />
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti;<br />
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico <strong>di</strong> raccolta dei rifiuti urbani, con i<br />
quali sia stata stipulata apposita convenzione;<br />
d) utilizzazione del trasporto ferroviario <strong>di</strong> rifiuti pericolosi per <strong>di</strong>stanze superiori a trecentocinquanta<br />
chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;<br />
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.<br />
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:<br />
a) in caso <strong>di</strong> conferimento dei rifiuti al servizio pubblico <strong>di</strong> raccolta;<br />
b) in caso <strong>di</strong> conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività <strong>di</strong> recupero o <strong>di</strong> smaltimento, a<br />
con<strong>di</strong>zione che il detentore abbia ricevuto il formulario <strong>di</strong> cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo<br />
dal destinatario entro tre mesi dalla data <strong>di</strong> conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza<br />
del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del<br />
formulario. Per le spe<strong>di</strong>zioni transfrontaliere <strong>di</strong> rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è<br />
effettuata alla Regione.<br />
4. Nel caso <strong>di</strong> conferimento <strong>di</strong> rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni <strong>di</strong> raggruppamento,<br />
ricon<strong>di</strong>zionamento e deposito preliminare, in<strong>di</strong>cate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B<br />
alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è<br />
esclusa a con<strong>di</strong>zione che questi ultimi, oltre al formulario <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong> cui al comma 3, lettera b), abbiano<br />
ricevuto il certificato <strong>di</strong> avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni <strong>di</strong><br />
cui ai punti da D1 a D12 del citato Allegato B. Le relative modalità <strong>di</strong> attuazione sono definite con decreto<br />
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da<br />
attribuire all'interme<strong>di</strong>ario dei rifiuti.
Articolo 190 - Registri <strong>di</strong> carico e scarico - TU<br />
1. I soggetti <strong>di</strong> cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo <strong>di</strong> tenere un registro <strong>di</strong> carico e scarico su<br />
cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da<br />
utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi<br />
<strong>di</strong> cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo <strong>di</strong> tenere un registro <strong>di</strong> carico e<br />
scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.<br />
Le annotazioni devono essere effettuate:<br />
a) per i produttori, almeno entro <strong>di</strong>eci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del<br />
medesimo;<br />
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro <strong>di</strong>eci giorni lavorativi dalla<br />
effettuazione del trasporto;<br />
c) per i commercianti, gli interme<strong>di</strong>ari e i consorzi, almeno entro <strong>di</strong>eci giorni lavorativi dalla<br />
effettuazione della transazione relativa;<br />
d) per i soggetti che effettuano le operazioni <strong>di</strong> recupero e <strong>di</strong> smaltimento, entro due giorni lavorativi<br />
dalla presa in carico dei rifiuti.<br />
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività <strong>di</strong> smaltimento e <strong>di</strong><br />
recupero <strong>di</strong> rifiuti deve, inoltre, contenere:<br />
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;<br />
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo <strong>di</strong> trasporto utilizzato;<br />
c) il metodo <strong>di</strong> trattamento impiegato.<br />
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto <strong>di</strong> produzione, <strong>di</strong> stoccaggio, <strong>di</strong> recupero e <strong>di</strong><br />
smaltimento <strong>di</strong> rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività <strong>di</strong> raccolta e<br />
trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e <strong>degli</strong> interme<strong>di</strong>ari. I registri integrati con i<br />
formulari <strong>di</strong> cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data<br />
dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni <strong>di</strong> smaltimento dei rifiuti in<br />
<strong><strong>di</strong>scarica</strong>, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono<br />
essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
Articolo 193<br />
Trasporto dei rifiuti - TU<br />
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario <strong>di</strong><br />
identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:<br />
a) nome ed in<strong>di</strong>rizzo del produttore e del detentore;<br />
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;<br />
c) impianto <strong>di</strong> destinazione;<br />
d) data e percorso dell'istradamento;<br />
e) nome ed in<strong>di</strong>rizzo del destinatario.<br />
2. Il formulario <strong>di</strong> identificazione <strong>di</strong> cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari,<br />
compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal<br />
trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre<br />
tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal<br />
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono<br />
essere conservate per cinque anni. …omissisi<br />
4. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma 1 non si applicano al trasporto <strong>di</strong> rifiuti urbani effettuato dal<br />
soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti <strong>di</strong> rifiuti non pericolosi effettuati dal<br />
produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità <strong>di</strong> trenta<br />
chilogrammi o <strong>di</strong> trenta litri.<br />
4-bis. Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong> rifiuti<br />
speciali <strong>di</strong> cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in<br />
modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico <strong>di</strong><br />
raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non<br />
eccedano la quantità <strong>di</strong> trenta chilogrammi o <strong>di</strong> trenta litri.
Articolo 200 - TU<br />
Organizzazione territoriale del servizio <strong>di</strong> gestione integrata dei rifiuti urbani<br />
1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base <strong>di</strong> ambiti territoriali ottimali, <strong>di</strong> seguito anche denominati<br />
Ato, delimitati dal piano regionale <strong>di</strong> cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida <strong>di</strong> cui all'articolo 195, comma<br />
1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:<br />
a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio <strong>di</strong> gestione integrata dei rifiuti;<br />
b) conseguimento <strong>di</strong> adeguate <strong>di</strong>mensioni gestionali, definite sulla base <strong>di</strong> parametri fisici, demografici, tecnici e<br />
sulla base delle ripartizioni politico amministrative;<br />
c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario <strong>di</strong> comunicazione al fine <strong>di</strong> ottimizzare i trasporti<br />
all'interno dell'Ato;<br />
d) valorizzazione <strong>di</strong> esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;<br />
e) ricognizione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> rifiuti già realizzati e funzionanti;<br />
f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi Ato si <strong>di</strong>scostino dai precedenti solo sulla base <strong>di</strong><br />
motivate esigenze <strong>di</strong> efficacia, efficienza ed economicità.<br />
2. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni interessati, nell'ambito delle attività <strong>di</strong> programmazione e <strong>di</strong><br />
pianificazione <strong>di</strong> loro competenza, entro il termine <strong>di</strong> sei mesi dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della parte quarta del<br />
presente decreto, provvedono alla delimitazione <strong>degli</strong> ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida <strong>di</strong> cui<br />
all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provve<strong>di</strong>mento è comunicato alle Province ed ai Comuni interessati.<br />
3. Le Regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli Ato qualora essi siano ricompresi nel territorio <strong>di</strong> due o<br />
più Regioni.<br />
4. Le Regioni <strong>di</strong>sciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni <strong>di</strong> gestione dei rifiuti, della<br />
funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.<br />
5. Le città o gli agglomerati <strong>di</strong> Comuni, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni maggiori <strong>di</strong> quelle me<strong>di</strong>e <strong>di</strong> un singolo ambito, possono<br />
essere sud<strong>di</strong>visi tenendo conto dei criteri <strong>di</strong> cui al comma 1.<br />
6. I singoli Comuni entro trenta giorni dalla comunicazione <strong>di</strong> cui al comma 2 possono presentare motivate e<br />
documentate richieste <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e <strong>di</strong> spostamento in un<br />
ambito territoriale <strong>di</strong>verso, limitrofo a quello <strong>di</strong> assegnazione.<br />
7. Le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello <strong>degli</strong> ambiti territoriali ottimali laddove<br />
pre<strong>di</strong>spongano un piano regionale dei rifiuti che <strong>di</strong>mostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici<br />
previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia,<br />
allo Stato ai sensi dell'articolo 195.
Facoltà <strong>di</strong> <strong>Ingegneria</strong> – <strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Siena</strong><br />
Laurea Magistrale in “<strong>Ingegneria</strong> Gestionale”<br />
Sezione 2<br />
D.Lgs 36/2003 e Criteri realizzativi
SECONDO CORRETTIVO TUA<br />
PRIMO CORRETTIVO TUA<br />
AUTORIZZAZIONI<br />
TUA<br />
CRITERI DI AMMISSIBILITà<br />
DISCARICHE<br />
Pronta dal 1991 è approvata solo del<br />
1999<br />
Quadro normativo<br />
Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59<br />
Attuazione <strong>di</strong> obblighi comunitari ed esecuzione <strong>di</strong> sentenze della<br />
Corte <strong>di</strong> giustizia Ue - Acque - Discariche rifiuti - Raee - Veicoli<br />
fuori uso - Stralcio<br />
Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4<br />
Ulteriori <strong>di</strong>sposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile<br />
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale<br />
Dm Ambiente 29 gennaio 2007<br />
Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l'in<strong>di</strong>viduazione e<br />
l'utilizzazione delle migliori tecniche <strong>di</strong>sponibili, in materia <strong>di</strong><br />
gestione dei rifiuti<br />
Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59<br />
Norme in materia <strong>di</strong> autorizzazione integrata ambientale<br />
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152<br />
Norme in materia ambientale - Stralcio - Gestione dei rifiuti e<br />
bonifica dei siti inquinati<br />
Dm Ambiente 3 agosto 2005<br />
Definizione dei criteri <strong>di</strong> ammissibilità dei rifiuti in <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36<br />
Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 1999/31/Ce - Discariche <strong>di</strong> rifiuti<br />
Direttiva Consiglio Ue 1999/31/Ce<br />
Discariche <strong>di</strong> rifiuti<br />
http://www.reteambiente.it/normativa/rifiuti/in<strong>di</strong>ci/vigente/
SOMMARIO<br />
•Cenni storici: Come si arriva all’attuale quadro normativo<br />
•Bilancio <strong>di</strong> massa <strong>di</strong> una <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
•D.Lgs 36/03<br />
•Criteri realizzativi<br />
•Sistemi <strong>di</strong> gestione: percolato, biogas, ecc…<br />
•Introduzione al monitoraggio
LE DISCARICHE
FLUSSI DI MATERIALI IN INGRESSO ED IN USCITA DA UNA DISCARICA<br />
Si considera barriera qualsiasi misura<br />
atta a ridurre la <strong>di</strong>ffusione incontrollata<br />
nell'ambiente <strong>di</strong> percolato e biogas
CENNI STORICI: COME SI ARRIVA AL D.LGS 36 1/3<br />
Per quanto riguarda l’evoluzione della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> controllata il filo conduttore nello<br />
sviluppo concettuale e tecnologico del sistema è stato il controllo delle emissioni e del<br />
rischio ambientale ed igienico sanitario ad esse associato. La <strong><strong>di</strong>scarica</strong> costituisce<br />
infatti a tutti gli effetti un reattore dove materiali in fase liquida, solida e gassosa,<br />
reagiscono dando luogo ad emissioni liquide (percolato) e gassose (biogas) con una<br />
fase solida (il rifiuto in posto) che rappresenta la fonte delle potenziali emissioni<br />
residue. Evoluzione nel tempo della gestione e delle tecnologie realizzative delle<br />
<strong>di</strong>scariche delle emissioni avviene me<strong>di</strong>ante l'impiego <strong>di</strong> barriere intese come strumenti<br />
atti a ridurre la <strong>di</strong>ffusione incontrollata delle emissioni verso l'ambiente. L'evoluzione<br />
delle barriere nel tempo cadenza la storia della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> controllata. Dal gettito<br />
incontrollato si è passati allo scarico controllato. In quel tipo <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, secondo il<br />
principio dell‘ "attenua e <strong>di</strong>sper<strong>di</strong>", il controllo del percolato era demandato ad una<br />
attenuazione negli strati <strong>di</strong> terreno insaturo, a bassa permeabilità, che dovevano essere<br />
presenti (naturalmente e /o artificialmente) al <strong>di</strong> sotto del deposito dei rifiuti. Per la<br />
localizzazione delle <strong>di</strong>scariche non venivano quin<strong>di</strong> prese in considerazione aree<br />
caratterizzate da suoli con elevata permeabilità o comunque ambientalmente<br />
vulnerabili. Successivamente lo sviluppo, che si è avuto . a cominciare dagli anni<br />
ottanta, dei materiali geosintetici, ed in particolare delle geomembrane in polietilene,<br />
ha portato all'affermazione della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> a contenimento delle emissioni, con<br />
drenaggio, raccolta del percolato, deposito con forte compattazione dei rifiuti, processo<br />
anaerobico, captazione del biogas.
CENNI STORICI: COME SI ARRIVA AL D.LGS 36 2/3<br />
Le emissioni contenute e captate necessitano ovviamente <strong>di</strong> una successiva fase <strong>di</strong><br />
trattamento e smaltimento, cosa che a sua volta ha determinato lo sviluppo <strong>di</strong> una<br />
ampia serie <strong>di</strong> tecnologie de<strong>di</strong>cate. In particolare per il biogas sono svariate le<br />
possibilità <strong>di</strong> recupero che sono state proposte (purificazione a gas <strong>di</strong> rete, produzione<br />
<strong>di</strong> energia termica ed elettrica, combustibile per autotrazione ecc.).<br />
Questo tipo <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, fondato su materiali e tecnologie avanzate, ha mostrato in<br />
questi anni tutti i suoi limiti. In particolare l'accettazione fideistica della potenziale<br />
efficienza dei nuovi materiali ha portato a realizzare <strong>di</strong>scariche dove mai, anche da<br />
parte del sindaco meno avveduto del paesino più sperduto, si sarebbe realizzato né un<br />
mondezzaio né uno scarico controllato <strong>di</strong> tipo semplice. Si sono così realizzate<br />
<strong>di</strong>scariche in cave <strong>di</strong> ghiaia, in valli con risorgive, in cave con venute d'acqua, ecc.<br />
La riscontrata limitata efficienza nel tempo dei materiali e delle tecnologie, la loro<br />
fragilità fisica e stretta <strong>di</strong>pendenza da gestioni spesso inadeguate tecnicamente,<br />
unitamente ad un impressionante pressappochismo progettuale, ha portato a veri e<br />
propri <strong>di</strong>sastri ambientali. Mai registrati, neanche lontanamente, con i vecchi<br />
mondezzai o con i vecchi scarichi controllati. Quando oggi si parla <strong>di</strong> bonifica <strong>di</strong><br />
vecchie <strong>di</strong>scariche, i casi più gravi riguardano "moderne" <strong>di</strong>scariche costruite negli<br />
ultimi vent'anni. È da questo tipo <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong> che ha preso avvio la normativa europea<br />
e la recente normativa italiana. La normativa europea, pubblicata nel 1999 era in realtà<br />
già pronta nel 1993 e solo per l'ostilità della Gran Bretagna, ha visto la luce solo sei<br />
anni dopo, quando tale paese concordò sulla "posizione comune" richiesta per la<br />
legislazione comunitaria.
Oggi le nuove <strong>di</strong>scariche tendono ad<br />
essere concepite sulla base del principio<br />
della sostenibilità, attente cioè a<br />
riconsegnare in tempi brevi alle generazioni<br />
che seguono un ambiente fruibile, nelle<br />
stesse in cui le presenti generazioni ne<br />
usufruiscono. In questo senso la ricerca è<br />
tutta orientata a definire alternative filosofie<br />
progettuali e a i comportamenti <strong>di</strong> lungo<br />
termine, delle emissioni, dei materiali e<br />
delle tecnologie. E su queste tematiche<br />
oggi ruota l'intera galassia della gestione<br />
dei rifiuti la <strong><strong>di</strong>scarica</strong> controllata è, <strong>di</strong> fatto,<br />
la madre <strong>di</strong> tutte le moderne normative<br />
adottate nei paesi più avanzati. Ridurre i<br />
volumi impegnati dalle <strong>di</strong>scariche, ridurre i<br />
fasti<strong>di</strong>, i rischi ed i problemi ambientali <strong>di</strong><br />
breve e luogo termine delle <strong>di</strong>scariche ha<br />
portato allo sviluppo gerarchico <strong>degli</strong> sta<strong>di</strong><br />
della gestione integrata (minimizzazione,<br />
recupero <strong>di</strong> materiali; recupero <strong>di</strong> energia,<br />
<strong><strong>di</strong>scarica</strong> sicura).<br />
CENNI STORICI: COME SI ARRIVA AL D.LGS 36 3/3<br />
Questo sviluppo in alcuni paesi, come l'Italia,<br />
non è peraltro avvenuto in modo congruo con<br />
gli obiettivi <strong>di</strong> cui sopra. Cioè la moderna<br />
normativa spesso, proprio per essere<br />
ancorata ad un vecchio modello <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
non rappresenta lo strumento più idoneo per<br />
il raggiungimento dell'obiettivo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
sostenibile, ma ad<strong>di</strong>rittura ne può costituire<br />
ostacolo.
IL SISTEMA MULTIBARRIERA
BILANCIO DI MASSA DI UNA DISCARICA 1/3
BILANCIO DI MASSA DI UNA DISCARICA 1/4<br />
Assumendo che la <strong><strong>di</strong>scarica</strong> si comporti come un reattore completamente miscelato<br />
CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor), con l'assunzione quin<strong>di</strong> che la concentrazione<br />
<strong>di</strong> una data sostanza sia sempre uniformemente <strong>di</strong>stribuita nel volume del reattore,<br />
l'equazione del bilancio <strong>di</strong> massa può essere riassunta come segue:<br />
accumulo = ingresso - uscita +- reazione (1)<br />
Il termine ingresso rappresenta la massa <strong>di</strong> una data sostanza (es. carbonio, azoto) che<br />
entra in un dato tempo nella <strong><strong>di</strong>scarica</strong> <strong>di</strong> volume V, associata sostanzialmente ai rifiuti<br />
conferiti. Se si considerano "n" flussi <strong>di</strong> "i" tipologie <strong>di</strong> rifiuto con portata Qi (t/anno),<br />
ciascuna <strong>di</strong> esse con <strong>di</strong>verse concentrazioni della data sostanza nella fase solida (xi, mg/kg <strong>di</strong> rifiuto), l'ingresso può essere così espresso:<br />
Il termine uscita nell'equazione (1) rappresenta la massa uscente dalla <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
associata alle portate <strong>di</strong> biogas (q G m 3 /anno) e <strong>di</strong> percolato (q L l/anno). Se le<br />
concentrazioni della data sostanza nel biogas e nel percolato sono rispettivamente x G,<br />
(mg/mc) e x L (mg/l), si ha:
BILANCIO DI MASSA DI UNA DISCARICA 2/4<br />
Distinguendo le frazioni <strong>di</strong> percolato e <strong>di</strong> biogas che vengono raccolte (q Lr e q Gr ) dalla<br />
frazione che si <strong>di</strong>sperde in modo incontrollato attraverso le barriera del sistema <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
(q Ld e q Gd), si può scrivere:<br />
Il termine <strong>di</strong> accumulo, che rappresenta l'incremento <strong>di</strong> massa (m) nel sistema <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
nel tempo (t), espresso come dm/dt può a sua volta essere considerato come somma <strong>di</strong><br />
due termini, definiti graficamente in Figura. Un accumulo <strong>di</strong> sostanza che può degradarsi<br />
ed essere lisciviata dal sistema, e che pertanto deve essere contenuta con sistemi <strong>di</strong><br />
impermeabilizzazione atti ad evitarne la <strong>di</strong>spersione incontrollata nella l'ambiente (m (mmob), ),<br />
ed un accumulo <strong>di</strong> sostanza che si stabilizza trasformandosi in forme non più <strong>di</strong>sponibili<br />
alla mobilizzazione (m fix). Il temine <strong>di</strong> reazione nell'equazione (1) rappresenta la massa<br />
che si allontana dal sistema per degradazione biologica e può essere espressa tramite<br />
una cinetica <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne zero o <strong>di</strong> primo or<strong>di</strong>ne (r in mg/m 3 anno):<br />
Le reazioni possono avvenire in un ambiente anaerobico (tipicamente con formazione <strong>di</strong><br />
biogas) o in con<strong>di</strong>zioni aerobiche con ingresso <strong>di</strong> aria e formazione <strong>di</strong> gas ossidati. Le<br />
velocità in ambiente aerobico sono in<strong>di</strong>cativamente <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> grandezza superiori a<br />
quelle in ambiente anaerobico.
BILANCIO DI MASSA DI UNA DISCARICA 3/4
BILANCIO DI MASSA DI UNA DISCARICA 4/4<br />
Il bilancio globale del sistema è rappresentato in Figura 3/4, in cui vengono<br />
espressi i <strong>di</strong>versi termini precedentemente descritti.<br />
Portando a primo membro nell'equazioni <strong>di</strong> bilancio i termini che esprimono le<br />
emissioni incontrollate <strong>di</strong> percolato e <strong>di</strong> biogas, risulta chiaro, da un punto <strong>di</strong><br />
vista matematico, che se si vogliono minimizzare le emissioni incontrollate<br />
occorre minimizzare i termini positivi al secondo membro del bilancio <strong>di</strong> massa<br />
e massimizzare quelli negativi.<br />
Questo significa operativamente:<br />
1. minimizzare la massa <strong>di</strong> contaminante introdotta in <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, controllandone<br />
sia il flusso (Qi) che la qualità (xi) dei rifiuti in ingresso;<br />
2. massimizzare la massa associata al biogas e al percolato raccolti,<br />
controllandone sia il flusso che la composizione;<br />
3. massimizzare il contenimento della frazione mobile accumulata e i processi <strong>di</strong><br />
stabilizzazione;<br />
4. massimizzare la velocità <strong>di</strong> reazione dei composti degradabili; questo è favorito<br />
dalle con<strong>di</strong>zioni aerobiche.<br />
É importante evidenziare, contrariamente alla generale tendenza che vuole<br />
minimizzare la produzione <strong>di</strong> percolato, la rilevanza che ha nell'equazione<br />
del bilancio <strong>di</strong> massa l'ingresso <strong>di</strong> acqua nel corpo rifiuti, sia come<br />
reagente per la degradazione biologica sia come mezzo <strong>di</strong> trasporto <strong>di</strong><br />
massa (flushing) .
REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA<br />
L’iter realizzativo relativo alla costruzione <strong>di</strong> una <strong><strong>di</strong>scarica</strong> è generalmente complesso e<br />
lungo e comprende le seguenti fasi:<br />
• localizzazione del sito (vagliatura dei siti, indagine a grande scala, indagine <strong>di</strong><br />
dettaglio, scelta del sito, verifica della <strong>di</strong>sponibilità, valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale e<br />
richiesta e concessione dei permessi);<br />
• caratterizzazione geotecnica <strong>di</strong> dettaglio (caratteristiche <strong>di</strong> resistenza e deformabilità<br />
del terreno <strong>di</strong> fondazione, regime idraulico sotterraneo e caratteristiche <strong>di</strong> permeabilità<br />
microscopiche e macroscopiche);<br />
• progettazione (definizione del tipo, volume, geometria della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, tipologie e<br />
numero <strong>di</strong> barriere, tipologia e <strong>di</strong>mensioni della copertura, presenza e caratteristiche del<br />
sistema <strong>di</strong> raccolta e rimozione del percolato, modalità <strong>di</strong> messa in opera dei materiali e<br />
particolari esecutivi);<br />
• controlli in corso <strong>di</strong> realizzazione (campi prova), durante la fase attiva della <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
e dopo la chiusura (sistemi <strong>di</strong> monitoraggio).
Struttura del Decreto Legislativo 36/2003<br />
attuazione della <strong>di</strong>rettiva europea 1999/31/CE<br />
Art.1 - Finalità<br />
Art.2 - Definizioni<br />
Art.3 - Ambito <strong>di</strong> applicazione<br />
Art.4 - Classificazione delle <strong>di</strong>scariche<br />
decreto legislativo 13<br />
gennaio 2003, n.36,<br />
attuazione della <strong>di</strong>rettiva<br />
europea 1999/31/CE<br />
Art.5 - Obiettivi <strong>di</strong> riduzione del conferimento <strong>di</strong> rifiuti in <strong><strong>di</strong>scarica</strong> relativa alle <strong>di</strong>scariche <strong>di</strong><br />
Art.6 - Rifiuti non ammessi in <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
rifiuti il quale “stabilisce<br />
Art.7 - Rifiuti ammessi in <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
Art.8 - Domanda <strong>di</strong> autorizzazione<br />
Art.9 - Con<strong>di</strong>zioni per il rilascio dell’autorizzazione delle<br />
<strong>di</strong>scariche<br />
Art.10 - Contenuto dell’autorizzazione<br />
requisiti operativi e tecnici<br />
per i rifiuti e le <strong>di</strong>scariche,<br />
misure, procedure e<br />
orientamenti tesi a prevenire<br />
o a ridurre il più possibile le<br />
ripercussioni negative<br />
Art.11 - Procedure <strong>di</strong> ammissione<br />
sull’ambiente, in particolare<br />
Art.12 - Procedura <strong>di</strong> chiusura<br />
l’inquinamento delle acque<br />
Art.13 - Gestione operativa e post-operativa<br />
Art.14 - Garanzie finanziarie<br />
Art.15 - Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle <strong>di</strong>scariche<br />
Art.16 - Sanzioni<br />
Art.17 - Disposizioni transitorie e finali<br />
superficiali, delle acque<br />
sotterranee, del suolo e<br />
dell’atmosfera, e<br />
sull’ambiente globale,<br />
compreso l’effetto serra,<br />
nonché i rischi per la salute<br />
Allegato 1 - Criteri costruttivi e gestionali <strong>degli</strong> impianti <strong>di</strong><br />
umana risultanti dalle<br />
<strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
<strong>di</strong>scariche <strong>di</strong> rifiuti, durante<br />
Allegato 2 - Piani <strong>di</strong> gestione operativa, <strong>di</strong> ripristino ambientale,<br />
<strong>di</strong> gestione post-operativa, <strong>di</strong> sorveglianza e controllo, finanziario<br />
l’intero ciclo <strong>di</strong> vita della<br />
<strong><strong>di</strong>scarica</strong>.” (articolo 1).
Art.2: DEFINIZIONI<br />
"<strong><strong>di</strong>scarica</strong>": “area a<strong>di</strong>bita a smaltimento dei rifiuti me<strong>di</strong>ante operazioni <strong>di</strong> deposito<br />
sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo <strong>di</strong> produzione dei rifiuti<br />
a<strong>di</strong>bita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore <strong>degli</strong> stessi, nonché<br />
qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più <strong>di</strong> un anno.<br />
Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine <strong>di</strong><br />
essere preparati per il successivo trasporto in un impianto <strong>di</strong> recupero, trattamento<br />
o smaltimento, e lo stoccaggio <strong>di</strong> rifiuti in attesa <strong>di</strong> recupero o trattamento per un<br />
periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio <strong>di</strong> rifiuti in attesa<br />
<strong>di</strong> smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”.<br />
"gas <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong>": tutti i gas generati dai rifiuti in <strong><strong>di</strong>scarica</strong>;<br />
"percolato": liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione <strong>di</strong> acqua nella massa dei<br />
rifiuti o dalla decomposizione <strong>degli</strong> stessi.
Il D.Lgs 36/2003 e le BAT<br />
Migliori tecniche <strong>di</strong>sponibili – BAT (Best Available Techniques):<br />
la più efficiente e avanzata fase <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> attività e relativi<br />
meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> esercizio, che risulti economicamente e tecnicamente<br />
valida per l’applicazione nell’impianto e a cui sono ancorati i valori<br />
limite <strong>di</strong> emissione (emission limit values ELV).<br />
D. Lgs. 59/2005 – art. 4<br />
Discariche che ricevono più <strong>di</strong> 10<br />
tonnellate al giorno o con una<br />
capacità totale <strong>di</strong> oltre 25.000<br />
tonnellate, ad esclusione delle<br />
<strong>di</strong>scariche per i rifiuti inerti.<br />
4. Per le <strong>di</strong>scariche <strong>di</strong> rifiuti da autorizzare ai sensi del<br />
presente decreto, si considerano sod<strong>di</strong>sfatti i requisiti<br />
tecnici <strong>di</strong> cui al presente decreto se sono sod<strong>di</strong>sfatti i<br />
requisiti tecnici <strong>di</strong> cui al decreto legislativo 13 gennaio<br />
2003, n. 36.
GLI ALLEGATI<br />
Allegato 1 - Criteri costruttivi e gestionali <strong>degli</strong> impianti <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
L’allegato è sud<strong>di</strong>viso in tre paragrafi principali:<br />
1. Impianti <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong> per rifiuti inerti<br />
2. Impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi<br />
3. Caratteristiche <strong>degli</strong> impianti <strong>di</strong> deposito sotterraneo dei rifiuti<br />
Allegato 2 - Piani <strong>di</strong> gestione operativa, <strong>di</strong> ripristino ambientale,<br />
<strong>di</strong> gestione post-operativa, <strong>di</strong> sorveglianza e controllo, finanziario<br />
Struttura dell’allegato:<br />
1. Principi generali<br />
2. Piano <strong>di</strong> gestione operativa<br />
3. Piano <strong>di</strong> ripristino ambientale<br />
4. Piano <strong>di</strong> gestione in fase post-operativa<br />
5. Piano <strong>di</strong> sorveglianza e controllo<br />
6. Piano finanziario
UBICAZIONE (All. 1)<br />
La scelta del sito per l’ubicazione <strong>di</strong> una <strong><strong>di</strong>scarica</strong> costituisce una delle fasi più delicate,<br />
che richiede un’attenta analisi e la valutazione <strong>di</strong> aspetti più propriamente tecnici, <strong>di</strong><br />
carattere idrologico, geologico, geotecnico e climatico, <strong>di</strong> aspetti logistici, legati alla<br />
vicinanza delle sorgenti <strong>di</strong> rifiuto, alla rete <strong>di</strong> trasporti, e infine <strong>di</strong> aspetti sociali, legati<br />
all’impatto ambientale.<br />
In linea teorica comunque un sito si considera ideale per l’ubicazione <strong>di</strong> una <strong><strong>di</strong>scarica</strong>,<br />
quando:<br />
• è situato vicino alle sorgenti dei rifiuti che dovrà ospitare;<br />
• è collegato da un’efficiente rete <strong>di</strong> trasporti;<br />
• non si trova in un’area morfologicamente depressa o in una piana alluvionale;<br />
• è caratterizzato da terreni <strong>di</strong> fondazione resistenti (per garantire la stabilità della<br />
struttura) e impermeabili;<br />
• presenta una situazione idrogeologica e climatica favorevole.<br />
La procedura da seguire per la scelta del sito si sviluppa in tre fasi temporalmente<br />
<strong>di</strong>stinte: vagliatura dei siti (site screening), indagine iniziale dei siti selezionati (I fase)<br />
e indagine <strong>di</strong> dettaglio sui siti possibili (II fase).
UBICAZIONE D.Lgs. 36/2003<br />
Di norma i siti idonei alla realizzazione <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong> per rifiuti inerti non<br />
devono ricadere in:<br />
- aree in<strong>di</strong>viduate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n.<br />
183;<br />
“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della <strong>di</strong>fesa del suolo” che prevede la<br />
realizzazione dei Piani <strong>di</strong> Bacino, all’interno dei quali vengono in<strong>di</strong>viduate aree <strong>di</strong> tutela<br />
-aree in<strong>di</strong>viduate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre<br />
1997, n. 357;<br />
“Regolamento recante attuazione della <strong>di</strong>rettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione <strong>degli</strong><br />
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.<br />
-aree collocate nelle zone <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11<br />
maggio 1999, n. 152;<br />
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della <strong>di</strong>rettiva<br />
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della <strong>di</strong>rettiva 91/676/CEE<br />
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti<br />
agricole"<br />
Art. 21- Disciplina delle aree <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a delle acque superficiali e sotterranee destinate al<br />
consumo umano<br />
-territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.<br />
490.<br />
Testo unico delle <strong>di</strong>sposizioni legislative in materia <strong>di</strong> beni culturali e ambientali
UBICAZIONE D.Lgs. 36/2003<br />
Le <strong>di</strong>scariche per rifiuti inerti non devono essere normalmente localizzate:<br />
-in corrispondenza <strong>di</strong> doline, inghiottitoi o altre forme <strong>di</strong> carsismo superficiale;<br />
-in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilita' dei pen<strong>di</strong>i, le<br />
migrazioni <strong>degli</strong> alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita' della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>;<br />
-in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con<br />
tempo <strong>di</strong> ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali mo<strong>di</strong>fiche al valore da adottare per<br />
il tempo <strong>di</strong> ritorno sopra riportato in accordo con l'Autorita' <strong>di</strong> bacino laddove costituita;<br />
- aree naturali protette sottoposte a misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ai sensi dell'articolo 6, comma 3,della legge 6<br />
<strong>di</strong>cembre 1991, n. 394; Legge quadro sulle aree protette<br />
Le Regioni possono, con provve<strong>di</strong>mento motivato, autorizzare la realizzazione delle <strong>di</strong>scariche per inerti nei<br />
siti <strong>di</strong> cui al comma precedente.<br />
La <strong><strong>di</strong>scarica</strong> puo' essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
cui sopra, o le misure correttive da adottare, in<strong>di</strong>chino che la <strong><strong>di</strong>scarica</strong> non costituisca un grave rischio<br />
ecologico.<br />
Per ciascun sito <strong>di</strong> ubicazione devono essere valutate le con<strong>di</strong>zioni locali <strong>di</strong> accettabilita' dell'impianto in<br />
relazione ai seguenti parametri:<br />
-<strong>di</strong>stanza dai centri abitati;<br />
- fascia <strong>di</strong> rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;<br />
Nell'in<strong>di</strong>viduazione dei siti <strong>di</strong> ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da<br />
ripristinare sotto il profilo paesaggistico.
UBICAZIONE D.Lgs. 36/2003<br />
Di norma gli impianti <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong> per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:<br />
- aree in<strong>di</strong>viduate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183;<br />
- aree in<strong>di</strong>viduate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;<br />
- territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;<br />
- aree naturali protette sottoposte a misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6<br />
<strong>di</strong>cembre 1991, n. 394; Legge quadro sulle aree protette<br />
- aree collocate nelle zone <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.<br />
152.<br />
Gli impianti non vanno ubicati <strong>di</strong> norma:<br />
-in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico <strong>di</strong> 1^ categoria cosi' come<br />
classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provve<strong>di</strong>menti attuativi, e aree interessate da attivita‘<br />
vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensita' potrebbero pregiu<strong>di</strong>care l'isolamento<br />
dei rifiuti;<br />
- in corrispondenza <strong>di</strong> doline, inghiottitoi o altre forme <strong>di</strong> carsismo superficiale;<br />
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilita' dei pen<strong>di</strong>i, le<br />
migrazioni <strong>degli</strong> alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita' della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> e delle opere ad essa<br />
connesse;<br />
- in aree soggette ad attività <strong>di</strong> tipo idrotermale;<br />
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con<br />
tempo <strong>di</strong> ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali mo<strong>di</strong>fiche al valore da adottare per il<br />
tempo <strong>di</strong> ritorno in accordo con l'Autorità <strong>di</strong> bacino laddove costituita.<br />
Con provve<strong>di</strong>mento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scariche per rifiuti non<br />
pericolosi nei siti sopradescritti.<br />
La <strong><strong>di</strong>scarica</strong> può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui<br />
sopra, o le misure correttive da adottare, in<strong>di</strong>chino che la <strong><strong>di</strong>scarica</strong> non costituisca un grave rischio ecologico.
UBICAZIONE D.Lgs. 36/2003<br />
Per ciascun sito <strong>di</strong> ubicazione devono essere esaminate le con<strong>di</strong>zioni locali <strong>di</strong> accettabilita' dell'impianto in<br />
relazione a:<br />
- <strong>di</strong>stanza dai centri abitati;<br />
- collocazione in aree a rischio sismico <strong>di</strong> 2^ categoria cosi' come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n.<br />
64, e provve<strong>di</strong>menti attuativi, per gli impianti <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong> per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri <strong>di</strong><br />
progettazione <strong>degli</strong> impianti stessi;<br />
- collocazione in zone <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> prodotti agricoli ed alimentari definiti ad in<strong>di</strong>cazione geografica o a<br />
denominazione <strong>di</strong> origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si<br />
ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91;<br />
- presenza <strong>di</strong> rilevanti beni storici, artistici, archeologici.<br />
Per le <strong>di</strong>scariche <strong>di</strong> rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere<br />
oggetto <strong>di</strong> specifico stu<strong>di</strong>o, al fine <strong>di</strong> evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la <strong>di</strong>stanza dai centri<br />
abitati in relazione alla <strong>di</strong>rettrice dei venti dominanti. Tale <strong>di</strong>rettrice e' stabilita sulla base <strong>di</strong> dati statistici<br />
significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.
FATTORE AMBIENTALE CRITERIO<br />
USI DEL SUOLO<br />
Aree interessate da boschi, foreste e selve Penalizzante<br />
Aree coltivate a risaie, frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noce, ciliegio Escludente<br />
Colture <strong>di</strong> aziende specializzate e vivai <strong>di</strong> essenze legnose agrarie forestali a pieno campo o<br />
protette<br />
Penalizzante<br />
Aree <strong>di</strong> pregio agricolo (DOC, DOCG, DOP..) Escludente<br />
CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO<br />
Altimetria D.Lgs. 42/04 (sopra i 1.200 m <strong>di</strong> altezza) Escludente<br />
PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE<br />
Protezione della falda (5 m sotto dal piano campagna, ad esclusione delle <strong>di</strong>scariche in rilevato) Escludente<br />
L.R. 26/03 aree <strong>di</strong> ricarica della falda, <strong>di</strong> riserva e <strong>di</strong> protezione dell’acquifero Penalizzante<br />
Distanza da opere <strong>di</strong> captazione <strong>di</strong> acqua destinata al consumo umano ad uso potabile me<strong>di</strong>ante<br />
infrastrutture <strong>di</strong> pubblico interesse D.Lgs. 152/99 (200 m)<br />
Escludente<br />
Distanza da corsi d’acqua e laghi Reg.decr. 523/1904 (10 m) Escludente<br />
Vulnerabilità me<strong>di</strong>o alta del sottosuolo ai sensi dell’allegato 7 del D.Lgs. 152/99 Penalizzante
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA’<br />
Aree soggette a rischio idraulico, aree esondabili A e B del PAI (art. 29-30-31) Escludente<br />
Aree caratterizzate dall’instabilità del suolo (art. 9 del PAI) Escludente<br />
Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato (art. 48 PAI e art. 4 PS267) Escludente<br />
PROTEZIONE DI BENI STORICI E RISORSE NATURALI<br />
Aree naturali protette: parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali (D.Lgs. 394/91) Escludente<br />
Sistema delle aree protette regionali: parchi regionali, parchi locali interesse sovracomunale-PLIS<br />
(L.R. 86/83)<br />
Penalizzante<br />
Beni paesaggistici (art. 134-136 nuovo co<strong>di</strong>ce dei beni culturali e del paesaggio) Escludente<br />
Beni culturali (art. 10 nuovo co<strong>di</strong>ce dei beni culturali e del paesaggio) Escludente<br />
Zone <strong>di</strong> interesse archeologico (art. 142 nuovo co<strong>di</strong>ce dei beni culturali e del paesaggio) Escludente<br />
Distanza dai corsi d’acqua D.Lgs. 42/04 (entro 150 m dai fiumi) Penalizzante<br />
Distanza dalle sponde dei laghi D.Lgs. 42/04 (300 m dalle sponde dei laghi) Escludente<br />
Zone umide D.Lgs. 42/04 Escludente<br />
Oasi e zone <strong>di</strong> ripopolamento o cattura (L.R. 26/93) Penalizzante
PREVISIONI P.R.G. COMUNALI<br />
Destinazione urbanistica: aree A,B,C Escludente<br />
Classe <strong>di</strong> fattibilità stu<strong>di</strong>o geologico comunale: classe 4 Penalizzante<br />
Aree in vincolo idrogeologico Penalizzante<br />
Zone e fasce <strong>di</strong> rispetto Escludente<br />
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALI<br />
Preesistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>scariche e impianti esistenti Preferenziale<br />
Preesistenza <strong>di</strong> infrastrutture e dell’acquedotto Preferenziale<br />
Aree con destinazione d’uso industriale/artigianale Preferenziale<br />
Vicinanza ad aree <strong>di</strong> maggiore produzione <strong>di</strong> rifiuti Preferenziale<br />
Presenza <strong>di</strong> cave (L.R. 14/98) Preferenziale<br />
Presenza <strong>di</strong> aree da bonificare Preferenziale<br />
Profon<strong>di</strong>tà della falda (sotto i 5 metri dal piano campagna) Preferenziale<br />
Barriera geologica naturale (1 metro con k ≤ 10 -9 m/s) Preferenziale
UBICAZIONE – caratterizzazione idrogeologica<br />
Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> indagine idrogeologica che dovrebbero essere almeno condotti per definire correttamente al<br />
struttura idrogeologica dell’area (National Water Well Association, 1986)<br />
Obiettivi Tecniche <strong>di</strong> indagine Risultati/informazioni<br />
DEFINIZIONE DELLA GEOLOGIA DELL’AREA<br />
Esame dei dati geologici esistenti Descrizione della<br />
geologia dell’area<br />
Esecuzione <strong>di</strong> nuove perforazioni Sezioni geologiche<br />
Esecuzione <strong>di</strong> carotaggi o campionamenti Carta geologica (1:2000)<br />
Prove in sito e in laboratorio (penetrometria,<br />
granulometria, etc.)<br />
Logs geofisici in pozzo (log elettrico; log <strong>di</strong> conducibilità<br />
dei flui<strong>di</strong>; log <strong>di</strong> resistività della formazione; log raggi<br />
gamma naturali; etc.)<br />
Prospezioni geofisiche <strong>di</strong> superficie (meto<strong>di</strong> elettrici,<br />
meto<strong>di</strong> elettromagnetici; meto<strong>di</strong> sismici)<br />
Determinazione su campioni della conducibilità idraulica<br />
(zona satura e zona non satura)<br />
Foto aree (analisi <strong>di</strong> tracce <strong>di</strong> fratture)<br />
Carta geologica e strutturale <strong>di</strong> dettaglio <strong>degli</strong><br />
affioramenti<br />
Logs in pozzo<br />
Carte strutturali<br />
dell’acquifero<br />
Esposizione dei dati e<br />
interpretazione <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong><br />
geofisici<br />
Esposizione dei dati e<br />
interpretazione delle<br />
prove sui materiali
UBICAZIONE – caratterizzazione idrogeologica<br />
Obiettivi Tecniche <strong>di</strong> indagine Risultati/informazioni<br />
CARATTERIZZAZIONE<br />
IDROGEOLOGICA<br />
DELL’AREA<br />
Installazione dei piezometri Descrizione delle<br />
modalità <strong>di</strong> circolazione<br />
delle acque sotterranee<br />
Misura del livello della falda in <strong>di</strong>versi punti e a <strong>di</strong>verse<br />
profon<strong>di</strong>tà<br />
Carta delle<br />
isopiezometriche con<br />
linee <strong>di</strong> flusso (1:2000)<br />
Prove <strong>di</strong> pompaggio e/o slug tests Sezioni idrogeologiche<br />
<strong>Stu<strong>di</strong></strong> con l’utilizzo <strong>di</strong> traccianti<br />
Valori stimati dei parametri tramite prove<br />
Valori stimati dei parametri tramite prove<br />
granulometriche
ELEMENTI COSTRUTTIVI<br />
All’interno <strong>di</strong> una <strong><strong>di</strong>scarica</strong> si possono in<strong>di</strong>viduare schematicamente i seguenti elementi:<br />
a) Terreno <strong>di</strong> fondazione e sottofondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
b) Barriera <strong>di</strong> impermeabilizzazione sul fondo e sui fianchi<br />
c) Sistema <strong>di</strong> drenaggio del percolato<br />
d) Ammasso dei rifiuti compattati in strati<br />
e) Coperture <strong>di</strong> interstrato<br />
f) Sistema <strong>di</strong> captazione del biogas<br />
g) Copertura finale<br />
Oltre ad eventuali rilevati <strong>di</strong> contenimento al piede delle <strong>di</strong>scariche in elevazione o in pen<strong>di</strong>o.
DISCARICHE RIFIUTI INERTI<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriera geologica / artificiale - D.Lgs. 36/2003<br />
Il substrato della base e dei lati della <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
deve consistere in una formazione geologica<br />
naturale che risponda a requisiti <strong>di</strong> permeabilità e<br />
spessore almeno equivalente a quello risultante<br />
dai seguenti criteri:<br />
- conducibilità idraulica k ≤ 1 x 10 -7 m/s;<br />
- spessore ≥ 1 m.<br />
La barriera geologica, qualora non sod<strong>di</strong>sfi<br />
naturalmente le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui sopra, può essere<br />
completata artificialmente attraverso un sistema<br />
barriera <strong>di</strong> confinamento opportunamente<br />
realizzato che fornisca una protezione equivalente.<br />
La barriera messa in opera artificialmente deve<br />
avere uno spessore non inferiore a 0,5 metri.<br />
DISCARICHE RIFIUTI NON PERICOLOSI<br />
DISCARICHE RIFIUTI PERICOLOSI<br />
Il substrato della base e dei lati della <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
deve consistere in una formazione geologica<br />
naturale che risponda a requisiti <strong>di</strong> permeabilità e<br />
spessore almeno equivalente a quello risultante<br />
dai seguenti criteri:<br />
Per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1 x 10 -9 m/s e<br />
spessore ≥ 1 m.<br />
Per rifiuti pericolosi: k ≤ 1 x 10 -9 m/s e<br />
spessore ≥ 5 m.<br />
La barriera geologica, qualora non sod<strong>di</strong>sfi<br />
naturalmente le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui sopra, può essere<br />
completata artificialmente attraverso un sistema<br />
barriera <strong>di</strong> confinamento opportunamente<br />
realizzato che fornisca una protezione equivalente.<br />
Per tutti gli impianti deve comunque essere<br />
prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle<br />
pareti con un rivestimento <strong>di</strong> materiale artificiale<br />
posto al <strong>di</strong> sopra della barriera geologica, su uno<br />
strato <strong>di</strong> materiale minerale compattato. Tale<br />
rivestimento deve avere caratteristiche idonee a<br />
resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche<br />
presenti nella <strong><strong>di</strong>scarica</strong>.
DISCARICHE RIFIUTI INERTI<br />
Il piano <strong>di</strong> imposta della<br />
barriera <strong>di</strong> confinamento deve<br />
essere posto al <strong>di</strong> sopra del<br />
tetto dell'acquifero confinato o<br />
della quota <strong>di</strong> massima<br />
escursione della falda, nel<br />
caso <strong>di</strong> acquifero non<br />
confinato, con un franco <strong>di</strong><br />
almeno 1,5 metri.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriera geologica - D.Lgs. 36/2003<br />
DISCARICHE RIFIUTI NON PERICOLOSI<br />
DISCARICHE RIFIUTI PERICOLOSI<br />
Il piano <strong>di</strong> imposta dello strato inferiore della barriera <strong>di</strong> confinamento<br />
deve essere posto al <strong>di</strong> sopra del tetto dell'acquifero confinato con un<br />
franco <strong>di</strong> almeno 1,5 metri, nel caso <strong>di</strong> acquifero non confinato, al <strong>di</strong><br />
sopra della quota <strong>di</strong> massima escursione della falda con un franco <strong>di</strong><br />
almeno 2 metri.<br />
Le caratteristiche del sistema barriera <strong>di</strong> confinamento artificiale sono<br />
garantite normalmente dall'accoppiamento <strong>di</strong> materiale minerale<br />
compattato (caratterizzato da uno spessore <strong>di</strong> almeno 100 cm con una<br />
conducibilità idraulica k ≤ 10-7 cm/s, depositato preferibilmente in strati<br />
uniformi compattati dello spessore massimo <strong>di</strong> 20 cm) con una<br />
geomembrana.<br />
L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso<br />
un sistema <strong>di</strong> impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere<br />
posta a <strong>di</strong>retto contatto con lo strato minerale compattato, senza<br />
interposizione <strong>di</strong> materiale drenante.<br />
Sul fondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, al <strong>di</strong> sopra del rivestimento impermeabile,<br />
deve essere previsto uno strato <strong>di</strong> materiale drenante con spessore ≥<br />
0,5 metri.<br />
Il fondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, tenuto conto <strong>degli</strong> assestamenti previsti,<br />
deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del<br />
percolato ai sistemi <strong>di</strong> raccolta.
ARGILLA – SABBIA - GHIAIA<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriere/strati in materiali naturali<br />
I suoli argillosi rappresentano il materiale impermeabile naturale più comune. I principali parametri che ne<br />
influenzano la proprietà <strong>di</strong> impermeabilizzazione sono: conducibilità idraulica, livello <strong>di</strong> compattazione,<br />
contenuto <strong>di</strong> acqua, <strong>di</strong>stribuzione granulometrica e qualità, tecniche <strong>di</strong> posa, spessore dello strato.<br />
Ad<strong>di</strong>tivi, come la bentonite o altri materiali argillosi, possono <strong>di</strong>minuire la conducibilità idraulica del suolo<br />
locale. La bentonite è un minerale <strong>di</strong> argilla che si espande (15 -18 volte) quando viene in contatto con<br />
l’acqua (idratazione), assorbendo l’acqua all’interno della matrice minerale.<br />
In <strong><strong>di</strong>scarica</strong> la bentonite viene impiegata usualmente in polvere e miscelata con sabbia o con terreno<br />
<strong>di</strong>sponibile in loco. Il contenuto <strong>di</strong> acqua deve essere attentamente controllato.<br />
Il vantaggio della miscela sabbia/bentonite è l’abilità <strong>di</strong> risaldarsi quanto perforata (autosigillante) e la<br />
possibilità <strong>di</strong> aumentare o ridurre la permeabilità del terreno aggiungendo <strong>di</strong>verse percentuali <strong>di</strong> bentonite<br />
alla miscela.<br />
Bentonite so<strong>di</strong>ca: ad<strong>di</strong>tivo più utilizzato per mo<strong>di</strong>ficare le caratteristiche dei suoli. Il principale problema<br />
legato al suo utilizzo consiste nella vulnerabilità alla degradazione causata dal contatto con agenti chimici e<br />
con il percolato.<br />
Bentonite <strong>di</strong> calcio: più permeabile della bentonite <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o ma ugualmente molto utilizzata.<br />
Approssimativamente, è necessario il doppio del quantitativo <strong>di</strong> bentonite so<strong>di</strong>ca per raggiungere la<br />
permeabilità analoga utilizzando bentonite <strong>di</strong> calcio.<br />
Il contenuto <strong>di</strong> acqua, la percentuale <strong>di</strong> bentonite e la <strong>di</strong>stribuzione granulometrica devono essere<br />
accuratamente controllate quando si effettua la miscela e la posa.<br />
Le miscele sabbia/bentonite (come anche le argille) hanno anche una buona potenzialità nella riduzione del<br />
carico inquinante del percolato, in particolare, per i metalli pesanti (scambio ionico).
ARGILLA – SABBIA - GHIAIA<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriere/strati in materiali naturali<br />
La sabbia, oltre che nelle miscele descritte, è utilizzata anche per proteggere meccanicamente i rivestimenti<br />
impermeabili sintetici e per fornire un letto filtrante sul fondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>.<br />
La ghiaia è il principale materiale per la filtrazione e il drenaggio.<br />
L’efficienza <strong>degli</strong> strati <strong>di</strong> ghiaia <strong>di</strong>pende da: porosità dei grani, <strong>di</strong>mensione, forma, resistenza meccanica,<br />
qualità del materiale, stabilità, spessore.<br />
In linea <strong>di</strong> massima è da evitare in <strong><strong>di</strong>scarica</strong> l’utilizzo <strong>di</strong> ghiaie calcaree che vanno in soluzione a contatto<br />
con il percolato.
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriere/strati in materiali sintetici<br />
Durante gli ultimi anni l’utilizzo <strong>di</strong> materiali sintetici per migliorare le caratteristiche dei suoli, è molto<br />
aumentata poiché sono capaci <strong>di</strong> svolgere <strong>di</strong>versi compiti (impermeabilizzazione, separazione <strong>di</strong> materiali a<br />
<strong>di</strong>versa <strong>di</strong>stribuzione granulometrica, drenaggio, filtrazione, rinforzo, ecc.).<br />
I principali vantaggi offerti rispetto ai materiali naturali sono la pronta <strong>di</strong>sponibilità, la bassa occupazione<br />
volumetrica (maggiore volume x deposito rifiuti), ecc..<br />
Le categorie <strong>di</strong> geosintetici che possono essere utilizzati nella realizzazione <strong>di</strong> una <strong><strong>di</strong>scarica</strong> sono:<br />
GEOMEMBRANE<br />
GEOTESSILI<br />
GEORETI<br />
GEOGRIGLIE<br />
GEOCOMPOSITI<br />
Per l’impermeabilizzazione delle <strong>di</strong>scariche vengono usate principalmente le GEOMEBRANE
ELEMENTI COSTRUTTIVI – GEOMEMBRANE<br />
Le geomembrane sono manti sintetici flessibili caratterizzati da una bassissima permeabilità.<br />
I materiali utilizzati permettono <strong>di</strong> classificare le geomembrane in:<br />
- Geomembrane bituminose: prodotte impregnando <strong>di</strong> asfalto o bitume materiali tessili, tessuti o non tessuti<br />
- Geomembrane polimeriche: prodotte utilizzando <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> polimeri o elastomeri<br />
I materiali più comunemente utilizzati per la realizzazione delle geomembrane sono:<br />
HDPE (HIGH DENSITY POLYETHILENE)<br />
LLDPE (LINEAR LOW DENSITY POLYETHILENE)<br />
PVC (POLYVINYL CHLORIDE)<br />
fPP (flexible POLYPROPYLENE)<br />
CSPE (CHLOROSULFONATED POLYETHILENE)<br />
Lo spessore delle geomembrane può variare da un minimo raccomandato <strong>di</strong> 0,75 mm (ad eccezione del<br />
HDPE per cui il minimo raccomandato è 1,5 mm per permetterne la saldatura per estrusione) fino a 3 mm.<br />
La principale caratteristica delle geomembrane è la permeabilità, che risulta essere effettivamente molto<br />
bassa quando la geomembrana è intatta:<br />
GEOMEMBRANA SPESSORE [mm] Velocità <strong>di</strong> trasmissione del vapor d’acqua attraverso la geomembrana<br />
[g/m 2 /giorno]<br />
PVC 0,75 1,9<br />
CSPE 1,0 0,4<br />
HDPE 0,75 0,02<br />
HDPE 2,45 0,006<br />
Trasmissione del vapore acqueo per <strong>di</strong>verse geomembrane (USEPA, 1998)
Il materiale più largamente usato è l’HDPE<br />
soprattutto per la sua resistenza agli<br />
attacchi chimici, biologici e alla facilità <strong>di</strong><br />
saldatura.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – GEOMEMBRANE<br />
GEOMEMBRANA SPESSORE [mm] Velocità <strong>di</strong> trasmissione del vapor d’acqua attraverso la geomembrana<br />
[ml/m 2 /giorno]<br />
PVC 0,25 4,4<br />
PVC 0,5 3,3<br />
LLDPE 0,45 2,3<br />
CSPE 0,8 0,27<br />
CSPE 0,85 1,6<br />
HDPE 0,6 1,3<br />
HDPE 0,85 1,4<br />
Trasmissione del METANO per <strong>di</strong>verse geomembrane (USEPA, 1998)<br />
I maggiori problemi sono connessi con i<br />
rischi <strong>di</strong> rottura a trazione e che si hanno<br />
con l’invecchiamento del materiale.<br />
SALDATURA MEMBRANA HDPE
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriere/strati in materiali sintetici<br />
GEOTESSILI: sono formati da fibre sintetiche assemblate in forma <strong>di</strong> tessuto costituito da una tramatura<br />
incrociata o in forma <strong>di</strong> non tessuto formato da un filamento a fibra corta (a fiocco) o lunga (a filo continuo),<br />
arrangiata in modo caotico e tenuta coerente con <strong>di</strong>verse tecniche (agugliatura, termosaldatura, etc.) I<br />
polimeri più usati per la manifattura delle fibre dei geotessili sono polipropilene e poliestere.<br />
GEOGRIGLIE: sono costituite da una struttura bi<strong>di</strong>mensionale e vengono prodotti estrudendo un foglio <strong>di</strong><br />
plastica o saldando e collegando barre perpen<strong>di</strong>colari, con aperture variabili da 1 a 10 cm. Hanno forma<br />
geometrica ben definita, presentano un elevato carico <strong>di</strong> rottura e sono impiegate soprattutto con funzione <strong>di</strong><br />
rinforzo dei terreni. Materiale più usato: polietilene (a volte polipropilene e poliestere).<br />
GEORETI: sono prodotte per estrusione <strong>di</strong> due fili che si intersecano formando una struttura tri<strong>di</strong>mensionale<br />
a rete che mostra buone caratteristiche per un funzionamento come dreno. Materiale più usato: polietilene (a<br />
volte polipropilene e poliestere).<br />
GEOCOMPOSITI: sono prodotti ottenuti dalla combinazione <strong>di</strong> due o più <strong>di</strong>versi geosintetici e, talvolta,<br />
anche materiali naturali.<br />
Le più tipiche configurazioni sono:<br />
- geotessile + georete<br />
- geotessile + geomembrana<br />
- geotessile + bentonite + geotessile (geocompositi bentonitici).
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriere/strati in materiali sintetici<br />
FUNZIONE PRODOTTI DESCRIZIONE<br />
Filtrazione<br />
Drenaggio<br />
Separazione<br />
Protezione<br />
Impermeabilizzazione<br />
geotessili,<br />
geocompositi<br />
georeti,<br />
geocompositi<br />
geotessili,<br />
geocompositi<br />
geotessili nontessuti,<br />
georeti,<br />
geocompositi<br />
geomembrane,<br />
geocompositi<br />
Consentono il passaggio <strong>di</strong> flui<strong>di</strong><br />
impedendo il "pompaggio" <strong>di</strong><br />
particelle <strong>di</strong> terreno<br />
Trasportano flui<strong>di</strong> e gas<br />
Impe<strong>di</strong>scono la contaminazione<br />
tra due <strong>di</strong>fferenti terreni o<br />
materiali <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa granulometria<br />
Impe<strong>di</strong>scono il danneggiamento<br />
meccanico <strong>di</strong> strutture, materiali<br />
o <strong>di</strong> altri geosintetici<br />
Costituiscono barriera ai flui<strong>di</strong>
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriere/strati in materiali sintetici<br />
Le principali funzioni richieste ai <strong>di</strong>versi componenti del sistema sono:<br />
• impermeabilizzazione<br />
• filtrazione del percolato (flusso verticale)<br />
• drenaggio del percolato (flusso orizzontale)<br />
• filtrazione <strong>di</strong> acqua<br />
• drenaggio <strong>di</strong> acqua<br />
• supporto meccanico<br />
• protezione meccanica<br />
• separazione<br />
• controllo dell’erosione
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriere/strati<br />
IMPERMEABILIZZAZIONE: è la funzione principale per un sistema barriera e si basa sull’utilizzo <strong>di</strong> materiali<br />
a bassa permeabilità, includendo materiali naturali e sintetici e spesso geocompositi bentonitici.<br />
FILTRAZIONE DEL PERCOLATO: filtrazione del flusso verticale del percolato verso il fondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>.<br />
Materiali naturali, come la ghiaia, vengono usati sia per le barriere <strong>di</strong> fondo che per la copertura. I geotessili<br />
tendono ad essere intasati dalla crescita batterica e quin<strong>di</strong> non vengono utilizzati.<br />
DRENAGGIO DEL PERCOLATO: per evitare l’accumulo <strong>di</strong> percolato ed i conseguenti rischi <strong>di</strong> <strong>di</strong> infiltrazione<br />
attraverso l’impermeabilizzazione, questo deve essere convogliato ed allontanato il più velocemente<br />
possibile me<strong>di</strong>ante un sistema <strong>di</strong> drenaggio (flusso orizzontale) e <strong>di</strong> raccolta. A questo scopo sono utilizzati i<br />
materiali naturali granulari in combinazione con tubazioni drenanti.<br />
FILTRAZIONE DI ACQUA: oltre ai materiali visti per la filtrazione del percolato si possono impiegare anche<br />
la sabbia, i geotessili ed i geocompositi filtranti.<br />
DRENAGGIO DI ACQUA: l’acqua <strong>di</strong> infiltrazione sia superficiale (pioggia) sia laterale (falde superficiali) deve<br />
essere prontamente allontanata sia per evitarne il contatto con i rifiuti sia per problemi <strong>di</strong> stabilità del<br />
deposito (soprattutto importante nelle <strong>di</strong>scariche in pen<strong>di</strong>o), sia per evitare pressioni sul sistema barriera. I<br />
materiali adottabili sono gli stessi visti per il percolato e la filtrazione dell’acqua.<br />
SUPPORTO MECCANICO: questa funzione è importante per consolidare il fondo e le pareti della <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
così da assicurare una stabile fondazione per il sistema barriera.<br />
PROTEZIONE MECCANICA: le impermeabilizzazioni sintetiche devono necessariamente essere protette<br />
dall’azione <strong>di</strong> parti acuminate o taglienti contenute nei rifiuti, dalla pressione dei materiali granulari impiegati<br />
per il drenaggio e dalle sollecitazioni dei veicoli e dei mezzi operativi addetti alla movimentazione rifiuti. La<br />
protezione delle geomembrane può essere ottenuta impiegando sabbia, ghiaia <strong>di</strong> ridotta <strong>di</strong>mensione,<br />
materiali <strong>di</strong> scarto fini (ad es. ceneri <strong>di</strong> carbone) e per le pareti i pneumatici riempiti con terreno sfuso. Questi<br />
materiali possono essere accoppiati a geotessili e geocompositi.
ELEMENTI COSTRUTTIVI – Barriere/strati<br />
SEPARAZIONE: l’accoppiamento <strong>di</strong> materiali a <strong>di</strong>versa granulometria può dar luogo ad una<br />
indesiderata compenetrazione tra i materiali che potrebbe ridurre l’efficienza delle loro funzioni.<br />
Per separare ad esempio strati <strong>di</strong> argilla da strati <strong>di</strong> ghiaia vengono usati con successo i<br />
geotessili non-tessuto.<br />
CONTROLLO DELL’EROSIONE: una volta completato un settore <strong>di</strong> scarico e provveduto alla<br />
copertura finale è necessario proteggerlo dall’erosione del vento e delle acque. Georeti<br />
speciali ed altri materiali (stuoie rinforzate) forniscono una soluzione al problema. Spesso<br />
associati a materiali <strong>di</strong> supporto per la messa a verde.
ELEMENTI COSTRUTTIVI – ESEMPI IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDO/PARETI<br />
40 cm ghiaia lavata 20/30 (<strong>di</strong> fiume)<br />
2x500g/m 2 tessuto-non-tessuto antiperforante<br />
2 mm geomembrana HDPE<br />
30 cm bentonite so<strong>di</strong>ca preidratata<br />
1x500g/m 2 tessuto-non-tessuto<br />
40 cm ghiaia lavata 20/30 (<strong>di</strong> fiume)<br />
2x500g/m 2 tessuto-non-tessuto antiperforante<br />
2 mm geomembrana HDPE<br />
1 m argilla (k≤10 -9 m/s)<br />
In generale una configurazione dello strato <strong>di</strong> fondo con doppia impermeabilizzazione composita, associata<br />
alla presenza <strong>di</strong> una strato drenante interno, rappresenta la configurazione più sicura (<strong>di</strong> solito per rifiuti<br />
pericolosi, ma anche utilizzata per non pericolosi/urbani).<br />
Lo strato drenante offre un sistema <strong>di</strong> controllo ed allontanamento del percolato che fosse eventualmente<br />
penetrato attraverso la prima impermeabilizzazione (a causa <strong>di</strong> rotture) impedendo l’accumulo sulla<br />
seconda impermeabilizzazione (no battente).<br />
D.Lgs. 36/2003 – requisito minimo NP e P<br />
LETTO DRENANTE<br />
GEOMEMBRANA<br />
ARGILLA<br />
LETTO DRENANTE<br />
GEOMEMBRANA<br />
ARGILLA<br />
LETTO DRENANTE > 0,5 m<br />
GEOMEMBRANA<br />
ARGILLA > 1 m<br />
(MATERIALE MINERALE)
ELEMENTI COSTRUTTIVI – DRENAGGIO del PERCOLATO<br />
I sistemi <strong>di</strong> raccolta del percolato sono generalmente composti dai seguenti elementi:<br />
- Strato drenante <strong>di</strong>sposto sul fondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, con la funzione <strong>di</strong> captare e convogliare il percolato<br />
nei collettori; questo strato dovrà essere in grado <strong>di</strong> assicurare la stessa funzione del collettore drenante,<br />
qualora questo si dovesse successivamente danneggiare.<br />
Nella pratica più comune viene utilizzata ghiaia pulita <strong>di</strong> pezzatura compresa tra 16 e 32 mm. Lo strato<br />
drenante si trova al <strong>di</strong> sopra dello strato impermeabilizzante, <strong>di</strong> solito una geomembrana, con<br />
l’interposizione <strong>di</strong> uno strato <strong>di</strong> separazione in geotessile, che ha lo scopo <strong>di</strong> proteggere la geomembrana<br />
dalle azioni <strong>di</strong> taglio e deformazione della ghiaia stessa.<br />
In alternativa al materiale naturale,<br />
lo strato drenante può essere realizzato<br />
per mezzo <strong>di</strong> georeti<br />
GEORETE accoppiata con<br />
GEOTESSILE NON TESSUTO<br />
singolo<br />
doppio
ELEMENTI COSTRUTTIVI – DRENAGGIO del PERCOLATO<br />
-rete <strong>di</strong> tubazioni (collettori <strong>di</strong> drenaggio), alloggiata all’interno dello strato drenante, che<br />
permetta <strong>di</strong> raccogliere e allontanare rapidamente fuori dalla <strong><strong>di</strong>scarica</strong> il percolato captato<br />
dallo strato drenante.<br />
Per la progettazione della rete dei collettori drenanti devono essere considerate i seguenti<br />
punti:<br />
-Caratteristiche dei materiali (resistenza meccanica, resistenza chimica, resistenza<br />
all’aumentare della temperatura).<br />
I materiali più utilizzati sono HDPE (con densità maggiore rispetto a quello delle<br />
geomembrane) e PVC. I tubi <strong>di</strong> drenaggio sono dotati <strong>di</strong> fori o fessure che garantiscono<br />
un’adeguata area <strong>di</strong> afflusso (= area libera in ingresso in cm2 per metro <strong>di</strong> lunghezza del tubo)<br />
<strong>di</strong> almeno 100 cm2 <strong>di</strong> almeno 100 cm /m. 2 /m.<br />
In previsione <strong>di</strong> possibili incrostazioni il <strong>di</strong>ametro del foro non deve essere inferiore ai 12 mm<br />
e le fessure devono avere un’ampiezza <strong>di</strong> almeno 5 mm.
ELEMENTI COSTRUTTIVI – DRENAGGIO del PERCOLATO<br />
- <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o delle pendenze <strong>di</strong> fondo e dei collettori <strong>di</strong> raccolta.<br />
In <strong>di</strong>pendenza della morfologia dell’area il lay-out della rete può variare e assumere <strong>di</strong>verse configurazioni.<br />
Il fondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> dovrà quin<strong>di</strong> essere conformato in modo da conferire le adeguate pendenze e<br />
costituire il piano <strong>di</strong> posa delle tubazioni.<br />
Schemi alternativi <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> drenaggio <strong>di</strong> fondo Esempi <strong>di</strong> sistemazioni del fondo
- Spaziatura e <strong>di</strong>sposizione dei collettori <strong>di</strong> raccolta.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – DRENAGGIO del PERCOLATO<br />
La rete <strong>di</strong> raccolta può essere strutturata secondo rami principali, costituita da collettori che convogliano<br />
<strong>di</strong>rettamente il percolato nei pozzetti raccolta, e da rami secondari, costituita da trincee <strong>di</strong> ghiaia <strong>di</strong><br />
pezzatura grossa nelle quali posso essere alloggiati tubi forati che garantiscono una maggiore velocità <strong>di</strong><br />
movimento del percolato verso le linee <strong>di</strong> compluvio.<br />
I collettori principali <strong>di</strong> raccolta del percolato vanno posizionati nel fondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> in corrispondenza<br />
delle linee <strong>di</strong> compluvio, al <strong>di</strong> sopra della barriera <strong>di</strong> impermeabilizzazione. Solitamente le tubature vengono<br />
protette con cumuli <strong>di</strong> ghiaione (30-70 mm) allo scopo <strong>di</strong> garantire un più rapido convogliamento dle<br />
percolato dallo strato drenante ai collettori.<br />
Nelle aree pianeggianti la pendenza dei collettori e la <strong>di</strong>stanza minima tra i tubi devono essere stabilite l’una<br />
in <strong>di</strong>pendenza dall’altra. La pendenza minima delle tubazioni principali dovrebbe essere almeno dell’1% per<br />
consentire, nel caso <strong>di</strong> basse portate <strong>di</strong> percolato, una sufficiente velocità del flusso. L’incremento al 2%<br />
della pendenza assicura che non si verifichi se<strong>di</strong>mentazione delle particelle <strong>di</strong>lavate dal percolato.<br />
Per consentire la conservazione dell’efficienza del sistema drenante, anche dopo ebentuali rotture, la<br />
<strong>di</strong>stanza fra i collettori non deve superiore ai 50-60 m (<strong>di</strong>ametro minimo 200-300 mm per permette<br />
ispezione con sonde e manutenzione)
Rappresentazione schematica del collettore <strong>di</strong> raccolta del percolato sul fondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>
ELEMENTI COSTRUTTIVI – DRENAGGIO del PERCOLATO<br />
- Conservazione della geometria della rete drenante in <strong>di</strong>pendenza dei valori dei ce<strong>di</strong>menti del terreno <strong>di</strong><br />
sottofondo<br />
E’ necessario considerare sempre che il terreno <strong>di</strong> sottofondo subirà ce<strong>di</strong>menti causati dalla pressione<br />
dell’ammasso <strong>di</strong> rifiuti depositati. In virtù <strong>di</strong> tali ce<strong>di</strong>menti la pendenza dei collettori può essere mo<strong>di</strong>ficata.<br />
In fase <strong>di</strong> progettazione sarà opportuno eseguire uno stu<strong>di</strong>o preliminare dei possibili ce<strong>di</strong>menti del piano <strong>di</strong><br />
posa e prevedere pendenze maggiori <strong>di</strong> quelle teoricamente necessarie.<br />
Nel caso in cui il terreno presenti marcate <strong>di</strong>suniformità <strong>di</strong> costituzione e caratteristiche, il sistema <strong>di</strong><br />
drenaggio potrà essere costituito da più reti in<strong>di</strong>pendenti.
ELEMENTI COSTRUTTIVI – DRENAGGIO del PERCOLATO<br />
-sistema <strong>di</strong> drenaggi verticali, che si sviluppano per l’intera altezza dello deposito, la cui funzione è quella<br />
<strong>di</strong> costituire delle vie preferenziali per il movimento del percolato dagli strati <strong>di</strong> rifiuti sovrastanti verso il<br />
fondo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>.<br />
Il sistema <strong>di</strong> drenaggio viene completato da pozzi verticali costituiti da un rivestimento laterale (tratti<br />
cilindrici <strong>di</strong> rete elettrosaldata o anelli <strong>di</strong> calcestruzzo forati <strong>di</strong>ametro circa 80 cm) e riempiti <strong>di</strong> ghiaia nella<br />
quale viene inserito un tubo in polietilene rigido microfessurato, allo scopo <strong>di</strong> captare contemporaneamente<br />
anche il biogas. I pozzi poggiano su una piastra <strong>di</strong> fondazione <strong>di</strong> cemento armato.<br />
I pozzi hanno la funzione <strong>di</strong> drenare il percolato in<br />
corrispondenza dei <strong>di</strong>versi strati <strong>di</strong> rifiuto: infatti il materiale<br />
impiegato per la copertura interme<strong>di</strong>a potrebbe impe<strong>di</strong>re un<br />
regolare flusso del percolato verso il fondo con conseguenti<br />
e indesiderati ristagni.
ELEMENTI COSTRUTTIVI – DRENAGGIO del PERCOLATO<br />
- pozzetti <strong>di</strong> raccolta finale, facilmente accessibili per consentire l’ispezione e la manutenzione dei<br />
collettori <strong>di</strong> drenaggio.<br />
Il percolato in arrivo dai collettori <strong>di</strong> drenaggio deve essere recapitato in appositi pozzetti <strong>di</strong> raccolta e da qui<br />
allontanato per gravità o per pompaggio.<br />
I materiali più frequentemente utilizzati sono calcestruzzo rinforzato, vetroresina, polietilene.<br />
Inserire figura 5.9 pag 136 Cossu-Frangipane
Malfunzionamento del sistema <strong>di</strong> drenaggio<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – DRENAGGIO del PERCOLATO<br />
Problemi: occlusione, deformazione, per<strong>di</strong>te e rottura della tubazione <strong>di</strong> drenaggio<br />
<strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> laboratorio sulle occlusioni hanno <strong>di</strong>rettamente collegato lo sporcamento dei materiali drenanti al<br />
contenuto organico dei rifiuti<br />
La deposizione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti nel sistema drenante avviene per due meccanismi:<br />
• i batteri della fermentazione ed i batteri ferro/manganese riducenti, operano la conversione <strong>di</strong><br />
parte della frazione organica in aci<strong>di</strong> grassi volatili che si <strong>di</strong>ssolvono nel percolato. Questo<br />
provoca una riduzione del pH, aumentando la <strong>di</strong>ssoluzione della frazione inorganica (metalli);<br />
• i batteri riducenti del metano e dei solfati causano la formazione <strong>di</strong> solfuri insolubili e <strong>di</strong><br />
carbonati, dagli ioni metallici che si sono precedentemente <strong>di</strong>ssolti nel percolato così la<br />
deposizione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti ha luogo quando il percolato contiene sia composti organici<br />
facilmente degradabili e composti inorganici.<br />
I maggiori danni possono avvenire quando si utilizzano materiali molto fini e ben assortiti, con una<br />
significativa <strong>di</strong>minuzione della porosità.<br />
Il geotessile può perdere completamente la permeabilità.<br />
Per ridurre la formazione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti è necessario ridurre l’intensità e la durata della biodegradazione <strong>degli</strong><br />
aci<strong>di</strong> ad es. favorendo la degradazione aerobica, con pretrattamenti <strong>di</strong> compostaggio, <strong>di</strong>minuzione del<br />
riempimento, raccolta <strong>di</strong>fferenziata della frazione organica.
ELEMENTI COSTRUTTIVI –CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
“Le <strong>di</strong>scariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati <strong>di</strong> impianti per l'estrazione dei gas<br />
che garantiscano la massima efficienza <strong>di</strong> captazione e il conseguente utilizzo energetico” (D. Lgs.<br />
36/2003).<br />
“La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e<br />
per la salute umana” (D. Lgs. 36/2003) (anche in termini <strong>di</strong> sicurezza dell’ambiente <strong>di</strong> lavoro) “l'obiettivo è<br />
quello <strong>di</strong> non far percepire la presenza della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> una ristretta fascia <strong>di</strong> rispetto” (D. Lgs.<br />
36/2003).<br />
Gli obiettivi del sistema <strong>di</strong> captazione, trattamento/utilizzo sono:<br />
- garantire la sicurezza all’interno della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> e nelle aree limitrofe<br />
- minimizzare le emissioni moleste, ed eventualmente nocive, che possono esercitare un forte impatto<br />
negativo sulla popolazione limitrofa, sul personale dell’impianto e sulla vegetazione<br />
- consentire il recupero <strong>di</strong> una fonte <strong>di</strong> energia rinnovabile.<br />
Una corretta gestione del biogas deve innanzitutto garantire le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza in <strong><strong>di</strong>scarica</strong>,<br />
me<strong>di</strong>ante il controllo dell’infiammabilità della miscela costituente il biogas e la prevenzione <strong>di</strong> meccanismi <strong>di</strong><br />
migrazione e <strong>di</strong> accumulo del biogas.<br />
Il biogas può trovarsi nell’intervallo <strong>di</strong> infiammabilità a seguito <strong>di</strong> un’eccessiva aspirazione o all’accumulo in<br />
ambienti chiusi interni alla <strong><strong>di</strong>scarica</strong> (locali <strong>di</strong> servizio, componenti della rete <strong>di</strong> raccolta del biogas o del<br />
percolato) o esterni (cantine, seminterrati, etc.) in seguito a migrazione laterale nel terreno.<br />
Un sistema completo <strong>di</strong> captazione, trattamento/utilizzo comprende i seguenti elementi:<br />
- sistema <strong>di</strong> captazione<br />
- rete <strong>di</strong> trasporto<br />
- impianto <strong>di</strong> pre-trattamento<br />
- utilizzo/trattamento finale
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
Il sistema <strong>di</strong> captazione del biogas può essere posizionato nel corpo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> durante la fase<br />
operativa o al momento della chiusura.<br />
E’ tuttavia buona norma procedere alla captazione del biogas sin dalle prime fasi <strong>di</strong> esercizio della <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
(dopo sei mesi - un anno <strong>di</strong> esercizio).<br />
A tale scopo è opportuno adottare tutti i possibili interventi progettuali (coltivazione per lotti a rapido<br />
esaurimento, sistemi <strong>di</strong> captazione temporanei orizzontali o verticali) e gestionali (interventi mirati a<br />
velocizzare l’instaurazione della fase metanigena stabile ad es. basamento <strong>di</strong> compost o rifiuti degradati<br />
aerobicamente, etc) per accelerare i tempi <strong>di</strong> attivazione del sistema <strong>di</strong> captazione.<br />
Dal momento che la qualità del biogas è inevitabilmente<br />
variabile da una zona all’altra, è opportuno strutturare la<br />
rete <strong>di</strong> captazione in sottoreti separate.<br />
In particolare vengono solitamente realizzate due sottoreti:<br />
una principale ed una secondaria.<br />
La rete principale capta il biogas dalle zone centrali del<br />
deposito dove la qualità è migliore; la depressione è<br />
controllata al fine <strong>di</strong> ridurre al minimo l’infiltrazione <strong>di</strong> aria<br />
esterna.<br />
La rete secondaria preleva il biogas dalle zone periferiche<br />
dove (minore ammasso <strong>di</strong> rifiuti, maggiore infiltrazione <strong>di</strong><br />
aria) la qualità è inferiore.<br />
Può poi essere presente un sistema <strong>di</strong> captazione esterno<br />
alla <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, con l’unica funzione <strong>di</strong> sicurezza rispetto alla<br />
migrazione del biogas.
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
La rete <strong>di</strong> captazione del biogas deve essere <strong>di</strong>mensionata sulla base dei seguenti dati:<br />
- Produzione massima specifica <strong>di</strong> biogas (m 3 /t R/h)<br />
- Volume <strong>di</strong> influenza dei manufatti <strong>di</strong> captazione (pozzi verticali, orizzontali, drenaggi)<br />
La produzione <strong>di</strong> biogas è variabile nel tempo, con un massimo, in genere, dopo alcuni anni dal deposito<br />
se il sistema viene realizzato fin dall’inizio: <strong>di</strong>mensionamento sulla base <strong>di</strong> modelli <strong>di</strong> produzione con<br />
opportuni margini <strong>di</strong> sicurezza<br />
se il sistema viene realizzato dopo alcuni anni, è necessario tenere conto dell’età dei rifiuti e del grado <strong>di</strong><br />
decomposizione, utilizzando anche dati misurati in situ.<br />
Relativamente al volume <strong>di</strong> influenza, sono state proposte numerose espressioni teoriche o empiriche per<br />
la valutazione del raggio <strong>di</strong> influenza, che tuttavia trovano scarsa applicazione pratica a causa<br />
dell’eterogeneità spaziale dell’ammasso dei rifiuti, delle modalità <strong>di</strong> deposito, <strong>degli</strong> assestamenti.<br />
Si ricorre pertanto ad assunzioni derivanti dall’esperienza:<br />
- pozzi <strong>di</strong> captazione verticali: raggio <strong>di</strong> influenza non superiore ai 30 m<br />
- pozzi <strong>di</strong> captazione orizzontale: raggio <strong>di</strong> influenza non superiore a 10 m<br />
Tali <strong>di</strong>stanze possono essere anche inferiori, in virtù dei seguenti fattori:<br />
- spessore dei rifiuti<br />
- <strong>di</strong>stanza dal confine<br />
- finalità della captazione (bonifica o recupero energetico)
Pozzi <strong>di</strong> captazione verticali.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
Questa è la tipologia più <strong>di</strong>ffusa per <strong>di</strong>versi motivi legati alla praticità, al ren<strong>di</strong>mento ed ai fattori economici.<br />
Non è tuttavia raccomandabile nelle <strong>di</strong>scariche <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà ridotta (< 10 m), per le quali si fa ricorso in<br />
genera a drenaggi orizzontali.<br />
I pozzi vengono trivellati a secco, con <strong>di</strong>ametri<br />
variabili in genera da un minimo <strong>di</strong> 0,3 m fino ad un<br />
massimo <strong>di</strong> 1 m (valore consigliato non inferiore a 0,6<br />
m).<br />
Il riempimento del pozzo viene effettuato con ghiaia<br />
silicea <strong>di</strong> granulometria me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 30/60, mentre il<br />
tratto terminale superiore viene sigillato con materiale<br />
impermeabilizzante (argilla e bentonite).<br />
All’interno del pozzo viene collocato il tubo <strong>di</strong><br />
captazione micro o macro fessurato, <strong>di</strong>mensionato<br />
sulla base delle portate <strong>di</strong> estrazione e delle velocità<br />
minime del gas nelle tubazioni.<br />
Tenuto conto della necessità <strong>di</strong> inserire eiettori<br />
per l’estrazione del percolato, è comunque<br />
raccomandabile un <strong>di</strong>ametro non inferiore ai 140<br />
mm.<br />
La testa <strong>di</strong> pozzo deve essere ispezionabile e dotata<br />
<strong>di</strong> un sistema per l’intercettazione del gas in<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> emergenza.<br />
Nella realizzazione dei pozzi si deve tenere conto<br />
<strong>degli</strong> assestamenti <strong>di</strong>fferenziali tra massa <strong>di</strong> rifiuti e<br />
tubazione che possono causa problemi <strong>di</strong><br />
connessione alla rete <strong>di</strong> trasporto superficiale.<br />
Figura 6.1 pag 223<br />
cossu frangipane
Pozzi <strong>di</strong> captazione verticali perforati.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
Il sistema <strong>di</strong> pozzi verticali permette una considerevole facilità <strong>di</strong> regolazione: tramite la regolazione delle<br />
valvole <strong>di</strong> testa si può calibrare la depressione nelle varie zone a seconda delle necessità.<br />
Si possono escludere aree in cui, per <strong>di</strong>versi motivi, la miscela è <strong>di</strong> qualità inferiore, o convogliare tali<br />
miscele alla rete <strong>di</strong> trasporto secondaria.<br />
L’efficienza <strong>di</strong> estrazione dai pozzi verticali è particolarmente con<strong>di</strong>zionata dal possibile, anzi frequente,<br />
riempimento dei pozzi da parte del percolato. E’ pertanto necessario pre<strong>di</strong>sporre un collegamento con la<br />
rete <strong>di</strong> captazione del percolato o un sistema <strong>di</strong> estrazione dai pozzi me<strong>di</strong>ante eiettori.
Pozzi <strong>di</strong> captazione verticali in opera.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
Questa tipologia <strong>di</strong> manufatti viene realizzata durante l’esercizio della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, utilizzando una camicia <strong>di</strong><br />
lunghezza superiore ai 3 m (in acciaio o HDPE) all’interno della quale viene alloggiato un tubo fessurato<br />
immerso nella ghiaia.<br />
Man mano che si raggiunge il bordo superiore della camicia, la stessa viene sollevata con una gru. Se la<br />
camicia è sigillata superiormente è possibile effettuare la captazione del biogas sin dalla prima fase<br />
operativa della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>.<br />
Una soluzione più semplice è costituita dalla sovrapposizione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> anelli forati in calcestruzzo o <strong>di</strong><br />
gabbioni <strong>di</strong> rete metallica <strong>di</strong> altezza pari a circa 1-1,5 m e <strong>di</strong>ametro 0,5-2m, con un filtro interno in ghiaia<br />
silicea ed una tubazione <strong>di</strong> estrazione del biogas
Drenaggi orizzontali.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista della messa in opera e quin<strong>di</strong> dei costi, un sistema <strong>di</strong> captazione orizzontale, costituito da<br />
trincee <strong>di</strong> sezione variabile, riempite <strong>di</strong> ghiaia i cui è installato un tubo fessurato, risulta notevolmente più<br />
favorevole rispetto ai pozzi verticali.<br />
I sistemi orizzontali non costituiscono ostacolo per le operazioni <strong>di</strong> smaltimento quoti<strong>di</strong>ano dei rifiuti e sono<br />
pertanto idonei ad una captazione del biogas effettuata sin dalle prime fasi <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> una <strong><strong>di</strong>scarica</strong>.<br />
Per contro i sistemi orizzontali risentono maggiormente dei fenomeni <strong>di</strong> assestamento che possono<br />
provocare rotture o blocchi della rete <strong>di</strong> captazione. Per questo motivo la lunghezza massima deve essere<br />
contenuta al <strong>di</strong> sotto <strong>degli</strong> 80-100 m, impiegando materiali resistenti (HDPE) con <strong>di</strong>ametri appropriati per<br />
l’ispezione ed i lavaggi.<br />
La pendenza dei dreni deve essere superiore al 3% in <strong>di</strong>rezione dei pozzetti <strong>di</strong> drenaggio verticale, che<br />
vanno previsti ogni 15-20 m.<br />
La <strong>di</strong>stanza verticale fra i dreni varia da 5 a 10 m, mentre quella orizzontale può arrivare fino a 40 m.<br />
L’efficienza <strong>di</strong> captazione è molto inferiore rispetto a quella dei pozzi verticali, in quanto la stratificazione dei<br />
rifiuti aumenta ulteriormente l’anisotropia della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, con permeabilità del gas superiore in senso<br />
orizzontale rispetto a quella in senso verticale.<br />
Il volume <strong>di</strong> influenza, quin<strong>di</strong>, potrà avere un’altezza massima <strong>di</strong> 10 m, larghezza massima <strong>di</strong> 30 m<br />
lunghezza massima leggermente superiore a quella del dreno. Il raggio <strong>di</strong> influenza è inoltre influenzato<br />
dalla frequenza e dalla natura <strong>degli</strong> strati <strong>di</strong> copertura interme<strong>di</strong>a.<br />
E’ possibile che si formino battenti idraulico <strong>di</strong> percolato all’interno dei dreni rendendo necessaria la la<br />
connessione alla rete del percolato.
Sistema <strong>di</strong> captazione orizzontale, costituito da trincee <strong>di</strong> sezione variabile riempite <strong>di</strong> ghiaia, in cui è istallato un tubo<br />
fessurato
Drenaggi misti.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
La captazione del biogas e del percolato avvengono sfruttando al stessa rete, costituita da pozzi verticali e<br />
drenaggi orizzontali collegati alla rete <strong>di</strong>r accolta del percolato. Tutti gli sbocchi esterni dovranno essere<br />
dotati <strong>di</strong> sifoni per evitare la fuoriuscita <strong>di</strong> biogas. Si avrà in tutti i casi una limitata solubilizzazione del<br />
biogas nel percolato.<br />
Figura 6.6 pag 230 cossu frangipane
SISTEMI DRENO MISTO<br />
Geotessile<br />
filtrante<br />
Geomembrana<br />
HDPE 2mm<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
Ghiaia 40/60<br />
Tubo fessurato HDPE Ø<br />
110 mm <strong>di</strong> captazione del<br />
biogas<br />
Tubo fessurato PVC Ø 75<br />
mm per reiniezione<br />
percolato<br />
Rifiuti<br />
Torcia<br />
Cisterne<br />
Percolato<br />
livello -10<br />
livello -3<br />
drenaggio periferico
Rete <strong>di</strong> trasporto.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
La rete <strong>di</strong> trasporto è costituita dai manufatti e dalle tubazioni che collegano i punti <strong>di</strong> captazione della<br />
<strong><strong>di</strong>scarica</strong> alla centralina <strong>di</strong> aspirazione. La configurazione della rete <strong>di</strong>pende dalle caratteristiche del sito,<br />
dalle scelte progettuali (sistemi <strong>di</strong> controllo, tipologia <strong>di</strong> trattamento finale del biogas) e da fattori economici.<br />
I criteri progettuali della rete <strong>di</strong> trasporto possono essere così sintetizzati:<br />
- in presenza <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong> recupero energetico è necessario prevedere due sottoreti <strong>di</strong> trasporto: una<br />
per il biogas <strong>di</strong> caratteristiche adeguate per la combustione ed un’altra per quello <strong>di</strong> cattiva qualità;<br />
- le linee dovranno essere dotate <strong>di</strong> adeguate pendenze, mai inferiori al 2%, considerando gli assestamenti;<br />
- per minimizzare gli effetti <strong>degli</strong> assestamenti è necessario minimizzare gli attraversamenti della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> e<br />
sistemare la maggior parte della rete sul terreno circostante;<br />
- devono essere previsti opportuni separatori della condensa formatasi nelle condutture. Ogni punto <strong>di</strong><br />
minimo della rete dovrà essere dotato <strong>di</strong> un separatore, per evitare occlusioni parziali delle tubazioni;<br />
- laddove si attivi il sistema <strong>di</strong> captazioni fin dalle prime fasi <strong>di</strong> esercizio della <strong><strong>di</strong>scarica</strong>, è opportuno<br />
pre<strong>di</strong>sporre inizialmente una rete <strong>di</strong> trasporto provvisoria, che verrà successivamente sostituita da quella<br />
definitiva (una volta esaurita la <strong><strong>di</strong>scarica</strong> e raggiunto un sufficiente livello <strong>di</strong> assestamento).
Rete <strong>di</strong> trasporto.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
Sono possibili <strong>di</strong>verse configurazioni della rete <strong>di</strong> trasporto.<br />
- Rete aperta lineare: tutti i punti <strong>di</strong> captazione sono collegati in serie o in parallelo. La configurazione in<br />
serie è la più semplice e prevede un unico collettore che collega tutti i punti <strong>di</strong> captazione. Tale soluzione è<br />
applicabile solo per piccole <strong>di</strong>scariche, allo scopo <strong>di</strong> minimizzare le emissioni <strong>di</strong> biogas nell’ambiente.<br />
La soluzione in parallelo è la più onerosa, in quanto tutti i punti <strong>di</strong> captazione sono collegati al collettore<br />
principale (buona qualità) o a quello secondario (bassa qualità). Questa configurazione consente <strong>di</strong><br />
controllare la qualità <strong>di</strong> ogni singolo punto d captazione e <strong>di</strong> agire sulle valvole <strong>di</strong> regolazione e <strong>di</strong><br />
derivazione alla rete secondaria, per ottimizzare il recupero energetico. Tale configurazione ha tuttavia costi<br />
<strong>di</strong> impianto elevati.<br />
- Rete aperta ramificata: i punti <strong>di</strong> captazione sono raggruppati a grappoli che convergono in un unico punto<br />
<strong>di</strong> raccordo al collettore (o ai collettori in presenza <strong>di</strong> due reti separate), dove sono posti gli organi <strong>di</strong><br />
regolazione e controllo del collettore immissario. Questa soluzione è concettualmente valida, ma presenta<br />
la debolezza intrinseca delle reti aperte: nel caso si verifichi una <strong>di</strong>sfunzione in un tratto <strong>di</strong> collettore (per<br />
esempio un assestamento che danneggia i giunti o la tubazione stessa) si ha blocco totale dell’attività <strong>di</strong><br />
tutti i punti collegati.<br />
Rete aperta lineare Rete aperta ramificata<br />
Figura 6.7 pag 231 a b cossu frangipane
Rete <strong>di</strong> trasporto.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – CAPTAZIONE DEL BIOGAS<br />
- Rete ad anello: è costituita da un anello principale (o due) cui si collegano i singoli collettori lineari o<br />
ramificati (anello ibrido). E’ una soluzione moto <strong>di</strong>ffusa in quanto rappresenta un punto <strong>di</strong> equilibrio tra la<br />
necessità <strong>di</strong> minimizzare i costi <strong>di</strong> impianto e quella <strong>di</strong> ottimizzare il controllo e l’eventuale recupero<br />
energetico. Consente inoltre, nella maggior parte dei casi, <strong>di</strong> posare l’anello all’esterno della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> su<br />
terreno compatto e <strong>di</strong> ridurre sostanzialmente i rischi <strong>di</strong> blocco della captazione, insiti nelle strutture <strong>di</strong> rete<br />
aperta.<br />
Rete ad anello Rete ad anello ramificata
ELEMENTI COSTRUTTIVI – COPERTURA<br />
La copertura superficiale finale della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> deve rispondere ai seguenti criteri:<br />
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;<br />
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;<br />
- riduzione al minimo della necessità <strong>di</strong> manutenzione;<br />
- minimizzazione dei fenomeni <strong>di</strong> erosione;<br />
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni <strong>di</strong> subsidenza localizzata.
DISCARICHE RIFIUTI INERTI<br />
La copertura deve essere realizzata me<strong>di</strong>ante una<br />
struttura multistrato costituita, dall'alto verso il<br />
basso, almeno dai seguenti strati:<br />
1. strato superficiale <strong>di</strong> copertura con spessore ≥ 1<br />
m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali <strong>di</strong><br />
copertura ai fini del piano <strong>di</strong> ripristino ambientale e<br />
fornisca una protezione adeguata contro l'erosione<br />
e consenta <strong>di</strong> proteggere le barriere sottostanti<br />
dalle escursioni termiche;<br />
2. strato drenante con spessore ≥ 0,5 m in grado <strong>di</strong><br />
impe<strong>di</strong>re la formazione <strong>di</strong> un battente idraulico<br />
sopra le barriere <strong>di</strong> cui ai successivi punti 3) e 4);<br />
3. strato minerale superiore compattato <strong>di</strong><br />
spessore ≥ 0,5 m e <strong>di</strong> bassa conducibilità idraulica;<br />
4. strato <strong>di</strong> regolarizzazione per la corretta messa<br />
in opera <strong>degli</strong> elementi superiori e costituito da<br />
materiale drenante.<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – COPERTURA - D.Lgs. 36/2003<br />
DISCARICHE RIFIUTI NON PERICOLOSI<br />
DISCARICHE RIFIUTI PERICOLOSI<br />
La copertura deve essere realizzata me<strong>di</strong>ante una<br />
struttura multistrato costituita, dall'alto verso il<br />
basso, almeno dai seguenti strati:<br />
1. strato superficiale <strong>di</strong> copertura con spessore ≥ 1<br />
m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali <strong>di</strong><br />
copertura ai fini del piano <strong>di</strong> ripristino ambientale e<br />
fornisca una protezione adeguata contro l'erosione<br />
e <strong>di</strong> proteggere le barriere sottostanti dalle<br />
escursioni termiche;<br />
2. strato drenante protetto da eventuali<br />
intasamenti con spessore ≥ 0,5 m in grado <strong>di</strong><br />
impe<strong>di</strong>re la formazione <strong>di</strong> un battente idraulico<br />
sopra le barriere <strong>di</strong> cui ai successivi punti 3) e 4);<br />
3. strato minerale compattato dello spessore ≥ 0,5<br />
m e <strong>di</strong> conducibilità idraulica k ≤ 10 -8 m/s o <strong>di</strong><br />
caratteristiche equivalenti, integrato da un<br />
rivestimento impermeabile superficiale per gli<br />
impianti <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong> <strong>di</strong> rifiuti pericolosi;<br />
4. strato <strong>di</strong> drenaggio del gas e <strong>di</strong> rottura capillare,<br />
protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥<br />
0,5 m;<br />
5. strato <strong>di</strong> regolarizzazione con la funzione <strong>di</strong><br />
permettere la corretta messa in opera <strong>degli</strong> strati<br />
sovrastanti.
DISCARICHE RIFIUTI INERTI<br />
ELEMENTI COSTRUTTIVI – COPERTURA - D.Lgs. 36/2003<br />
STRATO SUPERFICIALE > 1m<br />
STRATO DRENANTE > 0,5<br />
DISCARICHE RIFIUTI NON PERICOLOSI<br />
DISCARICHE RIFIUTI PERICOLOSI<br />
STRATO MINERALE k < 10<br />
COMPATTATO > 0,5 m<br />
-8 m/s<br />
STRATO DRENAGGIO GAS<br />
> 0,5 m<br />
STRATO DI<br />
REGOLARIZZAZIONE
PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO- D.Lgs. 36-Alleg.II<br />
Il piano <strong>di</strong> sorveglianza e controllo deve essere costituito da un documento<br />
unitario, comprendente le fasi <strong>di</strong> realizzazione, gestione e postchiusura,<br />
relativo a tutti i fattori ambientali da controllare, i parametri ed i<br />
sistemi unificati <strong>di</strong> prelevamento, trasporto e misure dei campioni, le<br />
frequenze <strong>di</strong> misura ed i sistemi <strong>di</strong> restituzione dei dati. Il piano è finalizzato<br />
a garantire che:<br />
• tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono<br />
progettate in tutte le con<strong>di</strong>zioni operative previste;<br />
• vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i<br />
<strong>di</strong>sagi per la popolazione;<br />
• venga assicurato un tempestivo intervento in caso <strong>di</strong> imprevisti;<br />
• venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella<br />
gestione;<br />
• venga garantito l’accesso ai principali dati <strong>di</strong> funzionamento nonché ai<br />
risultati delle campagne <strong>di</strong> monitoraggio.<br />
Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi <strong>di</strong> personale<br />
qualificato ed in<strong>di</strong>pendente con riguardo ai parametri ed alle perio<strong>di</strong>cità<br />
riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato su:<br />
– acque sotterranee;<br />
– percolato;<br />
– acque <strong>di</strong> drenaggio superficiale;<br />
– gas <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong>;<br />
– qualità dell’aria;<br />
– parametri meteoclimatici;<br />
– stato del corpo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong> (volumi).
Tabella 1 - Analisi delle acque<br />
sotterranee<br />
Parametri *=Parametri fondamentali<br />
*pH<br />
*temperatura<br />
*Conducibilità elettrica<br />
*Ossidabilità Kubel<br />
BOD5<br />
TOC<br />
Ca, Na, K<br />
*Cloruri<br />
*Solfati<br />
Fluoruri<br />
IPA<br />
*Metalli: Fe, Mn<br />
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr Vi, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn<br />
Cianuri<br />
*Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico<br />
Composti organoalogenati (compreso cloruro <strong>di</strong> vinile)<br />
Fenoli<br />
Pestici<strong>di</strong> fosforiti e totali<br />
Solventi organici aromatici<br />
Solventi organici azotati<br />
Solventi clorurati
Tabella 2 - Parametri da misurare e frequenza minima delle misure*<br />
Percolato<br />
Acque superficiali <strong>di</strong><br />
drenaggio<br />
Qualità dell’aria<br />
Parametro<br />
Frequenza<br />
Misure <strong>di</strong> gestione<br />
operativa<br />
Volume Mensile Semestrale<br />
Composizione Trimestrale Semestrale<br />
Composizione Trimestrale Semestrale<br />
Immissioni gassose potenziali e<br />
pressione atmosferica<br />
Mensile Semestrale<br />
Gas <strong>di</strong> <strong><strong>di</strong>scarica</strong> Composizione Mensile Semestrale<br />
Acque sotterranee<br />
Dati meteoclimatici<br />
Topografia dell’area<br />
Livello <strong>di</strong> falda Mensile Semestrale<br />
Composizione Trimestrale Semestrale<br />
precipitazioni Giornaliera<br />
Frequenza<br />
Misure<br />
gestione post- operativa<br />
Temperatura (min, max, 14 h CET) Giornaliera Me<strong>di</strong>a mensile<br />
Direzione e velocità del vento Giornaliera non richiesta<br />
Evaporazione Giornaliera<br />
Umi<strong>di</strong>tà atmosferica (14 h CET) Giornaliera Me<strong>di</strong>a mensile<br />
Struttura e composizione della<br />
<strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
Comportamento d’assestamento del<br />
corpo della <strong><strong>di</strong>scarica</strong><br />
Annualmente<br />
Semestrale<br />
Giornaliera, sommata ai valori<br />
mensili<br />
Giornaliera, sommata ai valori<br />
mensili<br />
Semestrale per i primi 3 anni<br />
quin<strong>di</strong> annuale