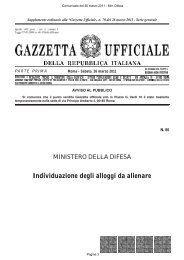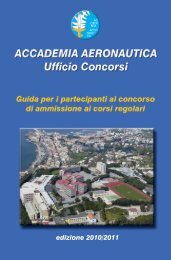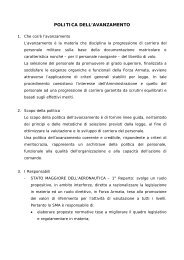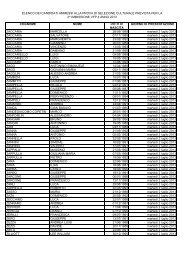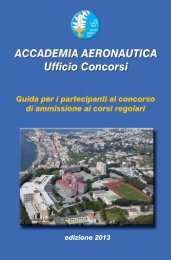2010 è iniziato come Annus Mirabilis. Durante il suo scorrere ...
2010 è iniziato come Annus Mirabilis. Durante il suo scorrere ...
2010 è iniziato come Annus Mirabilis. Durante il suo scorrere ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I<strong>2010</strong> <strong>è</strong> <strong>iniziato</strong> <strong>come</strong> <strong>Annus</strong> <strong>Mirab<strong>il</strong>is</strong>. <strong>Durante</strong> <strong>il</strong> <strong>suo</strong> <strong>scorrere</strong> avremo infatti ben cinque anniversari canonici, tutti legati<br />
tra loro attraverso la meteorologia e rappresentati nella copertina di questo primo numero che segna “un cambio”<br />
anche nella grafica della Rivista.<br />
In considerazione di questa felice coincidenza astrale abbiamo chiesto a vari autori di scriverci articoli significativi dei<br />
vari eventi. Si inizia dal più antico dei fatti, <strong>il</strong> centenario: nel 1910 nacque infatti <strong>il</strong> Servizio di Meteorologia Aeronautica,<br />
<strong>il</strong> nostro antenato, con caratteri profondamente diversi da quanti erano già sulla scena sin dai secoli precedenti. La nascita<br />
del Servizio di Meteorologia Aeronautica segnò un momento di sostanziale cambiamento per la materia atmosferica.<br />
L’osservazione e la previsione del tempo si estesero nello spazio per cogliere quei dettagli fino ad allora trascurati che<br />
divennero indispensab<strong>il</strong>i per garantire che quei pezzi di ferro, legno e tela potessero librarsi nell’aria in condizioni di sicurezza.<br />
Ancora oggi, a un secolo di distanza, la meteorologia aeronautica <strong>è</strong> la più accurata e da essa discendono le altre,<br />
quasi <strong>come</strong> una benefica ricaduta. Successivamente, andando in ordine decrescente d’anzianità, così <strong>come</strong> si conviene<br />
nelle Forze Armate dove l’anzianità fa grado, celebriamo i 70 anni della nostra Rivista di Meteorologia Aeronautica:<br />
un bellissimo traguardo. Fondata nel 1937 fu sospesa durante gli anni del conflitto per cui la sua numerazione si <strong>è</strong> sfasata<br />
di un po’ rispetto al secolo, ma per noi sono settanta annualità edite e questo conta. Segue a un decennio di distanza,<br />
e quindi celebra i <strong>suo</strong>i 60 anni, l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, l’Agenzia delle Nazioni Unite che rappresenta le<br />
attività meteorologiche sul globo. Ente fondamentale per le attività di coordinamento che svolge, fa sì che la meteorologia<br />
sia una scienza omogenea e quindi <strong>come</strong> branca della fisica sia riproducib<strong>il</strong>e. Ogni misurazione fatta seguendo le raccomandazioni<br />
dell’organizzazione genera misure omogenee e confrontab<strong>il</strong>i tra loro indipendentemente dal luogo e dal<br />
tempo in cui sono state effettuate. Scendendo lungo la chioma di Crono troviamo <strong>il</strong> cinquantenario delle “Frecce Tricolori”,<br />
la Pattuglia Acrobatica Nazionale vanto e orgoglio dell’Aeronautica M<strong>il</strong>itare italiana. Da 50 anni evoluiscono nei cieli<br />
portando <strong>il</strong> Tricolore nelle più remote lande della Terra a ricordare l’italico ardimento per la gioia dei grandi e dei piccini.<br />
Anche loro però prima di ogni volo acrobatico o di trasferimento chiedono all’aruspice meteorologo le condizioni che <strong>il</strong><br />
tempo riserberà loro. Ultima celebrazione <strong>è</strong> riservata al venticinquennale delle attività italiane nel continente antartico.<br />
Oggi queste azioni sono condotte dal Piano nazionale di ricerca in Antartide, organismo creato proprio con lo scopo di<br />
dare unità alle ricerche in terra australe. Sin dalla prima spedizione la meteorologia ha avuto un ruolo importantissimo<br />
per lo svolgimento delle operazioni e per le ricerche sul clima e sull’ambiente, sia antartico sia generale del pianeta. I nostri<br />
colleghi sono presenti dall’inizio per dare <strong>il</strong> loro contributo professionale alle attività nelle condizioni estreme polari,<br />
senza però sottrarsi alle attività di ricerca sul clima. Un numero quindi ricco di celebrazioni ma anche di informazioni su<br />
un ampio panorama di eventi. Buona lettura.<br />
Costante De Simone
RIVISTA DI METEOROLOGIA AERONAUTICA - N° 1/<strong>2010</strong><br />
ANNO 70 N° 1 GENNAIO - MARZO <strong>2010</strong><br />
Organo del Servizio<br />
Meteorologico dell’Aeronautica<br />
Sommario<br />
Anno 70° gennaio - marzo <strong>2010</strong><br />
Editoriale<br />
Costante De Simone 1<br />
<strong>2010</strong>: un anno di ricorrenze<br />
Paolo Capizzi 5<br />
Un sistema integrato per <strong>il</strong> supporto alle previsioni<br />
meteorologiche<br />
Paola Colagrande, Marco Fontana 19<br />
Il sistema di previsione del mare "NETTUNO"<br />
Luciana Bertotti, Luigi Cavaleri, Costante<br />
De Simone, Lucio Torrisi, Antonio Vocino 25<br />
A proposito di meteorologia<br />
Un inspiegab<strong>il</strong>e fenomeno meteorologico: <strong>il</strong> "Minigap"<br />
Gianpaolo Miniscalco 37
Notiziario<br />
EDITORE MINISTERO della DIFESA<br />
AERONAUTICA MILITARE<br />
STATO MAGGIORE AERONAUTICA<br />
UFFICIO GENERALE SPAZIO AEREO E METEOROLOGIA<br />
Legale rappresentante: gen. isp. Massimo Capaldo<br />
Le opinioni espresse negli articoli della Rivista di Meteorologia Aeronautica sono degli Autori e<br />
non riflettono necessariamente lo spirito del Servizio Meteorologico. La riproduzione degli articoli<br />
<strong>è</strong> consentita citando la fonte e inviando copia alla direzione della Rivista. La collaborazione<br />
alla Rivista <strong>è</strong> aperta a tutti gli studiosi.<br />
Periodico trimestrale fondato nel 1937<br />
Anno 70° gennaio-marzo <strong>2010</strong><br />
Fascicolo n.1<br />
Registrazione n. 191/1984<br />
Tribunale di Roma-Sez. Stampa<br />
Direttore responsab<strong>il</strong>e:<br />
Costante De Simone<br />
Redazione:<br />
Paolo Capizzi,<br />
Marina Bonanni, Maria Paola Giammatteo, IItalo Piattelli<br />
Comitato scientifico:<br />
Paolo Pagano, Sergio Pasquini, Paolo Cesolari<br />
Corrado Tedeschi, Paolo Malco, Tiziano Colombo,<br />
Luigi De Leonibus, Massimo Ferri, Gaetano Cosimo Cacciola<br />
Consulenti di redazione:<br />
Adriano Raspanti, Roberto Tajani, Alessandro Galliani<br />
Progetto grafico e impaginazione:<br />
Italo Piattelli<br />
Direzione e produzione<br />
Rivista di Meteorologia Aeronautica<br />
Viale dell’Università, 4 - 00185 Roma Italia<br />
tel.:+39 06 4986 7039- fax.:+39 06 4986 7051<br />
Esercitazione "Amitie 2009" 41<br />
Sommario climatologico italiano<br />
del trimestre gennaio - marzo <strong>2010</strong><br />
gennaio 44<br />
febbraio 56<br />
marzo 68<br />
sito web:www.meteoam.it - e-ma<strong>il</strong>:rivista@meteoam.it<br />
La Rivista di Meteorologia <strong>è</strong> ceduta esclusivamente per abbonamento postale.<br />
L’abbonamento dà diritto a ricevere quattro fascicoli della pubblicazione.<br />
Le quote per <strong>il</strong> <strong>2010</strong> sono:<br />
Abbonamento annuale<br />
Italia: € 20,00 - Estero: € 30,00<br />
Fascicoli arretrati<br />
Italia: € 5,00 - Estero: € 7,50<br />
L’abbonamento può essere acceso mediante versamento sul c/c postale 597005 intestato a:<br />
COMAER - Quartier Generale - Servizio Amministrativo - Rivista di Meteorologia<br />
Viale dell’Università, 4 - 00185 Roma.<br />
In alternativa, tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente<br />
Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)<br />
Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN)<br />
Paese Check CIN ABI CAB N. CONTO<br />
IT 04 D 07601 03200 000000597005<br />
Codice BIC: BPPIITRRXXX<br />
L’abbonamento decorre dal primo numero ut<strong>il</strong>e successivo alla data del versamento.<br />
Per accelerare le pratiche di accensione dell’abbonamento si prega di inviare<br />
via fax al +39 06 4986 7051 copia della ricevuta del c/c postale o del bonifico bancario.<br />
Stampa e fotocomposizione:<br />
STILGRAFICA s.r.l.<br />
Via Ignazio Pettinengo, 31/33<br />
00159 Roma - Italia<br />
Tel.: +39 06 43588200 - Fax.: +39 06 4385693
In senso orario: cento anni di Meteorologia Aeronautica,<br />
sessant’ anni dell’Organizzazione Mondiale di Meteorologia,<br />
cinquant’anni della creazione della Pattuglia Acrobatica<br />
Nazionale, ovvero delle Frecce Tricolori, venticinque<br />
anni di collaborazione del Servizio Meteorologico<br />
dell’A.M. con <strong>il</strong> Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide;<br />
a sinistra, centrale, la nostra ricorrenza, ovvero <strong>il</strong><br />
70° anniversario della pubblicazione della prestigiosa Rivista<br />
di Meteorologia Aeronautica.
Lavoro pervenuto <strong>il</strong> 28/03/<strong>2010</strong><br />
<strong>2010</strong>:<br />
un anno di ricorrenze<br />
a cura di Paolo Capizzi<br />
Sommario - Il <strong>2010</strong> risulterà essere un anno particolare relativamente<br />
alle ricorrenze che riguardano la nostra F.A..<br />
Tra le tante, abbiamo scelto di evidenziare quelle che sono<br />
più consone all’attività svolta dal Servizio Meteorologico e<br />
quindi più significative. Sulla copertina, abbiamo voluto<br />
rappresentare <strong>il</strong> logo di ogni evento accompagnato da una<br />
breve descrizione per meglio evidenziare l’importanza<br />
della ricorrenza. Abbiamo seguito un criterio puramente<br />
cronologico, partendo quindi dai 100 anni della “meteorologia<br />
aeronautica” per continuare con i 70 anni di vita di<br />
questa prestigiosa rivista. Ma non rivestono minore importanza<br />
i 60 anni di attività dell’Organizzazione Mondiale<br />
per la Meteorologia e i 25 anni di collaborazione in<br />
campo meteorologico con le spedizioni italiane in Antartide.<br />
Infine, abbiamo voluto mettere in risalto anche<br />
l’evento per cui tutta l’Aeronautica M<strong>il</strong>itare si sta prodigando<br />
al fine di cerebrarlo nel migliore dei modi, ovvero<br />
<strong>il</strong> cinquantenario delle Frecce Tricolori, punto di eccellenza<br />
dell’Arma Azzurra che, insieme al Servizio Meteorologico<br />
costituiscono un binomio di indubbia visib<strong>il</strong>ità per la<br />
F.A., mettendo continuamente in luce le capacità e la preparazione<br />
dei nostri uomini. Come una staffetta nel tempo,<br />
insieme tramandano quell’eredità che già un secolo fa legava<br />
la meteorologia aeronautica all’assistenza dei primi<br />
palloni aerostatici del Regio Esercito.<br />
Summary - The year <strong>2010</strong> w<strong>il</strong>l result to be a special year<br />
about recurrences in our Air Force. Among those, we have<br />
chosen to lay stress on those that have more sense for the<br />
activity of our meteorological service. On the cover of our<br />
meteorological magazine, we have decided to represent<br />
the logo of any chosen event matched with a brief description<br />
of the relative event. We have chosen a purely<br />
chronological criteria, starting with 100 years of aeronautical<br />
meteorology and going on with the 70 years of this<br />
prestigious magazine. It is not less important the 60 years<br />
of the World Meteorological Organization and the 25 years<br />
of collaboration in meteorological field with the antartica<br />
Italian project. The last but not the least we have wished<br />
to put in evidence also the event for that the entire Italian<br />
Air Force is making an effort, that is the 50 years of<br />
our acrobatic air patrol, the wellknown “frecce tricolori”,<br />
another eminent unit of the air force that, together the<br />
Meteorological Service, gives a wide visib<strong>il</strong>ity of ab<strong>il</strong>ity and<br />
training of our “men”. Like a relay in the time, together<br />
they transmit an inheritance that already<br />
bound a century ago the Aeronautical Meteorology to the<br />
first aerostat Real Army balloons activity.
La nascita della meteorologia aeronautica<br />
Vittorio Cantù, Gianluca Venanzi<br />
La storia dell’Osservatorio<br />
di Vigna di Valle<br />
<strong>è</strong> strettamente<br />
legata al sorgere<br />
della tecnicaaeronautica<br />
in Italia. Il Reparto dell’Esercito cui erano affidate le<br />
attività aeronautiche (nel 1906 denominato Brigata Specialisti<br />
del Genio) incominciò a ut<strong>il</strong>izzare <strong>il</strong> Lago di Bracciano<br />
quale campo sperimentale allorché Gaetano Arturo<br />
Crocco e Ottavio Ricaldoni costruirono un aliscafo per provare<br />
eliche aeree (1905-1907). Alla fine del 1906, <strong>il</strong> maggiore<br />
Maurizio Moris, comandante del Reparto summenzionato,<br />
chiese un ufficiale adatto a impiantare un<br />
osservatorio aerologico. Nel novembre del 1907 l’ottenne<br />
nella persona del tenente Att<strong>il</strong>io Cristoforo Ferrari <strong>il</strong> quale,<br />
dopo aver visitato i principali osservatori aerologici europei,<br />
intraprese la costruzione dell’edificio nel giugno del<br />
1909, mentre già si eseguivano le prime misurazioni mediante<br />
palloni p<strong>il</strong>ota con attrezzature di fortuna. I lavori<br />
procedettero alacremente e già nel maggio del 1910 ebbe<br />
inizio l’attività regolare dell’Osservatorio. L’intendimento<br />
del maggiore Moris era la costituzione di un Osservatorio<br />
che avrebbe dovuto «curare studi e lavori di esplorazione<br />
dell’atmosfera (alta e bassa) intesi a contribuire convenientemente<br />
alla migliore conoscenza dell’oceano aereo<br />
nel quale i nascenti aeromob<strong>il</strong>i dovevano navigare» (Att<strong>il</strong>io<br />
Cristoforo Ferrari: vita e opere nelle sue memorie,<br />
Roma - Associazione Culturale Aeronautica 1950).<br />
L’Osservatorio di Vigna di Valle in analogia a quello di<br />
Lindenberg (Berlino), diretto dal professor Richard Assmann<br />
e visitato dal Ferrari, era composto da:<br />
• un fabbricato principale, sede degli uffici, della biblioteca<br />
e dei gabinetti scientifici;<br />
• una rimessa per ricoverare palloni frenati, cervi volanti<br />
e palloni sonda;<br />
• un fabbricato destinato a ospitare un’officina meccanica<br />
di precisione e un’officina elettrica;<br />
• una torretta c<strong>il</strong>indrica del diametro di circa 4 metri girevole<br />
intorno al <strong>suo</strong> asse e contenente un verricello elettrico<br />
per le ascensioni dei cervi volanti e dei palloni frenati.<br />
Contemporaneamente, nel luglio del 1910, <strong>il</strong> Comitato<br />
Talassografico Italiano, costituito l’anno precedente dalla<br />
Società italiana per <strong>il</strong> progresso delle scienze, acquistò ca-<br />
rattere ufficiale ed ebbe anche <strong>il</strong> compito di provvedere<br />
all’esplorazione dell’atmosfera nei riguardi della navigazione<br />
aerea. Il Ferrari incominciò subito a operare per riunire<br />
in un unico servizio tutte le stazioni aerologiche italiane.<br />
Una convenzione tra i Ministeri della Guerra e<br />
dell’Agricoltura, Industria e Commercio e <strong>il</strong> Comitato Talassografico<br />
Italiano approvata nell’ottobre del 1911 e<br />
sancita da un decreto nel febbraio del 1912 istituì <strong>il</strong> Servizio<br />
Aerologico Italiano. Esso durò fino al 1925 ed ebbe<br />
sempre <strong>come</strong> centro l’Osservatorio di Vigna di Valle, che<br />
in quel periodo si chiamò Regia Stazione Aerologica principale.<br />
Sebbene <strong>il</strong> Ministero della Pubblica Istruzione non<br />
avesse partecipato alla convenzione, furono comandati<br />
presso l’Osservatorio alcuni professori delle scuole medie<br />
superiori che poi non abbandonarono più gli studi aeronautici<br />
e meteorologici: Cesare Fabris (marzo 1911), Giulio<br />
Elliot e Raffaele Gia<strong>come</strong>lli (novembre 1913), Giuseppe<br />
Crestani e Mario Tenani (gennaio 1915). <strong>Durante</strong> la<br />
prima guerra mondiale la stazione contribuì allo sforzo bellico<br />
aeronautico svolgendo in particolare le seguenti attività:<br />
• taratura e riparazione degli strumenti di bordo (l’impianto<br />
costruito nel 1916 per eseguire tali lavori fu uno dei<br />
primi al mondo);<br />
• sv<strong>il</strong>uppo delle tecniche per tenere conto dei fattori meteorologici<br />
nella determinazione della rotta degli aeromob<strong>il</strong>i;<br />
• istruzione meteorologica del personale aeronautico.<br />
L‘attività didattica del personale della stazione, che<br />
aveva avuto inizio con <strong>il</strong> corso di meteorologia e aerologia<br />
tenuto dal Fabris nel 1912-1913 alla Scuola di Costruzioni<br />
Aeronautiche, nel periodo bellico fu notevolmente intensificata<br />
ad opera del Crestani, del Gia<strong>come</strong>lli e del Tenani.<br />
Foto d’epoca della sensoristica della stazione meteo di<br />
Vigna di Valle.
Torretta per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio dei cosidetti “cervi volanti” ovvero,<br />
aqu<strong>il</strong>oni dotati di alcuni sensori meteo.<br />
Il primo quindicennio di vita dell’Osservatorio rappresenta<br />
certamente <strong>il</strong> periodo nel quale esso fu più conosciuto<br />
e incise maggiormente sullo sv<strong>il</strong>uppo della scienza<br />
e della tecnica nazionale. Non soltanto ne trattarono<br />
spesso riviste tecniche, ma la rivista mens<strong>il</strong>e del Touring<br />
Club Italiano gli dedicò un ampio ed esauriente articolo<br />
nell’ottobre del 1913 e la 1 a edizione della Guida d’Italia<br />
dello stesso sodalizio, pur molto più succinta dell’attuale,<br />
nel descrivere <strong>il</strong> percorso Roma-Viterbo nota: «km 47<br />
ferm. Vigna di Valle: a poco distanza a d., l’edifico della<br />
Regia Stazione Aerologica principale....» Ne parlò anche<br />
l’allora diffusissima rivista “La Lettera” nel 1915. Il Ferrari<br />
divenne l’anima dell’attività di ricerca e sperimentazione<br />
della Regia Aeronautica e fu tra l’altro <strong>il</strong> creatore dei<br />
grandiosi impianti di Guidonia. L’Elliot, con la costituzione<br />
del Ministero dell’Aeronautica, divenne capo della<br />
Sezione Aerologica dell’ufficio dell’aviazione civ<strong>il</strong>e e traffico<br />
aereo. L’8 novembre 1927 perse la vita in un incidente<br />
di volo a Centocelle. Nell’agosto del 1937 la Stazione Aerologica<br />
Sperimentale assunse <strong>il</strong> nome di Osservatorio<br />
Scientifico Sperimentale di Meteorologia Aeronautica (OS-<br />
SMA) e venne intitolato alla memoria del maggiore Elliot,<br />
continuando la propria attività con prestigio fino all’ 8 set-<br />
<br />
tembre 1943. Il Gia<strong>come</strong>lli, forse influenzato dall’eccezionale<br />
personalità di Gaetano Arturo Crocco, <strong>il</strong> più eminente<br />
tra i tecnici che realizzarono i primi dirigib<strong>il</strong>i m<strong>il</strong>itari<br />
italiani, si appassionò ai problemi aeronautici in<br />
generale e fu, per lunghissimi anni, <strong>il</strong> redattore capo dell’Aerotecnica,<br />
la rivista dell’omonima associazione. Il Fabris<br />
e <strong>il</strong> Crestani passarono al Magistrato delle Acque e ne<br />
crearono la sezione meteorologica, senz’altro la più importante<br />
dal punto di vista scientifico tra quelle degli Enti<br />
periferici del Servizio Idrografico dei Lavori Pubblici. Il Crestani<br />
insegnò inoltre all’università di Padova consolidandone<br />
la tradizione di studi meteorologici avviata da Luigi<br />
De Marchi, <strong>il</strong> grande precursore che nel 1884 intravide<br />
l’ut<strong>il</strong>ità di supporre costante la velocità nei moti atmosferici.<br />
Il Tenani, nel 1924, fu chiamato all’Istituto Idrografico<br />
della Marina <strong>come</strong> professore di meteorologia e<br />
geofisica e diede notevole impulso alla sezione geofisica<br />
dell’istituto, provvedendo anche a pubblicare diversi manuali<br />
di fondamentale importanza. Il periodo successivo<br />
alla grande guerra <strong>è</strong> meno ben documentato del precedente.<br />
Verso <strong>il</strong> 1923, l’Osservatorio divenne sede dei corsi<br />
della scuola aerologisti. I corsi di formazione e perfezionamento<br />
per ufficiali geofisici che vi si tennero più tardi,<br />
videro tra gli insegnanti figure <strong>come</strong> i professori F<strong>il</strong>ippo<br />
Eredia, Raul B<strong>il</strong>ancini e Oreste De Pasquale. I danni causati<br />
dalla Seconda Guerra Mondiale furono notevoli e le attività<br />
dell’Osservatorio ripresero solo nel 1952, con la realizzazione<br />
di strumenti di nuova concezione, l’organizzazione<br />
di reti di misura e la riparazione e sperimentazione di radiosonde,<br />
apparecchiature ideate per la misura della pressione,<br />
temperatura, direzione e intensità del vento e umidità<br />
che, portate nell’atmosfera da un pallone-sonda,<br />
trasmettono a terra i r<strong>il</strong>evamenti effettuati ai vari livelli.<br />
Altri compiti d’indagine assegnati furono la misura dell’elettricità<br />
atmosferica, della turbolenza nei bassi strati<br />
e della radiazione solare. Iniziò un crescente potenziamento<br />
dell’Osservatorio, che fu dotato di officine e laboratori<br />
propri, sotto <strong>il</strong> cui coordinamento scientifico vennero<br />
istituiti gli osservatori di Monte Cimone, di Cagliari,<br />
di Messina e di Taranto. Nel 1979 l’Osservatorio completò<br />
<strong>il</strong> <strong>suo</strong> potenziamento e assunse l’attuale configurazione.<br />
Dal 1985 l’Ente ha assunto <strong>il</strong> nome di “Reparto Sperimentazioni<br />
di Meteorologia Aeronautica” (ReSMA). Attualmente<br />
<strong>il</strong> Reparto, dipendente dal CNMCA, assicura la gestione<br />
operativa di una stazione per le osservazioni meteorologiche<br />
che effettua servizio 24 ore su 24. Nell’ambito dei propri<br />
compiti istituzionali, continua a garantire <strong>il</strong> controllo<br />
di qualità delle osservazioni meteorologiche, a certificare,<br />
per <strong>il</strong> Servizio Meteorologico, la rispondenza della
strumentazione meteo agli standard nazionali e internazionali<br />
e ad effettuare campagne di misurazioni speciali<br />
che consentono di valutare le diverse prestazioni degli apparati<br />
osservativi di interesse.<br />
Tra queste, si ricorda l’ultima campagna internazionale,<br />
organizzata dall’OMM (Organizzazione Meteorologica Mondiale),<br />
per <strong>il</strong> confronto tra pluviometri di diversa fattura<br />
e concezione tecnica, mirata soprattutto alla misura dell’intensità<br />
di precipitazione (fondamentale per gli eventi<br />
estremi) nonché la misura accurata del consueto valore cumulato<br />
su tempi lunghi. Il Reparto gestisce, inoltre, una<br />
Unità Meteo Mob<strong>il</strong>e operativa, ovvero un mezzo attrezzato<br />
per le osservazioni e le previsioni, di cui può avvalersi anche<br />
personale meteorologico proveniente dagli Enti territoriali,<br />
consentendo <strong>il</strong> supporto e l’assistenza meteorologica<br />
per diverse esigenze sul territorio nazionale, anche<br />
non legato a quelle di F. A.. Ultimamente si può citare l’impiego<br />
in supporto alle operazioni di aiuto per <strong>il</strong> disastroso<br />
terremoto de L’Aqu<strong>il</strong>a, disponendosi in piena operatività in<br />
meno di due ore dall’ordine di missione per la zona interessata<br />
dal sisma, con grande beneficio per quanti si sono<br />
trovati ad operare in condizioni di grave disagio materiale<br />
e morale per fornire <strong>il</strong> migliore soccorso alle popolazioni<br />
colpite. Inoltre <strong>il</strong> ReSMA gestisce e cura gli archivi della<br />
rete di osservazioni speciali, <strong>come</strong> per l’ozono (tre stazioni:<br />
Vigna di Valle, Monte Cimone e Messina), la radiazione<br />
solare globale e durata del soleggiamento (30 stazioni),<br />
l’anidride carbonica (1 stazione: Monte Cimone) e<br />
l’analisi chimica delle precipitazioni. Nell’ambito del programma<br />
dell’Organizzazione Mondiale di Meteorologia,<br />
denominato (Global Atmosphere Watch) GAW (veglia mondiale<br />
dell’atmosfera), i dati di ozono vengono inviati al<br />
Centro di Raccolta Mondiale di Downsvieu in Canada, quelli<br />
Foto d’epoca dell’attuale sede del ReSMA.<br />
di radiazione solare globale e durata del soleggiamento al<br />
(World Radiation Data Center) WRDC di San Pietroburgo in<br />
Russia e quelli di precipitazione al Centro Mondiale di raccolta<br />
di Albany (New York).<br />
70 anni di storia della Rivista di Meteorologia Aeronautica<br />
Gaetano Cosimo Cacciola<br />
La Rivista di Meteorologia<br />
Aeronautica <strong>è</strong> l’organo<br />
di informazione tecnicoscientifico<br />
professionale<br />
del Servizio Meteorologico<br />
dell’Aeronautica. La pubblicazione,<br />
diffusa in Italia<br />
e all’estero, costituisce un<br />
insostituib<strong>il</strong>e strumento di<br />
informazione per la collettività<br />
meteorologica nazionale<br />
e un valido terreno di<br />
confronto per tutti gli operatori del settore. Nella sua duplice<br />
veste, specialistica e divulgativa, essa consente la<br />
presentazione di lavori e ricerche originali, promuove la<br />
meteorologia italiana e fa conoscere le attività e le linee<br />
di sv<strong>il</strong>uppo del Servizio Meteorologico. Le funzioni di editore<br />
sono svolte, su delega del Ministro, dal capo del Servizio<br />
Meteorologico, attualmente <strong>il</strong> generale ispettore<br />
Massimo Capaldo, mentre <strong>il</strong> direttore responsab<strong>il</strong>e <strong>è</strong> <strong>il</strong><br />
brigadier generale Costante De Simone che ricopre anche<br />
l’incarico di direttore del Centro Nazionale di Meteorologia<br />
e Climatologia Aeronautica di Pratica di Mare (RM).<br />
Quest’anno ricorre <strong>il</strong> 70° anno di attività della Rivista, <strong>il</strong><br />
cui primo numero vide la luce nel luglio del 1937. Da allora<br />
“molte pagine” sono state scritte e vogliamo di seguito<br />
ricordare <strong>il</strong> cammino della Rivista, diviso in serie secondo<br />
una variazione cromatica della copertina.<br />
La prima serie, “bianco-celeste” (1937-1943) (vedi immagine<br />
soprastante), risultava molto curata, nel classico<br />
st<strong>il</strong>e dell’epoca e sulla copertina, di un colore bianco-celeste<br />
con varie tonalità, oltre al titolo in alto, un bel disegno<br />
simbolizzante <strong>il</strong> diuturno impegno del Servizio e dei<br />
meteorologi di quel tempo (figura in apertura). A suggellare<br />
l’opera, la firma prestigiosa del prof. F<strong>il</strong>ippo Eredia,<br />
vero animatore e promotore dell’iniziativa editoriale nonché<br />
primo direttore della Rivista. Con questa veste tipografica<br />
la Rivista continua le sue pubblicazioni fino al 1943<br />
quando, per i noti avvenimenti conseguenti all’armistizio<br />
dell’8 settembre, sospende l’attività. In questa prima fase
furono pubblicati complessivamente<br />
26 fascicoli.<br />
Dopo la sosta forzata dovuta<br />
agli eventi bellici, la<br />
ripresa delle pubblicazioni<br />
avvenne nel 1948, con la<br />
seconda serie, “avorio”<br />
(1948-1975).<br />
Dopo la morte improvvisa<br />
del prof. F<strong>il</strong>ippo Eredia,<br />
(14 febbraio 1948), gli<br />
successe <strong>come</strong> direttore <strong>il</strong><br />
prof. Raoul B<strong>il</strong>ancini, già allievo di Eredia e insigne studioso,<br />
<strong>il</strong> quale diresse egregiamente <strong>il</strong> periodico fino alla<br />
fine del 1967. La veste tipografica cambiò radicalmente .<br />
Aspetto sobrio, con la copertina realizzata prevalentemente<br />
di un unico colore di fondo avorio su carta molto<br />
sott<strong>il</strong>e, tant’<strong>è</strong> che i pochi numeri superstiti presentano<br />
qualche problema di consistenza. Si decise di dare al periodico<br />
una nuova impronta; così <strong>come</strong> recita la premessa<br />
del primo fascicolo della nuova serie, <strong>il</strong> proposito principale<br />
fu quello di recuperare <strong>il</strong> tempo perduto nel progetto<br />
scientifico a causa degli eventi di guerra. La collaborazione<br />
fu aperta a tutti gli studiosi della materia, non necessariamente<br />
del Servizio, sia italiani sia stranieri. Si diede ampio<br />
spazio alla recensione di libri e articoli e ai notiziari<br />
sull’attività meteorologica in campo internazionale. Nacquero<br />
le due storiche rubriche: <strong>il</strong> Notiziario e In margine<br />
e, con <strong>il</strong> fascicolo numero due del 1948, a firma dell’ormai<br />
celeberrimo col. Edmondo Bernacca, anche Il tempo in Italia,<br />
una delle più seguite sezioni della Rivista e che, ancor<br />
oggi, offre un’analisi retrospettiva delle condizioni meteorologiche<br />
sul nostro Paese. Il col. Bernacca curò ininterrottamente<br />
la rubrica per ben 19 anni, fino al dicembre<br />
del 1967. Complessivamente, in questo secondo periodo<br />
furono pubblicati 108 fascicoli e tre supplementi. Alla fine<br />
del 1967, dopo 19 anni di assiduo e fecondo impegno, <strong>il</strong><br />
prof. B<strong>il</strong>ancini lasciò la Rivista. A seguito della costituzione<br />
del Centro Nazionale per la Fisica dell’Atmosfera e la Meteorologia<br />
(CeNFAM), attualmente IFA, in seno al Consiglio<br />
Nazionale delle Ricerche (CNR), <strong>il</strong> campo di studi della rivista<br />
si ampliò notevolmente. Dalla stretta collaborazione<br />
con <strong>il</strong> Servizio Meteorologico si sv<strong>il</strong>upparono numerosi<br />
studi e ricerche scientifiche, i cui risultati furono puntualmente<br />
pubblicati sulla Rivista.<br />
Con riferimento agli aspetti legali, dal 1968 la direzione<br />
del periodico fu istituzionalmente destinata al capo<br />
del Servizio Meteorologico in carica. Fu così che al prof. B<strong>il</strong>ancini<br />
successe <strong>il</strong> gen. prof. Giorgio Fea fino alla fine del<br />
<br />
1971. Successivamente, alla direzione del periodico si<br />
sono succeduti: <strong>il</strong> gen. Antonio Serra fino alla fine del<br />
1973; <strong>il</strong> gen. Giuseppe Cena fino alla fine del 1977; <strong>il</strong> gen.<br />
Vittorio Mastino fino al settembre del 1978; <strong>il</strong> gen. Raffaele<br />
Ferraris fino al dicembre 1979; <strong>il</strong> gen. Roberto Pirro<br />
fino al settembre 1983; <strong>il</strong> gen. Abele Nania fino al dicembre<br />
1986; <strong>il</strong> gen. Sabino Palmieri fino al dicembre 1988; <strong>il</strong><br />
gen. Francesco Fantauzzo fino al dicembre 1991; <strong>il</strong> gen.<br />
Giuseppe Faraco fino al giugno 1993; <strong>il</strong> gen. Carlo Finizio<br />
fino al febbraio 1999.<br />
Dal primo marzo 1999, data di chiusura dell’Ispettorato<br />
Telecomunicazioni e Assistenza al Volo (ITAV) e di nascita<br />
dell’Ufficio Generale per la Meteorologia (UGM), oggi 2°<br />
Reparto dell’Ufficio generale Spazio Aereo e Meteorologia<br />
(USAM), la funzione di editore, precedentemente svolta<br />
dall’Ispettore, <strong>è</strong> stata assegnata, su delega del Ministro, direttamente<br />
al capo del Servizio Meteorologico, <strong>il</strong> quale nomina,<br />
a sua volta, <strong>il</strong> direttore responsab<strong>il</strong>e. Così, fino al 15<br />
maggio 2001 la funzione di editore <strong>è</strong> stata svolta dal gen.<br />
Roberto Epifani; successivamente, dal gen. Roberto Sorani,<br />
quindi dal gen. Massimo Capaldo, attuale capo del Reparto<br />
Meteorologia dell’USAM. L’incarico di direttore responsab<strong>il</strong>e<br />
<strong>è</strong> stato assegnato al col. Stefano Zanni fino al dicembre<br />
1999, dopodiché fino a oggi, l’incarico <strong>è</strong> ricoperto dal<br />
brigadier generale Costante<br />
De Simone, attuale<br />
direttore del CNMCA. All’inizio<br />
del 1976 la veste<br />
tipografica della rivista<br />
cambiò nuovamente e<br />
siamo alla terza serie, “blu<br />
ardesia” (1976-1983), con<br />
la copertina blu ardesia<br />
con riquadro bianco a<br />
tutta pagina, titolo in<br />
bianco e, in basso al centro,<br />
per la prima volta, <strong>il</strong><br />
logo del Servizio Meteorologico. Con <strong>il</strong> numero 2 del 1978<br />
finalmente appare anche <strong>il</strong> primo disegno a colori; fino ad<br />
allora infatti, la stampa della rivista, eccezion fatta per la<br />
copertina, era stata eseguita rigorosamente in bianco e<br />
nero anche per i disegni e le fotografie. E’ questo <strong>il</strong> periodo<br />
durante <strong>il</strong> quale si consolida la collaborazione tra <strong>il</strong> Servizio<br />
Meteorologico e <strong>il</strong> Centro internazionale di cultura<br />
scientifica “Ettore Majorana” di Erice; <strong>il</strong> numero 2-3 del<br />
1980 della Rivista, fu interamente dedicato al primo corso<br />
della scuola, dal titolo Previsioni a breve e lungo termine<br />
nell’area mediterranea; l’edizione, interamente in lingua<br />
inglese, consentì di portare a conoscenza dei lettori
una considerevole parte della produzione scientifica<br />
emersa durante lo svolgimento del corso. Analoga iniziativa<br />
si ebbe con la pubblicazione<br />
del numero 2-3 del<br />
1982 che presentò i risultati<br />
del terzo corso della<br />
scuola di Erice dal titolo<br />
Previsioni meteorologiche<br />
con modelli a griglia fine.<br />
La serie si concluse con <strong>il</strong><br />
fascicolo numero 3 del<br />
1983. In questa terza fase<br />
furono pubblicati complessivamente<br />
26 fascicoli.<br />
Con la quarta serie “blu<br />
notte” (1984-2001), la copertina risulta più moderna, con<br />
titolo in alto e la parte restante occupata da un’immagine<br />
fotografica spesso attinente ad uno degli argomenti trattati<br />
all’interno. La serie ebbe varie vicissitudini e, dal<br />
1988, si stab<strong>il</strong>izzò con la pubblicazione di solo due fascicoli<br />
semestrali. Complessivamente, fino al 2001, la serie<br />
ha visto la pubblicazione di 39 fascicoli e 9 supplementi.<br />
Con <strong>il</strong> supplemento del 1994 fu data una nuova impostazione<br />
alla Rivista; atteso l’interesse crescente per l’andamento<br />
degli eventi atmosferici, <strong>il</strong> contenuto della rubrica<br />
Il tempo in Italia fu progressivamente arricchito con dati<br />
climatici e medie statistiche e si diede corso alla pubblicazione<br />
di un inserto parallelo alla rivista, supplemento appunto,<br />
dal titolo Sommario climatologico. L’esperimento<br />
piacque ai lettori e, dal 1996, <strong>il</strong> sommario assunse dignità<br />
quasi pari a quella della Rivista e la sua pubblicazione divenne<br />
regolare fino al 1999. Nel 1997, oltre al normale supplemento<br />
climatologico del fascicolo 1-2, fu pubblicato un<br />
secondo supplemento dal titolo: Informazioni sul Servizio<br />
Meteorologico dell’Aeronautica; si trattava di un’ut<strong>il</strong>e<br />
monografia che riassumeva sinteticamente <strong>il</strong> ruolo e i<br />
compiti del momento svolti dal Servizio Meteorologico, con<br />
particolare riferimento alla<br />
cooperazione in campo internazionale.<br />
In concomitanza<br />
con la soppressione<br />
dell’ITAV e la nascita dell’UGM<br />
nell’ambito del Comando<br />
Squadra Aerea, la<br />
pubblicazione della Rivista <strong>è</strong><br />
ripresa con nuovo impulso<br />
sotto la direzione, dal 2000,<br />
dell’allora Col. Costante De<br />
Simone. Con la quinta serie,<br />
“blu manganese” (2002-2007), viene ripristinata la cadenza<br />
trimestrale del periodico in modo da poter informare<br />
con maggior tempestività i lettori sui principali avvenimenti<br />
in campo nazionale e internazionale. Con <strong>il</strong><br />
primo numero del 2002 si <strong>è</strong> anche deciso di aggiornare la<br />
veste tipografica. Il logo del Servizio Meteorologico, ormai<br />
conosciuto in tutto <strong>il</strong> mondo, <strong>è</strong> stato inserito direttamente<br />
nel titolo e in ultima di copertina; si <strong>è</strong> deciso di inserire<br />
l’indirizzo web del nuovo sito del Servizio Meteorologico<br />
www.meteoam.it, sul quale la Rivista <strong>è</strong> integralmente<br />
consultab<strong>il</strong>e on-line. Anche le pagine interne sono state rivisitate<br />
e, dato <strong>il</strong> crescente interesse per gli avvenimenti<br />
meteorologici nella vita di tutti i giorni, la rubrica climatologica<br />
<strong>è</strong> stata arricchita e ampliata; la parte statisticoclimatologica<br />
<strong>è</strong> stata estesa a tutti gli osservatori meteorologici<br />
dell’Aeronautica M<strong>il</strong>itare e quella relativa al tempo<br />
in Italia <strong>è</strong> stata pure ampiamente rivisitata e ampliata, sia<br />
nella parte descrittiva sia nella parte di presentazione dei<br />
campi barici e dell’analisi frontale.<br />
Con la soppressione dell’UGM e la nascita dell’Ufficio<br />
Generale Spazio Aereo e Meteorologia e <strong>il</strong> successivo trasferimento,<br />
nell’autunno del 2008, dalla sede di Centocelle<br />
a quella di Palazzo A.M., sono stati ulteriormente sv<strong>il</strong>uppati<br />
e consolidati i rapporti<br />
di collaborazione con la redazione<br />
della Rivista Aeronautica.<br />
Con la sesta serie,<br />
“aeronautica” (2007-2009)<br />
<strong>è</strong> stata nuovamente cambiata<br />
e migliorata la veste<br />
editoriale, resa più leggera<br />
e al passo con i tempi; si <strong>è</strong><br />
migliorata l’architettura<br />
delle pagine interne e l’impostazione<br />
grafica dei lavori<br />
proposti ai lettori, sempre<br />
in un’ottica di apertura e di collaborazione con tutta<br />
la comunità scientifica della meteorologia. E’ stato ampliato<br />
<strong>il</strong> notiziario ed <strong>è</strong> stato portato a termine con successo,<br />
<strong>il</strong> progetto di attualizzazione della rubrica statistico-climatologica.<br />
In pratica, all’inizio del 2008 <strong>è</strong> stato<br />
pubblicato un ricco supplemento contenente tutti i dati<br />
dell’intera annata 2007. Nel contempo, sui fascicoli base<br />
si <strong>è</strong> dato corso alla pubblicazione della nuova rubrica climatologica<br />
che adesso riporta dati e statistiche del trimestre<br />
di copertina nonché una ricca descrizione sinottica<br />
degli eventi meteorologici dello stesso periodo. In tal<br />
modo, l’immediatezza dell’informazione meteorologica<br />
coglie <strong>il</strong> lettore nel ricordo vivo degli eventi.
Per concludere queste brevi note storiche, si può affermare<br />
che la Rivista di Meteorologia Aeronautica, per quasi<br />
70 anni, con l’eccezione della breve parentesi della seconda<br />
guerra mondiale, ha sempre rappresentato un periodico<br />
unico nel <strong>suo</strong> genere nel panorama delle pubblicazioni<br />
scientifiche italiane ed internazionali. Da sempre<br />
all’avanguardia quanto a contenuti e attualità dei lavori<br />
presentati, <strong>è</strong> stata ed <strong>è</strong> una pubblicazione molto apprezzata<br />
in Italia e all’estero. Con <strong>il</strong> presente numero, si inaugura<br />
la settima serie (<strong>2010</strong>)<br />
che presenta delle importanti<br />
novità, sia dal punto<br />
di vista editoriale con una<br />
nuova grafica, sia nei contenuti<br />
con l’aggiunta, nella ormai<br />
consolidata rubrica climatologica,<br />
della verifica<br />
mens<strong>il</strong>e dell’attendib<strong>il</strong>ità<br />
del modello ad alta risoluzione<br />
COSMO-ME.<br />
I 60 anni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale<br />
Massimo Capaldo<br />
Nel <strong>2010</strong> corrono i 60 anni<br />
dalla istituzione dell’Organizzazione<br />
Meteorologica<br />
Mondiale (OMM) la cui Convenzione<br />
fu ratificata <strong>il</strong> 23<br />
marzo 1950, giorno in cui da<br />
quell’anno, conseguentemente,<br />
si celebra la Giornata<br />
Meteorologica Mondiale.<br />
L’OMM, che attualmente consta<br />
di 189 membri, ovvero<br />
da tutti i Paesi che possano<br />
annoverare un servizio meteorologico organizzato, venne<br />
designata quale agenzia specializzata delle Nazioni Unite<br />
nell’anno successivo. Ciò in riconoscimento della sua potenzialità<br />
a contribuire ai processi di pace e benessere dell’umanità.<br />
Sessanta anni sono tanti. Tuttavia ne furono necessari<br />
più che altrettanti per giungere a tale importante<br />
risultato. In effetti, insieme a fondamentali scoperte tecnologiche,<br />
quali ad esempio l’invenzione del telegrafo<br />
(Morse, 1843) con le connesse potenzialità di scambio in<br />
tempi brevi di misure meteorologiche prese da Paesi diversi,<br />
furono i due Congressi intergovernativi di Vienna<br />
(1873) e Roma (1879) a tracciare <strong>il</strong> solco che quasi ottanta<br />
<br />
anni dopo ha portato alla costituzione dell’OMM. A Vienna<br />
ci si accordò su una sostanziale definizione di standard<br />
strumentali e osservativi, nonché sullo scambio delle misure<br />
effettuate e, con l’occasione, fu istituita la Organizzazione<br />
Meteorologica Internazionale (OMI). Un risultato<br />
fondamentale del Congresso tenuto a Roma nel 1879 fu<br />
l’istituzione di un Comitato Meteorologico Internazionale<br />
(IMC), precursore dell’attuale Consiglio Esecutivo dell’OMM,<br />
con la responsab<strong>il</strong>ità di rivedere periodicamente<br />
i progressi della OMI.<br />
Il Congresso di Roma (1879)<br />
Nonostante i primi due Congressi citati avessero carattere<br />
governativo, <strong>il</strong> Comitato Meteorologico Internazionale<br />
prese la decisione che, a tutti gli effetti, era più opportuno<br />
ed efficace che l’OMI funzionasse <strong>come</strong> Organizzazione<br />
Non-Governativa. Nel 1935 l’OMI decise di invitare i governi<br />
dei Paesi interessati a designare i direttori dei Servizi<br />
Meteorologici Nazionali a rappresentarli. Tale pratica,<br />
mantenuta in ambito OMM, porta attualmente a designare<br />
i Rappresentanti Permanenti in ottemperanza a tale prassi<br />
e alla Convenzione in vigore. Nel 1935, i direttori si riunirono<br />
in Commissioni Regionali, successivamente denominate<br />
Associazioni Regionali. La prima fu l’Africa che tuttora<br />
rappresenta la prima Associazione Regionale dell’OMM.<br />
Nel 1947 erano state ormai costituite sei Associazioni Regionali<br />
mentre l’attività meteorologica, dal momento che<br />
l’OMI non aveva un effettivo Segretariato, veniva svolta da<br />
Commissioni Tecniche cui partecipavano esperti inviati<br />
dai diversi direttori dei Servizi Meteorologici Nazionali su<br />
base volontaria. Le Commissioni affrontavano un ampio panorama<br />
di attività nei settori meteorologici sinottici legati<br />
all’agricoltura, all’oceanografia, all’aviazione con connessi<br />
interessi per le comunicazioni e per la climatologia.<br />
Altri soggetti applicativi includevano la radiazione terrestre,<br />
l’ozono, <strong>il</strong> magnetismo terrestre e l’elettricità at-<br />
Immagine del primo Congresso del WMO (World Meteorological<br />
Organization) tenutosi a Roma nel 1879.
mosferica. La ricerca era alle fondamenta dell’OMI che iniziò<br />
due importanti progetti nelle regioni polari collaborando<br />
con varie organizzazioni, e tale interesse si trasferì<br />
naturalmente all’OMM dei nostri tempi e fu strumentale al<br />
riconoscimento, già dal 1951, della nuova organizzazione<br />
quale agenzia specializzata delle Nazioni Unite per l’acqua,<br />
<strong>il</strong> tempo e <strong>il</strong> clima. Il numero dei membri <strong>è</strong> cresciuto<br />
rapidamente dai 37 del 1950 (l’Italia fu subito membro) ai<br />
<strong>suo</strong>i attuali 189, che includono 183 Stati e 6 Territori, ma<br />
<strong>è</strong> interessante osservare che, nell’ambito dell’organizzazione,<br />
tornata ad essere formalmente intergovernativa,<br />
sono state mantenute,<br />
quali organi costitutivi,<br />
le Associazioni<br />
Regionali e le<br />
Commissioni Tecniche,<br />
mentre a coadiuvare<br />
<strong>il</strong> Congresso,<br />
organo supremo dell’organizzazione,abbiamo<br />
da un lato <strong>il</strong><br />
Consiglio Esecutivo,<br />
moderno discendente<br />
Il gen. isp. Massimo Capaldo,<br />
Capo del Reparto Meteorologia<br />
dello SMA - USAM.<br />
del Comitato Internazionale<br />
dell’OMI, e <strong>il</strong><br />
Segretariato che con-<br />
duce l’importante opera di coordinamento internazionale<br />
necessaria ad assicurare la definizione, <strong>il</strong> consolidamento<br />
e <strong>il</strong> perseguimento dei diversi standard strumentali e procedurali<br />
nonché l’adeguamento delle capacità idro-meteoclimatiche<br />
degli Stati Membri. L’OMM ha sempre ben figurato<br />
nel <strong>suo</strong> periodo di attività: attraverso gli anni e grazie<br />
alle volontà del Congresso sono stati costruiti tutti quegli<br />
elementi funzionali volti ad assicurare lo scambio delle informazioni<br />
meteo-climatiche e idrologiche senza conoscere<br />
frontiere e senza limitazioni di carattere politico. In<br />
tal senso, negli anni sono stati avviati importanti ed essenziali<br />
Programmi di Cooperazione, primo fra tutti la Veglia<br />
Meteorologica Mondiale (1967) di enorme successo<br />
nell’assicurare, a carico dei membri, l’effettuazione, lo<br />
scambio globale delle osservazioni (Sistema Osservativo<br />
Globale), la loro disseminazione (Sistema di Telecomunicazioni<br />
Globale) e <strong>il</strong> loro processamento con analisi e modelli<br />
di previsione (Sistema Globale di Processamento<br />
Dati). Ciò ha consentito la messa a punto di previsioni di<br />
qualità sempre crescente, fino a raggiungere, oggi, con<br />
previsioni di sette giorni, una qualità equivalente a quella<br />
di previsioni per <strong>il</strong> giorno dopo caratteristica di sessanta<br />
anni fa. La guadagnata accuratezza ha reso le previsioni<br />
del tempo cruciali nel settore della sicurezza ma anche<br />
fondamentali nei settori socio-economici fino a rendere la<br />
meteorologia un elemento centrale alle diverse attività del<br />
mondo moderno. Le iniziative dell’OMM nel tempo sono<br />
state molteplici e di grande r<strong>il</strong>ievo. Menzionarle tutte richiederebbe<br />
molto più spazio di quello dedicab<strong>il</strong>e in questa<br />
breve nota. Tuttavia occorre citare certamente quelle<br />
che hanno maggiormente connotato l’organizzazione nella<br />
propria crescita a supporto degli Stati Membri. A valle<br />
della Prima Conferenza Mondiale sul Clima (1979), l’OMM<br />
ha intrapreso <strong>il</strong> Programma Climatico Mondiale (WCP) dedicato<br />
alla comprensione del sistema climatico per l’esigenza<br />
della società a interagire con la variab<strong>il</strong>ità del clima<br />
e delle sue mutazioni. A seguire, nello sforzo di comprensione<br />
e approfondimento delle problematiche ambiental<strong>il</strong>’OMM,<br />
ha intrapreso <strong>il</strong> Programma di Ricerca sull’Atmosfera<br />
(AReP) per <strong>il</strong> coordinamento e lo stimolo della ricerca<br />
sulla composizione dell’atmosfera e sulle previsioni numeriche<br />
con particolare attenzione sugli eventi estremi e<br />
i connessi impatti socio-economici, fondandolo su una<br />
componente di monitoraggio esercitata attraverso la rete<br />
di Veglia Atmosferica Globale (GAW) e sullo stimolo alla ricerca<br />
avanzata nei settori della modellistica atmosferica.<br />
Nel 1983, per agevolare gli Stati Membri nella costruzione<br />
delle applicazioni collegate alla fornitura dei Servizi Meteorologici<br />
Nazionali, l’OMM ha lanciato anche <strong>il</strong> Programma<br />
per le Applicazioni Meteorologiche (AMeP) che fornisce<br />
<strong>il</strong> supporto e <strong>il</strong> coordinamento necessari ai settori<br />
collegati alle risorse agricole e alimentari, la sicurezza ed<br />
efficienza alle attività di volo e alle operazioni collegate<br />
all’oceanografia nonché alla sicurezza dell’uomo in mare<br />
e lo sv<strong>il</strong>uppo delle infrastrutture e dei servizi pubblici dedicati.<br />
Facendo un salto ai tempi più recenti, vogliamo ricordare<br />
le importanti iniziative riferite al Programma di Riduzione<br />
dei Rischi determinati dai Disastri Naturali (DRRP)<br />
in cui <strong>il</strong> Servizio Meteorologico dell’Aeronautica M<strong>il</strong>itare <strong>è</strong><br />
stato tra i contributori più attivi portando la vasta esperienza<br />
maturata nel rapporto efficace e proficuo con <strong>il</strong> Dipartimento<br />
della Protezione Civ<strong>il</strong>e della Presidenza del<br />
Consiglio dei Ministri. Tale programma <strong>è</strong> ora trasversale<br />
alle diverse componenti e programmi dell’OMM istituendo<br />
procedure di messa a punto di specifici sistemi di allertamento<br />
(tsunami, uragani tropicali, ecc.) attraverso una<br />
fitta rete di enti responsab<strong>il</strong>i e centri regionali specializzati<br />
in collegamento con istituti contribuenti a diverso titolo.<br />
In tal senso l’OMM ha messo a profitto anni di cooperazione<br />
con altri importanti organizzazioni in uno<br />
sv<strong>il</strong>uppo sinergico di iniziative che altrimenti non avreb-
ero potuto trovare completo soddisfacimento all’interno<br />
della sola OMM. Per tutte basti menzionare <strong>il</strong> Programma<br />
della Ricerca sul Clima Globale in cooperazione con <strong>il</strong><br />
Consiglio Internazionale delle Unioni Scientifiche (ICSU) e<br />
l’UNESCO e l’International Panel for Climate Change<br />
(IPCC) co-sponsorizzato con <strong>il</strong> Programma Ambientale delle<br />
Nazioni Unite (UNEP) che nel 2007 ha ricevuto <strong>il</strong> premio<br />
Nobel per la Pace (insieme ad Al Gore ex vice-presidente<br />
degli Stati Uniti) per i «loro sforzi di costruzione e disseminazione<br />
di una più vasta conoscenza della variab<strong>il</strong>ità climatica<br />
antropogenica e per aver posto le fondamenta all’individuazione<br />
delle misure da prendere per contrastare<br />
tale variab<strong>il</strong>ità».<br />
Non occorre evidenziare che <strong>il</strong> successo dell’OMM sia<br />
stato costruito sul coinvolgimento dei diversi Paesi alle proprie<br />
attività, sullo sv<strong>il</strong>uppo di una cooperazione funzionale<br />
ad assicurare <strong>il</strong> progresso anche dei paesi in via di sv<strong>il</strong>uppo<br />
o con economie in transizione, garantendo la possib<strong>il</strong>ità ai<br />
Servizi Idro-Meteorologici nazionali di dotarsi degli strumenti<br />
necessari ad assistere i governi locali nei propri<br />
progetti di sv<strong>il</strong>uppo sostenib<strong>il</strong>e<br />
delle diverse attività socio-economiche.<br />
Ciò usufruendo<br />
di importanti<br />
contributi del Programma di<br />
Sv<strong>il</strong>uppo delle Nazioni Unite<br />
(UNDP), della Banca Mondiale,<br />
del Programma Alimentare<br />
Mondiale (PAM) e<br />
anche, più recentemente,<br />
della Commissione Europea.<br />
L’attuale sede del WMO a<br />
Ginevra.<br />
I professionisti del volo acrobatico: 50 anni della PAN<br />
Alessandro Cornacchini<br />
Un altro evento di<br />
particolare r<strong>il</strong>evanza<br />
per l’A.M. italiana che<br />
si celebra in quest’anno<br />
<strong>è</strong> <strong>il</strong> 50° anniversario<br />
della creazione delle<br />
note “Frecce Tricolori”,<br />
uno dei fiori all’occhiello<br />
della Forza Armata<br />
insieme al Servizio<br />
Meteorologico. In<br />
realtà <strong>il</strong> volo acrobatico<br />
ha origini più remote:<br />
era infatti <strong>il</strong> novembre 1929 quando i sergenti Citi e Briz-<br />
<br />
zolari, a bordo di due velivoli Fiat CR.20 del 1° Stormo Caccia,<br />
effettuarono alcuni passaggi a bassa quota sull’aeroporto<br />
di Campoformido realizzando una serie di looping a<br />
distanza, allora, proibitiva, ala contro ala. I due p<strong>il</strong>oti volevano<br />
mettere in evidenza in modo così spettacolare che<br />
un volo tanto spericolato era in realtà un’esigenza della<br />
“caccia”, che avrebbe permesso di ottenere <strong>il</strong> massimo nel<br />
combattimento aereo. Il colonnello Rino Corso Fougler,<br />
loro comandante, sposò in pieno quella tesi e la rappresentò<br />
ai superiori riuscendo a convincerli. Nacque così la<br />
stagione epica del volo acrobatico m<strong>il</strong>itare. Le prime pattuglie<br />
acrobatiche furono inizialmente individuate nell’ambito<br />
dei reparti da caccia: alla pattuglia del 1° Stormo<br />
seguì, nel ´36, la formazione del 4° Stormo e poi quella del<br />
6° e del 53° Stormo, che suscitarono da subito ammirazione<br />
e apprezzamento, in Italia e all’estero. Dopo la 2a Guerra Mondiale, in perfetta concordanza con la rinascita<br />
dell’Aeronautica, manifestazioni nazionali e internazionali<br />
fecero da ribalta a compagini alate leggendarie e l’acrobazia<br />
collettiva riprese dunque rapidamente quota.<br />
Negli anni 50, l’Italia veniva rappresentata dalla pattuglia<br />
del “Cavallino Rampante” della 4a Aerobrigata equipaggiata<br />
con De Hav<strong>il</strong>land DH-100 Vampire; dai Getti Tonanti<br />
della 5a Aerobrigata dotata di Republic F-84G<br />
Thunderjet; dalle Tigri Bianche della 51a Aerobrigata, con<br />
gli stessi velivoli; dal “Cavallino Rampante” della 4a Aerobrigata<br />
con i North American F-86E Sabre; dai “Diavoli<br />
Rossi” della 6a Aerobrigata con i Republic F-84F Thunderstreak;<br />
dai “Lancieri Neri” della 2a Aerobrigata su velivoli<br />
Sabre e infine di nuovo dai “Getti Tonanti” della 5a Aerobrigata<br />
con gli F-84F. Gli innumerevoli impegni della formazione<br />
acrobatica rendevano però sempre più diffic<strong>il</strong>e<br />
mantenere la formula dell’alternanza tra i reparti da caccia.<br />
Si rendeva perciò necessaria la costituzione di una pattuglia<br />
“dedicata”. Nel 1960 la pattuglia titolare era quella<br />
dei “Getti Tonanti” con i <strong>suo</strong>i F-84F, <strong>come</strong> pattuglia di<br />
Modello F-86 delle Frecce Tricolori 1958 - 1959.
iserva <strong>il</strong> “Cavallino Rampante” montata sugli F-86E. Questa<br />
pattuglia formò <strong>il</strong> nucleo del 313° Gruppo Addestramento<br />
Acrobatico “Frecce Tricolori” che nel 1961 lo Stato<br />
Maggiore dell’Aeronautica costituì con sede stab<strong>il</strong>e sull’aeroporto<br />
di Rivolto. Le “Frecce Tricolori” erano ben evidenti<br />
sulla livrea del Sabre: fondo blu con le strisce tricolori<br />
sul ventre delle superfici orizzontali e fregio sui fianchi<br />
che rappresentava un rombo celeste allungato con decorazione<br />
in nero e rosso all’interno, quindi le tre saette tricolori<br />
della PAN. La prima macchina in dotazione, la versione<br />
canadese del caccia statunitense F-86 E Sabre<br />
(sciabola), era caratterizzata dalla “coda volante” (piani<br />
orizzontali interamente mob<strong>il</strong>i e servocomandati), dal parabrezza<br />
a tre pannelli già introdotto sulle ultime serie (A-<br />
6 e A-7) di F-86A e dal radar di direzione tiro inserito nel<br />
“labbro” superiore della presa d’aria e collegato a un traguardo<br />
di puntamento computerizzato. Queste innovazioni<br />
erano state apportate per dare più efficacia al Sabre<br />
consolidando la sua superiorità complessiva rispetto al<br />
MIG-15 la cui comparsa nei cieli coreani aveva messo in<br />
crisi le forze aeree alleate. Nel 1964 le “Frecce Tricolori”<br />
acquisiscono una nuova macchina, <strong>il</strong> velivolo Fiat G 91 PAN<br />
e una diversa livrea: i rombi sulla fusoliera furono sostituiti<br />
da tre frecce st<strong>il</strong>izzate con i colori nazionali e la deriva fu<br />
contraddistinta da numeri individuali di colore giallo. La<br />
versione PAN del G 91, di esclusiva dotazione della Pattuglia<br />
Acrobatica, si differenzia dal G 91R per i comandi “desensib<strong>il</strong>izzati”<br />
con smorzatori di beccheggio (pitch damper),<br />
e per un impianto per i fumi colorati. Le armi, con <strong>il</strong><br />
relativo munizionamento, sono state sostituite da contrappesi<br />
sagomati (sostituzione reversib<strong>il</strong>e per riportare gli<br />
aerei alla configurazione operativa) e infine non vi sono in-<br />
Modello G 91 ut<strong>il</strong>izzato dalle “Frecce Tricolori” 1964 -<br />
1981.<br />
stallate le macchine fotografiche Vinten di serie sull’erre.<br />
Nel gennaio 1982 giungono a Rivolto i primi Aermacchi<br />
MB.339 A/PAN che equipaggiano ancora oggi le Frecce Tricolori<br />
e che sono vanto dell’Aeronautica italiana nel<br />
mondo.<br />
25 anni di collaborazione tra PNRA e Servizio Meteorologico<br />
dell’A.M.<br />
Roberto Cervellati, Andrea Pellegrini<br />
L’Italia <strong>è</strong> presente in<br />
Antartide con un programma<br />
scientifico governativo<br />
dal 1985. Tale<br />
programma noto sotto<br />
l’acronimo PNRA, Programma<br />
Nazionale di Ricerche<br />
in Antartide finanziato<br />
dal Ministero per<br />
l’Istruzione, l’Università<br />
e la Ricerca scientifica<br />
(MIUR) − compie nel <strong>2010</strong> venticinque anni di attività. Si<br />
<strong>è</strong> trattato di un arco di tempo che ha visto importanti mutamenti<br />
anche nelle aspettative dell’opinione pubblica<br />
mondiale. Alle prospettive iniziali di uno sfruttamento<br />
economico dell’Antartide si sono sostituite una crescente<br />
coscienza ambientale e la consapevolezza che questo continente<br />
rimane l’ultimo angolo incontaminato del Pianeta,<br />
con potenzialità uniche per aiutarci a capire una quantità<br />
di fenomeni fisici, chimici e biologici che riguardano sia <strong>il</strong><br />
nostro passato sia <strong>il</strong> nostro futuro. E’ soprattutto per tali<br />
valori che esso va studiato e consegnato a chi verrà dopo<br />
di noi. Dal punto di vista del diritto internazionale l’Antartide<br />
<strong>è</strong> una parte del pianeta non assoggettata alla sovranità<br />
di alcuno Stato. Esistono delle rivendicazioni territoriali,<br />
che però sono state sospese con l’entrata in<br />
vigore del Trattato internazionale per l’ Antartide. Il Trattato<br />
regola la presenza sul continente dei Paesi interessati.<br />
E’ stato stipulato nel 1959 fra 12 dei Paesi partecipanti<br />
all’Anno Geofisico Internazionale, allora appena<br />
concluso, ed <strong>è</strong> entrato in vigore nel 1961. Lo spirito del<br />
Trattato <strong>è</strong> quello di favorire una presenza pacifica nel<br />
continente e di assicurare nell’interesse dell’umanità la<br />
conservazione della fauna, della flora (invero esigua) e dell’ambiente<br />
naturale. Nel 1991 <strong>è</strong> stato siglato, ad integrazione<br />
del Trattato Antartico, un accordo di particolare r<strong>il</strong>ievo:<br />
<strong>il</strong> Protocollo sulla Protezione Ambientale. Noto anche
Principale area d’interesse italiano in Antartide.<br />
<strong>come</strong> Protocollo di Madrid, esso stab<strong>il</strong>isce la messa al<br />
bando, fino almeno al 2015, di ogni forma di sfruttamento<br />
minerario e impone alle nazioni operanti in Antartide la valutazione<br />
dell’impatto ambientale per qualsiasi attività. Al<br />
Trattato Antartico aderiscono oggi 46 Paesi che rappresentano<br />
più dell’80% della popolazione globale. Nel corso<br />
dell’Anno Geofisico Internazionale (1957-58), <strong>il</strong> mondo<br />
scientifico internazionale varò una organizzazione destinata<br />
a promuovere e coordinare la ricerca in Antartide: lo<br />
SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research). Lo<br />
SCAR costituisce tuttora <strong>il</strong> più autorevole forum scientifico<br />
internazionale per l’Antartide. L’Italia ne fa parte dal<br />
1988. Il governo italiano ha sottoscritto <strong>il</strong> Trattato Internazionale<br />
per l’Antartide <strong>il</strong> 18 marzo 1981; <strong>il</strong> 10 giugno<br />
1985 <strong>è</strong> stata approvata la legge n. 284 istitutiva del PNRA.<br />
Il Programma di ricerca, sotto l’egida MIUR, include numerose<br />
discipline: scienze della Terra, fisica dell’atmosfera,<br />
cosmologia, biologia, medicina, oceanografia,<br />
scienze dell’ambiente, tecnologia. Nel corso del <strong>suo</strong> sv<strong>il</strong>uppo<br />
esso <strong>è</strong> stato indirizzato sempre più verso studi multidisciplinari<br />
aventi per oggetto i fenomeni globali che avvengono<br />
all’interno dell’atmosfera, della biosfera e della<br />
geosfera. Per 18 anni l’Ente per le Nuove tecnologie,<br />
l’Energia e l’Ambiente (ENEA) ha provveduto, d’intesa<br />
con <strong>il</strong> Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per i contenuti<br />
scientifici, all’attuazione dei programmi. Nel 2003<br />
tale ruolo <strong>è</strong> stato affidato ad un Consorzio costituito da<br />
quattro Enti dei quali uno <strong>è</strong> l’ENEA, gli altri sono <strong>il</strong> CNR,<br />
l’INGV e l’OGS. Al Consorzio, denominato PNRA SCrl, spetta<br />
la gestione dei fondi e quindi l’acquisto o <strong>il</strong> nolo di mezzi<br />
di trasporto, materiali e strumentazione necessari alle<br />
spedizioni e alle ricerche in Italia. Il Consorzio provvede<br />
anche alla preparazione e selezione del personale mediante<br />
corsi di addestramento e verifiche medico-psicologiche.<br />
Numerosi Ministeri sono coinvolti nella realizzazione<br />
del Programma. Il Ministero degli Affari Esteri<br />
coordina la presenza dell’Italia alle riunioni del Trattato<br />
Antartico e tiene i rapporti formali con la Segreteria dello<br />
stesso, mentre <strong>il</strong> Ministero della Difesa contribuisce all’addestramento<br />
preliminare dei candidati e assegna alle<br />
spedizioni proprio personale specializzato, quali guide alpine,<br />
incursori, meteoprevisori, addetti alla sala-controllo.<br />
Per molti anni l’Aeronautica M<strong>il</strong>itare ha messo a disposizione<br />
anche l’aereo da trasporto per i voli dalla<br />
Nuova Zelanda al continente bianco. Il programma governativo<br />
ha portato a termine, tra <strong>il</strong> 1985 e <strong>il</strong> <strong>2010</strong>, 25 campagne<br />
scientifiche nazionali (una ogni anno), ha realizzato<br />
due basi permanenti in Antartide (una interamente italiana<br />
e l’altra in collaborazione con la Francia) e ha sv<strong>il</strong>uppato<br />
attività scientifiche e tecnologiche. Di seguito una breve<br />
storia delle 25 spedizioni.<br />
La prima <strong>è</strong> servita per individuare, a Baia Terra Nova<br />
(BTN), <strong>il</strong> sito per l’insediamento della base principale italiana<br />
e per impostare <strong>il</strong> programma di ricerche. Già nella<br />
2a spedizione veniva costruito <strong>il</strong> nucleo iniziale della base<br />
a BTN. Nella 3a ha avuto luogo una prima campagna di<br />
oceanografia e di biologia marina nel Mare di Ross mentre<br />
la nave Explora (oggi OGS Explora) effettuava la prima di<br />
numerose campagne geofisiche. I collegamenti veloci tra<br />
la Nuova Zelanda e BTN sono stati attivati per la prima<br />
volta nella quinta spedizione con l’aereo C-130 dell’A.M..<br />
Una importante acquisizione tecnologica della 6 a <br />
spedizione<br />
<strong>è</strong> stata la realizzazione di un sistema automatico<br />
di produzione di energia elettrica, controllo della stru-<br />
Prima immagine da satellite ricevuta dall’ufficio meteo<br />
della base italiana”Mario Zucchelli” (1987).
mentazione, acquisizione dati e trasmissione via satellite<br />
che resta in funzione tutto l’anno, quindi anche negli<br />
otto mesi in cui la base BTN <strong>è</strong> chiusa. Il sistema si aggiungeva<br />
a quelli che costituiscono la rete delle stazioni<br />
meteo AWS tuttora in funzione. Superato un periodo di ridotti<br />
finanziamenti, nella 9a della deposizione della neve. Nel 2003, anno<br />
di costituzione del Consorzio PNRA, viene a<br />
mancare Mario Zucchelli, <strong>suo</strong> primo presidente<br />
e infaticab<strong>il</strong>e animatore di gran parte<br />
della storia precedente. La stazione di Baia<br />
Terra Nova prende <strong>il</strong> <strong>suo</strong> nome. <strong>Durante</strong> la<br />
20<br />
spedizione <strong>è</strong> stato dato l’avvio<br />
alla realizzazione della stazione italo-francese Concordia,<br />
preceduta da un grosso campo estivo,<br />
sull’altopiano glaciale, in località Dome C, a circa 3.000<br />
metri di altezza e 1.000 km dalla costa. La prima e principale<br />
attività a Dome C <strong>è</strong> consistita in una trivellazione<br />
profonda dell’intero strato di ghiaccio, ciò che ha permesso<br />
di recuperare campioni di ghiaccio antichi fino a<br />
900.000 anni. Com’<strong>è</strong> noto, da tale programma internazionale<br />
(EPICA, uno dei fiori all’occhiello del PNRA) sono<br />
state ricavate e si stanno tuttora ricavando informazioni<br />
sulla composizione che l’atmosfera aveva alle epoche<br />
a spedizione la Stazione Concordia viene<br />
ultimata e con l’inverno australe 2005 ha<br />
inizio una occupazione ininterrotta di essa,<br />
estate e inverno; <strong>il</strong> primo equipaggio, italofrancese,<br />
conta 13 persone. Dalla 22a alla<br />
24a spedizione <strong>il</strong> finanziamento del PNRA<br />
subisce una progressiva contrazione e se<br />
dapprima i residui, sia in termini monetari<br />
sia di merce e strumentazione acquisite in<br />
precedenza, permettono di attenuarne gli<br />
effetti, la dimensione delle spedizioni si riduce<br />
inevitab<strong>il</strong>mente. Allo stesso modo i<br />
giorni di apertura di MZS si riducono da 110<br />
a 64. Il rapporto tra ricercatori ed addetti<br />
alla logistica si riduce, non potendo la logistica<br />
scendere al di sotto di una soglia minima.<br />
Le attività a Concordia, vincolate da<br />
accordi di cooperazione internazionale, proseguono<br />
senza subire riduzioni importanti.<br />
Volgiamo ora uno sguardo più incisivo<br />
sulla parte meteorologica e sull’importante<br />
ruolo giocato dalla collaborazione tra <strong>il</strong><br />
PNRA e <strong>il</strong> Servizio Meteo dell’A.M. sin dagli<br />
esordi delle attività antartiche. Escludendo<br />
infatti la prima Spedizione − estate australe<br />
1985-1986, che aveva esclusivamente <strong>il</strong> carattere<br />
di ricognizione sul sito individuato<br />
per la prima Stazione italiana in Antartide − già nella seconda<br />
Spedizione (1986 – 87) l’allora cap. Claudio Giudici,<br />
ha prestato la sua opera nell’allestimento del primo, pionieristico,<br />
Ufficio Meteorologico di Baia Terra Nova, nella<br />
Terra Vittoria Settentrionale (41° 42’ S, 164° 07’ E). Nell’arco<br />
di due mesi estivi venivano installate: 4 stazioni meteorologiche<br />
automatiche (in un raggio di circa 300 km attorno<br />
alla Stazione Baia Terra Nova); un sistema per la<br />
ricezione in tempo reale dei dati trasmessi, via satellite,<br />
dalle stazioni automatiche; un apparato per <strong>il</strong> radiosondaggio;<br />
un ricevitore per le immagini APT trasmesse dai satelliti<br />
polari NOAA; un ricevitore per le carte meteorologiche<br />
via radiofacsim<strong>il</strong>e; sistemi di calcolo asserviti alla<br />
strumentazione ed <strong>il</strong> primo edificio ospitante l’Ufficio<br />
Meteorologico, una baracca da cantiere prefabbricata di<br />
circa 6 m2 COGNOME<br />
GIUDICI<br />
NOME<br />
CLAUDIO<br />
sped<br />
2,3,5,9,12<br />
FRUSTACI GIUSEPPE 4,7,23<br />
BACCI GIUSEPPE 4,6,7<br />
SOTTOCORONA PAOLO 5<br />
ADAMO LUCIANO 6<br />
ROMITO ANGELO 9,10,12,19,21,22<br />
COLOMBO FRANCO 10,11,13<br />
NAPPI DOMENICO 10,12<br />
MAURO LUIGI 11,14<br />
ROSCI PAOLO 11<br />
COPPOLA<br />
GUIDI<br />
CLEMENTI<br />
CAPIZZI<br />
RINIERI<br />
P.FRANCESCO<br />
GUIDO<br />
VITTORIO<br />
PAOLO<br />
LEONARDO<br />
12,13,15<br />
13<br />
14<br />
14,17<br />
15,16<br />
GUARNERA UGO 16<br />
EMILIANI PATRIZIO 16<br />
MOLINARI STEFANO 17<br />
ALESSIO DETTO GRASSI GIORGIO 18,20,21<br />
VILLA DOMENICO 18<br />
DI DIODATO ATTILIO 19<br />
LUCE GIUSEPPE 20,25<br />
BOVE ROBERTO 22,24<br />
CORSI MARCO 23<br />
REYES IVAN 23<br />
ANTONUCCI MARCO 25<br />
UGHETTO SILVIA 25<br />
Ufficiali del Servizio Meteorologico dell’A.M. che hanno partecipato<br />
alle 25 spedizioni italiane in Antartide.<br />
, ancorata con stralli in cavo d’acciaio per resistere<br />
ai venti catabatici che spirano, in estate, con raffi-
Primo Ufficio Meteorologico della base Italiana in Antartide<br />
(1986).<br />
che fino ad 80 nodi, mentre d’inverno sono stati registrati<br />
anche 125 nodi. Da allora <strong>è</strong> stata fatta molta strada: 28 tra<br />
previsori senior e junior del Servizio Meteorologico A.M.<br />
hanno partecipato alle 25 spedizioni Italiane in Antartide,<br />
per un totale di 53 presenze, garantendo sempre elevati<br />
standard di competenza e professionalità, al servizio dell’efficienza<br />
e, soprattutto, della sicurezza delle operazioni<br />
antartiche. Attualmente l’Ufficio Meteorologico della Stazione<br />
Mario Zucchelli (già Stazione di Baia Terra Nova) <strong>è</strong><br />
parte integrante della Sala Operativa, la struttura che sovrintende<br />
allo svolgimento di tutte le attività della Base.<br />
I gruppi di ricercatori, le squadre di manutenzione della<br />
base, gli equipaggi di volo e gli eventuali campi remoti<br />
fanno tutti riferimento alla Sala Operativa in tutte le fasi<br />
del loro lavoro: dalla pianificazione di dettaglio, allo svolgimento<br />
delle operazioni, fino al debriefing finale.<br />
Per fornire l’assistenza richiesta, l’Ufficio Meteo può<br />
contare oggi su una rete locale di 15 stazioni meteorologiche<br />
automatiche e una stazione di radiosondaggio, strumentazione<br />
dedicata sulle aviosuperfici, un nefoipsometro<br />
e due sistemi per la ricezione di dati HRPT (High Resolution<br />
Picture Transmission) dai satelliti polari NOAA e DMSP.<br />
Inoltre, grazie alla collaborazione con <strong>il</strong> Centro Nazionale<br />
<br />
di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) di<br />
Pratica di Mare (RM), <strong>è</strong> possib<strong>il</strong>e disporre dei campi meteorologici<br />
previsti dall’ECMWF (European Centre for Medium-range<br />
Weather Forecasts), dei quali <strong>il</strong> Servizio Meteorologico<br />
A.M. <strong>è</strong> <strong>il</strong> distributore esclusivo per l’Italia.<br />
Inoltre <strong>il</strong> CNMCA provvede anche all’inoltro sul GTS (Global<br />
Telecommunication System della World Weather<br />
Watch) dei dati raccolti e codificati presso le stazioni meteorologiche<br />
installate dal PNRA in Antartide, contribuendo<br />
pertanto alla rete mondiale di osservazioni sinottiche.<br />
Anche le osservazioni e previsioni aeronautiche<br />
effettuate dai previsori presso la Stazione Mario Zucchelli<br />
durante le campagne estive sono inviate al CNMCA per <strong>il</strong><br />
successivo inoltro sui circuiti internazionali. L’apporto<br />
meteorologico <strong>è</strong> di estrema importanza in un ambiente,<br />
<strong>come</strong> quello antartico, in cui tutte le attività sono legate<br />
alle condizioni meteorologiche; fin dalle prime spedizioni,<br />
pertanto, si <strong>è</strong> presentata la necessità di formare preventivamente<br />
<strong>il</strong> previsore che doveva confrontarsi con fenomeni<br />
e situazioni meteorologiche al di fuori di qualsiasi<br />
precedente esperienza. Da allora, l’esperienza professionale<br />
dei previsori che hanno già prestato servizio presso<br />
Stazione Mario Zucchelli <strong>è</strong> stata di volta in volta trasmessa<br />
alle nuove leve durante un corso organizzato ad<br />
hoc presso <strong>il</strong> PNRA, ogni anno, prima della campagna<br />
estiva. Dal momento che le attività antartiche sono sempre<br />
e ampiamente inserite in un contesto internazionale,<br />
numerose sono le occasioni di incontro e confronto, sia su<br />
tematiche scientifiche sialogistico-operative, con colleghi<br />
di altri programmi nazionali. Anche in questo campo <strong>il</strong> contributo<br />
del Servizio Meteorologico A.M. <strong>è</strong> stato ed <strong>è</strong> importante,<br />
attraverso la presentazione, nei consessi internazionali,<br />
delle attività dell’Italia in campo meteorologico.<br />
L’Italia <strong>è</strong> tra le nazioni che operano un’intensa attività di<br />
volo, sia per collegamenti intercontinentali tra l’Antartide<br />
e la Nuova Zelanda, sia all’interno del continente antartico:<br />
questa attività, che si pone, per numero di ore di volo<br />
e per area coperta, ai primi posti tra i programmi nazionali<br />
in Antartide, non sarebbe possib<strong>il</strong>e senza l’efficiente<br />
assistenza meteorologica fornita attraverso l’opera dei<br />
previsori che, per inciso, in Antartide svolgono anche <strong>il</strong><br />
compito di osservatori, dovendo limitare <strong>il</strong> più possib<strong>il</strong>e <strong>il</strong><br />
personale presente in Base. L’efficienza e l’affidab<strong>il</strong>ità dell’assistenza<br />
meteo, che copre oggi un teatro di operazioni<br />
con un raggio di oltre 2.500 km da Stazione Mario Zucchelli,<br />
<strong>è</strong> ormai riconosciuta a livello internazionale, in<br />
particolare da quegli operatori − programmi nazionali o<br />
consorzi di programmi antartici nazionali − che svolgono<br />
attività nella stessa area del PNRA o in aree collegate. La<br />
collaborazione del Servizio Meteorologico dell’A.M. <strong>è</strong>
quindi una componente essenziale del sistema PNRA, e costituisce<br />
un esempio di <strong>come</strong>, ut<strong>il</strong>izzando al meglio le<br />
competenze specifiche di ciascun partner dell’impresa, sia<br />
possib<strong>il</strong>e raggiungere risultati di eccellenza anche in condizioni<br />
particolarmente diffic<strong>il</strong>i, sia logistiche sia ambientali.<br />
Ci auguriamo che questa interazione si sv<strong>il</strong>uppi maggiormente,<br />
con uno spirito collaborativo ancor più necessario<br />
adesso, visto che <strong>il</strong> futuro del Programma antartico<br />
italiano non appare così nitido: la riduzione dei finanziamenti<br />
che abbiamo sperimentato negli ultimi anni ci ha costretti<br />
a ridurre notevolmente <strong>il</strong> livello di attività, ma esistono<br />
alcuni aspetti, <strong>come</strong> tutti quelli legati alla sicurezza<br />
ed all’economicità delle operazioni, che non possono essere<br />
compressi in nessun caso. Per questo, <strong>il</strong> contributo del<br />
Servizio Meteorologico A.M. <strong>è</strong> ancora più essenziale e irrinunciab<strong>il</strong>e.<br />
Si deve almeno sperare, e ci si deve impegnare<br />
per questo, che la guida del Paese voglia almeno accorgersi<br />
di quanto di scientifico e di geopolitico <strong>è</strong> stato realizzato<br />
dall’Italia finora in Antartide e non voglia sprecarlo.<br />
Per ulteriori informazioni su climatologia e meteorologia<br />
in ambito PNRA:<br />
http://www.pnra.it - www.climantartide.it<br />
Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia:<br />
gen. isp. Massimo Capaldo<br />
capaldo@meteoam.i<br />
col. Gaetano Cosimo Cacciola<br />
cacciola@meteoam.it<br />
ten. col. Paolo Capizzi<br />
capizzi@meteoam.it<br />
già del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica<br />
M<strong>il</strong>itare:<br />
prof. Vittorio Cantù<br />
ReSMA Vigna di Valle:<br />
m.llo Gianluca Venanzi<br />
venanzi@meteoam.it<br />
5° Reparto SMA:<br />
ten. col.Alessandro Cornacchini<br />
alessandro.cornacchini@aeronautica.difesa.it<br />
PNRA S.C.r.l.-Roma:<br />
Roberto Cervellati<br />
ENEA -Roma:<br />
Andrea Pellegrini<br />
andrea.pellegrini@enea.it<br />
A sinistra: lancio del pallone sonda (1987). In alto a destra, installazione della stazione automatica denominata<br />
“Sofia” (1987). In basso, <strong>il</strong> Twin Otter uno dei velivoli più versat<strong>il</strong>i e affidab<strong>il</strong>i ut<strong>il</strong>izzati in Antartide.
lavoro pervenuto <strong>il</strong> 25/03/<strong>2010</strong><br />
Un sistema integrato per <strong>il</strong> supporto<br />
alle previsioni meteorologiche<br />
Sommario - La corretta interpretazione dei fenomeni atmosferici<br />
<strong>è</strong> la base di partenza per l’elaborazione di una<br />
buona previsione meteorologica. L’analisi dei fenomeni si<br />
deve avvalere, quindi, di una base di dati r<strong>il</strong>evati che sia<br />
la più ampia e affidab<strong>il</strong>e possib<strong>il</strong>e.<br />
Nell’articolo che segue si propone un modello di “catena<br />
informativa” meteo che, partendo dalla r<strong>il</strong>evazione del<br />
dato atmosferico e attraverso l’ut<strong>il</strong>izzo di strumenti informatici<br />
dedicati, conduce a rappresentazioni di sintesi,<br />
frutto di analisi ed elaborazioni eseguite su ingenti quantità<br />
d’informazioni. Il sistema proposto offre un valido supporto<br />
alla quotidiana attività previsionale e può essere altresì<br />
considerato uno strumento di training per le attività<br />
del previsore stesso.<br />
di Paola Colagrande, Marco Fontana<br />
Summary - The correct understanding of atmospheric phenomena<br />
is the start-up for a trusty weather forecast. The<br />
analysis of the weather conditions relies on an amount of<br />
data as large and reliable as possible.<br />
The aim of this work is to introduce a model for a “meteorological<br />
information chain” which, starting from the<br />
atmospheric data sensing, offers tools to realize specific<br />
outputs as result of the computational and analysis activities<br />
carried out on a huge amount of data. The system<br />
proposed represents an effective solution to a growing demand<br />
for higher-performing ab<strong>il</strong>ity in handling weather information<br />
and offers to the forecasters a tool for training<br />
and improving its own forecasting ab<strong>il</strong>ity so that a better<br />
service may be offered to the external users.
Introduzione<br />
La comprensione del tempo, delle sue possib<strong>il</strong>i evoluzioni<br />
e cambiamenti <strong>è</strong> base fondamentale per molte attività<br />
della vita quotidiana. Tra queste, particolare importanza<br />
rivestono quelle concernenti l’assistenza alla<br />
navigazione aerea e la sicurezza sia delle attività di volo<br />
sia la sicurezza sul territorio, nel tentativo di prevenire o<br />
gestire al meglio, situazioni di calamità o disastri naturali<br />
causati da severe condizioni meteorologiche. Accanto a<br />
queste, molte altre sono le attività per le quali l’impatto<br />
della previsione meteo, pur non assumendo caratteristiche<br />
vitali, riveste grande r<strong>il</strong>evanza. Si pensi, per esempio, all’importanza<br />
che può avere una corretta previsione nel<br />
campo dell’agricoltura, dell’industria del turismo, dello<br />
sport e del tempo libero (economia a rischio per le industrie<br />
del settore alimentare, rimborsi delle compagnie assicurative<br />
nel caso di dichiarata calamità naturale, condizioni<br />
del mare per i natanti o gare veliche, condizioni della<br />
montagna durante <strong>il</strong> periodo invernale).<br />
Un efficace servizio di previsione deve basarsi essenzialmente<br />
sui seguenti elementi fondamentali:<br />
• una rete di r<strong>il</strong>evamento dati cap<strong>il</strong>lare ed efficiente (sia<br />
da terra sia dallo spazio);<br />
• un sistema di acquisizione, raccolta e catalogazione in<br />
tempo reale dei dati r<strong>il</strong>evati;<br />
• un sistema flessib<strong>il</strong>e di supporto ai previsori;<br />
• un sistema di supervisione e raccordo tra tutti gli elementi<br />
della “catena” previsionale.<br />
Il primo obiettivo da perseguire per un’efficace strategia<br />
di gestione dell’informazione meteo <strong>è</strong> la creazione di<br />
un sistema unico di raccolta e distribuzione delle informazioni,<br />
con particolare attenzione a tutte quelle particolarmente<br />
critiche (ad esempio in ambiente ATC durante<br />
le fasi di decollo e atterraggio), seguendo gli standard internazionali<br />
(ICAO, WMO, EUMETNET, ecc.) per tutti i dati<br />
raccolti dalla sensoristica installata presso le aree aeroportuali,<br />
presso siti opportunamente scelti per le loro caratteristiche<br />
meteorologiche e acquisiti da sensori a bordo<br />
di satelliti per l’osservazione della Terra.<br />
Il secondo obiettivo <strong>è</strong> quello di migliorare tale sistema<br />
disegnando e sv<strong>il</strong>uppando un’interfaccia più ampia e completa<br />
possib<strong>il</strong>e, integrando strumenti di visualizzazione<br />
dei dati più intuitivi ed efficaci dedicati sia ai controllori<br />
di volo che ai previsori meteo. In questo modo, attraverso<br />
l’acquisizione, la raccolta, <strong>il</strong> processamento e l’analisi<br />
dei dati meteo <strong>è</strong> possib<strong>il</strong>e sv<strong>il</strong>uppare un sistema completo<br />
in grado di offrire una piattaforma affidab<strong>il</strong>e per le attività<br />
giornaliere di controllo e monitoraggio meteorologico,<br />
ambientale e aeronautico.<br />
Vitrociset, al fianco delle Forze Armate e delle Pubbliche<br />
Amministrazioni Centrali e Locali, <strong>è</strong> impegnata nella<br />
realizzazione di sistemi complessi per la gestione del territorio<br />
e dell’ambiente. L’Azienda vanta storicamente una<br />
competenza nello sv<strong>il</strong>uppo di sistemi volti allo studio dei<br />
fenomeni meteorologici per <strong>il</strong> supporto alla navigazione<br />
aerea e alla sicurezza dell’attività di volo, alla quale si<br />
somma una consolidata esperienza in materia d’infrastrutture<br />
e servizi per l’assunzione della conoscenza e<br />
promozione del territorio.<br />
Rispetto a quest’ultimo ambito, oltre ai servizi d’infomob<strong>il</strong>ità<br />
per <strong>il</strong> mercato trasporto, assume particolare r<strong>il</strong>ievo<br />
la pluriennale esperienza maturata nella progettazione<br />
e nella realizzazione di Infrastrutture che assicurano<br />
la condivisione dei dati geo-topo-cartografici d’interesse<br />
ambientale e territoriale. Forte di questo background tecnico<br />
scientifico, nel corso degli anni Vitrociset ha elaborato<br />
una serie di prodotti e programmi che sono <strong>il</strong> risultato di<br />
Figura 1 – Flusso delle informazioni, dall’acquisizione dei dati meteorologici alla loro visualizzazione e ut<strong>il</strong>izzazione da parte<br />
dell’utente.
una lunga collaborazione con partner di r<strong>il</strong>evanza internazionale<br />
nel campo meteorologico quale ENAV e soprattutto<br />
con <strong>il</strong> CNMCA, che rappresenta <strong>il</strong> centro nazionale di<br />
eccellenza nel campo della meteorologia e climatologia<br />
italiana. In quest’ottica, <strong>è</strong> possib<strong>il</strong>e individuare una serie<br />
di strumenti e prodotti che, opportunamente integrati tra<br />
di loro, possono realizzare quella “catena informativa” la<br />
quale, partendo dal semplice dato r<strong>il</strong>evato, conduce l’operatore<br />
al risultato finale nella forma di previsione, analisi,<br />
tendenze, opportunamente codificate e rappresentate di<br />
volta in volta secondo la richiesta e la necessità dell’utente<br />
finale. Con la realizzazione dell’integrazione di un<br />
tale sistema, attraverso i processi di acquisizione, raccolta,<br />
processamento e visualizzazione, <strong>è</strong> possib<strong>il</strong>e sv<strong>il</strong>uppare<br />
un sistema completo di aus<strong>il</strong>io reale alle attività<br />
previsionali necessarie a tutti i campi di applicazione individuati<br />
in precedenza.<br />
Figura 2 – Schema logico delle relazioni tra i tre sistemi proposti.<br />
Sistema standard di teler<strong>il</strong>evamento a terra SWS (Standard<br />
Weather Station)<br />
SWS <strong>è</strong> un sistema in corso di realizzazione da parte del<br />
Servizio Meteorologico Nazionale Italiano in cooperazione<br />
con <strong>il</strong> Dipartimento di Meteorologia della Vitrociset, con<br />
l’obiettivo di modernizzare e migliorare la rete nazionale<br />
di osservazioni a terra. La Forza Armata <strong>è</strong> costantemente<br />
alla ricerca di nuove e più ricercate metodologie di analisi<br />
ed elaborazione dei dati meteorologici e quindi persegue<br />
un continuo aggiornamento della propria rete di monitoraggio<br />
sia dal punto di vista della componente di<br />
acquisizione sia in quella di elaborazione; in quest’ottica<br />
si pone <strong>il</strong> progetto SWS.<br />
Com’<strong>è</strong> fac<strong>il</strong>e intuire, un sistema di r<strong>il</strong>evamento e monitoraggio<br />
di dati meteorologici <strong>è</strong> formato da una compo-<br />
<br />
nente hardware, essenzialmente sensoristica, e da una<br />
software necessario per la raccolta ed elaborazione delle<br />
informazioni. Dal punto di vista dell’acquisizione ed elaborazione<br />
dei dati raccolti dalla rete sensoristica, la Forza<br />
Armata si <strong>è</strong> dotata di un software all’avanguardia, che<br />
presenta importanti novità rispetto al passato.<br />
Tale prodotto, infatti, ha le seguenti caratteristiche innovative:<br />
• portab<strong>il</strong>ità: <strong>il</strong> codice applicativo <strong>è</strong> portab<strong>il</strong>e su qualsiasi<br />
piattaforma;<br />
• modificab<strong>il</strong>ità: <strong>il</strong> software <strong>è</strong> di tipo aperto cio<strong>è</strong> documentato,<br />
accessib<strong>il</strong>e, modificab<strong>il</strong>e ed aggiornab<strong>il</strong>e;<br />
• modularità: le differenti funzionalità sono state sv<strong>il</strong>uppate<br />
in maniera modulare ovvero racchiuse in moduli specifici,<br />
ognuno dei quali svolge un determinato compito, in<br />
tal modo la modifica di una funzionalità non comporta la<br />
modifica delle altre;<br />
• configurab<strong>il</strong>ità: tutte le opzioni di amministrazione del<br />
software possono essere gestite tramite apposite tabelle<br />
di configurazione consultab<strong>il</strong>i e modificab<strong>il</strong>i dall’operatore;<br />
• protezione: tutti gli accessi al sistema seguono una policy<br />
di autorizzazione secondo i livelli di utenza.<br />
Costruita sulla base dei requisiti del programma EU-<br />
METNET AWS, la stazione può operare secondo una procedura<br />
sia manuale sia automatica. Le principali caratteristiche<br />
del sistema possono essere riassunte nei seguenti<br />
aspetti funzionali: capacità di interfacciarsi direttamente<br />
con qualunque tipo di sensore mediante semplici tabelle<br />
di configurazione; archiviazione automatica dei dati os-<br />
Figura 3 – Esempio di Stazione Meteo.
Figura 4 – SWS: schema generale della componente software.<br />
servati e loro elaborazioni; generazione di messaggi e bollettini<br />
in entrambi i formati TAC e BUFR in accordo con i<br />
requisiti del WMO MTDCF (Migration to Table Driven Code<br />
Forms); trasmissione di dati verso un archivio centrale;<br />
possib<strong>il</strong>ità di controllo locale e remoto.<br />
Il sistema inoltre offre una soluzione completa e flessib<strong>il</strong>e<br />
per la gestione di reti di osservazioni a terra all’avanguardia,<br />
rappresentando per questo uno standard di<br />
riferimento per la rete meteorologica nazionale italiana.<br />
Esso <strong>è</strong> stato sv<strong>il</strong>uppato per acquisire parametri atmosferici<br />
da sensori meteo, generare archivi di variab<strong>il</strong>i osservate<br />
e calcolate, processare e trasmettere dati e messaggi<br />
meteo, operare manualmente o in automatico, nel<br />
pieno rispetto degli standard internazionali WMO, ICAO ed<br />
EUMETNET.<br />
La semplicità, la modularità, la scalab<strong>il</strong>ità ed espandib<strong>il</strong>ità,<br />
la portab<strong>il</strong>ità e flessib<strong>il</strong>ità del codice applicativo,<br />
l’uso del sistema operativo LINUX e la ridotta criticità<br />
nella sua manutenzione rappresentano le caratteristiche<br />
fondamentali che contraddistinguono <strong>il</strong> sistema SWS, <strong>il</strong><br />
quale può essere ut<strong>il</strong>izzato con qualunque sensore o dispositivo<br />
completamente automatico acquistab<strong>il</strong>e sul mercato,<br />
provvisto di specifica documentazione dei dati in<br />
uscita. Esso si basa su i più noti pacchetti software incluso<br />
le interfacce web. Il software operativo <strong>è</strong> costituito da tre<br />
moduli principali (Ingest, GUI e Sender), controllati mediante<br />
un programma di supervisione che ne assicura l’alta<br />
affidab<strong>il</strong>ità. Un sistema GPS assicura <strong>il</strong> riferimento di<br />
tempo assoluto all’intero sistema. Il modulo Ingest può collezionare,<br />
processare, validare e archiviare i dati meteo,<br />
da dati di telemetria dei sensori (frequenza di campionamento,<br />
controlli preliminari, medie, ecc.) a variab<strong>il</strong>i derivate<br />
da un successivo processamento dei dati grezzi acquisiti<br />
(temperatura di “dew point”, QFE, QNH, ecc.). Il<br />
modulo d’interfaccia grafica per l’utente (GUI) permette<br />
di gestire e controllare l’intera stazione, la sua configurazione,<br />
<strong>il</strong> <strong>suo</strong> stato, la visualizzazione dei dati, l’accesso<br />
da parte di utenti diversi, l’inserimento manuale delle osservazioni<br />
da parte dell’operatore, la produzione di messaggistica<br />
in formato TAC e BUFR secondo lo standard<br />
WMO. Il modulo “Sender” infine <strong>è</strong> responsab<strong>il</strong>e della trasmissione<br />
di dati e messaggi verso unità remote centrali o<br />
locali. Tutti e tre i moduli operativi sono completamente<br />
gestib<strong>il</strong>i tramite semplici tabelle di configurazione attraverso<br />
l’interfaccia grafica: tabella di configurazione del<br />
sito, tabella di configurazione dei sensori, tabella di configurazione<br />
dei dati (variab<strong>il</strong>i istantanee, parametri di<br />
controllo preliminari, variab<strong>il</strong>i dirette o derivate significative),<br />
tabelle di configurazione relative si servizi della<br />
stazione oltre che della messaggistica meteo e parametri<br />
di rete.<br />
Interfaccia per scambio dati meteo (IMX)<br />
Il sistema IMX sv<strong>il</strong>uppato da Vitrociset e già operativo nei<br />
principali aeroporti italiani, gioca un ruolo chiave nel collegamento<br />
tra <strong>il</strong> sistema SWS e qualunque altro strumento<br />
di analisi e visualizzazione delle osservazioni meteo.<br />
Esso gestisce tutti i flussi di dati acquisiti da sensoristica<br />
a terra dislocata in aree aeroportuali, fornendo una corretta<br />
distribuzione di tutte le informazioni, basata anche<br />
sulla capacità di armonizzare formati tra loro diversi <strong>come</strong><br />
pure molteplici protocolli di comunicazione. Poiché ciascun<br />
sistema di acquisizione e di gestione successiva dei dati<br />
(processamento, analisi, visualizzazione) ha i propri formati<br />
e protocolli, l’IMX agisce da ponte tra i diversi sistemi,<br />
adattando automaticamente <strong>il</strong> formato iniziale con<br />
quello finale, in accordo con regole e criteri predefiniti
Figura 5 – Esempi di analisi e visualizzazioni del sistema IMS.<br />
<strong>come</strong> richiesti dai vari sistemi. Sul piano teorico l’IMX non<br />
ha un limite riguardo al numero di sistemi che <strong>è</strong> in grado<br />
di mettere in comunicazione, a meno d’impedimenti di natura<br />
fisica o tecnologica.<br />
Le principali funzioni svolte dal sistema IMX possono essere<br />
riassunte in: stab<strong>il</strong>ire la comunicazione tra i vari accentratori<br />
di dati meteo forniti dai sensori a terra; acquisire<br />
i dati eseguendone un pre-processamento e, se<br />
necessario, una conversione di formato; trasmettere i dati<br />
acquisiti verso altri sistemi fungendo da ponte tra essi.<br />
La trasmissione dei dati, infatti, <strong>è</strong> bidirezionale, in altre<br />
parole l’informazione può essere ritrasmessa verso <strong>il</strong> sistema<br />
di origine, eventualmente arricchita con <strong>il</strong> contributo<br />
derivante da altri sistemi. In pratica tutte le<br />
informazioni che riguardano l’osservazione atmosferica<br />
(siano esse automatiche o manuali) sono inviate alle autorità<br />
aeroportuali dopo essere state adattate ai formati<br />
richiesti. Il sistema <strong>è</strong> in grado di interfacciarsi con la rete<br />
AFTN, ricevendo messaggi di testo che saranno a loro<br />
volta trasmessi verso i sistemi riceventi, avendo cura della<br />
loro standardizzazione. Inoltre <strong>il</strong> sistema <strong>è</strong> in grado di<br />
collegarsi con sensori di nuova tecnologia ma anche con<br />
sensori di precedente generazione, adattando vecchi protocolli<br />
ai nuovi e realizzando un ampio numero di conversioni<br />
(tipo, formato, unità, ecc.) permettendo così l’in-<br />
terfaccia con sistemi obsoleti. Lo stesso processo ha luogo<br />
tra sistemi/sensori più semplici con quelli più complessi superando<br />
le differenze e adattandone l’interfaccia di comunicazione.<br />
Dopo la fase di acquisizione e prima di quella di distribuzione,<br />
tutte le informazioni che transitano nel sistema<br />
IMX possono essere visualizzate dall’operatore, tramite<br />
un’interfaccia grafica personalizzata, realizzata tramite la<br />
scelta di liste di parametri meteorologici e dati di osservazione.<br />
Tutto questo permette di monitorare e controllare<br />
<strong>il</strong> corretto funzionamento dell’intero sistema sin dalla<br />
fase di acquisizione, garantendo l’affidab<strong>il</strong>ità delle misure<br />
basata sulla loro corretta interpretazione fino alla loro distribuzione<br />
finale.<br />
Sistema di analisi e visualizzazione delle informazioni<br />
meteorologiche IMS (Integrated Meteo System)<br />
A completamento dei sistemi sopra descritti, IMS, software<br />
sv<strong>il</strong>uppato da Vitrociset, integra più strumenti dedicati<br />
all’analisi e alla visualizzazione di una vasta tipologia<br />
d’informazioni meteorologiche, offrendo, insieme alle funzionalità<br />
di decodifica, analisi e comparazione di prodotti,<br />
la possib<strong>il</strong>ità di definire procedure operative implementate<br />
opportunamente per le attività giornaliere del
previsore, dipendenti da stringenti tempistiche di distribuzione<br />
verso entità esterne nel pieno rispetto degli standard<br />
ICAO e WMO. Poiché le attività di un previsore richiedono<br />
la capacità di lavorare con grandi quantità di dati<br />
di diverso formato, IMS supporta l’utente nella raccolta,<br />
processamento, visualizzazione e archiviazione dei dati acquisiti<br />
ed elaborati, fornendo ut<strong>il</strong>i strumenti anche per un<br />
successivo recupero delle informazioni per studi di tipo statistico<br />
e o di tendenze di fenomeni meteorologici a breve<br />
o lungo termine.<br />
Il sistema <strong>è</strong> in grado di ricevere dati in tempo reale sia<br />
da sensori meteo a terra costituenti sistemi quali l’AWOS,<br />
WindShear, SODAR, Radiometri, RADAR meteo, sia da sistemi<br />
di distribuzione satellitare <strong>come</strong> <strong>il</strong> SADIS2G, Meteosat,<br />
DWDSAT, HRPT, permettendo così di monitorare costantemente<br />
le condizioni meteorologiche, a livello locale<br />
nazionale e internazionale. In seguito alle fasi di raccolta<br />
dati, di processamento e analisi di tutte le informazioni<br />
meteorologiche disponib<strong>il</strong>i, operazioni che possono essere<br />
eseguite sia tramite procedure manuali che automaticamente<br />
schedulate, IMS consente non solo di creare e visualizzare<br />
i risultati sotto forma di immagini, mappe, bollettini,<br />
carte, ma anche di creare dei prodotti ad hoc,<br />
senza limiti di combinazione di informazioni se non la loro<br />
compatib<strong>il</strong>ità nel confronto o significato fisico. Una gestione<br />
ben organizzata dei dati raccolti e generati da<br />
parte di IMS, inoltre, agevola l’utente nei propri compiti<br />
giornalieri, automatizzando attività operative, <strong>come</strong> per<br />
esempio la comp<strong>il</strong>azione assistita di bollettini o <strong>il</strong> controllo<br />
della loro validità, riducendo così errori e ritardi nella distribuzione<br />
dei dati agli utenti finali. Infine, potendo fare<br />
affidamento su un archivio di dati storici <strong>il</strong> sistema costituisce<br />
un valido strumento di training per l’utente, <strong>il</strong><br />
quale avrà così la possib<strong>il</strong>ità di migliorare le proprie capacità<br />
previsionali offrendo un servizio migliore a chi usufruirà<br />
dei risultati ottenuti.<br />
Conclusioni<br />
La soluzione proposta nel presente lavoro per un sistema<br />
integrato volto alla gestione delle informazioni meteorologiche,<br />
può considerarsi un’efficace risposta ai nuovi requisiti<br />
derivanti dalla continua evoluzione dei sistemi sv<strong>il</strong>uppati<br />
per supportare tutte le attività di previsione meteo<br />
e può rappresentare un framework standard per tutti i provider<br />
nazionali di dati meteorologici. Nell’elaborazione di<br />
tale framework, grande parte ha svolto <strong>il</strong> CNMCA nell’ambito<br />
della progettazione della stazione meteo standard. Di<br />
grande aiuto <strong>è</strong> stata anche l’esperienza maturata da Vitrociset<br />
nell’ambito dell’elaborazione e visualizzazione<br />
dei dati meteo acquisita nella consolidata collaborazione<br />
con ENAV.<br />
Dipartimento di Meteorologia e Ambiente Vitrociset<br />
S.p.A.:<br />
Paola Colagrande<br />
p.colagrande@vitrociset.it<br />
Marco Fontana<br />
m.fontana@vitrociset.it
lavoro pervenuto <strong>il</strong> 04/02/<strong>2010</strong><br />
Il sistema di previsione del mare<br />
"NETTUNO"<br />
di Luciana Bertotti, Luigi Cavaleri, Costante De Simone, Lucio Torrisi, Antonio Vocino<br />
Sommario - L’articolo descrive l’implementazione e l’operatività<br />
del sistema di previsione del mare NETTUNO. Dopo<br />
una breve panoramica degli aspetti storici e una descrizione<br />
dell’ambiente geografico, vengono descritti i modelli<br />
sia meteorologico sia del moto ondoso, l’operatività del sistema<br />
ed i siti dove trovare i risultati. Quest’ultimi vengono<br />
descritti sia <strong>come</strong> statistica a confronto di misure da<br />
satellite, sia <strong>come</strong> analisi di un eccezionale evento avvenuto<br />
nel gennaio 2009. L’articolo si conclude con un breve<br />
commento sull’uso dei dati ottenuti.<br />
Summary - The paper describes the implementation and<br />
operationality of the wave forecast system NETTUNO. After<br />
a short excursus on the historical aspects and a description<br />
of the geographical environment, in we describe<br />
the meteorological and wave models, the operational system<br />
and the websites where the results are ava<strong>il</strong>able.<br />
These results are described, both as statistics when compared<br />
to satellite data and as analysis of an exceptional<br />
event happened in January 2009. The paper ends with a<br />
short comment on the use of the results.
Lo stato dell’arte<br />
La sempre crescente attività marittima, sia in mare<br />
aperto sia presso la costa, presuppone di avere a disposizione<br />
una dettagliata descrizione della distribuzione e<br />
delle caratteristiche del moto ondoso, sia per <strong>il</strong> futuro immediato<br />
sia per i primi giorni a venire. Disporre di un’ affidab<strong>il</strong>e<br />
previsione dello stato del mare <strong>è</strong> quindi necessario<br />
in campi <strong>come</strong> la sicurezza, in particolare per <strong>il</strong> turismo<br />
costiero, la gestione portuale e delle rotte delle navi, o<br />
nell’ambito dell’ingegneria costiera, sia nella progettazione<br />
di opere marittime sia nel controllo dell’erosione<br />
delle coste.<br />
Sin dall’antichità l’uomo ha cercato di prevedere quello<br />
che la natura gli avrebbe riservato per l’indomani. Fino a<br />
un secolo fa, e anche in tempi più recenti, la previsione<br />
era basata sull’esperienza del marinaio. Valida com’<strong>è</strong> (e<br />
uno degli autori deve la vita a una geniale intuizione della<br />
persona che lo accompagnava in mare), questa esperienza<br />
<strong>è</strong> limitata in tempo e spazio. La grande sfida in avanti<br />
venne con la seconda guerra mondiale, quando Sverdrup e<br />
Munk produssero per la Marina degli Stati Uniti <strong>il</strong> metodo<br />
che sarebbe poi stato per almeno 30 anni lo strumento<br />
principale dei meteorologi e degli ingegneri marittimi<br />
(prodotto nel 1943, pubblicato nel 1946). Questo fu un<br />
enorme passo in avanti e fornì per la prima volta l’idea di<br />
“onda e altezza significativa”. E’ interessante notare che<br />
questa quantità, che solo per caso <strong>è</strong> eguale a 4√E, con E<br />
l’energia del sistema di onda, fu scelta perché corrisponde<br />
Figura 1. Batimetria ed orografia del Mediterraneo.<br />
mediamente alla stima visiva dell’altezza d’onda durante<br />
una mareggiata.<br />
Il metodo di Sverdrup e Munk si basava su un numero di<br />
condizioni idealizzate che, non appena le necessità dell’utenza<br />
si fecero più specifiche, mostrarono chiaramente<br />
i loro limiti. Parallelamente ai miglioramenti oceanografici,<br />
anche la meteorologia stava rapidamente migliorando<br />
i <strong>suo</strong>i risultati, grazie sia alla nuova potenza dei calcolatori<br />
sia alle conoscenze che si andavano accumulando<br />
sulla fisica dell’atmosfera e sui metodi numerici che si andavano<br />
sv<strong>il</strong>uppando per la soluzione delle relative equazioni.<br />
Ovviamente l’informazione fondamentale per <strong>il</strong> calcolo<br />
delle onde su un’oceano su un mare interno <strong>è</strong> <strong>il</strong><br />
campo di vento che su questi agisce. Proprio la qualità raggiunta<br />
nella definizione dei campi di vento sul mare e la<br />
necessità di sfruttare quindi l’informazione disponib<strong>il</strong>e,<br />
spinsero a migliorare profondamente l’approccio al calcolo<br />
delle onde. La chiave fu <strong>il</strong> passaggio al concetto di spettro.<br />
In pratica, seguendo un’intuizione di Pierson (1) (Pierson<br />
e Marks, 1952), la superficie del mare <strong>è</strong> concepita<br />
<strong>come</strong> una sovrapposizione lineare di sinusoidi, ognuna caratterizzata<br />
dalla sua altezza, quindi energia F, e dalla sua<br />
frequenza f e direzione di propagazione θ. L’insieme di<br />
tutte queste energie, F(f, θ),<strong>è</strong> appunto lo spettro. Poich<strong>è</strong><br />
<strong>il</strong> processo <strong>è</strong> concepito lineare, l’energia totale E <strong>è</strong> la<br />
somma dell’energia delle singole componenti, E=∑F(f,θ) ∆f<br />
∆θ. Tipicamente allo stato attuale si considerano 25-30 frequenze<br />
e 24-36 direzioni, <strong>il</strong> che <strong>è</strong> più che sufficiente per<br />
quasi tutte le applicazioni, sia ingegneristiche sia di ri-
cerca. La citata ipotesi lineare permette anche di calcolare<br />
l’energia fornita dal vento al sistema <strong>come</strong> la somma<br />
di quelle passate alle singole componenti sinusoidali. Grazie<br />
a un seguito di contributi fondamentali quali Ph<strong>il</strong>lips<br />
(1957), M<strong>il</strong>es (1957), Hasselmann (1962a,b,c), Hasselmann<br />
et al. (1973), Hasselmann (1974), Snyder et al. (1981), fu<br />
possib<strong>il</strong>e quantificare con sempre maggior accuratezza i<br />
guadagni e le perdite di energia che caratterizzano l’evoluzione<br />
del mare. Questo portò a sempre migliori risultati<br />
fino agli attuali cosiddetti modelli della terza generazione<br />
dove, con buona approssimazione, tutti i processi fisici<br />
sono esplicitati trascurando, o quasi, qualsiasi parametrizzazione.<br />
Il primo di questi modelli fu <strong>il</strong> WAM (WAMDI<br />
Group, 1988; Komen et al., 1994), seguito dal WAVEWATCH<br />
(Tolman, 2007) e SWAN (Booij et al, 1999; Ris et al., 1999)<br />
e da altri, principalmente nell’ambito commerciale. Questi<br />
modelli si differenziano parte nella descrizione della fisica,<br />
parte nella numerica. Specie i primi tre forniscono,<br />
per riconoscimento internazionale, ottimi risultati, sia pur<br />
con caratteristiche diverse nelle diverse situazioni, per<br />
esempio in condizioni “normali” o nell’estremo di una<br />
tempesta, oppure in acqua fonda o bassa.<br />
Il Centro Meteorologico Europeo per le Previsioni a Medio<br />
Termine (ECMWF, Reading, Gran Bretagna) produce<br />
operativamente previsioni dello stato del mare: negli<br />
oceani dal 1991 e nel Mediterraneo, poi espanso al Nord<br />
Atlantico, includendo <strong>il</strong> Baltico e <strong>il</strong> Mare del Nord, dal luglio<br />
1992. Parallelamente all’incremento della potenza di<br />
calcolo la risoluzione dei modelli, sia meteorologico (Simmons,<br />
1991; Buizza et al, 2007) sia delle onde (Janssen,<br />
2007), <strong>è</strong> andata aumentando nel tempo. Da gennaio <strong>2010</strong><br />
<strong>il</strong> modello meteorologico spettrale opera con T1279, corrispondente<br />
a circa 16 km di risoluzione. Corrispondentemente<br />
<strong>il</strong> modello globale delle onde usa una risoluzione di<br />
25 km e di 11 km nel cosiddetto modello europeo, comprendente<br />
appunto <strong>il</strong> Mediterraneo. E’ su quest’ultimo<br />
bacino che concentriamo <strong>il</strong> nostro interesse.<br />
La qualità dei risultati di un modello delle onde dipende<br />
in maniera critica da quella del vento che <strong>è</strong> l’informazione<br />
in ingresso. Mentre la qualita’ dei venti ECMWF<br />
<strong>è</strong> elevatissima negli oceani, in generale negli spazi ampi ed<br />
aperti, nei mari interni vi <strong>è</strong> un’evidente tendenza a sottostimarne<br />
la velocità. Cavaleri e Bertotti (2004), tramite<br />
estesi confronti con dati da satellite, hanno mostrato che<br />
la ragione consiste in una non sufficientemente rapida risposta<br />
del modello ad aumentare la velocita’ del vento alla<br />
superficie, U 10 , quando <strong>il</strong> vento passa dalla terra al mare.<br />
La zona interessata può estendersi per qualche centinaio<br />
di ch<strong>il</strong>ometri e l’effetto <strong>è</strong> più marcato quanto più piccolo<br />
<br />
<strong>è</strong> <strong>il</strong> bacino. Tramite una serie di test Cavaleri e Bertotti<br />
(2003, 2006) hanno quantificato la presente sottostima in<br />
una cifra che per <strong>il</strong> vento può raggiungere <strong>il</strong> 10% nel bacino<br />
occidentale del Mediterraneo ed <strong>il</strong> 15% o più’ nei bacini più<br />
piccoli tipo l’Adriatico. Le corrispondenti cifre per l’altezza<br />
d’onda crescono al 10-15% e 20% rispettivamente.<br />
Queste cifre hanno una grande variab<strong>il</strong>ità spaziale, <strong>come</strong>,<br />
sia pur per una delle precedenti risoluzioni T511 del modello<br />
meteorologico, hanno mostrato i risultati del progetto<br />
MEDATLAS (Cavaleri e Sclavo, 2006).<br />
Per quanto la previsione ECMWF sia ottima dal punto di<br />
vista qualitativo, per esempio l’evoluzione di una perturbazione<br />
e <strong>il</strong> tempo di passaggio di un fronte, <strong>è</strong> evidente<br />
che le approssimazioni sopra indicate, specie per l’altezza<br />
d’onda, non sono operativamente accettab<strong>il</strong>i. L’ovvia<br />
soluzione, perseguita nel Mediterraneo da diversi centri<br />
(es. Puertos del Estado, Meteo-France, SHOM, UKMO,<br />
Arpa Em<strong>il</strong>ia-Romagna), consiste nell’uso di un modello<br />
meteorologico ad area limitata che copra con sufficiente<br />
margine tutta la zona di interesse, nel nostro caso <strong>il</strong> Mediterraneo<br />
o parte di esso, con una risoluzione ben superiore<br />
al modello globale ECMWF, sufficiente a superare<br />
parte, se non tutti, i problemi associati al modello globale.<br />
Su questa linea di condotta <strong>è</strong> stato stipulato un accordo fra<br />
CNMCA e ISMAR per sv<strong>il</strong>uppare e rendere operativo un<br />
avanzato sistema di previsione dello stato del mare, denominato<br />
NETTUNO, con una risoluzione superiore a quelle<br />
già esistenti. Il sistema <strong>è</strong> operativo dall’estate 2008. Lo<br />
scopo del presente articolo <strong>è</strong> fornire una dettagliata descrizione<br />
del sistema e un’analisi della qualità dei risultati<br />
che ne derivano.<br />
Geografia del Mediterraneo<br />
In questo paragrafo si fornisce una descrizione dell’area<br />
d’interesse e delle suecaratteristiche orografiche.<br />
Il Mediterraneo Figura 1) copre un’area con un’estensione<br />
di quasi 3.500 km in longitudine e più di 1.600 in latitudine.<br />
La sua geometria <strong>è</strong> estremamente complicata, e<br />
viene suddivisa in vari sottobacini di diversa ampiezza.Inoltre<br />
la r<strong>il</strong>evante orografia che caratterizza la maggior parte<br />
delle sue coste, spiega la difficoltà di una corretta modellizzazione<br />
dei fenomeni meteo-oceanografici, specie se<br />
non fatta con un’elevata risoluzione. In particolare i vari<br />
sistemi montuosi che caratterizzano <strong>il</strong> bordo nord del bacino<br />
(Pirenei, Massiccio Centrale, Alpi, Alpi Dinariche,<br />
monti della Grecia e della Turchia) interferiscono con lamaggior<br />
parte delle perturbazioni, che giungono da nordovest<br />
sul Mediterraneo. Questo rende le previsioni parti-
Figura 2. Campo di vento alle 00 UTC 25 gennaio 2009 secondo la previsione fatta 24 ore prima. Grafica secondo<br />
la convenzione WMO.<br />
colarmente diffic<strong>il</strong>i. Per quanto concerne i mari italiani i<br />
venti principali possono riassumersi nel maestrale, libeccio,<br />
scirocco e bora, rispettivamente da N-O, S-O, S-E, N-<br />
E. Il vento potenzialmente più violento <strong>è</strong> la bora, i cui effetti<br />
in termini di onde sono però limitati dal relativamente<br />
breve campo di mare (fetch) disponib<strong>il</strong>e al traverso dell’Adriatico.<br />
Le mareggiate più violente si trovano ad ovest<br />
della Sardegna, dovute al maestrale (2) , e si manifestano<br />
principalmente nelle stagioni autunnale e invernale. Questo<br />
tipo di mareggiate sono caratterizzate, specie nei<br />
primi 200-300 km dalla costa francese, da un mare giovane<br />
ed estremamente generativo, ovverosia onde molto ripide,<br />
creste elevate rispetto all’altezza significativa, frangenti<br />
molto frequenti. Al contrario, <strong>il</strong> libeccio e, con le do-<br />
Figura 2 bis. Campo di vento alle 00 UTC 25 gennaio 2009 secondo la previsione fatta 24 ore prima. Secondo la<br />
convenzione oceanografico-scientifica.
vute proporzioni, lo scirocco nell’Adriatico agiscono con<br />
fetch molto lungo (<strong>il</strong> libeccio che interessa la Sardegna può<br />
iniziare dal mare di Alboran, ad est di Gib<strong>il</strong>terra), e quindi<br />
<strong>il</strong> mare <strong>è</strong> più sv<strong>il</strong>uppato, con frangenti meno frequenti ed<br />
onde meno ripide e piccate.<br />
Modelli<br />
Modello meteorologico<br />
NETTUNO usa <strong>come</strong> forzante <strong>il</strong> vento previsto dal modello<br />
COSMO-ME del CNMCA. Esso <strong>è</strong> l’implementazione<br />
operativa sullo scenario Mediterraneo con passo di griglia<br />
7 km del modello non-idrostatico sv<strong>il</strong>uppato dal consorzio<br />
COSMO (www.cosmo-model.org) formato dai servizi meteorologici<br />
di Germania, Svizzera, Italia, Grecia, Polonia,<br />
Romania e Russia. Il modello COSMO <strong>è</strong> basato su equazioni<br />
primitive senza approssimazioni di scala risolte numericamente<br />
con <strong>il</strong> metodo delle differenze finite (dinamica). Lo<br />
stato futuro dell’atmosfera <strong>è</strong> descritto tramite variab<strong>il</strong>i<br />
prognostiche (in quota: temperatura, componenti del<br />
vento meridiano e zonale, deviazione della pressione,<br />
umidità specifica, contenuto liquido e solido delle nubi,<br />
pioggia, neve, energia turbolenta; in superficie: temperatura,<br />
contenuto d’acqua, contenuto equivalente in acqua<br />
della neve, ecc.). Attualmente lo schema di integrazione<br />
temporale usato <strong>è</strong> <strong>il</strong> LeapFrog con differenze spaziali centrate<br />
del 2° ordine. Gli effetti dei processi non risolti<br />
esplicitamente dalla dinamica sono tenuti in considerazione<br />
tramite le cosiddette parametrizzazioni fisiche (effetti<br />
della radiazione, microfisica delle nubi, convezione,<br />
processi dello strato limite, orografia non risolta, processi<br />
del <strong>suo</strong>lo). Il modello COSMO-ME ut<strong>il</strong>izza i campi del sistema<br />
di assim<strong>il</strong>azione dati del CNMCA <strong>come</strong> condizioni iniziali<br />
e i campi previsti del modello globale dell’ECMWF<br />
<strong>come</strong> condizioni al contorno. I campi di analisi sono prodotti<br />
ut<strong>il</strong>izzando l’algoritmo 3D-Var FGAT (Bonavita e Torrisi,<br />
2005) che assim<strong>il</strong>a le osservazioni di superficie (SYNOP,<br />
SHIP, BUOY, WIND-PROFILER, PILOT, TEMP), da aeroplano<br />
(AIREP, AMDAR, ACAR) e da satellite (AMV, venti da scatterometro,<br />
radianze AMSUA). Il modello COSMO-ME <strong>è</strong> integrato<br />
due volte al giorno (00-12UTC) fino a 72 ore. La<br />
bontà delle previsioni <strong>è</strong> oggetto di continua valutazione<br />
(contro le osservazioni) sia al CNMCA (http://www.meteoam.it/modules.php?name=Approfondimenti&page=Ctrl<br />
Previ) e sia nell’ambito del consorzio COSMO.<br />
Modello delle onde<br />
Il modello usato nel sistema NETTUNO <strong>è</strong> <strong>il</strong> WAM (WAMDI<br />
Group, 1988; Komen et al., 1994). WAM fu <strong>il</strong> primo modello<br />
della terza generazione, attualmente usato da molti dei<br />
principali centri di previsione nel mondo. Ed <strong>è</strong> di tipo<br />
spettrale. La struttura, in termini di frequenza e direzione,<br />
<strong>è</strong> analoga a quella usata all’ECMWF. Lo spettro <strong>è</strong> composto<br />
di 30 frequenze e 36 direzioni. Le frequenze sono distribuite<br />
con progressione geometrica (fn+1 =1.1 fn ), da<br />
0.05 a 0.793 Hz. Le direzioni, ad intervalli di 10 gradi,<br />
sono specificate da (centrate su) 0o +n10o <br />
, con n da 1 a 36.<br />
Il non far coincidere alcuna direzione coi punti cardinali ha<br />
lo scopo di evitare che nella propagazione di un mare<br />
molto direzionale, tipo swell, si creino delle non-realistiche<br />
zone d’ombra a valle delle isole o di qualche promontorio<br />
quando le onde si propagano lungo una delle<br />
quattro direzioni cardinali (particolarmente nord e sud).<br />
Ad ogni passo di integrazione temporale, per ogni punto<br />
di griglia e per ogni componente dello spettro (1080 nella<br />
presente implementazione) l’evoluzione dell’energia viene<br />
descritta mediante l’equazione del b<strong>il</strong>ancio energetico. Più<br />
esattamente si considera l’evoluzione della cosiddetta action<br />
density, N = F/σ, dove F rappresenta l’energia della<br />
singola componente spettrale, specificata in frequenza f<br />
e direzione θ e σ <strong>è</strong> la frequenza angolare. Il vantaggio di<br />
operare con N anzich<strong>è</strong> F <strong>è</strong> di poter considerare con relativa<br />
fac<strong>il</strong>ità l’effetto delle correnti. L’equazione e’ data da<br />
dove i termini di sinistra rappresentano la variazione spaziale<br />
e temporale dell’energia dovuta all’avvezione ed i<br />
termini di destra rappresentano la fisica del processo. In<br />
particolare:<br />
N = N (σ,θ,λ,φ,t)<br />
<strong>è</strong> funzione, oltre che f e θ, dello spazio<br />
(in coordinate geografiche) e del tempo. λ e φ sono rispettivamente<br />
la latitudine e longitudine del punto considerato,<br />
cg,x , cg,y sono le componenti della velocità di<br />
gruppo cg con cui si trasferisce l’energia, velocità funzione<br />
di f e della profondità, cθ = cg sinθ tanφ/R, con R <strong>il</strong> raggio<br />
terrestre, <strong>è</strong> la velocità di rotazione dell’onda che procede<br />
lungo un cerchio massimo sulla superficie terrestre,<br />
cσ rappresenta la variazione di frequenza relativa dovuta<br />
alle variazioni di profondità e corrente.<br />
Per la parte fisica Sin rappresenta l’energia fornita dal<br />
vento, Sdis riassume la perdita di energia dovuta ai vari<br />
processi dissipativi, quali <strong>il</strong> frangimento in acqua fonda<br />
(white-capping) e fondamentalmente l’attrito di fondo e<br />
<strong>il</strong> frangimento in acqua bassa che si presentano nei bassi<br />
fondali. Una descrizione dettagliata della fisica relativa<br />
esula dagli scopi di questo articolo. E’ qui sufficiente specificare<br />
che le singole routine del programma descrivono<br />
(1)
Figura 3. Campo d’onda alle 00 UTC 25 gennaio 2009 secondo la previsione fatta 24 ore prima. Si noti la zona<br />
fuori scala (Hs>11 m) ad ovest della Sardegna.<br />
ogni singolo processo con la fisica più aggiornata. Per un<br />
approfondimento <strong>il</strong> lettore interessato può consultare<br />
l’ampia letteratura disponib<strong>il</strong>e fra cui Komen et al. (1994)<br />
per una profonda discussione sulla fisica del moto ondoso<br />
e <strong>il</strong> relativo approccio numerico, Janssen (1991, 2004) per<br />
i successivi sv<strong>il</strong>uppi sull’interazione vento-onde, Bidlot et<br />
al. (2002) per diversi problemi pratici sull’implementazione<br />
operativa del modello e sulla performance di differenti<br />
sistemi operativi, Janssen (2008) per una fotografia<br />
del presente stato dell’arte.<br />
Una delle caratteristiche bas<strong>il</strong>ari dei modelli della terza<br />
generazione <strong>è</strong> <strong>il</strong> considerare pienamente tutte le interazioni<br />
fra le diverse componenti spettrali. ll secondo termine<br />
nella parte fisica dell’equazione (1) rappresenta appunto<br />
tale interazione. Hasselmann (1962a,b,c) dimostrò<br />
che le singole componenti spettrali non sono reciprocamente<br />
trasparenti, ma interagiscono pesantemente. Contrariamente<br />
ai termini S in ed S dis le interazioni S nl sono<br />
conservative.<br />
Per quanto riguarda questo processo l’energia totale<br />
dello spettro non varia, ma viene ridistribuita fra le varie<br />
componenti spettrali. Il processo <strong>è</strong> fondamentale per la<br />
crescita delle onde sotto l’effetto del vento. Il trasferimento<br />
di energia dalla zona di maggior contributo da<br />
parte del vento verso le basse frequenze <strong>è</strong> quello che permette<br />
<strong>il</strong> progressivo crescere della lunghezza d’onda dominante<br />
e quindi <strong>il</strong> crescere dell’altezza significativa. Per<br />
quanto la teoria relativa sia compiutamente definita, <strong>il</strong><br />
problema pratico <strong>è</strong> <strong>il</strong> calcolo di S nl che in un modello ope-<br />
rativo trascende la potenza di calcolo oggi disponib<strong>il</strong>e. Una<br />
soluzione, non perfetta ma soddisfacente, fu offerta da<br />
Hasselmann ed Hasselmann (1981) e Hasselmann et al.<br />
(1985).<br />
La cosiddetta Discrete Interaction Approximation (DIA)<br />
<strong>è</strong> stata ormai, per più di 20 anni, la spina dorsale dei modelli<br />
della terza generazione.<br />
Per quanto vi sia un continuo sforzo per produrre un metodo<br />
operativo più avanzato (vedi per es. van Vledder,<br />
2006), nessun nuovo metodo <strong>è</strong> attualmente sufficientemente<br />
rapido per essere implementato in un modello operativo.<br />
E’ opportuno specificare che la DIA dà ottimi risultati,<br />
ed <strong>è</strong> solo quando si va nei dettagli più minuti, per<br />
esempio nella forma dello spettro bi-dimensionale F(f,θ),<br />
che si possono notare alcune differenze rispetto al computo<br />
completo.<br />
Il modello WAM <strong>è</strong> stato implementato nel Mediterraneo<br />
su una griglia geografica con risoluzione 0,05° corrispondenti<br />
a 5,5 km in latitudine e mediamente 3,8 km in longitudine<br />
(da 3,8 a 4,7 km). Questo corrisponde a quasi<br />
105.000 punti di griglia sul mare. Con un passo temporale<br />
di 120 s per la propagazione e 240 s per la fisica, e 10800<br />
componenti per punto di griglia, questo corrisponde a risolvere<br />
l’equazione (1) e tutta la fisica implicita nei vari<br />
termini più di 8*10 10 volte per ogni giorno di simulazione.<br />
L’uscita del modello <strong>è</strong> per ogni punto di griglia <strong>il</strong> completo<br />
spettro bi-dimensionale F(f,θ). Da questo, mediante<br />
successive integrazioni, vengono ricavate tutte le quantità<br />
di pratico interesse, quali:
Operatività<br />
Come indicatoin precedenza, <strong>il</strong> modello COSMO-ME produce<br />
ogni giorno, a partire dalle 00 e 12.00 UTC, previsioni<br />
per le prossime 72 ore. I risultati del sistema NETTUNO<br />
sono disponib<strong>il</strong>i intorno alle 5 e 17 UTC. I risultati, cioé le<br />
componenti U, V del vento superficiale U 10 per <strong>il</strong> modello<br />
meteorologico, più le quantità integrate H s , T p , T m , θ m<br />
per <strong>il</strong> modello delle onde, vengono salvati ed archiviati in<br />
corrispondenza delle ore sinottiche.<br />
I risultati sono disponib<strong>il</strong>i in forma grafica ai due siti<br />
www.meteoam.it (CNMCA) e www.ismar.cnr.it (ISMAR). La<br />
Figura 2 mostra le due grafiche usate per la rappresentazione<br />
dei campi di vento, la prima basata sulla normativa<br />
WMO, la seconda secondo la convenzione in uso nell’ambito<br />
oceanografico. La Figura 3 mostra la rappresentazione<br />
del corrispondente campo d’onda, basata sull’altezza significativa<br />
e la direzione media di propagazione. Si noti<br />
che per ragioni di chiarezza grafica <strong>è</strong> stato fatto un grosso<br />
setacciamento (“sieving”) nella rappresentazione. E’ tuttavia<br />
evidente che le risoluzioni disponib<strong>il</strong>i, 7 km per <strong>il</strong><br />
vento e 3.8-4.7 km per le onde, permettono un’ottima rappresentazione<br />
delle condizioni meteo-marine lungo tutte<br />
Figura 4. Confronto fra velocità del vento sul mare previste<br />
dal modello sul Mediterraneo (+1-24 ore) ed i corrispondenti<br />
valori misurati con scatterometro<br />
QuikSCAT. I diversi colori indicano, con progressione<br />
geometrica (vedi scala sulla destra) diversa densità di<br />
eventi nelle varie combinazioni.<br />
le coste del Mediterraneo, ed italiane in particolare.<br />
Risultati<br />
Precedentemente all’operatività <strong>è</strong> stata fatta un’analisi<br />
molto dettagliata delle capacità dei modelli COSMO-ME e<br />
WAM di riprodurre e prevedere l’effettiva evoluzione del<br />
tempo e del mare nel Mediterraneo. La validazione di CO-<br />
SMO-ME <strong>è</strong> stata fatta usando i dati di vento derivati dallo<br />
scatterometro QuikSCAT (la cui operatività <strong>è</strong> terminata nel<br />
novembre 2009). Quest’ultimo, in orbita sincrona rispetto<br />
al Sole, effettuava due passate al giorno, una ascendente<br />
ed una discendente, su quasi tutti i mari della Terra. L’ampiezza,<br />
1.800 km, della striscia di mare su cui i dati sono<br />
disponib<strong>il</strong>i assicura un’ottima copertura dei dati di interesse.<br />
Di principio i dati sono disponib<strong>il</strong>i ad intervalli di 25<br />
km (recentemente la risoluzione <strong>è</strong> stata portata a 12,5<br />
km). L’effettiva disponib<strong>il</strong>ità <strong>è</strong> tuttavia inferiore in quanto<br />
<strong>il</strong> segnale, contaminato e quindi non affidab<strong>il</strong>e, non viene<br />
per esempio fornito in caso di pioggia. Ciò nonostante<br />
QuikSCAT <strong>è</strong> stato per molti anni la piùvalida sorgente di<br />
dati di vento sulla superficie del mare.<br />
La Figura 4 mostra <strong>il</strong> confronto fra i valori di U 10 derivati<br />
da COSMO-ME e QuikSCAT nel Mediterraneo, per i mesi di<br />
novembre e dicembre 2006. Questo confronto <strong>è</strong> stato fatto<br />
per le prime 24 ore di previsione. Nella figura ogni pixel<br />
rappresenta una possib<strong>il</strong>e combinazione di valori. Il colore,<br />
con la scala mostrata nella figura, indica <strong>il</strong> numero di<br />
campioni in ogni pixel. E’ immediatamente evidente che<br />
la maggior parte dei dati sono distribuiti vicino alla linea<br />
a 45°, quindi con valori COSMO-ME e QuikSCAT pratica-<br />
Figura 5. Confronto fra altezze significative previste<br />
dal modello sul Mediterraneo (+1-24 ore) ed i corrispondenti<br />
valori misurati tramite altimetro Jason. I diversi<br />
colori indicano, con progressione geometrica (vedi<br />
scala sulla destra) diversa densità di eventi nelle varie<br />
combinazioni.
mente coincidenti. Si noti a questo proposito che la scala<br />
colore-numerosità ha progressione geometrica. L’apparente<br />
grosso scatter suggerito dal colore <strong>è</strong> dovuto in realtà<br />
a una parte estremamente ridotta (
Figura 6. Evoluzione del campo d’onda nei mari italiani durante la tempesta del 24-25 gennaio 2009. Previsione<br />
24 gennaio 00 UTC: a) 24 gennaio 12 UTC, b) 18 UTC, c) 25 gennaio 00 UTC. Previsione 25 gennaio 00<br />
UTC: d) 25 gennaio 06 UTC, e) 12 UTC, f) 18 UTC.<br />
tempesta di eccezionale violenza, rappresentando un<br />
evento che, sia pur da un confronto non approfondito, non<br />
si verificava da più di 10 o 20 anni. Le Figure 2 e 3 mostrano<br />
la distribuzione a scala mediterranea rispettivamente<br />
dei campi di vento ed onde al culmine della tempesta.<br />
Un’analisi più dettagliata dei campi di onda,<br />
focalizzata sui mari italiani e più estesa nel tempo, <strong>è</strong> data<br />
nella Figura 6 a-f. Si noti a destra nei vari pannelli la scala<br />
delle altezze d’onda, con una maggior risoluzione nei valori<br />
più bassi in quanto quelli piu’ frequenti. Il massimo <strong>è</strong><br />
stato scelto non <strong>come</strong> superiore al massimo possib<strong>il</strong>e, ma<br />
<strong>come</strong> un compromesso fra la risoluzione della scala e la<br />
frequenza con cui i vari valori vengono raggiunti.<br />
L’evoluzione della tempesta <strong>è</strong> stata tipica di un evento<br />
di mistral. L’evento (Figura 6a) inizia con un sostenuto<br />
vento di libeccio su tutto <strong>il</strong> bacino occidentale del Mediterraneo<br />
con una mareggiata da O-S-O che già di per s<strong>è</strong><br />
aveva raggiunto altezze significative superiori ai 9 metri.<br />
Si notino <strong>il</strong> massimo a S-O della Sardegna e la penetrazione<br />
del mare di libeccio nel Tirreno meridionale. Sei ore dopo<br />
(6b), alle 18 UTC del 24 gennaio, <strong>il</strong> massimo temporaneo<br />
sulla Sardegna <strong>è</strong> già avvenuto, mentre onde elevate cominciano<br />
ad arrivare sulle coste della Campania e Calabria.<br />
A quell’ ora <strong>il</strong> mistral sta già soffiando sul mare fra le Ba-
leari e la Sardegna portando a un pericoloso mare incrociato.<br />
La sovrapposizione fra le ancora presenti onde da S-<br />
O e le crescenti onde da N-O porta ad una direzione media<br />
da ovest verso est, direzione che progressivamente<br />
ruota da N-O man mano che, <strong>come</strong> già avviene nel golfo<br />
del Leone, <strong>il</strong> mare da mistral prende <strong>il</strong> sopravvento. Questo<br />
ormai <strong>è</strong> completamente avvenuto alla mezzanotte fra<br />
<strong>il</strong> 24 ed <strong>il</strong> 25.<br />
L’altezza significativa supera gli 11 metri, andando con<br />
ciò fuori scala nel diagramma, da cui la macchia bianca che<br />
rappresenta appunto <strong>il</strong> picco del campo. Onde con H s superiori<br />
ai 10 metri giungono sulle coste della Sardegna. E’<br />
opportuno ricordare che durante una tempesta in acqua<br />
fonda nell’arco di tre ore <strong>è</strong> elevata la probab<strong>il</strong>itàdi raggiungere<br />
singole altezze d’onda quasi <strong>il</strong> doppio della significativa.<br />
Nel frattempo le onde si propagano a sud della<br />
Sic<strong>il</strong>ia verso <strong>il</strong> bacino orientale.<br />
Alle 06 UTC del 25 (6d) <strong>il</strong> fronte meteorologico ha ormai<br />
raggiunto lo Jonio. Alle sue spalle <strong>il</strong> mistral si sta espandendo<br />
nel bacino occidentale del Mediterraneo e va perdendo<br />
potenza. Alle 12 UTC (6e) le onde più alte, ora sui<br />
7-8 metri, si trovano sulla Sic<strong>il</strong>ia. Sulla Sardegna le onde<br />
vanno rapidamente diminuendo, mentre le onde più lunghe<br />
si propagano rapidamente verso <strong>il</strong> bacino orientale del<br />
Mediterraneo. Alle 18 UTC (6f) la tempesta <strong>è</strong> virtualmente<br />
finita. Le onde sulla Sic<strong>il</strong>ia sono ancora relativamente sostenute<br />
(H s = 4-5 m), ma in rapida diminuzione. Onde elevate<br />
(H s > 6 m) continuano a propagarsi verso oriente,<br />
dando luogo ad uno swell che raggiungerà l’Egitto prima e<br />
Israele poi nell’arco di 45-50 ore. L’evoluzione descritta,<br />
salvo per l’intensità, <strong>è</strong> tipica della tempesta di mistral.<br />
L’evento del 24-25 gennaio 2009 <strong>è</strong> teoricamente un’ottima<br />
occasione per verificare, tramite confronto coi dati<br />
misurati, la validità dei modelli di vento e onde. Questo <strong>è</strong><br />
ancora più vero perché vi sono buone ragioni per ritenere<br />
(vedi Cavaleri, 2009) che in tali condizioni estreme la fisica<br />
dei processi in corso possa essere differente. In particolare<br />
sembra esservi una tendenza a sottostimare i valori<br />
di picco, sia di vento che di onde. Purtroppo nel caso<br />
del gennaio 2009 nessun satellite, in particolare quelli con<br />
altimetro, <strong>è</strong> passato sulle zone più r<strong>il</strong>evanti e al momento<br />
giusto. Facendo di necessità virtù, si sta cercando di valutare<br />
l’affidab<strong>il</strong>ità dei risultati tramite <strong>il</strong> confronto coi<br />
dati disponib<strong>il</strong>i nelle zone periferiche o non al massimo<br />
della tempesta. Un esteso studio comparato <strong>è</strong> attualmente<br />
in corso, in cui sono considerati i risultati di molti<br />
dei sistemi operativi nel Mediterraneo. I risultati saranno<br />
riportati in una pubblicazione dedicata.<br />
Commento<br />
I risultati del sistema NETTUNO sono estremamente soddisfacenti.<br />
L’elevata risoluzione, sia del modello meteorologico<br />
che delle onde, assieme alla fisica all’avanguardia<br />
in entrambi i modelli, assicura una fedele riproduzione<br />
degli eventi in natura. Ne segue l’affidab<strong>il</strong>ità dei risultati<br />
nella grandissima maggioranza dei casi. Un certo livello di<br />
dubbio esiste per i valori ottenuti per le tempeste più violente<br />
in quanto vi sono ragioni per ritenere che alcuni<br />
aspetti della fisica, specie dell’interazione vento-onde,<br />
cambino in queste condizioni. In ogni caso questo <strong>è</strong>un<br />
problema di fondo di tutti i modelli e non infirma <strong>il</strong> valore<br />
relativo dei vari sistemi, in particolare di quelli operativi<br />
nel Mediterraneo. In tale ambito NETTUNO <strong>è</strong> <strong>il</strong> sistema di<br />
previsione vento-onde a più alta risoluzione attualmente<br />
operativo nel Mediterraneo. In questo articolo si <strong>è</strong> preferito<br />
fornire una visione sinottica dei risultati mostrando<br />
l’evoluzione dei campi in tempo e spazio. E’ tuttavia evidente<br />
che la risoluzione di 7 km per <strong>il</strong> vento e di 4-5 km<br />
per le onde, con un ampio spettro delle onde in frequenza<br />
e direzione, permette di descrivere con molta accuratezza<br />
l’evoluzione ed <strong>il</strong> dettaglio dei campi lungo le coste.<br />
La pratica mancanza, per quanto riguarda le onde, di un<br />
collegamento con l’oceano Atlantico fa sì che, salvo <strong>il</strong><br />
Mare di Alboran, le condizioni del mare nel Mediterraneo<br />
dipendano solo dai venti locali. Poiché la maggior parte<br />
delle perturbazioni che interessano <strong>il</strong> bacino hanno un’origine<br />
atlantica, specie nella parte occidentale a cui l’Italia<br />
sostanzialmente afferisce, i tempi di risposta del mare<br />
a un impulso meteorologico sono relativamente brevi, dell’ordine<br />
di mezza giornata al più. Ne segue che i tre giorni<br />
di previsione forniti dal sistema sono sufficienti per tutte<br />
le necessità pratiche. Sono sufficienti anche per la navigazione<br />
commerciale per poter ottimizzare la rotta in<br />
funzione del mare atteso o per scegliere una rotta più sicura.<br />
Mentre la previsione meteorologica <strong>è</strong> ormai parte<br />
dell’informazione che <strong>il</strong> pubblico si aspetta giornalmente<br />
e usa per pianificare le proprie attività, la previsione dello<br />
stato del mare, e in particolare la sua affidab<strong>il</strong>ità, sono<br />
fatti ancora poco conosciuti, diffusi solo fra una stretta<br />
utenza. Data la r<strong>il</strong>evanza di questa informazione per l’economia<br />
marittima e la sicurezza, <strong>è</strong> indispensab<strong>il</strong>e che essa<br />
venga resa più trasparente possib<strong>il</strong>e. Il CNMCA ed ISMAR<br />
stanno operando attivamente in questa direzione.
Note<br />
(1) W<strong>il</strong>lard Pierson, persona di carattere energico, ma estremamente onesto,<br />
ammise candidamente da subito che l’idea di spettro era venuta ad<br />
un <strong>suo</strong> amico che gliela confidò una sera al tavolo di un bar. Il giorno dopo<br />
l’amico morì in un incidnte motociclistico e Pierson pubblicò l’idea con entrambi<br />
i nomi.<br />
(2) A questo riguardo vi <strong>è</strong> un’interessante divergenza fra i nomi italiani e<br />
francesi. Per quest’ultimi <strong>il</strong> “mistral”, corrispondente all’italiano “maestrale”,<br />
<strong>è</strong> <strong>il</strong> vento da nord che soffia lungo la valle del Rodano, mentre<br />
quello da N-O, attraverso <strong>il</strong> passo di Carcassone, viene chiamato “tramontana”.<br />
In Italia i due significati sono scambiati rispetto alla direzione. Forse con<br />
un po’ di bias noi propendiamo per la seconda ipotesi, confortati in<br />
questo dal nome latino del vento da N-O, “magister”, indicante la r<strong>il</strong>evanza<br />
per gli antichi romani di questo vento per i loro traffici marittimi.<br />
Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia<br />
Aeronautica, Pratica di Mare:<br />
gen. Costante De Simone<br />
c.desimone@meteoam.it<br />
ten. col. Lucio Torrisi<br />
torrisi@meteoam.it<br />
magg. Antonio Vocino<br />
vocino@meteoam.it<br />
Istituto di Scienze Marine – CNR, Venezia:<br />
Luciana Bertotti<br />
luciana.bertotti@ismar.cnr.it<br />
Luigi Cavaleri<br />
luigi.cavaleri@ismar.cnr.it
Bibliografia<br />
Ardhuin, F., L.Bertotti, J.-R.Bidlot, L.Cavaleri, V.F<strong>il</strong>ipetto, J.M.Lefevre, and P.Wittmann, 2007, Comparison of wind<br />
and wave measurements and models in the Western Mediterranean Sea, Ocean Engineering, Vol.34, Issues 3-4,<br />
526-541.<br />
Bonavita M. and L. Torrisi, 2005, Impact Of a Variational Objective Analysis Scheme On a Regional Area Numerical<br />
Model: The Italian Air Force Weather Service Experience, Meteorology and Atmospheric Physics, Vol.88, No.1-<br />
2 (Springer).<br />
Bidlot, J.-R., D.J.Holmes, P.A.Wittmann, R.Lalbeharry, e H.s.Chuen, 2002, Intercomparison of the performance<br />
of operational ocean wave forecasting systems with buoy data, Weather and Forecasting, 17, 287-310.<br />
Booij, N., R. C. Ris, and L. H. Holthuijsen, 1999: A third generation wave model for coastal regions, Part I: Model<br />
description and validation. J.Geophys.Res., 104, C4, 7649-7666.<br />
Buizza, R., H.Asensio,m G.Balint, J.Bartholmes, J.Biefelnicgt, K.Bogner, F.Chavaux, A.de Roo, J.Donnad<strong>il</strong>le, V.Ducrocq,<br />
C.Edlind, V.Kotroni, P.Krahe, M.Kunz, K.Lacire, M.Lelay, C.Marsigli, M.M<strong>il</strong>elli, A.Montani, F.Pappenberger,<br />
D.Rabufetti, M.-H.Ramos, B.Ritter, J.W.Shipper, P.Steiner, J.Thieken-Del Pozzo, e B.Vincendon, 2007, EURORISK-<br />
PREVIEW report on the technical quality, functional quality and forecast value of meteorological and hydrological<br />
forecasts, ECMWF Tech.Memo. 516.<br />
Cavaleri, L., 2009, Wave modeling – missing the peaks, J. Phys. Oceanogr., 39, 2757-2778<br />
Cavaleri,L., e L.Bertotti, 2003, The characteristics of wind and wave fields modelled with different resolutions,<br />
Q.J.R.Meteorolog.Soc., 129, 1647-1662.<br />
Cavaleri, L., e L.Bertotti, 2006, The improvement of modelled wind and wave fields with increasing resolution,<br />
Ocean Engineering, 33, 5-6, 553-565<br />
Cavaleri, L., e M.Sclavo, 2006, The calibration of wind and wave model data in the Mediterranean Sea, Coastal<br />
Engineering, 53, 613-627.<br />
De Boni, M., L. Cavaleri, e A. Rusconi, 1993, The Italian waves measurement network, Proc. 23rd Int. Conf.<br />
on Coastal Eng., pp.1840-1850, 4-9 Oct 1992, Venice, 3516 pp.<br />
Hasselmann, K., 1962a: On the non-linear energy transfer in a gravity-wave spectrum. Part 1. General theory.<br />
Journal of Fluid Mechanics, 12, 481-500.<br />
Hasselmann, K., 1962b: On the non-linear energy transfer in a gravity-wave spectrum. Part 2 Conservation theorems;<br />
wave-particle analogy; irreversib<strong>il</strong>ity. Journal of Fluid Mechanics, 15, 273-281.<br />
Hasselmann, K., 1962c: On the non-linear energy transfer in a gravity-wave spectrum. Part 3. Evaluation of energy<br />
flux and swell-sea interaction for a Neumann spectrum. Journal of Fluid Mechanics, 15, 385-398.<br />
Hasselmann, K., 1974: On the spectral dissipation of ocean waves due to white capping. Boundary-Layer Meteorology,<br />
6, 107-127.<br />
Hasselmann, K., T. P. Barnett, E. Bouws, H. Carlson, D. E. Cartwright, K. Enke, J. I. Ewing, H. Gienapp, D. E. Hasselmann,<br />
P. Kruseman, A. Meerburg, P. Müller, D. J. Olbers, K. Richter, W. Sell, and H. Walden, 1973: Measurements<br />
of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project (JONSWAP). Deutsche Hydrographische<br />
Zeitschrift, A8(12), 1-95.<br />
Hasselmann, S., e K.Hasselmann, 1981, A symmetrical method of computing the non-linear transfer in agravity<br />
wave spectrum, Hamb. Geophys. Einzelschr., Serie A, 52, 138 pp.<br />
Hasselmann, S., K. Hasselmann, J. A. Allender, and T. P. Barnett, 1985, Computations and parameterizations of<br />
the non-linear energy transfer in a gravity-wave spectrum. Part 2: parameterizations of the non-linear transfer<br />
for application in wave models, J.Phys.Oceanogr., 15, 1378-1391.<br />
Janssen, P.A.E.M., 1991, Quasi-linear theory of wind wave generation applied to wave forecasting, J. Phys. Oceanogr.,<br />
21, 1631-1642.<br />
Janssen, P.A.E.M., 2004, The interaction of ocean waves and wind, Cambridge University Press, 300 pp.
lavoro pervenuto <strong>il</strong> 26/03/<strong>2010</strong><br />
A proposito di meteorologia<br />
Un inspiegab<strong>il</strong>e fenomeno<br />
meteorologico: <strong>il</strong> "Minigap"<br />
Estate 1993, costa della Cornovaglia: Base Royal Navy di<br />
Culdrose (UK). Guardo preoccupato <strong>il</strong> cielo, <strong>come</strong> faccio<br />
sempre <strong>il</strong> giorno di un’esibizione, cercando di indovinare<br />
le condizioni meteo che realmente dovrò affrontare<br />
al momento dell’esecuzione del programma del nostro<br />
Team. Ogni volo delle “Frecce Tricolori” ha infatti una<br />
“storia a se” che <strong>è</strong> <strong>il</strong> frutto della combinazione di m<strong>il</strong>le fattori,<br />
fra i quali quelli meteo giocano un ruolo determinante.<br />
C’<strong>è</strong> sempre una nuvola che ti aspetta in cima a un<br />
looping, un riflesso del sole nel momento sbagliato che ti<br />
nasconde <strong>il</strong> riferimento, un vento teso di trenta nodi che<br />
mette a dura prova i miei gregari per la forte turbolenza<br />
che sbatte i nostri piccoli “MB339” e che stravolge tutte le<br />
complesse geometrie che disegno insieme al mio fido numero<br />
sei (con conseguenti imprecazioni del solista che non<br />
riesce più a inserirsi in sequenza). Altre volte, invece,<br />
di Gianpaolo Miniscalco<br />
quella bava di vento che decide all’ultimo istante di soffiare<br />
verso <strong>il</strong> pubblico, fa ristagnare le nostre scie tricolori<br />
sulla pista, impedendoci così di farci vedere dalla folla. Per<br />
dirla in breve, anche se ci piacerebbe tanto, <strong>è</strong> ovvio che<br />
pure nel campo delle esibizioni delle Fecce non esiste quel<br />
mondo “precisino e ordinatello” al quale si riferiva spesso<br />
l’allora ten col GArf Lucio Neri, nostro insegnante in Accademia<br />
di Analisi Matematica 1 e 2, nonché di meteorologia<br />
che, nella sua personale interpretazione, si trasformava<br />
in “analisi matematica 3”! Oggi, però, c’<strong>è</strong> poco da<br />
guardare <strong>il</strong> cielo, dato che dalla vicina costa arrivano in<br />
continuazione schiere di “rollocumuli” che, con <strong>il</strong> loro<br />
pesante incedere rotolante, avv<strong>il</strong>uppano tutto in una densissima<br />
nebbia, compreso quel bel castello medioevale<br />
davanti alla pista che mi sarebbe servito da riferimento per<br />
“tirar su” Cardioide e Arizona (due figure tipiche del pro-
Una delle figure eseguite dalle “frecce tricolori” nel loro programma<br />
di esibizione: <strong>il</strong> cardioide.<br />
gramma della PAN). Questa uscita britannica sembra proprio<br />
inserirsi nella peggiore delle tradizioni meteorologiche<br />
isolane. Già all’arrivo, due giorni fa, la pattuglia di 11<br />
aeroplani giunta in perfetta formazione sulla verticale del<br />
campo, a causa del maltempo, si era dovuta dividere in<br />
tre sezioni, <strong>come</strong> da procedure standard, per eseguire l’avvicinamento<br />
strumentale e l’atterraggio in due formazioni<br />
di quattro Aermacchi ciascuna e una con i restanti tre,<br />
sbucando dalla fitta coltre di nubi a una quota di circa 200<br />
piedi. Ieri, alle prove, <strong>il</strong> ce<strong>il</strong>ing, ovvero la base della copertura<br />
nuvolosa, si era alzato quel tanto che basta per effettuare<br />
un rapido giro del campo, operazione indispensab<strong>il</strong>e<br />
per identificare i riferimenti che avevamo studiato<br />
in precedenza consultando le foto aeree dell’area. Questa<br />
mattina, al briefing generale, l’impeccab<strong>il</strong>e ufficiale meteo<br />
britannico non aveva lasciato speranze e con tipico humor<br />
inglese aveva concluso con la speranza che la pioggia<br />
non annacquasse la birra che ci<br />
avrebbe aspettato al tradizionale<br />
“hangar party” serale. Mancano ancora<br />
due ore all’ora prevista per <strong>il</strong><br />
nostro decollo. Vado a trovare i nostri<br />
specialisti in linea di volo per verificare<br />
l’efficienza degli aerei. Dalla<br />
nebbia sbuca la sagoma tondeggiante<br />
del nostro ufficiale tecnico. I <strong>suo</strong>i baffoni,<br />
incorniciati da una faccia di solito<br />
arrossata dalla continua esposizione<br />
al sole, grondano acqua. Da<br />
dietro gli fa eco <strong>il</strong> capo dei montatori,<br />
che apostrofa la finissima e incessante<br />
pioggerella con una tipica espressione<br />
campana. Sconsolato, torno indietro attraversando<br />
le schiere di spettatori che ,impassib<strong>il</strong>i,<br />
assistono dietro le transenne alla cancellazione<br />
in sequenza di una esibizione dopo l’altra.<br />
Adesso <strong>è</strong> <strong>il</strong> turno di annullare quella della<br />
“Patrou<strong>il</strong>le de France”. Fra un pò toccherà all’Harrier,<br />
poi al Lancaster e quindi, inesorab<strong>il</strong>mente,<br />
anche a noi.<br />
Entro nell’aula briefing. Manca un’ora e<br />
mezza al nostro orario di decollo. Dopo di noi<br />
spetterebbe la chiusura, <strong>come</strong> da tradizione,<br />
alla pattuglia di casa: i “Red Arrows”. Decido<br />
di effettuare comunque <strong>il</strong> briefing per l’esibizione<br />
e inizio a descrivere le procedure per <strong>il</strong><br />
programma piatto (senza nemmeno i tonneaux)<br />
che in caso di miracolo meteorologico<br />
potremmo forse sperare di effettuare. Poi,<br />
però, per scrupolo, analizzo anche <strong>il</strong> caso del programma<br />
basso che, prevedendo l’effettuazione dei tonneaux, necessita<br />
di un ce<strong>il</strong>ing di almeno 2.500 piedi. Quando alla fine<br />
passo a descrivere l’eventualità del programma alto, che<br />
con looping e separazioni prevede una base delle nubi non<br />
inferiore a 4.000 piedi, a un p<strong>il</strong>ota di media anzianità<br />
sfugge un commento a mezza voce su fumo e alcol. Lo fulmino<br />
con lo sguardo e concludo con calma l’analisi del<br />
volo, rimando la pubblica fustigazione del novello Spartaco<br />
alla conclusione della giornata, tanto per non arroventare<br />
gli animi, ma so che i fatti danno ragione al ragazzo.<br />
Manca un’ora al decollo. Andremo agli aerei trenta minuti<br />
prima, <strong>come</strong> da procedura, ma intanto dedico, <strong>come</strong> sempre,<br />
gli ultimi trenta minuti a r<strong>il</strong>assarmi e a concentrarmi.<br />
In questo mi aiuta da sempre la lettura dei romanzi di Tom<br />
Clancy. Perciò mi siedo, estraggo <strong>il</strong> mio libro dalla borsa<br />
porta-casco e mi immergo nella lettura. Ne riemergo a X
meno 35 minuti e comincio<br />
a indossare<br />
l’equipaggiamento per<br />
<strong>il</strong> volo. Mentre chiudo<br />
gli ultimi zip dell’anti-<br />
G, guardo con la coda<br />
dell’occhio fuori dalla<br />
finestra e mi accorgo,<br />
con sorpresa, che non<br />
piove più. Prendo casco<br />
e guanti e con passo<br />
misurato mi avvio verso<br />
<strong>il</strong> mio aereo. Le nuvole<br />
che arrivano dalla costa<br />
sembrano ora un<br />
po’ più alte. Mi fermo<br />
davanti al “Pony 1”:<br />
tutti i p<strong>il</strong>oti e gli specialisti<br />
sono alle posizioni assegnate. Alzo <strong>il</strong> braccio e segnalo<br />
di salire a bordo. Batteria su ON, anti-G e radio collegate,<br />
cinghie strette e bloccate. Indosso <strong>il</strong> casco e vedo<br />
che per un attimo fra le nuvole fa capolino <strong>il</strong> sole. La torre<br />
mi dice che le condizioni meteo sono ancora proibitive, ma<br />
non si esclude un lieve temporaneo miglioramento. Comunico<br />
pertanto la decisione di mettere in moto e mi riservo<br />
di cancellare <strong>il</strong> volo una volta verificate le condizioni<br />
all’ora X, così almeno questi inglesi sentiranno <strong>il</strong> rumore<br />
dei nostri aerei e annuseranno un po’ di odore di kerosene.<br />
Mentre rulliamo in bell’ordine, sul cielo campo si aprono<br />
degli sprazzi di sereno e <strong>il</strong> cuore comincia a sperare, anche<br />
se tutto intorno i rollocumuli ci guardano ancora con<br />
fare di sfida. Il castello medioevale, però ora si vede e via<br />
via anche le colline più alte si liberano rapidamente. “Andiamo<br />
in volo!”, comunico alla formazione e al comandante<br />
che ci controlla dalla biga, poi chiedo alla torre<br />
l’autorizzazione al decollo. Appena in volo comincio a svitare<br />
la testa a 360 gradi. E’ incredib<strong>il</strong>e, ma intorno al<br />
campo per qualche miglio si <strong>è</strong> aperto un buco di sereno<br />
completo, quasi <strong>come</strong> nell’occhio di un ciclone. «Facciamo<br />
l’alto!», dichiaro alla radio e chiamo la trasformazione<br />
della formazione da doppio cuneo a triangolo, quindi<br />
butto giù <strong>il</strong> muso per guadagnare l’energia necessaria al<br />
looping di ingresso. «Fumi colorati, via!» e per venti minuti<br />
disegniamo indisturbati <strong>il</strong> tricolore in quel fazzoletto<br />
di blu. Tornando al parcheggio, dopo <strong>il</strong> volo, so bene che<br />
dietro ognuna delle dieci maschere per l’ossigeno é stampato<br />
sul volto dei miei p<strong>il</strong>oti lo stesso sorriso di soddisfazione<br />
che stanno sfoggiando l’ufficiale tecnico e gli specialisti.<br />
Con la mano saluto l’irriducib<strong>il</strong>e pubblico inglese<br />
che applaude, e apro <strong>il</strong> tettuccio. Come al solito, per la<br />
tensione e la fatica del volo la tuta <strong>è</strong> bagnata di sudore,<br />
ma questa volta non solo di quello: sta infatti ricominciando<br />
a piovere e <strong>il</strong> cielo si sta richiudendo con la stessa<br />
velocità con la quale si era aperto. Dalla cabina del <strong>suo</strong><br />
rosso Hawk, Andy, <strong>il</strong> leader dei “Red Arrows”, segnala ai<br />
<strong>suo</strong>i di scendere dagli aerei. Per oggi loro non voleranno.<br />
Alla sera, davanti alle birre pagate dallo “Spartaco”,<br />
Andy plaude alla nostra fortuna meteorologica. Questa fortuna<br />
si ripeterà però immancab<strong>il</strong>mente con le stesse modalità<br />
a tutti gli incontri internazionali dei due anni nei<br />
quali sarò leader della PAN, al punto da far coniare agli inglesi<br />
<strong>il</strong> termine di “Minigap” per descrivere questo ricorrente<br />
fenomeno. In effetti sono poi passato alle statistiche<br />
<strong>come</strong> l’unico leader della PAN che non sia mai stato costretto<br />
a volare nemmeno un programma basso a causa di<br />
condizioni meteorologiche sfavorevoli. Nella speranza di<br />
non aver annoiato i lettori più colti che sono giunti fino a<br />
questo punto del racconto, e dato che da fedele discepolo<br />
di Cartesio non posso ascrivere le cause del Minigap a<br />
quello che i miei poco eruditi p<strong>il</strong>oti collegavano alla nota<br />
parte anatomica, sarei veramente grato al Direttore della<br />
Rivista di Meteorologia se potesse aiutarmi ad individuare<br />
una spiegazione del fenomeno che sia più in linea con i<br />
dettami della scienza meteorologica.<br />
Cercheremo di rispondere ai quesiti del gen. Miniscalco<br />
ut<strong>il</strong>izzando due strumenti: <strong>il</strong> primo mediante la Statistica,<br />
la seconda con la Meteorologia attraverso un’analisi della<br />
situazione atmosferica così <strong>come</strong> la possiamo ricostruire<br />
dal racconto del protagonista.
Fig.1.Stratus fractus causati dallo scorrimento di aria umida<br />
e temperata su una superficie fredda che diventano cumulus<br />
fractus per debole turbolenza provocata dal riscaldamento solare<br />
o dallo shear del vento.<br />
Dal punto di vista puramente statistico e della Teoria<br />
delle Probab<strong>il</strong>ità, gli eventi descritti e la definizione del<br />
Minigap sono da ricondurre alla Legge di Murphy che<br />
dice: «quando un evento può accadere prima o poi accadrà».<br />
(legge empirica che viene fatta risalire al cap. Murphy<br />
del Genio Aeronautico degli Stati Uniti d’America durante<br />
la 2 a Guerra Mondiale). La circostanza specifica<br />
propostaci può essere correttamente interpretata, <strong>come</strong><br />
d’altronde hanno fatto i colleghi p<strong>il</strong>oti, <strong>come</strong> una violazione<br />
della Legge di Murphy. Violazione che ne conferma<br />
la validità.<br />
Dal punto di vista meteorologico invece, i tenenti colonnelli<br />
Teodoro La Rocca e Alessandro Fuccello, due valenti<br />
meteorologi aeronautici del nostro Servizio, tenendo<br />
conto delle condizioni meteo riportate (vento teso, pioviggine,<br />
celing di 200 ft ), della stagione (estiva) e delle località<br />
(Cornovaglia), ipotizzano la presenza di una nebbia<br />
da avvezione prefrontale in cui lo scorrimento di aria<br />
calda su una superficie più fredda (in questa stagione <strong>il</strong><br />
Fig.2. Stratocumulus cumulogenitus formatesi per moderata<br />
turbolenza dovuta allo shear del vento; essi hanno un’origine<br />
primaria dagli strati e sono ben distinguib<strong>il</strong>i nelle schiarite<br />
temporanee, classiche di un’avvezione calda nei bassi strati,<br />
in coincidenza di un rinforzo del vento.<br />
mare) genera la formazione di strati; la presenza di un<br />
vento teso, comunque caratteristico per questo tipo di<br />
evento, trasforma queste nubi in stratus fractus o cumulus<br />
fractus (Fig.1), denominati in maniera poco ortodossa<br />
rollo cumuli, da cui può scaturire la pioviggine. Le aperture<br />
del cielo più o meno estese e comunque temporanee<br />
sono dovute invece a un innalzamento del livello di condensazione,<br />
per aumento della temperatura (specie nelle<br />
ore centrali della giornata) o per un rinforzo ulteriore del<br />
vento, la cui turbolenza indotta allontana <strong>il</strong> livello della<br />
base delle nubi dallo strato mescolato; in questo caso le<br />
tipiche nubi sono ancora i cumulus fractus ma anche gli<br />
stratocumulus cumulogenitus.<br />
Il direttore<br />
Costante De Simone<br />
Segredifesa - Roma<br />
gen. b.a. Gianpaolo Miniscalco<br />
gianpaolo.miniscalco@aeronautica.difesa.it
NOTIZIARIO<br />
ESERCITAZIONE "AMITIE 2009"<br />
Nei giorni 8-13 dicembre 2009, <strong>come</strong> già anticipato nel<br />
4° numero della Rivista del 2009 si <strong>è</strong> svolta in Tunisia,<br />
nella regione di Gabes, l’esercitazione denominata “Amitié<br />
2009 – Lotta contro le locuste del deserto”, alla quale<br />
<strong>il</strong> ten. col. Simone Siena e <strong>il</strong> ten. col. Paolo Capizzi, hanno<br />
partecipato in qualità di osservatori. Rispetto all’anno<br />
precedente, questa volta si <strong>è</strong> trattato di una vera e propria<br />
esercitazione campale condotta congiuntamente da<br />
Tunisia e Francia con <strong>il</strong> Comando dislocato presso <strong>il</strong> Quartier<br />
Generale della 1 a Brigata di Fanteria Meccanizzata tunisina,<br />
sito in Gabes, ed <strong>è</strong> stata aperta a osservatori delle<br />
nazioni dell’Iniziativa 5+5, nel quadro delle attività di<br />
cooperazione prevista per l’anno 2009. Oltre all’Italia,<br />
hanno partecipato, sempre <strong>come</strong> osservatori, i rappresentanti<br />
di Algeria, Libia e Spagna. Lo schema dell’esercitazione<br />
ha ricalcato quello posto in essere nel 2008 con la<br />
simulazione di una emergenza nazionale dovuta a una invasione<br />
di locuste del deserto delle regioni meridionali<br />
della Tunisia. A differenza dello scorso anno, in questa occasione<br />
<strong>è</strong> stata inserita una fase campale con impiego di<br />
unità sia tunisine — tra le quali un’ Unità di decontaminazione<br />
(UDT), con ospedale da campo e un elicottero per<br />
Impattogramma su una delle località dell’esercitazione<br />
elaborato dal CNMCA.<br />
trattamenti con pesticidi — sia francesi (Unità di Decontaminazione<br />
Medica dell’Esercito - UDME). Come già specificato<br />
nell’articolo citato (Rivista Aeronautica n.4/2009<br />
pg. 13), l’organizzazione e l’esecuzione dell’esercitazione<br />
ha ricalcato lo schema già in uso presso la NATO. Sono state<br />
infatti attivate le seguenti cellule operative: J1 (personnel),<br />
J2 (intelligence), J3 (operation), J4 (logistics), J5<br />
(planning), J6 (communication and information system).<br />
Rispetto all’esercitazione Amitie 2008, era presente nell’organizzazione<br />
di comando uno specialista meteo francese<br />
che partecipava ai briefing per fornire punti di situazione<br />
inerenti la branca di competenza, simulando una<br />
situazione meteorologica non reale, ma già prefissata a tavolino<br />
durante le fasi di preparazione dell’esercitazione.<br />
In questa occasione, forte dell’esperienza maturata lo<br />
scorso anno e della collaborazione con la FAO, <strong>il</strong> rappresentante<br />
meteo italiano, t. col. Capizzi, ha presentato nell’ambito<br />
della giornata introduttiva dell’esercitazione, i<br />
prodotti meteo ut<strong>il</strong>i per lo scopo. Nello specifico, grazie<br />
anche alla stretta collaborazione con <strong>il</strong> CNMCA di Pratica<br />
di Mare, sono state mostrate le mappe grafiche dell’evoluzione<br />
dei parametri di vento a 10 metri, pressione al<br />
Copertura di nubi medie desunte dal modello COSMO-<br />
ME ritagliato ad hoc sul territorio tunisino.
Personale tunisino impiegato nella simulazione della disinfestazione<br />
di una piantagione di ulivi dalle locuste.<br />
<strong>suo</strong>lo, nuvolosità medio-bassa, delle precipitazioni e della<br />
temperatura a 2 metri e a 950hPa, relativa all’area tunisina<br />
con una scadenza di +72 ore e un “time-step” di 3 ore,<br />
desunti dal modello COSMO-MED del Servizio meteorologico<br />
dell’A.M.. Inoltre sono stati mostrati i meteogrammi<br />
ad alta risoluzione (ovvero con l’evoluzione oraria dei parametri<br />
meteo) relativi alle località di azione dell’esercitazione<br />
(Gabes, Medenine, Tataouine, Remada e Keb<strong>il</strong>i),<br />
ognuno corredato con un impattogramma, ovvero un “fly<br />
/ non-fly scheme” relativo sia alle locuste sia ai mezzi aerei<br />
ut<strong>il</strong>izzati per la diffusione dell’insetticida sul terreno<br />
infestato e che quindi tiene conto del valore orario dei parametri<br />
meteo necessari per l’attività (orario del giorno,<br />
intensità del vento, temperatura, copertura nuvolosa,<br />
presenza di precipitazioni).<br />
La presentazione ha suscitato vivo apprezzamento e<br />
grande interesse, soprattutto da parte delle autorità tunisine,<br />
che hanno chiesto di poterne acquisire copia, e<br />
hanno manifestato la volontà di chiedere all’Italia eventuali<br />
approfondimenti nel prossimo futuro.<br />
L’esercitazione si <strong>è</strong> confermata <strong>come</strong> attività di r<strong>il</strong>ievo<br />
inquadrata nella cooperazione b<strong>il</strong>aterale tra Tunisia e<br />
Francia. Peraltro, l’impiego di unità dispiegate sul campo<br />
ha evidenziato un adeguato grado di cooperazione e interoperab<strong>il</strong>ità.<br />
Anche sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o dell’Iniziativa 5+5,<br />
l’esercitazione ha mostrato di essere un’ottima opportunità<br />
per favorire <strong>il</strong> dialogo tra i Paesi partecipanti. Sotto<br />
<strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o tecnico-sanitario <strong>è</strong> emersa l’importanza di un<br />
adeguato livello di conoscenza in materia di effetti tossicologici<br />
dei più comuni pesticidi ut<strong>il</strong>izzati nella lotta contro<br />
le cavallette e delle relative contromisure sanitarie,<br />
Ten. col. Capizzi durante <strong>il</strong> briefing di spiegazione dei<br />
prodotti elaborati dal CNMCA per l’esercitazione Amitie.<br />
nonché dei sistemi di lotta biologica alternativi all’uso di<br />
sostanze chimiche. Inoltre, l’esercitazione ha evidenziato<br />
un possib<strong>il</strong>e impiego delle unità di decontaminazione medica<br />
m<strong>il</strong>itare, normalmente collegate a operazioni di tipo<br />
CBRN, in scenari di pubblica ut<strong>il</strong>ità.<br />
Per gli aspetti meteo <strong>è</strong> stato r<strong>il</strong>evato che:<br />
— la lesson identified evidenziata dal membro italiano lo<br />
scorso anno — ovvero l’esigenza di inserire uno specialista<br />
meteo nel Quartier Generale responsab<strong>il</strong>e delle operazioni<br />
— <strong>è</strong> stata recepita ed attuata da parte degli organizzatori<br />
dell’esercitazione;<br />
— l’offerta della capacità meteo e lo sv<strong>il</strong>uppo di sistemi di<br />
previsione ad hoc rappresenta un efficace mezzo per mantenere<br />
aperto <strong>il</strong> dialogo e la cooperazione nello specifico<br />
ambito.<br />
Paolo Capizzi
Sommario climatologico italiano del trimestre gennaio - marzo <strong>2010</strong><br />
hanno collaborato a questo numero:<br />
Tiziano Colombo, Adriano Raspanti, Angela Celozzi, Fabrizio Ciciulla,<br />
S<strong>il</strong>via Ughetto, F<strong>il</strong>ippo Maimone, Nicola Bitetto, Emanuele Regoli, Francesco Volpe<br />
La rete degli Osservatori del Servizio Meteorologico dell’A.M.<br />
I dati provenienti dagli Osservatori meteorologici dell’Aeronautica M<strong>il</strong>itare e dell’ENAV sono stati ut<strong>il</strong>izzati per ottenere i valori medi mens<strong>il</strong>i delle principali<br />
grandezze meteorologiche da confrontare con i valori della climatologia riferita al trentennio 1961-1990. Vengono evidenziati inoltre i fenomeni<br />
di scariche elettriche verificatisi in Italiae r<strong>il</strong>evati dalla rete del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica M<strong>il</strong>itare.
Temperature, precipitazioni, attività elettrica e commento sinottico<br />
del mese di gennaio <strong>2010</strong> in Italia<br />
Figura 1 e figura 2. Geopotenziale e temperatura decadale media a 500-hPa. (1 a e 2 a decade).<br />
Campi medi decadali in quota<br />
I campi decadali di geopotenziale e temperatura a 500<br />
hPa sono ottenuti mediando i campi di analisi dell’ECMWF<br />
su ciascuna delle successive tre decadi del mese di gennaio<br />
<strong>2010</strong>, <strong>come</strong> rappresentato sullo scenario europeo nelle<br />
mappe sopra evidenziate. Esse mostrano nel corso della<br />
prima decade un’ampia saccatura che si estende nella direzione<br />
del <strong>suo</strong> asse principale dalla penisola scandinava<br />
fino a nord della penisola iberica, lasciando sulle regioni<br />
meridionali una circolazione pressoché zonale. Nella seconda<br />
decade si nota una discesa dell’aria fredda in quota<br />
verso latitudini inferiori, con un nucleo presente sull’Europa<br />
centro-orientale, mentre la saccatura <strong>è</strong> spostata<br />
verso est, con asse in senso meridiano. Nell’ultima decade<br />
<strong>il</strong> campo medio di bassa pressione presenta una estensione<br />
su buona parte dell’area mediterranea, con l’aria fredda<br />
in quota che interessa più uniformemente la nostra penisola.<br />
Temperature, precipitazioni e attività elettrica in Italia<br />
Temperature massime. La mappa delle temperature<br />
massime medie per <strong>il</strong> mese di gennaio mostra valori un po’<br />
al disotto delle medie del periodo su gran parte del territorio<br />
nazionale, ma contenuti all’interno della naturale variab<strong>il</strong>ità<br />
del periodo nell’intervallo (-1/2,+1/2), in unità<br />
delle deviazioni standard delle distribuzioni climatologiche<br />
(CliNo’61-90). Il picco massimo dei valori di anomalia re-<br />
lativa si <strong>è</strong> avuto sulla Sic<strong>il</strong>ia centrale e orientale, con<br />
circa +1.5 unità. A seguire, sulla Bas<strong>il</strong>icata e sulla Puglia ionica,<br />
sulle coste di Abruzzo e Molise, su una zona centrale<br />
del Lazio, nella laguna padano-veneta, su una zona tra<br />
Lombardia e Piemonte e sulla Sardegna orientale e sudorientale<br />
si sono verificate anomalie leggermente positive,<br />
minori di 0.5 unità. Le anomalie (relative) negative più<br />
alte, in valore assoluto, sono state registrate invece sul<br />
settore di nord-ovest e sull’estremità occidentale della Sic<strong>il</strong>ia,<br />
con -1.5 unità. Un raffreddamento un pó meno intenso,<br />
ma ancora significativo, ha interessato <strong>il</strong> settore di<br />
nord-ovest, la costa settentrionale delle Marche e la costa<br />
dell’Em<strong>il</strong>ia Romagna, la costa laziale meridionale e la Calabria<br />
centrale, con valori nell’intervallo (-1.5,-1) unità.<br />
Anomalie relative intermedie si sono verificate altrove. I<br />
valori assoluti delle temperature massime non hanno subito<br />
eccessive variazioni nel corso del mese, neanche per<br />
quanto riguarda la loro distribuzione geografica. Nel complesso<br />
durante la prima decade i valori sono stati di qualche<br />
grado più alti sulle regioni meridionali, in particolare<br />
sulla Sic<strong>il</strong>ia orientale, con temperature massime comprese<br />
tra 20°C e 25°C, mentre sul resto della Sic<strong>il</strong>ia, sulla Puglia,<br />
sulla Sardegna e sulla costa tirrenica esse sono state comprese<br />
tra 15°C e 20°C. Sul resto delle regioni meridionali<br />
le massime sono state tra 10°C e 15°C, <strong>come</strong> sulle fasce<br />
costiere delle regioni centrali. A partire dalla seconda decade,<br />
i valori nel complesso si sono alzati di qualche grado<br />
sulle zone continentali delle regioni centrali e settentrionali<br />
e si sono poi mantenuti pressoché invariati, con un significativo<br />
abbassamento (di qualche grado) sulla parte
Figura 3. Anomalie delle temperature massime. Figura 4. Anomalie delle temperature minime.<br />
continentale del Centro e sulle regioni tirreniche meridionali<br />
soltanto negli ultimi giorni del mese. Al Sud, invece,<br />
i valori massimi sono rimasti pressoché stazionari la<br />
maggior parte del mese, con fluttuazioni dell’ordine di<br />
qualche grado. Non sono stati registrati record storici di<br />
temperature massime nel corso del mese di gennaio.<br />
Temperature minime. Le anomalie relative per le temperature<br />
minime del mese di gennaio sono state, coerentemente<br />
con <strong>il</strong> caso delle massime, ampiamente comprese<br />
all’interno della naturale variab<strong>il</strong>ità del mese, per lo<br />
più all’interno dell’intervallo (-1.5,+1.5), in unità delle deviazioni<br />
standard delle distribuzioni climatologiche<br />
(CliNo’61-90). A differenza del caso delle massime, i picchi<br />
più alti delle anomalie relative sono stati più localizzati.<br />
I valori più bassi sono stati registrati sul settore di<br />
nord-ovest della penisola (buona parte della Liguria e la<br />
parte occidentale del Piemonte), con circa -1.7 unità, sull’estremo<br />
settore di Nord-Est, con -1 unità. Valori un pó più<br />
alti si sono avuti sulla parte settentrionale delle Marche e<br />
sull’Umbria, con -0.7 unità, sulla Sardegna orientale e<br />
sulla parte centrale della Calabria, con -0.5 unità. I valori<br />
massimi di anomalia relativa si sono avuti sulla Bas<strong>il</strong>icata<br />
e Puglia ionica, sulla Campania settentrionale e in una<br />
zona a ridosso della costa laziale centrale con circa +1.5<br />
unità. Inoltre, valori più alti della media del periodo si sono<br />
avuti sulla Lombardia e sulla pianura padano-veneta, con<br />
circa +0.5 unità. Anomalie intermedie e tendenzialmente<br />
lievemente positive, sono state registrate altrove. Nella<br />
prima decade, sulle zone continentali delle regioni settentrionali<br />
sono state registrate temperature minime mediamente<br />
di circa -10°C, seguite dai -5°C di minima registrato<br />
sulle zone continentali delle regioni centrali e<br />
parzialmente su quelle meridionali. Le fasce costiere dell’Italia<br />
centrale, meridionale, nonché le due isole maggiori<br />
hanno mantenuto per tutta la durata del mese tempera-<br />
ture minime di circa 5°C, con punte sui 10°C in Sic<strong>il</strong>ia,<br />
Sardegna occidentale e Puglia centrale. A partire dalla seconda<br />
decade le temperature minime si sono innalzate di<br />
qualche grado sulle zone continentali del Centro e del Nord<br />
e la situazione <strong>è</strong> rimasta pressoché stazionaria fino agli ultimi<br />
tre giorni del mese (quando <strong>è</strong> occorso un generale abbassamento<br />
delle temperature), con una osc<strong>il</strong>lazione dei<br />
valori sulle isole compresa tra 5°C e 10°C circa. Non sono<br />
stati registrati record storici di temperatura minima nel<br />
corso del mese.<br />
Precipitazioni<br />
La mappa delle anomalie delle precipitazioni cumulate<br />
nel corso del mese mostra una condizione più diffusa di<br />
lieve deficit rispetto alle precipitazioni tipiche del periodoe<br />
dei picchi di precipitazioni significativamente al disopra<br />
prevalentemente sulle due isole maggiori. Le anomalie<br />
relative sono state nel complesso comprese<br />
nell’intervallo (-0.5,+3), in unità dello scarto interquint<strong>il</strong>e<br />
delle distribuzioni climatologiche (per una stima più quantitativa,<br />
si tenga conto del fatto che <strong>il</strong> valore di tale<br />
scarto, mediato su tutte le stazioni per <strong>il</strong> mese di gennaio,<br />
<strong>è</strong> di circa 79 mm). Le maggiori quantità di precipitazione<br />
sono state registrate sulla parte centrale della Sic<strong>il</strong>ia,<br />
sulla parte orientale della Sardegna, fino a 2.5-3 unità degli<br />
scarti interquint<strong>il</strong>i e inoltre sulla parte centrale della<br />
Calabria, compresi i versanti tirrenico e ionico e sulle regioni<br />
centro−settentrionali, interessando Umbria, Toscana,<br />
Marche ed Em<strong>il</strong>ia Romagna, con circa +1.5 unità. Le zone<br />
che hanno presentato <strong>il</strong> deficit maggiore sono state invece<br />
la parte orientale della Lombardia e <strong>il</strong> Friuli Venezia-Giulia,<br />
con anomalie relative di -0.7 unità. Rispetto all’andamento<br />
delle precipitazioni nel corso del mese, generalmente<br />
su gran parte del territorio (regioni settentrionali e
centrali e parte delle regioni meridionali), la parte centrale<br />
del mese <strong>è</strong> stata più secca, mentre durante la prima<br />
decade e durante la seconda parte dell’ultima decade le<br />
precipitazioni sono state più sparse. In particolare, nel<br />
corso della prima decade si sono verificate precipitazioni<br />
abbondanti (tra 100 e 200 mm) su Umbria e Toscana, mentre<br />
sulle regioni tirreniche e sul medio e alto versante<br />
adriatico si sono verificate precipitazioni fino a 50 mm,<br />
così <strong>come</strong> sulla Sic<strong>il</strong>ia centro-occidentale. Nella seconda<br />
decade le precipitazioni sono state alquanto scarse su<br />
gran parte del territorio nazionale. Hanno fatto eccezione<br />
la parte occidentale della Bas<strong>il</strong>icata e della Calabria, con<br />
50-100 mm, della Sic<strong>il</strong>ia centrale e occidentale, con circa<br />
100-200 mm, e buona parte della Sardegna, con precipitazioni<br />
fino a 50 mm nella prima parte della seconda decade.<br />
Nell’ultima decade le regioni meridionali sono state<br />
le più interessate dai fenomeni, in special modo la Calabria<br />
(dove nella parte centrale sono state registrate precipitazioni<br />
tra 100 e 200 mm), <strong>il</strong> Lazio, le Marche, la Sardegna<br />
nord-orientale e meridionale, con piogge fino a 50<br />
mm. Precipitazioni fino a 25 mm sono state registrate altrove,<br />
eccetto che sulle regioni settentrionali dove sono<br />
state scarse se non assenti. Sono da segnalare alcuni record<br />
storici relativi alle precipitazioni (fra parentesi l’anno in<br />
cui si <strong>è</strong> verificato <strong>il</strong> precedente estremo negli ultimi 59<br />
anni e l’aumento relativo in mm). Da notare <strong>il</strong> record storico<br />
registrato dalla stazione di Prizzi, nella Sic<strong>il</strong>ia centrale,<br />
che ha sostituito <strong>il</strong> record dell’anno precedente.<br />
Neve sulle Alpi<br />
Arezzo (249 mt.s.l.m.) mens<strong>il</strong>e:<br />
128.8 mm (1987, +13.7).<br />
Prizzi (1035 mt.s.l.m.) mens<strong>il</strong>e:<br />
269.8 mm (2009, +3.6).<br />
Frontone (574 mt.s.l.m.) giornaliero:<br />
66.4 mm (1987, +6.8).<br />
Grosseto (7 mt.s.l.m.) giornaliero:<br />
56.6 mm (1998, +3.2).<br />
La mappa della neve, ovvero dell’altezza media del manto<br />
nevoso sulle Alpi per <strong>il</strong> mese di gennaio, <strong>è</strong> stata realizzata<br />
a partire dalle r<strong>il</strong>evazioni (orarie) effettuate da 42 stazioni<br />
della Rete Meteomont dislocate sulle Alpi. Il sistema di monitoraggio<br />
del Servizio Meteomont del Comando Truppe Alpine<br />
ha <strong>come</strong> compito quello di acquisire i parametri meteo-nivologici,<br />
finalizzati soprattutto alla continua<br />
Figura 5. Precipitazioni cumulate.<br />
valutazione e determinazione del rischio valanghe. La<br />
mappa indica uno spessore medio del manto nevoso, sulle<br />
zone monitorate, di circa 1.2 m, con punte massime fino<br />
a 1.8m. Sulle Alpi Retiche lo spessore <strong>è</strong> stato mediamente<br />
maggiore, dell’ordine di 1.5 m. Spessori mediamente<br />
un pó inferiori sono stati registrati sulle Alpi Tirolesi<br />
e su quelle Marittime (dell’ordine di 1 m), mentre sulle<br />
Alpi Cozie e Graie lo spessore medio <strong>è</strong> stato di circa 60 cm.<br />
Scariche elettriche<br />
La mappa di densità delle scariche elettriche mostra<br />
una fenomenologia molto modesta sul territorio nazionale<br />
e sui mari circostanti, <strong>come</strong> <strong>è</strong> caratteristico del mese<br />
di gennaio. Attività elettrica di r<strong>il</strong>ievo <strong>è</strong> da riferirsi al Tirreno<br />
centro-meridionale, al largo delle coste della Sardegna,<br />
sulla parte centrale delle coste campane, e sull’alto<br />
Adriatico. I fenomeni si sono verificati per lo più nel<br />
corso della prima decade (sulla penisola) e dell’ultima decade<br />
(al largo delle coste sarde orientali).<br />
Figura 6. Manto nevoso.
Figura 7. Densità di scariche elettriche.<br />
Evoluzione sinottica<br />
• 1-4 Domina una saccatura con centro di azione sulla penisola<br />
scandinava e l’Italia si trova nel ramo sud-orientale<br />
del flusso principale perturbato. L’asse della saccatura<br />
nella circolazione principale <strong>è</strong> diretta in senso quasi zonale,<br />
mentre la circolazione ciclonica derivata si estende<br />
fino all’Italia centrale; Il passaggio del transiente avviene<br />
rapidamente, lasciando a ovest della nostra penisola un<br />
promontorio in rimonta.<br />
• 5-11 Il minimo inserito nel ramo secondario meridionale<br />
del flusso principale perturbato viene alimentato dalle<br />
correnti umide del Nord Atlantico,<br />
determinando un’ampia<br />
saccatura con asse diretto<br />
lungo la penisola iberica; la<br />
circolazione <strong>è</strong> bloccata da un<br />
promontorio fisso sul Nord-<br />
Atlantico, con un minimo persistente<br />
inizialmente centrato<br />
sulla penisola iberica, in lento<br />
spostamento verso est, che ha<br />
investito la nostra penisola a<br />
partire dal giorno 10.<br />
• 12-22 Il progressivo sfaldamento<br />
del promontorio sul<br />
Nord Atlantico ha lasciato una<br />
circolazione prevalentemente<br />
zonale da ovest, determinando<br />
un modesto promontorio sulla<br />
nostra penisola; una nuova<br />
saccatura in seno al ramo se-<br />
condario del flusso principale<br />
perturbato si sv<strong>il</strong>uppa rapida-<br />
<br />
mente grazie all’instab<strong>il</strong>ità baroclina presente<br />
sulla penisola iberica; la presenza di un<br />
forte promontorio sull’Europa nord-orientale<br />
ne determina lo schiacciamento zonale e l’approfondimento<br />
verso sud, con un minimo in<br />
fase di cut-off sul Nord Africa, in spostamento<br />
verso est.<br />
• 19-23 La circolazione sull’Italia <strong>è</strong> fortemente<br />
meridiana, schiacciata tra <strong>il</strong> promontorio<br />
sull’Ingh<strong>il</strong>terra e la stretta saccatura<br />
che si protende dalla penisola scandinava investendo<br />
la penisola iberica; <strong>il</strong> moto retrogrado<br />
del minimo investe anche le nostre regioni<br />
centro-meridionali.<br />
• 24-27 Il minimo in esaurimento lascia spazio<br />
ad ovest a un regime transitorio di alta pressione, che<br />
si sfalda rapidamente sotto l’azione della divergenza di un<br />
flusso fortemente meridiano proveniente dal Nord Europa.<br />
• 28-31 La circolazione meridiana apporta ora aria artica<br />
sulla nostra penisola, instaurandosi tra un ampio promontorio<br />
che si protende sull’Europa nord-occidentale, e un<br />
minimo centrato sull’area siberiana. Il flusso presenta una<br />
notevole divergenza sul bacino del Mediterraneo, dominato<br />
nella sua parte occidentale da una vasta e debole circolazione<br />
depressionaria. L’approfondimento del minimo sopra<br />
menzionato determina l’organizzazione di una perturbazione<br />
che spazza l’Italia, apportando tra l’altro le nevicate<br />
Figura 8. Mappe di analisi di geopotenziale e temperatura a 500hPa in alcuni momenti<br />
salienti della circolazione sullo scenario Euro-Atlantico.
Figura 9. Una merla tra <strong>il</strong> ghiaccio, simbolo, nella tradizione<br />
popolare, dei giorni più freddi dell’anno.<br />
degli ultimi giorni del mese.<br />
L’evento saliente del mese: l’ondata di freddo nei<br />
"giorni della merla"<br />
I giorni 29, 30 e 31 di gennaio, noti <strong>come</strong> “i giorni della<br />
merla”, sono stati caratterizzati, in accordo con la tradizione<br />
popolare, da una ondata di freddo proveniente dalle<br />
regioni artiche che ha portato nevicate sulle regioni settentrionali<br />
che hanno marginalmente interessato anche<br />
zone costiere, <strong>come</strong> ad esempio <strong>il</strong> litorale ravennate. Le<br />
temperature percepite sono state ulteriormente abbassate<br />
dall’effetto del forte vento. Questi giorni sono considerati<br />
tra i più freddi dell’anno anche secondo la tradizione popolare<br />
e derivano <strong>il</strong> loro nome da una leggenda secondo la<br />
quale una merla, tormentata dal freddo di gennaio, che allora<br />
aveva solo 28 giorni, alla fine del mese credette di essere<br />
uscita dall’inverno e disse: «più non ti curo, Domine<br />
che uscita son del verno»; ma gennaio, fattosi prestare 3<br />
giorni da febbraio, che allora ne aveva 31, scatenò un<br />
freddo intenso con bufere terrib<strong>il</strong>i, <strong>come</strong> continua a fare<br />
oggi perché la merla subisca <strong>il</strong> meritato castigo. Esiste anche<br />
un’altra versione della leggenda per la quale la merla<br />
e i <strong>suo</strong>i pulcini, in origine bianchi, per ripararsi dal gran<br />
freddo, si rifugiarono dentro <strong>il</strong> comignolo di una casa, dal<br />
quale emersero <strong>il</strong> 1° febbraio e da quel giorno rimasero per<br />
sempre neri a causa della fuliggine. Leggende e tradizioni<br />
a parte, <strong>è</strong> stato riscontrato che alcuni giorni dell’anno corrispondono,<br />
almeno statisticamente, a momenti particolari<br />
nella risposta non-lineare dell’atmosfera al ciclo stagionale<br />
della radiazione solare. Gennaio <strong>è</strong> <strong>il</strong> mese più freddo dell’anno<br />
e anche quello in cui l’altezza del Sole sull’orizzonte<br />
<strong>è</strong> ricominciata a crescere (a partire dal solstizio d’inverno<br />
del 21 dicembre). Il mare in questo periodo<br />
dell’anno <strong>è</strong> ancora molto freddo, avendo attraversato un<br />
lungo periodo in cui <strong>è</strong> stata scarsa la radiazione solare in-<br />
Figura 10. Immagine dal satellite polare (NOAA), canale<br />
del visib<strong>il</strong>e, del giorno 31 ore 12:11 UTC. Tra le altre<br />
cose, si possono osservare le onde orografiche provenienti<br />
da ovest, la nuvolosità compatta sul settore nordorientale<br />
e <strong>il</strong> dettaglio della neve sulle Alpi.<br />
cidente, mentre la sua inerzia termica impedisce una risposta<br />
rapida della temperatura anche degli strati vicini<br />
alla superficie. Ad esempio, uno studio effettuato dal Servizio<br />
di Climatologia del CNMCA ha evidenziato che una situazione<br />
analoga si verifica nella primavera inoltrata, in<br />
cui <strong>il</strong> riscaldamento degli strati bassi dell’atmosfera avviene<br />
con un processo quasi lineare con l’aumentare della<br />
radiazione solare incidente, e a un certo punto si interrompe<br />
pressoché bruscamente (sempre in senso statistico)<br />
in alcuni giorni tra marzo e apr<strong>il</strong>e; ciò <strong>è</strong> dovuto a una rapida<br />
ridistribuzione meridiana del calore accumulato, se-<br />
Figura 11. Vento massimo registrato dalle stazioni della<br />
rete dell’Aeronautica M<strong>il</strong>itare <strong>il</strong> giorno 31. Le temperature<br />
percepite, per l’effetto wind-ch<strong>il</strong>l sono risultate<br />
sensib<strong>il</strong>mente più basse rispetto a quelle misurate a<br />
causa del vento intenso presente.
condo <strong>il</strong> meccanismo principale di trasferimento del calore<br />
delle nostre latitudini, ovvero quello della instab<strong>il</strong>ità baroclina.<br />
Per quanto concerne i disagi creati dall’ondata di<br />
freddo, essi sono stati certamente non paragonab<strong>il</strong>i con la<br />
situazione del mese precedente, ma hanno inciso comunque,<br />
in particolare, sul traffico autostradale. Sull’autostrada<br />
A14 e in diversi tratti autostradali del Nord, ad<br />
esempio, la Polizia Stradale ha istituito f<strong>il</strong>tri per la verifica<br />
della presenza di catene alle ruote degli autoveicoli o a<br />
bordo degli stessi, provvedendo anche alla regolarizzazione<br />
del traffico degli automezzi pesanti.<br />
Verifiche del modello COSMO−ME relative al mese di<br />
gennaio <strong>2010</strong><br />
I grafici, anche per le verifiche dei mesi successivi, riportano<br />
le serie temporali e <strong>il</strong> ciclo diurno di temperatura<br />
a 2 metri e pressione sul livello del mare del mese in<br />
esame. Sono messi a confronto i Synop forniti dalle stazioni<br />
Italiane e i dati di previsione del COSMO−ME corsa-00. Il<br />
modello non idrostatico COSMO−ME <strong>è</strong> integrato sull’Europa<br />
in una griglia spaziale a 7 km usando l’analisi 3D-VAR del<br />
CNMCA interpolata e usando i campi previsti IFS <strong>come</strong><br />
condizioni al contorno laterali. La risoluzione verticale<br />
comprende 40 livelli. I dati ottenuti sono successivamente<br />
raggruppati per zone geografiche: Italia settentrionale,<br />
Italia centrale con Sardegna e Italia meridionale<br />
e Sic<strong>il</strong>ia.<br />
Sommario del mese<br />
L’analisi delle serie temporali dei dati osservati e previsti,<br />
mostra un andamento coerente del campo della<br />
pressione in tutta l’Italia. Il ciclo diurno mostra questo<br />
<br />
comportamento del modello durante tutta la giornata. Il<br />
campo della temperatura, invece, evidenzia soprattutto<br />
per <strong>il</strong> Nord e <strong>il</strong> Centro Italia temperature osservate più alte<br />
rispetto a quelle previste. Il modello sembra quindi sottostimare<br />
le temperature del mese. Il ciclo diurno evidenzia<br />
tale discrepanza a partire dalle 9 del mattino incrementandola<br />
con <strong>il</strong> tra<strong>scorrere</strong> della giornata.<br />
I grafici delle anomalie di temperatura e precipitazioni<br />
sono costruiti confrontando le medie mens<strong>il</strong>i delle temperature<br />
giornaliere (massime o minime) e le precipitazioni<br />
cumulate mens<strong>il</strong>i con i valori del Climate Normals<br />
1961-90 (CliNo: valori medi costruiti sulle osservazioni dal<br />
1961 al 1990). La differenza tra <strong>il</strong> valore medio di gennaio<br />
<strong>2010</strong> e quello del CliNo viene divisa per la deviazione<br />
standard (nel caso delle temperature) o per lo scarto interquint<strong>il</strong>e<br />
Q4-Q1 (nel caso delle precipitazioni) dello<br />
stesso CliNo. Relativamente alle sole temperature, <strong>è</strong> possib<strong>il</strong>e<br />
quantificare in gradi centigradi l’entità dell’anomalia<br />
evidenziata dai grafici semplicemente moltiplicando<br />
<strong>il</strong> valore mostrato dalla barra delle intensità per i rispettivi<br />
valori delle deviazioni standard. La deviazione standard,<br />
che rappresenta lo scostamento delle misure dal valore<br />
medio delle osservazioni (1961-1990), nel mese di<br />
gennaio risulta in Italia mediamente pari ad 1.5°C per le<br />
temperature massime e ad 1.7 °C per le minime. La mappa<br />
di densità relativa ai fulmini, invece, rappresenta <strong>il</strong> numero<br />
di scariche per ogni unità di superficie (quadrato di<br />
10km×10km).<br />
Per evidenziare i confronti specifici sulle singole stazioni<br />
si rimanda all’indirizzo internet:<br />
http://clima.meteoam.it/Clino61-90.php
Figura 12. Nord Italia.<br />
Figura 13. Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 14. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.<br />
Verifiche del modello COSMO−ME<br />
Serie Temporale gennaio <strong>2010</strong> MSLP Ciclo Diurno gennaio <strong>2010</strong> MSLP<br />
Figura 15. Nord Italia.<br />
Figura 16. Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 17. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.
Serie Temporale gennaio <strong>2010</strong> Temperatura 2g Ciclo Diurno gennaio <strong>2010</strong> MSLP<br />
Figura 18. Nord Italia.<br />
Figura 19. Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 20. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.<br />
Figura 21. Nord Italia.<br />
Figura 22.Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 23. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.
Temperature, precipitazioni, attività elettrica e commento sinottico<br />
del mese di febbraio <strong>2010</strong> in Italia<br />
Figura 1. Geopotenziale e temperatura decadale<br />
media a 500-hPa. (2 a decade).<br />
Campi medi decadali in quota<br />
I campi decadali di geopotenziale e temperatura a 500<br />
hPa sono ottenuti mediando i campi di analisi dell’ECMWF<br />
su ciascuna delle successive tre decadi del mese di febbraio<br />
<strong>2010</strong>, <strong>come</strong> rappresentato sullo scenario europeo<br />
nelle mappe che seguono. Nella prima decade del mese la<br />
massa d’aria presente sull’Europa centrale e sul settore<br />
centrale del Mediterraneo <strong>è</strong> stata di origine polare continentale,<br />
per effetto di una prolungata retrogressione del<br />
flusso perturbato principale. Successivamente <strong>il</strong> flusso <strong>è</strong><br />
stato caratterizzato da un più elevato indice zonale. Nella<br />
terza decade ha prevalso una massa d’aria sempre di origine<br />
polare ma più umida, essendo di origine marittima.<br />
Temperature, precipitazioni e attività elettrica in Italia<br />
Temperature massime. La mappa delle temperature<br />
massime medie per <strong>il</strong> mese di febbraio mostra valori compatib<strong>il</strong>i<br />
con le medie del periodo su gran parte del territorio<br />
nazionale, e contenuti per lo più all’interno dell’intervallo<br />
(-1.5,+1), in unità delle deviazioni standard delle<br />
distribuzioni climatologiche (CliNo’61-90). Il maggiore riscaldamento<br />
relativo si <strong>è</strong> avuto sulle regioni settentrionali,<br />
con l’eccezione del settore alpino e pre-alpino centroorientale,<br />
in particolare sulla pianura padana e sulla zona<br />
di Trieste, con +1 unità. Un riscaldamento superiore alla<br />
media <strong>è</strong> stato inoltre registrato su tutto <strong>il</strong> medio e alto ver-<br />
Figura 2. Anomalie delle temperature massime.<br />
sante adriatico, sulla Bas<strong>il</strong>icata centrale, sulla Puglia meridionale<br />
ionica e sulla Calabria meridionale, con anomalie<br />
relative di +0.5/+1 unità. Le anomalie relative più<br />
basse sono occorse sulla Sic<strong>il</strong>ia occidentale, con circa -2.5<br />
unità, sulla parte continentale del Lazio e sull’Umbria, con<br />
-1.5 unità, sulla riviera ligure di levante, sulla Puglia centrale<br />
e sulla Sic<strong>il</strong>ia sud-orientale, con -1/-1.5 unità. Valori<br />
molto prossimi alle medie del periodo sono stati registrati<br />
sulla Sardegna e in Toscana. <strong>Durante</strong> la prima fase del<br />
mese (prima metà della prima decade), le temperature<br />
massime sono state mediamente di circa 5-10°C al Nord<br />
(eccetto che sulla fascia alpina), di 10-15°C sulle regioni<br />
centrali e meridionali, e di 15-20°C sulle coste della Sic<strong>il</strong>ia<br />
meridionale e settentrionale, sulla Calabria meridionale<br />
e sulla Sardegna. Nella fase successiva, fino a metà del<br />
mese, si <strong>è</strong> avuto un generale raffreddamento, con valori<br />
massimi che si sono attestati in media sui 5-10°C anche<br />
sulle zone continentali del Centro-Sud. Nella seconda metà<br />
del mese le temperature massime sono considerevolmente<br />
aumentate su buona parte della penisola, raggiungendo anche<br />
i 20-25°C sulla Sic<strong>il</strong>ia e Sardegna sud-orientali. Con riferimento<br />
ai record storici di temperature massime, <strong>è</strong> da<br />
segnalare una singola stazione tab.1 (fra parentesi, l’anno<br />
in cui si <strong>è</strong> verificato <strong>il</strong> precedente estremo negli ultimi 59<br />
anni e l’aumento relativo in °C):<br />
tab. 1.<br />
Civitavecchia (4 mt.s.l.m.) mens<strong>il</strong>e:<br />
13.5 °C (2006, +0.5).
Temperature minime. Le anomalie relative per le temperature<br />
minime del mese di febbraio sono state, <strong>come</strong> per<br />
le massime, comprese all’interno della naturale variab<strong>il</strong>ità<br />
del periodo, con valori nell’intervallo (-1.5,+1) in unità<br />
delle deviazioni standard delle distribuzioni climatologiche<br />
(CliNo’61-90). Le anomalie sono state prevalentemente positive<br />
al Nord, vicine allo zero o leggermente negative sulle<br />
regioni centrali, negative sulle regioni meridionali, coste<br />
tirreniche in particolare, e sulle isole maggiori. I valori<br />
massimi delle anomalie relative sono stati raggiunti sul settore<br />
alpino e pre-alpino centrale, sulla parte continentale<br />
del Veneto, in una zona tra Liguria ed Em<strong>il</strong>ia Romagna e<br />
sulla Bas<strong>il</strong>icata centrale e ionica, con più di 1 unità di anomalia<br />
relativa. I valori più bassi sono invece da attribuirsi<br />
a gran parte della Sic<strong>il</strong>ia, dove si sono avuti valori pressoché<br />
uniformi di circa -1.5 unità (eccetto che in una zona<br />
intorno a Palermo e sulla parte centrale dell’isola), sulla<br />
Calabria centrale e sulle coste del Tirreno meridionale,<br />
sulle coste pugliesi orientali, e anche lungo l’Appennino<br />
centrale, con -1/-1.5 unità di anomalia relativa. Nel complesso,<br />
le temperature minime più basse sono state raggiunte<br />
nel corso della prima parte della prima decade, con<br />
valori di -5/-10°C sulle estreme regioni settentrionali (con<br />
l’eccezione della fascia alpina, caratterizzata da valori ancora<br />
più bassi, fortemente dipendenti dalla quota) e sulle<br />
zone continentali delle regioni del Centro-Nord. Sulla riviera<br />
ligure di ponente, su buona parte delle regioni centro-meridionali,<br />
e sulla parte settentrionale della Sardegna,<br />
si sono avute temperature minime comprese tra -5°C<br />
e 0°C, mentre su Sic<strong>il</strong>ia, Calabria meridionale, sulla restante<br />
parte della Sardegna, sulle coste tirreniche meridionali<br />
e sulla Puglia meridionale si sono avuti valori minimi<br />
fino a circa 5°C. A partire da questo stato iniziale, <strong>il</strong><br />
campo termico delle minime <strong>è</strong> evoluto verso di un aumento<br />
di qualche grado sulle zone continentali delle regioni del<br />
centro-settentrionali e sulla Sardegna settentrionale fino<br />
a metà mese, poi si <strong>è</strong> avuto un graduale riscaldamento di<br />
3-4°C generalmente su tutta la penisola, con valori minimi<br />
che su Sic<strong>il</strong>ia, Puglia e Sardegna si sono attestati sui 5-<br />
10°C. Non sono stati registrati record storici di temperatura<br />
minima nel corso del mese.<br />
Precipitazioni<br />
La mappa delle anomalie delle precipitazioni cumulate<br />
nel corso del mese mostra una situazione vicina alla norma<br />
climatica, con una tendenza più diffusa sul territorio nazionale<br />
verso un leggero deficit e con surplus più localizzati<br />
al Nord e al Sud, che non hanno comunque superato<br />
Figura 3. Anomalie delle temperature minime.<br />
1.7 unità dello scarto interquint<strong>il</strong>e delle distribuzioni climatologiche<br />
(per una stima più quantitativa, si tenga<br />
conto del fatto che <strong>il</strong> valore di tale scarto, mediato su<br />
tutte le stazioni per <strong>il</strong> mese di febbraio, <strong>è</strong> di circa 71 mm).<br />
Le precipitazioni più consistenti hanno avuto luogo sulla<br />
Calabria centrale, con anomalie relative poco superiori a<br />
1.5 unità dello scarto interquint<strong>il</strong>e, sulla Lombardia e sul<br />
Friuli Venezia-Giulia, con +1.2 unità, sulle coste della Toscana<br />
settentrionale, con +1 unità, e sulla parte occidentale<br />
della Sic<strong>il</strong>ia, con +0.8 unità. La zona che ha presentato<br />
<strong>il</strong> deficit maggiore <strong>è</strong> stata invece l’estremo settore di<br />
nord-est della penisola, con circa -0.7 unità. Anomalie<br />
negative, comunque non inferiori a -0.5 unità, hanno riguardato<br />
<strong>il</strong> settore di nord-ovest, le regioni centrali e meridionali,<br />
la Sardegna e la parte orientale della Sic<strong>il</strong>ia. Le<br />
precipitazioni sono state abbastanza distribuite nel corso<br />
del mese, con (nel complesso) una maggiore concentrazione<br />
nella seconda decade e, limitatamente ad alcune<br />
zone, nella prima parte del mese. In particolare, nei primi<br />
giorni di febbraio e tra la prima e la seconda decade, su<br />
Calabria centrale e Sic<strong>il</strong>ia nord-occidentale sono caduti tra<br />
i 100 e 200 mm di pioggia e fino a 50 mm sulle regioni meridionali<br />
tirreniche, sulla Sardegna meridionale e sulla fascia<br />
costiera marchigiana. Nello stesso intervallo temporale<br />
sulle regioni settentrionali non sono cadute<br />
precipitazioni di r<strong>il</strong>ievo, mentre nel corso della decade<br />
successiva piogge fino a 50 mm hanno interessato buona<br />
Tab 2.<br />
Radicofani (828 mt.s.l.m.)<br />
mens<strong>il</strong>e: 225.0 mm (1984, +109.4),<br />
giornaliero : 141.2 mm (2004, +70.2).<br />
Civitavecchia (4 mt.s.l.m.)<br />
mens<strong>il</strong>e: 156.8 mm (1979, +8.2).
Figura 4. Precipitazioni cumulate. Figura 5. Manto nevoso.<br />
parte delle regioni centrali e settentrionali. Nell’ultima<br />
parte del mese, invece, le precipitazioni più intense (tra<br />
25 mm e 50 mm) si sono avute sul Lazio, lsulla Toscana e<br />
sulla Calabria centro-meridionale.<br />
Sono da segnalare alcuni record storici delle precipitazioni<br />
tab.2(fra parentesi l’anno in cui si <strong>è</strong> verificato <strong>il</strong> precedente<br />
estremo negli ultimi 59 anni e l’incremento relativo<br />
in mm).<br />
Neve sulle Alpi<br />
La mappa della neve, ovvero dell’altezza media del<br />
manto nevoso sulle Alpi per <strong>il</strong> mese di febbraio, <strong>è</strong> stata<br />
realizzata a partire dalle r<strong>il</strong>evazioni (orarie) effettuate da<br />
42 stazioni della Rete Meteomont dislocate sulle Alpi.<br />
Il sistema di monitoraggio del Servizio Meteomont del<br />
Comando Truppe Alpine ha <strong>come</strong> compito quello di acquisire<br />
i parametri meteo-nivologici, finalizzati soprattutto<br />
alla continua valutazione e determinazione del rischio valanghe.<br />
La mappa indica uno spessore medio del manto nevoso,<br />
sulle zone monitorate, di circa 1.2 m, con punte massime<br />
fino a 2.3 m. Sulle Alpi Retiche e sulla parte<br />
meridionale di quelle Tirolesi lo spessore <strong>è</strong> stato più alto<br />
della media di circa 30-50 cm. Più vicini alla media e talvolta<br />
un po’ inferiori, sono stati gli spessori del manto nevoso<br />
registrati sulle Alpi Marittime Cozie e Giulie.<br />
Scariche elettriche<br />
La mappa di densità delle scariche elettriche mostra una<br />
fenomenologia molto modesta sul territorio nazionale e sui<br />
mari circostanti, <strong>come</strong> <strong>è</strong> caratteristico del mese di febbraio.<br />
L’attività elettrica si <strong>è</strong> prodotta per lo più sull’Appennino<br />
centro-settentrionale e in generale sulle regioni<br />
centro-settentrionali, sul Tirreno e lo Ionio meridionali, e<br />
sulle coste ad essi prospicienti, e sull’Adriatico centrale.<br />
Gli eventi più r<strong>il</strong>evanti sull’Appennino e sulle regioni centro-settentrionali<br />
si sono verificati nel corso della terza decade,<br />
mentre nelle prime due si <strong>è</strong> avuta una attività, peraltro<br />
molto modesta, diffusa soprattutto su Tirreno e<br />
Ionio meridionali.<br />
Evoluzione sinottica<br />
• 1-3 Lo scenario euro-atlantico si presenta con un promontorio<br />
che si spinge fin sull’Islanda e una vasta circolazione<br />
depressionaria sull’Europa centro-orientale. La temporanea<br />
erosione del promontorio favorisce valori di<br />
geopotenziale più elevati sul Mediterraneo.<br />
• 4-5 L’approfondimento di una vasta depressione sull’Atlantico<br />
genera un flusso di correnti anticicloniche sul<br />
Mediterraneo.<br />
• 6-8 La depressione atlantica entra nel Mediterraneo richiamando<br />
al <strong>suo</strong> interno aria più fredda di origine continentale.<br />
Alle spalle della depressione torna a sv<strong>il</strong>upparsi <strong>il</strong><br />
promontorio sul 10°W.<br />
• 9 Il flusso assume temporaneamente curvatura anticiclonica<br />
sul Mediterraneo centrale.<br />
• 10-12 Una massa d’aria di origine polare marittima inizia<br />
ascendere sull’Europa centrale, mentre tra <strong>il</strong> 35°e <strong>il</strong><br />
40°N scorre un flusso di aria delle medie latitudini; <strong>il</strong><br />
flusso di aria polare evolve in un cut off sull’Europa centrale<br />
ed entra nel Mediterraneo.<br />
• 13-16 Il cut off scorre verso i Balcani, mentre un asse secondario<br />
si approfondisce sulla Spagna innescando un<br />
flusso di correnti occidentali barocline sul Mediterraneo<br />
centrale.<br />
• 17-24 Il flusso sul Mediterraneo assume una direttrice<br />
dapprima sud-occidentale e poi occidentale, favorendo <strong>il</strong><br />
passaggio di frequenti transienti.
Figura 6. Densità di scariche elettriche.<br />
• 25-28 Ancora un flusso zonale baroclino sul Mediterraneo,<br />
con sv<strong>il</strong>uppo di un promontorio alla fine del mese.<br />
L’evento saliente del mese: la neve sulla città di Roma<br />
e sulle coste del medio Tirreno<br />
Il 12 febbraio la città di Roma <strong>è</strong> stata interessata da una<br />
relativamente intensa precipitazione nevosa. La neve sul<br />
versante tirrenico dell’Italia centrale non <strong>è</strong> molto frequente<br />
e ancor meno lo <strong>è</strong> sulla zona urbana della città,<br />
normalmente alcuni gradi centigradi più calda delle zone<br />
circostanti. Inoltre, la città di Roma <strong>è</strong> ben protetta dalla<br />
catena appenninica dai flussi freddi nord-orientali ed <strong>è</strong><br />
esposta all’aria più mite proveniente dal Tirreno. Per queste<br />
ragioni, la neve può cadere sulla città solo al verificarsi<br />
di condizioni particolari: aria fredda in ingresso da nord,<br />
aria più calda proveniente dal Tirreno centrale e <strong>il</strong> contemporaneo<br />
sv<strong>il</strong>uppo su quest’area di un minimo depressionario.<br />
Nella prima mattina del 12 febbraio, erano attese<br />
precipitazioni diffuse su tutta l’area. Le temperature al<br />
<strong>suo</strong>lo erano piuttosto alte, ma in quota, a 850 hPa, erano<br />
presenti temperature di -5°C circa. Subito dopo l’inizio<br />
delle precipitazioni, <strong>il</strong> calo termico generato dalle correnti<br />
discendenti delle precipitazioni ha consentito alla neve di<br />
arrivare al <strong>suo</strong>lo, <strong>come</strong> previsto, dapprima lungo la costa,<br />
poi sulle colline appena a sud della città e successivamente<br />
sulla parte più meridionale dell’area urbana. La precipitazione<br />
nevosa ha raggiunto le zone centrali e settentrionali<br />
della città soltanto più tardi, durante la seconda parte<br />
dell’evento.<br />
Quanto segue <strong>è</strong> una lista di misurazioni della tempera-<br />
<br />
tura gent<strong>il</strong>mente resa disponib<strong>il</strong>e<br />
dal Sig. Patrizio<br />
Rapesi (www.romameteo.it)<br />
raccolte da stazioni<br />
meteorologiche amatoriali<br />
sia professionali.<br />
Tra le 2.00 e le 4.00 si<br />
sono registrati i valori massimi<br />
della giornata e nessun<br />
fenomeno era in atto<br />
(tab 3). Questa invece la<br />
situazione alle 7.00: i valori<br />
più elevati si osservano<br />
in Centro e nelle zone settentrionali<br />
della città, più<br />
bassi a Sud e verso <strong>il</strong> litorale<br />
dove, tra l’altro, sono<br />
iniziate le prime precipitazioni<br />
(tab 4). Situazione<br />
alle 8.30 i fenomeni interessano l’intero territorio citta-<br />
Tab 3.<br />
Collegio Romano CAE +6.8°C<br />
Roma Macao +6.6°C<br />
Montelibretti +6.6°C<br />
Roma Sud (Ostiense km 11.7) +6.3°C<br />
Roma Eur (Tre Fontane) +6.1°C<br />
Roma Flaminio (Flaminia km 9.2) +6.1°C<br />
Castelgiub<strong>il</strong>eo +5.8°C<br />
Massimina +5.4°C<br />
Salone +5.3°C<br />
Tor Vergata +5.2°C<br />
Roma Monte Mario +4.9°C<br />
Formello +4.0°C<br />
Collegio Romano CAE +6.0°C<br />
Roma Macao +5.5°C<br />
Roma Flaminio (Flaminia km 9.2) +4.7°C (0,2 mm)<br />
Roma Monte Mario +4.1°C (0,2 mm)<br />
Castelgiub<strong>il</strong>eo +4.0°C<br />
Tor Vergata +4.0°C<br />
Roma Eur (Tre Fontane) +3.9°C (0,2 mm)<br />
Salone +3.5°C<br />
Roma Sud (Ostiense km 11.7) +3.4°C (0,4 mm)<br />
Montelibretti +3.7°C n.d.<br />
Formello +2.7°C<br />
Massimina +2.1°C (1,2 mm)<br />
Tab 4.
Massimina +0.4°C (4,0 mm)<br />
Roma Monte Mario +0.4°C (1,6 mm)<br />
Roma Sud (Ostiense km 11.7) +0.7°C (1,6 mm)<br />
Roma Eur (Tre Fontane) +0.8°C (2,6 mm)<br />
Formello +0.9°C (0,4 mm)<br />
Roma Flaminio (Flaminia km 9.2) +1.1°C (2,4 mm)<br />
Tor Vergata +1.2°C (1,6 mm)<br />
Roma Macao +1.5°C (2,8 mm)<br />
Collegio Romano CAE +1.9°C (3,0 mm)<br />
Salone +2.2°C (1,8 mm)<br />
Montelibretti +2.4°C n.d.<br />
Castelgiub<strong>il</strong>eo +2.9°C (1,2 mm)<br />
Tab 5.<br />
Formello -0.5°C(11:30)<br />
Salone -0.1°C(9:15)<br />
Roma Macao +0.0°C (11:00)<br />
Roma Flaminio (Flaminia km 9.2) +0.0°C (11:15)<br />
Roma Eur (Tre Fontane) +0.1°C (10:45)<br />
Roma Monte Mario +0.1°C (11:00)<br />
Massimina +0.2°C (10;45)<br />
Montelibretti +0.2°C (11:45)<br />
Tor Vergata +0.4°C (11:00)<br />
Roma Sud (Ostiense km 11.7) +0.7°C (dalle 8:00 alle 9:00)<br />
Collegio Romano CAE +0.9°C (11:00)<br />
Tab 6.<br />
dino e con essi <strong>è</strong> evidente un notevole calo termico<br />
(tab.5). Tra le 9.00 e le 10.00 si osserva (mediamente) una<br />
pausa dei fenomeni e un generale rialzo termico di circa<br />
1-2°C poi, <strong>il</strong> nuovo peggioramento che interessa l’intera<br />
città (tab. 5). Alle 12.00 l’evento, per gran parte dell’area<br />
urbana può considerarsi terminato.<br />
Verifiche del modello COSMO-ME relative al mese di<br />
Febbraio <strong>2010</strong><br />
Sommario del mese: l’analisi delle serie temporali dei<br />
dati osservati e previsti mostrano un andamento coerente<br />
del campo della pressione in tutta l’Italia. Tale congruenza<br />
<strong>è</strong> evidente anche analizzando <strong>il</strong> ciclo diurno del parametro.<br />
Il campo della temperatura, invece, evidenzia la<br />
previsione di temperature più alte rispetto a quelle osservate,<br />
soprattutto sull’Italia Settentrionale. Tale comportamento<br />
<strong>è</strong> confermato anche analizzando <strong>il</strong> ciclo diurno<br />
in cui si osservano temperature maggiori di quelle osservate<br />
dalle prime ore del mattino.<br />
Figura 7. San Pietro sotto la neve - Roma<br />
12/02/<strong>2010</strong>.<br />
Figura 8. Il Colosseo sotto la neve - Roma<br />
12/02/<strong>2010</strong>.<br />
Figura 9. Piazza Barberini sotto la neve - Roma<br />
12/02/<strong>2010</strong>.<br />
Figura 10. Piazzale dell’Obelisco all’EUR sotto<br />
la neve - Roma 12/02/<strong>2010</strong>.
I grafici delle anomalie di temperatura e precipitazioni<br />
sono costruiti confrontando le medie mens<strong>il</strong>i delle temperature<br />
giornaliere (massime o minime) e le precipitazioni<br />
cumulate mens<strong>il</strong>i con i valori del Climate Normals<br />
1961-90 (CliNo: valori medi costruiti sulle osservazioni dal<br />
1961 al 1990). La differenza tra <strong>il</strong> valore medio di febbraio<br />
<strong>2010</strong> e quello del CliNo viene divisa per la deviazione<br />
standard (nel caso delle temperature) o per lo scarto interquint<strong>il</strong>e<br />
Q4-Q1, pari a 71 mm in febbraio, (nel caso delle<br />
precipitazioni) dello stesso CliNo. Relativamente alle sole<br />
temperature, <strong>è</strong> possib<strong>il</strong>e quantificare in gradi centigradi<br />
l’entità dell’anomalia evidenziata dai grafici semplicemente<br />
moltiplicando <strong>il</strong> valore mostrato dalla barra delle in-<br />
Figura 11. Precipitazione Roma Fiumicino 12 febbraio <strong>2010</strong>.<br />
<br />
tensità per i rispettivi valori delle deviazioni standard. La<br />
deviazione standard, che rappresenta lo scostamento delle<br />
misure dal valore medio delle osservazioni (1961-1990), nel<br />
mese di febbraio risulta in Italia mediamente pari ad 1.8<br />
°C per le temperature massime e ad 1.7 °C per le minime.<br />
La mappa di densità relativa ai fulmini, invece, rappresenta<br />
<strong>il</strong> numero di scariche per ogni unità di superficie<br />
(quadrato di 10km x 10km).<br />
Per evidenziare i confronti specifici sulle singole stazioni<br />
si rimanda all’indirizzo internet:<br />
http://clima.meteoam.it/Clino61-90.php
Serie Temporale febbraio <strong>2010</strong> MSLP Ciclo Diurno febbraio <strong>2010</strong> MSLP<br />
Figura 12. Nord Italia.<br />
Figura 13. Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 14. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.<br />
Verifiche del modello COSMO−ME<br />
Figura 15. Nord Italia.<br />
Figura 16.Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 17. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.
Serie Temporale febbraio <strong>2010</strong> Temperatura 2M Ciclo Diurno febbraio <strong>2010</strong> MSLP<br />
Figura 18. Nord Italia.<br />
Figura 19. Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 20. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.<br />
Figura 21. Nord Italia.<br />
Figura 22.Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 23. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.
Temperature, precipitazioni, attività elettrica e commento sinottico<br />
del mese di marzo <strong>2010</strong> in Italia<br />
Figura 1. Geopotenziale e temperatura decadale<br />
media a 500-hPa. (2 a decade).<br />
Campi medi decadali in quota<br />
I campi decadali di geopotenziale e temperatura a 500<br />
hPa sono ottenuti mediando i campi di analisi dell’ECMWF<br />
su ciascuna delle successive tre decadi del mese di marzo<br />
<strong>2010</strong>, <strong>come</strong> rappresentato a esempio nella mappa che<br />
(fig.1). La prima decade del mese ha visto una massa<br />
d’aria polare continentale interessare l’Europa centrale<br />
con moto retrogrado sul Mediterraneo centrale fino alla<br />
fine della decade. Il flusso perturbato principale ha successivamente<br />
assunto una traiettoria più nord-occidentale,<br />
consentendo ad aria delle medie latitudini più temperata<br />
di fare <strong>il</strong> <strong>suo</strong> ingresso nel corso della seconda<br />
decade sull’Europa occidentale. Alla fine del mese, <strong>il</strong><br />
flusso ha assunto un elevato indice zonale, segnando l’inizio<br />
della transizione stagionale.<br />
Temperature, precipitazioni e attività elettrica in Italia<br />
Temperature massime. La mappa delle temperature massime<br />
medie per <strong>il</strong> mese di marzo mostra uno scenario<br />
piuttosto omogeneo con una preponderanza di anomalie<br />
negative sulle regioni settentrionali e una maggiore quantità<br />
di anomalie positive, con punte ben al di sopra della<br />
norma, sulle regioni meridionali. Complessivamente le<br />
anomalie relative sono risultate comprese nell’intervallo<br />
(-1.3, +1.8), in unità di deviazioni standard delle distribuzioni<br />
climatologiche (CliNo’61-90). Le anomalie relative<br />
Figura 2. Anomalie delle temperature massime.<br />
più basse, leggermente al di sotto della media del periodo,<br />
sono state registrate sulla Toscana settentrionale e sulla Liguria<br />
con punte fino a -1.3 unità, corrispondente a circa -<br />
2.5 °C. Sulle restanti regioni del Settentrione le anomalie<br />
sono risultate per lo più negative ma con valori che rientrano<br />
nella naturale variab<strong>il</strong>ità climatica del mese di<br />
marzo. Il riscaldamento maggiore, invece, <strong>è</strong> stato osservato<br />
sulle regioni prospicienti <strong>il</strong> Mar Tirreno meridionale<br />
con valori più alti lungo i settori costieri, in modo particolare<br />
sulle coste della Sic<strong>il</strong>ia nord-orientale e della Calabria<br />
meridionale dove sono stati raggiunti valori compresi<br />
tra +1.5 e +1.8 unità. Anomalie positive leggermente più<br />
basse, con valori compresi tra +0.5 e +1.0 unità, sono<br />
stati r<strong>il</strong>evati sulla Sardegna meridionale, Sic<strong>il</strong>ia meridionale,<br />
su una vasta area comprendente la Puglia settentrionale,<br />
<strong>il</strong> Molise e la Bas<strong>il</strong>icata. Anomalie dello stesso ordine<br />
di grandezza sono state registrate anche su un’area<br />
limitata del Lazio centrale, tra Roma e Viterbo. Sulle restanti<br />
zone la temperatura media mens<strong>il</strong>e si <strong>è</strong> mantenuta<br />
vicino alla media del periodo. La prima decade del mese<br />
<strong>è</strong> stata caratterizzata da un ulteriore e marcato calo delle<br />
temperature che ha determinato valori di temperatura<br />
massima mediamente tra +5 °C e +10 °C su gran parte<br />
delle regioni settentrionali (eccetto che sulla fascia alpina),<br />
delle regioni centrali adriatiche e sull’Appennino<br />
meridionale. Sulle regioni centrali tirreniche, sulle regioni<br />
meridionali (eccetto che sulla fascia appenninica), sulla<br />
Sardegna e sulla Sic<strong>il</strong>ia occidentale i valori massimi sono<br />
stati mediamente compresi tra +10°C e +15°C mentre
Figura 3. Anomalie delle temperature minime.<br />
sulla Sic<strong>il</strong>ia orientale e sulla Calabria meridionale hanno<br />
raggiunto circa +10-20°C. A partire dall’inizio della seconda<br />
decade un generale riscaldamento ha portato le<br />
temperature a circa +10-15°C al Nord e lungo la dorsale<br />
appenninica, +15/20°C sulle regioni centro-meridionali<br />
raggiungendo +20/25°C sulla Sardegna occidentale e sulla<br />
Sic<strong>il</strong>ia orientale. L’aumento delle temperature massime <strong>è</strong><br />
continuato anche nelle terza decade con valori di circa<br />
+15/20°C su gran parte del territorio nazionale e di circa<br />
+20/25°C sulla Sardegna, sulla Sic<strong>il</strong>ia e sulle regioni meridionali<br />
tirreniche. Non sono stati registrati record storici<br />
di temperatura massima nel corso del mese.<br />
Temperature minime. Le anomalie relative delle temperature<br />
minime del mese di marzo sono risultate, leggermente<br />
al di sopra della naturale variab<strong>il</strong>ità del periodo,<br />
con valori nell’intervallo (-1.5, +2.0) in unità di<br />
deviazioni standard delle distribuzioni climatologiche<br />
(CliNo’61-90). Le anomalie sono state per lo più negative<br />
sulle regioni settentrionali, con valori vicini allo zero o leggermente<br />
negativi, ad eccezione di alcune aree limitate<br />
della Pianura Padana dove sono state registrate anomalie<br />
positive con valori compresi tra +0.5 e +1.0 unità. Sulle regioni<br />
centrali e sulla Sardegna lo scenario <strong>è</strong> alquanto eterogeneo<br />
con valori per lo più compresi tra -0.5 e +0.5 unità<br />
salvo che sulla Sardegna meridionale e su un’area limitata<br />
nel Lazio, tra Roma e Viterbo, dove si sono avuti valori<br />
compresi tra +0.8 e +1.5 unità. Sulle regioni meridionali vi<br />
<strong>è</strong> stata una prevalenza di anomalie positive salvo che su alcune<br />
aree del settore adriatico della Puglia, sul Salento e<br />
sulle coste della Calabria meridionale prospicienti <strong>il</strong> Mar Ionio,<br />
dove sono state osservate anomalie negative con<br />
punte fino a -1.6 unità sul Salento. Il riscaldamento maggiore<br />
<strong>è</strong> stato registrato sulla Sic<strong>il</strong>ia occidentale con punte<br />
fino a +2.0 unità. Anomalie più basse, con valori intorno a<br />
+1.0 unità, sono stati r<strong>il</strong>evati su aree estese della Bas<strong>il</strong>i-<br />
<br />
cata, del Molise, della Campania e della Calabria tirrenica.<br />
La marcata irruzione fredda nel corso della prima decade<br />
ha determinato le temperature minime più basse che<br />
hanno raggiunto, mediamente, -10/-5 °C sulla Lombardia<br />
e sulle regioni nord-orientali (con l’eccezione della fascia<br />
alpina, caratterizzata da valori ancora più bassi, fortemente<br />
dipendenti dalla quota) mentre sul resto del Paese<br />
sono state essenzialmente comprese tra -5/0 °C eccetto<br />
che sulle isole maggiori, lungo le coste tirreniche del centro-sud<br />
e lungo le coste adriatiche della Puglia dove sono<br />
stati registrati valori più elevati, compresi tra 0 °C e +10<br />
°C. Il riscaldamento, <strong>iniziato</strong> nel corso della seconda decade,<br />
ha determinato un iniziale e generale aumento di<br />
circa + 4/6 °C che si <strong>è</strong> protratto anche nell’ultima decade<br />
con un ulteriore incremento di +3/5 °C su tutta la penisola.<br />
Non sono stati registrati record storici di temperatura<br />
minima nel corso del mese.<br />
Precipitazioni<br />
La mappa delle anomalie delle precipitazioni cumulate<br />
nel corso del mese mostra una situazione deficitaria, leggermente<br />
al di sotto della norma climatica, su gran parte<br />
del territorio nazionale ad eccezione della Sic<strong>il</strong>ia meridionale<br />
e di alcune aree limitate della penisola. Le precipitazioni<br />
più consistenti hanno avuto luogo sulla Sic<strong>il</strong>ia meridionale<br />
con anomalie relative comprese tra +1.5 e +2.9<br />
unità dello scarto interquint<strong>il</strong>e delle distribuzioni climatologiche<br />
(per una stima più quantitativa, si tenga conto<br />
del fatto che <strong>il</strong> valore di tale scarto, mediato su tutte le<br />
stazioni per <strong>il</strong> mese di marzo, <strong>è</strong> di circa 65 mm). Anomalie<br />
positive di minore entità sono state registrate nella<br />
zona di Taranto, con punte fino a +1.5 unità relative,<br />
lungo le coste della Romagna, con valori fino a +1.0 unità<br />
relative, e nelle aree interne del Molise circostanti la<br />
zona di Campobasso, con valori fino a +0.8 unità relative.<br />
Il deficit maggiore si <strong>è</strong> avuto sulle regioni nord-orientali,<br />
con anomalie comprese tra -1.1 e -0.6 unità relative. Anomalie<br />
negative dell’ordine comprese tra -0.8 unità sono<br />
state registrate sull’Appennino tosco-em<strong>il</strong>iano e sulle zone<br />
interne della Toscana settentrionale. Sul resto del territorio<br />
nazionale le precipitazioni sono risultate comprese tra<br />
-0.5 e +0.5 unità dello scarto interquint<strong>il</strong>e, sebbene vi sia<br />
una prevalenza di anomalie negative rispetto a quelle positive.<br />
Le precipitazioni sono occorse principalmente durante<br />
la prima parte del mese, con una maggiore concentrazione<br />
durante la seconda settimana, interessando<br />
principalmente le regioni centro-meridionali e risultando<br />
abbastanza scarse sulle regioni settentrionali. In partico-
Figura 4. Precipitazioni cumulate. Figura 5. Manto nevoso.<br />
lare, specie durante la seconda settimana, su gran parte<br />
della Sic<strong>il</strong>ia, lungo le coste della Romagna, nell’area di Taranto<br />
e del Salento, in Puglia, sono caduti tra 100 e 200<br />
mm di pioggia. Nello stesso periodo temporale sulle restanti<br />
zone del centro-sud si sono avuti valori cumulati<br />
compresi tra 25 e 100 mm ad eccezione dell’Abruzzo,<br />
della Sardegna meridionale e del Gargano dove i quantitativi<br />
non hanno superato i 25 mm. Al Nord le precipitazioni<br />
cumulate non hanno superato 10 mm ad eccezione<br />
della Romagna e del Veneto meridionale ove sono risultate<br />
comprese tra 10 e 25 mm. Nella seconda parte del mese<br />
le piogge sono state poco frequenti su tutto <strong>il</strong> territorio nazionale<br />
con quantitativi alquanto modesti, infatti i valori<br />
cumulati tra 10 mm e 25 mm sono stati registrati su gran<br />
parte delle regioni settentrionali ad eccezione della Romagna,<br />
lungo le coste marchigiane, nel Molise e sulle<br />
estremità occidentale e meridionale della Sic<strong>il</strong>ia mentre<br />
sul resto del Paese sono risultate inferiori a 10 mm o del<br />
tutto assenti.<br />
Sono da segnalare alcuni record storici sulle precipitazioni<br />
(fra parentesi si indica l’anno in cui si <strong>è</strong> verificato <strong>il</strong><br />
precedente estremo negli ultimi 59 anni e l’incremento relativo<br />
in mm. Tab. 1):<br />
Neve sulle Alpi<br />
La mappa della neve, ovvero dell’altezza media del manto<br />
Cozzo Spadaro (SR) (51 m. s.l.m.) mens<strong>il</strong>e:<br />
129.7.0 mm (2007, +121.4)<br />
Messina (ME) (54 m. s.l.m.) giornaliero: 68.20<br />
mm (1960, +61.2),<br />
Ponza (Isola di) (LT) (185 m. s.l.m.) giornaliero:<br />
48.2 mm (1964, +44.0).<br />
Tab.1.<br />
nevoso sulle Alpi per <strong>il</strong> mese di marzo, <strong>è</strong> stata realizzata<br />
a partire dalle r<strong>il</strong>evazioni (orarie) effettuate da 42 stazioni<br />
della Rete Meteomont dislocate sulle Alpi. Il sistema di monitoraggio<br />
del Servizio Meteomont del Comando Truppe Alpine<br />
ha <strong>come</strong> compito quello di acquisire i parametri meteo-nivologici,<br />
finalizzati soprattutto alla continua<br />
valutazione e determinazione del rischio valanghe.<br />
La mappa indica uno spessore medio del manto nevoso,<br />
sulle zone monitorate, abbastanza irregolare che assume<br />
valori da un minimo di circa 0.4 mt (in corrispondenza<br />
delle stazioni di r<strong>il</strong>evamento situate a quote più basse) fino<br />
ad un massimo di circa 2.4 mt. sulle Alpi Retiche e Tirolesi<br />
e di circa 1.5 mt sulle Alpi Marittime, Cozie e Giulie.<br />
Scariche elettriche<br />
La mappa di densità delle scariche elettriche mostra una<br />
fenomenologia alquanto modesta sul territorio nazionale<br />
e sui mari circostanti. L’attività elettrica <strong>è</strong> occorsa principalmente<br />
nel corso dell’ultima decade interessando per<br />
lo più la Liguria, l’Appennino Tosco - em<strong>il</strong>iano, la Pianura<br />
Padano-Veneta e l’Alto Adriatico. I fenomeni più consistenti<br />
si sono verificati sull’Appennino e lungo le coste<br />
della Liguria.<br />
Evoluzione sinottica<br />
• 1-2 Lo scenario euro-atlantico si presenta con un flusso<br />
perturbato principale basso di latitudine; sul Mediterraneo<br />
le correnti sono da W/SW moderatamente barocline.<br />
• 3 Sull’area mediterranea si sv<strong>il</strong>uppa un promontorio interciclonico.<br />
• 4-5 Lo sv<strong>il</strong>uppo di un promontorio in Atlantico favorisce<br />
la discesa di aria polare sull’Europa centrale.<br />
• 6-7 La massa d’aria diviene di origine polare continentale<br />
per effetto del t<strong>il</strong>ting del promontorio sulla Scandi-
Figura 6. Densità di scariche elettriche.<br />
navia.<br />
• 8-11 Cut-off retrogrado dapprima sulla Francia e poi su<br />
Spagna, Mediterraneo centrale e Italia.<br />
• 12-15 Il flusso perturbato principale assume una direttrice<br />
più nord-occidentale sull’Europa, così <strong>come</strong> sul Mediterraneo.<br />
• 16-21 Sul Mediterraneo <strong>il</strong> flusso <strong>è</strong> zonale, lievemente anticiclonico<br />
e moderatamente baroclino.<br />
• 22-24 Una saccatura atlantica attraversa <strong>il</strong> Mediterraneo.<br />
• 25-26 L’approfondimento di una depressione sul vicino<br />
Atlantico innesca un flusso sud-occidentale stab<strong>il</strong>e sul<br />
Mediterraneo.<br />
• 27-28 La depressione entra nel Mediterraneo; l’asse di<br />
saccatura associato attraversa rapidamente l’Italia.<br />
• 29 Un altro promontorio interciclonico sul Mediterraneo<br />
centrale.<br />
• 30-31 Una saccatura atlantica entra sul Mediterraneo occidentale.<br />
Un evento saliente del mese: la neve al Nord e le piogge<br />
torrenziali sulle coste ioniche e sulla Sic<strong>il</strong>ia meridionale<br />
Figura 8. Andamento dell’indice AO – (NOAA-CPC).<br />
<br />
Nei tre giorni tra <strong>il</strong> 9 e l’11 marzo, tutta la penisola <strong>è</strong><br />
stata interessata da una fase di forte maltempo, coincisa<br />
con un nuovo repentino abbassamento delle temperature.<br />
L’evento <strong>è</strong> culminato in intense precipitazioni nevose sulla<br />
gran parte delle regioni settentrionali e in piogge a carattere<br />
torrenziale su Sic<strong>il</strong>ia, Calabria e Puglia. Dal punto di<br />
vista sinottico l’evento ha confermato una tendenza riscontratasi<br />
per buona parte della stagione invernale, ovvero<br />
<strong>il</strong> contributo di masse d’aria di origine polare in contrasto<br />
con una posizione piuttosto bassa di latitudine della<br />
storm-track atlantica. La stagione invernale ha visto la persistenza<br />
di valori dell’indice di Osc<strong>il</strong>lazione Artica in territorio<br />
negativo, fattore questo che favorisce lo sv<strong>il</strong>uppo di<br />
circolazioni meridiane. Al contempo, anche la NAO (North<br />
Figura 7. Analisi del 10 marzo, ore 00:00 UTC. In evidenza<br />
<strong>il</strong> minimo depressionario sul Tirreno.<br />
Atlantic Osc<strong>il</strong>lation) ha assunto valori in prevalenza negativi,<br />
permettendo alle perturbazioni atlantiche di <strong>scorrere</strong><br />
verso <strong>il</strong> Mediterraneo piuttosto che dirigersi verso <strong>il</strong> nord<br />
Europa. L’evento della prima decade di marzo ha confermato<br />
questa tendenza. L’aria di origine polare continentale<br />
scesa sul Mediterraneo in seguito al cut-off del minimo<br />
ha ricevuto un contributo di umidità dal flusso zonale. Le<br />
precipitazioni nevose sul nord Italia sono state associate all’occlusione<br />
del sistema frontale, mentre le piogge torrenziali<br />
sul meridione ionico e sulla Sic<strong>il</strong>ia meridionale sono<br />
state innescate da linee di convergenza nei bassi strati, cui<br />
si <strong>è</strong> associato lo sv<strong>il</strong>uppo di sistemi convettivi a mesoscala<br />
sui suddetti settori.<br />
Verifiche del modello COSMO-ME relative al mese di<br />
marzo <strong>2010</strong><br />
Sommario del mese: l’analisi delle serie temporali, mo-
Figura 9. Andamento dell’indice NAO – (NOAA-CPC).<br />
stra un andamento coerente del campo della pressione in<br />
tutta l’Italia. Confrontando però <strong>il</strong> ciclo diurno sembra evidente<br />
uno sfasamento di circa tre ore tra i dati osservati<br />
e previsti. Il campo della temperatura evidenzia soprattutto<br />
nell’Italia settentrionale, l’osservazione di temperature<br />
più alte rispetto a quelle previste. Anche <strong>il</strong> ciclo<br />
diurno mostra questo comportamento per <strong>il</strong> Nord Italia.<br />
mentre per le altre stratificazioni l’andamento dei dati osservati<br />
e previsti <strong>è</strong> più sim<strong>il</strong>e.<br />
I grafici delle anomalie di temperatura e precipitazioni<br />
sono costruiti confrontando le medie mens<strong>il</strong>i delle temperature<br />
giornaliere (massime o minime) e le precipitazioni<br />
cumulate mens<strong>il</strong>i con i valori del Climate Normals<br />
1961-90 (CliNo: valori medi costruiti sulle osservazioni dal<br />
1961 al 1990). La differenza tra <strong>il</strong> valore medio di Marzo<br />
<strong>2010</strong> e quello del CliNo viene divisa per la deviazione<br />
standard (nel caso delle temperature) o per lo scarto interquint<strong>il</strong>e<br />
Q4-Q1, pari a 65 mm in Marzo, (nel caso delle<br />
precipitazioni) dello stesso CliNo. Relativamente alle sole<br />
temperature, <strong>è</strong> possib<strong>il</strong>e quantificare in gradi centigradi<br />
l’entità dell’anomalia evidenziata dai grafici semplicemente<br />
moltiplicando <strong>il</strong> valore mostrato dalla barra delle intensità<br />
per i rispettivi valori delle deviazioni standard. La<br />
deviazione standard, che rappresenta lo scostamento delle<br />
misure dal valore medio delle osservazioni (1961-1990), nel<br />
mese di Marzo risulta in Italia mediamente pari ad 1.8 °C<br />
per le temperature massime e ad 1.5 °C per le minime. La<br />
mappa di densità relativa ai fulmini, invece, rappresenta<br />
<strong>il</strong> numero di scariche per ogni unità di superficie (quadrato<br />
di 10Km x10Km).<br />
Per evidenziare i confronti specifici sulle singole stazioni<br />
si rimanda al sito:<br />
http://clima.meteoam.it/Clino61-90.php
Serie Temporale marzo <strong>2010</strong> MSLP Ciclo Diurno marzo <strong>2010</strong> MSLP<br />
Figura 10. Nord Italia.<br />
Figura 11. Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 12. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.<br />
Verifiche del modello COSMO−ME<br />
Figura 13. Nord Italia.<br />
Figura 14. Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 15. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.
Serie Temporale marzo <strong>2010</strong> Temperatura 2M<br />
Figura 16. Nord Italia.<br />
Figura 17. Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 18. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.<br />
Ciclo Diurno marzo <strong>2010</strong> Temperatura 2M<br />
Figura 19. Nord Italia.<br />
Figura 20. Centro Italia e Sardegna.<br />
Figura 21. Sud Italia e Sic<strong>il</strong>ia.
guida per gli autori<br />
La Rivista di Meteorologia Aeronautica pubblica trimestralmente articoli di meteorologia e climatologia con<br />
riguardo alle applicazioni in campo aeronautico. La collaborazione <strong>è</strong> aperta a tutti gli studiosi italiani e stranieri.<br />
Si accettano articoli redatti in lingua italiana e, occasionalmente, in lingua inglese. I lavori devono essere originali<br />
e inediti. Gli Autori sono responsab<strong>il</strong>i del contenuto degli scritti e delle <strong>il</strong>lustrazioni pubblicate. I pareri e le<br />
opinioni espresse nei lavori pubblicati rappresentano l’esclusivo pensiero dei loro Autori. I lavori sono pubblicati<br />
ad insindacab<strong>il</strong>e giudizio del Comitato di Redazione. I lavori proposti, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.<br />
Nella redazione degli elaborati, gli Autori sono invitati a seguire le indicazioni sotto riportate.<br />
I lavori proposti alla Redazione (testo e immagini) devono essere inviati su supporto informatico [un singolo f<strong>il</strong>e<br />
per <strong>il</strong> testo e un singolo f<strong>il</strong>e (almeno 300 dpi) per ogni immagine] e devono essere redatti con i più comuni software<br />
attualmente in uso. E’ necessario inviare anche due copie su carta (formato A4) dell’elaborato. L’elaborato<br />
deve essere redatto in forma chiara e concisa e non superare sedici pagine di stampa della Rivista (circa trenta<br />
cartelle A4). Ogni copia deve riportare la data e la firma autografa dell’Autore (o degli Autori). Occasionalmente<br />
possono essere accettati lavori manoscritti, per cui valgono le regole di cui sopra. La redazione potrà stab<strong>il</strong>ire di<br />
scindere uno stesso lavoro in due parti, pubblicandolo su fascicoli consecutivi.<br />
Il titolo dell’articolo deve essere breve, possib<strong>il</strong>mente contenuto in una sola riga. Se ritenuto ut<strong>il</strong>e sarà possib<strong>il</strong>e<br />
ut<strong>il</strong>izzare un sottotitolo. Il nome dell’Autore (o degli Autori) deve essere riportato sulla riga successiva (nome<br />
e cognome devono essere riportati per esteso e senza abbreviazioni) eventualmente preceduto dal grado m<strong>il</strong>itare.<br />
Per esigenze editoriali <strong>il</strong> titolo potrà essere modificato.<br />
Il testo del lavoro deve essere preceduto da un breve ed esauriente riassunto (massimo 300 parole) redatto sia<br />
in lingua italiana sia in lingua inglese (summary).<br />
Le <strong>il</strong>lustrazioni, tabelle o figure, devono essere numerate e riportare un titolo o una breve didascalia. A discrezione<br />
dell’Autore, sulle copie cartacee, esse possono già risultare contenute nel testo o essere allegate a parte,<br />
fermo restando che, per motivi tipografici, la Redazione si riserva di spostare, ingrandire, ridurre etc. ogni singola<br />
<strong>il</strong>lustrazione, al fine di conseguire una armonica impaginazione del periodico.<br />
Le formule matematiche, ridotte al minimo indispensab<strong>il</strong>e, devono essere scritte chiaramente e con ampio spazio<br />
intorno. I simboli devono risultare fac<strong>il</strong>mente identificab<strong>il</strong>i. Una distinzione dovrà essere fatta tra lettere greche<br />
e simboli inusuali, tra lettere maiuscole e minuscole, tra la lettera o e lo zero, tra la lettera i <strong>il</strong> numero 1 o<br />
<strong>il</strong> numero primo (1°). I simboli e le unità non devono mai essere seguiti dal punto di abbreviazione.<br />
Le unità di misura devono essere espresse secondo <strong>il</strong> Sistema Internazionale di Misura (SI).<br />
La bibliografia posta alla fine dell’articolo <strong>è</strong> ordinata alfabeticamente nella forma standard. Nell’articolo, i riferimenti<br />
alla bibliografia devono essere fatti mediante <strong>il</strong> cognome del primo degli autori in parentesi.<br />
Il lavoro deve concludersi con l’indicazione dell’Ente di appartenenza e di un recapito dell’Autore (e-ma<strong>il</strong>, telefono,<br />
fax) per favorire <strong>il</strong> contatto con i lettori interessati.<br />
Gli Autori correderanno i lavori presentati con una breve scheda biografica contenente, tra l’altro, l’esatto recapito<br />
postale al quale la Redazione curerà di inoltrare copia della Rivista.