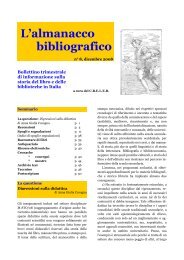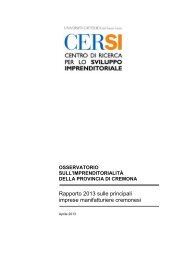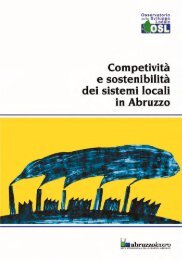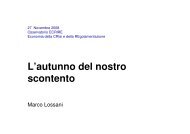La valigia in viaggio: biografia culturale di un oggetto 'quasi ...
La valigia in viaggio: biografia culturale di un oggetto 'quasi ...
La valigia in viaggio: biografia culturale di un oggetto 'quasi ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> <strong>valigia</strong> <strong>in</strong> <strong>viaggio</strong>: <strong>biografia</strong> <strong>culturale</strong> <strong>di</strong> <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> <strong>'quasi</strong>' quoti<strong>di</strong>ano 1<br />
<strong>di</strong> Lucia Ruggerone<br />
1. Una premessa teorica<br />
L'<strong>in</strong>teresse per i significati sociali degli oggetti materiali e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> per il ruolo che essi svolgono<br />
nella vita quoti<strong>di</strong>ana degli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui è <strong>un</strong>a caratteristica recente della sociologia della cultura. Per<br />
anni <strong>in</strong>fatti lo stu<strong>di</strong>o sociologico della cultura sia <strong>in</strong> Europa sia <strong>in</strong> America si è sviluppato sulla base<br />
<strong>di</strong> <strong>un</strong>a vaga def<strong>in</strong>izione antropologica secondo cui il term<strong>in</strong>e "cultura" <strong>in</strong><strong>di</strong>ca <strong>in</strong> genere tutto<br />
l'<strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> valori, norme, credenze, abitud<strong>in</strong>i, stili <strong>di</strong> vita e pr<strong>in</strong>cipi <strong>di</strong> convivenza che<br />
caratterizzano (e sono espressione de) i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> strutture sociali. Naturalmente<br />
all'affermazione <strong>di</strong> tale def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> cultura ha contribuito il successo <strong>di</strong> quelle tra<strong>di</strong>zioni<br />
sociologiche, come il f<strong>un</strong>zionalismo e il marxismo, che <strong>di</strong> fatto <strong>in</strong>terpretano la cultura come «il<br />
parente povero della struttura» (Archer 1988:1) e che pertanto trascurano <strong>di</strong> porre l'accento<br />
sull'importanza del significato quale elemento <strong>di</strong>st<strong>in</strong>tivo <strong>di</strong> qualsiasi espressione <strong>culturale</strong>.<br />
Naturalmente questa tendenza non si trova <strong>di</strong>ffusa <strong>un</strong>iformemente <strong>in</strong> tutti gli autori classici; per<br />
esempio, Weber, <strong>in</strong>troducendo <strong>in</strong> Economia e società (1968, 1974) la sua tipologia dell'azione<br />
sociale, assegna centralità al significato restituendo agli attori sociali la facoltà <strong>di</strong> attribuire senso<br />
alle proprie azioni. Qualche anno più tar<strong>di</strong>, sempre <strong>in</strong> ambito tedesco, Simmel <strong>in</strong>terpreta il<br />
mutamento nello stile <strong>di</strong> vita caratteristico della modernità alla luce del cambiamento dei mo<strong>di</strong> <strong>in</strong><br />
cui gli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui si appropriano della cultura materiale, e nello stesso tempo sottol<strong>in</strong>ea l'importanza<br />
degli oggetti nella def<strong>in</strong>izione delle relazioni sociali moderne 2 . Contemporaneamente, al <strong>di</strong> là<br />
dell'oceano, Veblen (1948) elabora la teoria del consumo vistoso, anticipando per certi versi le<br />
riflessioni <strong>di</strong> Bour<strong>di</strong>eu (1984) sul capitale <strong>culturale</strong>, mentre, a Chicago (con G.H.Mead 1966) e poi<br />
a Berkley (con Blumer 1969) gli <strong>in</strong>terazionisti simbolici aprono la strada ad <strong>un</strong>a composita corrente<br />
<strong>di</strong> sociologie anti-f<strong>un</strong>zionaliste che negli anni Sessanta e Settanta porranno le basi per <strong>un</strong>a ra<strong>di</strong>cale<br />
riconsiderazione del concetto <strong>di</strong> cultura. In questo quadro risultano particolarmente significativi i<br />
contributi provenienti dalle sociologie <strong>di</strong> ispirazione fenomenologica (Schutz, Goffman, Berger e<br />
Luckmann e gli etnometodologi) che, <strong>in</strong>terpretando la realtà sociale come il risultato delle<br />
attribuzioni <strong>di</strong> senso negoziate nelle <strong>in</strong>terazioni tra soggetti, chiudono def<strong>in</strong>itivamente quel gap tra<br />
struttura e cultura che per anni aveva relegato la sociologia della cultura ai marg<strong>in</strong>i della <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a.<br />
Senza la pretesa <strong>di</strong> <strong>di</strong>l<strong>un</strong>garsi <strong>in</strong> questa sede <strong>in</strong> <strong>un</strong>'analisi più dettagliata <strong>di</strong> queste correnti <strong>di</strong><br />
pensiero, è opport<strong>un</strong>o sottol<strong>in</strong>eare come tutte queste prospettive teoriche abbiano imposto alla teoria<br />
sociologica <strong>un</strong>a riconsiderazione della def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> cultura e del suo impatto sociale, e abbiano<br />
portato <strong>in</strong> primo piano la necessità <strong>di</strong> elaborare approcci <strong>in</strong>novativi per lo stu<strong>di</strong>o degli aspetti<br />
culturali del vivere, ormai <strong>di</strong>fficilmente <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guibili da quelli meramente 'sociali'.<br />
Tuttavia, il genere <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o che più ci riguarda <strong>in</strong> questo contesto, cioè l'estendersi dell'<strong>in</strong>teresse<br />
sociologico alla considerazione dei significati sociali <strong>in</strong>corporati negli oggetti materiali, non si apre<br />
1 Questo articolo prende sp<strong>un</strong>to da <strong>un</strong> lavoro <strong>di</strong> ricerca condotto da <strong>un</strong> équipe <strong>di</strong> tre ricercatori del Centro per lo stu<strong>di</strong>o<br />
della moda e della produzione <strong>culturale</strong> dell'Università Cattolica del Sacro Cuore <strong>di</strong> Milano e cof<strong>in</strong>anziato dai fon<strong>di</strong><br />
MURST negli anni 1998-2000. Il programma <strong>di</strong> cof<strong>in</strong>anziamento del MURST, <strong>in</strong>augurato nel 1997, f<strong>in</strong>anzia progetti <strong>di</strong><br />
ricerca <strong>in</strong>ter<strong>un</strong>iversitari a cui partecipano <strong>di</strong>versi atenei (le <strong>un</strong>ità locali) coord<strong>in</strong>ate da <strong>un</strong>a delle <strong>un</strong>ità che f<strong>un</strong>ge anche da<br />
responsabile nazionale. In questo caso il progetto locale e quello nazionale (<strong>in</strong>titolati rispettivamente "<strong>La</strong> moda tra<br />
produzione e consumo. Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> tre casi esemplari" e "Le <strong>in</strong>dustrie culturali tra produzione e consumo") sono stati<br />
entrambi coord<strong>in</strong>ati da <strong>La</strong>ura Bovone che ricopriva il ruolo <strong>di</strong> responsabile locale e nazionale. <strong>La</strong> ricerca qui descritta,<br />
svolta da me e da altri due ricercatori, ha stu<strong>di</strong>ato la <strong>biografia</strong> <strong>culturale</strong> <strong>di</strong> tre oggetti scelti tra i prodotti del settore<br />
dell'abbigliamento e degli accessori, ovvero ha seguito il percorso <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> dal momento della sua<br />
progettazione f<strong>in</strong>o al momento del consumo f<strong>in</strong>ale, attraverso <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> <strong>in</strong>terviste motivazionali realizzate con i<br />
soggetti considerati rilevanti: le <strong>di</strong>verse figure professionali venute a contatto con il prodotto e <strong>un</strong> numero limitato <strong>di</strong><br />
consumatori reperiti a volte dal database dell'azienda, <strong>in</strong> altri casi <strong>di</strong>rettamente contattati dal ricercatore nei p<strong>un</strong>tiven<strong>di</strong>ta.<br />
In particolare, questo articolo descrive la <strong>biografia</strong> <strong>culturale</strong> <strong>di</strong> <strong>un</strong>o <strong>di</strong> questi oggetti: <strong>un</strong> modello <strong>di</strong> <strong>valigia</strong><br />
rigida denom<strong>in</strong>ato Oyster (<strong>in</strong> italiano "conchiglia") prodotto da <strong>un</strong>'azienda mult<strong>in</strong>azionale, la Samsonite.<br />
2 Per approfon<strong>di</strong>menti si veda Simmel (1984 e 1985) e Dant (1999).<br />
1
automaticamente con l'affermarsi <strong>di</strong> queste nuove prospettive, ma prende piede <strong>in</strong> <strong>un</strong> tempo ancora<br />
più recente (soprattutto negli ultimi <strong>di</strong>eci anni <strong>in</strong> alc<strong>un</strong>i Paesi europei, mentre solo attualmente sta<br />
facendo la sua comparsa <strong>in</strong> Italia) anche per effetto <strong>di</strong> contributi provenienti da altre <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>e. In<br />
particolare l'antropologia, la semiotica e i cultural stu<strong>di</strong>es <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e britannica hanno fortemente<br />
<strong>in</strong>fluenzato lo sviluppo degli stu<strong>di</strong> sulla cultura materiale, che <strong>in</strong>fatti danno vita ad <strong>un</strong> genere<br />
<strong>di</strong>fficilmente <strong>in</strong>seribile <strong>in</strong> <strong>un</strong> <strong>un</strong>ico settore <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>are, ma piuttosto per eccellenza trasversale a<br />
tutte queste <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>e 3 .<br />
Tra i sociologi contemporanei, due stu<strong>di</strong>ose americane, Diana Crane e Wendy Griswold, sono<br />
recentemente <strong>in</strong>tervenute nel <strong>di</strong>battito <strong>in</strong> merito alla def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> material culture e<br />
all'<strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione degli oggetti da considerare app<strong>un</strong>to 'culturali'. <strong>La</strong> def<strong>in</strong>izione proposta da Crane<br />
(1994) tende a porre l'accento, più che sulla cultura materiale, su ciò che può essere considerato <strong>un</strong><br />
particolare sotto-sistema <strong>di</strong> questa: la «recorded culture», cioè la «cultura registrata»,<br />
<strong>un</strong>'espressione con cui Crane si riferisce all'<strong>in</strong>sieme dei vari significati culturali veicolati attraverso<br />
l'utilizzo <strong>di</strong> supporti dotati <strong>di</strong> fisicità; per esempio i <strong>di</strong>schi, i cd, la carta stampata, ma anche, da <strong>un</strong><br />
p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista più ampio, le opere d'arte 4 . <strong>La</strong> def<strong>in</strong>izione data da Griswold (1997:26) è più estesa e<br />
arriva ad <strong>in</strong>cludere sotto l'etichetta <strong>di</strong> '<strong>oggetto</strong> <strong>culturale</strong>' qualsiasi 'cosa' <strong>in</strong> cui siano <strong>in</strong>corporati dei<br />
significati sociali con<strong>di</strong>visi. Se si adotta quest'ultima def<strong>in</strong>izione si possono allora considerare<br />
culturali non soltanto gli oggetti che si presentano come veicolo o supporto per il passaggio <strong>di</strong><br />
contenuti che hanno a che fare con attività ritenute tra<strong>di</strong>zionalmente culturali, ma anche altri oggetti<br />
<strong>in</strong>seriti <strong>in</strong> pratiche più quoti<strong>di</strong>ane, ma ugualmente capaci <strong>di</strong> farsi portatori, a livello connotativo 5 , <strong>di</strong><br />
valenze simboliche socialmente significative; <strong>in</strong> <strong>un</strong>a parola tutti gli oggetti capaci <strong>di</strong> 'com<strong>un</strong>icare'<br />
qualcosa all'<strong>in</strong>terno perlomeno <strong>di</strong> determ<strong>in</strong>ate com<strong>un</strong>ità sociali.<br />
Questa concezione si rifà ad <strong>un</strong> concetto antropologico <strong>di</strong> cultura più <strong>in</strong>novativo rispetto a quello<br />
riferito più sopra, che si riallaccia alla def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> Geertz secondo cui la cultura è «<strong>un</strong>a struttura<br />
<strong>di</strong> significati trasmessa storicamente, <strong>in</strong>carnati <strong>in</strong> simboli, <strong>un</strong> sistema <strong>di</strong> concezioni ere<strong>di</strong>tate<br />
espresse <strong>in</strong> forme simboliche per mezzo <strong>di</strong> cui gli uom<strong>in</strong>i com<strong>un</strong>icano, perpetuano e sviluppano la<br />
loro conoscenza e i loro atteggiamenti verso la vita» (1997: 141). In base a questa def<strong>in</strong>izione il<br />
term<strong>in</strong>e "cultura" <strong>in</strong>tende fare riferimento non soltanto alle manifestazioni <strong>di</strong> cultura alta, dotate <strong>di</strong><br />
elevato contenuto creativo ed estetico e prodotte da <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui o gruppi 'speciali' operanti <strong>in</strong> sfere<br />
separate dalla quoti<strong>di</strong>anità, ma a tutte le forme implicite ed esplicite, materiali ed immateriali, entro<br />
cui si possono leggere dei significati ulteriori rispetto al mero livello denotativo. Gli oggetti presi <strong>in</strong><br />
considerazione nello stu<strong>di</strong>o della cultura materiale sono pertanto tutti quegli oggetti <strong>di</strong> uso com<strong>un</strong>e,<br />
che partecipano della vita quoti<strong>di</strong>ana <strong>di</strong> gran parte delle persone, assumendo per queste ultime non<br />
solo <strong>un</strong> significato f<strong>un</strong>zionale, ma anche <strong>un</strong> significato simbolico con<strong>di</strong>viso.<br />
2. Come si può stu<strong>di</strong>are la cultura materiale<br />
<strong>La</strong> <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>a dell'antropologia ha senza dubbio giocato <strong>un</strong> ruolo determ<strong>in</strong>ante nella <strong>di</strong>ffusione<br />
anche <strong>in</strong> campo sociologico dell'<strong>in</strong>teresse per la cultura materiale. A <strong>di</strong>fferenza dei sociologi, <strong>in</strong>fatti,<br />
gli antropologi hanno da tempo <strong>in</strong>tuito l'importanza degli oggetti <strong>di</strong> uso com<strong>un</strong>e per<br />
l'<strong>in</strong>terpretazione della cultura e dello stile <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> <strong>un</strong>a società. Tra<strong>di</strong>zionalmente però anche gli<br />
antropologi tendevano a limitare questo approccio allo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> società antiche oppure molto<br />
<strong>di</strong>stanti dalla nostra, senza pensare che questa stessa l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong> <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e poteva essere applicata<br />
utilmente anche alle società moderne. È soltanto nella seconda metà del XX secolo, quando cioè<br />
3<br />
Per <strong>un</strong>a sia pur s<strong>in</strong>tetica considerazione nel merito dei contributi apportati dalle s<strong>in</strong>gole <strong>di</strong>scipl<strong>in</strong>e si veda Sempr<strong>in</strong>i<br />
1999.<br />
4<br />
Sebbene questo elenco rispecchi la concezione <strong>di</strong> <strong>oggetto</strong> <strong>culturale</strong> adottata da Crane (1997), nell'antologia da lei<br />
curata nel 1994, viene proposta <strong>un</strong>a concezione più ampia che comprende nell'<strong>in</strong>sieme degli oggetti culturali anche gli<br />
strumenti usati dagli scienziati nello svolgimento del loro lavoro quoti<strong>di</strong>ano, nonché i prodotti dell'attività scientifica e<br />
tecnica. Su questo p<strong>un</strong>to si veda però pr<strong>in</strong>cipalmente <strong>La</strong>tour1996 e Mukerji 1994.<br />
5<br />
Per <strong>un</strong>a considerazione del significato connotativo contrapposto a quello denotativo degli oggetti culturali, si veda<br />
Barnard, 1996.<br />
2
l'antropologia com<strong>in</strong>cia ad <strong>in</strong>teressarsi delle pratiche <strong>di</strong> consumo contemporanee, che si com<strong>in</strong>cia a<br />
porre l'attenzione sul fatto che buona parte della vita sociale degli esseri umani, (i mo<strong>di</strong> <strong>in</strong> cui essi<br />
vengono <strong>in</strong> contatto e com<strong>un</strong>icano tra <strong>di</strong> loro) passa proprio attraverso l'acquisizione, l'uso e lo<br />
scambio <strong>di</strong> oggetti materiali. Un primo approccio antropologico allo stu<strong>di</strong>o della cultura materiale<br />
consiste d<strong>un</strong>que nel cercare <strong>di</strong> decifrare <strong>di</strong> quali messaggi gli oggetti si fanno portatori <strong>in</strong> <strong>di</strong>verse<br />
situazioni sociali.<br />
Un antropologo contemporaneo, Marshall Sahl<strong>in</strong>s, ha affermato (1976) che gli artefatti<br />
<strong>in</strong>dustriali svolgono per i membri delle società moderne la stessa f<strong>un</strong>zione che avevano i totem nelle<br />
società tra<strong>di</strong>zionali e che i <strong>di</strong>versi gruppi <strong>di</strong> consumatori rappresentano le tribù dell'età<br />
contemporanea. Prendendo <strong>in</strong> considerazione soprattutto l'abbigliamento e le abitud<strong>in</strong>i alimentari,<br />
Sahl<strong>in</strong>s fa notare come, per esempio, i vestiti che <strong>in</strong>dossiamo f<strong>un</strong>zion<strong>in</strong>o come dei totem, nel senso<br />
che veicolano dei messaggi relativi alle varie identità sociali e identificano <strong>di</strong>verse 'tribù' <strong>di</strong><br />
consumo. In questa prospettiva, il sistema dell'abbigliamento non è semplicemente <strong>un</strong> <strong>in</strong>sieme <strong>di</strong><br />
oggetti materiali f<strong>in</strong>alizzati a riparare dal freddo, ma <strong>di</strong>venta <strong>un</strong> co<strong>di</strong>ce simbolico attraverso cui le<br />
persone com<strong>un</strong>icano la loro appartenenza ai vari gruppi sociali. Per Sahl<strong>in</strong>s, d<strong>un</strong>que, «la cultura<br />
materiale è basata sullo scambio entro <strong>un</strong> sistema <strong>di</strong> significati simbolici le cui <strong>di</strong>st<strong>in</strong>zioni hanno<br />
delle corrispondenze nell'ord<strong>in</strong>e sociale nelle categorie quali l'età, il genere, il tempo, il lavoro e il<br />
tempo libero» (Dant, 1999: 22).<br />
In <strong>un</strong> altro importante contributo antropologico allo stu<strong>di</strong>o della cultura materiale, Mary Douglas<br />
e Baron Isherwood (1984) sostengono la tesi secondo cui le scelte <strong>di</strong> consumo <strong>di</strong>pendono anche dai<br />
costumi e dalle pratiche sociali, oltre che da decisioni strettamente economiche. I beni materiali<br />
<strong>in</strong>fatti sono acquisiti <strong>in</strong> <strong>di</strong>verse con<strong>di</strong>zioni e per <strong>di</strong>verse f<strong>in</strong>alità che hanno spesso a che fare con le<br />
pratiche com<strong>un</strong>i <strong>di</strong> <strong>un</strong>a società: per esempio si può acquistare per fare regali, per <strong>di</strong>mostrarsi fedeli<br />
ad <strong>un</strong>'usanza, per sottol<strong>in</strong>eare certi legami e così via. In questo senso i beni materiali partecipano<br />
dell'ambiente sociale <strong>in</strong> cui sono <strong>in</strong>seriti e scambiati e <strong>in</strong>sieme esprimono qualcosa relativamente a<br />
questo ambiente. I due autori sottol<strong>in</strong>eano <strong>in</strong>oltre come le scelte <strong>di</strong> consumo, soprattutto nel caso <strong>di</strong><br />
beni quali il cibo, lo spazio abitativo, l'abbigliamento, il mezzo <strong>di</strong> trasporto, i prodotti sanitari,<br />
abbiano <strong>un</strong> effetto importante sull'ord<strong>in</strong>e sociale <strong>in</strong> quanto, <strong>in</strong> certi casi, possono riprodurre (e<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong> r<strong>in</strong>forzare) le <strong>di</strong>visioni e le <strong>di</strong>scrim<strong>in</strong>azioni sociali, <strong>in</strong> altri, possono <strong>in</strong>vece risultare <strong>in</strong><br />
contro-tendenza rispetto all'ord<strong>in</strong>e sociale dom<strong>in</strong>ante.<br />
I due approcci antropologici f<strong>in</strong> qui ricordati sono stati, <strong>in</strong>sieme ad altri (per esempio, Campbell<br />
1989 e Willis 1982) determ<strong>in</strong>anti nel mettere <strong>in</strong> evidenza l'importanza degli oggetti materiali<br />
nell'analisi della cultura, <strong>di</strong>mostrando che è riduttivo considerare il valore dei beni esclusivamente<br />
come <strong>un</strong>a f<strong>un</strong>zione della loro utilità, sulla base <strong>di</strong> <strong>un</strong> modello <strong>di</strong> consumatore concepito come<br />
<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo razionale volto a massimizzare la propria utilità attraverso la scelta dei beni. Gli<br />
antropologi per primi fanno <strong>in</strong>fatti notare come quella economica sia <strong>un</strong>a concezione<br />
eccessivamente astratta, che trascura l'<strong>in</strong>fluenza della storia e dei contesti sociali <strong>in</strong> cui i beni<br />
vengono scambiati. Al contrario, essi sostengono che il valore <strong>di</strong> <strong>un</strong> bene è sempre relativo anche al<br />
sistema sociale <strong>in</strong> cui circola e <strong>di</strong>pende dal tipo <strong>di</strong> scambio <strong>di</strong> cui il bene stesso è <strong>oggetto</strong>; <strong>in</strong> altre<br />
parole essi sostengono che il concetto <strong>di</strong> utilità non è <strong>in</strong> grado da solo <strong>di</strong> dare ragione del valore <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong> <strong>oggetto</strong>, per stabilire il quale occorre fare ricorso anche a fattori <strong>di</strong> tipo simbolico.<br />
Invece <strong>di</strong> limitarsi a sottol<strong>in</strong>eare l'importanza degli oggetti nelle quoti<strong>di</strong>ane pratiche sociali<br />
caratteristiche della società contemporanea (soprattutto le pratiche del consumo) <strong>un</strong>'altra scuola<br />
antropologica <strong>di</strong> orig<strong>in</strong>e stat<strong>un</strong>itense ha proposto <strong>in</strong> anni ancora più recenti <strong>un</strong>a nuova prospettiva <strong>in</strong><br />
base alla quale gli oggetti stessi possiedono <strong>un</strong>a vera e propria vita sociale. Mettendo <strong>in</strong> <strong>di</strong>scussione<br />
l'ass<strong>un</strong>to marxiano secondo cui nelle società capitaliste tutti gli oggetti non sono altro che merci<br />
scambiabili con altre attraverso il tramite della moneta, Igor Kopytoff e Arj<strong>un</strong> Appadurai (1986)<br />
sostengono che <strong>in</strong> tutti i tipi <strong>di</strong> società, compresa qu<strong>in</strong><strong>di</strong> anche la nostra, gli oggetti possono entrare<br />
ed uscire dal ruolo <strong>di</strong> merci a seconda del loro utilizzo e della loro f<strong>un</strong>zione nella società <strong>in</strong><br />
generale, oppure all'<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> gruppi più limitati. Pertanto, per comprendere i significati degli<br />
oggetti occorre ripercorrere la loro <strong>biografia</strong> e seguire le varie tappe attraverso cui essi passano nel<br />
3
corso della loro esistenza. Una tale operazione può avere due esiti analiticamente, ma non<br />
realmente, <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guibili: la ricostruzione della "<strong>biografia</strong> <strong>culturale</strong>" dell'<strong>oggetto</strong>, attraverso i<br />
passaggi tra <strong>un</strong> contesto sociale e l'altro, oppure la ricostruzione <strong>di</strong> "storia sociale" dell'<strong>oggetto</strong> i cui<br />
significati cambiano nel passaggio tra <strong>di</strong>verse epoche storiche o tra ambiti socio-culturali molto<br />
lontani ed eterogenei 6 .<br />
I vantaggi <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> approccio sono, a nostro parere, molteplici. In primo luogo<br />
l'attenzione del ricercatore non privilegia ness<strong>un</strong> momento particolare nella vita sociale dell'<strong>oggetto</strong><br />
rischiando <strong>di</strong> mettere a fuoco soltanto <strong>un</strong>o dei molteplici significati sociali <strong>di</strong> cui esso si è fatto<br />
portatore e trascurando <strong>in</strong> modo arbitrario tutti gli altri. In secondo luogo, questo tipo <strong>di</strong> approccio<br />
consente <strong>di</strong> utilizzare gli oggetti <strong>in</strong> modo praticamente uguale a quanto si fa con gli esseri umani,<br />
quando si adotta il metodo delle storie <strong>di</strong> vita: come gli episo<strong>di</strong> della vita <strong>di</strong> <strong>un</strong>a persona fanno luce<br />
sugli ambienti sociali <strong>in</strong> cui quella ha vissuto e sui <strong>di</strong>versi ruoli e significati che ha <strong>in</strong>carnato per gli<br />
"altri significativi", così la ricostruzione dell'it<strong>in</strong>erario <strong>di</strong> vita degli oggetti porta il ricercatore a<br />
venire <strong>in</strong> contatto con i vari significati che quell'<strong>oggetto</strong> ha <strong>in</strong>corporato per gli <strong>in</strong><strong>di</strong>vidui che l'hanno<br />
utilizzato nelle <strong>di</strong>verse circostanze della realtà sociale. Questa più ampia prospettiva possiede (ed è<br />
questo il terzo vantaggio) <strong>un</strong> grado <strong>di</strong> flessibilità più elevato <strong>in</strong> quanto si presta a ricomprendere la<br />
complessa struttura <strong>di</strong> significati che possono convivere <strong>in</strong> corrispondenza <strong>di</strong> ogni passaggio <strong>di</strong> <strong>un</strong><br />
<strong>oggetto</strong> da <strong>un</strong>a nicchia all'altra del tessuto sociale: quelli connessi al valore economico e quelli<br />
collegati <strong>in</strong> vari mo<strong>di</strong> a fattori culturali (la tra<strong>di</strong>zione, i rituali della vita quoti<strong>di</strong>ana, lo stile <strong>di</strong> vita,<br />
eccetera). Inf<strong>in</strong>e, come fa notare Dant (1999: 24), l'approccio proposto da Appadurai «sc<strong>in</strong>de il<br />
valore dall'<strong>oggetto</strong> <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seco e dai mezzi utilizzati per la sua produzione. È la storia<br />
dell'associazione <strong>di</strong> <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> con gli esseri umani a determ<strong>in</strong>are il suo valore <strong>di</strong> merce <strong>in</strong> qualsiasi<br />
momento. In questa prospettiva l'<strong>oggetto</strong> è <strong>un</strong> veicolo attraverso cui il valore sociale è espresso<br />
come <strong>un</strong>a traccia delle persone, delle occasioni e dei contesti culturali che hanno <strong>in</strong>scritto valore<br />
dentro all'<strong>oggetto</strong>».<br />
3. Opzioni teoriche e metodologiche per <strong>un</strong>a ricerca sugli oggetti<br />
<strong>La</strong> prospettiva a partire dalla quale abbiamo condotto la ricerca <strong>di</strong> cui qui <strong>di</strong> seguito <strong>in</strong>tendo<br />
trattare (cfr. nota 1) è frutto <strong>di</strong> <strong>un</strong>a comb<strong>in</strong>azione tra sp<strong>un</strong>ti derivabili da tale più recente letteratura<br />
antropologica e da alc<strong>un</strong>e idee elaborate nell'ambito dei cultural stu<strong>di</strong>es. Più precisamente, l'idea <strong>di</strong><br />
analizzare la storia <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> tre oggetti <strong>di</strong> moda si rifà, da <strong>un</strong> lato, all'approccio della <strong>biografia</strong><br />
<strong>culturale</strong> degli oggetti proposto dall'antropologo, Igor Kopytoff, dall'altro tiene conto<br />
dell'esperienza già realizzata da alc<strong>un</strong>i stu<strong>di</strong>osi <strong>di</strong> cultural stu<strong>di</strong>es, che nella seconda metà degli anni<br />
Novanta de<strong>di</strong>cano <strong>un</strong> <strong>in</strong>tero volume al Sony Walkman, presentato come <strong>un</strong>o degli oggetti culturali<br />
più significativi del nostro tempo. Naturalmente come équipe <strong>di</strong> ricerca siamo stati f<strong>in</strong> dall'<strong>in</strong>izio<br />
consapevoli del fatto che si tratta <strong>di</strong> due ottiche solo <strong>in</strong> parte accom<strong>un</strong>abili <strong>in</strong> quanto sviluppate a<br />
partire da <strong>in</strong>teressi piuttosto eterogenei. Mentre <strong>in</strong>fatti la riflessione <strong>di</strong> Kopytoff prende le mosse dal<br />
concetto marxiano <strong>di</strong> mercificazione per metterlo <strong>in</strong> <strong>di</strong>scussione e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> contestare l'idea secondo<br />
cui gli oggetti hanno <strong>in</strong> sé quale caratteristica <strong>in</strong>tr<strong>in</strong>seca lo status <strong>di</strong> merci, lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Stuart Hall et<br />
al.(1997) mira soprattutto ad esemplificare attraverso la storia del Sony Walkman la tesi, cara agli<br />
stu<strong>di</strong>osi <strong>di</strong> questa corrente, secondo cui i consumatori, l<strong>un</strong>gi dall'essere soggetti massificati e<br />
passivi, mostrerebbero <strong>di</strong> avere <strong>un</strong> ruolo attivo nel processo <strong>di</strong> attribuzione <strong>di</strong> significato agli<br />
oggetti e ai messaggi che ricevono 7 . Le due prospettive sono però accom<strong>un</strong>ate dalla critica ad alc<strong>un</strong>i<br />
6 Un esempio <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> questo tipo è costituito dal lavoro <strong>di</strong> Heb<strong>di</strong>ge (1988) sulla storia dello scooter italiano. Come<br />
fa notare Appadurai (1986) è <strong>in</strong> pratica molto <strong>di</strong>fficile tenere <strong>di</strong>st<strong>in</strong>ti i due piani che tendono cont<strong>in</strong>uamente a<br />
richiamarsi e a sovrapporsi nella concreta realizzazione degli stu<strong>di</strong> che hanno come protagonisti gli oggetti. Tale<br />
osservazione trova conferma anche nell'esperienza della ricerca da noi eseguita.<br />
7 Secondo questi autori, gli oggetti dell'<strong>in</strong>dustria <strong>culturale</strong> sarebbero <strong>in</strong>fatti caricati, durante il processo <strong>di</strong> produzione, <strong>di</strong><br />
<strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> significati che mirano a stabilire <strong>un</strong>'identificazione tra l'<strong>oggetto</strong> e <strong>un</strong> particolare gruppo <strong>di</strong> consumatori<br />
Questo processo viene da loro chiamato «encod<strong>in</strong>g». Quando i consumatori acquisiscono l'<strong>oggetto</strong> e <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciano ad<br />
4
dei pr<strong>in</strong>cipi fondamentali della corrente marxista e tendono entrambe a rivalutare la capacità degli<br />
oggetti <strong>di</strong> farsi portatori <strong>di</strong> <strong>un</strong> <strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> significati ulteriori rispetto a quello del loro valore <strong>di</strong><br />
scambio, significati che possono essere recuperati seguendo <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> attraverso le fasi della sua<br />
esistenza e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> analizzando le relazioni tra l'<strong>oggetto</strong> stesso e le com<strong>un</strong>ità (culture professionali e<br />
pubblici) con cui viene a contatto. Mettendo <strong>in</strong> evidenza la pluralità <strong>di</strong> tali significati, si smentisce<br />
<strong>di</strong> fatto anche la concezione, proposta dalla scuola <strong>di</strong> Francoforte, secondo cui i prodotti <strong>in</strong>dustriali<br />
sarebbero per def<strong>in</strong>izione non-culturali.<br />
Una volta deciso <strong>di</strong> adottare l'approccio della <strong>biografia</strong> <strong>culturale</strong> degli oggetti, nella fase<br />
successiva del lavoro <strong>di</strong> ricerca si è reso necessario operazionalizzare tale approccio del<strong>in</strong>eando <strong>un</strong><br />
idealtipo empirico dell'it<strong>in</strong>erario generalmente seguito - pur nella varietà dei s<strong>in</strong>goli casi - dai<br />
prodotti dell'<strong>in</strong>dustria <strong>culturale</strong> moderna. A questo f<strong>in</strong>e il riferimento teorico è stato fornito dal<br />
citatissimo schema proposto da Hirsch nel 1972 e relativo proprio al percorso-tipo dei prodotti<br />
dell'<strong>in</strong>dustria <strong>culturale</strong>. Qui <strong>di</strong> seguito ne riporto <strong>un</strong>a rappresentazione grafica [fig.1] adattata da<br />
Griswold (1997).<br />
Sottosistema tecnico ⇒ Sottosistema manageriale ⇒ Sottosistema istituzionale ⇒ Consumatori<br />
(ideazione, progettaz.) (Produzione) (Com<strong>un</strong>icazione) (Consumo)<br />
⇑ ⇓ ⇓<br />
↑___________________________ feed back ___________ ↵<br />
Fig.1<br />
L'utilizzo <strong>di</strong> questo schema consente <strong>di</strong> identificare agevolmente i quattro pr<strong>in</strong>cipali no<strong>di</strong><br />
tematici <strong>in</strong>torno ai quali si è svolto il nostro lavoro <strong>di</strong> ricerca: il momento dell'ideazione, della<br />
produzione, della com<strong>un</strong>icazione e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e del consumo f<strong>in</strong>ale <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong>o dei tre oggetti che<br />
abbiamo stu<strong>di</strong>ato. Se immag<strong>in</strong>iamo ciasc<strong>un</strong>o <strong>di</strong> questi momenti come <strong>un</strong> contenitore, il nostro<br />
stu<strong>di</strong>o (svolto con il metodo delle <strong>in</strong>terviste motivazionali a testimoni privilegiati e a figure ritenute<br />
rilevanti <strong>in</strong> ciasc<strong>un</strong>a delle fasi dell'it<strong>in</strong>erario, oltre che con l'impiego <strong>di</strong> <strong>in</strong>terviste <strong>di</strong> gruppo<br />
realizzate con i consumatori) si è orientato, da <strong>un</strong> lato, ad analizzare i processi com<strong>un</strong>icativi <strong>in</strong>terni<br />
a ciasc<strong>un</strong>a fase, dall'altro, ad identificare anche i processi <strong>di</strong> conf<strong>in</strong>e attraverso i quali si realizza il<br />
passaggio dell'<strong>oggetto</strong> da <strong>un</strong>a fase a quella successiva. Poiché ciasc<strong>un</strong>o <strong>di</strong> questi passaggi può<br />
essere visto come l'<strong>in</strong>contro tra due o più culture professionali <strong>di</strong>fferenti, l'analisi ha messo <strong>in</strong><br />
evidenza le modalità formali e <strong>in</strong>formali con cui viene <strong>di</strong> volta <strong>in</strong> volta raggi<strong>un</strong>to l'accordo<br />
com<strong>un</strong>icativo che rende possibile il procedere dell'<strong>oggetto</strong> verso la sua dest<strong>in</strong>azione f<strong>in</strong>ale: il<br />
mercato del consumo. Come la nostra analisi mette <strong>in</strong> evidenza, tale accordo viene realizzato<br />
talvolta grazie all'adozione <strong>di</strong> particolari procedure <strong>di</strong> lavoro che contengono <strong>in</strong> sé delle risorse<br />
f<strong>in</strong>alizzate al raggi<strong>un</strong>gimento <strong>di</strong> tale accordo, altre volte grazie all'azione <strong>di</strong> particolari figure <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>atori che, collocandosi tra <strong>un</strong>a fase e l'altra, sono <strong>in</strong> grado app<strong>un</strong>to <strong>di</strong> me<strong>di</strong>are tra i <strong>di</strong>versi<br />
l<strong>in</strong>guaggi tecnici <strong>in</strong> quel p<strong>un</strong>to rilevanti. Si tratta spesso <strong>di</strong> tipi i professionalità non-tra<strong>di</strong>zionali e<br />
relativamente recenti <strong>in</strong> corrispondenza dei quali si registra <strong>un</strong>a domanda <strong>in</strong> costante crescita nel<br />
mercato del lavoro 8 .<br />
Le nostre analisi hanno <strong>in</strong>oltre prodotto risultati <strong>in</strong>teressanti anche per quanto riguarda delle<br />
possibili revisioni dello schema <strong>di</strong> Hirsch che pure aveva fornito <strong>un</strong> valido p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> partenza per<br />
l'impostazione del lavoro: <strong>in</strong> particolare, i meccanismi <strong>di</strong> feed-back messi <strong>in</strong> evidenza da Hirsch<br />
utilizzarlo mettono <strong>in</strong> atto <strong>un</strong> processo <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>fica («decod<strong>in</strong>g») <strong>di</strong> tali significati che non necessariamente si<br />
sovrappone alle <strong>in</strong>tenzioni dei produttori.<br />
8 Si tratta <strong>di</strong> figure professionali che possono rientrare nella def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> Bour<strong>di</strong>eu (1984) <strong>di</strong> «<strong>in</strong>terme<strong>di</strong>ari <strong>di</strong> cultura».<br />
Sul tema si veda anche Bovone 1994.<br />
5
appaiono, <strong>in</strong> base alle osservazioni empiriche, eccessivamente limitati e <strong>di</strong> fatto non <strong>in</strong> grado <strong>di</strong><br />
rendere conto della circolarità esistente tra l'<strong>in</strong>izio e la f<strong>in</strong>e del processo dell'<strong>in</strong>dustria <strong>culturale</strong>, che<br />
costituiva, tra l'altro, <strong>un</strong>a delle ipotesi <strong>di</strong> partenza del nostro lavoro. Si tratta, come detto, della<br />
circolarità già <strong>in</strong>tuita e messa <strong>in</strong> evidenza da alc<strong>un</strong>i stu<strong>di</strong>osi anglosassoni <strong>di</strong> cultural stu<strong>di</strong>es (Hall et<br />
al. 1997) che mostra come molto spesso le modalità <strong>di</strong> <strong>in</strong>terpretazione e <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> <strong>in</strong><br />
fasi <strong>di</strong>verse dalla produzione abbiano importanti ricadute sulle scelte <strong>di</strong> designer e produttori.<br />
Oltre a confermare questa <strong>in</strong>terpretazione, il nostro lavoro ha ulteriormente complicato il<br />
modello della circolarità; <strong>in</strong>fatti, p<strong>un</strong>tando l'attenzione sulle zone <strong>di</strong> conf<strong>in</strong>e tra <strong>un</strong>a fase e l'altra<br />
dell'it<strong>in</strong>erario, è stato possibile rilevare anche l'esistenza <strong>di</strong> quelle che potremmo chiamare delle<br />
«micro-circolarità» che si <strong>in</strong>staurano cont<strong>in</strong>uamente tra le fasi e sotto-fasi <strong>in</strong>terme<strong>di</strong>e dell'it<strong>in</strong>erario<br />
sopra schematizzato. Sembra pertanto riduttivo ipotizzare, come fa Hirsch, solo due gran<strong>di</strong> flussi <strong>di</strong><br />
feed-back (dai consumatori ai produttori e dai me<strong>di</strong>a ai produttori): i processi com<strong>un</strong>icativi <strong>in</strong> atto<br />
<strong>in</strong> tutti i p<strong>un</strong>ti del percorso realizzano <strong>in</strong>fatti <strong>un</strong>a <strong>in</strong>cessante serie <strong>di</strong> riman<strong>di</strong> tali per cui tutti i<br />
momenti dell'it<strong>in</strong>erario risultano essere sempre contemporaneamente presenti <strong>in</strong> ogni suo p<strong>un</strong>to<br />
sotto forma <strong>di</strong> variabili <strong>di</strong> cui tenere conto <strong>in</strong> tutti i processi decisionali.<br />
Per illustrare quanto detto f<strong>in</strong> qui sembra a questo p<strong>un</strong>to opport<strong>un</strong>o presentare analiticamente<br />
<strong>un</strong>o dei tre casi analizzati nella ricerca: il caso della <strong>valigia</strong> rigida Oyster <strong>di</strong> Samsonite.<br />
4. <strong>La</strong> scelta dell'<strong>oggetto</strong><br />
Partendo dal backgro<strong>un</strong>d teorico e dalle ipotesi che ho f<strong>in</strong> qui presentato, la ricerca realizzata<br />
dall'équipe <strong>di</strong> cui facevo parte, si proponeva <strong>di</strong> realizzare la <strong>biografia</strong> <strong>culturale</strong> <strong>di</strong> tre oggetti<br />
particolarmente significativi prodotti nel settore dell'abbigliamento e degli accessori. <strong>La</strong> scelta <strong>di</strong><br />
Samsonite quale azienda produttrice <strong>di</strong> <strong>un</strong>o degli oggetti da stu<strong>di</strong>are è motivata da <strong>di</strong>versi fattori:<br />
<strong>in</strong>nanzitutto l'azienda si è subito <strong>di</strong>mostrata <strong>in</strong>teressata al progetto e <strong>di</strong>sposta ad aprire le porte al<br />
ricercatore; <strong>in</strong> secondo luogo, dal nostro p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, Samsonite poteva senza dubbio<br />
rappresentare <strong>un</strong> caso <strong>in</strong>teressante, dal momento che non solo è azienda leader nel settore del<br />
bagaglio, ma il suo nome è particolarmente legato ad <strong>un</strong>a specifica tipologia <strong>di</strong> <strong>valigia</strong>: app<strong>un</strong>to la<br />
<strong>valigia</strong> rigida.<br />
Una volta stabilita la collaborazione con Samsonite, la scelta dell'<strong>oggetto</strong> da stu<strong>di</strong>are si è def<strong>in</strong>ita<br />
nei colloqui prelim<strong>in</strong>ari tra ricercatori e il management dell'azienda: da questi ultimi è partito il<br />
suggerimento <strong>di</strong> concentrarsi sulla l<strong>in</strong>ea Oyster. Pur essendo <strong>un</strong> modello oramai datato, (è stata<br />
presentata sul mercato nel 1986) la Oyster (<strong>in</strong> italiano «conchiglia») viene considerata dal<br />
management <strong>un</strong>a sorta <strong>di</strong> <strong>oggetto</strong>-simbolo dell'azienda sia per il suo straord<strong>in</strong>ario successo <strong>di</strong><br />
mercato, sia perché è stata la prima <strong>valigia</strong> Samsonite totalmente <strong>di</strong>segnata e prodotta <strong>in</strong> Europa<br />
utilizzando fra l'altro <strong>un</strong> progetto e delle tecniche <strong>di</strong> produzione del tutto <strong>in</strong>novative.<br />
Dal nostro p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, la scelta <strong>di</strong> Oyster era particolarmente <strong>in</strong>teressante perché ci consentiva <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>are <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> che, pur essendo tuttora commercializzato con successo, rappresenta<br />
nell'immag<strong>in</strong>ario collettivo <strong>un</strong>a sorta <strong>di</strong> stereotipo della <strong>valigia</strong> rigida, <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> quasi cult che<br />
<strong>in</strong>carna le caratteristiche essenziali <strong>di</strong> <strong>un</strong>'<strong>in</strong>tera tipologia <strong>di</strong> artefatti dell'<strong>in</strong>dustria <strong>culturale</strong> della<br />
moda.<br />
FOTO<br />
6
4. 1. <strong>La</strong> Oyster come <strong>oggetto</strong> <strong>di</strong> design: designed for manufactur<strong>in</strong>g<br />
Quale merce <strong>di</strong> consumo, la <strong>valigia</strong> si presenta imme<strong>di</strong>atamente come <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> dalla "doppia<br />
personalità": da <strong>un</strong> lato, poiché ha a che fare con il look <strong>di</strong> <strong>un</strong>a persona, può essere considerato a<br />
pieno titolo <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> <strong>di</strong> moda, <strong>in</strong>seribile nella categoria degli accessori; dall'altro, vista la sua<br />
dest<strong>in</strong>azione d'uso, la <strong>valigia</strong> <strong>in</strong>carna senza dubbio <strong>un</strong> importante ruolo f<strong>un</strong>zionale che <strong>in</strong>fatti<br />
rappresenta <strong>un</strong>a variabile cruciale <strong>in</strong> tutte le fasi della sua '<strong>biografia</strong>'. Non a caso, qu<strong>in</strong><strong>di</strong>, la<br />
necessità <strong>di</strong> abb<strong>in</strong>are proprietà estetiche e f<strong>un</strong>zionali <strong>in</strong> <strong>un</strong>a medesima forma viene citato dal<br />
progettista <strong>di</strong> Oyster come <strong>un</strong> primo fondamentale fattore <strong>di</strong> <strong>in</strong>fluenza sul suo lavoro: nell'<strong>oggetto</strong><strong>valigia</strong><br />
<strong>in</strong>fatti è a <strong>di</strong>sposizione <strong>un</strong>'<strong>un</strong>ica struttura materiale per sod<strong>di</strong>sfare due esigenze <strong>di</strong> segno<br />
<strong>di</strong>verso 9 .<br />
Infatti, il designer che ha realizzato con la sua équipe il progetto per Oyster sottol<strong>in</strong>ea<br />
nell'<strong>in</strong>tervista alc<strong>un</strong>e caratteristiche peculiari connesse al <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>valigia</strong>:<br />
Con gli articoli <strong>di</strong> bagaglio, non c'è <strong>un</strong> 'dentro' e <strong>un</strong> 'fuori', ma sta tutto <strong>in</strong>sieme….voglio <strong>di</strong>re, se<br />
pren<strong>di</strong>amo per esempio <strong>un</strong>'automobile, c'è <strong>un</strong>a forma esterna e <strong>un</strong> <strong>in</strong>terno… la parte esterna è tutto<br />
ciò che importa esteticamente, si sa che ciò che sta sotto la carrozzeria è solo <strong>un</strong> guazzabuglio <strong>di</strong><br />
parti meccaniche e la sua estetica non <strong>in</strong>teressa a ness<strong>un</strong>o. Nel caso della <strong>valigia</strong>, <strong>in</strong>vece, si vedono<br />
sempre tutte e due le parti; è veramente <strong>un</strong> caso <strong>di</strong> <strong>in</strong>dustrial design perché occorre tenere conto <strong>di</strong><br />
tutto, altrimenti si rischia <strong>di</strong> dare agli <strong>in</strong>gegneri <strong>un</strong> compito impossibile.<br />
Per questo, f<strong>in</strong> dalle fasi <strong>in</strong>iziali dell'ideazione, il lavoro su Oyster è caratterizzato da <strong>un</strong>a <strong>in</strong>tensa<br />
collaborazione tra l'équipe dei designer e i responsabili della produzione che, lavorando <strong>in</strong> stretto<br />
contatto, realizzano <strong>un</strong>'impostazione del lavoro <strong>in</strong> l<strong>in</strong>ea con la nuova strategia dell'azienda il cui<br />
obiettivo consiste, <strong>in</strong> quel periodo (la seconda metà degli anni Ottanta) nell'immettere sul mercato<br />
<strong>in</strong> tempi brevissimi <strong>un</strong> prodotto <strong>in</strong>novativo nella forma e competitivo nel prezzo. Da ciò deriva la<br />
necessità <strong>di</strong> concentrare il più possibile le fasi della lavorazione per non rischiare <strong>di</strong> dover fare e<br />
rifare, nel passaggio tra <strong>un</strong>a fase della lavorazione a quella successiva. Come ci racconta <strong>un</strong><br />
membro del top management <strong>di</strong> Samsonite Europe, che partecipò attivamente a tutte le fasi della<br />
produzione della <strong>valigia</strong> e che è <strong>in</strong>fatti scherzosamente <strong>in</strong><strong>di</strong>cato come "il padre della Oyster":<br />
9 Per <strong>in</strong>ciso è <strong>in</strong>teressante ricordare che il design <strong>in</strong>dustriale nasce proprio, all'<strong>in</strong>izio del Novecento, come <strong>un</strong> settore <strong>di</strong><br />
attività dove la creatività degli autori viene applicata alla progettazione <strong>di</strong> oggetti dest<strong>in</strong>ati alla produzione <strong>in</strong> serie:<br />
«siamo nel delicato momento storico <strong>in</strong> cui si verifica il passaggio dal consumatore-committente, e d<strong>un</strong>que da <strong>un</strong> 'fare<br />
dell'<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo per l'<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo' tipico dell'artigianato, a <strong>un</strong>a 'produzione collettiva per la collettività', ad <strong>un</strong> pubblico <strong>di</strong><br />
consumatori vasto e <strong>in</strong>def<strong>in</strong>ito» (Cutolo, 1989:24). In questo quadro, il ruolo del progettista si configura come quello <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>atore non solo tra consumatore e <strong>in</strong>dustria, ma tra domanda <strong>di</strong> esteticità dell'<strong>oggetto</strong> e sua rispondenza ad <strong>un</strong><br />
preciso ruolo f<strong>un</strong>zionale.<br />
7
Abbiamo scelto, per il design, <strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o <strong>in</strong>glese con cui avevamo già collaborato, e gli abbiamo<br />
fornito <strong>un</strong> brief…Dopo <strong>un</strong> mese erano già qui con parecchie idee <strong>in</strong>teressanti…In più avevo deciso<br />
che l'eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g del prodotto sarebbe stato fatto non solo dall'<strong>in</strong>gegnere del prodotto, ma anche da<br />
<strong>un</strong> altro <strong>in</strong>gegnere che stu<strong>di</strong>asse la produzione, che tenesse conto della produzione f<strong>in</strong><br />
dall'orig<strong>in</strong>e….era <strong>un</strong> proce<strong>di</strong>mento nuovo, perché <strong>di</strong> solito all'<strong>in</strong>izio c'era il design, poi si stu<strong>di</strong>ava il<br />
prodotto <strong>in</strong> f<strong>un</strong>zione del design, poi si andava dal manufactur<strong>in</strong>g eng<strong>in</strong>eer e si <strong>di</strong>ceva: 'adesso<br />
producete'. Spesso però a questo p<strong>un</strong>to sorgeva la necessità <strong>di</strong> fare delle correzioni, <strong>in</strong> modo da<br />
rendere più agevole la produzione e certe cose si potevano ancora cambiare, altre no…<br />
Per lavorare <strong>in</strong> questo modo, potremmo <strong>di</strong>re, a competenze sovrapposte, è <strong>in</strong><strong>di</strong>spensabile<br />
garantire che vi sia <strong>un</strong> cont<strong>in</strong>uo contatto tra designer e <strong>in</strong>gegneri addetti alla produzione; come ci<br />
spiega il manager <strong>in</strong>tervistato, tale necessità, <strong>in</strong>sieme al desiderio <strong>di</strong> realizzare <strong>un</strong> prodotto <strong>di</strong><br />
elevata qualità formale, rappresentano i fattori determ<strong>in</strong>anti nella scelta dello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> design cui<br />
affidare il progetto <strong>di</strong> Oyster. Viene <strong>in</strong>fatti prescelto <strong>un</strong>o stu<strong>di</strong>o già conosciuto <strong>in</strong> azienda e<br />
<strong>di</strong>mostratosi aperto alla collaborazione con gli "uom<strong>in</strong>i <strong>di</strong> produzione", <strong>un</strong>a flessibilità che non<br />
sempre è <strong>di</strong>ffusa tra i designer. Per esempio, i designer italiani, pur essendo anche al tempo molto<br />
ammirati <strong>in</strong> Samsonite, vengono considerati, <strong>in</strong> quest'occasione, troppo attenti alla forma estetica,<br />
ma tra<strong>di</strong>zionalmente poco preoccupati <strong>di</strong> facilitare il compito degli <strong>in</strong>gegneri addetti alla<br />
realizzazione del prodotto.<br />
Parlando <strong>di</strong> questo aspetto della vicenda, sempre lo stesso manager ci racconta:<br />
avevamo provato già molte persone, tra cui <strong>un</strong> designer <strong>di</strong> Tor<strong>in</strong>o e <strong>un</strong> altro designer belga, ma<br />
questi designer <strong>in</strong>glesi facevano proprio al caso nostro…. i designer italiani hanno <strong>un</strong>a grande<br />
sensibilità per l'estetica e per il colore, ma quando si cerca <strong>di</strong> realizzare il prodotto meccanicamente<br />
ci si accorge che è impossibile da fare. Una volta mi successe, glielo feci notare e loro mi risposero<br />
che questo era <strong>un</strong> problema <strong>di</strong> noi <strong>in</strong>gegneri…I designer <strong>in</strong>glesi <strong>in</strong>vece <strong>di</strong> solito hanno <strong>un</strong> ottimo<br />
backgro<strong>un</strong>d <strong>in</strong>gegneristico, ci sono molti bravi designer <strong>in</strong> Gran Bretagna….<br />
Dalle <strong>in</strong>terviste realizzate durante la nostra ricerca sia con gli addetti al design sia con gli<br />
<strong>in</strong>gegneri <strong>di</strong> produzione viene d<strong>un</strong>que confermata l'immag<strong>in</strong>e <strong>di</strong>ffusa e prevalente del design<br />
italiano come <strong>un</strong>o stile <strong>di</strong> design che p<strong>un</strong>ta molto [a volte troppo, e da qui l'accusa <strong>di</strong> "ipertrofia<br />
estetica" che si trova <strong>in</strong> qualche brano della letteratura (De Fusco,1985)] sulle caratteristiche<br />
formali degli oggetti a scapito delle loro qualità f<strong>un</strong>zionali. Tale op<strong>in</strong>ione sembra essere con<strong>di</strong>visa<br />
anche dalla com<strong>un</strong>ità <strong>in</strong>ternazionale dei designer, come si deduce anche dalle parole del progettista<br />
<strong>di</strong> Oyster <strong>in</strong>tervistato nella sede del suo stu<strong>di</strong>o:<br />
Suppongo che se stesse parlando con <strong>un</strong> designer italiano, l'aspetto emotivo e soggettivo sarebbe<br />
messo molto più <strong>in</strong> risalto, mentre mi accorgo che io sto parlando soprattutto <strong>di</strong> particolari tecnici<br />
più che degli aspetti visuali del progetto..questo non significa che non ci teniamo all'estetica, ma<br />
non si può progettare <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> senza pensare al suo f<strong>un</strong>zionamento. Potremmo <strong>di</strong>re, come<br />
designer, "ok, lo vogliamo così, deve avere questo aspetto, voi, uom<strong>in</strong>i della produzione, pensate a<br />
realizzarlo", ma noi non lavoriamo così, noi <strong>di</strong>ciamo "se f<strong>un</strong>ziona così, allora può avere soltanto<br />
questa forma". Perciò con Oyster abbiamo lavorato molto sulla forma, ma tenendo sempre conto<br />
delle modalità <strong>di</strong> costruzione dell'<strong>oggetto</strong>, poi siamo passati dal modello al prototipo f<strong>un</strong>zionale e a<br />
questo p<strong>un</strong>to gli <strong>in</strong>gegneri <strong>di</strong> produzione potevano veramente valutare tutte le implicazioni del<br />
progetto e fare tutti i cambiamenti per renderlo completamente efficiente dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista<br />
produttivo e del costo.<br />
Del resto, guardando la Oyster, è <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>re se abbia veramente prevalso l'orientamento<br />
f<strong>un</strong>zionale sull'orientamento estetico; <strong>in</strong> realtà, l'eccezionale successo ottenuto dal prodotto, che<br />
8
cont<strong>in</strong>ua, a quasi qu<strong>in</strong><strong>di</strong>ci anni dalla sua prima comparsa, ad essere leader sul mercato, è forse<br />
proprio <strong>un</strong> segnale del fatto che è stato raggi<strong>un</strong>to <strong>un</strong> felice equilibrio tra queste due esigenze.<br />
4.1.1. Un sistema alternativo <strong>di</strong> produzione<br />
A quanto pare la decisione da parte <strong>di</strong> Samsonite <strong>di</strong> lanciare <strong>un</strong> prodotto nuovo e completamente<br />
europeo derivava pr<strong>in</strong>cipalmente dalla necessità <strong>di</strong> contrastare la concorrenza che, all'<strong>in</strong>izio degli<br />
anni Ottanta, com<strong>in</strong>ciava a <strong>in</strong>si<strong>di</strong>are più pericolosamente che <strong>in</strong> passato la leadership <strong>di</strong> Samsonite<br />
nel mercato del bagaglio hard-side. In quegli anni si era qu<strong>in</strong><strong>di</strong> del<strong>in</strong>eata l'esigenza <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare<br />
l'<strong>in</strong>tero sistema produttivo per renderlo più efficiente (attraverso la riduzione dei 'tempi morti' della<br />
lavorazione) e più flessibile e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> adattarsi alle fluttuazioni del mercato senza creare<br />
scorte eccessive nel magazz<strong>in</strong>o e provocare per<strong>di</strong>te per l'azienda. A questo f<strong>in</strong>e <strong>un</strong>'équipe <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>gegneri stava da alc<strong>un</strong>i anni stu<strong>di</strong>ando la messa a p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> <strong>un</strong> nuovo sistema <strong>di</strong> lavorazione capace<br />
<strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare il più possibile gli obiettivi proposti dal management.<br />
Inizialmente l'idea era quella <strong>di</strong> <strong>in</strong>trodurre i cambiamenti sulla lavorazione <strong>di</strong> Saturn, la l<strong>in</strong>ea<br />
precedente alla Oyster, che, pur essendo la prima <strong>valigia</strong> <strong>in</strong> polipropilene <strong>di</strong>segnata negli Stati Uniti,<br />
già da anni era <strong>in</strong> produzione nello stabilimento belga <strong>di</strong> Oudenaarde 10 ; successivamente però<br />
questa idea venne abbandonata <strong>in</strong> quanto il design <strong>di</strong> Saturn non si prestava agli aggiustamenti<br />
previsti dalle mo<strong>di</strong>fiche del sistema produttivo se non a costi elevatissimi per l'azienda. Il capo<br />
dell'équipe degli <strong>in</strong>gegneri <strong>in</strong>caricati <strong>in</strong> quegli anni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are la realizzabilità <strong>di</strong> questi<br />
cambiamenti sul sistema produttivo ci racconta:<br />
andai dal mio General Manager e gli <strong>di</strong>ssi "non mi sembra <strong>un</strong>a buona idea, non ha senso….I nostri<br />
stu<strong>di</strong> ci <strong>di</strong>cono che è possibile razionalizzare il sistema <strong>di</strong> produzione, ma solo con <strong>un</strong> gran<strong>di</strong>ssimo<br />
<strong>in</strong>vestimento <strong>di</strong> (cita la cifra)", e aggi<strong>un</strong>si "se tu con quell'<strong>in</strong>vestimento riesci a creare <strong>un</strong> nuovo<br />
prodotto con le caratteristiche che <strong>di</strong>co io, allora è meglio spendere i sol<strong>di</strong> così, <strong>in</strong>vece che tentare<br />
<strong>di</strong> adattare la produzione <strong>di</strong> Saturn al nuovo sistema". Qualche tempo dopo vide sul mercato <strong>un</strong><br />
prodotto della concorrenza e decise che era ora che Samsonite uscisse con qualcosa <strong>di</strong> nuovo. Trovò<br />
i designer, li portò qui e io spiegai loro tutta la storia esponendo le nuove idee che avevamo per la<br />
produzione, anche se, al p<strong>un</strong>to <strong>in</strong> cui eravamo arrivati, restavano aperti dei problemi che ancora non<br />
sapevamo come risolvere. Il mio obiettivo era <strong>di</strong> arrivare ad <strong>un</strong> sistema per cui <strong>un</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>viduo<br />
produceva tutta <strong>un</strong>a <strong>valigia</strong>, dall'<strong>in</strong>izio alla f<strong>in</strong>e, lì <strong>in</strong>fatti stavano tutti i vantaggi. Quando si decise<br />
<strong>di</strong> fare Oyster pensai che quella doveva essere l'occasione per raggi<strong>un</strong>gere quell'obiettivo.<br />
D<strong>un</strong>que f<strong>in</strong> dall'<strong>in</strong>izio la realizzazione <strong>di</strong> Oyster rappresenta <strong>un</strong> processo <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento per<br />
varie categorie professionali: lo è per i designer, che si trovano per la prima volta a dover progettare<br />
<strong>un</strong>a <strong>valigia</strong> e per <strong>di</strong> più a realizzarla secondo determ<strong>in</strong>ate esigenze (Oyster è sotto questo aspetto <strong>un</strong><br />
tipico esempio <strong>di</strong> prodotto designed for manufactur<strong>in</strong>g, cioè progettato con caratteristiche<br />
f<strong>un</strong>zionali alla sua realizzazione <strong>in</strong>gegneristica); lo è per gli <strong>in</strong>gegneri <strong>di</strong> produzione che,<br />
collaborando con i designer alla ideazione del prodotto, <strong>in</strong>tendono <strong>in</strong> questa occasione rivoluzionare<br />
l'<strong>in</strong>tero sistema <strong>di</strong> lavorazione per renderlo più efficiente; lo è <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e per tutto il management <strong>di</strong><br />
Samsonite Europe, che con Oyster si lancia <strong>in</strong> <strong>un</strong>'operazione <strong>in</strong> fondo piuttosto rischiosa, ancora<br />
costellata da molte <strong>in</strong>certezze e <strong>in</strong> cui si procede certo sulla base <strong>di</strong> conoscenze tecniche<br />
consolidate, ma anche <strong>di</strong> tentativi f<strong>in</strong>alizzati alla ricerca <strong>di</strong> <strong>un</strong>'<strong>in</strong>novazione che <strong>in</strong> questo caso deve<br />
essere realizzata <strong>in</strong> fretta.<br />
Di solito per realizzare <strong>un</strong> nuovo prodotto - ci spiega il padre della Oyster - ci volevano almeno due<br />
anni e mezzo o tre; per Oyster, siccome c'era <strong>un</strong>a grande fretta, io mi ero impegnato con il<br />
10 Si tratta della cittad<strong>in</strong>a belga dove ha sede Samsonite Europe.<br />
9
Presidente ad uscire <strong>in</strong> <strong>un</strong> anno e mezzo, almeno con la prima fase della l<strong>in</strong>ea per poi completarla<br />
entro sei mesi.<br />
Forse proprio a causa delle particolari circostanze che <strong>di</strong>edero orig<strong>in</strong>e al progetto <strong>di</strong> Oyster, il<br />
processo <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> questo prodotto viene raccontato da tutti coloro che vi si de<strong>di</strong>carono <strong>in</strong><br />
prima persona come <strong>un</strong>a sorta <strong>di</strong> 'avventura', <strong>un</strong>'esperienza che nei ricor<strong>di</strong> emerge come<br />
entusiasmante e affasc<strong>in</strong>ante sicuramente per il successo che l'ha coronata, ma anche per l'atmosfera<br />
<strong>di</strong> 'sperimentazione' su vari fronti, che ha caratterizzato le fasi <strong>di</strong> progettazione e <strong>di</strong> realizzazione<br />
dell'<strong>oggetto</strong> e che ha costretto gli operatori a trovare soluzioni creative, e a volte rischiose, per i<br />
problemi che <strong>in</strong>evitabilmente sorgono ogni volta che si lavora ad <strong>un</strong> progetto <strong>in</strong>novativo.<br />
Lo scopo pr<strong>in</strong>cipale dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista degli <strong>in</strong>gegneri della produzione consisteva<br />
nell'abbandonare il sistema <strong>di</strong> lavorazione a catena <strong>di</strong> montaggio per <strong>in</strong>trodurre <strong>in</strong>vece<br />
<strong>un</strong>'organizzazione più flessibile, costituita da isole autosufficienti <strong>di</strong> lavoro <strong>in</strong> cui ciasc<strong>un</strong> addetto<br />
avesse a <strong>di</strong>sposizione tutti gli attrezzi che gli occorrevano per assemblare la <strong>valigia</strong> almeno nelle<br />
sue parti fondamentali. Questo tipo <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento, oltre a ridurre al massimo i rallentamenti che<br />
facilmente si verificavano nella catena <strong>di</strong> montaggio, aveva anche il vantaggio <strong>di</strong> rendere il lavoro<br />
<strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong> addetto meno ripetitivo e meno alienante.<br />
Uno degli ideali-guida che <strong>in</strong>tendevamo realizzare - ci racconta l'<strong>in</strong>gegnere <strong>di</strong> produzione - era<br />
anche quello <strong>di</strong> creare <strong>un</strong>'atmosfera <strong>di</strong> lavoro con m<strong>in</strong>imi livelli <strong>di</strong> stress per <strong>in</strong>centivare la<br />
produttività, ma anche perché gli operai potessero lavorare meglio ed essere più sod<strong>di</strong>sfatti del loro<br />
operato. Nel sistema a isole <strong>di</strong> lavoro, ogn<strong>un</strong>o può andare al suo ritmo (naturalmente abbiamo<br />
fissato dei limiti <strong>in</strong>feriori e superiori <strong>di</strong> produttività) e <strong>in</strong> più ciasc<strong>un</strong>o si sente responsabile <strong>in</strong> prima<br />
persona del proprio lavoro, perché <strong>di</strong> fatto crea l'<strong>in</strong>tera <strong>valigia</strong>; <strong>in</strong>oltre la produttività così migliora<br />
perché i problemi e i rallentamenti che <strong>un</strong>o può avere <strong>in</strong> <strong>un</strong> certo p<strong>un</strong>to non si ripercuotono sugli<br />
altri.<br />
Il brief consegnato al designer tiene ovviamente conto delle caratteristiche del nuovo sistema<br />
produttivo e pertanto pone dei v<strong>in</strong>coli sul progetto per quanto riguarda soprattutto i dettagli tecnici<br />
della <strong>valigia</strong> (per esempio si impone a volte l'uso <strong>di</strong> certi materiali anziché <strong>di</strong> altri), senza però<br />
pesare eccessivamente sulla libertà espressiva dei progettisti per quanto riguarda le qualità estetiche<br />
dell'<strong>oggetto</strong>.<br />
Un altro aspetto <strong>in</strong>teressante del processo <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> Oyster è dato dal fatto che il<br />
designer viene co<strong>in</strong>volto pesantemente <strong>in</strong> quasi tutta la fase produttiva: per esempio, <strong>in</strong> momenti<br />
quali la scelta dei fornitori delle serrature e successivamente nella messa a p<strong>un</strong>to degli stampi<br />
fabbricati presso <strong>un</strong> artigiano italiano. In questo periodo il top management dell'azienda e il gruppo<br />
dei designer si <strong>in</strong>contrano regolarmente (almeno <strong>un</strong>a volta al mese) per <strong>di</strong>scutere del progetto e per<br />
mettere a p<strong>un</strong>to i vari dettagli sia formali sia tecnici del nuovo prodotto. Si tratta <strong>di</strong> <strong>un</strong> modo <strong>di</strong><br />
lavorare molto flessibile e, pare, poco <strong>di</strong>ffuso almeno <strong>in</strong> quei tempi; con tale impostazione delle<br />
operazioni si tende <strong>in</strong>fatti a non considerare rigidamente la <strong>di</strong>visione delle competenze, che anzi<br />
viene spesso scavalcata a favore <strong>di</strong> <strong>un</strong> modo <strong>di</strong> lavorare che si sviluppa tenendo come centro<br />
d'attenzione il prodotto. Questo aspetto è molto <strong>in</strong>teressante dal nostro p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> sociologi<br />
della cultura, <strong>in</strong> quanto ci permette <strong>di</strong> esam<strong>in</strong>are <strong>un</strong>a situazione <strong>in</strong> cui <strong>di</strong>verse 'culture professionali'<br />
non solo vengono <strong>in</strong> contatto, ma, dovendo collaborare <strong>in</strong>tensamente, sono costrette a trovare delle<br />
forme <strong>di</strong> com<strong>un</strong>icazione efficienti al f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> risolvere problemi com<strong>un</strong>i. Come ai livelli operativi<br />
della lavorazione è considerata <strong>di</strong> primaria importanza la versatilità degli operatori, nel senso della<br />
loro capacità <strong>di</strong> svolgere <strong>di</strong>verse f<strong>un</strong>zioni, così anche a livello <strong>di</strong> top management la filosofia <strong>di</strong><br />
Samsonite sembra privilegiare <strong>un</strong> atteggiamento flessibile e l'abilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogare anche con i<br />
rappresentanti <strong>di</strong> culture professionali <strong>di</strong>verse dalla propria. In queste circostanze può avvenire (ed è<br />
avvenuto durante la realizzazione <strong>di</strong> Oyster) che gli uom<strong>in</strong>i <strong>di</strong> produzione trov<strong>in</strong>o la soluzione<br />
10
giusta ad <strong>un</strong> problema <strong>di</strong> design e, viceversa, che il progettista presieda alla costruzione degli<br />
stampi oppure <strong>di</strong>a idee per abbreviare i tempi <strong>di</strong> testaggio <strong>di</strong> <strong>un</strong> nuovo prodotto.<br />
4.1.2. Oyster come <strong>oggetto</strong>-simbolo<br />
Nella descrizione fatta dal progettista, il design <strong>di</strong> Oyster sarebbe fortemente caratterizzato da<br />
due aspetti-chiave:<br />
<strong>un</strong>o è la connessione tra il coperchio e la base con questo angolo particolare che è stato stu<strong>di</strong>ato così<br />
per rendere la base più capiente…ed è anche <strong>un</strong> vantaggio dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista estetico perché quando<br />
la si apre la <strong>valigia</strong> è <strong>un</strong> po' più bassa nella parte <strong>di</strong> fronte e questa forma rende l'accesso più<br />
naturale; il secondo è senza dubbio il sistema <strong>di</strong> ganci <strong>di</strong> chiusura che era all'epoca completamente<br />
nuovo perché tutti i modelli erano basati sullo standard Samsonite <strong>in</strong> cui c'era <strong>un</strong> complicato<br />
meccanismo con <strong>un</strong>a parte <strong>in</strong> metallo montata sul coperchio che si deve <strong>in</strong>castrare con quella<br />
montata sull'altro guscio…<strong>in</strong>vece qui il p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> fissaggio del gancio è già pre<strong>di</strong>sposto nella<br />
struttura del guscio, non c'è montaggio, non ci sono parti aggi<strong>un</strong>tive..<br />
A parte, com<strong>un</strong>que, il suo elevato livello <strong>di</strong> <strong>in</strong>novatività tecnica, che probabilmente solo <strong>un</strong>a<br />
piccola parte del pubblico è <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> apprezzare appieno, le ragioni del grande successo <strong>di</strong> Oyster<br />
vanno forse ricercate anche altrove. Poiché <strong>in</strong>fatti a tutt'oggi Oyster costituisce il prodotto più<br />
rappresentativo <strong>di</strong> Samsonite, e poiché si può <strong>di</strong>re che è <strong>di</strong>ventata <strong>un</strong>o degli oggetti cult del design<br />
<strong>in</strong>dustriale <strong>di</strong> f<strong>in</strong>e XX secolo (affiancabile probabilmente ad oggetti, come per esempio, la<br />
caffettiera Alessi) si può ipotizzare che i motivi del suo successo vadano al <strong>di</strong> là del solo aspetto<br />
tecnico-f<strong>un</strong>zionale. Quando <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> <strong>di</strong>venta cult significa, <strong>in</strong> genere, che esso è riuscito meglio<br />
<strong>di</strong> altri a <strong>in</strong>carnare <strong>un</strong> certo 'spirito dei tempi', cioè <strong>un</strong> misto <strong>di</strong> gusto, stile <strong>di</strong> vita, bisogni, ma anche<br />
i desideri e i sogni <strong>di</strong> <strong>un</strong> grande fascia <strong>di</strong> utilizzatori.<br />
In primo luogo vale la pena sottol<strong>in</strong>eare che nel periodo <strong>in</strong> cui Oyster arriva sul mercato è <strong>in</strong> atto<br />
<strong>un</strong> processo <strong>di</strong> 'sdrammatizzazione' del <strong>viaggio</strong>, che da attività straord<strong>in</strong>aria e riservata ad <strong>un</strong> élite,<br />
<strong>di</strong>venta <strong>un</strong>a pratica <strong>di</strong>ffusa e frequente per gran<strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> popolazione. <strong>La</strong> scelta della forma, meno<br />
razionale e meno squadrata del solito, e soprattutto i colori vivaci con cui viene presentata<br />
contrastano con l'idea <strong>di</strong> <strong>valigia</strong> come <strong>oggetto</strong> grigio e severo che aveva dom<strong>in</strong>ato il mercato f<strong>in</strong>o ad<br />
allora.<br />
Non era più la solita <strong>valigia</strong>, era qualcosa <strong>di</strong> più, qualcosa <strong>di</strong> più vic<strong>in</strong>o dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista<br />
emozionale, che è molto importante perché la <strong>valigia</strong> ha senza dubbio <strong>un</strong> contenuto<br />
emozionalmente forte. Nella <strong>valigia</strong> si mettono i propri averi, le proprie cose, gli si affida quello che<br />
abbiamo <strong>di</strong> più caro…qu<strong>in</strong><strong>di</strong> la <strong>valigia</strong> deve dare rassicurazione…nel caso <strong>di</strong> Oyster la<br />
rassicurazione <strong>di</strong>venta ad<strong>di</strong>rittura simpatica…è come la casa dove si vive, la casa dove fa piacere<br />
stare<br />
Se poi la si considera dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista più tecnico, osservandola sullo sfondo dell'evoluzione<br />
della moda nel design, si comprende come, anche da questo p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, Oyster <strong>in</strong>carni il gusto<br />
del tempo che tende <strong>in</strong> quel periodo (e ancora oggi) a privilegiare le forme essenziali, pulite e senza<br />
fronzoli. A questo proposito è significativo il fatto che, alc<strong>un</strong>i anni prima del lancio della Oyster,<br />
alc<strong>un</strong>i architetti milanesi avessero stu<strong>di</strong>ato, per Samsonite Italia, <strong>un</strong> modello mai realizzato <strong>di</strong><br />
<strong>valigia</strong> che aveva molte caratteristiche <strong>in</strong> com<strong>un</strong>e con Oyster. Ci racconta <strong>un</strong>o degli autori <strong>di</strong> questo<br />
progetto:<br />
Potrei sovrapporre al ricordo della Oyster il ricordo <strong>di</strong> <strong>un</strong> progetto <strong>di</strong> massima, poi mai portato<br />
avanti, <strong>di</strong> <strong>un</strong>a <strong>valigia</strong> <strong>in</strong> polipropilene, come la Oyster, che prevedeva proprio per la prima volta,<br />
11
almeno <strong>in</strong> Samsonite, la <strong>di</strong>visione tra coperchio e contenitore…Il nostro progetto si è fermato lì,<br />
perché non c'era <strong>in</strong>teresse a portarlo a buon f<strong>in</strong>e, però con grande sod<strong>di</strong>sfazione si constatò che<br />
anche a Londra, lo stu<strong>di</strong>o che aveva <strong>in</strong> mano la Oyster portò avanti questo <strong>di</strong>scorso….<br />
L'aspetto <strong>in</strong>teressante <strong>di</strong> questa vicenda sta nel fatto che non ci furono mai contatti <strong>di</strong>retti tra lo<br />
stu<strong>di</strong>o milanese e quello <strong>in</strong>glese <strong>in</strong> cui venne <strong>di</strong>segnata la Oyster, anche se il prototipo italiano era<br />
stato effettivamente <strong>in</strong>viato <strong>in</strong> Belgio. Ce lo conferma la designer italiana che aveva lavorato al<br />
progetto:<br />
In realtà noi non abbiamo collaborato, il nostro <strong>di</strong>scorso non aveva <strong>un</strong> f<strong>in</strong>e, era solo l'<strong>in</strong>seguire<br />
<strong>un</strong>'idea, <strong>di</strong>re questa cosa ci sembra <strong>in</strong>teressante e <strong>di</strong>vertente…è stato mandato <strong>in</strong> Belgio, non<br />
sappiamo quanto poi il Belgio abbia elaborato su questa <strong>in</strong><strong>di</strong>cazione o, come succede spessissimo <strong>in</strong><br />
fasi progettuali, poi ritrovarsi con dei p<strong>un</strong>ti <strong>di</strong> partenza o dei p<strong>un</strong>ti <strong>di</strong> arrivo che sono molto<br />
simili….<strong>in</strong> realtà il designer risente delle tendenze della società che ci circonda e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> può essere<br />
<strong>un</strong> puro caso che si sia arrivati a def<strong>in</strong>ire delle cose che si somigliassero non tanto nel f<strong>in</strong>ale quanto<br />
nelle scelte fatte <strong>in</strong> partenza<br />
Questo <strong>in</strong>tervento è molto <strong>in</strong>teressante dal nostro p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista poiché sembra alludere al fatto<br />
che le mode, nel design, così come nell'abbigliamento, non siano dei flussi arbitrari, ma che al<br />
contrario siano ispirati da qualcosa che esiste nella società e che viene colto da certe persone prima<br />
che dalle altre. Ma che cosa sia questo 'qualcosa', dove e come si manifest<strong>in</strong>o questi sentori nella<br />
società, <strong>di</strong> cui l'architetto ci parla e che poi sfociano <strong>in</strong> nuove forme <strong>di</strong> moda, cont<strong>in</strong>ua a rimanere<br />
<strong>un</strong> mistero. Si tratta naturalmente <strong>in</strong> buona parte <strong>di</strong> tendenze del gusto a cui però il tessuto sociale e<br />
gli stili <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> <strong>un</strong>a com<strong>un</strong>ità contribuiscono <strong>in</strong> modo notevole.<br />
Questo <strong>di</strong>scorso viene fuori molto spesso - cont<strong>in</strong>ua la designer, quando le chie<strong>di</strong>amo chiarimenti su<br />
questo p<strong>un</strong>to -; molto spesso anche noi stessi che lavoriamo <strong>in</strong>torno a qualcosa ci chie<strong>di</strong>amo il<br />
perché, improvvisamente, da tutti i lati nascano forma, colori, profon<strong>di</strong>tà delle materie che sono<br />
<strong>di</strong>verse, estremamente contrastanti col passato, oppure che delimitano <strong>un</strong> percorso <strong>di</strong> variazione <strong>di</strong><br />
cose già esistenti…potrei <strong>di</strong>re che è <strong>un</strong> mistero, <strong>in</strong> realtà è <strong>un</strong> <strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> <strong>in</strong>f<strong>in</strong>ite cose…..che vanno<br />
dall'andamento <strong>di</strong> <strong>un</strong>a società <strong>in</strong> tutti i sensi, politico, economico, sociale, che con<strong>di</strong>ziona<br />
moltissimo…..ma questo già la storia lo <strong>in</strong>segna: an<strong>di</strong>amo da epoche estremamente ricche, decorate<br />
ad epoche estremamente povere, m<strong>in</strong>imaliste…..sono percorsi……anche dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista del<br />
gusto, Oyster ben <strong>in</strong>terpreta le tendenze del proprio tempo che è <strong>un</strong> periodo <strong>in</strong> cui si va a fare <strong>un</strong>a<br />
certa pulizia <strong>di</strong> tutto quello che circonda, pulizia nel senso <strong>di</strong> rifiuto della decorazione per arrivare a<br />
qualcosa <strong>di</strong> più sobrio, l<strong>in</strong>eare e che suggerisce <strong>un</strong>'imme<strong>di</strong>atezza d'uso.<br />
Da questo p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista il successo <strong>di</strong> Oyster può essere <strong>in</strong>terpretato come <strong>un</strong> evento che<br />
conferma quella che alc<strong>un</strong>i stu<strong>di</strong>osi <strong>di</strong> cultural stu<strong>di</strong>es hanno <strong>in</strong><strong>di</strong>viduato come la tendenza<br />
all'estetizzazione della vita quoti<strong>di</strong>ana, <strong>in</strong> base alla quale anche gli oggetti che hanno <strong>un</strong> valore<br />
em<strong>in</strong>entemente f<strong>un</strong>zionale devono <strong>in</strong>carnare elevati livelli <strong>di</strong> qualità estetica. In altre parole, anche<br />
quando acquistano oggetti f<strong>un</strong>zionali, come la <strong>valigia</strong>, i consumatori non si concentrano<br />
esclusivamente sui loro requisiti tecnici; al contrario <strong>in</strong> misura maggiore anche solo <strong>di</strong> c<strong>in</strong>quant'anni<br />
fa, essi sono molto sensibili all'estetica e tendono a privilegiare prodotti che siano, oltre che<br />
f<strong>un</strong>zionali, anche gradevoli per la forma 11 .<br />
11 Tale tendenza all'estetizzazione, che pare proprio costituire <strong>un</strong>a caratteristica evidente delle pratiche <strong>di</strong> consumo<br />
contemporanee, ha suscitato l'<strong>in</strong>teresse <strong>di</strong> molti stu<strong>di</strong>osi e <strong>in</strong>terpreti della società contemporanea tra cui <strong>un</strong>o dei più<br />
importanti è sicuramente Mike Featherstone. Occupandosi espressamente <strong>di</strong> questo tema egli suggerisce <strong>in</strong> <strong>un</strong> suo<br />
recente testo che tale estetizzazione è <strong>un</strong>a conseguenza «del desiderio <strong>di</strong> cont<strong>in</strong>uare ad imparare e <strong>di</strong> arricchire se stessi,<br />
<strong>di</strong> perseguire nuovi valori e nuovi vocabolari…..» (1991: 48).<br />
12
Infatti <strong>un</strong>a delle caratteristiche per cui Oyster viene spesso riconosciuta e apprezzata dal pubblico<br />
è data dalla vasta gamma <strong>di</strong> colori con cui è presente sul mercato. A <strong>di</strong>fferenza dei prodotti che<br />
l'hanno preceduta, tutti progettati e realizzati negli Stati Uniti <strong>in</strong> pochi colori tra<strong>di</strong>zionali (nero,<br />
grigio, marrone), Oyster viene f<strong>in</strong> dall'<strong>in</strong>izio prodotta <strong>in</strong> molte varianti cromatiche. Tale tendenza<br />
del mercato americano a non sperimentare con colori <strong>in</strong>novativi era dovuta, secondo il designer <strong>di</strong><br />
Oyster, al fatto che il <strong>di</strong>segno <strong>in</strong>dustriale americano è molto più <strong>di</strong>pendente dalle ricerche <strong>di</strong><br />
mercato <strong>di</strong> quanto lo sia quello europeo:<br />
era tra<strong>di</strong>zione americana fare parecchia ricerca <strong>di</strong> mercato che poi veniva usata nella progettazione<br />
e questo portava il design su <strong>un</strong>a strada piuttosto convenzionale e a risultati piuttosto convenzionali.<br />
E <strong>un</strong>a cosa strana era che, per far <strong>di</strong>menticare alla gente il colore o per elim<strong>in</strong>are la variabile colore<br />
dal modo <strong>in</strong> cui la gente percepiva il design, a quei tempi il loro approccio era <strong>di</strong> fare ricerca<br />
soltanto su valigie nere. Poi usavano molto il cromo per le f<strong>in</strong>iture e ovviamente il cromo stava bene<br />
con il nero, però aveva <strong>un</strong> look proprio americano….noi <strong>in</strong>vece, come europei, pensavamo che il<br />
cromo stesse passando <strong>di</strong> moda, com<strong>in</strong>ciava <strong>in</strong> quel periodo a scomparire nei prodotti <strong>di</strong> consumo.<br />
Con il modello Oyster vengono <strong>in</strong>fatti <strong>in</strong>trodotti, accanto ai classici nero e grigio anche delle<br />
colorazioni del tutto nuove come lo 'space blue' e poi, su esplicita richiesta della clientela italiana,<br />
<strong>un</strong> fiammante 'rosso Ferrari' 12 .<br />
Secondo la designer italiana, che a sua volta accenna all'elemento colore come ad <strong>un</strong>a delle<br />
caratteristiche v<strong>in</strong>centi <strong>di</strong> Oyster, la componente cromatica <strong>di</strong>st<strong>in</strong>gue questo modello <strong>di</strong> <strong>valigia</strong> dagli<br />
altri, mentre la possibilità <strong>di</strong> scegliere tra <strong>un</strong>a gamma molto vasta rende Oyster adatta a molti tipi<br />
<strong>di</strong>versi <strong>di</strong> consumatore;<br />
Il colore nella Oyster, forse più che <strong>in</strong> altre valigie è stato ed è tuttora <strong>un</strong>a carta da giocare. Quando<br />
si vuole r<strong>in</strong>novare la Oyster si parte con i colori, si decide come mischiarli o come renderli tutti<br />
uguali, come contrastarli con colori <strong>di</strong>versi per mo<strong>di</strong>ficarla…viene utilizzato il colore per dare alla<br />
Oyster <strong>un</strong>'immag<strong>in</strong>e totalmente <strong>di</strong>versa e qu<strong>in</strong><strong>di</strong> anche <strong>un</strong> fruitore <strong>di</strong>verso, <strong>un</strong> consumatore con età<br />
o con stile <strong>di</strong> vita <strong>di</strong>verso dall'<strong>un</strong>a all'altra, quando poi <strong>in</strong> realtà la <strong>valigia</strong> è sempre la stessa..<br />
4.2. Com<strong>un</strong>icare la Oyster<br />
Nella seconda metà degli anni Ottanta, quando Oyster è lanciata sul mercato europeo, essa<br />
rappresenta per molti versi l'avanguar<strong>di</strong>a nel mercato delle valigie. Innanzitutto compare <strong>in</strong> <strong>un</strong><br />
periodo <strong>in</strong> cui si stanno realizzando ra<strong>di</strong>cali mutamenti nel modo <strong>di</strong> viaggiare: il <strong>viaggio</strong> aereo, per<br />
l<strong>un</strong>go tempo riservato soltanto ad <strong>un</strong>a élite <strong>di</strong> classi abbienti, <strong>di</strong>venta accessibile a tutti (o quasi);<br />
cambia anche lo stile <strong>di</strong> vacanza e i tour operator propongono sempre più spesso viaggi <strong>in</strong> località<br />
esotiche; parallelamente le prime avvisaglie del processo <strong>di</strong> globalizzazione economica fanno<br />
aumentare anche il volume dei viaggi <strong>di</strong> lavoro e d'affari. In breve il <strong>viaggio</strong> e soprattutto il <strong>viaggio</strong><br />
<strong>in</strong> aereo per cui la <strong>valigia</strong> rigida è appositamente stu<strong>di</strong>ata, cessa <strong>di</strong> essere, almeno per la<br />
maggioranza delle persone, <strong>un</strong> evento eccezionale, trasformandosi, per alc<strong>un</strong>i, quasi nel suo<br />
contrario e cioè <strong>un</strong> evento pressoché quoti<strong>di</strong>ano o settimanale.<br />
Il forte legame tra Oyster e la r<strong>in</strong>novata concezione del <strong>viaggio</strong> fornisce l'idea guida per i<br />
professionisti che, all'<strong>in</strong>terno <strong>di</strong> Samsonite, hanno il compito <strong>di</strong> elaborare le strategie <strong>di</strong><br />
com<strong>un</strong>icazione per il nuovo prodotto. Il tema del parallelismo tra il nuovo modo <strong>di</strong> viaggiare e il<br />
nuovo prodotto, da <strong>un</strong> lato, e l'esigenza, dall'altro, <strong>di</strong> riba<strong>di</strong>re gli standard <strong>di</strong> qualità già associati al<br />
12 Un particolare <strong>in</strong>teressante riguarda il contrasto cromatico, presente <strong>in</strong> molti modelli, tra il sigillo <strong>di</strong> gomma tra i due<br />
gusci e i gusci stessi. Si tratta <strong>di</strong> <strong>un</strong> altro particolare estetico che fu <strong>in</strong> orig<strong>in</strong>e determ<strong>in</strong>ato da <strong>un</strong>a ragione tecnica; <strong>in</strong>fatti<br />
nel periodo <strong>in</strong>iziale, il tipo <strong>di</strong> gomma che occorreva per il sigillo veniva prodotto soltanto <strong>in</strong> nero che contrastava così<br />
con il colore della <strong>valigia</strong>. In seguito il sigillo <strong>di</strong> gomma venne prodotto anche <strong>in</strong> altri colori.<br />
13
marchio Samsonite con il successo dei prodotti precedenti forniscono le coord<strong>in</strong>ate <strong>di</strong> base cui si è<br />
ispirata l'elaborazione della campagna <strong>di</strong> com<strong>un</strong>icazione su Oyster realizzata al momento della sua<br />
prima comparsa sul mercato. I due temi emergono <strong>in</strong>fatti chiaramente nell'<strong>in</strong>teressante <strong>in</strong>tervista<br />
con l'allora <strong>di</strong>rettrice della com<strong>un</strong>icazione <strong>di</strong> Samsonite Europe:<br />
Prima <strong>di</strong> allora la gente usava viaggiare con valigie tra<strong>di</strong>zionali, morbide, valigie artigianali, fatte <strong>di</strong><br />
cuoio o <strong>di</strong> v<strong>in</strong>ile…Solo la gente ricca poteva permettersi <strong>di</strong> viaggiare e loro compravano valigie<br />
molto care…ma nel momento <strong>in</strong> cui viaggiare <strong>in</strong>com<strong>in</strong>cia a <strong>di</strong>ventare parte della vita…Come scrissi<br />
allora nel profilo, noi siamo oggi i nuovi noma<strong>di</strong>. Il bagaglio è parte della vita quoti<strong>di</strong>ana. Qu<strong>in</strong><strong>di</strong> si<br />
prospettava per Samsonite <strong>un</strong> compito <strong>di</strong>fficile: <strong>di</strong>re ai consumatori che le abitud<strong>in</strong>i <strong>di</strong> <strong>viaggio</strong> erano<br />
cambiate, gli aerei erano <strong>di</strong>ventati così importanti e d<strong>un</strong>que sia l'aspetto sia i criteri delle valigie<br />
avevano dovuto essere adattati ai nuovi mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> viaggiare, soprattutto alla necessità <strong>di</strong> maneggiarle<br />
<strong>in</strong> aeroporto.<br />
Se da <strong>un</strong> lato occorreva d<strong>un</strong>que sottol<strong>in</strong>eare l'<strong>in</strong>novatività del prodotto, dall'altro era necessario<br />
riba<strong>di</strong>re che Oyster possedeva caratteristiche <strong>di</strong> cont<strong>in</strong>uità con il resto della produzione Samsonite:<br />
<strong>in</strong> particolare che possedeva quelle caratteristiche che avevano già determ<strong>in</strong>ato il successo<br />
<strong>in</strong>ternazionale <strong>di</strong> Samsonite: l'affidabilità e la resistenza.<br />
Nelle campagne pubblicitarie abbiamo sempre messo <strong>in</strong> primo piano la resistenza del prodotto e<br />
abbiamo anche cercato <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrarla negli spot evitando però <strong>di</strong> mostrare la <strong>valigia</strong> <strong>in</strong> scene reali,<br />
<strong>di</strong> vita quoti<strong>di</strong>ana, ma sempre associandola a situazioni <strong>di</strong> vacanza, esotiche, piacevoli…soprattutto<br />
perché nella vita reale tutto ciò che è associato alle valigie è negativo: la gente o<strong>di</strong>a fare le valigie,<br />
trasportarle, abbandonarle al check-<strong>in</strong> sperando <strong>di</strong> rivederle dall'altra parte del mondo, quell'<strong>oggetto</strong><br />
che <strong>in</strong> quel momento contiene tutta la loro vita, tutte le loro cose… per questo è importante<br />
sottol<strong>in</strong>eare la protezione e la resistenza…<br />
Il brief consegnato dall'azienda a partire da idee chiave fu poi tradotto creativamente all'esterno<br />
<strong>di</strong> Samsonite <strong>in</strong> <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> campagne giornalistiche e televisive che fecero il giro d'Europa.<br />
Soltanto <strong>in</strong> Italia, a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> circa <strong>un</strong> anno dalla comparsa della prima pubblicità stu<strong>di</strong>ata sulla<br />
Oyster 13 , il management chiede ed ottiene <strong>di</strong> gestire <strong>in</strong> proprio la com<strong>un</strong>icazione del prodotto <strong>in</strong><br />
Italia. Anche <strong>in</strong> questo caso il brief stu<strong>di</strong>ato <strong>in</strong> azienda è affidato per la realizzazione artistica a<br />
creativi <strong>in</strong>card<strong>in</strong>ati <strong>in</strong> <strong>un</strong>'agenzia esterna. <strong>La</strong> prima campagna realizzata specificamente per il<br />
pubblico italiano risale al 1988/89 e viene <strong>di</strong>ffusa su tutti i maggiori quoti<strong>di</strong>ani e perio<strong>di</strong>ci<br />
d'op<strong>in</strong>ione con messaggi a tutta pag<strong>in</strong>a. Si tratta <strong>di</strong> <strong>un</strong>a campagna piuttosto «sofisticata» (almeno<br />
così la def<strong>in</strong>isce il suo creatore che ho <strong>in</strong>tervistato) che, analogamente alla pubblicità europea,<br />
sottol<strong>in</strong>eava soprattutto la resistenza della <strong>valigia</strong> attraverso il paradosso <strong>di</strong> mostrare due Oyster<br />
assolutamente identiche, <strong>un</strong>a usata e l'altra nuova, senza che visivamente si riuscisse a percepire<br />
alc<strong>un</strong>a <strong>di</strong>fferenza. Il testo posto <strong>in</strong> calce all'immag<strong>in</strong>e delle valigie recitava: "<strong>La</strong> Samsonite a destra<br />
è nuova, anzi no, è quella <strong>di</strong> s<strong>in</strong>istra la nuova. O forse no. Allora, quella <strong>di</strong> s<strong>in</strong>istra è nuova, quella<br />
<strong>di</strong> destra è usata. Però forse è quella <strong>di</strong> destra ad essere nuova. Sì, sì, sì, sì quella <strong>di</strong> destra è nuova e<br />
qu<strong>in</strong><strong>di</strong> quella <strong>di</strong> s<strong>in</strong>istra è usata. O….oppure…od<strong>di</strong>o! Come si fa a <strong>di</strong>st<strong>in</strong>guere <strong>un</strong>a Samsonite usata<br />
da <strong>un</strong>a nuova?". Il creativo commenta così questa pubblicità:<br />
Era <strong>un</strong>a pubblicità rivolta ad <strong>un</strong> viaggiatore colto, <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> percepire lo humour, <strong>in</strong> grado <strong>di</strong><br />
percepire il messaggio celato <strong>di</strong>etro <strong>un</strong>a com<strong>un</strong>icazione fredda ed elegante. Era <strong>un</strong>a barzelletta, <strong>un</strong><br />
13 È <strong>in</strong>teressante notare che Samsonite non realizza mai campagne specifiche per ogni prodotto o l<strong>in</strong>ea <strong>di</strong> prodotto; al<br />
contrario l'azienda pubblicizza l'<strong>in</strong>tera gamma dei suoi prodotti utilizzando <strong>in</strong> ogni periodo il modello che è considerato<br />
più significativo e perciò più adatto a rappresentare le qualità positive <strong>di</strong> tutti i prodotti Samsonite. Oyster è stata scelta<br />
come <strong>oggetto</strong> simbolo <strong>in</strong> <strong>di</strong>verse annate consecutive tra la f<strong>in</strong>e degli anni Ottanta e l'<strong>in</strong>izio del decennio successivo.<br />
14
nonsense, <strong>un</strong>a caricatura della pubblicità che <strong>di</strong>ceva "il mio lava più bianco"…..è <strong>un</strong>a delle mie<br />
campagne preferite <strong>in</strong> quanto bilanciava bene tutto ciò che poteva essere veicolato.<br />
Il creativo ritiene <strong>in</strong>fatti che questa pubblicità risultò determ<strong>in</strong>ante nel creare il posizionamento<br />
elevato che il prodotto acquisì nel mercato italiano e contribuì a trasformare la Oyster <strong>in</strong> <strong>un</strong> vero e<br />
proprio simbolo <strong>di</strong> status e questo obiettivo sarebbe stato raggi<strong>un</strong>to anche grazie allo stile sobrio e<br />
<strong>un</strong> po' <strong>di</strong>staccato della campagna pubblicitaria.<br />
Questo prodotto è stato lanciato negli anni Ottanta, nel pieno degli anni <strong>di</strong> plastica, nel boom della<br />
ricerca degli status….qu<strong>in</strong><strong>di</strong> doveva assolvere sia a f<strong>un</strong>zioni pratiche (<strong>in</strong> questi anni gli italiani<br />
stanno <strong>di</strong>ventando i più gran<strong>di</strong> viaggiatori d'Europa), sia costruire al marchio <strong>un</strong>'aura <strong>di</strong> status<br />
symbol che era estremamente importante.<br />
Dopo circa <strong>un</strong> anno e mezzo <strong>di</strong> questa campagna il management decide <strong>di</strong> <strong>in</strong>serire delle<br />
mo<strong>di</strong>fiche nella com<strong>un</strong>icazione <strong>di</strong> Oyster sia dal p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista dei me<strong>di</strong>a strategici, sia per quanto<br />
riguarda il tono del messaggio. Viene d<strong>un</strong>que richiesto, sempre agli stessi copy writer, <strong>di</strong> realizzare<br />
<strong>un</strong>a campagna più calda, che allargasse le possibilità <strong>di</strong> assimilazione del messaggio. Da qui nasce<br />
la seconda serie <strong>di</strong> pubblicità comparse anche <strong>in</strong> televisione, che mostrano <strong>un</strong>a Oyster (<strong>di</strong> solito<br />
rossa) e <strong>un</strong> bamb<strong>in</strong>o piccolo <strong>in</strong>tento a scalarla con la voce narrativa <strong>di</strong> sfondo che <strong>di</strong>ce: "tra qualche<br />
anno lui sarà molto <strong>di</strong>verso, ma la <strong>valigia</strong> sarà sempre la stessa….Samsonite, le belle valigie che<br />
durano".<br />
Durante il colloquio il creativo riba<strong>di</strong>sce più volte che la seconda campagna fu creata <strong>in</strong> <strong>un</strong>o<br />
spirito <strong>di</strong> cont<strong>in</strong>uità con la prima, sia pur r<strong>in</strong><strong>un</strong>ciando ad <strong>un</strong> po' <strong>di</strong> ricercatezza e <strong>di</strong> humour, ma <strong>di</strong><br />
fatto mantenendosi coerenti con lo spirito <strong>in</strong>iziale:<br />
il bamb<strong>in</strong>o <strong>in</strong>trodotto nella pubblicità è <strong>un</strong> simbolo, <strong>un</strong> gancio; <strong>in</strong>fatti è mostrato asetticamente non<br />
nella sua cameretta, ma su <strong>un</strong>o sfondo neutro da laboratorio e soprattutto non <strong>in</strong>serito nella solita<br />
storiella f<strong>in</strong>ta della réclame, dove nove volte su <strong>di</strong>eci si vede <strong>un</strong>a storia falsa con protagonisti falsi<br />
<strong>in</strong> contesti che non esistono. Cioè il target che ci eravamo conquistati con la prima pubblicità<br />
doveva restare lo stesso, dovevamo solo allargarlo senza perderlo…<br />
Tuttavia risulta anche chiaro dalle sue parole come egli giu<strong>di</strong>chi negativamente l'esplicito<br />
richiamo al fattore estetico contenuto nello slogan "le belle valigie che durano", peraltro già<br />
presente nella prima sotto forma <strong>di</strong> m<strong>in</strong>uta base-l<strong>in</strong>e e nella campagna successiva messo <strong>in</strong><br />
maggiore evidenza da <strong>un</strong> corpo più grande e soprattutto dalla voce fuori campo dello spot<br />
televisivo.<br />
Con quel "belle" si voleva proprio sottol<strong>in</strong>eare l'aspetto estetico…io però non avrei mai usato quel<br />
term<strong>in</strong>e, fu il cliente a metterci lo zamp<strong>in</strong>o, siamo stati obbligati a farlo, ma alla f<strong>in</strong>e, si sa, la<br />
com<strong>un</strong>icazione è piena <strong>di</strong> compromessi…<br />
Così adesso Oyster non è più lo status symbol, ma <strong>in</strong>vece il prodotto che fa i volumi, mentre è<br />
Epsylon l'apice della piramide.<br />
<strong>La</strong> presenza <strong>di</strong> microcircolarità caratterizza qu<strong>in</strong><strong>di</strong> anche la fase com<strong>un</strong>icativa della traiettoria<br />
seguita dall'<strong>oggetto</strong> <strong>valigia</strong> nel suo procedere sul cont<strong>in</strong>uum schematizzato da Hirsch. Dall'analisi<br />
dell'<strong>in</strong>terfaccia tra la produzione/<strong>di</strong>stribuzione e la com<strong>un</strong>icazione <strong>di</strong> Oyster è <strong>in</strong>fatti emersa<br />
l'esistenza <strong>di</strong> reciproche <strong>in</strong>fluenze tra produttori e com<strong>un</strong>icatori; nelle reti operative da loro<br />
costituite, i <strong>di</strong>versi significati attribuiti all'<strong>oggetto</strong> da rappresentanti <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse culture professionali<br />
vengono me<strong>di</strong>ati e <strong>in</strong>corporati nel prodotto concorrendo a formare il suo valore f<strong>in</strong>ale.<br />
4.3. <strong>La</strong> Oyster come <strong>oggetto</strong> <strong>di</strong> consumo<br />
15
L'ultima fase della ricerca è stata poi de<strong>di</strong>cata a considerare l'ultimo sta<strong>di</strong>o dello schema <strong>di</strong><br />
Hirsch, cioè quello co<strong>in</strong>cidente con il consumo del prodotto Oyster. Anche <strong>in</strong> questa fase il nostro<br />
approccio si qualifica come specificamente <strong>culturale</strong>: raccogliendo le testimonianze <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i<br />
consumatori <strong>in</strong>tervistati <strong>in</strong> due gruppi (il primo composto da studenti <strong>un</strong>iversitari <strong>di</strong> età compresa<br />
tra i 18 e i 24 anni, il secondo da adulti tra i 25 e i 55) abbiamo <strong>in</strong>fatti cercato <strong>di</strong> mostrare come <strong>un</strong><br />
particolare artefatto materiale (<strong>in</strong> questo caso la Oyster) possa essere utilizzato dalle persone per<br />
creare dei significati all'<strong>in</strong>terno del normale svolgimento della loro vita quoti<strong>di</strong>ana. In altre parole,<br />
analizzare il consumo <strong>di</strong> Oyster era importante dal nostro p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> vista, non per fornire dei dati <strong>di</strong><br />
scenario sul consumo <strong>di</strong> questo <strong>oggetto</strong> <strong>in</strong> <strong>un</strong>a determ<strong>in</strong>ata area, bensì per capire e per mettere <strong>in</strong><br />
evidenza come i significati degli oggetti della cultura materiale non siano semplicemente creati dai<br />
produttori (magari con la collaborazione dei pubblicitari) e ricevuti e subiti dai consumatori, ma<br />
come al contrario alc<strong>un</strong>i <strong>di</strong> questi significati siano sempre creati anche durante l'uso. È proprio a<br />
partire da questi ultimi che si genera quel flusso <strong>di</strong> feed back rappresentato nello schema <strong>di</strong> Hirsch<br />
come <strong>un</strong>a freccia che dai consumatori risale prima verso i com<strong>un</strong>icatori e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e torna ai produttori e<br />
che qu<strong>in</strong><strong>di</strong> produce la circolarità <strong>di</strong> cui parlavamo nello spiegare le ipotesi del nostro lavoro.<br />
Infatti <strong>un</strong>o dei risultati più <strong>in</strong>teressanti dei focus group è costituito dalla <strong>di</strong>screpanza tra il<br />
significato che i giovani assegnano all'<strong>oggetto</strong> <strong>valigia</strong>-rigida (compresa Oyster) e le strategie <strong>di</strong><br />
market<strong>in</strong>g che l'azienda sta da alc<strong>un</strong>i anni mettendo <strong>in</strong> atto sul prodotto Oyster. Dalle <strong>in</strong>terviste<br />
realizzate con il personale <strong>di</strong> market<strong>in</strong>g era <strong>in</strong>fatti apparso ben chiaro il tipo <strong>di</strong> posizionamento che<br />
essi ritengono attuale per Oyster:<br />
Anche se vende ancora molto - ci <strong>di</strong>ce la responsabile del market<strong>in</strong>g <strong>di</strong> Samsonite Europe - Oyster è<br />
ormai <strong>un</strong> prodotto vecchio, superato dagli altri modelli più recenti…siccome però ha <strong>un</strong> prezzo<br />
relativamente basso va ancora molto tra i giovani e <strong>in</strong>fatti tutta la nostra strategia <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, le<br />
promozioni che facciamo ogni anno su Oyster hanno chiaramente <strong>un</strong> target giovanile..<br />
E con lei concorda anche il responsabile della com<strong>un</strong>icazione <strong>in</strong> Italia, che afferma:<br />
il target <strong>di</strong> Oyster è cambiato negli ultimi anni. Oggi la Oyster, per come la stiamo posizionando<br />
noi, dovrebbe avere <strong>un</strong> target giovane. questo <strong>di</strong>pende da tutta <strong>un</strong>a serie <strong>di</strong> fattori, non ultimo il<br />
prezzo. Perché la Oyster ormai nella mostra architettura <strong>di</strong> prodotto è collocata nella fascia più<br />
bassa, perché sono entrati altri prodotti più complicati, con più f<strong>un</strong>zioni, più belli, che chiaramente<br />
costano <strong>di</strong> più. Qu<strong>in</strong><strong>di</strong> sicuramente Oyster nei nostri programmi oggi dovrebbe essere la prima<br />
<strong>valigia</strong> rigida che <strong>un</strong> giovane si compra, con cui fa il primo <strong>viaggio</strong> <strong>di</strong> vacanza <strong>in</strong> aereo. Questo è<br />
oggi. All'epoca (quando fu lanciata) no, sicuramente allora il target <strong>di</strong> Oyster era più adulto, era la<br />
<strong>valigia</strong> "status symbol", la prima <strong>in</strong> polipropilene, con <strong>un</strong> <strong>di</strong>segno assolutamente nuovo per i<br />
tempi…<br />
Invece i giovani che ho <strong>in</strong>tervistato, pur <strong>di</strong>mostrando <strong>di</strong> avere poca consapevolezza della<br />
<strong>di</strong>st<strong>in</strong>zione tra Oyster e gli altri modelli, <strong>di</strong>chiarano com<strong>un</strong>que <strong>di</strong> avere poca s<strong>in</strong>tonia con la<br />
categoria '<strong>valigia</strong> rigida', <strong>un</strong> articolo che considerano poco adatto non tanto ai loro gusti, ma<br />
piuttosto al loro stile <strong>di</strong> vita e al loro modo <strong>di</strong> viaggiare. Quasi tutti <strong>di</strong>chiarano <strong>di</strong> preferire, per<br />
qualsiasi <strong>viaggio</strong>, l'uso <strong>di</strong> borsoni più economici e più facili da maneggiare:<br />
mi è capitato <strong>un</strong>a volta <strong>di</strong> fare <strong>un</strong> <strong>viaggio</strong> con tanti cambi e avevo la <strong>valigia</strong> rigida dei miei…anche<br />
a portarla per due m<strong>in</strong>uti impazzisci, ti vengono i calli alle mani….e poi per la <strong>valigia</strong> rigida devi<br />
sempre trovare <strong>un</strong> posto, la sacca <strong>in</strong>vece la puoi cacciare dove vuoi…<br />
16
Dagli <strong>in</strong>terventi <strong>di</strong> alc<strong>un</strong>i <strong>di</strong> loro si percepisce ad<strong>di</strong>rittura che, al <strong>di</strong> là della scarsa praticità, la<br />
<strong>valigia</strong> rigida viene considerata anche <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> per loro 'fuori età' cioè stu<strong>di</strong>ato per persone più<br />
gran<strong>di</strong>, con altre esigenze e con altri look:<br />
la <strong>valigia</strong> rigida, costosa fa pensare ad <strong>un</strong>a persona ricca, più su…io penso che le persone più gran<strong>di</strong><br />
sono e più tendono ad usare la <strong>valigia</strong> rigida, mentre più giovani sono e più tendono ad usare le<br />
sacche…<strong>in</strong> aeroporto io vedo che la maggior parte delle persone anziane hanno la <strong>valigia</strong> rigida,<br />
mentre per i giovani è raro…<br />
Anche nel gruppo degli adulti c'è <strong>un</strong>a certa <strong>di</strong>fficoltà a mantenere il <strong>di</strong>scorso sul modello Oyster,<br />
mentre tutti tendono a riferirsi più che altro alla <strong>valigia</strong> rigida <strong>in</strong> genere. A <strong>di</strong>fferenza dei giovani,<br />
però, gli <strong>in</strong>tervistati vedono nella <strong>valigia</strong> rigida <strong>un</strong> <strong>oggetto</strong> importante e, <strong>in</strong> certe circostanze per<br />
esempio quando si viaggia per lavoro, ad<strong>di</strong>rittura <strong>in</strong><strong>di</strong>spensabile:<br />
è solo grazie alla <strong>valigia</strong> rigida che <strong>un</strong>o che è <strong>in</strong> giro per lavoro riesce a conservare gli abiti <strong>in</strong><br />
maniera decente….la scelta della rigida è proprio dovuta alla possibilità <strong>di</strong> conservare bene gli abiti<br />
piegati dentro…è ovvio che questo crea <strong>un</strong> obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni…per me <strong>in</strong>fatti la <strong>valigia</strong> rigida<br />
piccola non ha senso, deve essere grossa….<br />
per me la <strong>valigia</strong> vuol <strong>di</strong>re libertà, <strong>in</strong>contro, andare….qu<strong>in</strong><strong>di</strong> deve essere veloce, graziosa, car<strong>in</strong>a,<br />
maneggevole…i borsoni vanno bene per <strong>un</strong> abbigliamento sportivo, ma se <strong>un</strong>o deve andare anche<br />
<strong>un</strong>a sola sera a teatro, con il borsone è f<strong>in</strong>ita….arrivo lì come <strong>un</strong>a povera….allora ci vuole la <strong>valigia</strong><br />
rigida.<br />
Inoltre nel gruppo degli adulti l'<strong>oggetto</strong> <strong>in</strong> questione viene spesso citato come materiale <strong>di</strong> regalo,<br />
<strong>di</strong> solito riservato a circostanze importanti, donato oppure ricevuto:<br />
per il mio matrimonio mi avevano regalato tutto <strong>un</strong> set <strong>di</strong> Samsonite rigide rosse, tutto il set più il<br />
beauty case….le tenevamo lì sempre <strong>in</strong> vista, pronte per partire…allora avevo <strong>un</strong>a casa grande non<br />
avevo problemi <strong>di</strong> spazio. Mio marito usava spesso per lavoro quella proprio formato-giacca, poi<br />
c'era la grande per noi due…Quando aprivo l'arma<strong>di</strong>o, le vedevo lì e già sognavo…<br />
mentre sembra esserci <strong>un</strong>a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> genere nella valutazione dell'importanza del fattore<br />
estetico: le signore si <strong>di</strong>mostrano piuttosto attente alla bellezza dell'<strong>oggetto</strong> o del set <strong>di</strong> bagaglio,<br />
<strong>in</strong>vece gli uom<strong>in</strong>i spesso stentano a ricordarsi perf<strong>in</strong>o il colore delle valigie rigide possedute nel<br />
passato:<br />
nella <strong>valigia</strong> non ho mai cercato l'estetica, non mi <strong>in</strong>teressa, mi piacerebbe che spiccasse <strong>in</strong> mezzo<br />
alle altre perché è più facile reperirla, quello sì….<br />
5. Conclusioni<br />
Alla f<strong>in</strong>e <strong>di</strong> questo <strong>viaggio</strong>, pare opport<strong>un</strong>o, vista l'ispirazione <strong>di</strong> tutto il lavoro, chiudere il<br />
cerchio ritornando ancora <strong>un</strong>a volta allo schema <strong>di</strong> Hirsch, utilizzandolo questa volta come <strong>un</strong>a<br />
griglia <strong>in</strong>terpretativa da sovrapporre ai risultati dell'<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e. Tale operazione consente <strong>di</strong> fare <strong>un</strong>a<br />
serie <strong>di</strong> osservazioni che da <strong>un</strong> lato assegnano concretezza a tutte le fasi comprese nel percorso<br />
idealtipico, dall'altro ci permettono <strong>di</strong> <strong>in</strong><strong>di</strong>viduare la molteplicità dei significati che caratterizzano le<br />
<strong>di</strong>verse fasi e che corrispondono alle <strong>di</strong>verse com<strong>un</strong>ità (o nicchie) culturali che gli artefatti<br />
<strong>in</strong>dustriali <strong>in</strong>contrano nel loro camm<strong>in</strong>o verso il mercato del consumo.<br />
17
Ho già sottol<strong>in</strong>eato <strong>in</strong> precedenza come l'analisi <strong>di</strong> tutti e tre i casi stu<strong>di</strong>ati nella ricerca abbia<br />
evidenziato l'esistenza <strong>di</strong> meccanismi <strong>di</strong> feed back molto più numerosi e complessi <strong>di</strong> quelli<br />
ipotizzati da Hirsch (v. supra p.5); pertanto <strong>in</strong> queste conclusioni desidero soprattutto concentrarmi<br />
su <strong>un</strong>a rilettura della traiettoria pr<strong>in</strong>cipale dello schema (quella, per <strong>in</strong>tenderci contenente i vari<br />
sottosistemi) attraverso il filtro dei dati empirici raccolti nello stu<strong>di</strong>o su Oyster.<br />
Una prima sostanziale <strong>di</strong>vergenza tra gli ass<strong>un</strong>ti <strong>di</strong> Hirsch e le osservazioni ispirate dal caso della<br />
<strong>valigia</strong> hanno <strong>di</strong>rettamente a che fare con la <strong>di</strong>versa def<strong>in</strong>izione <strong>di</strong> <strong>in</strong>dustria <strong>culturale</strong> che<br />
contrad<strong>di</strong>st<strong>in</strong>gue le due prospettive. Infatti l'it<strong>in</strong>erario idealtipico <strong>di</strong>segnato da Hirsch chiaramente<br />
utilizza come p<strong>un</strong>to <strong>di</strong> riferimento <strong>un</strong>a def<strong>in</strong>izione ancora classica <strong>di</strong> <strong>in</strong>dustria <strong>culturale</strong> <strong>in</strong> base alla<br />
quale questa espressione descrive l'<strong>in</strong>sieme <strong>di</strong> organizzazioni che producono articoli culturali legati<br />
alla com<strong>un</strong>icazione e dell'<strong>in</strong>trattenimento <strong>di</strong> massa, come <strong>di</strong>schi, libri <strong>di</strong> facile lettura e film <strong>di</strong><br />
cassetta. Per questo, trattando del primo anello della catena, il cosiddetto sottosistema tecnico,<br />
Hirsch sottol<strong>in</strong>ea come esso tenda ad essere caratterizzato da <strong>un</strong>a eccedenza <strong>di</strong> creatori che<br />
sp<strong>in</strong>gono sulle porte del sotto sistema manageriale per portare le loro opere all'attenzione delle<br />
organizzazioni che possono produrle su larga scala.<br />
Nel caso qui descritto, e più <strong>in</strong> generale nel settore dell'<strong>in</strong>dustria dell'abbigliamento e degli<br />
accessori, il conf<strong>in</strong>e tra il sottosistema tecnico e quello manageriale è molto più sfumato; o meglio<br />
si potrebbe forse <strong>di</strong>re che non esiste <strong>un</strong> vero e proprio sottosistema tecnico, se con questo si <strong>in</strong>tende<br />
<strong>un</strong>'area che racchiude <strong>in</strong> sé espressioni relativamente libere dell'impulso creativo. Nel nostro caso,<br />
<strong>in</strong>fatti, l'attività creativa <strong>in</strong>iziale si situa nell'area del design <strong>in</strong>dustriale e perciò non può essere<br />
considerata, nemmeno all'orig<strong>in</strong>e, come <strong>un</strong>a f<strong>un</strong>zione completamente <strong>di</strong>staccata dal sottosistema<br />
produttivo; al contrario il contributo del designer è richiesto e attivato dagli stessi produttori che,<br />
avendo deciso <strong>di</strong> lanciare nuovi modelli, cercano all'esterno il professionista più adatto a progettare<br />
tali oggetti sulla base <strong>di</strong> <strong>un</strong> brief, più o meno preciso, fornito dall'azienda stessa.<br />
Se da <strong>un</strong> lato è vero che nell'attuale sistema economico la creatività pura e sv<strong>in</strong>colata dal mercato<br />
è sempre più ridotta anche nell'area della produzione artistica e <strong>di</strong> certo è prossima all'est<strong>in</strong>zione nei<br />
settori dell'<strong>in</strong>dustria <strong>culturale</strong> <strong>in</strong>tesa <strong>in</strong> senso classico, dall'altro la figura del designer <strong>in</strong>dustriale<br />
rappresenta senza dubbio la tipologia <strong>di</strong> creativo tra<strong>di</strong>zionalmente più compromessa con l'<strong>in</strong>dustria.<br />
<strong>La</strong> nascita stessa del design come oggi lo conosciamo co<strong>in</strong>cide <strong>in</strong>fatti con il «delicato momento<br />
storico <strong>in</strong> cui si verifica il passaggio dal consumatore-committente, e d<strong>un</strong>que da <strong>un</strong> 'fare<br />
dell'<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo per l'<strong>in</strong><strong>di</strong>viduo' tipico dell'artigianato, a <strong>un</strong>a 'produzione collettiva per la collettività',<br />
ad <strong>un</strong> pubblico <strong>di</strong> consumatori vasto e <strong>in</strong>def<strong>in</strong>ito» (Cutolo, 1989:24). In questo quadro, il ruolo del<br />
progettista si configura come quello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atore non solo tra consumatore e <strong>in</strong>dustria, ma tra<br />
domanda <strong>di</strong> esteticità dell'<strong>oggetto</strong> e sua rispondenza ad <strong>un</strong> preciso ruolo f<strong>un</strong>zionale 14 . Il concetto<br />
stesso <strong>di</strong> design contiene <strong>in</strong> sé l'idea <strong>di</strong> commistione tra esigenze estetiche (obiettivo precipuo delle<br />
opere d'arte) e esigenze f<strong>un</strong>zionali; <strong>in</strong>oltre, poiché l'<strong>oggetto</strong> <strong>di</strong> design è per def<strong>in</strong>izione (a meno che<br />
sia <strong>un</strong> prototipo mai realizzato) prodotto <strong>in</strong> serie, «la figura del designer, che spesso, soprattutto agli<br />
<strong>in</strong>izi, presenta <strong>un</strong>a <strong>biografia</strong> molto compromessa con l'artigianato, si lega sempre <strong>di</strong> più all'<strong>in</strong>dustria,<br />
legittimando e istituzionalizzando le specificità del proprio ruolo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atore tra memoria artigiana<br />
e <strong>in</strong>venzione tecnologica, tra artigiano-bricoleur e <strong>in</strong>gegnere-<strong>in</strong>ventore» (Cutolo 1989:25). Pertanto<br />
si potrebbe <strong>di</strong>re che l'essenza del lavoro del designer è <strong>un</strong> atto creativo v<strong>in</strong>colato da criteri <strong>di</strong><br />
efficienza f<strong>un</strong>zionale e <strong>di</strong> realizzabilità meccanica, oltre che naturalmente da v<strong>in</strong>coli <strong>di</strong> tipo<br />
economico. Nel caso <strong>di</strong> Oyster tutte queste caratteristiche sono rispecchiate <strong>in</strong> modo evidente: la<br />
<strong>valigia</strong> rappresenta <strong>in</strong>fatti <strong>un</strong> tipico prodotto "designed for manufactur<strong>in</strong>g", dove le necessità e le<br />
esigenze della realizzazione meccanica <strong>in</strong>fluiscono <strong>in</strong> modo notevole sulle potenzialità espressive<br />
del progetto.<br />
Nella cultura della produzione (sottosistema manageriale) Oyster <strong>di</strong>venta l'<strong>oggetto</strong> <strong>in</strong>augurale e<br />
perciò il simbolo <strong>di</strong> <strong>un</strong>a evoluzione importante nell'organizzazione del lavoro. <strong>La</strong> produzione <strong>di</strong><br />
Oyster segna <strong>in</strong>fatti, <strong>in</strong> Samsonite, l'evoluzione tra <strong>un</strong> sistema <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> stampo ancora<br />
tayloristico fondato sulla logica della catena <strong>di</strong> montaggio, ad <strong>un</strong> sistema organizzato <strong>in</strong>vece <strong>in</strong> isole<br />
14 Per ulteriori approfon<strong>di</strong>menti si può vedere D'Auria, 1988 e De Fusco, 1985).<br />
18
<strong>di</strong> lavoro. Operando <strong>in</strong> <strong>un</strong>o spazio attrezzato con tutti i pezzi occorrenti, ciasc<strong>un</strong> operatore è <strong>in</strong> tal<br />
modo <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> assemblare <strong>in</strong>teramente il prodotto che esce dall'isola <strong>di</strong> lavoro privo soltanto <strong>di</strong><br />
alc<strong>un</strong>i accessori <strong>in</strong>terni, ma per il resto è pronto per lo stockaggio <strong>in</strong> magazz<strong>in</strong>o. Per gli <strong>in</strong>gegneri <strong>di</strong><br />
produzione, l'<strong>oggetto</strong> Oyster sembra assumere prevalentemente significato <strong>in</strong> quanto<br />
materializzazione <strong>di</strong> <strong>un</strong>a nuova filosofia organizzativa e veicolo per testare le possibilità <strong>di</strong> modalità<br />
<strong>di</strong> lavoro meno alienanti 15 . Sempre all'<strong>in</strong>terno del sottosistema tecnico, ma <strong>in</strong> <strong>un</strong>a posizione quasi <strong>di</strong><br />
<strong>in</strong>terfaccia con il pubblico, le culture del market<strong>in</strong>g e della <strong>di</strong>rezione ven<strong>di</strong>te appaiono come quelle<br />
per cui l'<strong>oggetto</strong> si avvic<strong>in</strong>a <strong>di</strong> più all'idea marxiana <strong>di</strong> merce. Poiché l'obiettivo fondamentale è<br />
costituito dalla massimizzazione delle ven<strong>di</strong>te il prodotto, qualsiasi prodotto, è considerato,<br />
all'<strong>in</strong>terno e tra gli addetti ai lavori, semplicemente per il suo valore <strong>di</strong> scambio, mentre all'esterno<br />
(cioè <strong>di</strong> fronte al pubblico) esso viene caricato, attraverso le <strong>in</strong>iziative promozionali, i corner e gli<br />
eventi speciali, <strong>di</strong> significati del tutto fittizi che fanno tanto pensare alla teoria del feticismo delle<br />
merci. In altre parole sembra che agli addetti al market<strong>in</strong>g e ven<strong>di</strong>te non <strong>in</strong>teressi per nulla capire<br />
come <strong>un</strong> prodotto è, quali caratteristiche ha, eccetera, ma soltanto <strong>in</strong>tuire con quali associazioni<br />
positive, non importa se del tutto artificiose, può essere presentato per venderlo il più possibile.<br />
Insomma, per <strong>di</strong>rla con Kopytoff, <strong>in</strong> questa fase Oyster riprende, o forse acquisisce per la prima<br />
volta lo status <strong>di</strong> pura merce, per uscirne subito dopo, quando proseguendo nell'it<strong>in</strong>erario, entra nel<br />
sottosistema della com<strong>un</strong>icazione.<br />
Insieme alla fase progettuale, quella della creazione e realizzazione delle campagne <strong>di</strong><br />
com<strong>un</strong>icazione si profilano come i momenti a più elevato contenuto <strong>di</strong> creatività. L'idea base della<br />
com<strong>un</strong>icazione consiste <strong>in</strong>fatti nel tentativo <strong>di</strong> afferrare le caratteristiche essenziali e <strong>di</strong>st<strong>in</strong>tive del<br />
prodotto per farle conoscere, sia pur <strong>in</strong> modo lu<strong>di</strong>co o humoristico, anche alla massa dei<br />
consumatori. In questa fase d<strong>un</strong>que l'<strong>oggetto</strong> si fa veicolo per la trasmissione <strong>di</strong> <strong>un</strong> messaggio, il cui<br />
contenuto è costituito da idee, ideali, valori, scelte estetiche e f<strong>un</strong>zionali, <strong>in</strong> <strong>un</strong>a parola, da tutto<br />
quell'<strong>in</strong>effabile a cui il prodotto ha dato forma tangibile 16 .<br />
Per quanto riguarda le pratiche <strong>di</strong> consumo, il nostro lavoro ha confermato che i consumatori non<br />
sono affatto dei soggetti passivi sui quali il sistema produttivo può imporre gusti e criteri <strong>di</strong> scelta.<br />
Al contrario, i processi <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>fica dei significati messi <strong>in</strong> atto dal pubblico sui prodotti <strong>di</strong><br />
consumo possono attribuire agli oggetti significati anche lontani o imprevisti rispetto alle strategie<br />
<strong>di</strong> market<strong>in</strong>g delle aziende produttrici. Per questo le aziende, che negli ultimi anni sono <strong>di</strong>ventate<br />
molto più sensibili ai feed back provenienti dal consumo, <strong>in</strong>vestono risorse sempre più cospicue <strong>in</strong><br />
attività volte a facilitare il contatto <strong>di</strong>retto con il pubblico ormai considerato come fonte <strong>di</strong><br />
suggerimenti e <strong>di</strong> creatività per l'adeguamento dei prodotti e l'<strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> nuovi possibili<br />
utilizzi degli stessi.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
APPADURAI A. (ed)<br />
(1986) The social life of th<strong>in</strong>gs, Cambridge University Press, Cambridge.<br />
ARCHER M.<br />
(1988) Culture and agency: the place of culture <strong>in</strong> social theory, Cambridge University<br />
Press, New York.<br />
BARNARD M.<br />
15 Sarebbe stato <strong>in</strong>teressante ascoltare su questo p<strong>un</strong>to le op<strong>in</strong>ioni degli operatori dello stabilimento <strong>di</strong> Oudenaarde;<br />
purtroppo questo non è stato possibile sia per mancanza <strong>di</strong> tempo, sia per la <strong>di</strong>fficoltà a com<strong>un</strong>icare con persone <strong>di</strong><br />
madrel<strong>in</strong>gua fiamm<strong>in</strong>ga.<br />
16 Naturalmente non possiamo presumere che l'attività <strong>di</strong> com<strong>un</strong>icazione sia sempre svolta secondo questi criteri; nel<br />
caso esam<strong>in</strong>ato <strong>di</strong> Oyster, com<strong>un</strong>que, questo è il quadro che ne abbiamo tratto.<br />
19
(1996) Fashion as comm<strong>un</strong>ication, Routledge, London<br />
BLUMER H.<br />
(1969) Symbolic <strong>in</strong>tercationism, Prentice Hall, Englewood Cliffs.<br />
BOURDIEU P.<br />
(1984) <strong>La</strong> <strong>di</strong>st<strong>in</strong>zione, Il Mul<strong>in</strong>o, Bologna.<br />
BOVONE L.<br />
(1994) Creare com<strong>un</strong>icazione. I nuovi <strong>in</strong>terme<strong>di</strong>ari <strong>di</strong> cultura a Milano, FrancoAngeli,<br />
Milano.<br />
CAMPBELL C.<br />
(1989) The romantic ethic and the spirit of modern consumerism, Blackwell, London.<br />
CRANE D.<br />
(1994) (ed) The sociology of culture, Blackwell, Cambridge.<br />
(1997) <strong>La</strong> produzione <strong>culturale</strong>, Il Mul<strong>in</strong>o, Bologna.<br />
CUTOLO G.<br />
(1989) L'edonista virtuoso: creatività mercantile e progetto <strong>di</strong> consumo, Lybra Immag<strong>in</strong>e,<br />
Milano.<br />
D'AURIA A.<br />
(1988) Il designer, il bricoleur, l'<strong>in</strong>gegnere, Milano.<br />
DANT T.<br />
(1999) Material culture <strong>in</strong> the social world, Open University Press, Buck<strong>in</strong>gham.<br />
DE FUSCO R.<br />
(1985) Storia del design, <strong>La</strong>terza, Bari.<br />
DOUGLAS M. - ISHERWOOD B.<br />
(1984) Il mondo delle cose, Il Mul<strong>in</strong>o, Bologna.<br />
FEATHERSTONE M.<br />
(1991) Consumer culture and postmodernism, Sage, London.<br />
GEERTZ C.<br />
(1997) L'<strong>in</strong>terpretazione delle culture, Il Mul<strong>in</strong>o, Bologna.<br />
GRISWOLD W.<br />
(1997) Sociologia della cultura, Il Mul<strong>in</strong>o, Bologna.<br />
HALL S. et al.<br />
(1997) Do<strong>in</strong>g cultural stu<strong>di</strong>es: the story of the Sony Walkman, Sage, London.<br />
HEBDIGE D.<br />
(1988) Hid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> the light: on images and th<strong>in</strong>gs, Routledge, London.<br />
HIRSCH P. M.<br />
20
(1972) "Process<strong>in</strong>g fads and fashions: an organization set analysis of culture <strong>in</strong>dustry<br />
system", <strong>in</strong> American Journal of Sociology, 77, pp.639-659.<br />
KOPYTOFF I.<br />
(1986) "The cultural biography of th<strong>in</strong>gs: commo<strong>di</strong>tization as process", <strong>in</strong> A.<br />
APPADURAI, cit.<br />
LATOUR B.<br />
(1996) Petite réflexion sur le culte moderne des <strong>di</strong>eux faitiches, Les empêcheurs de penser<br />
en rond, Parigi.<br />
MEAD G.H.<br />
(1966) Mente, sé e società, Barbera, Firenze.<br />
MUKERJI C.<br />
(1994) "Toward a sociology of material culture", <strong>in</strong> CRANE D. , cit.<br />
SAHLINS M.<br />
(1976) Culture and practical reason, University of Chicago Press, Chicago.<br />
SEMPRINI A. (a cura <strong>di</strong>)<br />
(1999) Il senso delle cose, FrancoAngeli, Milano.<br />
SIMMEL G.<br />
(1984) Filosofia del denaro, Utet, Tor<strong>in</strong>o.<br />
(1985) <strong>La</strong> moda,E<strong>di</strong>tori Ri<strong>un</strong>iti, Roma.<br />
VEBLEN T.<br />
(1948) <strong>La</strong> teoria della classe agiata, E<strong>in</strong>au<strong>di</strong>, Tor<strong>in</strong>o.<br />
WEBER M.<br />
(1968) Economia e società, Com<strong>un</strong>ità, Milano.<br />
(1974) Il metodo delle scienze storico-sociali, Mondadori. Milano.<br />
WILLIS P.<br />
(1982) "The motr-bike and motor-bike culture", <strong>in</strong> WAITES B. et al. (eds), Popular culture:<br />
past and present, Croom Helm, London, pp. 284-94.<br />
21