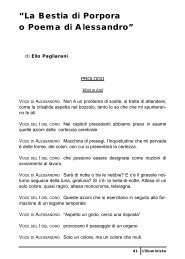Vedere, descrivere e dipingere l'Italia tra Sette - Italianistica e ...
Vedere, descrivere e dipingere l'Italia tra Sette - Italianistica e ...
Vedere, descrivere e dipingere l'Italia tra Sette - Italianistica e ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Immagini dell’Italia<br />
277
CHIARA STEFANI<br />
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia<br />
<strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento*<br />
La recente ripubblicazione, sotto forma di monografia, del saggio di Cesare De<br />
Seta apparso nel 1982 nel quinto volume degli Annali della Storia d’Italia Einaudi<br />
— L’Italia nello specchio del Grand Tour —, costituisce la sintesi e il bilancio<br />
finora più aggiornato degli studi sulla percezione visiva che della nos<strong>tra</strong> penisola<br />
aveva chi vi giungeva «da fuori». 1 Tuttavia, per chi affronti questo tema spingendosi<br />
fino ai primi decenni dell’Ottocento, con l’intento di cogliere l’immagine<br />
dell’Italia riflessa dagli occhi degli s<strong>tra</strong>nieri, il compito resta di non facile soluzione.<br />
Se da una parte esistono infatti testimonianze letterarie, della cui ricchezza e<br />
varietà non è dato a me riferire in questa sede, dall’al<strong>tra</strong> i documenti figurativi<br />
sono tali e tanti da scoraggiare chiunque volesse farne un provvisorio censimento.<br />
A questa difficoltà si aggiunga, in campo storico-artistico, la mancanza o l’incompletezza<br />
di strumenti di carattere repertoriale. 2 Molti paesaggisti europei non<br />
1 C. DE SETA, L’Italia del Grand Tour. Da Montaigne a Goethe, Napoli, 1992. Per l’aggiornamento<br />
bibliografico si veda la premessa, e inoltre il catalogo della mos<strong>tra</strong> Grand Tour.<br />
The Lure of Italy in the Eighteenth Century, edited by A. Wilton and I. Bignamini, London,<br />
1996.<br />
2 Oltre a R. SORIA, Dictionary of Nineteenth-Century American artists in Italy 1760-1914,<br />
Rutherford, 1982, indicazioni bio-bibliografiche su artisti viaggiatori sono offerte anche da L.<br />
HARAMBOURG, Dictionnaire des peintres paysagistes français au XIXe siècle, Neuchâtel, 1985,<br />
e da J. INGAMELLS, A dictionary of British and Irish <strong>tra</strong>vellers in Italy, 1701-1800: compiled<br />
from the Brinsley Ford Archive, New-Haven-London, 1997. Esistono strumenti simili in ambito<br />
letterario, per cui si vedano, ad esempio, G. C. MENICHELLI, Viaggiatori francesi reali o immaginari<br />
nell’Italia dell’Ottocento, Roma, 1962; R. S. PINE-COFFIN, Bibliography of the British<br />
and American Travel in Italy to 1860, Firenze, 1974; L. TRESOLDI, Viaggiatori tedeschi in Italia<br />
1452-1870. Saggio Bibliografico, Roma, 1975; G. VAN DE MOETTER, Historisch-<br />
Bibliographischer Abriss der DeutschenSizilienreisenden 1600-1900, Messina, 1992 (con <strong>tra</strong>duzione<br />
di F. Severini Giordano).<br />
279
Chiara Stefani<br />
godono ancora di un’opera monografica, e non tutti i luoghi classici del viaggio in<br />
Italia sono stati illus<strong>tra</strong>ti in modo esauriente. Per Roma e Napoli o la Sicilia, per<br />
esempio, si dispone di una documentazione figurativa che non trova un corrispettivo<br />
qualora si sposti l’attenzione su altre città o regioni italiane.<br />
È però vero che nell’ultimo ventennio alcune mostre dedicate a paesaggisti<br />
europei 3 , e in particolare a pittori francesi, attivi in Italia — quali Pierre-Henri de<br />
Valenciennes, François-Marius Granet, Jean-Joseph-Xavier Bidault, Théodore<br />
Caruelle d’Aligny, Jean-Antoine Constantin, Carl Blechen, Achille-Etna<br />
Michallon, Louis-François Cassas, Franz Ludwig Catel 4 —, e la recente esposizione<br />
In the Light of Italy: Corot and Early Open-Air Painting, 5 hanno colmato<br />
molte lacune. Si comincia così a possedere un quadro più chiaro delle presenze<br />
3 Romanticismo. Il nuovo sentimento della natura (Trento, Palazzo delle Albere), Milano,<br />
1993, a cura di G. Belli, A. Ottani Cavina, F. Rella, P. Rosemberg, P. Schiera.<br />
4 Les paysages de Pierre-Henri de Valenciennes, Paris (Musée du Louvre), 1976, Dossier<br />
du Département des Peintures n°11, a cura di G. Lacambre (mos<strong>tra</strong> senza catalogo, accompagnata<br />
da un petit journal) e Pierre-Henri de Valenciennes 1750-1819, (Spoleto, Palazzo<br />
Racani Arroni) Napoli, 1996, a cura di B. Mantura e G. Lacambre. Molte sono state le mostre<br />
su Granet a partire da quella in occasione del Deuxième centenaire de la naissance de F.-<br />
M. Granet. Du peintre des cloîtres au maître du plein-air, Aix-en-Provence (Musée Granet),<br />
1976, introduzione di L. Malbos; Granet, paysages de l’Ile-de-France, Aix-en-Provence<br />
(Musée Granet), 1984, introduzione di D. Coutagne; Granet, paysages de Provence, Aix-en-<br />
Provence (Musée Granet), 1988, introduzione di D. Coutagne; F.-M. Granet, watercolours<br />
from the Musée Granet at Aix-en-Provence, New York (The Frick Collection); a cura di E.<br />
Munhall; Paesaggi perduti. Granet a Roma 1802-1824, (Roma, American Academy) Milano,<br />
1996, a cura di C. Bruzelius; Jean-Joseph-Xavier Bidault (1758-1846). Peintures et dessins,<br />
Carpen<strong>tra</strong>s (Musée Duplessis), 1978-79, a cura di S. Gutwirth; Théodore Caruelle d’Aligny et<br />
ses compagnons, Dunkerque (Musée des Beaux-Arts), 1979, a cura di M.M. Aubrun; Jean-<br />
Antoine Constantin, Marseille (Musée des Beaux-Arts), 1985-86, a cura di H.Wytenhove;<br />
Carl Blechen. Zwischen Romantik und Realismus, München (Nationalgalerie Berlin), 1990, a<br />
cura di P. K. Schuster; Achille-Etna Michallon, Paris (Musée du Louvre), 1994, a cura di V.<br />
Pomarède, B. Lesage, C. Stefani; Louis-François Cassas 1756-1827, (Tours, Musée des<br />
Beaux-Arts — Köln, Wallraf-Richartz Museum) Mainz am Rhein, 1994; Franz Ludwig Catel<br />
e i suoi amici a Roma. Un album di disegni dell’Ottocento, (Roma, Galleria Nazionale d’Arte<br />
Moderna), Torino, 1996, a cura di E. Di Majo. Sui pittori tedeschi nel Lazio si veda il catalogo<br />
della mos<strong>tra</strong> Gli artisti romantici tedeschi del primo Ottocento a Olevano Romano,<br />
(Olevano Romano, Villa De Pisa), Milano, 1997, a cura di D. Riccardi. Anche il catalogo<br />
della recente mos<strong>tra</strong> Itinerari sublimi. Viaggi d’artisti <strong>tra</strong> il 1750 e il 1850, (Lugano, Museo<br />
Cantonale d’arte), Milano, 1998, è improntato allo studio degli artisti in <strong>tra</strong>nsito at<strong>tra</strong>verso<br />
una determinata area geografica (Svizzera e regione dei laghi lombarda).<br />
5 In the Light of Italy. Corot and Early Open-Air Painting, (Washington, National<br />
Gallery of Art) New Haven and London, 1996, a cura di P. Conisbee, S. Faunce, J. Strick. Ho<br />
avuto modo di discutere alcuni motivi comuni a questa e altre mostre in una recensione in<br />
«Roma Moderna e Contemporanea», Anno IV, n. 3, 1996, pp. 743-750.<br />
280
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento<br />
s<strong>tra</strong>niere in Italia, degli itinerari di viaggio privilegiati dagli artisti, e quindi<br />
anche dell’immagine della nos<strong>tra</strong> penisola quale <strong>tra</strong>spare dalle loro opere.<br />
Prescindendo da problemi relativi allo specifico settore disciplinare — alludo<br />
in particolare alla necessità di una maggiore informazione su tutte le fasi elaborative<br />
dei paesaggi eseguiti <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento, e sui puntuali contatti <strong>tra</strong> pittori<br />
s<strong>tra</strong>nieri attivi nello stesso momento in Italia —, manca forse una riflessione, in<br />
materia di viaggio, sul rapporto <strong>tra</strong> fonti letterarie e documenti iconografici. 6 In<br />
che senso cioè, essi «si integrano a vicenda», 7 secondo un’espressione di Cesare<br />
De Seta? È certo che, per riprendere i termini di un famoso saggio di Panofsky,<br />
quelli che sono monumenti per lo storico dell’arte — i dipinti, per esempio —,<br />
diventeranno documenti per lo storico della letteratura, e viceversa avverrà per<br />
diari o corrispondenze di viaggio. 8 Tuttavia, al di là di questo rapporto di reciprocità,<br />
è forse lecito chiedersi se, fatte salve le diverse forme di espressione,<br />
scrittori e artisti «vedessero» l’Italia nello stesso modo. Non essendo mio com-<br />
6 Sulla necessità, in materia di viaggio, di studi a carattere interdisciplinare si veda<br />
Paliopticon Italiano, Genève, 1992, a cura di E. Kanceff, vol. I, p. 9. Non mi sembra che l’argomento<br />
sia stato affrontato all’interno degli atti del convegno (Parma, 1986) La letteratura<br />
di viaggio: storia e prospettive di un genere letterario, a cura di M. E. d’Agostini, Milano,<br />
1987. Sono per lo più dedicati agli scrittori: Viaggio nel Sud, a cura di E. Kanceff e R.<br />
Rampone, Genève, 1992 (vol. I I viaggiatori s<strong>tra</strong>nieri in Sicilia, vol. II Verso la Calabria,<br />
vol. III Il profondo Sud: Calabria e dintorni); T. SCAMANDRI, Viaggiatori tedeschi in Puglia<br />
nel <strong>Sette</strong>cento, Fasano, 1988 e Idem, Viaggiatori tedeschi in Puglia nell’Ottocento, Fasano,<br />
1993; H. TUZET, Voyageurs français en Sicile au temps du romantisme: 1802-1848; Forbin,<br />
Didier, Alexandre Dumas, Paul de Musset, Paris, 1945 (<strong>tra</strong>duzione italiana Palermo, 1988).<br />
Ancora sulla Sicilia: G. FALZONE, Viaggiatori s<strong>tra</strong>nieri in Sicilia <strong>tra</strong> il ‘700 e l’800. L’Europa<br />
scopre la Sicilia, Palermo, 1963; E. DI CARLO, Viaggiatori s<strong>tra</strong>nieri in Sicilia nei secoli XVIII<br />
e XIX, Palermo, 1964; I. HILLER FOTI, Viaggiatori tedeschi nella Sicilia orientale 1592-1822,<br />
Catania, 1981. Esistono poi studi su aree più periferiche: Viaggiatori inglesi in Valle d’Aosta<br />
(1800-1860), a cura di P. Malvezzi, Milano, 1972; M. CABIDDU, La Sardegna vista dagli<br />
inglesi: i viaggiatori dell’Ottocento, Quartu S. Elena, 1982; E. RUTIGLIANO, Sulle <strong>tra</strong>cce di<br />
Goethe: poeti e filosofi tedeschi in viaggio at<strong>tra</strong>verso il Trentino, Trento, 1982. D’al<strong>tra</strong> parte,<br />
molti sono i lavori a carattere generale quali, a solo titolo d’esempio, C. HIBBERT, The Grand<br />
Tour, London, 1969; C. BERNARI, L’Italia dei grandi viaggiatori, Roma, 1986; A. BRILLI, Il<br />
viaggio in Italia. Storia di una grande <strong>tra</strong>dizione culturale dal XVI al XIX secolo, Milano,<br />
1987; A. BRILLI, Arte del viaggiare. Il viaggio materiale dal XVI al XIX secolo, Milano,<br />
1992; S. WARNEKE, Images of the educational <strong>tra</strong>veller in early modern England, Leiden,<br />
1995, che, pur provvisti di utili informazioni, rischiano spesso di diventare generici.<br />
7 C. DE SETA, op. cit., p. 18. Sulla relazione <strong>tra</strong> scrittori e artisti viaggiatori si veda inoltre<br />
C. DE SETA, Prima di Corot. Pittori e scrittori <strong>tra</strong> Roma e Napoli, in Corot, un artiste et son<br />
temps, (Actes des Colloques Paris, Louvre 1.-2.3.1996 – Rome, Villa Médicis 9.3.1996) sous<br />
la direction scientifique de C. Stefani-V. Pomarède, Paris, 1998, pp. 385-396.<br />
8 E. PANOFSKY, Il significato nelle arti visive, Torino, 1962, pp. 5-28 (tit. orig. Meaning<br />
in the Visual Arts. Papers in and on Art History, Doubleday, Garden City, N.Y. 1955).<br />
281
Chiara Stefani<br />
pito in questa sede affrontare un tema di così vasta portata, mi limiterò a segnalare,<br />
quando sarà possibile, momenti di tangenza, privilegiando lo sguardo che<br />
sull’Italia hanno posato alcuni artisti francesi appartenenti alla generazione vissuta<br />
a cavallo dell’Ottocento.<br />
In una pagina dell’Italienische Reise, datata 14 settembre 1786, Goethe riassume<br />
in poche righe quale fosse considerata da sempre l’at<strong>tra</strong>ttiva maggiore<br />
della penisola, ironizzando al tempo stesso sulla parzialità e quindi sul limite di<br />
tale giudizio. A un passante che si era fermato stupito, vedendolo intento a disegnare<br />
una vecchia torre in rovina del castello di Malcesine, l’«io narrante» replicava<br />
che «molti viaggiatori (...) venivano in Italia solo per vedere delle rovine;<br />
che Roma, la capitale del mondo devastata dai barbari, era piena di rovine;<br />
ri<strong>tra</strong>tte centinaia e centinaia di volte, e che non tutte le antichità erano rimaste<br />
ben conservate come l’anfiteatro di Verona...». 9 All’occhio selettivo del viaggiatore,<br />
che rischiava pertanto di diventare miope, come altrove Goethe scriveva in<br />
modo più esplicito, 10 veniva evidentemente rimproverata una visione dell’Italia<br />
che, non sapendo fare as<strong>tra</strong>zione dai monumenti antichi, ne ignorava le bellezze<br />
paesaggistiche.<br />
A dieci anni di distanza, nel 1796, Quatremère de Quincy dava alle stampe<br />
les Lettres sur le préjudice qu’occasionneroient aux arts et à la science le<br />
déplacement des monumens de l’art de l’Italie..., dalle quali, per quanto nel<br />
contesto di un primissimo dibattito su problemi di tutela del patrimonio storicoartistico,<br />
emergeva un’immagine a dittico dell’Italia che forse stenta ancora a<br />
imporsi. Così scriveva Quatremère de Quincy, le cui parole, anche se riferite a<br />
Roma, avrebbero potuto estendersi all’Italia intera: «Le véritable museum de<br />
Rome, celui dont je parle, se compose, il est vrai, de statues, de colonnes<br />
triomphales, de thermes, de cirques, d’ampithéatres, d’arcs de triomphe, de tombeaux,<br />
de stucs, de fresques, de bas-reliefs, d’inscriptions, de fragmens d’ornemens,<br />
de matériaux de contruction, de meubles, d’ustensiles, etc., etc., mais il<br />
ne se compose pas moins des lieux, des sites, des montagnes, des carrières, des<br />
routes antiques, des positions respectives des villes ruinées, des rapports géographiques,<br />
des relations de tous les objets entre eux, des souvenirs, des <strong>tra</strong>di-<br />
9 J. W. GOETHE, Italienische Reise, herausgegeben von A. Beyer-N. Miller, München-<br />
Wien, 1992, qui e d’ora in poi citato nella <strong>tra</strong>duzione italiana, Viaggio in Italia, Milano, 1983,<br />
a cura di E. Castellani, p. 30.<br />
10 J. W. GOETHE, op. cit., p. 105: «Viaggiano dunque anche simili tipi! E io constato con<br />
meraviglia che uno può viaggiare senza vedere nulla al di là del proprio naso, pur essendo,<br />
nel suo genere, una persona colta, intelligente e ammodo.»<br />
282
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento<br />
tions locales, des usages encore existans, des parallèles et des rapprochemens<br />
qui ne peuvent se faire que dans le pays même.» 11 (fig. 1).<br />
Erano passati solo pochi anni da quando, nel 1791, Quatremère de Quincy<br />
aveva pubblicato a Parigi la Suite aux considérations sur les arts du dessin en<br />
France; ou Réflexions critiques sur le projet de Status et Réglemens de la majorité<br />
de l’Académie de Peinture et Sculpture. Con un anticipo di oltre vent’anni<br />
sull’istituzione del Grand Prix de Peinture de Paysage Historique (1817),<br />
Quatremère de Quincy aveva sostenuto la necessità, per il paesaggista, piuttosto<br />
che per qualsiasi altro pittore, di recarsi in Italia. Mentre in Francia l’artista non<br />
avrebbe potuto trovare, secondo l’autore del saggio, quelle condizioni geografiche<br />
e climatiche che avrebbero consentito di farne fruttare il lavoro — da svolgersi<br />
essenzialmente all’aperto —, questo poteva invece avvenire, a suo parere,<br />
in Italia, paese capace di offrire per di più un insieme e una varietà di siti altrove<br />
inattingibile. 12<br />
Sarebbero passati ancora parecchi anni prima che le convinzioni di<br />
Quatremère de Quincy venissero accettate dai membri dell’Académie des<br />
Beaux-Arts, e che il viaggio in Italia diventasse un momento indispensabile<br />
nella formazione del pittore di paesaggio, come ribadiscono <strong>tra</strong>ttatisti quali<br />
Charles-Henri Watelet, 13 Aubin-Louis Millin, 14 e Charles-Jacques-François<br />
Lecarpentier. 15 Con l’istituzione del Grand Prix de Peinture de Paysage<br />
11 Lettres sur le préjudice qu’occasioneroient Aux Arts et à la Science, le déplacement<br />
des monumens de l’art de l’Italie, le démembrement de ses Ecoles, et la spoliation de ses<br />
Collections, Galeries, Musées, etc., par A. Quatremère, A Paris, Desenne-Quatremère, An IV,<br />
1796, pp. 21-22. Esiste un’edizione italiana delle Lettres, preceduta da un saggio di A. Pinelli,<br />
in Lo studio delle arti e il genio dell’Europa. Scritti di A. C. Quatremère de Quincy e di Pio<br />
VII Chiaramonti, Bologna, 1989. Si vedano inoltre R. SCHNEIDER, Quatremère de Quincy et<br />
son intervention dans les arts (1788-1830), Paris, 1910 e, per il ruolo politico di Quatremère,<br />
A. D. POTTS, Political Attitudes and the Rise of Historicism in Art Theory, in «Art History»,<br />
vol. 1, n. 2, June 1978, pp. 191-213.<br />
12 A.-C. Quatremère de Quincy, Suite sur les considérations sur les arts du dessein en<br />
France; ou Réflexions critiques sur le projet de Status et réglemens de la majorité de<br />
l’Académie de Peinture et Sculpture, Paris, Desenne, 1791, p. 45.<br />
13 C. H. WATELET, Encyclopédie méthodique. Beaux-Arts, A Paris, chez Panckoucke, 1788,<br />
voce «Paysage», pp. 619-630. L’esigenza del viaggio in Italia, in Watelet, è strettamente legata<br />
alla necessità di compiere rappresentazioni ideali della natura: «Mais si nous arrêtons principalement<br />
à l’Italie, nous verrons premièrement que les aspects y sont généralement plus pittoresques<br />
et d’un caractère plus élevé que les sites de la Hollande: secondement que les esprits<br />
dans ce climat plus chaud, y sont aussi plus en mouvement que dans les plaines et les prairies<br />
Belgiques, et enfin qu’une <strong>tra</strong>nsmission continuelle d’idées qu’inspirent la poesie, la musique<br />
et généralement tous les arts libéraux, porte sensiblement l’imagination vers le beau idéal.»<br />
14 Dictionnaire des Beaux-Arts Par A.-L.Millin, De l’Imprimerie de Crapelet, A Paris,<br />
Desray, 1806, voce «Paysage», vol. III, pp. 107-114.<br />
15 C. J. F. LECARPENTIER, Essai sur le paysage, Paris, Treuttel et Wurtz, 1817, pp. 61-66.<br />
283
Chiara Stefani<br />
Historique, che prevedeva per l’artista una permanenza della durata di quattro<br />
anni all’Accademia di Francia a Roma, intervallata da soggiorni in altre zone<br />
d’Italia, l’immagine seppur parziale e frammentaria della penisola diventava il<br />
fulcro di un ben preciso programma di studi. 16 Al pittore che era risultato vincitore,<br />
veniva infatti richiesto di fornire, al termine di ognuno dei primi tre anni<br />
<strong>tra</strong>scorsi a Roma e nell’ordine da lui preferito, un dipinto eseguito d’après nature,<br />
che fosse un paesaggio agreste o montuoso, o con edifici e rovine, oppure<br />
una marina. Poichè l’artista avrebbe dovuto consegnare insieme ai dipinti una<br />
descrizione che consentisse di localizzare con esattezza i paesaggi rappresentati,<br />
è evidente che si cercava di ovviare in tal modo alla creazione di un’immagine<br />
generica dell’Italia, in accordo con le teorie estetiche del momento, sempre più<br />
orientate verso uno studio eseguito d’après nature, piuttosto che nell’atelier. 17<br />
D’al<strong>tra</strong> parte se, stando alle tabelle statistiche compilate da Carol Rose Wenzel,<br />
la presenza di paesaggi esposti ai Salons parigini <strong>tra</strong> il 1812 e il 1824 conosce<br />
un’ascesa costante, per poi stabilizzarsi fino al 1827, è dal 1814 che il genere della<br />
veduta aumenta progressivamente, mentre diminuiscono in parallelo i dipinti di<br />
tipo storico e bucolico. 18 Tuttavia, solo ai Salons del 1795 e del 1810 le vedute<br />
dell’Italia supereranno, in termini numerici, quelle dedicate alla Francia che rimaneva,<br />
a quanto pare, il soggetto privilegiato dai paesaggisti. Questi dati spiegano<br />
forse perchè, in una lettera inviata al pittore François-Marius Granet dallo scultore<br />
Paul Lemoyne, in merito al Salon del 1822, ci si esprimesse in questi termini: «En<br />
beaucoup de choses, mais surtout en fait de paysages, je veux de l’Italie.» 19 Ma<br />
qual’era, appunto, il paese che si voleva veder rappresentato alle esposizioni parigine<br />
e che gli artisti raggiungevano, spesso al termine di lunghi anni di attesa?<br />
Sicuramente, è con l’immagine della Roma antica che i pittori erano costretti<br />
a misurarsi al loro arrivo in Italia, nonostante, o forse proprio perchè Nicolas<br />
16 P. GRUNCHEC, Les Concours des Prix de Rome 1797-1863, Paris, 1986, vol. I, pp. 37-39.<br />
Rimando inoltre al mio contributo dal titolo Tableaux composés pour le Grand Prix de Peinture<br />
de Paysage Histoique negli atti del convegno 1797-1997 Deux siècles d’histoire de l’Académie<br />
de France à Rome. L’artiste, ses créations et les institutions (Roma, Villa Medici, 25.-<br />
27.9.1997), in corso di pubblicazione (éditeur Klincksieck, Paris).<br />
17 Come ho già sottolineato, C. STEFANI, Le voyage en Italie d’un peintre de paysage, in<br />
Achille-Etna Michallon, op. cit., pp. 105-115, alcuni disegni di paesaggio sembrano effettivamente<br />
essere stati realizzati con estrema accuratezza, come dimos<strong>tra</strong>no le iscrizioni ai margini<br />
dei fogli con indicazioni della data e del luogo, al fine di essere allegati alle descrizioni da<br />
consegnare al direttore dell’Accademia.<br />
18 C. R. WENZEL, The Transformation of French Landscape Painting from Valenciennes<br />
to Corot from 1787 to 1827, University of Pennsylvania, 1979, grafico 1, p. 303; grafico 2, p.<br />
304; tav.1, p. 370.<br />
19 Correspondence de Granet, par Isabelle Néto, «Archives de l’Art Français», T.XXXI,<br />
1995, lettera del 9.5.1822 da Parigi, n. 175, pp. 93-95.<br />
284
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento<br />
Cochin, nelle pagine del suo Voyage d’ Italie, pubblicato nel 1758, si esimesse<br />
dal fornirne una qualsiasi descrizione. 20 Ancora ad Ottocento avanzato, la pagina<br />
intera di Madame Gervaisais, che Balzac dedica alla contemplazione delle<br />
rovine, riassume lo sguardo panoramico su Roma che doveva accomunare, in un<br />
sentimento misto di stupore e sconforto, viaggiatori, artisti e scrittori: «C’était le<br />
Campo Vaccino: des portiques survivant à des temples écroulés, des colonnades<br />
isolées qui ne s’appuyaient plus qu’au ciel, des colonnes foudroyées soutenant<br />
des entablements où des graminées rongeaient des noms d’empereurs, des arcs<br />
de triomphe enterrés de vingt pieds et de vingt siècles, des fosses encombrées<br />
de fragments et de miettes d’édifices, d’énormes voûtes de basiliques, aux caissons<br />
effondrés, repercées par le bleu du jour...». 21<br />
Non a caso il primo tour di Madame Gervaisais per la città partiva proprio<br />
dal Campo Vaccino, ovvero da un luogo reso celebre, già da due secoli, da<br />
dipinti e stampe. Era stato infatti Claude Lorrain, in un dipinto datato — seppur<br />
in modo controverso — entro il 1636, a eseguire un prospetto con l’arco di<br />
Settimio Severo sulla sinis<strong>tra</strong>, colto lateralmente e avvolto in una luce dorata, e i<br />
resti del tempio di Giove Statore, sulla des<strong>tra</strong>. 22 Grande era stata la diffusione di<br />
tale veduta, favorita dall’artista medesimo. Claude infatti, oltre a <strong>tra</strong>rne un’incisione,<br />
aveva confezionato un libro di disegni autografi che riproducevano i suoi<br />
dipinti — fra i quali anche quello con il Campo Vaccino — ovvero il cosidetto<br />
Liber Veritatis, che <strong>tra</strong> la fine del <strong>Sette</strong>cento e l’inizio dell’Ottocento conobbe, a<br />
più riprese, <strong>tra</strong>duzioni all’acquaforte, a mezzatinta e all’acquatinta. 23 (fig. 5).<br />
20 C.-N. COCHIN, Voyage d’Italie ou Récueil de notes sur les ouvrages de peinture et de<br />
sculpture qu’on voit dans les principales villes d’Italie. Suivi des lettres à un jeune artiste<br />
peintre pensionnaire à l’Académie Royale de France à Rome, [A Paris, chez A. Jombert,<br />
1758] Genève, Minkoff Reprint, 1972.<br />
21 E. e J. DE GONCOURT, Madame Gervaisais, Gallimard, Paris, 1982, p. 83. Come è noto,<br />
la storia del romanzo si svolge nel 1844.<br />
22 Claude Lorrain <strong>tra</strong>sse dal proprio dipinto un’incisione firmata e datata «Claudio 1636<br />
Romae», poi riutilizzata da Sandrart, con modifiche, nella Teutsche Academie (Nurnberg,<br />
1675). Per tutte le copie o incisioni <strong>tra</strong>tte dal dipinto, e per la bibliografia relativa, si veda il<br />
catalogo della mos<strong>tra</strong> Claude Gellée et les peintres lorrains en Italie au XVII siècle, a cura di<br />
J.Thuiller, Nancy (Musée des Beaux-Arts) — Roma (Villa Medici), Roma, 1982, n. 106, pp.<br />
294-95. M. Kitson, Swanevelt, Claude Lorrain et le Campo Vaccino, in «La Revue des Arts»,<br />
1958, n. 5, pp. 215-220, e ivi, n. 6, pp. 259-266, ritiene che il modello del dipinto sia da ritrovarsi<br />
in una veduta di Hermann van Swanevelt al Fitzwilliam Museum di Cambridge, da lui<br />
datata al 1631.<br />
23 Liber Veritatis; or a Collection of Prints after the Original Designs of Claude le<br />
Lorrain; in the Collection of His Grace the Duke of Devonshire. Executed by Richard<br />
Earlom, in the Manner and Taste of the Drawings, In two volumes, published by Messrs<br />
Boydell and Co, Cheapside, London, 1777. Ne esiste un’edizione anastatica a cura di<br />
M.Kitson, Claude Lorrain: Liber Veritatis, London, Trustes of the British Museum, 1978.<br />
285
Chiara Stefani<br />
Osservando le rovine dagli Orti Farnesiani, Corot non poteva dimenticare un<br />
simile modello, ma nella serie dei tre dipinti a olio su carta del marzo 1826 —<br />
Rome, vue prise des jardins Farnèse, Le Colisée e Le Forum 24 —, realizzati a<br />
pochissimi mesi dal suo primo arrivo nella città, il rimando a Claude sarebbe<br />
stato del tutto personale e in stretto rapporto con la nuova percezione visiva<br />
acquisita in Italia. Moreau-Nélaton ricorda che a Corot sarebbero state necessarie<br />
quindici sedute, realizzate di seguito e ogni volta alla stessa ora, per cogliere<br />
le variazioni della luce, seguendo il corso del sole, in tre momenti del giorno:<br />
mattino, mezzogiorno e sera. 25<br />
Se l’abitudine di seguire le <strong>tra</strong>sformazioni della natura — le ore del giorno o<br />
l’avvicendarsi delle stagioni —, risaliva ai paesaggisti del Seicento, è vero<br />
anche che Corot, proprio nel marzo del 1826, scriveva una lettera all’amico<br />
Abel Osmond, rivelandogli l’inadeguatezza dei propri strumenti di lavoro<br />
rispetto all’intensità della luce solare: «...Tu ne peux te faire une idée du temps<br />
que nous avons à Rome. Voilà un mois que je suis chaque matin réveillé par l’éclat<br />
du soleil qui frappe sur le mur de ma chambre. Enfin, il est toujours beau.<br />
Mais aussi, en revanche, ce soleil répand une lumière désespérante pour moi. Je<br />
sens toute l’impuissance de ma palette.» 26 (fig. 2).<br />
Il problema della visione, 27 legata a un contesto luministico diverso da quello<br />
del paese di appartenenza, era stato al centro di una riflessione, inserita alla<br />
Riedizioni del Liber Veritatis apparvero, a Londra e a Roma, nel 1810, 1816 e 1819. Per la<br />
fortuna editoriale del testo si veda M. Röthlisberger, Claude Lorrain. The Paintings, New<br />
Haven, Yale University Press, 1961, vol. I, pp. 42-44.<br />
24 I tre studi, tutti a olio su carta <strong>tra</strong>sferita su tela e datati «mars 1826» (ma forse si <strong>tra</strong>tta<br />
di inscrizioni apocrife, a parte il primo), si trovano a Washington (Phillips Collection,<br />
Inv.0336 — Robaut 65) e a Parigi (Musée du Louvre, R.F.153 e 154 — Robaut 66 e 67). Per<br />
la bibliografia completa si veda il recente catalogo della mos<strong>tra</strong> Corot 1796-1875 (Paris-<br />
Ottawa-New York), Paris, 1996, cat.7-9, pp. 81-86. Di Le Forum (Robaut 68) esiste un’al<strong>tra</strong><br />
versione in collezione privata a New York, per cui si veda ibid, cat.10, p. 86.<br />
25 E. MOREAU-NÉLATON, Corot raconté par lui-même, Paris, 1924, I, p. 15. Era inoltre<br />
abitudine dei pittori, sull’esmpio già di Claude Lorrain, eseguire vedute a pendant (il mattino<br />
/ la sera) che riflettessero momenti diversi della giornata. Si vedano, a titolo d’esempio, quelle<br />
realizzate da uno dei maestri di Corot, Jean-Victor Bertin, ricordate da S. GUTWIRTH, Jean-<br />
Victor Bertin. Un paysagiste néo-classique (1767-1842), «Gazette des Beaux-Arts», tome<br />
LXXXIII, 1974, pp. 337-358, cat. 20-21 e cat. 32-33.<br />
26 A. ROBAUT — E. MOREAU NÉLATON, L’Oeuvre de Corot par Alfred Robaut. Catalogue<br />
raisonné et illustré précedé de l’Histoire de Corot et de ses oeuvres par Etienne Moreau-<br />
Nélaton ornée de dessins originaux et de croquis du maître, Paris, 1905, vol. I, p. 33.<br />
27 In generale si veda M. KEMP, The Science of Art. Optical Themes in Western Art from<br />
Brunelleschi to Seurat, New Haven-London, 1990 (con bibliografia selettiva alle pp. 363-<br />
364) e più in particolare sull’Ottocento J. CRARY, Tecnhiques of the Observer. On Vision and<br />
Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge (Massachusetts), 1990.<br />
286
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento<br />
data 8 ottobre 1786 dell’ Italienische Reise di Goethe, dopo una visita dell’autore<br />
al palazzo Pisani Moretta di Venezia, dove all’epoca si trovava un dipinto –<br />
La famiglia di Dario davanti ad Alessandro – di Paolo Veronese, oggi alla<br />
National Gallery di Londra: «È un fatto che l’occhio si conforma agli oggetti<br />
che vede sin dall’infanzia, e quindi è indubbio che il pittore veneziano debba<br />
vedere ogni cosa in una luce più chiara e più serena degli altri uomini. Vivendo,<br />
come noi viviamo, su un suolo che è ora fangoso, ora polveroso, che è privo di<br />
colori ed estingue tutti i riflessi, magari abitando in ambienti addirittura piccoli,<br />
non siamo in grado di proiettare all’esterno uno sguardo così pieno di felicità.» 28<br />
La luce conosciuta in Italia era stata un forte motivo di riflessione anche per<br />
Pierre-Henri de Valenciennes che, nella seconda metà degli anni novanta del<br />
<strong>Sette</strong>cento, subito dopo il rientro in Francia da Roma, aveva realizzato una serie<br />
di studi a olio su carta dove le immagini della città e dei suoi dintorni scomparivano<br />
completamente sotto cieli di nubi dorate o cariche di pioggia. L’abitudine a<br />
considerare i fenomeni luministici e atmosferici che Valenciennes aveva fatto<br />
propria, quale pittore, nel soggiorno in Italia, sarebbe stata teorizzata nelle pagine<br />
del suo <strong>tra</strong>ttato — gli Elémens de Perspective Pratique, à l’usage des<br />
artistes, pubblicati nel 1800 a Parigi — e vivamente consigliata ai paesaggisti<br />
delle generazioni successive che ne fecero uso. 29 Così, la scelta della veduta che<br />
il pittore doveva abbracciare diventava non meno importante di quella della<br />
luce, e spesso a questa subordinata, dal momento che Valenciennes stesso aveva<br />
rappresentato più di una volta il medesimo luogo, non tanto da un punto di vista<br />
diverso, quanto sotto una illuminazione differente. 30<br />
Questo modo di procedere, dettato inizialmente da osservazioni empiriche,<br />
sarebbe stato carico di conseguenze e avrebbe in un certo senso rivoluzionato la<br />
percezione visiva del pittore, e quindi anche, nel caso specifico, la veduta<br />
dell’Italia. Concen<strong>tra</strong>ndo la propria attenzione non più soltanto sui monumenti in<br />
se stessi, ma sulle pietre consumate dal tempo e battute dal sole, la Roma delle<br />
rovine sarebbe stata ben presto collocata a una certa distanza dall’occhio del pittore<br />
— come in uno dei primi dipinti di Corot (1825), 31 il Colosseo visto at<strong>tra</strong>verso<br />
28 J. W. GOETHE, op. cit., p. 93.<br />
29 P. H. DE VALENCIENNES, Elémens de Perspective Pratique. A’l’usage des artistes, suivis<br />
de Réfléxions et Conseils à un Elève sur la Peinture, et particulièrement sur le genre du<br />
Paysage, A Paris, chez Desenne-Duprat, an VIII (1799-1800), pp. 404-407. Sul problema<br />
della luce in Valenciennes si veda anche H. DORRA, Valencienne’s Theories: from Newton to<br />
Seurat, «Gazette des Beaux-Arts», 1994, 124, pp. 185-194.<br />
30 A questo proposito si vedano, a titolo d’esempio, le coppie di olii su carta di<br />
Valenciennes conservati al museo del Louvre: R.F. 2896 e R.F. 2935; R.F. 2899 e R.F. 2995;<br />
R.F. 2991 e R.F. 3036.<br />
31 Rome, le Colisée vu à <strong>tra</strong>vers les arcades de la basilique de Constantin (Paris, Musée<br />
du Louvre R.F.1696 — Robaut 44), olio su carta <strong>tra</strong>sferita su tela, datato «Xbre 1825», per la<br />
cui bibliografia si veda Corot 1796-1875, op. cit., cat.6, p. 78.<br />
287
Chiara Stefani<br />
le arcate della basilica di Costantino, già in un disegno di Théodore Caruelle<br />
d’Aligny (1822-27) —, o, pur rimanendo una presenza ingombrante per l’artista,<br />
avrebbe assolto il ruolo secondario di cornice rispetto al paesaggio dello sfondo,<br />
come dimos<strong>tra</strong> un quadro di Christoffer Wilhelm Eckersberg (1815-1816). 32<br />
Era al di fuori della città che gli artisti avrebbero indirizzato progressivamente<br />
il loro lavoro, una volta pagato il proprio debito con il passato. Già dalla<br />
seconda metà del <strong>Sette</strong>cento i dintorni di Roma disegnavano una cartografia<br />
assai intricata di punti intorno alla città, che una serie di itinerari convenzionali<br />
riuniva, in senso più o meno circolare. Per quanto alcuni luoghi avessero finito<br />
per diventare ben presto talmente conosciuti — quali Tivoli, per esempio — da<br />
non meritare se non un accenno di sfuggita nelle Réflexions et conseils à un<br />
Elève sur la Peinture, et particulièrement sur le genre du Paysage di Pierre-<br />
Henri de Valenciennes, 33 pochi erano gli scarti lungo percorsi che, tutto sommato<br />
potrebbero definirsi quasi turistici. La cittadina di Arsoli sembra restare un<br />
unicum lungo le rotte da Roma a Subiaco, 34 mentre il lago di Piediluco 35 non<br />
raggiungerà mai la celebrità di quello di Albano o di Nemi. Al con<strong>tra</strong>rio, le<br />
cascate di Tivoli non avrebbero cessato di esercitare il loro fascino, sollecitato<br />
da memorie storiche e iconografiche.<br />
Sull’esempio di due pittori che a Roma e dintorni avevano lavorato gomito a<br />
gomito, al punto che a volte riesce quasi difficile distinguerne le mani —<br />
Honoré Fragonard e Hubert Robert 36 —, Tivoli diventerà, con le sue cascate, il<br />
32 Questi accostamenti sono stati fatti da P. GALASSI, Corot in Italy, cit., pp. 138-139. Il<br />
disegno da lui riprodotto (n. 164, p. 138) con il nome di Achille-Etna Michallon (Paris,<br />
Musée du Louvre, R.F. 14024), è in realtà, a mio parere, un calco dall’artista medesimo. Su<br />
Théodore Caruelle d’Aligny, oltre al catalogo della mos<strong>tra</strong> (cfr. nota 4), P. RAMADE, Théodore<br />
Caruelle d’Aligny: dessins du premier séjour italien (1822-1827), «Revue du Louvre», 1986,<br />
XXXVI, pp. 121-129. Su C. W. Eckersberg si veda il numero monografico della rivista<br />
Meddelelser fra Thorvaldsens Museum del 1973, e T. GUNNARSON, The beginnings of openair<br />
oil-sketching in Scandinavia, «Nationalmuseum Bulletin», 1985, vol. 9, n. 2, pp. 67-99.<br />
33 P. H. DE VALENCIENNES, op. cit., p. 599.<br />
34 La cittadina è raffigurata in un disegno di grande formato (mm.434x581) di Achille-<br />
Etna Michallon (Paris, Musée du Louvre, R.F.13775), datato «juillet 1818» e riprodotto nel<br />
catalogo della mos<strong>tra</strong> (cfr. nota 4), p. 65 e n. 82, p. 139.<br />
35 Si veda il piccolo dipinto a olio su tela di Corot Le lac de Piediluco dell’Ashmolean<br />
Museum di Oxford (A 403 — Robaut 123), poi ripreso dall’artista in due opere successive<br />
per le quali si rimanda a Corot 1796-1875, cit., n. 25, p. 116. Nella scoperta del lago di<br />
Piediluco Corot era stato preceduto da uno dei suoi maestri, Achille-Etna Michallon, come<br />
dimos<strong>tra</strong>no due fogli (Paris, Musée du Louvre, R.F.14227 f.41 verso e f.48 verso) del taccuino<br />
del viaggio di ritorno in Francia (giugno-luglio 1821).<br />
36 Un serrato confronto sui dipinti e disegni eseguiti dai due artisti nel periodo 1759-61 è<br />
stato messo a punto in occasione della mos<strong>tra</strong> J.H.Fragonard e H.Robert a Roma, (Roma,<br />
Villa Medici 1990-91), Roma, 1990 al cui catalogo si rimanda per ogni discussione in merito<br />
e per le vedute di Tivoli (cat.101, p. 150 e cat.147, p. 210) a olio su tela. Pur eseguite anche a<br />
288
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento<br />
prototipo del luogo per eccellenza del lavoro dei paesaggisti d’après nature. 37<br />
Nella Teutsche Academie Joachim Sandrart aveva indicato i siti della campagna<br />
romana percorsi da Claude Lorrain che, in anticipo di più di un secolo, avrebbe<br />
lavorato en plein-air a Tivoli, Frascati, Subiaco, San Benedetto. 38 Forse questa<br />
fonte era nota all’acquarellista inglese Jonathan Skelton che, in una lettera da<br />
Tivoli del 23 aprile 1758, non poteva fare a meno di ricordare Claude e Dughet<br />
come i migliori interpreti del luogo, capace di offrire al contempo una natura<br />
armoniosa e selvaggia. 39 Sarà questo secondo aspetto a prevalere, in accordo<br />
con la sensibilità romantica, e verrà così selezionata un’immagine enfatizzata<br />
delle cascate, alla cui diffusione avrebbe ben presto concorso l’avvento della<br />
stampa litografica.<br />
È lecito supporre che, proprio per sot<strong>tra</strong>rsi al rischio di doversi misurare con<br />
un gusto ormai stereotipato, Corot abbia <strong>tra</strong>lasciato volutamente le cosidette<br />
cascate di Tivoli, per accennare solo alle cascatelle, a margine di un dipinto del<br />
1843, anno del suo terzo viaggio in Italia. Giunge a conferma di questa ipotesi<br />
un olio su tela con la cascata delle Marmore a Terni, eseguito quasi un ventennio<br />
prima (1826), dove già la caduta d’acqua si perdeva in una sinfonia di blu,<br />
di marrone e di verdi. 40<br />
A prescindere dall’interesse archeologico e letterario che ha determinato, fra<br />
<strong>Sette</strong> e Ottocento, la fortuna di vari siti della campagna laziale 41 , nuovi paesaggi<br />
parecchi anni di distanza dal soggiorno italiano (1776 è la data che porta il dipinto di<br />
H.Robert), le vedute presuppongono un’esperienza di visione diretta come indicano la sanguigna<br />
con la La grande Cascata, eseguita da Fragonard nel 1760 (cat.62, p. 112), e quella di<br />
H. Robert (cat.6, p. 58), eseguita forse nel 1758-59.<br />
37 Forse non è un caso che l’artista inglese Richard Wilson abbia dipinto un pittore<br />
davanti al suo cavalletto (un’autocitazione?) proprio sullo sfondo delle cascate di Tivoli, in<br />
un olio su tela della National Gallery of Ireland (Dublino). Un altro dipinto di Wilson dello<br />
stesso museo — probabilmente pendant del precedente — mos<strong>tra</strong> l’artista in atto di andarsene,<br />
con il cavalletto piegato sotto braccio. Per en<strong>tra</strong>mbi e la bibliografia relativa si veda<br />
P. CONISBEE, The Early History of Open-Air Painting in In the Light of Italy, cit., pp. 44-45.<br />
38 J. VON SANDRART, L’Academia Todesca della Architectura, Scultura et Pittura: oder<br />
Teutsche Academie, Nurnberg, J. P. Mitenberger, 1675, vol. I, Theils I, III Buch, 6, p. 71.<br />
39 B. FORD, The letters of Jonathan Skelton written from Rome and Tivoli in 1758,<br />
together with Correspondence relating to his Death on 19 Juanuary 1759, «The Walpole<br />
Society», 1956-58, vol. 36, pp. 23-84 (loc.cit. p. 42).<br />
40 È l’olio su tela (cm. 36x32) di proprietà della Banca Nazionale del Lavoro di Roma.<br />
Un olio su carta <strong>tra</strong>sportato su tela di Jean-Victor Bertin, di dimensioni leggermente maggiori<br />
(cm.51, 5x39), firmato e datato 1826 (Sotheby Parke Bernet, London, 9 May 1979) raffigura,<br />
sempre frontalmente, la cascata delle Marmore, ma da un punto di vista più ravvicinato.<br />
41 Su questo punto rimando al saggio di S. SUSINNO, Il successo di “Francesco” Catel <strong>tra</strong><br />
pittura di genere e di paese nella Roma della Restaurazione, in Franz Ludwig Catel, cit.,<br />
pp. 11-20, e al catalogo della mos<strong>tra</strong> I paesaggi di Nicolas-Didier Boguet e i luoghi tibulliani,<br />
Roma, 1984, a cura di G. Fusconi.<br />
289
Chiara Stefani<br />
en<strong>tra</strong>rono a far parte delle immagini collezionate durante il viaggio in Italia.<br />
Risalendo il corso del Tevere in direzione Terni, è nella zona di Civita Castellana<br />
che, a partire da Corot, l’incontro con la natura rocciosa del luogo lasciò un<br />
segno all’interno di più di un dipinto, dove la parete rossas<strong>tra</strong> della gola gioca a<br />
con<strong>tra</strong>sto con il verde della vegetazione e il blu del cielo. 42 L’attenzione per l’aspetto<br />
geologico del paesaggio e in particolare per le s<strong>tra</strong>tificazioni litologiche<br />
era vivamente raccomandato all’artista già nel Cours de peinture par principes di<br />
Roger de Piles, pubblicato nel 1708, e le rocce, più di qualsiasi elemento naturale,<br />
dovevano essere studiate in situ. 43 Ma se il mondo poteva essere scrutato con<br />
un occhio capace di cogliere anche la bellezza, oltre che la singolarità delle<br />
forme, non è detto che questo fosse sempre l’occhio dell’artista.<br />
Uno dei luoghi del viaggio in Italia che possedeva un indiscusso fascino dal<br />
punto di vista scientifico, e capace al tempo stesso di esercitare una forte seduzione<br />
per l’aspetto estetico della materia, era il Vesuvio. Arrivando nei pressi<br />
della bocca del vulcano, si ammirava un panorama al quale nessun viaggiatore,<br />
nonostante i disagi dell’ascesa a piedi, poteva rinunciare. Alla data 6 marzo<br />
1787, Goethe narra di esservi salito in compagnia del pittore Tischbein. «Per<br />
lui», osservava Goethe, «artista della figurazione, unicamente interessato alle<br />
più belle forme umane o animali, capace perfino di rendere umano l’informe —<br />
rocce o paesaggi che siano — col sentimento e col gusto, nulla può esistere di<br />
più repulsivo d’una simile massa paurosa e amorfa, che non fa che divorare se<br />
stessa ed è nemica dichiarata d’ogni senso di bellezza.» 44<br />
Il Vesuvio si era mos<strong>tra</strong>to, con tutta la sua forza, non solo nel 1771, quando<br />
aveva stupito Pierre-Jacques Volaire, ma ancora l’8 agosto del 1779. 45 Questa<br />
volta erano stati più numerosi gli artisti che avevano assistito a uno spettacolo<br />
che, specie per un pittore, doveva essere s<strong>tra</strong>ordinariamente singolare. Si trovavano<br />
nella città Jean-Pierre-Laurent Hoüel, 46 di ritorno dal viaggio in Sicilia, e il<br />
42 Si <strong>tra</strong>tta degli olii su carta conservati alla Staatliche Kunsthalle di Karlruhe (Robaut<br />
140), alla Neue Pinakothek di Monaco (Robaut 174), e al Nationalmuseum di Stoccolma<br />
(Robaut 137). Sull’importanza dello studio delle rocce già in Achille-Etna Michallon e<br />
Théodore Caruelle d’Aligny, si veda il saggio di chi scrive Le voyage en Italie d’un peintre<br />
de paysage, in Achille-Etna Michallon, cit., pp. 105-113 (in particolare pp. 110-111).<br />
43 R. DE PILES, Cours de peinture par principes, (Paris, Jacques Estienne, 1708) edizione<br />
citata Paris, 1989, con prefazione di J. Thuiller, p. 107.<br />
44 J. W. GOETHE, op. cit., p. 213.<br />
45 Sulla presenza a Napoli di Volaire e di altri vedutisti s<strong>tra</strong>nieri si veda R. CAUSA,<br />
Vedutisti s<strong>tra</strong>nieri a Napoli, nel catalogo della mos<strong>tra</strong> Civiltà del <strong>Sette</strong>cento a Napoli 1734-<br />
1799 (Napoli, 1979-1980) Firenze, 1979, vol. I, pp. 330-337.<br />
46 Sull’artista si veda il catalogo della mos<strong>tra</strong> Hoüel. Voyage en Sicile 1776-1779, Paris<br />
(Musée du Louvre), 1991, a cura di M. Pinault. Inoltre, L. MASCOLI VALLET, Racconto e<br />
immagine: Saint-Non e Hoüel. La fortuna dei Voyages Pittoresques, in Viaggio nel Sud, op.<br />
cit., vol. I, p. 451 e sgg.<br />
290
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento<br />
gruppo di artisti — Châtelet, Paris, Desprez, Renard — che insieme a Vivant-<br />
Denon lavoravano alle tavole del Voyage Pittoresque à Naples et en Sicile. 47<br />
Valenciennes, partito da Roma proprio il giorno precedente, aveva fatto in<br />
tempo a vedere l’eruzione del Vesuvio da lontano, e tuttavia molto distintamente,<br />
come annotava nel suo diario di viaggio. 48 Non dovevano passare per lui<br />
molti giorni che la veduta di un altro vulcano gli si sarebbe presentata in tutto il<br />
suo splendore: il 22 agosto lo Stromboli lo avrebbe colpito per l’aspetto inusuale<br />
del suo cratere e soprattutto per le fiammate, simili a fuochi d’artificio. 49 Di<br />
ritorno a Napoli, Valenciennes lasciava spazio, nella scarna prosa del suo diario,<br />
a una descrizione dettagliata dell’ascesa al Vesuvio: «après avoir marché pendant<br />
3 milles dans les laves anciennes et modernes, nous sommes arrivés au<br />
pied de ce volcan, où j’ai vu des pierres d’une grosseur prodigieuse qui ont été<br />
lancées par le cratère. Laves jettés par la bouche à une hauteur prodigieuse...<br />
Toutes sortes de laves très curieuses. Sels, cristaux et soufres de la plus grande<br />
beauté. Soufres vitrioliques des plus ex<strong>tra</strong>ordinaires...». 50 (fig. 3).<br />
Se, dovendo spiegare l’origine della località denominata la Solfatara —<br />
luogo più volte disegnato dagli artisti del XIX secolo — Valenciennes aveva<br />
premesso che si <strong>tra</strong>ttava di «une chose très curieuse pour les naturalistes», la<br />
stessa precisazione non era ritenuta necessaria per il Vesuvio. 51 Di fatto, però,<br />
egli era rimasto stupito non solo davanti agli effetti cromatici della lava, ma<br />
dalla sua potenza dirompente, dalla quantità e varietà di sali, cristalli, zolfi.<br />
Questo interesse per la materia, per le sue s<strong>tra</strong>tificazioni, non trova solo un<br />
riscontro all’interno del corpus delle opere di Valenciennes di cui è nota, grazie<br />
al catalogo della vendita di oggetti trovati nel suo atelier, una «collection de<br />
coquillages», ma in un’attenzione più generalizzata ai fenomeni della natura,<br />
47 L’opera più recente e completa sul Voyage pittoresque à Naples et en Sicile de l’Abbé<br />
de Saint-Non è il testo di P. LAMERS, Il viaggio nel Sud dell’Abbé de Saint-Non. Il «Voyage<br />
pittoresque à Naples et en Sicile»: la genesi, i disegni preparatori, le incisioni, Napoli, 1995.<br />
L’opera, che ha il pregio di riunire molti dei disegni preparatori, ha un catalogo ordinato alfabeticamente<br />
secondo il nome dei disegnatori, non rispettando così la sequenza originale delle<br />
tavole del testo.<br />
48 G. LACAMBRE, Pierre-Henri de Valenciennes en Italie: un journal de voyage inédit,<br />
«Bulletin de la société de l’histoire de l’art français», 1978, pp. 139-172 (loc.cit., p. 146).<br />
L’eruzione del Vesuvio del 22 ottobre 1822, osservata da Jean-Charles-Joseph Rémond<br />
durante il suo primo viaggio in Italia (1821-1825), sarà il soggetto di un dipinto datato 1842 e<br />
destinato alla decorazione della Galleria di Mineralogia del Jardin des Plantes di Parigi insieme<br />
a una veduta dello Stromboli, per i quali rimando a S. GUTWIRTH, Jean-Charles-Joseph<br />
Rémond (1785-1875), Premier Grand Prix de Rome du Paysage Historique, «Bulletin de la<br />
société de l’histoire de l’art français», 1981, pp. 189-216.<br />
49 Ivi, p. 147.<br />
50 Ivi, p. 155.<br />
51 Ivi, p. 153.<br />
291
Chiara Stefani<br />
nella quale il fascino per il dato scientifico va di pari passo con la seduzione<br />
esercitata dall’aspetto estetico degli elementi. 52 Esisteva a questo proposito tutta<br />
una letteratura che si era formata e nutrita dell’esperienza del viaggio, durante il<br />
quale il dato nuovo e meraviglioso che diversi orizzonti geografici rivelavano,<br />
si <strong>tra</strong>sfigurava immediatamente, nella <strong>tra</strong>scrizione letteraria o nell’immagine<br />
incisa che l’accompagnava, in un potenziale modello estetico. 53<br />
Al pari di rocce e vulcani, le grotte e le cavità naturali at<strong>tra</strong>evano inevitabilmente<br />
l’occhio del viaggiatore sette-ottocentesco. A Napoli uno dei luoghi più<br />
celebri, in questo senso, era la grotta di Posillipo, ovvero di Seiano, costruita nel<br />
I secolo a.C., che univa, al fascino pittoresco della vegetazione a ridosso del<br />
monte, l’at<strong>tra</strong>ttiva magica del percorso scavato nella roccia fino a Pozzuoli.<br />
Nell’agosto del 1782 il pittore inglese Thomas Jones ne aveva <strong>tra</strong>cciato l’ingresso<br />
su di un foglio di carta dipinto a olio, con una gamma ristretta di tinte solari<br />
che facevano perdere al luogo il fascino cupo del cunicolo privo di luce, quale<br />
appariva nelle tavole incise del Voyage Pittoresque dell’Abbé de Saint-Non. 54<br />
Era grazie alla sua tavolozza che negli stessi anni i muri scrostati della città partenopea<br />
avrebbero conosciuto una dignità pittorica fino allora insperata, restando<br />
un unicum, non tanto nel formato estremamente ridotto del foglio, quanto<br />
nella selezione del taglio visivo e nella sintesi dei pochi elementi cromatici. 55<br />
A latere di queste immagini dell’Italia, un passo dei Memoirs di Thomas<br />
Jones rivela quanto ancora il pittore fosse debitore, alle stesse date, nei confron-<br />
52 Paris, Fondation Jacques Doucet, copie ms. V.P.1819 (Lugt n. 9578), II partie, n. 1.<br />
Sulla collezione si veda W. WHITNEY, Pierre-Henri Valenciennes: An Unpublished<br />
Document, «The Burlington Magazine», 1976, vol. 118, pp. 225-227.<br />
53 È questo il significato che si desume dalla lettura dei testi di B. M. STAFFORD, Rude<br />
Sublime: the Taste for Nature’s Colossi during the late Eighteenth and early Nineteenth<br />
Centuries, «Gazette des Beaux-Arts», 1976, t. LXXXVII, pp. 113-124 e Voyage into<br />
Substance. Art, Science, Nature and the Illus<strong>tra</strong>ted Travel Account 1760-1840, Cambridge<br />
and London, 1984.<br />
54 Sull’artista si vedano J. A. GERE, An oil-sketch by Thomas Jones, «British Museum<br />
Quarterly», XXI, 1957-59, pp. 93-94; E. RALPH, Thomas Jones 1742-1803: A Reappraisal of<br />
his Art, «Connoisseur», 1968, vol. 168, n. 675, pp. 8-14; J. A. GERE, Thomas Jones: An<br />
Eighteenth Century Conundrum, «Apollo», vol. 91, 1970, pp. 469-470. Inoltre, L. STAINTON,<br />
«La terra classica»: pittori inglesi a Napoli nel <strong>Sette</strong>cento e nell’Ottocento, in All’ombra del<br />
Vesuvio. Napoli nella veduta europea dal Quattrocento all’Ottocento, Napoli, 1990, pp. 69-74.<br />
55 Il dipinto ad olio su carta (mm.206x264) si trova a Londra in collezione privata, e sul<br />
verso porta la scritta: TJ Naples August 1782. È stato riprodotto in F. W. HAWCROFT, Travels<br />
in Italy 1776-1783. Based on the Memoirs of Thomas Jones, (Whitworth Art Gallery, 1988)<br />
University of Manchester, 1988, n. 132, p. 111. Studi ad olio su carta, e di dimensioni ancor<br />
più ridotte, con i muri di Napoli si trovano all’Ashmolean Museum di Oxford, al National<br />
Museum and Gallery di Cardiff, e alla National Gallery di Londra: sono stati di nuovo esposti<br />
alla mos<strong>tra</strong> In the Light of Italy, cit., nn. 8-10, pp. 120-122. Per la tavola del Voyage<br />
dell’Abbé de Saint-Non si veda P. LAMERS, op. cit., p. 115, n. 21.<br />
292
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento<br />
ti di una visione convenzionale del paesaggio, nutrita di rimandi pittorici e legata<br />
a un preciso immaginario. Nel giugno del 1781 Thomas Jones descriveva<br />
infatti in questi termini un luogo dei dintorni di Napoli: «This sequestred place<br />
was environed on all sides, with hanging Roks here and there protunding themselves<br />
from behind dark masses of a variety of wild Shrubs, and overshadowed<br />
by branching trees.» 56 La scena era colta in tutta la sua potenzialità pittoresca,<br />
ma ancora mancava qualcosa per renderla pienamente tale e così Thomas Jones<br />
si rivolgeva all’amico: «Here, [says I, Mr Towne, ] is Salvator Rosa in perfection,<br />
we only want Banditti to compleat the Picture.» 57<br />
Ingrediente necessario delle scene che dovevano suscitare, secondo alcuni<br />
<strong>tra</strong>ttatisti, spavento e orrore, il brigante forniva al paesaggista un modello per gli<br />
studi di figura ritenuti anche per lui, come per il pittore di storia, una tappa indispensabile<br />
dell’apprendistato artistico. Era anche per l’aspetto variopinto dei<br />
costumi indossati che il brigante si prestava a un esercizio pittorico, come nel<br />
caso dei dipinti dello svizzero Léopold Robert. 58 Quasi contemporaneamente,<br />
Romain Colomb, cugino di Stendhal, indugiava a lungo e con una ricchezza di<br />
dettagli quasi lenticolare sui costumi dei briganti, nel suo Journal d’un voyage en<br />
Italie et en Suisse pendant l’année 1828, pubblicato a Parigi nel 1833: «Les bandits<br />
sont vêtus d’une manière à peu près uniforme; leur costume pittoresque a<br />
quelque chose de militaire: culotte courte en drap bleu, avec de longues boucles<br />
d’argent sur des jarretières rouges; gilet de même étoffe orné de deux ranges de<br />
boutons d’argent; veste ronde, également en drap bleu, garnie de poches de chaque<br />
côté; manteau de drap brun jeté sur l’épaule; chemise ouverte, à col rabattu;<br />
une cravate, dont les deux bouts sont réunis par les anneaux et bagues volés; chapeau<br />
de feutre roux, pointu et de forme élevée, avec des cordons ou rubans de<br />
diverses couleurs; bas attachés à la jambe par de petites bandes de cuir, qui tiennent<br />
à une sandale ou des brodequins serrés; large ceinture de cuir avec des fentes<br />
pour recevoir des cartouches, et fixée par des agrafes d’argent...» 59 (fig. 4).<br />
Insieme alle figure femminili di paesane, gli studi singoli di briganti costituiscono<br />
l’immagine degli abitanti dell’Italia forse più veritiera, anche se priva di<br />
intenti realistici. Non appena fatto ritorno nel paese di appartenenza, il pittore si<br />
sarebbe infatti servito degli studi di figura a scopo puramente esornativo, come<br />
dimos<strong>tra</strong> il Paysage inspiré de la vue de Frascati, 60 dipinto nel 1822 da Achille-<br />
56 A. P. OPPÉ (a cura di), Memoirs of Thomas Jones, «The Walpole Society», vol. 32,<br />
1946-48, loc.cit., pp. 103-104.<br />
57 Ibid.<br />
58 Su di lui si veda la monografia di P. GASSIER, Léopold Robert, Neuchâtel, 1983.<br />
59 Il brano è citato da Y. HERSANT, Italies. Anthologie des voyageurs français aux XVIIIe<br />
et XIXe siècles, Paris, 1988, p. 734.<br />
60 Sul significato di questo dipinto (Paris, Musée du Louvre, inv.6633), e sulla sua copia<br />
da parte di Corot, rimando al mio Corot peintre d’après nature Corot, un artiste et son temps,<br />
293
Chiara Stefani<br />
Etna Michallon, primo vincitore del Grand Prix de Paysage Historique. Qui la<br />
figura del brigante Masocco, 61 che l’artista aveva studiato dal vero nelle prigioni di<br />
Termini nel 1820, fa parte del gruppo in calma contemplazione della coppia che<br />
danza al centro di una radura, in un rapporto armonico <strong>tra</strong> figure e paesaggio,<br />
ovvero <strong>tra</strong> uomo e natura. Ben presto, le immagini folcloriche di briganti e di paesane<br />
avrebbero ceduto il posto a quelle malinconiche di giovani e bambini, dove il<br />
pennello di Corot sarebbe stato capace di spostare l’accento dall’esterno all’interno<br />
della figura. 62 Eppure, nonostante lo sguardo triste e spesso rassegnato di questa<br />
umanità colta da vicino e forse dal vero, ben al<strong>tra</strong> sarebbe stata la sua <strong>tra</strong>sposizione<br />
pittorica una volta che l’immagine dell’Italia rivivesse nel ricordo dell’artista.<br />
Ne è un esempio il Site des environs de Naples, 63 dipinto da Corot nel 1841,<br />
<strong>tra</strong> il secondo e il terzo viaggio in Italia: non tanto un paesaggio con elementi<br />
topografici riconoscibili, quanto un’idea dei dintorni di Napoli, almeno a prima<br />
vista. Ma una lettura più attenta rivela che il motivo del ballo, at<strong>tra</strong>verso il precedente<br />
di Achille-Etna Michallon, maestro per breve tempo di Corot, risale al<br />
Paesaggio con figure danzanti di Claude Lorrain della Galleria Doria Pamphilj<br />
(1648), diffuso dalle incisioni di François Vivarès (1766), James Mason (1774), e<br />
Wilhelm Friedrich Gmelin (1804), <strong>tra</strong> la fine del <strong>Sette</strong> e l’inizio dell’Ottocento.<br />
All’epoca del primo viaggio in Italia Corot doveva possedere già una perfetta<br />
conoscenza della <strong>tra</strong>dizione paesaggistica seicentesca, e può darsi che, a visitare<br />
a nord di Roma la zona dove sorge la villa chiamata La Crescenza, <strong>tra</strong> la via<br />
Cassia e la Flaminia, lo spingessero ben precise memorie pittoriche. 64 Qui infatti<br />
op. cit., pp. 193-225. Per la bibliografia sul dipinto si veda Achille-Etna Michallon, op. cit., n.<br />
111, p. 167.<br />
61 Ibid., n. 43, p. 125. Il dipinto di Léon Cogniet Femme de brigand fouillant une malle<br />
(cm.35, 2x27, 1) che ne costituiva il pendant, è recentemente riapparso sul mercato, come mi<br />
segnala Loïc Stavridès che colgo qui l’occasione di ringraziare.<br />
62 Alludo in particolare al Jeune Italien assis dans la chambre de Corot à Rome (Reims,<br />
Musée des Beaux-Arts — Robaut 57) e alla Jeune Italienne de Papigno tenant sa quenouille<br />
(coll.privata New York — Robaut 62), per la cui bibliografia rimando al catalogo Corot, op.<br />
cit., cat.18-19, pp. 102-104. Sul rapporto, per la figura di ragazzo, con un disegno preparatorio<br />
e sullo spostamento di accento verso l’interiorità delle figure già in Michallon, rimando al<br />
mio Corot peintre d’après nature (si veda qui nota 60).<br />
63 Springfield (Massachusetts), Museum of Fine Arts — Robaut 377. Per la bibliografia<br />
Corot, cit., cat.77, pp. 230-40. Corot aveva eseguito una copia del Paysage inspiré de la vue<br />
de Frascati di Achille-Etna Michallon, per la quale rimando al mio contributo Corot, peintre<br />
d’après nature, (si veda qui nota 60).<br />
64 Si veda a questo proposito A. e R. JULLIEN, Les campagnes de Corot au nord de Rome<br />
1826-1827, «Gazette des Beaux-Arts», XCIX, 1982, pp. 169-202. Inoltre, degli stessi autori,<br />
Corot dans les montagnes de la Sabine, CIII, 1984, pp. 179-197, e Corot dans les Castelli<br />
romani, «Gazette des Beaux-Arts», CX, 1987, pp. 109-130.<br />
294
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento<br />
si trovava un edificio dalle mura merlate, una specie di casa fortezza che ornava lo<br />
sfondo di un paesaggio di Claude Lorrain, oggi al Metropolitan Museum di New<br />
York. 65 Cosa essa evocasse per gli artisti che vi si recavano a più di un secolo di<br />
distanza si può forse immaginare. C’era il fascino del luogo classico, non tanto per<br />
le forme architettoniche dell’edificio — che classiche non potevano certo dirsi-,<br />
quanto per quell’incastro riuscito <strong>tra</strong> edificio e paesaggio. La Crescenza poggiava<br />
su di una specie di avvallamento della collina, e Claude Lorrain, ponendola nel<br />
suo dipinto a distanza, incorniciata da un gruppo di alberi sulla sinis<strong>tra</strong> e da una<br />
pianta sulla des<strong>tra</strong>, l’aveva resa una sorta di controparte simbolica del pastore<br />
seduto di spalle, in primo piano, a custodia dei buoi. In altri termini, la Crescenza<br />
marcava uno spazio in cui l’uomo conviveva armonicamente con gli animali e con<br />
i suoi simili: un paesaggio quindi abitato, come l’edificio stava a indicare.<br />
Erano queste le immagini dell’Italia sulle quali si formavano i paesaggisti,<br />
prima di farne un’esperienza visiva diretta. Si capisce così come il pittore norvegese<br />
Johan Christian Clausen Dahl potesse <strong>dipingere</strong> nel 1818 un Paesaggio<br />
italiano, due anni prima del suo unico viaggio in Italia 66 . Proprio nello stesso<br />
momento venivano commissionate, all’inglese Turner, delle vedute ad acquarello<br />
per illus<strong>tra</strong>re il Picturesque Tour of Italy di James Hakewill. Come è stato già<br />
sottolineato, Turner eseguì il lavoro mescolando alle proprie risorse creative una<br />
conoscenza di seconda mano dell’Italia, dove si sarebbe recato solo nell’estate<br />
del 1819. 67 Nei suoi taccuini restano le <strong>tra</strong>cce di una preparazione attenta del<br />
viaggio sulle guide turistiche del tempo, mentre la frequentazione di stampe e<br />
dipinti doveva senza dubbio concorrere alla formazione della sua immagine<br />
dell’Italia. Forse anche lui, come molti altri artisti, giunto in Italia, si sarebbe<br />
espresso con le parole di Goethe al suo arrivo a Roma: «Tutti i sogni della mia<br />
gioventù li vedo ora vivere; le prime incisioni di cui mi ricordo (mio padre<br />
aveva appeso ai muri di un vestibolo le vedute di Roma) le vedo nella realtà, e<br />
tutto ciò che conoscevo già da lungo tempo, ri<strong>tra</strong>tto in quadri e disegni, inciso<br />
su rame o su legno, riprodotto in gesso o in sughero, tutto è ora davanti a me;<br />
ovunque vado scopro in un mondo nuovo cose che mi son note; tutto è come me<br />
l’ero figurato, e al tempo stesso tutto è nuovo.» 68<br />
65 Per il dipinto di Claude Lorrain si veda M. RÖTHLISBERGER, Aggiunte a Claude, «Paragone»,<br />
vol. 20, 1969, pp. 54-58; per quello di Corot, P. GALASSI, Corot in Italy, cit., 1991, p. 148.<br />
66 È un olio su tela conservato a Oslo, Natjonalgalleriet (Inv. 270) per il quale si rimanda<br />
a Romanticismo, op. cit., cat. 40, pp. 127-128. Sull’artista si veda la monografia di M. L.<br />
BANG, Johan Christian Dahl 1788-1857. Life and Works, Arlöv, 1987.<br />
67 C. POWELL, Topography, Imagination and Travel. Turner’s Relationship with James<br />
Hakewill, «Art History», vol. V, 1982, n. 4, pp. 408-425. Su Turner illus<strong>tra</strong>tore e incisore si<br />
veda anche L. HERRMANN, Turner Prints. the Engraved Work of J.M.W. Turner, Oxford, 1990.<br />
68 J. W. GOETHE, op. cit., p. 138. Si ricordi che Goethe era anche disegnatore, e su questo<br />
aspetto della sua attività si vedano i cataloghi delle mostre L’invito al viaggio. Disegni di<br />
295
Chiara Stefani<br />
È fra questi due estremi, <strong>tra</strong> lo stupore di una realtà nuova e la conferma di<br />
un’idea preformata, che si colloca il viaggio in Italia, e quindi le immagini,<br />
siano esse dipinte o metaforiche, che ne derivano. È dunque anche su questo terreno<br />
che i documenti figurativi e letterari si incon<strong>tra</strong>no e trovano un punto di<br />
contatto comune. D’al<strong>tra</strong> parte, come è noto, spesso artisti e scrittori viaggiavano<br />
insieme: è il caso di Dominique Vivant Denon a fianco dell’équipe incaricata<br />
di preparare le illus<strong>tra</strong>zioni per il Voyage Pittoresque dell’Abbé de Saint-Non, di<br />
Richard Payne Knight 69 che percorse la Sicilia in compagnia di Jacob Philipp<br />
Hackert e, non da ultimo, di Goethe e di Christoph Heinrich Kniep. 70 Forse<br />
un’esempio riuscito di questo connubio si trova in un passo del Voyage en Sicile<br />
di Dominique Vivant-Denon dove rivive, at<strong>tra</strong>verso la duplice similitudine — ut<br />
poesia natura e ut natura pictura — il celebre paragone dell’ut pictura poësis.<br />
Giunto infatti al monte Etna Vivant-Denon lascia spazio, nel suo resoconto, a<br />
una riflessione che sarà ripresa nel <strong>tra</strong>ttato di Valenciennes: «Les champs élysées<br />
et l’enfer des Grecs semblent avoir été imaginés ou copiés d’après l’Etna.<br />
Il faut être également poëte et peintre pour décrire. Les habitations éparses ressemblent<br />
à ces paysages de Boûcher...». 71<br />
Questa abitudine a guardare il paesaggio in termini pittorici era diventata un<br />
tòpos, e non solo negli scritti letterari: nel suo diario di viaggio del 1777, rimasto<br />
inedito, Richard Payne Knight, davanti alle tinte perlacee del panorama che<br />
gli si presentava lasciando Napoli per la Sicilia, ricordava i dipinti di Claude<br />
Lorrain; 72 Pierre-Henri de Valenciennes, nel suo Journal manoscritto relativo al<br />
viaggio in Italia, cominciato nel 1779, ricorreva a Salvator Rosa per spiegare la<br />
bellezza delle conformazioni rocciose di Salerno; 73 e François-Marius Granet,<br />
nelle sue note autobiografiche, ricordava che al suo arrivo a Roma nel 1802 la<br />
piazza del Popolo gli aveva fatto venire in mente un dipinto di Giovanni Paolo<br />
Panini. 74<br />
Goethe su Roma e la campagna romana, a cura di P. CHIARINI, Roma, 1987; Goethe a Roma.<br />
Disegni e acquarelli da Weimar, a cura di P. Chiarini, Roma, 1988; Goethe e l’Italia, Milano,<br />
1989; Goethe in Sicilia. Disegni e acquarelli da Weimar, a cura di P. Chiarini, Roma, 1992;<br />
Goethe in Italia. Disegni e acquarelli da Weimar, a cura di R. Venuti, Roma, 1995.<br />
69 L. GIARDINA, La Expedition into Sicily — 1777 di Richard Payne Knight, in Viaggio<br />
nel Sud, cit., vol. I, pp. 307-316.<br />
70 G. STRIEHL, Christoph Heinrich Kniep. Zeichner an Goethes Seite zwischen<br />
Klassizismus, Realismus und Romantik, Hildesheim, 1993.<br />
71 D. VIVANT DENON, Voyage en Sicile (Paris, Didot l’Aîné, 1788) edizione citata, Paris,<br />
1993, p. 22.<br />
72 C. STUMPF (ed.), Richard Payne Knight — Expedition into Sicily, London, 1986, p. 26.<br />
73 G. LACAMBRE, op. cit., p. 147.<br />
74 Mémoires de Granet, p. 1670 della <strong>tra</strong>scrizione del manoscritto presso il Musée Granet<br />
di Aix-en-Provence, che Denis Coutagne mi ha gentilmente fatto pervenire. A lui rivolgo un<br />
sincero ringraziamento.<br />
296
<strong>Vedere</strong>, <strong>descrivere</strong> e <strong>dipingere</strong> l’Italia <strong>tra</strong> <strong>Sette</strong> e Ottocento<br />
L’immagine dell’Italia non era tuttavia solo precostituita su di una conoscenza<br />
profonda della <strong>tra</strong>dizione pittorica. Così come lo scrittore avrebbe rielaborato<br />
a posteriori l’esperienza del viaggio — quale è ad esempio il caso dell’Italienische<br />
Reise di Goethe —, così l’artista avrebbe consegnato ai posteri, o esposto<br />
pubblicamente ai Salons, paesaggi composés, ovvero composti nell’atelier dopo<br />
aver eseguito studi d’après nature. Questa rielaborazione dei testi pittorici è<br />
sempre il frutto di un rapporto con le fonti che ben difficilmente l’esperienza del<br />
viaggio, e quindi l’immagine diretta dell’Italia, sarebbero riuscite a cambiare,<br />
come mos<strong>tra</strong>no alcuni esempi.<br />
Nel luglio del 1821 Achille-Etna Michallon termina il dipinto con Phiritoos<br />
poursuivant un Centaure, esposto prima nell’Urbe e poi a Parigi fra gli envois<br />
de Rome di quell’anno, e ora al Museo del Louvre. 75 Se dal punto di vista compositivo<br />
l’artista riprendeva un’impaginatura lungo linee diagonali, a lui cara e<br />
già messa a punto precedentemente, i motivi paesaggistici studiati in Italia si<br />
trovavano fusi, proprio allo scadere del suo soggiorno a Roma, in un insieme<br />
privo di precedenti. Tutto il primo piano del dipinto, che occupa da solo più di<br />
un terzo della tela, sembra uno studio dal vero di boscaglia, mentre la cascata, lo<br />
sfondo con le rocce sulla des<strong>tra</strong>, e il tempio su di un colle in lontananza sono il<br />
miglior riassunto delle tappe dell’artista nel corso del suo viaggio in Italia:<br />
Tivoli, o forse piuttosto Terni, il tempio di Segesta o quello di Nettuno a<br />
Paestum. Tuttavia, come non riconoscere, nel masso roccioso sulla des<strong>tra</strong>, un<br />
motivo che assomiglia sì alle conformazioni delle «latomie» di Siracusa – visitate<br />
dall’artista –, ma anche a tanti dettagli dei paesaggi di Salvator Rosa?<br />
L’abitudine di giocare con le fonti, mescolandole agli studi dal vero, era propria<br />
anche di Corot. Nel dipinto esposto al Salon del 1839 con il titolo Site<br />
d’Italie au soleil levant, e ora al Paul Getty Museum di Malibu (fig. 1), l’inserto,<br />
sullo sfondo a sinis<strong>tra</strong>, di uno studio eseguito al lago di Piediluco 76 , convive<br />
con il motivo del passaggio del guado in primo piano, derivato dalla pittura nordica,<br />
forse anche per il <strong>tra</strong>mite di Claude Lorrain (fig. 5), mentre sulla des<strong>tra</strong> del<br />
dipinto il ballo della tarantella e le rovine in lontananza sono rimandi immediati<br />
ma generici all’Italia. Se in un caso del genere le memorie iconografiche en<strong>tra</strong>vano<br />
in gioco al pari della pittura cosidetta de ressouvenir, basata sulle immagi-<br />
75 Paris, Musée du Louvre inv.6631. Per la bibliografia Achille-Etna Michallon, cit., n.<br />
100, p. 155 da integrare ora con S. SUSINNO, Echi della pittura di paese nella stampa periodica<br />
romana di primo Ottocento, in Corot, un artiste et son temps, cit., pp. 457-476.<br />
Sull’assimilazione di modelli studiati in Italia rimando al mio saggio L’oeuvre graphique de<br />
Michallon dans le cadre de la peinture de paysage à la fin du XVIII siècle, in Achille-Etna<br />
Michallon, cit., pp. 49-62.<br />
76 Le Lac di Piediluco (The Visitors of the Ashmolean Museum, Oxford A 403 – Robaut<br />
123). Per la bibliografia Corot, cit., cat. 25, p. 116.<br />
297
Chiara Stefani<br />
ni effettivamente viste e richiamate alla mente, in altri casi poteva verificarsi un<br />
processo di sovrapposizione. 77 Quando Corot dipinse il nudo femminile della<br />
Marietta, non a caso scrisse il suo nome in alto a sinis<strong>tra</strong> accompagnato dall’indicazione<br />
«à Rome», 78 per evidenziare che si <strong>tra</strong>ttava di uno studio dal vero,<br />
eseguito in Italia, e sgombrare il campo da possibili citazioni. Infatti, come non<br />
pensare immediatamente alle odalische di Ingres, per poi risalire alle Veneri di<br />
Tiziano?<br />
Tra vedere e <strong>dipingere</strong> l’Italia, come <strong>tra</strong> vederla e descriverla, si interpone<br />
sempre un filtro che dipende da vari fattori — l’educazione dell’artista, lo scopo<br />
del viaggio, l’orizzonte di attesa del pubblico o del committente — e che sta a<br />
noi di volta in volta decifrare e interpretare. Ben sapendo che, come scriveva<br />
Giuliano Briganti, di rimando a un passo di Roberto Longhi, «non dobbiamo<br />
mai dimenticare che si vede sempre e soltanto quello che si vuole vedere o si è<br />
condizionati a vedere.» 79<br />
* Alla descrizione è stato dedicato il numero monografico di Yale French<br />
Studies, «Toward a Theory of Description», n. 61, 1981, che affronta il problema<br />
in campo storico-artistico solo relativamente alle nature morte (pp. 276-<br />
298). La scelta delle immagini, dovendo essere necessariamente contenuta, è<br />
stata effettuata soprattutto in rapporto ai testi citati e alle tematiche più importanti:<br />
rapporto con l’antico e la <strong>tra</strong>dizione (fig. 1), studio della luce (fig. 2),<br />
natura informe (fig. 3), immagine degli italiani (fig. 4), immagine dell’Italia già<br />
conosciuta prima del viaggio (fig. 5).<br />
Sono grata a Stefano Susinno per per avermi offerto l’occasione, prima del<br />
convegno, di riflettere su questi temi nel corso della lezione-seminario dal titolo<br />
“Corot in Italia. Precedenti e contesto di un’esperienza di viaggio pittorico”, da<br />
me tenuta dal Dipartimento delle Arti Visive dell’Università degli Studi di<br />
Bologna (22.4.1996).<br />
77 Di studi de ressouvenir parla già R. DE PILES, op. cit., pp. 121-122. A proposito del termine,<br />
impiegato da Valenciennes, si veda inoltre G. LACAMBRE, Une lettre de Pierre-Henri de<br />
Valenciennes à une jeune élève, «Archives de l’Art Français», t. XXVIII, 1986, pp. 159-160.<br />
78 L’Odalisque romaine ou Marietta (Paris, Musée du Petit Palais, Inv. P. Dut. 1158 —<br />
Robaut 458). Per la bibliografia Corot, cit., cat.85, p. 256 dove non si presta alcuna attenzione<br />
al fatto che il dipinto porti la scritta «Marietta à Rome».<br />
79 G. BRIGANTI, I vedutisti, Milano, s.d., p. 13; R. Longhi, Velasquez 1630: la rissa<br />
all’Ambasciata di Spagna, «Paragone», 1950, pp. 30-40.<br />
298