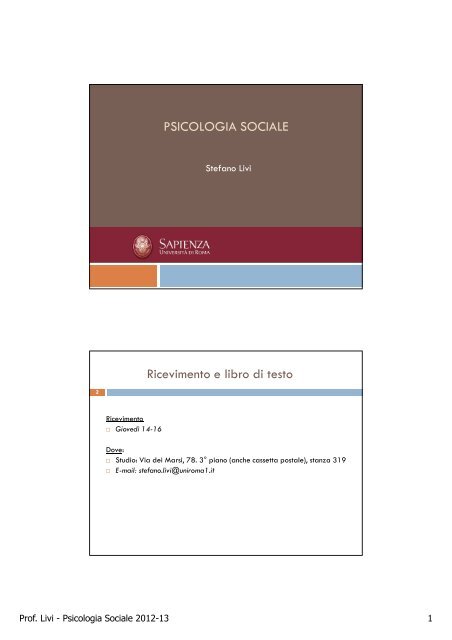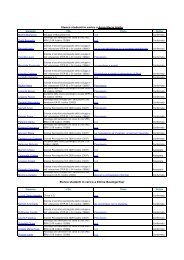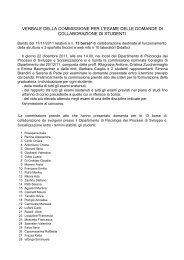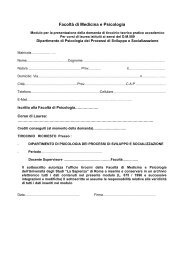Psicologia Sociale CLASS 2012-13 parte I - Dipartimento di ...
Psicologia Sociale CLASS 2012-13 parte I - Dipartimento di ...
Psicologia Sociale CLASS 2012-13 parte I - Dipartimento di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PSICOLOGIA SOCIALE<br />
Stefano Livi<br />
Ricevimento e libro <strong>di</strong> testo<br />
2<br />
Ricevimento<br />
Giovedì 14-16<br />
Dove:<br />
Stu<strong>di</strong>o: Via dei Marsi, 78. 3° piano (anche cassetta postale), stanza 319<br />
E-mail: stefano.livi@uniroma1.it<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 1
Ricevimento e libro <strong>di</strong> testo<br />
3<br />
Piano del corso: Esercitazioni, presentazioni<br />
Esame<br />
Preaccertamento <strong>di</strong>cembre:15 domande a scelta multipla e 3 domande aperte (0-5) .<br />
Orale a richiesta<br />
Tutti gli altri appelli, orale.<br />
Punti-esame aggiungibili: 1 (questionario e/o esperimento)<br />
Testi d’esame:<br />
Or<strong>di</strong>ne degli stu<strong>di</strong>:<br />
Mannetti (2002). <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong>. Carocci.<br />
Corso:<br />
Boca, Bocchiaro, Scaffi<strong>di</strong> (2003). Introduzione alla <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong>. Il Mulino<br />
Speltini, Palmonari (1998). I Gruppi Sociali. Il Mulino.<br />
Appunti<br />
<br />
Appunti:<br />
http://<strong>di</strong>p38.psi.uniroma1.it/dppss/livi<br />
I<br />
INTRODUZIONE ALLO STUDIO E AI<br />
PRINCIPALI ORIENTAMENTI TEORICI<br />
DELLA PSICOLOGIA SOCIALE<br />
Rif: Cap. 1 Boca, Bocchiaro, Scaffi<strong>di</strong><br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 2
5<br />
Breve lista <strong>di</strong> riviste per <strong>Psicologia</strong> che trattano <strong>di</strong><br />
psicologia dei gruppi<br />
In italiano<br />
Giornale Italiano <strong>di</strong> <strong>Psicologia</strong> (Il Mulino)<br />
<strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> (Il Mulino)<br />
Rassegna <strong>di</strong> <strong>Psicologia</strong> (Carocci)<br />
In lingua inglese<br />
Journal of Personality and Social Psychology<br />
European Journal of Social Psychology<br />
Group Dynamics: Theory, Research and Practice<br />
Personality and Social Psychology Review o Personality and Social<br />
Psychology Bulletin<br />
Social Psychological and Personality Science<br />
Current Research in Social Psychology (online:<br />
http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html)<br />
6<br />
<br />
Letture e approfon<strong>di</strong>menti consigliati<br />
Manuali:<br />
Fiske, Gilbert, Lindzey (2010), Handbook of Social<br />
Psychology, (Vol. 2), 5th ed. New York: McGraw-Hill.<br />
Reis, Judd (2000). Handbook of research methods in<br />
social and personality psychology. Cambridge<br />
University Press<br />
Manuali in italiano (1800 su Amazon?)<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 3
DEFINIRE<br />
LA PSICOLOGIA SOCIALE<br />
Una definizione <strong>di</strong> <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong><br />
“La <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> è la scienza<br />
che stu<strong>di</strong>a il modo in cui pensieri,<br />
sentimenti ed azioni sono influenzati<br />
dalla presenza, vera o immaginaria o<br />
implicita, degli altri.”<br />
(Gordon Allport, 1968)<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 4
Che cosa stu<strong>di</strong>a la psicologia sociale?<br />
9<br />
Il livello intrain<strong>di</strong>viduale Stu<strong>di</strong>a le modalità con<br />
cui l’in<strong>di</strong>viduo analizza la realtà e costruisce<br />
un’immagine del mondo sociale che lo circonda.<br />
Il livello intragruppo Analizza le <strong>di</strong>namiche<br />
interpersonali tra più soggetti che fanno <strong>parte</strong> <strong>di</strong> un<br />
medesimo gruppo (es. processi <strong>di</strong> conformismo,<br />
devianza, comunicazione e leadership).<br />
Il livello intergruppo Stu<strong>di</strong>a le relazioni<br />
esistenti tra gruppi sociali <strong>di</strong>fferenti.<br />
Il livello collettivo Prende in considerazione i<br />
processi sociali legati al contesto culturale e<br />
storico in cui gli in<strong>di</strong>vidui si trovano ad operare.<br />
Da Carrus, 2007<br />
Obiettivi <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong>:<br />
esempi <strong>di</strong> ricerca<br />
Comprendere le con<strong>di</strong>zioni per le quali gli<br />
in<strong>di</strong>vidui si conformano agli altri.<br />
(Milgram)<br />
Capire l’influenza dei gruppi (team,<br />
organizzazioni, associazioni) sugli<br />
in<strong>di</strong>vidui. (Asch)<br />
Comportamento antisociale (aggressività<br />
e comportamente d’aiuto) (Zimbardo)<br />
Devianza ed emarginazione<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 5
Obiettivi <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong>:<br />
esempi <strong>di</strong> ricerca<br />
L’effetto degli stili <strong>di</strong> leadership sulla<br />
prestazione dei singoli e del gruppo (Lewin).<br />
Rapporti tra gruppi sociali (tra gang,<br />
organizzazioni, minoranze e maggioranza).<br />
Rapporto tra in<strong>di</strong>viduo ed ambiente (rumore<br />
influenza comportamento prosociale).<br />
Applicazioni della <strong>Psicologia</strong><br />
<strong>Sociale</strong><br />
<br />
<br />
<br />
Salute. Comprensione dell’influenza <strong>di</strong> caratteristiche<br />
psicosociali su comportamenti preventivi (AIDS, alcolismo) o<br />
<strong>di</strong> comportamenti al volante.<br />
Marketing e Pubblicità. Aspetti sociali del comportamento<br />
economico (c. d’acquisto, efficacia <strong>di</strong> campagne pubblicitarie).<br />
– Persuasione<br />
Scuola: Interventi per intervenire su emarginati e bullismo<br />
Politica. Aspetti psicosociali delle campagne elettorali. -<br />
Propaganda<br />
<br />
<br />
Giurisprudenza. Comportamento <strong>di</strong> decisione delle giurie<br />
(selezioni scientifiche delle giurie).<br />
Integrazione immigrati: il pregiu<strong>di</strong>zio, le relazioni razziali e i<br />
conflitti <strong>di</strong> valore.<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 6
Assunzioni della <strong>Psicologia</strong><br />
<strong>Sociale</strong><br />
Comportamenti in<strong>di</strong>viduali o stati<br />
psicologici variano in funzione <strong>di</strong> altre<br />
persone o gruppi sociali<br />
Comportamenti in<strong>di</strong>viduali o stati<br />
psicologici sono dovuti, in <strong>parte</strong>, a<br />
sviluppi storici e culturali<br />
L’interazione sociale è bi<strong>di</strong>rezionale<br />
Assunzioni della <strong>Psicologia</strong><br />
<strong>Sociale</strong><br />
Gli in<strong>di</strong>vidui sono in grado <strong>di</strong> influenzare il<br />
proprio ambiente sociale<br />
Qualsiasi genere <strong>di</strong> organizzazione sociale<br />
- gruppi, team, o la società nel complesso<br />
- è il risultato <strong>di</strong> interazioni sociali.<br />
Qualsiasi tipo <strong>di</strong> gruppo sociale è più della<br />
somma delle singole interazioni o<br />
caratteristiche in<strong>di</strong>viduali.<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 7
I meto<strong>di</strong> della <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong><br />
Enfasi sulla scienza<br />
Metodo sistematico (Falsificabilità)<br />
Enfasi sui processi sociali<br />
Interazione sociale (reale o implicata)<br />
Enfasi sull’in<strong>di</strong>viduo<br />
Versus gruppi/sistemi (sociologia,<br />
scienze politiche, antropologia)<br />
<strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong>, saggezza popolare,<br />
filosofia ed altre scienze sociali<br />
A. La <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> si <strong>di</strong>fferenzia dalla “saggezza popolare” e dalla<br />
filosofia, perché le affermazioni sono verificare empiricamente.<br />
B. La <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> si <strong>di</strong>fferenzia dalle altre scienze sociali,<br />
perché in<strong>di</strong>vidua leggi generali sui processi <strong>di</strong> influenza sociale a<br />
livello in<strong>di</strong>viduale<br />
C. La <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> si <strong>di</strong>fferenzia dalla psicologia della<br />
personalità perché enfatizza il ruolo del contesto sociale in cui<br />
l’influenza si verifica<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 8
Scienza vs scienziati naive<br />
Errore fondamentale <strong>di</strong> attribuzione:<br />
Le persone tendono a spiegare il<br />
comportamento delle persone - proprio o<br />
altrui - in termini <strong>di</strong> tratti personalità,<br />
sottostimando il ruolo della situazione, e<br />
dell’influenza sociale, nel determinare il<br />
comportamento degli in<strong>di</strong>vidui.<br />
Critiche alla psicologia sociale<br />
La <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> spiega il senso<br />
comune?<br />
La <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> è scientifica?<br />
La <strong>Psicologia</strong> sociale può essere<br />
pericolosa?<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 9
19<br />
Come si è evoluta la teoria della<br />
psicologia sociale?<br />
Nel corso del XX secolo la psicologia sociale ha<br />
mantenuto la convinzione che l’in<strong>di</strong>viduo fosse un essere<br />
pensante, capace <strong>di</strong> generare ragionamenti valutazioni<br />
e inferenze.<br />
Tra gli anni ’50 e ‘60 stu<strong>di</strong>osi come Festinger con la sua<br />
teoria della <strong>di</strong>ssonanza cognitiva (1957) e Heider<br />
[1958] autore della teoria dell’equilibrio propongono<br />
una concezione dell’uomo come ricercatore <strong>di</strong> coerenza<br />
teso a cogliere l’equilibrio, da un lato, tra le credenze<br />
che possiede, dall’altro, tra il proprio sistema <strong>di</strong><br />
credenze ed i propri comportamenti.<br />
20<br />
Come si è evoluta la teoria della<br />
psicologia sociale?<br />
A partire dagli anni ’70 si afferma una nuova prospettiva<br />
che propone una concezione dell’in<strong>di</strong>viduo inteso non più<br />
come ricercatore <strong>di</strong> coerenza, ma come uno scienziato<br />
ingenuo (teorie naive).<br />
Successivamente, ci si è resi conto che l’in<strong>di</strong>viduo,<br />
avendo a <strong>di</strong>sposizione limitate risorse cognitive, deve<br />
ricorrere a delle strategie <strong>di</strong> elaborazione delle<br />
informazioni, le cosiddette euristiche, che gli consentono<br />
<strong>di</strong> risparmiare tempo e sforzi e, contemporaneamente,<br />
<strong>di</strong> ottenere delle informazioni sufficientemente<br />
atten<strong>di</strong>bili su quanto sta accadendo attorno a lui.<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 10
21<br />
Fino a che punto siamo consapevoli dei nostri<br />
pensieri?<br />
Non tutta l’attività della mente umana viene svolta<br />
in maniera consapevole. Compiti routinari (ad<br />
esempio, la lettura <strong>di</strong> un breve messaggio) possono<br />
essere attuati in maniera automatica con un carico<br />
attentivo bassissimo.<br />
I processi controllati, al contrario,<br />
presuppongono il controllo flessibile, intenzionale<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo e sono vincolati alla quantità <strong>di</strong><br />
attenzione attivata al momento (Bargh, 1989).<br />
22<br />
Fino a che punto siamo consapevoli dei nostri<br />
pensieri?<br />
Anche nell’elaborazione dell’informazione<br />
sociale facciamo ricorso a processi <strong>di</strong><br />
categorizzazione o giu<strong>di</strong>zio sociale che<br />
vengono, in buona <strong>parte</strong>, attivati in maniera<br />
automatica, cioè in<strong>di</strong>pendentemente dalla<br />
nostra consapevolezza<br />
Meccanismi alla base <strong>di</strong><br />
stereotipi e pregiu<strong>di</strong>zi<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 11
BREVE STORIA DELLA PSICOLOGIA<br />
SOCIALE E DEI SUOI ORIENTAMENTI<br />
TEORICI<br />
Stu<strong>di</strong>o scientifico della <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong><br />
24<br />
<br />
Lo stu<strong>di</strong>o scientifico della <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> inizia col 1890. Prima<br />
<strong>di</strong> allora filosofi analizzano la natura sociale dell’in<strong>di</strong>viduo (ad es.<br />
Aristotele e Machiavelli)<br />
Pietre miliari sino al 1960:<br />
<br />
<br />
1890: James propose <strong>di</strong>verse teorie per spiegare alcuni processi<br />
psicologico sociali, incluso il concetto <strong>di</strong> “identità sociale”.<br />
1895: LeBon pubblica “Le Psychologie des Foules”<br />
(dein<strong>di</strong>viduazione).<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 12
25<br />
Stu<strong>di</strong>o scientifico dei gruppi tra il 1890 e il 1960<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
1897: Durkheim analizza l’impatto dei gruppi sul comportamento<br />
sociale degli in<strong>di</strong>vidui (ed in particolare dai gruppi primari), col<br />
classico stu<strong>di</strong>o sul suici<strong>di</strong>o, che spiega come un’azione in<strong>di</strong>viduale può<br />
essere spiegata da forze sociali.<br />
1898: Triplett pubblica il primo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> laboratorio sulla<br />
facilitazione sociale (bicicletta)<br />
1908: Pubblicati i due primi volumi dal titolo “<strong>Psicologia</strong> sociale” uno<br />
ad opera <strong>di</strong> uno psicologo, William McDougall (“psicologia sociale<br />
psicologica” ), e l’altro <strong>di</strong> un sociologo, Edward E. Ross (psicologia<br />
sociale sociologica”).<br />
1920: Elton Mayo ad Hawthorne; <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> come i processi <strong>di</strong><br />
gruppo influenzano la produttività.<br />
1934: Moreno presenta la sociometria<br />
1936: Sherif: Primi stu<strong>di</strong> sulle norme sociali.<br />
1937: Lewin, Lippitt, e White stu<strong>di</strong>ano gli stili <strong>di</strong> leadership.<br />
26<br />
Stu<strong>di</strong>o scientifico della P.S. 1890 e il 1960<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Svolta della II Guerra Mon<strong>di</strong>ale.<br />
1943: Whyte usa l’osservazione <strong>parte</strong>cipante per stu<strong>di</strong>are le gang<br />
urbane (“Street corner society)”.<br />
1943: Newcomb esamina l’impatto della pressione sociale sugli<br />
atteggiamenti tra gli studenti del Bennington College.<br />
1946: Bales comincia a lavorare sull’ “Interaction Process<br />
Analysis”.<br />
1952: Esperimenti <strong>di</strong> Asch sulla pressione normativa<br />
1954: Pubblicazione dell’analisi <strong>di</strong> Allport su stereotipi e<br />
pregiu<strong>di</strong>zi.<br />
<br />
In Italia…<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> <strong>13</strong>
<strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> in Italia fino agli anni 70<br />
• Manuali <strong>di</strong> psicologia sociale in italiano<br />
Friedmann (1951). Introduzione alla psicologia sociale<br />
Asch (1955). <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong>.<br />
• Primi libri <strong>di</strong> psicologia sociale <strong>di</strong> autori italiani<br />
Sarfatti (1911). Note <strong>di</strong> <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> e inter-in<strong>di</strong>viduale.<br />
Reale (1923). Le aristocrazie: linee <strong>di</strong> psicologia sociale.<br />
Orano (1938). <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong>.<br />
Miotto (1939). <strong>Psicologia</strong> del comportamento sociale.<br />
Ancona (1952). La psicologia sociale negli Stati Uniti d’America<br />
Kanizsa (1956). Recenti ricerche in psicologia sociale<br />
De Grada (1972). Introduzione alla <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong>.<br />
• Rivista <strong>di</strong> <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> (1954-1973)<br />
• Libri <strong>di</strong> metodologia della ricerca psico-sociale <strong>di</strong> autori italiani<br />
<br />
De Grada (1972). Appunti <strong>di</strong> metodologia della ricerca psicologico sociale.<br />
<strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> in Italia<br />
Prime cattedre <strong>di</strong> <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong><br />
1969 Roma (De Grada); 1969 Trieste (Bozzi)<br />
S.I.Ps<br />
Società Italiana <strong>di</strong> <strong>Psicologia</strong><br />
A.I.P.<br />
Associazione Italiana <strong>di</strong> <strong>Psicologia</strong><br />
1995<br />
(prevalentemente accademici)<br />
S.I.Ps.<br />
(prevalentemente professionisti<br />
Div. <strong>di</strong> Ps. Sperimentale <strong>di</strong> base<br />
Div. Ps. dello Sviluppo<br />
Div. <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong><br />
Div. Ps. Dinamica e Clinica<br />
1995<br />
(53 soci)<br />
1996<br />
(75 soci)<br />
1997<br />
(98 soci)<br />
1° Congresso (Roma)<br />
1998<br />
(112 soci)<br />
2° Congresso (Firenze)<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 14
Principali orientamenti teorici<br />
Il Comportamentismo<br />
ha dominato la psicologia americana durante la<br />
prima metà del 900 e si è sviluppato a partire<br />
dalle ricerche sull’appren<strong>di</strong>mento negli animali.<br />
Assunzione <strong>di</strong> base: rifiuto <strong>di</strong> prendere in<br />
considerazione fenomeni non osservabili<br />
(“mentali” o “soggettivi”)<br />
Autori più rappresentativi: Pavlov (1927,<br />
con<strong>di</strong>zionamento classico), Skinner (1938,<br />
Con<strong>di</strong>zionamento operante),<br />
Principali orientamenti teorici<br />
Il Comportamentismo<br />
Watson ( 1924) e Skinner (1938): estensioni al<br />
comportamento umano:<br />
1. Il comportamento umano può essere<br />
spiegato facendo riferimento ai premi e alle<br />
punizioni (rinforzi positivi e negativi) presenti<br />
nell’ambiente;<br />
2. Non c’è alcun bisogno <strong>di</strong> ricorrere a concetti<br />
vaghi quali pensieri, emozioni, conoscenze,<br />
che non sono suscettibili <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o scientifico<br />
(non <strong>di</strong>rettamente osservabili).<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 15
Principali orientamenti teorici<br />
Il Comportamentismo<br />
bambino acquisisce un determinato repertorio<br />
comportamentale a seguito dei premi e delle punizioni che<br />
riceve dai genitori.<br />
l’appren<strong>di</strong>mento può avvenire semplicemente sulla base<br />
dell’osservazione dei rinforzi ricevuti da altri (appren<strong>di</strong>mento<br />
da un modello, Bandura, 1977).<br />
L’adozione <strong>di</strong> condotte aggressive potrebbe derivare<br />
dall’osservazione del comportamento <strong>di</strong> altri (adulti<br />
significativi, compagni, personaggi televisivi), che ottengono<br />
ricompense dopo aver messo in atto delle condotte<br />
aggressive.<br />
Principali orientamenti teorici<br />
Il Neocomportamentismo<br />
comportamentismo ra<strong>di</strong>cale soprattutto nell’ambito della<br />
psicologia sociale è stato notevolmente mo<strong>di</strong>ficato da autori<br />
successivi “neocomportamentisti”.<br />
il comportamento umano è troppo complesso per essere<br />
spiegato in termini <strong>di</strong> associazioni stimolo-risposta (modello S-<br />
R).<br />
anche pensieri ed emozioni possono essere in qualche modo<br />
stu<strong>di</strong>ati.<br />
riconoscono l’attività mentale del soggetto almeno in termini <strong>di</strong><br />
costrutto ipotetico che consente <strong>di</strong> spiegare la relazione tra<br />
stimolo e risposta,<br />
modello S (stimolo) -O (organismo)- R (risposta).<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 16
Principali orientamenti teorici<br />
La psicologia della Gestalt<br />
•I Gestaltisti ritenevano che la percezione <strong>di</strong><br />
oggetti significativi fosse il risultato della<br />
creazione da <strong>parte</strong> dei soggetti <strong>di</strong> configurazioni<br />
significative a partire da un insieme <strong>di</strong> stimoli<br />
elementari.<br />
• Secondo i Gestaltisti, il processo percettivo non è<br />
un mero rispecchiamento degli stimoli esterni, ma<br />
piuttosto un processo costruttivo <strong>di</strong> imposizione <strong>di</strong><br />
schemi mentali sulla realtà esterna.<br />
Principali orientamenti teorici<br />
La psicologia della Gestalt<br />
• Lewin ha esteso questo punto <strong>di</strong> vista in psicologia<br />
sociale:<br />
o Ciò che conta non è la realtà esterna, ma il modo<br />
in cui il soggetto percepisce tale realtà.<br />
• Il concetto centrale della teoria <strong>di</strong> Lewin è quello <strong>di</strong><br />
campo psicologico, concetto derivato dalla fisica<br />
teorica.<br />
• Il campo psicologico <strong>di</strong> un in<strong>di</strong>viduo è l’insieme <strong>di</strong><br />
tutti i fattori psicologicamente presenti in un dato<br />
momento e in grado <strong>di</strong> influenzare la condotta<br />
dell’in<strong>di</strong>viduo stesso.<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 17
Principali orientamenti teorici<br />
La psicologia della Gestalt<br />
•Il campo si articola in due regioni principali: la<br />
persona e l’ambiente<br />
•Sostenere, come fa Lewin e del resto anche Heider<br />
(1958), che la condotta sociale è influenzata<br />
dalle interpretazioni soggettive degli eventi vuol<br />
<strong>di</strong>re assumere una prospettiva fenomenologica, che<br />
si contrappone nettamente alla prospettiva<br />
comportamentista.<br />
Principali orientamenti teorici<br />
Il Cognitivismo <strong>Sociale</strong><br />
•Il cognitivismo sociale (Social Cognition)<br />
rappresenta un’evoluzione ulteriore del<br />
neocomportamentismo. E’ stato influenzato dagli<br />
stu<strong>di</strong> cognitivisti basati sull’intelligenza artificiale.<br />
•Il cognitivismo sociale focalizza attenzione sui<br />
processi mentali in<strong>di</strong>viduali, basandosi<br />
essenzialmente sulla metafora dell’uomo come<br />
elaboratore <strong>di</strong> informazioni ovvero su come<br />
l’in<strong>di</strong>viduo ricorda, seleziona e manipola le<br />
informazioni.<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 18
Principali orientamenti teorici<br />
L’interazionismo Simbolico<br />
I.S. cerca <strong>di</strong> risolvere il paradosso della relazione<br />
tra in<strong>di</strong>viduo e società:<br />
da un lato: solo gli in<strong>di</strong>vidui agiscono, e, quin<strong>di</strong>,<br />
la società, la cultura, i gruppi, le istituzioni,<br />
<strong>di</strong>pendono dalle azioni in<strong>di</strong>viduali.<br />
dall’altro lato: gli in<strong>di</strong>vidui possono agire solo in<br />
una società che fornisce gli “strumenti”per la<br />
condotta (linguaggio, cultura, struttura sociale,<br />
gruppi).<br />
Principali orientamenti teorici<br />
L’interazionismo Simbolico<br />
Il comportamento <strong>di</strong>pende dalla creazione e dal mantenimento del<br />
significato<br />
Pur non negando il ruolo dei fattori personali e culturali, danno<br />
maggiore importanza al fatto che la condotta prende forma mentre gli<br />
in<strong>di</strong>vidui interagiscono. (carattere emergente della condotta umana)<br />
La società e la cultura forniscono uno schema alla condotta umana,<br />
ma sono anche il prodotto <strong>di</strong> tale condotta.<br />
superamento della contrapposizione tra realismo e nominalismo:<br />
formazione della società e sviluppo dell’identità personale sono due<br />
facce <strong>di</strong> uno stesso processo che si verifica nell’interazione quoti<strong>di</strong>ana<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 19
In sintesi: Le visioni del mondo <strong>di</strong> due approcci alla<br />
psicologia <strong>Sociale</strong>:<br />
LA PSICOLOGIA SOCIALE “PSICOLOGICA”<br />
tesi nominalista sostiene che esistono solo gli<br />
in<strong>di</strong>vidui e le loro azioni e la società è solo il nome<br />
dato alla somma <strong>di</strong> tali azioni.<br />
tesi nominalista è quella dominante in psicologia e<br />
da essa deriva l’idea secondo la quale per<br />
comprendere i fenomeni sociali sia sufficiente<br />
comprendere i processi psicologici in<strong>di</strong>viduali.<br />
LA PSICOLOGIA SOCIALE “PSICOLOGICA”<br />
Il nominalismo è ben rappresentato da Allport<br />
che centra l’attenzione sui processi<br />
psicologici e considera i fattori sociali in<br />
termini <strong>di</strong> forze che intervengono per<br />
deviare/<strong>di</strong>storcere tali processi, considerati<br />
comunque come processi intrain<strong>di</strong>viduali.<br />
L’unità <strong>di</strong> analisi nella psicologia socialepsicologica<br />
è l’in<strong>di</strong>viduo.<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 20
LA PSICOLOGIA SOCIALE “SOCIOLOGICA”<br />
tesi realista sostiene che la società è<br />
l’unica vera realtà e gli in<strong>di</strong>vidui non sono<br />
che una manifestazione /prodotto <strong>di</strong> essa.<br />
secondo tali autori realisti le realtà sociali<br />
si impongono agli in<strong>di</strong>vidui i quali ne<br />
<strong>di</strong>ventano meri strumenti (determinismo<br />
sociale).<br />
LA PSICOLOGIA SOCIALE “SOCIOLOGICA”<br />
Hewitt (1996): la struttura sociale, la cultura, i<br />
ruoli, i gruppi, le organizzazioni e i<br />
comportamenti collettivi non sono ambienti nei<br />
quali vive l’in<strong>di</strong>viduo, ma rappresentano realtà in<br />
sé. Lo scopo finale non è spiegare cosa fanno<br />
gli in<strong>di</strong>vidui e perché, ma capire come la vita<br />
sociale sia possibile, come funzioni e come<br />
cambi nel tempo” .<br />
Prof. Livi - <strong>Psicologia</strong> <strong>Sociale</strong> <strong>2012</strong>-<strong>13</strong> 21