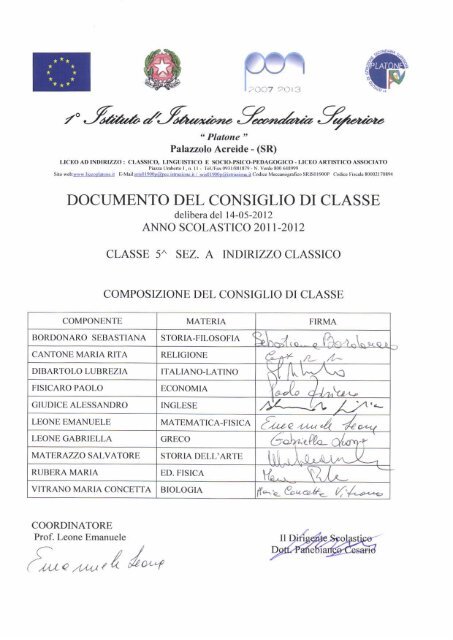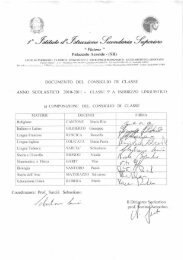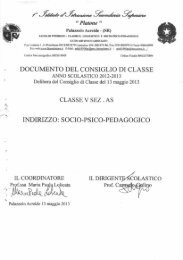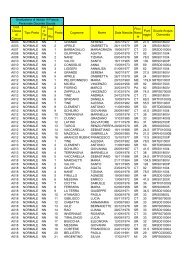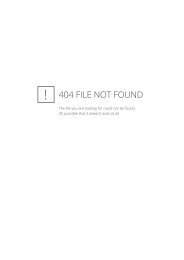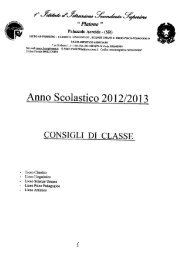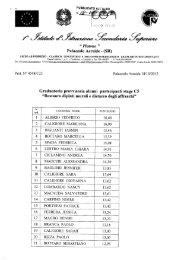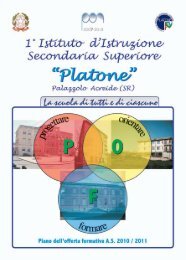SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA - Liceo Platone
SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA - Liceo Platone
SINTETICA DESCRIZIONE DELLA SCUOLA - Liceo Platone
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ffi<br />
r"""-lÍlfiíu" - ,r*,<br />
LICf,O AD lNDlRlTzO. CL^SS|CO, LINCUISnCO f, SOCrc-FIICO-PItDAOOGICO - l,lOEO<br />
Piru (rnh.no r. n. || Teì /F,x 043r/r3r&r9 - N v.nlè 300 6438 ^RTISTICO ^SSOCIATO<br />
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
delibera del | 4-05-2012<br />
ANNO SCOLASTICO 20 I I -2012<br />
CLASSE 5^ SEZ. A INDIRIZZO CLASSICO<br />
COMPOSZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
COMPONENTE MATERIA FIRMA<br />
BORDONARO SEBASTIANA STORIA-FILOSOFIA<br />
$\*{," - rP+,r^\^"."^<br />
CANTONE MARIA RITA RELIGIONE<br />
€-fi'*.,c-./1-<br />
DIBARTOLO LUBREZIA ITALIANO-LATINO<br />
d /l^t=/\-<br />
FISICARO PAOLO ECONOMIA<br />
\'*-b Jl..u,-<br />
CIUDICE ALESSANDRO INGLESE ,1 )^'-<br />
LEONE EMANUELE MATEMATICA-FISICA<br />
f,rue r,,.-4 4'..'<br />
LEONE GABRIELLA GRECO<br />
G-V"WC,ry',*'<br />
MATERAZZO SALVATORE STORIA DELL'ARTE<br />
iII ,,\t ,rli"".-lL-,<br />
RUBERA MARIA ED. FISICA<br />
ì4^", eL_ \-<br />
VITRANO MARIA CONCETTA BloLoctA ('- o- &ua*.- ('{,--...*,<br />
COORDINATORE<br />
Prof, Leone Emanuele<br />
,rr,.,,^rl lo*
<strong>SINTETICA</strong> <strong>DESCRIZIONE</strong> <strong>DELLA</strong> <strong>SCUOLA</strong><br />
Il I Istituto di Istruzione Secondaria Superiore <strong>Platone</strong> è costituito da quattro indirizzi: classico,<br />
linguistico, sociopsicopedagogico e artistico; l'indirizzo classico è il più "antico" e costituisce<br />
l’indirizzo base per l'esistenza degli altri, ad esso hanno fatto e fanno sempre riferimento tutti i<br />
Comuni della zona montana. Dal 1993 è stata avviata una maxisperimentazione Brocca che ha<br />
determinato l'esistenza degli indirizzi linguistico e sociopsicopedagogico; per l'indirizzo artistico è<br />
in vigore il progetto Michelangelo.<br />
Le finalità educative della Scuola, individuate dal Collegio dei Docenti e presenti nel POF possono<br />
essere così definite:<br />
formazione umana, civile e culturale dei giovani, basata sui valori della legalità e della tolleranza di<br />
ogni diversità etnica, ideologica, religiosa.<br />
Fanno da supporto a tali intendimenti la piena padronanza della lingua italiana, confrontata con la<br />
conoscenza scolastica delle due lingue classiche;<br />
il possesso di un adeguato patrimonio di cultura classico-umanistica e storico-filosofica, la<br />
conoscenza scolastica della lingua Inglese; la conoscenza di principi generali di Matematica, Fisica,<br />
Scienze, Educazione Fisica.<br />
Fra le competenze acquisite vi è la predisposizione al commento e alla critica, che pertanto consente il<br />
riconoscimento della struttura di ogni problematica presente nel contesto storico- sociale della nostra epoca.<br />
La formazione acquisita consente ai giovani di affrontare, ognuno secondo capacità personali, le<br />
facoltà universitarie.<br />
La classe, nel corso del triennio, è cresciuta ed ha raggiunto una formazione umana, culturale e<br />
te sui valori positivi della nostra società.<br />
2
PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO<br />
TRIENNIO<br />
Materia d’insegnamento III IV V<br />
Religione 1 1 1<br />
Italiano 4 4 4<br />
Latino 4 4 4<br />
Greco 3 3 3<br />
Lingua straniera Inglese 3 3 2<br />
Storia 3 3 3<br />
Storia dell’arte 2 2 2<br />
Filosofia 3 3 3<br />
Diritto 2 2 -<br />
Economia - - 2<br />
Matematica ed informatica 3 3 3<br />
Fisica - 4 2<br />
Biologia - - 3<br />
Chimica 4 - -<br />
Educazione fisica 2 2 2<br />
3
ELENCO DEI CANDIDATI<br />
COGNOME NOME<br />
DATA DI<br />
NASCITA<br />
COMUNE DI<br />
PROVENIENZA<br />
CREDITO III<br />
CREDITO IV<br />
AMATORE PAOLA 16/03/1993 PALAZZOLO A. 4 4<br />
ARENA ANGELA 18/04/1993 PALAZZOLO A. 4 4<br />
ARENA DALILA 05/09/1993 PALAZZOLO A. 6 7<br />
ARENA MICHELE 24/12/1193 PALAZZOLO A. 5 6<br />
CALIGIORE LORIANA 22/01/1993 PALAZZOLO A. 5 5<br />
CALIGIORE MARIO 01/10/1993 PALAZZOLO A. 6 7<br />
CARAMAZZA VALERIA 20/10/1993 PALAZZOLO A. 7 7<br />
CARBONE LORENZO 23/08/1993 PALAZZOLO A. 5 6<br />
CARPINO SAVERIO 05/10/1993 PALAZZOLO A. 7 7<br />
CATALDO ADRIANA 17/05/1993 PALAZZOLO A.. 7 7<br />
CONIGLIARO GASPERE 11/10/1993 PALAZZOLO A. 7 8<br />
DI PIETRO PAOLO 14/09/1993 BUSCEMI. 7 7<br />
DI PIETRO STEFANO 16/08/1993 BUSCEMI 7 8<br />
DIDOMENICO LAVINIA 23/01/1993 PALAZZOLO A. 5 5<br />
GIARDINA MIRIAM 24/06/1992 BUCCHERI. 4 4<br />
GIARDINA MARIA LEDA 29/07/1993 PALAZZOLO A. 7 6<br />
MITA ALICE 29/11/1993 PALAZZOLO A. 7 7<br />
MONTENERI LUCA 13/07/1993 PALAZZOLO A. 8 8<br />
PANTANO ALESSIA 02/08/1993 PALAZZOL A. 6 5<br />
SALONIA PAOLO 09/11/1993 PALAZZOLO A. 5 5<br />
SANTORO UGO 20/07/1993 PALAZZOLO A. 8 8<br />
SUDANO SIMONA 07/01/1993 FERLA. 6 6<br />
TANASI SALVATORE 04/11/1993 CANICATTINI B: 5 4<br />
TERZO LEANDRO CORRADO 10/12/1993 PALAZZOLO A. 7 8<br />
TINE’ LEANDRO 09/12/1993 PALAZZOLO A. 6 5<br />
TOLOMEO SALVATORE 03/04/1993 PALAZZOLO A 4 5<br />
VARRASI SIMONE 12/10/1993 PALAZZOLO A 8 8<br />
VENEZIANO MICHELA 04/12/1993 FERLA 7 8<br />
4
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE<br />
Discipline curriculari (1) Anni di corso Classe 1° <strong>Liceo</strong> Classe 3° <strong>Liceo</strong> Classe 3° <strong>Liceo</strong><br />
(2)<br />
(3)<br />
(3)<br />
(3)<br />
1 RELIGIONE 3 Cantone Cantone Cantone<br />
2 ITALIANO 3 Dibartolo Dibartolo Dibartolo<br />
3 LATINO 3 Dibartolo Dibartolo Dibartolo<br />
4 GRECO 3 Leone G. Leone G. Leone G.<br />
5 INGLESE 3 Nigro Nigro Giudice<br />
6 STORIA DELL’ARTE 3 Materazzo Materazzo Materazzo<br />
7a ECONOMIA 1 (3°) -------- -------- Fisicaro<br />
7b DIRITTO 2 (1° e 2°) Fisicaro Fisicaro --------<br />
8 STORIA 3 Cannata Sampugnaro Bordonaro<br />
9 FILOSOFIA 3 Cannata Sampugnaro Bordonaro<br />
10 MATEMATICA 3 Leone E. Leone E. Leone E.<br />
11 FISICA 2 (2° e 3°) -------- Leone Ruggieri<br />
12a BIOLOGIA 1 (3°) -------- -------- Vitrano<br />
12b CHIMICA 1 (1°) Santoro -------- --------<br />
13 EDUCAZINE FISICA 3 Rubera Rubera Rubera<br />
Note<br />
1. Elenco di tutte le discipline previste nel triennio<br />
2. Anni di corso nei quali è prevista la disciplina<br />
3. In corrispondenza di ogni disciplina è contraddistinto con * il caso in cui si sia verificato un cambiamento<br />
di docente rispetto all'anno precedente; con * * il caso in cui si sia verificato un cambiamento di docente nel<br />
corso dell'anno scolastico.<br />
Si precisa che le relazioni (All.A ) e i programmi (AILB) dei singoli docenti, allegati al presente<br />
documento, seguono l'ordine sopra indicato. 3<br />
Classe<br />
Iscritti stessa<br />
classe<br />
CONFIGURAZIONE <strong>DELLA</strong> CLASSE<br />
Trasferiti in<br />
altro istituto<br />
Promossi a<br />
giugno<br />
Promossi con<br />
sospensione<br />
del giudizio<br />
3^A 29 23 4 2<br />
4^A 28 23 5<br />
5^A 28<br />
Non promossi<br />
5
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI<br />
Gli obiettivi delle attività educative e didattiche, individuati nel POF, sono:<br />
- l'integrazione curricolare;<br />
- lo star bene con se stessi;<br />
- lo star bene con gli altri;<br />
- il successo scolastico;<br />
- educazione alla legalità;<br />
- educazione alla multiculturalità;<br />
Le attività didattiche curricolare e quelle di recupero e di sostegno programmate dei docenti sono:<br />
- attività in classe e di rielaborazione personale;<br />
- attività guidate dall' insegnante e svolte singolarmente o a gruppi;<br />
- attività di laboratorio svolte in classe con l'insegnante per il potenziamento di competenze di<br />
decodificazione, di analisi e di sintesi;<br />
- attività di snellimento di percorsi didattici delle varie discipline attraverso l'individuazione di<br />
nuclei tematici;<br />
- laboratorio linguistico per il greco, materia, oggetto della seconda prova scritta, effettuata<br />
settimanalmente dalla docente nelle ore curricolare;<br />
Le risorse strutturali dell' istituto sono:<br />
laboratorio di informatica, laboratorio di fisica, biblioteca, videoproiettore e computer,<br />
videoregistratore e televisione con antenna satellitare, antenna parabolica digitale, lavagna<br />
luminosa, stereo con lettore CD, cineteca didattica.<br />
La palestra è in comune con la Scuola Media; la scuola possiede una ricca attrezzatura sportiva per<br />
lo svolgimento delle varie attività.<br />
6
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE, INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI<br />
Sono state organizzate le seguenti attività complementari e aggiuntive quali momenti dell'attività<br />
formativa per favorire l'integrazione curricolare:<br />
Quotidiano in classe;<br />
Teatro classico;<br />
Giochi sportivi;<br />
Olimpiadi di matematica;<br />
Newspaper game;<br />
Scambi culturali;<br />
Gita di istruzione all'estero;<br />
Partecipazione al concorso "Nicholas Green";<br />
Giornale d'Istituto "Studenti per. .. ";<br />
Attività di orientamento;<br />
Progetto POR: il viaggio;<br />
Teatro in lingua italiana e inglese;<br />
Educazione stradale;<br />
Volare alto: progetto di informazione e prevenzione su alcol e droga;<br />
Documentario su Pippo Fava;<br />
Vola libro: conferenza sui 150 anni dell’unità d’Italia;<br />
7
Storia della classe<br />
La classe 5^A del <strong>Liceo</strong> Classico “<strong>Platone</strong>” di Palazzolo Acreide è formata da 28<br />
alunni provenienti dalla 4^A classe.<br />
Gli alunni si presentano diversi per capacità intellettive ed impegno nello studio,<br />
disponibili al dialogo e complessivamente interessati alle discipline e alle<br />
problematiche di attualità che sono state approfondite nelle assemblee d’ Istituto.<br />
Molti alunni si sono distinti per serietà e senso di responsabilità, altri non hanno<br />
saputo sfruttare le proprie capacità ed attitudini e si sono limitati ad uno studio<br />
superficiale, altri, a seguito delle continue sollecitazioni, da parte del corpo docente,<br />
hanno cercato di migliorare la propria preparazione.<br />
Il dialogo educativo, che, per tutto il triennio , si è svolto in modo sereno, ha<br />
consentito ai più responsabili e interessati di chiarire gli argomenti e i problemi e di<br />
far sviluppare la riflessione e il senso critico.<br />
La classe ha fruito delle continuità didattiche in quasi tutte le discipline.<br />
8
CRITERI DI VALUTAZIONE <strong>DELLA</strong> TERZA PROVA<br />
In previsione dell'esame di Stato, il Consiglio di classe ha provveduto a due simulazioni della terza<br />
prova con quesiti prevalentemente a risposta multipla ed anche a risposta aperta, valutate secondo<br />
le indicazioni del Ministero e i criteri stabiliti dal consiglio stesso e che si allegano.<br />
La prova sarà effettuata su quattro materie con due quesiti a risposta aperta (tipologia b) e cinque<br />
quesiti a scelta multipla (tipologia c) per ciascuna materia.<br />
Criteri per l'attribuzione del punteggio<br />
Per i quesiti a scelta multipla verrà assegnato il seguente punteggio:<br />
Risposta corretta<br />
Risposta errata o non data<br />
0,35<br />
0,00<br />
Per i quesiti a risposta singola verrà dato un punteggio massimo di 1,00 punti utilizzando il<br />
criterio sotto indicato:<br />
Risposta corretta, completa ed esaustiva 1,00<br />
Risposta corretta 0,80<br />
Risposta parzialmente corretta 0,60<br />
Risposta superficiale 0,30<br />
Risposta errata o non data 0,00<br />
Il punteggio massimo totalizzabile è pertanto 15 punti.<br />
In caso di risultato con decimali si effettuerà una approssimazione.<br />
Tempo a disposizione per la prova: novanta minuti.<br />
E’ consentito l'uso del dizionario bilingue di italiano-inglese.<br />
1^ simulazione effettuata il 15 marzo 2012<br />
Le materie oggetto della prova : Lingua inglese, Filosofia, Matematica e Biologia<br />
2^ simulazione effettuata il 10 maggio 2012<br />
Le materie oggetto della prova: Lingua inglese, Storia, Fisica e Latino<br />
Le prove effettuate sono a disposizione in segreteria.<br />
9
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI<br />
I criteri di valutazione delle singole discipline, sono stati fissati per Aree disciplinari e approvati dal<br />
Collegio docenti. ( Tutte le griglie di riferimento si trovano nella sezione all’All. B ).<br />
“ Le griglie di valutazione” fissano i livelli di apprendimento degli alunni, in termini di conoscenza,<br />
competenze e capacità acquisite.<br />
Verifiche e valutazioni<br />
Le verifiche a cadenza periodica con una valutazioni infraquadrimestrale hanno avuto una triplice<br />
valenza:<br />
a) sono servite a controllare le abilità e le competenze acquisite;<br />
b) hanno permesso agli insegnanti, nel caso di alunni con problemi di apprendimento, interventi<br />
tempestivi di recupero, tesi ad offrire a tutti gli allievi pari opportunità di maturazione;<br />
c) hanno valutato anche l’efficacia delle strategie didattico-metodologiche utilizzate dal docente.<br />
Accanto alle prove tradizionali si sono utilizzati anche test a risposta singola e multipla,<br />
corrispondenti alle tipologie richieste per gli esami di Stato.<br />
Le verifiche hanno permesso di accertare:<br />
1) la continuità dell’impegno e l’attenzione dimostrata nei riguardi dell’attività didattica svolta in<br />
classe;<br />
2) la comprensione e l’assimilazione dei contenuti;<br />
3) i progressi e la maturazione raggiunti rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi specifici<br />
disciplinari.<br />
L’anno scolastico è stato diviso in due periodi:<br />
1° periodo dal 15/09/2011 al 14/12/2011<br />
2°periodo dal 15/12/2011 all’12/06/2012<br />
Alla fine del primo periodo sono state consegnate, alle famiglie degli alunni, le relative pagelle; nel<br />
corso del secondo periodo, più lungo, è stata prevista una valutazione intermedia, con consegna di<br />
pagellini alle famiglie, che ha permesso di valutare la situazione in itinere e di rafforzare, ove<br />
necessario, l’azione didattico-formativa con i corsi di recupero. Nella valutazione sommativa i<br />
docenti hanno tenuto in considerazione sia la media aritmetica dei voti delle verifiche effettuate, sia<br />
l’interesse, la partecipazione alla dinamica di gruppo e il progresso rispetto ai livelli di partenza di<br />
ogni singolo alunno.<br />
10
ALLEGATO A<br />
11
RELAZIOIIE FINALf,, DEL DOCENTE<br />
Materia: Storia<br />
classe VA A.S.2011-2012<br />
ln relEzione Ella programmazione clrricllare sono stdi coÍseguiti i s€guenti obiettivi in termini di:<br />
CONOSCENZE: la classq nel complesso, conosce i fondsmentali awenimenti sîorici che hanno<br />
calatterizzato il Novecento ed è in grado, con coscienza civica e sensibilitÀ sociale, di comprendere il<br />
mondo sttuale € di rifleltere sulle tematiche tr8ttste. Un nutrito gruppo di alunni riesce ad esprimere<br />
purni di vi$a pefionali e a fsre co[egametti interdisciplinari.<br />
COMPETENAi/CAPACITA'/ABILITA': Al temine del corso di studi gli studenti hanno sviluppato,<br />
in liner di massima" le cap8cità di recup€rare ls memoda storiao-bterpr€tativE e di utilizzarlE anche<br />
nella decodifica di îematiche contempol8nee. Sono in grado di: a) ùsare la termologia sp€cifioa dell&<br />
dfuciplin&; b) organizzare i conteruti ir modo problematico; c) coll€garc pedodi stodci a movimenti<br />
culturEli.<br />
I.CONTENUTI DISCPLINARE E IEMPI DI REALZZAZIONE ESPOSTI PER:<br />
- Uaità didattiche<br />
- Percorsi fomativi ed evenoali approfondimenti<br />
U.D. lvlodulo- Percorso fomEtivo-A{Drofondimento<br />
L'Itdir c íl tovcrtro Giolitti: elementi genenli<br />
Periodo<br />
(espresso<br />
ore)<br />
l0<br />
UnitÀ l. Lr Grudc gùcrr c h rivoluziooc russr: L crisi dell'equilibrio:<br />
I,a Prime gu€fia mondiale; Dinamica ed eshi del conflitto; La rivoluzion€ Russa.<br />
UnitÀ 2.L lungr crisi curopcr: Il dopoguerra: un nuovo sceirario mondiale;<br />
Rivoluzione e coftrorivoluzione: il bieonio rosso;<br />
La costnzione dell'U on€ Sovietica<br />
Il csso italiarc: drllo stEto liberale al fascismo.<br />
UnitrÀ 3. L'Gtì dci Tot litùbmi: b graade oisi e il New Deal;L'lt'/.ith5tr,ist4<br />
Il nazismo e i regimi fascisti; L'Europa democratics;<br />
L'Intemazionale comunista e lo stslinismo.<br />
l9<br />
t2<br />
UnitÀ 4. La s€condr gucrrr moodid€<br />
Secorda guens mondiale;<br />
Il nuovo ordine mondiale.<br />
e h nrscitr dd bipolarirmo : Verso la 7<br />
Urità 5: L'ltdi| Rcpubblicrne : Nasce la ruova R€pubblica; Ls dcostruzione;<br />
I,€ €lezioni del 1948.<br />
3<br />
ADDrofondimenti: Doc 2 L'economia e la Grande nrerra pag. 133<br />
Doc 3 Il sold8to s€ozù ouslità Dal' 144<br />
Doc 4 L'esoerienza della morte e l'elaborazione del lutto psc- 146<br />
Visione del filrn ' Ia coraz,z^t^ PotèrnÍii' del regidE S€rgpj M. Ejzen$qn<br />
Totale delle ore di lezionì 63<br />
Totale ore di verifiche 22
Ot" efettiraneote wohe dal docente oell'idero altro scolsstico' comprese<br />
le verifiche 6no al 15 maggi<br />
METODOLOGIE: Lezioni fiolrtsli; dinamiche di psrtecipszione all'attività didattica sia a livello<br />
guppo che individùalizzEto.<br />
MATERIALI DIDATTICI:<br />
TBto itr rdùdonc: ALBERTO DE BERNARDI - SCPIOIìiE GUARRACINO<br />
I SAPERI DELI"A SîORIA EDÍL SCOLASTICEE BRUNO MOIIIDADORI<br />
TIPOLOGIÉ DELLE PROVE DMRIFIC AWILVZAITE:<br />
-Colloqui srgomertstivi<br />
- Test ogg€ltivi<br />
- Simulazioni<br />
A disposizione della commissione sorc depositati in segreteria gli ermpi delle prove di sirnulazione<br />
( a riiposta aperta e a scelta multipla) e delle verifiche oggettive efettuate.<br />
Palazzolo A. 1445-2012<br />
Il Docente<br />
tn\r;ì,.,- o 13"'^''l<br />
J o'*o-"tr<br />
/3
ANNO S€OLASTTCO 2011-2012<br />
PROGRAMMA OIÍORIA SVOLÍO DALLA PROF.SSA SEEAÍIANA BORDONARO NELLACI.ASSE V SEZ. A DEI- LICEO CI.ASSICO<br />
"PLAIONE" DI PAIAZZOLO ACREIDÉ<br />
TEstO: ATBERTO DE BERNARDI.SCIPIONEGUARRACINO<br />
I SAPERI <strong>DELLA</strong> STORIA COIZ. SCOLASTICHE BRUNO MONOADORI<br />
L'ltolio e ilooverno Giolitti: elementi generali<br />
1. Le condizionidivita degli italiani<br />
2. La classe dirigente:Destra e Sinistra<br />
3. Lo Stato accentrato e il Mezzogiorno<br />
4. lcosti dell'unificazione<br />
5. ll completamento dell'unità<br />
6. La Sinistra algoverno<br />
Z La politica economica: agricoltura e industria<br />
8. La politica estera: Triplice alleanza ed espansione coloniale<br />
9- Movimento operaio e organizzazioni cattoliche<br />
10. La democrazia autoritaria dì crispi<br />
11. La crisidifine secolo e la svolta liberale<br />
,2. Decollo industriale e questione meridionale<br />
.23. lgoverni Giolittie le riforme<br />
14. socialisti e cattolici<br />
15. La guerra di Libia e la crisìdel sistema giolittìano<br />
La Grande guerra e la rivoluzione russa<br />
Copitolo 1 - Lo crisi dell'equilibrio: Io P mo auerro mondiole<br />
1. te ra8ioni dell'immane conflitto<br />
2. Cultura e politica del nazionalismo<br />
3. L'iniziodelleoperazionimilitari<br />
4. L'interventoitaliano<br />
copitolo 2 - Dinomico ed esiti del conflitto<br />
1. Lo stallo del 1915-16<br />
2. Dalla guerra europea alla guerra mondiale<br />
. La svolta del 1917<br />
. Le rivolte popolaricontro la guerra e ìa miseria<br />
. L'offensiva austro-tedesca: la disfatta italiana diCaporetto<br />
3. La fine della Grande guerra<br />
Copitolo i - Lo rivoluzione Russa<br />
1. L'impero zarasta<br />
2. La caduta degìi zar<br />
3. La rivoluzione d'ottobre<br />
La lunta crisi europea<br />
copitolo 4 - ll dopoauefto: un nuovo scenodo mondiole<br />
1. La pacificazione impossibile<br />
. La contraddittoria ricerca di un nuovo equilibrio: iQuattordici puntidìWilson<br />
. Gli obiettividella Gran Bretagna e della Francia<br />
. lltrattatodiVersailles: l'annientamentodellaGermania<br />
. ll trattato di Saìnt-Germaìn: la spartizione dell'lmpero austro-Lrngarico<br />
Copitolo 5 - Rivoluzione e controrivoluzione: il biennio rosso<br />
1. La crisieuropea : alla ricerca dinuovìassetti<br />
2. La crisi negli stati democraticì<br />
. La democrazia alla prova: scontro e riorganizzazione socia'e<br />
. Gli Statì Uniti: tendenze conservatricie isolazioniste<br />
3. La Germania di Weimar<br />
Copitolo 6 - La costruzíone dell'Unione Sovietico<br />
1. ll periodo del Comunismo diGuerra<br />
I t t<br />
"T
. Lo scoppio della guerra civile e la vìttoria bolscevica<br />
. ll"cordone sanitario" e la nascita delComintern<br />
2. La nascìta dell'Urss<br />
. Fine del"comunismo diBuerra" e nascita dell'Urss<br />
. Accumulazione o pianificazione : i contrasti sulla Nep<br />
3. GIi inizi dell'egemonia diStalin<br />
Copitolo 7 - llcoso itoliono: dollo stoto liberole olfoscismo<br />
1- Difficoltà economiche nel primo dopoguerra<br />
. Gli effetti della guerra e glì squìlibri strutturali dell'economia<br />
. La questione meridionale<br />
2. ll biennio rosso in ltalia<br />
. La crisi nel settore industriale<br />
. Lamobilitazionedelproletariatoindustriale<br />
. Benito Mussolinie la nascita del Movimento deifascìdi combattimento<br />
. ll mito della "vìttoria mutilata" e la questione di Fiume<br />
. ll Partito popolare e ilcattolicesìmo democratico di Sturzo<br />
. La vittoria dei partiti popolari<br />
. La difficile ricerca di nuoviequilibri<br />
. La crisi del compromesso tiolìttiano<br />
. "Dal biennio rosso al biennio nero"<br />
3. fawento delfascismo<br />
. La crisidel 1921: sitrasforma lo scenarìo economico e sociale<br />
. [a fine del compromesso giolittiano e la nascita del Partito fascista<br />
. Glierroridi prospettiva diGiolittie l'impasse del Partito socialista<br />
. La marcia su Roma: l'ltalia verso la dittatura<br />
4. La costruzione delregime<br />
. lfascisti algoverno<br />
. lldelittoMatteotti:ilcarattereillibèraledelfascismo<br />
. ll 1926, l'anno disvolta: la costruzione del re8ime fascista<br />
. Le le8Sisindacali<br />
. ta svolta in politica economica: la rivalutazione della lira<br />
. Glieffetti sociali della rivoluzione: ilconsenso della piccola borghesia<br />
fetà dei totalitarismi<br />
Copitolo 8 - Lo arqnde uisi e il New Deol<br />
1, Una nuova crisigenerale: le cause<br />
2. Una nuova crisigenerale: gìi effetti<br />
. La reazione delsrstema economico<br />
. La scelta protezionistìca e la segmentazione del mercato mondiale<br />
3. Roosevelt e il New Deal<br />
. ll programma dì Roosevelt: dal libero mercato all'intervento dello stato nell'economia<br />
. ll riordino delsistema finanziario e la riduzìone della disoccupazione<br />
. Le batidello stèto sociale americano<br />
Copitolo 9 - L'ltolio fdscisto<br />
1. ltre capisaldi della svolta autoritaria delfascismo<br />
. Fascismo e democrazie neglianniventi<br />
. L'offensiva fascìsta ne8li annitrenta<br />
2. La fascistizzazione della società<br />
. L'organizzazione del consenso<br />
. llfascismo e la chiesa<br />
. LeorganirrarioniEiovanili<br />
3. fra dirigismo e autarchìa<br />
. Gli effetti delÌa crisi deglì annitrenta<br />
4. L'imperialismo e la nuova politica estera<br />
Cqpitolo 70 - ll nozismo e i reoimi foscisti<br />
1. La Germania nazista<br />
Copitolo 77 - L'Europo democrutico<br />
L'antifascismo /f
Copitolo 72 - L'internozionqle comunista e lo stolinismo<br />
1. ll mito dell'Urss e l'internazionale comunista<br />
2. La societa sovietica e la dittatura diStalin<br />
La Seconda guerra mondiale e la nascita del bipolarismo<br />
Copitolo 7i - Lo Secondo auerro mondidle<br />
l. Verso la Seconda guerra mondiale<br />
2. ll dominio nazifascista sull'Eurooa<br />
3. La mondializzazione del conflitto<br />
4. La controffensiva deglialleati nel 1943<br />
5. La sconfitta della Germania e delGiaooone<br />
Copitolo 74 - ll nuovo odine mondidle<br />
1. Gli sce nari economici dopo la guerra<br />
2. ll nuovo ordine nelle relazioni interna2ionali<br />
Cooitolo 15 - L'ltolío Repubblicono<br />
1. Nasce la nuova Repubblica<br />
2. La ricostruzione<br />
3. Le elezionidel 1948<br />
APPROFONDIMENTI<br />
(Libro dl testo)<br />
Doc 2 L'economia e la crtude guera pag. 133<br />
Doc 3 ll soldato senza qualità pag. 144<br />
Doc 4 L'esperienza dellamorte e I'elaborazione del lutto pag.146<br />
- Visione del film " La corazrúa Potènkin', det regista Sergej M. Ejzlnstejn<br />
PAT.AZZOLO ACRETDE 14-05-2012<br />
r INSEGNANTE<br />
cìt n /'\ \<br />
)bd,c.' - ife$.s;*urs<br />
GLIALUNNI<br />
ùllo,r,c é,felr'ù'<br />
Ootù,"rr $nou<br />
ú-/ //%*,<br />
/f
Rè]-azione Finà].è di Filoeofia A.S. 2OLf/12<br />
Prof. asa: Sobastiana Bo.donalo<br />
C[.È5SE: V SEZTONE: A r,iceo C].assico<br />
In relazióne aÌla progr@zione curricolale sono stati consequiti i sequenti obiettiri in<br />
1-CONOSqENZE<br />
ReÌative a teorie. autori e movirnenti filosoficirqli alunni hanno dimostraro neÌ<br />
corso dell'anno scolastico interesse e impegno per ta materia trattataita<br />
naqgior pèrlF di loro possiede<br />
accerrab_ t.; so o un grrppo r.gqrunge<br />
2-COMPEIENZE, CAPACIÎA' ED ABILITI.'<br />
SoÌo un gruppo di aÌùnnil<br />
-contestualizza i novimenti filosofici ne.Ila loro conplessità storico-sociale<br />
ed e capéce di esercitarè la riflessione critlca suÌìe diverse forme det saDere.<br />
NeI conplesso quasi tutta la classe:<br />
-utilízza un Ìessico appropriato<br />
-enuclea le idee centrall<br />
-riassume le tesi fondanentali.<br />
3-CONTENUTI DÌSCIPLINARI (articoÌati<br />
periodo (ore) di reaÌizzazione):<br />
UNITA' DIDAîTICA<br />
P€riodo (€sprssso in ore)<br />
:c!l!t q9ll1d93lrúo Dei caratteli senelali<br />
-rlalx: la società cone orizzontè ctella filosofia<br />
schopenhaue!:iÚazionalisno e pessifrismo<br />
-(ierkegaard: l'esistelza cont!o la totatità<br />
-!a fiÌosofia def Novecento: caratteri oènèr.<br />
-Nietzsche:ladicaliaà della ciisì. ladicalrrà creÌ pensiero 5<br />
-Caratteri qelerali dell'EsistenziaÌismo 2<br />
-Neoscolastica e Pelsonalismo:Jacques Malitain 2<br />
r. Poppe! . r: dibar r 1r; EE!ercG;i;;- .<br />
-tl. Alendt:l,a neditazióne €ull'aqire potitico 2<br />
-u. Jonas:unrètica che quarda al futuro 2<br />
TotaÌè delle orè di lèziÒni 52<br />
îotale ore di. verifiche 26<br />
pe! un totale di ore effettivanenrè svolte nell/intelo anno<br />
per unrta didartacbe con indicazione de1<br />
4 -ME IODOI,OGIE ADOTÎATE :<br />
--ezrone fron!èle e parLecipoz.ore alt-va dr LLLL- 9.. d.Lnni d lè dinamrca oi<br />
s.IIATERIAI.I DIDATTICI :<br />
- Testo utilizzato:PROTAGONISTI E TESTI <strong>DELLA</strong> FILOSOEIA D/1.D/2<br />
- Autori : ABBAGNANO NICOLA, FORNERO GIOVANNI<br />
- Casa Editrice: PAB.AVIA<br />
6-UPOI'GIE DE!1,8 PROVE DI VERIFIC.A lxtlLlZZAÎE I<br />
-verìfiche orali pèriodìche<br />
-Prove d.i s.imulazione a risposca operLd e c scel Ld nuILipla.<br />
A di3tD3iriore cù.ILa C@is3ionè sono c!.EÉaitlti io 6.9r.te.ia gli è3èú|)i al€llè prot ari<br />
PaLazzolo A. lj'<br />
IL DOCENIE<br />
Sì[*.<br />
"^^ "-brt .L. ,. ,,,
Programma di FlIOSOFIA svolto nella classe V A del <strong>Liceo</strong> classico<br />
dalla Prof.ssa Sebastiana Bordonaro nell' anno scolastico 2oLllt2<br />
Testo utifizzato: PROTAGONISTI E TESTI <strong>DELLA</strong> FILOSOqIADIL; Dl2<br />
Autori: Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero<br />
Casa editrice: PARAVIA<br />
CRISI DELTIDEALISMO NEI CAMTTERI GENERAI.I DELTIDÉALISMO<br />
HEGEL<br />
1. La razionalità del Reale<br />
2. La dialettica hegeliana<br />
3. lcaratterigeneralìdella logica, della filosofia della Natura e della filosofia dello Spirito<br />
SCHOPENHAUER: IRRAZIONALISMO E PESSIMISMO<br />
1.1. Vita e scritti<br />
1.2. Radici culturali del sistema<br />
1.3. ll mondo délla rappresentazione come "velo di lMaya"<br />
1.4. La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé<br />
1.5. caratteri e manifestazionidella "volontà divivere"<br />
1.6. ll pessìmismo<br />
. Dolore, piacere e îoia<br />
. La sofferenza universale<br />
. fillusionedell'amore<br />
1.7. Approfondimento: Ia critica delle varie forme di ottimismo<br />
. ll rifiuto dell'ottimismo cosmico<br />
. ll rìfiuto dell'ottimismo sociale<br />
. ll rifiuto dell'ottimismo storico<br />
1.8. Le vie di liberazione dal dolore<br />
. L'arte<br />
. L'etica della pietà<br />
. L'ascesi<br />
KIERKEGAARD:t'ESISTENZA CONTRO LA TOTALITA'<br />
1. Vita e scrittì<br />
2. L'esistenza come possibilità e fede<br />
3. Le verità del "singolo": il rifiuto dell'hegelismo e "l'infinita differenza qualitatìva fra l'uomo e<br />
Dio"<br />
4. Gli stadi dell'esistenza<br />
4.1. Vita estetica e vita etica<br />
4.2. La vìta reliSiosa<br />
5. L'angoscia<br />
6. Disperazione e fede<br />
7. L'attimo e Ia storia: l'eterno neltempo<br />
MARX:<br />
1. Vita e opere<br />
2. Caratteristiche del marxismo<br />
3. La critica al "misticismo logico"dì Hegel<br />
/8
4. La critìca della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione "politica" e " umana"<br />
5. La critica dell'economia borghese e la problematica dell"'alienazione"<br />
7. La concezione materialistica della storia<br />
7.1. Dall"'ideologia" alla "scienza<br />
7.2. Struttura e sovrastruttura<br />
7.3. La dialettica della storia<br />
7.4. La critica agli "ideologi" della sinistra hegeliana<br />
8. La sintesidel "Manifesto"<br />
8.1. Borghesia, proletariato e lotta diclasse<br />
9. " lL Capitale"<br />
9.1. Economia e dialettica<br />
9.2. Merce, lavoro e plus-valore<br />
9.3. Tendenze e contraddizione del capitalismo<br />
10. La rivoluzìone e la dittatura del proletariato<br />
11. Le fasi della futura società comunista<br />
NIETZSCHE:RADICALITA' <strong>DELLA</strong> CRlSl. RADICALIIA' DEL PENSIERo<br />
1. Vita e scritti<br />
3. Filosofia e malattia<br />
4. Nazificazione e denazificazione<br />
5. Caratteristiche del pensìero e della scrittura di Nietzsche<br />
7. ll periodo gìovanile<br />
7.1. Tragedia e filosofia<br />
. Nascita e decadenza della tragedia<br />
. Spirito tragico e accettazione della vita. La "metafisica da artista".<br />
8. ll periodo "illuministico"<br />
8.2 La "morte di Dìo" e la fine delle illusioni metafisiche<br />
. Realtà e menzogna<br />
. llgrande annuncio<br />
. Morte di Dio e awento delsuperuomo<br />
. Come il "mondo vero" finì per diventare favola e l'autosoppressione della morale<br />
9. ll periodo di " Zarathustra"<br />
9.1. La filosofia delmerjggio<br />
9.2. llsuperuomo<br />
9.3. feterno ritorno<br />
10. L'ultimo Nietzsche<br />
10.1. ll crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la "trasvalutazione deivalori"<br />
10.2. La volontà di potenza<br />
. Vita e potenza<br />
. La volontà di potenza come arte<br />
10.3. llproblema delnìchilismo e delsuo superamento<br />
CARATTTRI GENERATI DETTESISTENZIALISMO<br />
. Lo sfondo della riflessione esistenziale<br />
. L'esistenzialismo come clima culturale<br />
. Le radici<br />
. I nuclei fondamentali<br />
HEIDEGGER<br />
L. La nostalgia dell'essere in Heidegger<br />
lc)
. La domanda fondamentale<br />
. L'analìsidell'esistenza<br />
. fessere nelmondo<br />
. La comprensione<br />
. La cura<br />
. L'esistenzaautentica<br />
. La temporalità dell'esserci<br />
. La svolta<br />
. La lecntca<br />
. Nella notte del mondo, sulle tracce degli dei fuggiti<br />
. In cammino verso il lìngua88io<br />
. L'uomo come "pastore dell'essere"<br />
NEOSCOLASTICA E PERSONALISMO<br />
1. ll contesto storico-culturale<br />
JACQUES MARITAIN<br />
1. Vita e opere<br />
2. L'umanesimo integrale<br />
. Principio di analogia e autonomia del pensiero<br />
. Umanesimointegralecontro"antropocentrismo"<br />
3. La conce2ione etico-Politica<br />
KARL POPPER E IL DIBATTITO EPISTEMOLOGICO<br />
1. Vìta e opere<br />
2. Crìtica dell'Empirismo logico e dell'induttivìsmo<br />
3. ll falsìficazionismo<br />
4. Scienza e metafisica<br />
5. Congetture e confutazioni<br />
6. ll realismo critico<br />
7. llfallibilismo<br />
9. La società aperta<br />
HANNAH ARENDT: LA MEDITAZIONE SULL'AGIRE POLITICO<br />
3.1. Le origini del totalitarismo<br />
3.2. La politeia perduta<br />
HANs IoNAS: UN'ETICA CHE GUARDA AL FUTURO<br />
1. Un'etica per la civiltà tecnologica<br />
. L'imperativo ecologico diJonas<br />
2. La responsabilità verso le generazionifuture<br />
. / /^<br />
palazzotoA.lì I 4 /a 5 I -' a l{<br />
ll Docente<br />
$*1,.'-*- St^\ ù-\a-\.:,<br />
2t)
1" Istituto di lstruzione Superiore "<strong>Platone</strong>"<br />
<strong>Liceo</strong> Classico<br />
Classe 5 Sez. A<br />
Anno Scolastico 201 l-2012<br />
Materia Religione Cattolica<br />
Relazione Finale<br />
La classe lll B del <strong>Liceo</strong> Classico ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi prefissati. Cli<br />
alunni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo. ll profrlo attuale della classe evidenzia,<br />
dal punto di vista cognitivo, buone conoscenze e discrete abilità. L'IRC, "nel quadro delle finaliU<br />
della scuola" (lntesa 1,1), "in conformira alla dottrina della Chiesa" (lntesa l,l e 4,1), "e nel rispetto<br />
della libertà di coscienza degli alunni" ( Intesa l,l ), ha inteso Fomuovere l'acquisizione di elementi<br />
di cultura religiosa per la formazione dell'uomo e del cittadino e la conoscenza di alcuni principi del<br />
cattolicesimo che fanno parte del patimonio storico del nosho Paese. Ha offerto contenuti e<br />
sîrumenti specifici per una lettura della realtà storico-cultùale in cui gli alul|rli vivono; è andato<br />
inconto ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita; ha cercato di contribuire alla<br />
formazione della coscienza morale ed ha offerto elementi per scelte consapevoli e responsabili di<br />
fionte al problema religioso (DPR 21, 7, 1987, n339, I,l-2).<br />
Gli alurni sono stati aiulati: - a scoprire quei valori che sono significativi, secondo la tradizione<br />
cristian4 per I'esperienza di vita dei ngazzi stessi; - a trovare i significati valoriali assunti dalla<br />
Tradizione Cristiana Cattolica; - a rendersi conto con intelligenza critica dei valori della Religione<br />
Cattolica,<br />
In merito alle CoÍosceDzG gli alunni hanno inteso la religione come possibile risposta alle<br />
domande di senso dell'uomo; hanno conosciuto le verità escatologiche del cristianesimo in<br />
riferimento alla viîa oltre la mo.te; hanno conosciuto gli eventi finali del personaggio Gesr) di<br />
Nazareth riconoscendo neÌÌa morÎe e resurrezione di Cristo il centro delle fue cústiana; hanno<br />
intuito i significati valoriali di un'etica della vita secondo le indicazioni del Magistero della Chiesa<br />
in relazione alle principali tematiche attuali (ingegneria genetic4 eutanasi4 aborto,ecc....) anche<br />
alla luce dei principi enunciati nella Lettera Enciclica di Ciovanni Paolo ll Erangelium Vilae.<br />
ln merito alle Competenze, relativamente alle loro potenzialità e al diverso livello di partenza. gli<br />
alunni sono in grado di: - riconoscere il valore delle verità cristian€ sulla vita ultraterena; -<br />
individuare nella morte e resurezione di Cristo il fulcro e il fondamento del cristianesimo; -<br />
percepire il valore del rispetto della vita e della dignita della persona - cogliere la necessità di<br />
un'etica della vita in relazione alle principali tematiche attuali, anche alla luce del Magisîelo della<br />
Chiesa.<br />
In merito alle Capacità gli alunni, in maniera diversificata, sono in grado di: - analizzaxe,<br />
sintetizzare, argomentare e valutarc le conoscenze acquisite; - operare scelúe libere e responsabili; -<br />
sviluppare atteggiamenti di assolùto risp€tto per opinioni culturali e morali diverse dalle propúe.<br />
I Contenùti sono stati acquisiti sviluppando le seguenti Unita Didattiche: "La dignita della<br />
persona urnana e I'etica" - il valore della fìersona e la necessità di formarsi una coscienza morale<br />
Tra realtà maîeriale e spirituale: la dimensione religiosa. Vita teÍena e vite etema. Infemo.<br />
nella vita il Mistero di Dio. La vita: dono da<br />
Paradiso, Pugatorio.'La difesa della vit." -<br />
difendere sempre. Temi di bi
Mezzi e strumetrti di lavoro sono stati i documenti del Magisîero della Chiesa (o riconducibili ad<br />
esso), Sacra Bibbia.<br />
Lo Spazio utilizzato è stato sempre quello dell'aula didattica.<br />
Strumenti di veífica sono stati innanzitutto i colloqui individuali e di gruppo.<br />
Per la valut zione si è tenuto conto dei seguenti elementi: disponibilitàL ad apprendere dell'alunno,<br />
interesse, livello di partecipazione, conoscenza degli argomenti, uso della terminologia apFopriata,<br />
capacità di approfondimento, di comparazione, di rielaborazione, di matuazione di libere e<br />
personali opinioni.<br />
L'insegnante<br />
C--* av
LICEO CLASSICO CLASSE 5 SEZ A<br />
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' DISCPLINARI<br />
Mateúa<br />
Relisione Cattolica<br />
Docente Prof. CANTONE MARIA RITA<br />
Libro di testo adottato<br />
ore settimanali Orc d i lczione provist€ ncll'ùno<br />
Ore di lezione effetoate nell'a. s<br />
di lezione N. I Scoì6tico0ll-2012 N.13<br />
N.<br />
Nota bene: Lo scarto Íia le ore Dr€viste e ouelle efTetuate è dovuto alle attività inteùative e aìle assenu collettive<br />
Obiettivi realizziti<br />
(in termini di conoscenze,<br />
competenze! capacita)<br />
Conoscenze<br />
Gli alunni conoscono la religione come possibile risposta alle domande di senso<br />
dell'uomo; conoscono Ie verita escatologiche proposte dal cris.ian€simi; riconoscono il<br />
centro della fede cristiana nella mofe e resurrezione di Cesrì da cui scaturisce- D€r i<br />
cr€d€nti, il senso profondo della vita; conoscono i principi di un'etica della vila in<br />
rclazione all€ principali tematiche attuali (lngegnerìa genetica, fecondazione assistita,<br />
eutanasia ecc.) anche alla luce deiprincipienunciari da alcuni documenti<br />
def Magìstero della Chiesa ( Lettera Enciclica di Ciov^nni Paolo ll Elangeliun l/itae\.<br />
Competenze<br />
Relativamente aìle loro potenzialità e al djveno liv€llo di paftenza, gli alunni sono in<br />
grado di: - individuare nella r€ligione una possibile risposia alle domande esislenziali;<br />
riconoscere il valore d€lle v€rita cristian€ sulla vita ultratenena;- individuare nella morte<br />
€ resurezione di Cristo il fulcro e il fondam€nto del cristianesimo;- percepire il valore<br />
del rispetto per la vita che emerge dalle varie concezioni religiosei cogliere la necessità<br />
di un'etica della vita in relazione alle principaìi tematiche attunli, anche alla luce d€l<br />
Magistero della chiesa.<br />
CNpacità<br />
GIi afunni in maniem diversìficata sono in grado dii ana.lizzare, sinteriz re,<br />
argomentare e valutare le conosc€nza acquisite; operare scelte libere e responsabilìisv;luppar€<br />
atteggiamenti di assoluto rispetto per opinioni cultuali e norali diverse dalle<br />
CONTENUTT<br />
Unità Ore Titolazione delle uniu<br />
I<br />
'Religione e vita"<br />
La rcligìone: risposla alle domandc dell ùomo. TÉ rcalîa mteriale e spiritùalc: ladincnsionc<br />
r€ligiosa vila torena c liÌa ctcma. Infcmo, PuGatorio. Pamdie.<br />
',<br />
"La sacElità della vitr"<br />
Nella vita il " Mistero di Dio" . La vita: dono da difendere semore. Terni di bio€tica<br />
secondo il Magistero d€lla Chiesa: I'aborto nell'r/J& I'embrione nell'f/óJ e<br />
I'eutanasia n€ll't/ ó.,/.<br />
"La Pasqua: centro della fede cristiana"<br />
La Pasqua: fonte e fulcro del cristianesimo- Dallacrocg, font€ di vila, nasce e si<br />
diffonde iì"Popolo della vita'(r/J0). ta logìca del"dono".<br />
Melodo di insegnamento<br />
Mezzi e sÍumenti dì lavoro<br />
SDazi<br />
Strumentidiverifica<br />
Esperienziale e dialogico: inleroga la realtà e la reinterprela con l'ausilio deinuovi<br />
significati valoriale assunti dallatradazione crìstiana, nella lìbelà di scelta personale.<br />
t€zioni Fonlali. Interventi individualizari. livoro di eruDDo. Dibattili suidati.<br />
Libro di testo. Documentidel Magistero dellaChiesa ( o riconducibili ad esso), Sacm<br />
Bibbia-<br />
La verifica e stata attùata tÉmite colloqui individuali e d; gruppo.<br />
Per la valutazion€ si è tenuto conto dei seguenti elementi: disponibilila ad apprendere<br />
dell'alumo, interesse, liveìlo di partecipazione, conoscenza degli aryomenti, uso della<br />
terninologia appropriata, capacita di approfondinento, di comparazion€, di<br />
{ft rrq,ruro o. '|t- or- 2etrz<br />
€,* ,/L)
1' Istituto di Istruzione Superiore "<strong>Platone</strong>"<br />
<strong>Liceo</strong> Classico<br />
Classe 5 Sez A<br />
Anno scoìastico 201 l-2012<br />
Materia Religione Cattolica<br />
Programma svolto<br />
- La Religione: una possibile risposta alle domande della vita.<br />
- La vita terrena e il suo valore .<br />
- La vita etema: infemo, paradiso e purgatorio.<br />
- La sacralità della vita.<br />
- L'etica e la bioetica.<br />
- Natale: Dio diventa uomo.<br />
- La visione cristiana della sessualità.<br />
- La tutela della vita fin dal suo albore: EV 58 e I'abofo.<br />
- Il rispetto assoluto della vita in ogni suo stadio: EV64 e l'eutanasia.<br />
- L'amore cnsliano..<br />
- Il comandariento dell'amore di Gesu di nazareth.<br />
- La Pasqua ebraica.<br />
- La Pasqua, centro della fede cristiana.<br />
Gli alunni<br />
/. / / /4<br />
lu1-t t'ú't'I/\ /-9'"'<br />
C,r'^-"- Uoru.-'-<br />
L'lnsegnante<br />
€--*rt a<br />
t4
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPARIORE'PLATONE"<br />
ANNO SCOLASTTCO 20tl I t2<br />
INDTRTZZO CLASSTCO CLASSE V<br />
Relazione finale ITALIANO Docente Lucrezia Dibartolo<br />
La classe, nel suo complesso, ha dimostrato interesse al dialogo educativo e<br />
impegno costante durante tutto I'anno scolastico. Il rapporto è stato improntato<br />
su rispetto € stima reciproci.<br />
Sono state perseguite le segventil!U!!!E!!@!!yJ!!Wg!Sg!! attraverso lo studio<br />
dei contenuti relativi alla disciplina e anche attraverso le situazioni quotidiane di<br />
vita scolastica:<br />
l) sviluppo di emozioni e sensibilità soggettive per un più consapevole senso<br />
di sé nella vita di gruppo, e un più saldo equilibrio psico- fisico<br />
2) sviluppo di una coscienza della solidarietà, del rispetto delle diversità.<br />
3) sviluppo della coscienza civica<br />
4) sviluppo di una coscienza interculturale.<br />
Le finalità snecílíche della dìscìnlina sono state volte a<br />
l)Sviluppare la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno<br />
letterario, come espressione della civiltà e, in connessione con le altre<br />
manifestazioni afistiche. come forma di conoscenza del reale anche attraverso le<br />
vie del simbolico e dell'immaginariol<br />
2) favorire la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappres€ntativi del<br />
patrimonio letterario italiano, consid€rato anche nelle sue relazioni con altre<br />
letterature europee e mondiali<br />
3)svifuppare la padronanza del mez;zo linguistico nella ricezione e nella<br />
produzione orali e scritte nella consapevolezza della trasversalità della lingua.<br />
Circa Ia metà della classe ha raggiunto i seguenti<br />
Obiettivi minimi:<br />
Conoscenza e comprensione essenziale del proc€sso storico letterario dalla<br />
seconda metà dell'Ottocento ai nostri giorni; conoscenza e comprensione<br />
essenziale di canti del Paradiso di Dante Alighieri(parafrasi,riassunto,ricerca<br />
parole-chiave; conoscenza schema metrico); conoscenza delle diverse tipologie<br />
di scrittura(riassunto,analisi testo, saggio breve,articolo di giornale)<br />
Comqelenze capacità di orientamento nel panorama letterario studiatoi<br />
contestualizzazione di un autore; capacità di analisi di un testo sia in poesia che<br />
in prosa (comprensione essenziale del contenuto, rilevazione temi,<br />
riconoscimento delle più note forme metriche e figure retoriche) ;capacità di<br />
sintesi essenziale dei concetti portanti di un testo; capacità di produrre un testo<br />
scritto organico e logico con padronanza del mezzo linguistico; capacità di<br />
produrre un discorso orale logico e con padronanza della lingua<br />
Lf
Circa la metà della classe ha raggiunto i seguenti<br />
obiettivi discìnlinari soecifici aoorofonditi<br />
relativi a tre settori:<br />
l. analisi e contestualizzazione deí testì:<br />
o conduzione di una lettura diretta del t€sto com€ prima forma di<br />
interpretazione del suo significato;<br />
o collocazione del testo in un quadro di confronti e relazioni<br />
riguardanti: altre opere dello stesso autore o di altri autori, coevi e<br />
non; altre espressioni artistiche e culturali; il più generale contesto<br />
storico del tempo<br />
. rapporto del testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e<br />
formulare un proprio motivato giudizio critico<br />
2) rillessíone salla letleratura e sua DrosDeîtivt sîofica:<br />
riconoscimento, in una generale tipologia dei testi, dei caratteri<br />
specifici del testo letterario e della sua fondamentale polisemia, che<br />
lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative e di continue<br />
riproposte nel tempo.<br />
Conoscenza e utilizzazione dei metodi e degli strumenti<br />
fondamentali per I'interpretazione delle opere letterarie;<br />
Saper cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più<br />
rappresentativi, le linee fondamentali della prosp€ttiva storica nelle<br />
tradizioni letterarie italiane.<br />
3 )competenze e conoscenze ling aislìche<br />
. capacità di eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente e<br />
sintatticamente corretta<br />
. capacità di affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di<br />
vario genere, utilizzando le diverse tecniche di lettura( esplorativa,<br />
estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si legge<br />
. capacità di produrre testi scritti di diverso tipo : di sintesi dei<br />
contenuti fondamentali del testo; di rielaborazione di contenuti (<br />
analisi testo; saggio breve; articolo di giornale.<br />
Sono state utilizzate le seguenti<br />
METODOLOGIE :<br />
Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, apprendimento<br />
cooperatiyo, role play, metodo induttivo e deduttivo si sono alternate a seconda<br />
dell'argomento trattato. T€sti in adozione, DVD, visite guidate. Uso della lim<br />
CONTENUTI<br />
t6
1)Processo storico letterario dalla seconda metà dell'Ottocento al Duemila.<br />
2. Letlnr esegetica di alcuni canti del Paradiso di Dante Alighieri<br />
3. Esercitazioni sui diverse tipologie di scrittura<br />
ATTIVITA' PROGETTUALI EXTRACURRICULARI<br />
1. NEWS PAPER GAME : Conigliaro Gaspare, Monteneri Luca, Terzo<br />
Leandro, Santoro Ugo.<br />
VERIFICHE E VALUTAZIONT:<br />
Le verifiche scritte sono state tre per quadrimestre. Sono state volte<br />
all'accertamento delle conoscenze di argomenti trattati e all'accertamento delle<br />
competenz€ tecniche di scrittura in riferimento alle diverse tipologie di scrittura<br />
ministeriale. Le verifiche orali sono state diagnostiche e sommative. Le prime<br />
quotidiane volte all'accertamento dell'impegno e dell'apprendimento costante.<br />
Le seconde, alla fine dei singoli moduli o anche interpercorsuali ( a pettine) alla<br />
fine di singole unitài sono state almeno cinque per quadrimestre. La valutazione<br />
si è awalsa dell'applicazione delle griglie di valutazione per materie affini<br />
allegata al registro personale<br />
,-\ ll;^_<br />
27
I ISTITUTO D,ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PLATONE,'<br />
ANNO SCOLASTICO 207T-2072 LICEO CLASSICO<br />
CLASSE V SEZ.A DOC. DIBARTOLO LUCREZIA<br />
Programma di letteratu ra italiana<br />
Anno scolastico 2OIL/2OLZ<br />
L' età postunitaria<br />
1, Le strutture politiche, economiche e sociali<br />
. Lo stato accentratore<br />
. ll suffragio censitario<br />
. Le strutture economiche<br />
. L'ostilità allo sviluppo industriale<br />
. ll protezionismo<br />
. L'awioalla'industrializzazione<br />
. ll divario tra nord e sud: la questione meridionale<br />
. La frattura social€ nell'ltalia postunitaria<br />
2. t'ídeologie<br />
. L'atteggiamentodegliintellettuali<br />
. ll capitalismo industriale e i mutamenti sodali<br />
. La fìducla ottimktica ed il culto della scienza e d€lla tecnica<br />
. La validilà del metodo scìentifìco<br />
. ll metodo della scienza esteso alla realtà spirituali<br />
. La scapiglaatura<br />
. Verga ùa romanticismo ev€rasmo<br />
. De Sanctis ka idealismo e realismo<br />
. li liberalìsmo<br />
3. Le istituzioni culturali<br />
. fistruzioneobblìgatoria<br />
. La funzione della scuola<br />
. ll sistema scolaslico<br />
. llteatro, specchio della borghesia<br />
4. Gli intellettuali<br />
. ll rifiuto deivalorì borghesi e della civiltà moderna<br />
. L'esclusìone del letterato dalla realta moderna<br />
. La provenienza sociale dell'intellettuale in ltatia<br />
. I nuovi intellettuali specialisti<br />
. L'lntellettuale si attribuisce un ruolo<br />
29
'Percorso l-: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati<br />
. Gliscapigliati e la mod€rnità<br />
. La Scapigliatura e il Romanticismo stranÌero<br />
. Un oocevia intellettuale<br />
. Un'avanguardiamancata<br />
Emilio Praga<br />
o TL Preludio (p932)<br />
Percorso 2: il romanzo dal Naturalismo francese a Verismo italiano<br />
1. ll naturalismo francese<br />
. I fonda menti teorici<br />
. I precursorl<br />
. La poetica diZola<br />
. ll ciclo dei Rougon Macquart<br />
Gustave Flaubert<br />
. Madame Bovary (Trama) pg66<br />
T2 Un Manifesto del Naturalismo<br />
Emile Zola ( In sintesi)<br />
. T3 Lo scrittore come " operaio" del progresso sociale<br />
2 ll Verismo italiano<br />
Luigi Capuana<br />
. T5 Scienza e forma letteraria : l'impersonalità<br />
Federico De Roberto<br />
. T5 Politica, interesse di casta e decadenza biologica della stirpe<br />
Percorso 3 ll romanzo realista in Europa ( ln sintesi)<br />
Percorso 4 La condizione femminile nell'età borghese ( In sintesi )<br />
2t")
'Pércorso 5: Giosuè Carducci<br />
1 La vita<br />
2 L'evoluzioneideologica<br />
. dalla democrazia repubblicana all'ìnvoluzìonemonar€hica<br />
. dall'antiromanìicismo classicistico all'esotismo evasivo<br />
. "Sanità" classi€a e "rnalattia" tardo romantica<br />
3 La prima fase della produzione carducciana: Juvenialia, Levia gravia,<br />
Giambi ed Epodi<br />
4 Le Rime nuove<br />
. T2 San Martino<br />
. Pianto antico (extra testo)<br />
5 Le odi barbare<br />
. TS Nella piazza dì San Petronio (vv.l.9-20)<br />
6 Rime e ritmí<br />
Percorso 6: Giovanni Verga<br />
1 La vita<br />
. La formazione e le opere giovanili<br />
. A Milano: la svolta verso il Verismo<br />
2 lromanzi preveristi<br />
3 La svolta verista<br />
4 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista<br />
. la poetica dell'impersonalità<br />
. la tecnica narrativa<br />
. T2 "Sanità" rusticana e " malattia" cittadina<br />
. T3 impersonalità e regressione<br />
o T4 l"'eclisse " dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato pg204<br />
5 L'ideologiaverghiana<br />
. ll "diritto di giudicare" e il pessimismo<br />
6 ll verismo di Verga e il naturalismo zoliano pg210<br />
7 Vita dei campi<br />
. T5 Fantasticheria pag.2I2<br />
. T7 La Lupa pag.229<br />
3Ò
' 'g ll ciclo dei Vinti<br />
' . T8 I "vinti" e la " fiumana del progresso"<br />
9 lmalavoglia<br />
. T9 ll mondo arcaico e l'irruzione della storia<br />
. T10 | malavoglia e la comunità del villaggio:valori ideali e interesse economico<br />
10 Le Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana<br />
11 ll Mastro- don Gesualdo<br />
. T15 La tensione faustiana del self-made man (w.110-295)<br />
ll Decadentismo<br />
1 La visione del mondo decadente<br />
2 La poetica delDecadentismo<br />
3 Temi e miti della letteratura decadente<br />
4 Decadentismo e Romanticismo<br />
2 Decadentismo e Novecento<br />
Percorso 1 Charles Baudelaire<br />
1 La vita<br />
2 lfiori del male<br />
. T1 Corrispondenze<br />
. T2 L'albatro<br />
. T4 Spleen<br />
. T9 Perdita d'aureola<br />
Percorso 2 La poesia simbolista<br />
Paul Verlaine (ln sintesi)<br />
. T1 Arte poetica<br />
. T2 Languore<br />
Arthur Rimbaud (ln sintesi)<br />
. T4 Vocali<br />
Stèphane Mallarmè (ln sintesi)<br />
Percorso 3 ll romanzo decadente<br />
2l
-Pércorso 4 Gabriele D'Annunzio<br />
L La vita<br />
2 L'estetismo e la sua crisi<br />
. Tl Un ritratto allo specchio :Andrea Sperelli ed Elena Muti<br />
3 | romanzi del superuomo<br />
. T3 ll programma politico del superuomo<br />
4 Le opere drammatiche (Sintesi)<br />
5 Le laudi<br />
. T9 La pioggia nel pineto<br />
Percorso 5 Giovanni Pascoli<br />
1 La vita<br />
2 La visione del mondo<br />
3 La poetica<br />
o T1 Una poetica decadente<br />
o M11 ll " fanciullino" e il superuomo: due miti complementari<br />
4 L'ideologia politica<br />
5 ltemi della poesia pascoliana<br />
6 Le soluzioniformali<br />
7 Le raccolte poetiche<br />
8 Myricae<br />
. I puffini dell'Adriatico
ll. Primo Novecento<br />
1. L'ideologia<br />
. croce: la rinascita dell'idealismo<br />
2. Le istiturioni culturali<br />
. ll Panorama delle riviste<br />
Percorso 1La stagione delle avanguardie<br />
1. I futuristi<br />
Filìppo Tommaso Ma rinetti<br />
. T1 Manifesto del Futurismo (pg24)<br />
o T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista (pg26)<br />
o T3 Bombardamento (pg30)<br />
Aldo Palazzeschi<br />
o E lasciatemi divertire (p934)<br />
2. Le avanguardie in Europa (ln Sintesi)<br />
Percorso 2 La lirica del Primo Novecento in ltalia (ln sintesi) pg117<br />
1. I crepuscolari<br />
Guido Gozzano<br />
. TZ La signorina Felicita owero la felicità (pg72)<br />
. T3 Totò Merùmeni (pg85)<br />
Percorso 3 ltalo svevo<br />
1. La Vita<br />
2, La cultura di Svevo<br />
3, ll primo romanzo:Una vita<br />
o T1 Le ali del gabbiano (pg131)<br />
4. Senilità<br />
. T2 ll ritratto dell'inetto (p9141)<br />
5. La coscienza diZeno<br />
. T6 la salute "malata" di Augusta (pg170)<br />
Z
' Pércorso 4 luigi Pirandello<br />
1, [a vita<br />
2. [a vísione del mondo<br />
3. La poetica<br />
4. Le poesie e le novelle<br />
. T2 La trappola (p9244)<br />
. T4 il treno ha fischiato (p9256)<br />
5, I romanzi<br />
. T6 lo strappo nel cielo di carta (pg279)<br />
. T7 Nessun nome (pg290)<br />
6, Gli esordíteatrali e il periodo " grottesco"<br />
7. ll giuoco delle parti<br />
. Atto terzo (p9323)<br />
8. ll " teatro nel teatro"<br />
9. L'ultima produzione teatrale<br />
10, L'ultimo Pirandello narratore<br />
Tra le due suerre<br />
1. La realta politico-sociale in ltalia<br />
2. La cultura<br />
Percorso 1La narrativa straniera del primo Novecento (ln sintesi) pg434<br />
Percorso 2 Frank Kafka ( In sintesi) pg462<br />
Percorso 3 La società italiana fra arretratezza e modernità ( In sintesi) pg499<br />
Percorso 4 L'assurdo, l'irreale, il fantastico ( In sintesi) 521<br />
Percorso 5 L'Ermetismo<br />
Salvatore Quasimodo<br />
o T1 Ed è subito sera (pg526)<br />
o T2 Vento a Tindari (P9527)<br />
o T3 Alle fronde dei salici (pg529)<br />
Leonardo Sinisgalli ( In sintesi) pg541<br />
4/
'Pércorso 6 Umberto Saba<br />
1. La vita<br />
2. ll Canzoniere<br />
. T1 A mia moglie (pg544)<br />
o T2 La capra (p9557)<br />
. T3 Trieste(p9559)<br />
. T4 Città vecchia (pg551)<br />
. ts Mia figlia (p9562)<br />
o T9 Amai (p9568)<br />
o t10 Ulisse (p9570)<br />
3, Le prose<br />
. Ernesto<br />
Percorso 7 Giuseppe Ungaretti<br />
1. La vita<br />
2. L'allegria<br />
. T3 ll porto sepolto (p9601)<br />
o T4 Veglia (pg602)<br />
o ts I fiumi (pg604)<br />
o T6 San Martino del Carso (pg608)<br />
. T8 Mattina (p9611)<br />
. Tto Soldati (pg513)<br />
. T11 Girovago<br />
3. ll Sentimento del tempo<br />
4, ll dolore e le ultime raccolte<br />
. T15 Non gridate più (p9631)<br />
Percorso 8 Eugenio Montale<br />
1. La vita<br />
2. Ossi di Seppia<br />
o tl Limoni (pg549)<br />
T2 Non chiederci la parola (pg653)<br />
T3 Meriggiare pallido e assorto (pg655)<br />
T4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pg657l<br />
o T8 Casa sul mare (p9663)<br />
3r-
'. '3. ll secondo Montale : le occasioni<br />
o T12 La casa dei doganieri (pg679)<br />
4. ll terzo Montale<br />
o T13 La Primavera hitleriana (w.31-a3) (pg683)<br />
o t14 L'anguilla (pg687)<br />
. T15 piccoto Testamento (w.i.-7) (pg689)<br />
5. l'ultimo Montale<br />
. T17 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (extra testo )<br />
o ln Sulla Poesio (extra testo)<br />
36
tO SCENARIO:SÌORtCO, SOC|ETA,, CULfURA, tDEE<br />
1. lL QUADRO POIIT|CO<br />
LA COS-TITUZIONE<br />
. ll referendum 1946<br />
2. TRASFORMAZIONIECONOMICHE ESOCIALI<br />
LA RICOSTRUZIONE DET DOPOGUERRA E IL BOOM<br />
It coNsuMtsMo<br />
. PAG 581 IL RIMPIANÍO DEL MONDO CONTADINO E T'OMOLOGAZIONE CONTEMPORANEA<br />
I.'EMIGRAZIONE IINTERNA<br />
DAGLI ANNI SESSANTA AGtI ANNI OTIANIA<br />
GLI ANNI NOVANIA E LA SVOLTA DEL MILTENNIO<br />
3. rEO|TORiA<br />
BESI, SELLERS E IASCAEITI<br />
4. IL PUBBLICO<br />
5. tGtoRNAtl<br />
6. LA TETEVISJONE<br />
7. tL CONSUMTSMO<br />
- TNTERVTSTA AD ptER PAOLO pASOLtNt: - GENOC|D|O DELTE CUTTURE (you Tube)<br />
, tNfERVtSTA AD ZYGMOND BOUMAN: AMORE LleUtDO (you Tube)<br />
8. LE TECNOLOGIE INFORMATICHE E INIERNET<br />
9. tA SCUOTA E L'UNIVERSITA<br />
10. GLI INTELLETTUALI<br />
11. IL DIBATTIÍO DELTE IDEE<br />
. L,egemonia del marxismo e l,eredità idealistica<br />
. La contestazione e la Scuola di Francoforte<br />
. t'esistenzialismo<br />
PERCORSO 1: LA GRANDE NARRAÌVA SIRANtERA ( tN SlNÌESt pA6 99)<br />
PERCORSO 3: tL ROMANZO DELTA BORGHESTA (tN StNTES| pAG 149)<br />
Percorso 4: ILMtTO DEL popolo<br />
ETIO VITTORINI<br />
T1: ilnondo offeso<br />
PERCORSO 5: LA GUERRA, LA DAPORTAZ|ONE, tA RESTSTENZA<br />
PERCORSO 6: INDUSIRIA E LETTERA-rURA<br />
T3: la funzione dell'uomo-cosa<br />
PERCORSO 7r ITROMANZO E t-A STORTA (lN StNTES| pAG 288)<br />
GIIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA<br />
11: la Sicilia e la morte<br />
3/
SI INIENDE COMPI.ETARE CON:<br />
PERCORSO 9: LA POESIA OTTRE L'ERMETISMO (lN SlNTESl PAG 363)<br />
PERCORSO 10: LA POESIA DAGLI ANNI SESSANTA AD OGGI ( lN SINTESI PAG 385)<br />
PERcORSO 11: TQUIETUDINE GIOVANItE ( lN SlNrESl PAG 414 )<br />
PERCORSO 12: tA I-EfTERATURA DRAMMATICA ( lN SIN'rÉSI PAG 451)<br />
PERCORSO 14r CARLO EMILIO GADDA( lN SlNTESI PAG 560)<br />
PERCORSO 15: PIER PAOLO PASOIINI {lN SINTESI PAG 594)<br />
PERCORSO 16: ITAIO CALVINO (lN SINTESI PAG 650)<br />
INfERVISIA AD PIER PAOLO PASOLINI: IL GENOCIDIO DELLE CUITURE<br />
INTERVIS-IA AD ZYGMOND BOUMANT AMORE LIQUIDO<br />
FIRME DEGLIALUNNI<br />
3S
srrruro o, rsrRuzroru e s rcoru onnrn su pr Rro nÈ lRio rrr<br />
y<br />
INDIRIZZO CLASSICO CLASSE V SEZ.A<br />
DOCENTE DIBARTOLO LUCREZIA<br />
Programma di Divina Commedia<br />
PARADISO<br />
CANTO | (da w. 1a w.27, da w. 103 a w. 142)<br />
CANTO II<br />
CANIO VI<br />
CANIO XI<br />
CANIO XII<br />
CANTO XV {da w.25 a w. 30, da w.91 a w.148)<br />
CANTO XVlt (da w. 13 a w. 142)<br />
CANTO XXXIII<br />
FIRME DEGIIALUNNI<br />
)9
ISTITT TO D'ISTRT,ZIONE SECONI)ARIA STIPERIORI<br />
..{\\() scol.As I I('o 201 | /12<br />
Iì{DIRIZZZO CLASSICO CLASSE V<br />
.PI,ATO\ E'<br />
Relazione finale LATINO Docente Lucrezia Dibartolo<br />
La classe, nel sùo complesso, ha dimostrato interesse al dialogo educativo e impegno costatrte<br />
durante tutto I'anno scolastico. ll rapporto è stato improntato su rispetto e stima reciproci.<br />
Sotro state perseguite le segtentifug!!j39!g!!y1!gyg19g!jattraverso lo studio dei<br />
cotrtenuti relativi alla disciplina e anche attraverso le sitùazioni quotidiane di vita scolastica:<br />
1) sviluppo di emozioÍi e sensibilità soggettive per un più consapevole senso di sé nella<br />
vita di gruppo, e utr più saldo equilibrio psico- fisico<br />
2) sviluppo di una coscienza della solidarietà, del rispetto delle diversità .<br />
3) sviluppo della coscienzr civica<br />
4) sviluppo di una coscienza intercùlturale.<br />
Le linalità specifrche della disciplina sono stare volte a<br />
promuovere e svllupparei<br />
l. un ampliam€nto dell'orizzonte storico, in quanto l'insegnamento della lingua e della<br />
letteratùra latina riporta la civiltà europea ai suoi fondamenti linguistici e culturrli<br />
2, la coscienza della sostanziale unità della civiltà europea che, pur nella diversità delle<br />
culture nazionali, ha mantenuto sempre uno stretto legame con il mondo antico, ora in<br />
termini di continuità, ora di opposizione, ora di reinterpretazione secondo il motto attuale<br />
UNITA'NELLA DIVENSITA'<br />
3. la formazione di capacilà di astrazione e di riflessione, sviluppando, nella continuità della<br />
traduzione didsttica, abilità mentali di base in funzione preparatoria a studi superiori in<br />
diversi ambiti anche scientilici e tecnologici.<br />
4. una formazione umana più consapevole delle radici e quindi piir capace di conoscere per<br />
conoscersi meglio e per decodificare la complessità del reale, che solo con strumenti<br />
culturali ralidi, oggi piil che mai. può essere compresa.<br />
OBBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI RAGGIUNTI DA TATTI GLI ALUNNI<br />
CONOSCENZA essenziale del percorso storico letterario datt'età di Traiano alla caduta<br />
dell'impero romano d'occidente; per ogni autore conosceDza dell'ideologia, cotroscerùza id<br />
sintesi della biografia e del percorso letterrrio dell'aùfor€ e di passi scelti ir| lingua latiDa<br />
COMPETENZE cli alunni possiedono utra visione d'iDsieme degli aspetti<br />
storici,politici,culturali e antropologici emergenti dallo studio della letterahrra latina;<br />
un'adeguata padronanza delle strutture morfo-sintattiche, lessicali e stilistiche, Sono in grado<br />
di realizzare percorsi letterari sincronici e diacronici; istitùire confrorti tra la civiltà latina e<br />
quelle moderne.<br />
q0
OBIETTIVI DISCrcLINARI APPROFONDITI RAGGIUNTI DA ALCUNI<br />
ALUNNI<br />
1 lnterpretazione e traduzione di testi latini anche di notevole difricolta<br />
2. conoscenza di elementi della meirica latinai esametro<br />
3. sono in grado di cogliere in prospettiva diacronica i principali mutamenti dalla lingua<br />
lrtina alle lingue neolatine;<br />
4. sono in grado di dare al testo una collocazione storica, cogliendo alcuni legami<br />
essenziali con Ia cultura e la letteratura coeva;<br />
5. sono ir grado di individuare i vari generi letterari, le tradizioni di modelli e di stile, i<br />
topoi;<br />
6. sono in grado di individuare i caratteri s{lienti della letteratura latina e colloca.e i testi<br />
e gli autori nella trama generale della storia letteraria.;<br />
7. sono in grado di impostare insieme con probl€mi di comprensione storica, problemi di<br />
valulazione estetica<br />
8. sono in grado di riconoscere i rapporti del mondo latino con la cultùra moderna.<br />
CONTENATI<br />
Il programma di letteratura latina ha seguito le indicazioni dei PROGRAMMI IIROCCA che<br />
prevedono, nell'ultimo anno, lo studio da Marziale in poi, per poter dare ampio spazio alla<br />
letteratùra CRISTIANA LATINA, momento cruciale di passaggio {lla civiltà europea<br />
medievale. Seneca, autore trattato I'anno scorso è stato ripreso per l'importanza che svolge e<br />
nell'ambito della letteratura cristiana e nell'ambito della cùltum europea. Allo stesso modo è<br />
stato ripreso Petronio, autore trattato I'anno scomo , per i possibili confronti con Apuleio.<br />
l. Processo storico fetterario lall'età di Truia,n ullL cqllu1a leJ!j!!pg!9__!!g!!p.<br />
tl'Occi.lente<br />
2. Lettura ,analisi, commento di passi scelti degli autori studiati, Sirtassi dei modi;<br />
sintassi del periodo<br />
Mf,TODOLOGIf, e STRUMENTI UTILIZZATI: Lezione frontale, lezione diîlogata, lavori<br />
di gruppo, apprendimento cooperativo, role phy, metodo induttivo e deduttivo sono stati<br />
ùtilizzali a seconda dell'argomento trrttato. Testi in adozione. Uso delh LIM.<br />
ATTIVITA' PROGETTUALI CURR]CULARI ED EXTRACURRÌCULARI PREVISTE:<br />
1. PROGETTO NEWSPAPERGAME Conigliaro Gaspare,Varrasi Simone, Terzo<br />
Leandro, VeneziNno Michela.<br />
VERIFICHE E VALUTAZIONI:<br />
Le veriliche scritte sono state due nel primo periodo e due nel secondo, volte all'accertamento<br />
delle conoscenze di argomenti tratfati e all,accertamento delle competenze tectriche<br />
traduzione secondo le prescrizioni ministeriali. Le veriliche orali Sono state diagDostiche e<br />
sommative. Le prime quotidiane volte all'accertamento dell'impegno e dell'apprendimento<br />
costanfe. Le secondc, alla fine dei singoli moduli o anche interpercorsuali ( s pettile) alla line<br />
di singole unità) sono state almeno tre nel primo periodo e dmeno quattro nel secondo.Nel<br />
secondo è stato svolto un test a risposta chiusa e aperta e a trattazione sintetica. La<br />
valutazione si è awalsa dell'applicazione della griglia di valutazione per materie affini<br />
aflegata al registro personale.<br />
A<br />
I I<br />
a- l" v/"<br />
It<br />
\ l,/ , I n^<br />
/, .'t '1 n--/' /l r V-J-,\'.\J<br />
I
I ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "PLATONE"<br />
ANNO SCOLASTTCO 2011/2012<br />
INDIRIZZO CLASSICO CLASSE V SEZ.A<br />
DOCENTE DIBARTOLO LUCREZIA<br />
Programma di Latino<br />
Volume 4<br />
MARZIALE<br />
. Profilo letterario<br />
. Antologie<br />
TESTO 3: calpe diem (pag 319)<br />
TESTO 5: Ia vera libeftà (pal 322)<br />
TESTO 6: un conmensale disgustoso (pag 323)<br />
TESTO 9: sapore di umanità (pag 326)<br />
PLINIO IL GIOVANE<br />
. Profilo letterario<br />
. Antologia<br />
TESTO I : un principe senza difetti (pag 340)<br />
TESTO 3: la morte di Plinio il Vecchio (pag 345)<br />
TACITO<br />
TESTO 5: come componarsi con i cristiani ( pag 350)<br />
. Profilo letterario<br />
. Anrologia<br />
TESTO: tla passato e presente (pag 376)<br />
TESTO 9: il fallito attentato ad Ag ppina (pag 429)<br />
42
Volume 5<br />
CONTESTO STOzuCO<br />
. LO SCENARIO STORICO: il principato adottivo e l'età dei Severi (1 17-235 d.C.)<br />
l. La prudente politica di Adriano<br />
2. Antonino Pio: il periodo aureo dell'impero<br />
3. Marco Aurelio, l'imperatore filosofo<br />
4. Il govemo dispotico di Commodo<br />
5. Il crescente peso delle province e dell'esercito<br />
6. La monarchia militare di Settimio Severo<br />
7. L'editto di Caracalla<br />
8. La fine della dinasria dei Severi<br />
. IL CRISTIANESIMO E L'IMPERO<br />
L Conrastanti interFetazioni del documento di Traiano a Plinio il Giovane<br />
2. L'inasprimento sotto Antonino Pio e Marco Awelio<br />
3. L'integr^zione dei cristiani nella vita pubblica<br />
4. Episodi violenti in un quadro di inlolleranza generale<br />
5. Le simpatie filocristiane dei Severi<br />
6. I cristiani e il potere politico<br />
7. Il culto dell'imperatore<br />
. LE IDEE E LA CULTURA<br />
l L'ideale cosmopolita<br />
2. L'impofante ruolo della scuola<br />
3. Filellenismo degli imperi<br />
4. Intellettuali gÌeci pienamente integrati<br />
5. La seconda sofistica<br />
. INQUIETUDINI E RICERCHE RELIGIOSE<br />
1 . Una generalizzata domanda di significato<br />
2. La crisi della religione tradizionale<br />
3. llt onfo dell'inazionale<br />
4. Un atteggiamento di fondo: il sincretismo<br />
5. I nuovi culti che svlotano I'antico paganesimo<br />
6. lside e Mitra<br />
I LA NUOVA FEDE<br />
l. La diffusione del cristianesimo<br />
2. L'opposizione della cultura uffìciale<br />
3. Cosa c'è in comune tra Gerusalemme e Atene<br />
4. Il /ogos "seminale" di Giustino<br />
4)
. IL SISTEMA LETTERARIO<br />
1. La linfa nuova del cristianesimo<br />
2. La poesia: poeti "novelÌi"; Floro e Adriano; "Pervirgilium Veneris"<br />
3. La prosa: Floro e la biografia del popolo romano<br />
4. Letteratura crìstiana: una lingua speciale; apologetica e definizione dottrinale;<br />
. ORIGINI E PRIMI SVILUPPI <strong>DELLA</strong> LETTERATURA CRISTIANA<br />
l. I primi scritti cristiani<br />
2. Le prime traduzioni della Bibbia<br />
3. La letteratua deimartir.t Acta Martyrum, Passiones, Acfa Martyrum Scilitanorum,<br />
Passío Perpetuae et Felicítatis<br />
SVETONIO<br />
. Profilo lettera o<br />
. Antologia<br />
TESTOI: presagi della mofe di Cesare (fino a punto 2, pag6l)<br />
APULEIO<br />
. Profilo letterario<br />
. Antologia:<br />
TESTO 1: la vera magia (pag 80)<br />
TESTO 2: I demoni (pag 82)<br />
GLI APOLOGISTI: MINUCIO FELICE E TERTULLIANO<br />
. Profilo letterario<br />
. Antologia<br />
TESTO l: le critiche di Cecilio ai cristiani (pag 106)<br />
TESTO 2: la risposta di Ottaviano ( pag 107)<br />
TESTO 4: il Dio dei cristiani (pag I 19)<br />
CONTESTO STOzuCO<br />
o LO SCENARIO SToRICO:<br />
L L'anarchia militare: I'apice della crisi<br />
2- Le riforme di Diocleziano: la riforma istituionale militare; il fallimento della tetrarchia<br />
3. L'impero cristiano da Costantino a Teodosio: lo stato ed il controllo delle eresie; la<br />
prevalenza dell'Oriente; Giuliano I'Apostata e la restaurazione del paganesimo; con<br />
Teodosio il cristianesimo diviene religione di stato<br />
4. Le grandi invasioni e il crollo dell'impero d,Occidente: le stirpi germaniche; ì barbari<br />
federati delf impero; La conversione al cristianesimo secondo la forma ariana; la<br />
deposizione di Romolo Augustolo; una data simbolo per una caduîa senza rumore<br />
5. La funzione decisiva della chiesa: i modelli del monachesimo orientale e occidentale; i<br />
padri del monachesimo europeo: Benedetto e Colombano;<br />
6. I regni rcmano-g€rmanici: Ostogoti e Longobardi in Italia<br />
++
. LE IDEE E LA CULTURA<br />
l Rigorismo afiicano: montanisti e donatisti; Ie eresie cristologiche e dottrinali;<br />
Manicheismo e Gnosi<br />
2. Atene e Gerusalemme scontro e incontro tra due culture: il movimento neo-pagano dei<br />
Simmachi e Nicomachi; tradizioni, denaro e tolleranza; la replica di Ambrogio;<br />
I'epistolario apocrifo tra Seneca e San Paolo: tentativo di unificazione di Lattanzio<br />
. IL SISTEMA LETTERARIO<br />
L Un quadro in evoluzione: policentrismo culturale; differenziazione linguistica<br />
2. La poesia pagana tra il terzo e il quarto secolo.. AhÍhologia Latína e gli Epigrunni<br />
Bobbionesi; mi,s'ura breve e gusto per il paradosso<br />
J. La cultura tradizionalista e i prosatori pagani: la nostalgica rappresentaz ione dei<br />
Satumali; I'enciclopedia di Macrobìo; il commento di Macrobio al Somnium Scipionis<br />
l. I generi della letteratura cristiana: un largo spetho di temi e gene<br />
J. L'età della patristica: i maestri della civiltà europea; i Padri nel loro tempo; fede e<br />
cultura; I'umanesimo cristiano di Girolamoi Ambrogio e I'evangelizzazione dell'etica<br />
ciceronìana<br />
L'HISTORIA AUGUSTA E AMMIANO MARCELLINO<br />
. Profilo LetteBrio<br />
. Antologia<br />
TESTO l: Eliogabalo, il "mostro" ( punti 1,2,3,5,6,17, pagt9l)<br />
TESTO 3: Giuliano restaura i culti pagani (pag 201)<br />
TESTO 4: Morte di Giuliano (pag 202)<br />
AMBROGIO<br />
. Profilo lettera o<br />
. Antologia<br />
TESTO l: Contro I'avidità (pag 261)<br />
TESTO 2: Inno del mattino (pag 266)<br />
GIROLAMO<br />
. Profilo letteamrio<br />
. Antologia<br />
TESTO : Tradizione pagana e tradizione cristiana (pag 278)
AGOSTINO<br />
o Profilo letterario<br />
o Antologia<br />
TESTO: l'ìnvocazione d'apertura (pag 309)<br />
TESTO 4: le due citta (pag 330)<br />
FIRMA DEL DOCENTE<br />
FIRME DEGLI ALLINNI<br />
l-t o
ALLEGATO<br />
Materia: Economia<br />
RELAZIONE FINALf, DEL DOCENTE<br />
Classe: 5A <strong>Liceo</strong> classico Anno scolastico 2011/2012<br />
In relazìoùe alla programm^zion€ curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:<br />
CONOSCENZE: La classe è formata da aluoni interessati, che, in generale, hanno raggiunto<br />
risultati positivi, anche se differenziati nello specifico e che evidenziano un apprezzabile livello di<br />
conoscenza. delle tematiche proposte. Alcuni alunni si sono paficolarmente distinti, evidenziando<br />
conoscenze zrmpie, approfondite e coordinate.<br />
Le conoscenze acquisite riguardano specialmente: la dimensione e le caraferistiche dei sistemi<br />
economici modemi; le interdipendenze tra I'economia e gli altri aspetti sociali; la domanda,<br />
I'offerta e i mercati e il poterc economico; i processi di crescita, gli squilibri nello sviluppo e<br />
I'intervento pubblico; i rappofi economici intemazionali; lo sviluppo economico, il sottosviluppo<br />
e relative problematiche.<br />
COMPf,TENZE-CAPACITA'-ABILITA': la classe si è ben orientata nella disamina ed<br />
articolazione delle diverse problematiche tattate, acquisendo gradualmente, in generale, sicure<br />
competenze nell'acquisizione di nuovi codici linguistici, nelle tecniche di inîerpretazione della<br />
realtà sociale e sviluppando le capacità di analisi, di sintesi e di elaborazione.<br />
ln paficolare, sono stati sviluppati: l'uso di un linguaggio tecnico appropriato; la capacità di<br />
cogliere la dimensione storica dei fenomeni e dei sistemi economici; la capacità a cogliere la<br />
relativita degli schemi interpretativi della scienza economica; la capacità a cogliere la pluralità delle<br />
variabili economiche e la responsabilità delle scelte relative; la capacità ad operare collegamenti con<br />
le altre discipline.<br />
I. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI NEÀJ.IZZAZIONE ESPOSTI PER ORE:<br />
MODULI:<br />
Sistemi economici, soggetti economici€ funzioni. ...........................<br />
Teoria della domanda, dell'offerta e mercati.................................<br />
Il pensiero economico: lineamenti e púncipali scuole economiche<br />
Prodotto e reddito nazionale: teorie, tipi di reddito, consumi, risparmi, investimenti. ................<br />
Intervento dello stato nell'economia: firnzioni, strumenti e politiche di intervento................<br />
La moneta: funzioni, valore, politiche monetarie, inflazione_ Il credito, la borsa....................._.<br />
Squilibri economici. I cicli economici, la disoccupazione ed intervento pubb1ico......................<br />
Commercio intemazionale. Sistemi monetari e regimidi cambio.Sviluppo e sottosviluppo.......<br />
Ore effettivamente svolte e da svolgere nell'anno scolastico.......<br />
N.B.: nelle ore per le attività svolte e da svolgere sono comprese anche quelle utilizzate per<br />
verifìche dei dsultati.<br />
2. METODOLOGIf,:<br />
Lezione ftontale con una impostazione didattica apeda, prendendo spunto dalle situazioni concrete<br />
per arrivarc a progressive concettualizzazioni, generalizzazioni e all'elaborazione personale e critica<br />
Non sono state svolte attività di recupero, di sostegno o di integÌazione.<br />
3, TESTO E MATERIALI DIDATTICI :<br />
Testo adottato: Claudia De Rosa, Le basi dell'economia politica, editore Simone; materiali<br />
audiovisivi; uso di intemet, giomali economrcr.<br />
4. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:<br />
Verifiche orali.<br />
t3<br />
9<br />
4<br />
3<br />
2<br />
6<br />
t7<br />
65<br />
le<br />
/, )<br />
IL DOCENTE<br />
1P$[. P4olo\isicaro)<br />
\""!, /t^u"*
ALLEGATO<br />
LICEO CLASSICO STATALE (PLATONE"- PALAZZOLO ACR.EIDE<br />
PROGRAMMA SVOLTO PER LA MATERIA "ECONOMIA "<br />
ANNO SCOLASTICO 2OII DOI2<br />
CLASSE 5 A LICEO CLASSICO<br />
- Il problema economicot caratteristiche e principi generali sull'economia; i bisogni<br />
oconomici; i beni economici.<br />
- I sistemi economici: caratteristiche; il sistema liberista; il sistema ad economia mista, il<br />
sistema collettivista.<br />
- ll pensiero economico: evoluzione e scuole economiche. mercantilismol la<br />
fisiocrazia; la scuola classica; la scuola socialista; la scuola storica: la scuola<br />
neoclassica;il pensiero Keynesiano e successivi sviluppi delle teorie economiche.<br />
- Soggetti economici e loro fuDzioni: le famiglie: le imprese; lo stato: il resto del<br />
mondo.<br />
- La domanda, I'olTerta e le diverse forme di m€rcato:analisi della domanda dei beni e<br />
fattori che la determinano, elasticità della domanda; la produzione: nozione, funzione,<br />
costi, posizione di equilibrio dell'impresa; il mercato: nozione, posizione di equilibrio;<br />
tipi di mercato: la concoÍenza perfetta ed imperfetta, il monopolio, l'oligopolio.<br />
- Il prodotto e il reddito nazionale: nozione, teorie sulla determinazione del reddito e<br />
dell'occupazione; teoria classica, teotia keynesiana; il moltiplicatore; tipi di reddito:<br />
salario, prohtto, interesse, rendita.<br />
Consumi. risparmi. invesrimenri : funzioni.<br />
- La motreta il credito e la borsa: origini e funzioni della moneta; tipi di moneta; il<br />
mercato monetario; politica monetaria e stumenti di intervento. Il credito: funzioni; la<br />
banca e sue funzioni; il sistema bancado italiano. La borsa: funzioni e caratteristiche.<br />
- | cicli economici: nozione, fasi del ciclo e politica anticiclica.<br />
- L'inflazione: nozione, cause ,effetti e politiche antinflazionisîiche.<br />
- Occupazione e mercato del lavoro: occupazione e disoccupazione; cause della<br />
disoccupazione e rimedi.<br />
- L'intervento pubblico nell'economia: funzioni, obiettivi, strumenti dell,intervento<br />
dello sîato nell'economia.<br />
- Il commercio intern^zionale:caratteristiche; lib€ro scambio e protezionismo; ra rcona<br />
dei costi comparati; la bilancia dei pagamenti intemazionali.<br />
- Il mercato valutario e il cambio: caratteristiche, regimi di cambio; sistema monetado<br />
attuale.<br />
- L'integrazione economica europea: l'unione europea: firnzioni, caranedstiche, sistema<br />
moletafi o europeo, l'Euro.<br />
- Lo sviluppo economico e i problemi del sottosviluppo: problematiche attuall; verso<br />
uno sviluppo più sostenibile.<br />
,dA^". A*"'*"""<br />
qk
IS TITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECoNDARTA SUPERIORE "PLATONE" -<br />
PALAZZOLO (SR)<br />
A.S. 20r l/2012<br />
RELAZIONL IIINALE : INGLESE<br />
Prof. Giudice Alessandro<br />
Classe V Classico<br />
SITUAZIONE DI PARTENZA<br />
La classe è composîa da 28 allievi generalmente atterìti e motivati a seguire Ie lezioni. La sùa<br />
composizione è piuttosto eterogenea per interessi e livelli di competenza ma il diàlogo educativo si<br />
è mantenuto sen'ìpre costante e positivo nel corso dell'anno scolastico, duranle il quale gli studenti<br />
hanno comp;uto un percorso di maturazione personale e di crescita culturale.<br />
OBIETTIVT DIDA'I1'ICI<br />
Per quanto riguarda gli obiettivi generali la classe sa:<br />
l.Comprendere testi in lingua appanenenti ad ogni registfo linguistico.<br />
2.Rielaborare ed esporre con un vocabolario adeguato e con la competenza linguistica<br />
necessaria ad un livello intermedro.<br />
3.Affrontare temi di attualità e di vario generc in modo abbastanza corretto.<br />
I'er quanto riguarda gli obiettivi specifici la classe sal<br />
l.Riconoscere il panorama letterario e ilcontesto storico/sociale dei periodi degli autori<br />
studiati.<br />
2.lnterpretare. elaborare, sintetizzare. riconoscere e valutarc criticamente testi ad un livello<br />
pertinente.<br />
3.Espone gli argomenti studiati.<br />
4.Sapere lavorare in modo autonomo.<br />
5.Argomentarc ìn nlodo personale adeguato.<br />
RISULl'ATI CONSEGUITI<br />
Nel complesso la classe ha raggiunto un discreto livello di competenza linguistica.<br />
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obicttivi sopra indicati. a livello individLrale in termini<br />
di conoscenze, compctcnze e capacità i risultati si diÍÌèrenziano in relazione al livello di partenza.<br />
ai ritmi di apprendimento c all'impegno dei singoli alunni. ln paficolare. sulla base dci risultati<br />
raggiunti. la classe può essere divisa in tre fasce di livello:<br />
-una che raggiunSe ottimi risultati. risulta capacc di usare le competenze linguistiche<br />
acquisite in modo autonomol<br />
-una seconda, linguisticamente più dcbole c spesso motivata solo dalle verifiche, che si<br />
cdratterizza per lo piil per uno studio scolastico e nncmonico, ma comunquc in grado di sfruttare in<br />
qualche modo le conosccnze acquisite per rielaborazioni personali;<br />
-una terza, infine. in cui le competenze acquisile rienlrano a volte nei limiti degli obiettivi<br />
minimi prefissati anche per mancanza di uno studio adeguato e consapevole.<br />
+9
METODOLOGIA<br />
ll metodo di lavoro ha privilegiato la discussione sugli argomenti di letteratura proposti. Si è usato<br />
principalmente il libro di lesto e fotocopie. La visione di estratti da films, I'uso di supporti<br />
multimediali, la tecnologia informatica completano il percorso formativo degli studenti.<br />
VERIFICHE SCRITTE E ORALI<br />
Per I'orale si sono uîilizzate le interrog^zioni valutando la conoscenza degli a4omenti, la<br />
coÍettezza espositiva, la capacità di argomentare e gli approfondimenti auîonomi.<br />
Per le verifiche scritte si sono usate modalità di esecuzione conispondenti anche alle (due)<br />
simulazioni di terza prcva.<br />
CRITERI DI VALUTAZIONE<br />
In ogni prova scritta e orale sono stati considerati i seguenti crited di valul,azioae:<br />
-Coîeffezza, coeîeÌr,za, proprieta lessicale<br />
-Conoscenza dei contenuti e dei temi correlati<br />
-Originalilà e creatività nella rielaborazione p€rsonale<br />
-Approfondimenti autonomi.<br />
ANDAMENTO DISCIPLINARE<br />
ll comportamento della classe è stato corretto ed educato.<br />
SCALA DI MISURAZIONE<br />
Da I a l0 sia per le prove scritte che per quelle orali.<br />
EVENTUALI ALTRE OSSERVAZIONI<br />
Le lezioni sono state svolte principalmente in lingua Inglese. Alcuni studenti hanno sostenuto esami<br />
di certifi cazione Trinity.<br />
/, - / .,.t'<br />
/t /,/ /I / /l<br />
t)k-,----JC l.'\-'/' "--.'-<br />
,0
l-l('llO *Pl.^ION[:' - PAI-AZZOLO (SR)<br />
"l)ocurnento dcl l5 Maggio''<br />
A.S. l0t I/t2<br />
tN(ìt-tist:<br />
('lasse VA-Classìco<br />
l>rol'.,\lessandro Ciudice<br />
l-ìhri di tcslo adottali : l-itctl-lh. Zanichclli<br />
Orc di lczionc eftettuatc (due orc a sellintana) : 4lì (quarantotto) ore.<br />
Obicttir ì conscguiti I tcncndo cont(ì dì una distinzione f'ra i rlillèrenti lir,elli di conrpctcnza ed abilìtiì<br />
hggiùnli ddgli aìunni. la classe ha acquisito buone capacità ncl comprcndere. itnalizzaÌc cd<br />
inlcrprtlarc i tesli Icllc|ari/linguistici. coglieÌc c()|tnessioni fia tlisciplinc diversc. rielaborarc<br />
crilicamclìlc i conlen-Lf i. utilizzutc il le'ssico specifìco.<br />
In nrcrito allà rìrcbclologia. cd 0llc rr.r'ilìche e valutazioni regolarmcntc eflòttuate. si là rifèrimcnto<br />
allil progranrnlazionc annuale.<br />
E' slata svolta qualche lezionc in aula multintcdiale con l'uso di materialc audiovisivo e con<br />
collcgan'ìct1ti inlernet pcr riccrca ed all]pliutìtento su tcmi letterari.<br />
( onteúuli lirguisilici/gramnuticali : "ll-clauses" ll and Ill types.<br />
Contcnuti lcltcmri : [-cltura. analisidcl testo. riccrca sull'autore.<br />
"lrcar'. pcacc and licedoni_<br />
White Noisc - l)on lle Lillo. rcscarch or the author (8 ore)<br />
Slaughtcrhousc 5 KuÍ Vonncgut. rescarch on tlìc ruthor (8 orc)<br />
l9lìl Ccorgc Olucll. research on thc author (7 ore)<br />
''Modernisls"<br />
Mrs. l)allouar Vilgirria Woolt. rcscarch on lhc author (4 ore)<br />
[.ll]'sses .lànlcs.lo]cc. lrsearch ()n thc author (ó ofe)<br />
"A possible \\a\ '.)"<br />
Willdcn I lqrry. Dar icl I horcau. rc'search on the author (2 ore)<br />
IliìckSrouncls slorici-sociologici :<br />
Modcrnisnt (f orc)<br />
Post-modcrnism (l ofc)<br />
Non ù srara lìnora rcali/zatù. lì)ndamentalnìeDre pel la nlancanza di tenìpo dnta dallc lin'ilarli due<br />
orc sdlimallali di lczioDc. l'irÍi\ità l'aeoltarì\'r menzionùta nella progranìùlazionc. sccondo cui si<br />
diNî agli slùdcnti h possibitirrì cli pr.porre la crcntuale lraltazion!'di qualche ulleriorc argonrcnro<br />
cd írrrorc a loro liheril scclrî in base ai lorc inlercssi comuni; talc disponibililà ed inì/ialivada partc<br />
dcl sottoscrilto si inquacha logicanrcnlc uclla porcnriale apcrtura tenrltica irdispensabilc in un iiceo<br />
classico/'scìcnrilìco/lirrguisrico. rlaro il lallo clìc la Lelleratum Inglcse. Anglo-Americana c dcgli<br />
aulo.i anglolì)ni e un pirl,ìm.urio globalc ed un panorama clrlturale assaì anipio. al tluale attingclr.e<br />
ci)' c'lusiasmo pe' collegarc il passatr. il prcscntc ed il futuro coi'lvolgcndo nclla rilìessionc in<br />
lingua inglcsc lar-i anrbiti disciplinar.i anchc secondo critcri CLIL.<br />
fbf. U-------.rL .1-
Relazione finale del docente<br />
Materia: fisica<br />
classe: 5"A anno scolastico: 201l/2012<br />
In relazione alla programmazione curicolare sono stati conseguiti i seguenti obbiettivi:<br />
l. leggere un testo di fisica, comprendere ed acquisire la teminologia scientifica.<br />
2. rfillzzarc ed elaborare i simboli tipici della disciplina allo scopo di produrre una<br />
comurucazlone coerente e coretta.<br />
3. possedere, con consapevolezza critica, gli argomenti disciplinari e saperli gestire<br />
autonomarneme.<br />
4. la consapevolezza della possibilità di descrivere in termini di trasformazioni fisiche eventi<br />
osservabili anche al di fuori di laboratori scolastici.<br />
Gli alunni, in base alle conoscenze si possono dividere in due gruppi: del primo fanno parte quelli<br />
che conoscono gli elementi essenziali della disciplina; nel secondo si collocano quelli che mostrano<br />
una certa sicurezza nella comprensione e nella traduzione dei dati e possiedono conoscenze ampie<br />
sicure ed approfondite. Gli alunni del primo gruppo riescono ad elaborare le conoscenze nelle linee<br />
essenziali, ma non sono in grado di affrontare problematiche di varia natura. Gli alunni del secondo<br />
gruppo sanno operare con simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di<br />
trasformazione delle formule e possiedono capacità di analisi e di sintesi;<br />
METODOLOGIE<br />
Lezione frontale discussione in classe<br />
MTERIALI DIDATTICI<br />
Laboratorio. Testo adottato:Evoluzione della Fisica-OSTILI,PARODI,MOCHI-paravia.<br />
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFIC AUÎILIZZATE:<br />
verifica orale: esposizione sintetica ed analitica dei contenuti<br />
vcrilica scritta:per accertare le capacità di analisi di un problema<br />
In laboratorio sono state verificate le leggi studiate.<br />
'L<br />
Fbl"I do""nt"<br />
,//4u1
PROGRAMMA DI MATEMATICA<br />
ANNO SCOLASTICO2OIII2OI2, CLASSE 5^ A<br />
Concetto di funzione: funzioni algebriche e trascendenti;<br />
Dominio e codominio di una funzione;<br />
Intervallo, intomo e punti di accumulazione, estr. sup. e inf.;<br />
Funzioni limitate; monotòne, pari e dispari;<br />
Concetto di limite: limite destro e sinistro;<br />
Limiti infiniti;<br />
Limite di una forma algebrica di funzioni, limite del prodotto e del quoziente;<br />
Limiti fondamentali; forme indeterminate;<br />
Continuità di una funzione, discontinuità di l, 2 e 3 specie;<br />
Derivata e suo significato geometrico; derivate di funzioni particolari;<br />
Derivata di una somma, del prodotto e del quoziente;<br />
Derivata di una funzione composta (solo enunciato);<br />
Equazione della tangente ad una curva in un suo punto;<br />
Derivata di ordine superiore;<br />
Concetto di differenziale e suo significato geometrico;<br />
Teorema di Rolle, Lagrange e De L'Hospital (solo enunciato);<br />
Funzioni crescenti, decrescenti e teoremi relativi;<br />
Massimi e minimi di una funzione,<br />
Cemi sulla ricerca dei flessi di una funzione;<br />
Concavità e convessità di una curva;<br />
Asintoti verticali, orizzontali e obliquil<br />
Studio di una fi.mzione razionale e irrazionale;<br />
Integrali indefiniti e integrali immediati;<br />
Integrali definiti, problema delle aree, area di un trapezoide.<br />
z-/Zzú<br />
GLI ALUNNI<br />
U" cq-.g<br />
IL DOCENTE<br />
)Lt^^
Relazione finale del docente<br />
Materia: fisica classe: 5"A anno scolastico: 2011/2012<br />
ln relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obbiettivi:<br />
1 leggere un testo di fisica, comprendere ed acquisire la terminologia scientifica.<br />
2. ltilizz e ed elaborare i simboli tipici della disciplina allo scopo di produrre una<br />
comùicazione coerente e colletta.<br />
3. possedere, con consapevoleza critica, gli argomenti disciplinari e saperli gestire<br />
auÌonomatnenle.<br />
4. la consapevolezza della possibilita di descrivere in termini di trasformazioni fisiche eventi<br />
osservabili anche al di fuori di laboratori scolastici.<br />
GIi alunni, in base alle conoscenze si possono dividere in due guppi: del primo fanno parte quelli<br />
che conoscono gli elementi essenziali della disciplina; nel secondo si collocano quelli che mostrano<br />
una certa sicùezza nella comprensione e nella traduzione dei dati e possiedono conoscenze ampie<br />
sicure ed approfondite. Gli alunni del primo gruppo riescono ad elaborare le conoscenze nelle linee<br />
essenziali, ma non sono in grado di affrontare problematiche di varia natura. Gli alunni del secondo<br />
gruppo sanno operare con simbolisrno matematico riconoscendo le regole sintattiche di<br />
trasformazione deÌÌe fiormule e possiedono capacita di analisi e di sintesi;<br />
METODOLOGIE<br />
Lezione frontale -<br />
discussione in classe<br />
MTERIALI DIDATTICI<br />
Laboratorio. Testo adottato:Evoluzione della Fisica-OSTILI,PARODI,MOCHI-paravia.<br />
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI \ERIFIC ATJTILTZZATE:<br />
verifica orale: esposizione sintetica ed analitica dei contenuti<br />
verifica scritta:per accefare le capacità di analisi di un problema<br />
In laboratorio sono state verificate le leggi studiate.<br />
t<br />
Firma del docente<br />
) k *^^'
PROGRAMMA DI FISICA<br />
ANNO SCOLASTICO 20I112012, CLASSE 5^ A<br />
TERMOLOGIA<br />
LA TE9RIA CINETICA DEI GAS: l'energia intema di un gas; i gas reali e i gas perferti dal<br />
punto di vista molecolare; calcolo della pressione che un gas perfetto esercita sulle pareti del<br />
rccipiente; il significato della temperatura assoluta.<br />
IL CALORE: la trasmissione di energia mediante il calore e il lavoro; la capacità termica e il<br />
calore specifico;la caloria; le sorgenti di calore e il potere calorifico; la propagazione
Rehziore finde dcl docente<br />
Materia: Greco<br />
Classe V A Anno scolastico 201l/2012<br />
In rel^zione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenîi obiettivi in termini di<br />
conoscenze, competenze e capacta:<br />
Conoscenze relative ai generi letterari ed agli autori greci trattati e conoscenze inerenti il sist€ma<br />
lmgua.<br />
Gli alunni, in base alle proprie potenzialità, ai diversi livelli di partenza e alle personali motivazioni,<br />
sono in grado di individuare ed esporre i carafteri salienti della letteraîura greca e sanno analizzare e<br />
traduÍe i testi leîterari.<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE<br />
Periodo<br />
(esoresso in ore)<br />
L'età ellenistica 3<br />
Callimaco 4<br />
La commedia nuova e Menandro 5<br />
La Doesia bucolica e Teocnto 4<br />
ADollonio Rodio 4<br />
La storiosafia ellenislica e Polibio 4<br />
L'età imDeriale romana 2<br />
Plutarco 4<br />
* Classico 20<br />
.:. verifiche scritte l0<br />
t verifiche orali 30<br />
Ore effettivameúte svolte dal docente nell'inîero anno scolastico comprensive<br />
delle ore che Dresumibilmente saranno svolte €ntro la fine dell'anno 94<br />
METODOLOGIE<br />
I-ezioni frontali<br />
Lettura, analisi, traduzione e inte.pretazione di testi greci<br />
MATERIALI DIDATTICI<br />
Testi adottati :<br />
Rossi-Nicolai, Letteratura greca, III, Le MonÍier<br />
R. Carpino, Temi di versione dal greco, AG Edizioni<br />
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICHE UÎILIZZATE<br />
verifiche scritte: traduzioni<br />
Verifiche orali: esposizione degli argomenti trattati, lettura, traduzione e analisi dei testi proposti<br />
Pafazzolo A., 14 /.0.5.12aÉ:<br />
;6<br />
LA DOCENTE<br />
c.ot,'i0r 'Vcon"-
PROGRAMMA DT GRECO<br />
I-ÉTTERATURA<br />
L'età ellenistica<br />
Callimaco<br />
"Inno ad Artemide"<br />
"Inno a Demeta"<br />
"Aitia e Giambi", fr. l,67-75; 0<br />
La poesia bucolica e Teocrito<br />
"Idillio WI", w. r-51 64-142<br />
"Idillio V", w.80-135<br />
"Idi io m", w l-55<br />
"Idillio XV", w. l-43<br />
La commedia nuova e Menandro<br />
"Il hrisantropo", \.r. I -49, t 53-178; 233-28 t;<br />
w.7tt-l47;9Ol-969<br />
Apollonio Rodio<br />
"Le Argonautiche",l,w. t-22;IJl, v,r 2jS-299<br />
Polibio<br />
".ttoze ". proemio<br />
"Stoùe ", \'11. ll-14<br />
L'età greco-romana<br />
Pllularco, "Vile parallele",l, I<br />
La Seconda Sofistica<br />
Luciano *Sogho", 5-16<br />
"Nigrino", 19-25<br />
Sono stati tradotti e analizzati passi tratti dalle orazioni di Lisia e di Demostene<br />
5t<br />
LA DOCENTE<br />
Qàs""Q-^ e*"'
All.A-<br />
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE<br />
Materia - STORIA DELL'ARTE Classe 5'A <strong>Liceo</strong> Classico A.S.20l1ll2<br />
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi<br />
in termini di:<br />
CONOSCENZE: Gli alurmi hanno acquisito un adeguato lessico tecnico e criticq<br />
relle sus formulazioni spccifichc c gencrali; harmo individuato gli aspctti specifici<br />
dell'opera d'arte, relativi ai materiali, alle tecniche, all'iconografia e allo stile; hanno<br />
individuato le coordinate storico-culturali ento le quali si forma e si esprime I'opera<br />
d'arte.<br />
COMPETENZE/CAPACITA'/ABILITA': gli alunni hanno acquisito le<br />
competenze per la comprensione della naùr4 dei significati, e dei valori storici ,<br />
culturali ed estetici dell'opera d'afe; le competenze acquisite gli harmo tsasmesso il<br />
rispetto per il patrimonio storico-artistico, attuale e del passato, e l'abilita' nel<br />
riconoscere gli stili e le epoche.<br />
58
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE<br />
ESPOSTI PER:<br />
o Unita' didattiche e/o<br />
o Moduli e/o<br />
. Percorsi formarivi<br />
. Eventuali approfondimenti<br />
U.D. - Modulo - Percorso Formaîivo - Approfondrmento<br />
Ore effettivamenîe svolte dal docente fmo al l5 maggio 2012 ..... ... .56<br />
Periodo<br />
(espresso in ore)<br />
Il Seicento 4+4 = 8<br />
Il Settecento 2+2= 4<br />
Il Neoclassicismo<br />
Il Romanticismo<br />
L'lmDressionismo<br />
Il Postimoressionismo<br />
J+J= O<br />
3+3= ó<br />
3+3= ó<br />
J+J= tt<br />
L'Art Nouveau 2+2: 4<br />
L'Espressionismo 2+2= 4<br />
Le Avansuardie 6+ 6: 12<br />
Ore effettivamente svolte dal docente nell'intero hanno scolastico ... ....65<br />
2. METODOLOGIE ( lezione frontale, gnrppi di lavoro, processi individualizzati,<br />
anività di recupero, sostegno e integrazione, ecc. )<br />
L'attività didattica si è svolta in classe, con lezioni frontali, discussioni collettive, con<br />
approfondimenti mediante l'uso di audiovisivi e visite guidate in città d'arte e mostre,<br />
,c)
3. MATERJALI DIDATTICI (Testo adottalo, aftez^Íe, spazi e t€mpi<br />
laboratoriali, tecnologieaudiovisive e/o multimediali, eco.)<br />
Il materiale didattico ha visto l'inpiego del libro di testo, come traccia generale per la<br />
progrmmazione, inolt€ le lezioni si sono integrate con appunti e dispense fomite<br />
dall'insegrante.<br />
4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE<br />
Specificare: @rove scritte, verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza<br />
prova, prove grafiche, prove di laboratorio, simulazioni, ecc. )<br />
Per le prove di verifioa, si sono utilizzate, verifiche orali sugli rgomenti trattati in<br />
oqd unitÀ didetti€a.<br />
6o
ALL. È -<br />
PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5"A - LICEO CLASSICO . A.S.2O1IA2<br />
-IL SEICENTO: il Barocco, aspetti e caratteristiche;<br />
-CARLO MADERNO: San Pietro<br />
-G.L.BERNINI: la viîa € le opere;<br />
Ia Sculturr: il David, Apollo e Daftre, Baldacchino di S.Pieho, monumento<br />
funebre a Urbano VIII, Esasi di S.Teresa, Cattedra di S.Pietro;<br />
I'Architetturr: il colonnato di piazza S.Piefo, S.Andrea al Quirinale.<br />
-F.BORROMINI: la vita e le opere;<br />
S.Carlino alle 4 fontane, Oratorio dei Filippini" galleria di palazzo Spad4S.<br />
Ivo alla Sapienza, S.Giovarmi in Laterano, S.Agnese in piazza Navona;<br />
-B. LONGIIENA: S.Maria della salutet<br />
-G. GUARIM: Cappella della Sacra Sindone, S.Lorenzo.<br />
-IL SETTECENTO: il Rococo', aspeîti e ceatteristiche generali;<br />
F. JUVARRA: la Basilica di Superg4 la Palazzina di caccia di Stupinigi;<br />
L. VANVITELLI: Reggia di Caserta.<br />
-IL NEOCLASSICISMO: aspetti e caratteristiche generali;<br />
A.CANOVA: Paolina Bonaparte, Apollo e Dafne, il monumento a M.C.d'Austri4<br />
J.L.DAVID: il giurdnentù degli Orzi, la morte di hfmat;<br />
E.L.BOULLEE e C.N.LEDOUX.<br />
-IL ROMANTICISMO: aspetti e caratteristiche generali;<br />
C.DFRIEDRICH: viandante sul rnare di nebbia;<br />
T. GERICAULT : la Zatter a;<br />
E.DELACROX: la Liberta'che guida il Popolo.<br />
-L'IMPRESSIONISMO: aspetti e caratteri generali;<br />
E.MANET: Dejetmer sur l'herbe;<br />
C.PISSARO : Primavera a Eragny;<br />
C.MONET: la Grengnillqs, implessione del sole levante, la Cattedrale di Rouenl<br />
P.A.RENOIR: bal au moulin de la Galette:<br />
E.DEGAS: I'assenzio, la classe di danza del signor pirrot;<br />
P.CEZANNE: i giocatori di carte, bagnanti.<br />
-POSTIMPRESSIOMSMO: aspetti e caratteri generali;<br />
G.SEURAT: una domenica pomeriggio all'isola della grande jatte;<br />
P.GAUGUIN: donne Tahitiane, Chi siamo, da dove veniamo, dove andiarno.<br />
V.VAN GOGH: i mangiatori di patate, autorihatto, la cam€ra da letto, notte<br />
Stellat4 campo di grano con corvi;<br />
H.T.LAUTREC: ballo al Moulin Rouge.<br />
-I MACCHIAIOLI: aspetti e caratteristiche;<br />
G.FATTORI: Libecciata.<br />
-IL DMSIONISMO: aspetti e caratteristiche;<br />
G.SEGANTINI: alla stanga.<br />
-L'ART NOIIVEAU: aspetti e caratteristiche;<br />
ANIOM GAUDI: Casa Batlo', la Sagrata famigli4parco Guell;<br />
GUSTAVE KLIMT: Giuditta, I'Attesa, la Culla;<br />
A4
-I FAUVf,S: aspetti e caratteristiche;<br />
H.Matiss€: la Stanza ross4 i Pesci rossi, Donnacol.cappello, Nudo rosa;<br />
-IL CUBISMO: aspetti e caratteristiche;<br />
PABLO PICASSO: poveri in riva al mare, la vita, i giocolieri, les darnoiselles<br />
d'Avignon, Guemica;<br />
-L'ESPRESSIOMSMO: aspetti e caratteristiche;<br />
-L'ASTRATTISMO: aspetti e caratteristiche;<br />
V.KANDINSKIJ: composizione;<br />
-DE STIJL: aspetti e caratteristiche;<br />
P.MONDRLAN: Composizione;<br />
-IL FUTURISMO: aspetti e caratteristiche;<br />
U.BOCCIOM: stati d'animo, forme uniche nella continuita dello spazio;<br />
C.CARRA'.: il cavaliere rosso:<br />
G.BAILA: dinamismo di m cane al guinzaglio, la musa metafìsica;<br />
A.SANT'ELIA: archit€tture futuriste,<br />
-LA METAFISICA: aspetti e caratteristiche;<br />
G.DE CHIRICO: la piazza d'ltali4 le muse inquietanti, Ettore e Andromaca.<br />
-DADA e SIJRREALISMO: aspeJti e caraîferisiiche;<br />
M.DUCHAMP: la Gioconda;<br />
M.ER|IST: la vestizione del1a sposa;<br />
J.MIRO': il camevale di arlecchino;<br />
R.MAGRITTE: il doppio segreto;<br />
S.DALI': La persistenza della memori4 venere di Milo csn cassettil<br />
Y.TANGUY: se fosse.<br />
P.DELVAUX;<br />
.POPART.<br />
.L'ESPRESSIONISMO ASTRATTO.<br />
-L'INFOR,MALE.<br />
.ARCHITETTURA MODERNA:<br />
La scuole di Chicrgo: cenni;<br />
Gropius e l'esperienza del Bauhaus: le officine Fagus e la nuova sede del Bauhaus a<br />
Dessau;<br />
Le ricerrhe di Mi€s vrn der Rehe: il grattacielo in vetro;<br />
Le Corbusier e il movinento razionalista: Villa Savoye;<br />
L'architettura organica di Trank Lloid Wright: la casa sulla cascata;<br />
L'rrchitctturs frscistr: Piacentini, Tenagni, Liber4 Mchelucci.<br />
PN,AZZOLO A.r5.0s.t2<br />
GfiAlrmni<br />
tL PRPFESSORE ,ai<br />
À'\i"'\L;:'rrt'!1'.t<br />
"\<br />
6L
RELAZIONE FINALE<br />
Educazione fisica - Classe V ^A (Classico)<br />
a.s. 20ltl20l2 Prof.ssa: Rubera Maria<br />
ln relazione alla programmaziode curricularc sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:<br />
CONOSCENZE<br />
Al termine del corso degli studi gli allieq sanno conoscere:<br />
- Le caratteristiche tecnico tattiche e metodologiche della pallavolo del calcio e della<br />
pallacanestro:<br />
- Le modalita di allenamento per accrescere e migliorare le qualità fisiche (resistenza.<br />
forza. velocità e mobilità articolare);<br />
- L'impotanza dell'attiviîà fisica per il sistema muscolate e I'apparato cardioci.colatorio.<br />
scheletrico, articolare e respiratorio;<br />
- Lo spod attraverso i secoli.<br />
Tale conoscenza è: completa e apFofondita per la maggior parte degli alunni.<br />
COMPETENZE / CAPACITA' / ABILITA'<br />
Gli alunni hanno sviluppato:<br />
- la capacita di compiere attiviLà di resistenza, forz4 velocità e mobilita,<br />
- la capacìA di coordinare azioni efficaci in situazioni complesse;<br />
- l'abilita di utilizzare le qualita fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse<br />
esperienze ed ai vari contenutr;<br />
- la competenza, la capacità e I'abilità di praticare almeno due discipline sp,ortive nei ruoli<br />
più congeniali alle proprie attitudini;<br />
- I'abilità di svolgere compiti motori in situazioni inusuali.<br />
I _ CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI<br />
PER UNITA' DIDATTICHE,<br />
UNITA' DIDATTCA<br />
1. RESISTENZA<br />
2. FORZA.<br />
3. VELOCITA'<br />
4. MOBILITA' ARTICOLARE<br />
5. TECNICA. FONDAMENTALI E REGOLE <strong>DELLA</strong> PALLAVOLO E<br />
PALLACANESTRO<br />
6. TECNICA DI BASE DEL CALCIO<br />
7. TECNICA DI BASE <strong>DELLA</strong> PALLA TAMBURELLO<br />
8, METODICHE DI BODY-BUILDING<br />
9, SISTEMA MUSCOLARE<br />
IO. APPARATO RESPIRATORIO<br />
1 I. LE METODICHE E GLt ESERCIZI PER L'ALLUNGAMENTO MUSCOLARE<br />
I2. LO SPORT DAL MONDO ANTICO ALLA SOCIETA' POST-INDUSTRIALE<br />
6t
2 - METODOLOGIE<br />
L'attività didattica è slata svolta athaverso:<br />
- lezioni frontali;<br />
- esercitazionipratiche:<br />
- lavori di gruppo.<br />
3 -<br />
MATERIALI DIDATTICI<br />
Sono stati utilizzati i seguenti materiali didaftici:<br />
- libd di testo<br />
- palesra con irelativi attrezT ì ginnici:<br />
- piccoli attrezzi;<br />
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE<br />
Per la ve.ifica sono state utilizzate le seguenti tipologie:<br />
- colloqui orali;<br />
- partecipazione ed interventi durante le ore di lezione;<br />
- esercizi pratici svolti in palestra;<br />
- test motorii<br />
- questionarì.<br />
Prof.<br />
L'Insegnante<br />
{4
LICEO CLASSICO "PLATONE"<br />
PALAZZOLO ACREIDE<br />
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA<br />
Classe V^ A Classico<br />
^.s.201112012<br />
1. Attività ed esercizio a carico naturale:<br />
2. Esercizi per I'incremento della resistenza;<br />
3. Esercizi di controllo tonico e della respirazione;<br />
4. Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni di spazio temporali<br />
diversificate;<br />
5. Esercizi di coordinazione generale;<br />
6. Attività di tipo aerobico ed anaerobico;<br />
7 . Esercizi di allungamento muscolare;<br />
8. Fondamentali individuali e di squadra della pallavolo e della pallacanestro;<br />
9. Tecnica di base della palla tamburello;<br />
l0.Tecnica di base del calcio;<br />
I l.Esercizi con I'utilizzo di lat machine;<br />
l2.Conoscenze di base del sistema muscolare;<br />
l3.Conoscenze di base dell'apparato cardiocircolatorio;<br />
14.Lo sport dal mondo antico alla società post-industriale.<br />
Gli Alunni<br />
L'Insegnante<br />
P,.î. lu^, fz-<br />
6t-
RELAZIONII IrlNAl.ti<br />
I)r'of.ssa VI I I{ANO MAIIIA<br />
MA l'llRlA: BIOLO(ilA CLASSE VA A,S.](]I I /I2<br />
In relazionc alla programrnazione curliculale sono stati conseguiti i<br />
segucnli obicttir i in ternìini di.<br />
CONOSCIINZÌ;: Quasi tutti gli allicvi hanno una conoscenza completa<br />
dellc unità d idattiche;usano un lcssic() adeguato cd hanno acquisito una<br />
ccrta autor.ìomia nclla sintesi.<br />
COMPETIT.NZE / CAI'ACITA' /ABl LITA' :<br />
Gli allicvi hanno acquisito alcune conoscenze specitiche sull'organismo<br />
umano in salute o in nralattia. Sanno riconoscere strutturc e funzioni degli<br />
apparali umani .Sanno riconoscclc Ia terminologia ed utilizzarla<br />
auton()r'ì.ìamcnte.<br />
ME'I'ODOI,OGIIÌ:<br />
Lezioni liontali integrati oon audiovisivi,ed attività di recupero.<br />
MAl lrRIAl.l DIDAT'| ICI:<br />
Vidso cassctte,canìpioni di ulateriale biologico.<br />
CONTENTJ-I'I DISC]IPLINAIII E TIÌMPI DI REALIZZAZIONTJ<br />
Bioencrgelica e mctabolismo ore 3<br />
Sistema tegumentîrio<br />
I<br />
S istitnra schclctrioo<br />
I<br />
Digestione e nutrizione 2<br />
La rospirazionc 2<br />
Il sangue c la circolazionc 4<br />
Sistcr'ìra escl'etorc 2<br />
Sistema imnrunitalio 2<br />
C)mrostasi<br />
I<br />
Sistcnra endocrino 2<br />
Pcrcczione e cooltlinantctrto 2<br />
S isterna nervoso 3<br />
La riproduzione dcll'uomo 2<br />
66
'I lPOLOGIA [)trLt-E PROVE DI VtilìlFICA U'|ILIZZAII:.<br />
La vcritica degli otriettivi si è basata su test a risposta rnultipla - aperta ed<br />
intcrrogazion i<br />
Pt .A/.7.()L() A,.t I ()5 20 I :<br />
INSIiGNANI'E<br />
67
PR(XìRAMMA DI IIIOLOGIA<br />
Svolto nella clirssc V A dcl <strong>Liceo</strong> Classico <strong>Platone</strong> Palazzolo<br />
A. S.2011112<br />
SIS'I'IIMA SCI II]I-I] IRICO<br />
Le artico lazion i<br />
[-o schelctlo<br />
Imuscoli<br />
DI(ìUS llONtr Ii NU'l'RIZIONE,<br />
l,a nutrizione<br />
I -' appaf at0 diger.cntc'<br />
Il fègato c il pancrcas<br />
I pt incipi rrutritir i c le loro liutzionì<br />
l.A fìl:SPtRAZIONII<br />
Apparato lcspiraturio<br />
ll trasporto dei gas rcspiratoli<br />
II. SAN(iI,JF- F, I-A CIRCOI,AZIONIl<br />
ll sanguc<br />
Apparato c irco latoliti<br />
Ll: t)lFl:Str Dllt-t.'ORGANISMO<br />
l-e dilèsc specifìchc<br />
I componcrrti dcl sistema imnrunilario<br />
6t
OMEOS I'ASI<br />
La tcrmorcgolazione<br />
Apparato Lrlinalio<br />
PI ]RCBZIONI] IJ COORDINAMENTO<br />
Orecchio . Occhio<br />
'l cssuto norvoso e i ncrvi<br />
'l'essuto nclvoso centralo c perifelico<br />
ljisiologia tlel neurone<br />
SIS'I'HMA ENIX)CI{INC)<br />
l,c glriandole endncrinc dcll'uomo<br />
LA IìIPRODUZI()NE DELT,'UOMO<br />
Apparato riproduttore maschile e lènrminile<br />
P AL AZ7.()t.O ACTREI Dt i 1<br />
fit-u"tr 1<br />
4 t05 t2o t2<br />
k,'. .<br />
INSEGNANTE<br />
c. / L-**<br />
ó9
ALLEGATO B<br />
v0
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE<br />
.'PLATONE'<br />
PALAZZOLO A.S.2O1Ol11<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRIÎTA ITALIANO<br />
TIPOLOGIA A<br />
AMPIEZZA <strong>DELLA</strong> TRATTAZIONE E PADRONAI'':IA<br />
DELL'ARGOIIENTO<br />
SCARSA 0,5<br />
APPROSSIT4ATA<br />
I<br />
ESSENZIATE 1,5<br />
COMPI.ETA E APPROFONDIIA 2<br />
ANALISI DEL TESTO<br />
ÍÍ{DIVIDUAZIONE PAROLE CHIAVE E TEI.IATICHE PORTANÎI<br />
SCARSA o,5<br />
SUPERRCIALT<br />
ESSENZIALE 1,5<br />
APPROFONDITA 2<br />
ANALISI FORIIIALE<br />
SCARSA o,5<br />
APPROSSIMATA 1<br />
ESSENZIATE 1,5<br />
COMPLETA E APPROFONDITA 2<br />
APPROFOilDIMENTI<br />
CAPACITA'DI CONFRO TI E RELA:ZIONI<br />
APPROFONDITA<br />
ELEIiIEI{TI DI ORIGINALIîA'<br />
PADROilANZA <strong>DELLA</strong> LINGUA<br />
CORREÍTEZZA SI NTATTICA'ÍIIO RFO LOGICA,<br />
ORTOGRAFICA, LÉSSICALE<br />
SUFRCIENTE o,5<br />
CORRÉTTA<br />
CORRETTEZZA LOGTCA E COESIONE GENERALE<br />
SUFRCIENfE 0,5<br />
CORRETTA<br />
I<br />
I<br />
o,5<br />
I<br />
I<br />
I<br />
PUNTEGGIO <strong>DELLA</strong> PROVA:<br />
t10<br />
-7 .'l
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE<br />
'PLIATONE"<br />
PALAZZOLO A.S.20lo/11<br />
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO<br />
TIPOLOGIA B<br />
SÍRUTTURA ELABORAÎO<br />
APPROSSIMATIVA 0,5<br />
POCO ORGANICA<br />
SUFRCIENTEMENTE COES4 1,5<br />
coEsA É CONSEQUENZIA!t 2<br />
uso Docur,lENTAzIoltE<br />
SCARSA<br />
o,5<br />
POCO CORRETTA<br />
1<br />
SUFRCIENTEMENTE CORRETTA 1,5<br />
CORRETTA E ADEGUATA 2<br />
ARGOMÈI{TAZIO I<br />
ADEGUATE I4A GÉNERICHE<br />
PERTINENETI E SVILUPPATE SUFFICIENTEI''IENfE<br />
VALIDE E APPROFONDITE<br />
d.qE E l",!allìlNAl I<br />
I<br />
CORREÎTEZZA STTTATTICA,filORFOIOGICA'<br />
ORf OGRAFICA, LESSICALÉ<br />
o,5<br />
SUFFICIENTE<br />
CORRETTA<br />
_-re<br />
SUFFICIENfE<br />
PUNTEGGIO <strong>DELLA</strong> PROVA: ,î0<br />
I<br />
o,5<br />
1
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE<br />
"PLATONE"<br />
PALAZZOLO A.S.201Ol11<br />
@ASCRIÎÎA<br />
TIPOLOGIE C - D<br />
ITALIANO<br />
STRUTIURA ELABORATO<br />
APPROSSIMATIVA 0,5<br />
POCO ORGANICA<br />
I<br />
ORGANICA E PERTINENTE 2<br />
ORGANICA E COESA 3<br />
col|oscEr{za<br />
SCARSA o,5<br />
ARGOI4 EI,ITAZIONI GENERICHE E SUPERFICIALI 1<br />
ARGOMENTAZIONI SUFFICIEIITI E{DEGUATE 2<br />
ARGOEMTAZIONI VALIDE E APPROFONDTTE 3<br />
CAPACÎIA'<br />
RELAZIONI E CONFRONTI<br />
ELEMENTI DI ORIGINAIT{ 2<br />
PADRONANZA <strong>DELLA</strong> LINGUA<br />
CORRETTEZZA SINTATTIGA.MORFOLO6ICÀ<br />
ORTOGRAFICA, LÉSSICALE<br />
SUFFICIENTE 0,s<br />
CORRETTA<br />
CORRETÍEZZA LOGTCA E COÉSIOI{E GENÉRALE<br />
SUFRCIENTE 0,5<br />
-ó.REETE- 1<br />
PUNTEGGIO <strong>DELLA</strong> PROVA:<br />
I<br />
I<br />
t10<br />
4)
ÀR;AUMANISTICO LETTERARIA<br />
Anno Scolastico 206CYll<br />
SCRITTO di LATINO - GRECO ( biennio e tri€Ddo )<br />
(.ÓNOSCÉNZD<br />
MORFOSINTAfiICHE<br />
Buon liveìlo<br />
p.4<br />
l)iscrctù lir'€llo<br />
Srifiiciente o quasi suficiente<br />
livello<br />
312<br />
gravr<br />
.2<br />
t lriil laìcune lrammatìcJli<br />
1,5<br />
Cravissrme<br />
nrorlòsintattiche<br />
dton<br />
TRADUZIONE DEL TESTO<br />
Ottimo livello<br />
Buon livello<br />
Súf6cienrc livello p. 2,5<br />
Numerosi gravi enori di<br />
lf umerosi pa$i fmintesi<br />
Senso det braoo quasi del tutto<br />
a AcrrA'EsPRDsswA<br />
lvlolîo sir,a c tluida<br />
Abbastenza esPressiva<br />
e fluida<br />
c scialba P. 0.50<br />
Trascurata, lalìcosa r<br />
0,25<br />
74
TABEL["{ DI<br />
VA.LUTAZIONE<br />
PROVE SCR]TTE<br />
'|RrENlllO _<br />
voTo<br />
l-8 (rNsuFF.J<br />
4 INSUFF<br />
I<br />
L | ..r Èt'n<br />
COMPREN SIONE<br />
Iton cooprcndc it<br />
pdziEildentc t] seDso<br />
tNtLúrti<br />
coNoscEllzA<br />
GRAIiV-AÎCALE<br />
Non ri.s.. a tr'Àdure<br />
ir modo acccttabllc.<br />
mo.fo'sintsttici arche<br />
CAÌACITA DI<br />
TRASPOSIZIONB E<br />
PRf,DUZIONE<br />
AUÎONOMA IN<br />
LINGUA<br />
lineuaggio lctt.rano<br />
con,uso illingua88]o<br />
scnso Elobal. del testo regoic gra@ticaI è elebetrti basilùi ed<br />
óon'prenae in r"oao I L'appucazione dclle<br />
Èallmcntario il scnso I resolc srammadcdi è<br />
.Pp.ne a.:e abil: € sl<br />
scnza riuscire a nlwaiú aÌcuor .nbrr<br />
.apimc i couèga-úenti I morfo smrattici di<br />
!!a i vúi Put| l Ie!!{gCr!!3,<br />
codplcnd. iD tlodo<br />
rcgolc aratnmaticali è<br />
5 MEDIOCRE r:obr.le d.l tcsro, |<br />
6 SUFF]CIENTE<br />
r èrano,-cuni cnori<br />
ling!.aggio lcttcrÀrio<br />
linguàggio letterario<br />
I<br />
7 DISCRETQ<br />
C.mplendc an aodo<br />
g-cbale del teslo e :è<br />
..isioni ùt Ee ad<br />
Egol. Armaaticali è<br />
tro.i morfo-sittattrci<br />
RÍ€labora il<br />
ljnE!asgo l€tte.ario<br />
8 BUONO<br />
approfo0dito il tèslo<br />
îesolc Era:ffa'jcali é<br />
coDpl€la e sr rú.vano<br />
solo alcur. stuf,at1tc<br />
rèlla tr'àsposrztoúc 0<br />
contenuti . 4ÀPacirà<br />
s-10 oTTIMO<br />
..p!rófoD dito Ù teslo<br />
_<br />
ici_-e!ùio proPosto ed<br />
è in gîado dt<br />
r€go1è grúhaticaìr è<br />
contenuu c caPaclta<br />
coicgamenti con anrl<br />
ccceil€Dtc dàl Punto dr<br />
!oTo
GRl6l-lA Ol VAIUTAZIONE : ORALE<br />
.9<br />
P<br />
E<br />
ii ,: .=<br />
BÉ5<br />
s -È!<br />
=<br />
ó<br />
:<br />
É<br />
,.<br />
=<br />
=<br />
E<br />
0,80<br />
limitala 1,60<br />
sufficiente<br />
z,4a<br />
approfondite 3,20<br />
lorosa 4,00<br />
mar3inal€ o,40<br />
agprossimata 0,80<br />
ade8uala 1,20<br />
aderente 1,60<br />
ountuale 2,00<br />
errata o erbitraria 0.20 0,40<br />
incerta o contraddittoria 0,40 0,80<br />
accettabile e coefente 0,60 1,2O<br />
sicura e documentata 0,80 1,60<br />
autonoma e critica 1,00 2,00<br />
suPerficiale 0.40 0,20<br />
confusa 0,80 0,40<br />
essenziale 1,20 0,60<br />
articolata r,60 0,80<br />
profonda 2,00 1,00<br />
inconsostente 0,20<br />
flammentaria 0,40<br />
coerenre 0,60<br />
signifìcatrva 0,80<br />
oriSinale 1,00<br />
to
INDICE<br />
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO <strong>DELLA</strong> CLASSE V SEZ. A Pag. 1<br />
<strong>SINTETICA</strong> <strong>DESCRIZIONE</strong> <strong>DELLA</strong> <strong>SCUOLA</strong><br />
Pag.2<br />
PIANO DI STUDIO E QUADRO ORARIO Pag. 3<br />
ELENCO DEI CANDIDATI Pag. 4<br />
VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE Pag. 5<br />
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' RISPETTO AGLI OBIETTIVI<br />
FISSATI<br />
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' FORMATIVE<br />
Pag. 6<br />
P^9.7<br />
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO <strong>DELLA</strong> V CLASSE Pag. 8<br />
CRITERI DI VALUTAZIONf, <strong>DELLA</strong> TERZA PROVA Pag. 9<br />
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI<br />
Pag. l0<br />
ALLEGATO A: RELAZIOM E PROGRAMMI Page. 1l-69<br />
ALLEGATO B: GRIGLIE DI VALUTAZIONE<br />
P^9.70-76