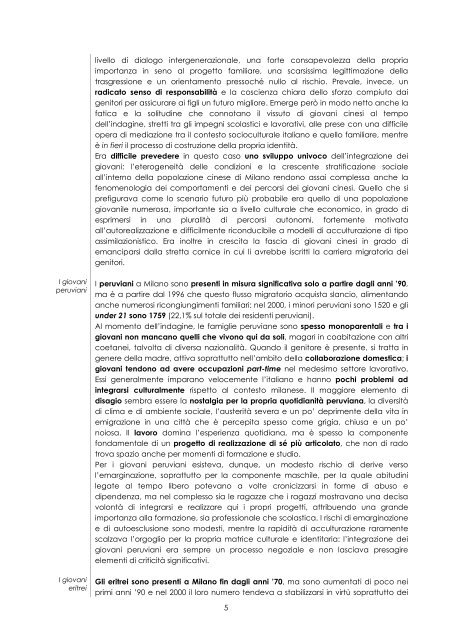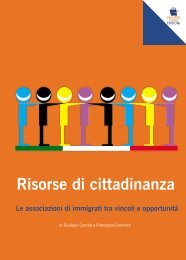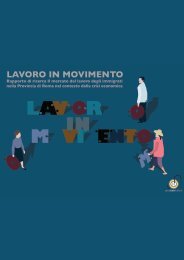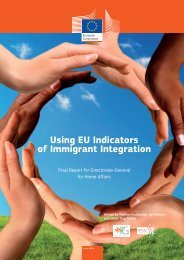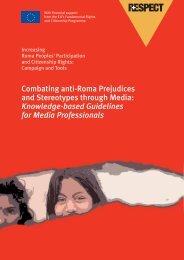SYNERGIA Sistemi di conoscenza e di gestione del cambiamento
SYNERGIA Sistemi di conoscenza e di gestione del cambiamento
SYNERGIA Sistemi di conoscenza e di gestione del cambiamento
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo intergenerazionale, una forte consapevolezza <strong>del</strong>la propriaimportanza in seno al progetto familiare, una scarsissima legittimazione <strong>del</strong>latrasgressione e un orientamento pressoché nullo al rischio. Prevale, invece, unra<strong>di</strong>cato senso <strong>di</strong> responsabilità e la coscienza chiara <strong>del</strong>lo sforzo compiuto daigenitori per assicurare ai figli un futuro migliore. Emerge però in modo netto anche lafatica e la solitu<strong>di</strong>ne che connotano il vissuto <strong>di</strong> giovani cinesi al tempo<strong>del</strong>l’indagine, stretti tra gli impegni scolastici e lavorativi, alle prese con una <strong>di</strong>fficileopera <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione tra il contesto socioculturale italiano e quello familiare, mentreè in fieri il processo <strong>di</strong> costruzione <strong>del</strong>la propria identità.Era <strong>di</strong>fficile prevedere in questo caso uno sviluppo univoco <strong>del</strong>l’integrazione deigiovani: l’eterogeneità <strong>del</strong>le con<strong>di</strong>zioni e la crescente stratificazione socialeall’interno <strong>del</strong>la popolazione cinese <strong>di</strong> Milano rendono assai complessa anche lafenomenologia dei comportamenti e dei percorsi dei giovani cinesi. Quello che siprefigurava come lo scenario futuro più probabile era quello <strong>di</strong> una popolazionegiovanile numerosa, importante sia a livello culturale che economico, in grado <strong>di</strong>esprimersi in una pluralità <strong>di</strong> percorsi autonomi, fortemente motivataall’autorealizzazione e <strong>di</strong>fficilmente riconducibile a mo<strong>del</strong>li <strong>di</strong> acculturazione <strong>di</strong> tipoassimilazionistico. Era inoltre in crescita la fascia <strong>di</strong> giovani cinesi in grado <strong>di</strong>emanciparsi dalla stretta cornice in cui li avrebbe iscritti la carriera migratoria deigenitori.I giovaniperuvianiI giovanieritreiI peruviani a Milano sono presenti in misura significativa solo a partire dagli anni ’90,ma è a partire dal 1996 che questo flusso migratorio acquista slancio, alimentandoanche numerosi ricongiungimenti familiari: nel 2000, i minori peruviani sono 1520 e gliunder 21 sono 1759 (22,1% sul totale dei residenti peruviani).Al momento <strong>del</strong>l’indagine, le famiglie peruviane sono spesso monoparentali e tra igiovani non mancano quelli che vivono qui da soli, magari in coabitazione con altricoetanei, talvolta <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa nazionalità. Quando il genitore è presente, si tratta ingenere <strong>del</strong>la madre, attiva soprattutto nell’ambito <strong>del</strong>la collaborazione domestica; igiovani tendono ad avere occupazioni part-time nel medesimo settore lavorativo.Essi generalmente imparano velocemente l’italiano e hanno pochi problemi a<strong>di</strong>ntegrarsi culturalmente rispetto al contesto milanese. Il maggiore elemento <strong>di</strong><strong>di</strong>sagio sembra essere la nostalgia per la propria quoti<strong>di</strong>anità peruviana, la <strong>di</strong>versità<strong>di</strong> clima e <strong>di</strong> ambiente sociale, l’austerità severa e un po’ deprimente <strong>del</strong>la vita inemigrazione in una città che è percepita spesso come grigia, chiusa e un po’noiosa. Il lavoro domina l’esperienza quoti<strong>di</strong>ana, ma è spesso la componentefondamentale <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> sé più articolato, che non <strong>di</strong> radotrova spazio anche per momenti <strong>di</strong> formazione e stu<strong>di</strong>o.Per i giovani peruviani esisteva, dunque, un modesto rischio <strong>di</strong> derive versol’emarginazione, soprattutto per la componente maschile, per la quale abitu<strong>di</strong>nilegate al tempo libero potevano a volte cronicizzarsi in forme <strong>di</strong> abuso e<strong>di</strong>pendenza, ma nel complesso sia le ragazze che i ragazzi mostravano una decisavolontà <strong>di</strong> integrarsi e realizzare qui i propri progetti, attribuendo una grandeimportanza alla formazione, sia professionale che scolastica. I rischi <strong>di</strong> emarginazionee <strong>di</strong> autoesclusione sono modesti, mentre la rapi<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> acculturazione raramentescalzava l’orgoglio per la propria matrice culturale e identitaria: l’integrazione deigiovani peruviani era sempre un processo negoziale e non lasciava presagireelementi <strong>di</strong> criticità significativi.Gli eritrei sono presenti a Milano fin dagli anni ’70, ma sono aumentati <strong>di</strong> poco neiprimi anni ’90 e nel 2000 il loro numero tendeva a stabilizzarsi in virtù soprattutto dei5