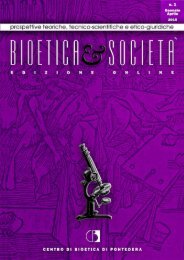You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Bioetica</strong> & <strong>Società</strong> - <strong>Anno</strong> <strong>XIII</strong> - n. 2/3 - maggio/dicembre 2015<br />
D I S C U S S I O N I<br />
A proposito di...<br />
Il rapporto uomo-animale<br />
I commenti di:<br />
Matteo Galletti<br />
Gli interventi di Zini e Marchesini, pubblicati rispettivamente sullo scorso e su<br />
questo numero di <strong>Bioetica</strong> e società, presentano impostazioni ed esiti diversi ma<br />
condividono un interesse comune. Zini presenta un’articolata critica alla bioetica<br />
utilitaristica di Peter Singer e al suo obiettivo di costituire un’etica egualitaria che<br />
annulli qualsiasi differenza morale tra interessi umani e animali.<br />
Le obiezioni che Zini muove a Singer colpiscono sia gli esiti a cui approda il<br />
suo utilitarismo, sia l’impostazione della sua teoria dello status morale, ossia la<br />
possibilità di individuare una soglia minima sotto la quale la tutela morale indebolisce<br />
fino a esaurirsi e sopra la quale si configura una speculare gradazione<br />
delle tutele e delle garanzie. Per Singer è la sentience, la capacità di provare<br />
piacere e dolore, che determina la soglia minima di protezione morale (le forme<br />
più complesse di autoconsapevolezza corrispondono poi a tutele morali più<br />
stringenti) a discapito delle proprietà relazionali, che uniscono gli individui a<br />
determinati gruppi, come la specie o le etnie.<br />
Nell’etica singeriana, la determinazione dello status morale di un individuo<br />
dipende sia dalla negazione dell’individualità (non conta chi è il soggetto che<br />
possiede la capacità considerata) sia della relazionalità (non conta quali relazioni<br />
intrattiene con altre entità) 1 .<br />
Alla proposta di Singer, Zini contrappone un’analisi d’ispirazione fenomenologica<br />
che mira a ripristinare la prima evidente conseguenza dell’egualitarismo<br />
singeriano, ossia quella differenza ontologica fondamentale che si basa fondamentalmente<br />
sulla contrapposizione tra l’istintività deterministica del mondo<br />
animale e la ricchezza sovra-empirica del mondo umano, caratterizzata principalmente<br />
da «ragione e libertà». La mossa consiste quindi nel recuperare una<br />
divisione che da Descartes corre fino ad alcuni filosofi kantiani dei nostri giorni,<br />
passando da Rousseau e Kant 2 .<br />
L’esito è quindi dualistico e gerarchico: uomo e animale tornano a differenziarsi<br />
e, sul piano morale, gli interessi del primo hanno la precedenza rispetto<br />
a quelli del secondo. L’identità e la relazionalità sono riacquisite in termini di<br />
1 Ciò non significa che tale relazionalità non svolga alcun ruolo sul piano normativo. Cfr. ad esempio P. Singer, A Response, in D.<br />
Jamieson (a cura di), “Singer and His Critics”, Oxford, Blackwell, 1999 e Riflessioni, in J.M. Coetzee, “La vita degli animali”, Milano,<br />
Adelphi, 2000, p. 105.<br />
2 Insieme a Kant, Descartes è il bersaglio privilegiato degli anti-specisti. Per Rousseau, cfr. Discorso sull’origine della diseguaglianza<br />
fra gli uomini, in “Discorsi”, Milano, Rizzoli, 1997, p. 106; per i kantiani, cfr. C. Korsgaard, Self-Constitution, Oxford, Oxford<br />
University Press, 2009, pp. 109-132.<br />
70 71