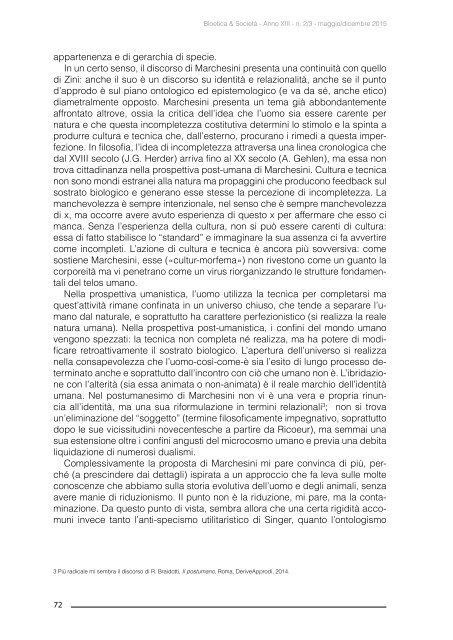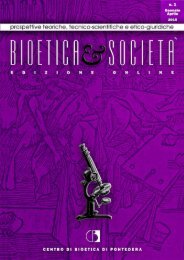You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Bioetica</strong> & <strong>Società</strong> - <strong>Anno</strong> <strong>XIII</strong> - n. 2/3 - maggio/dicembre 2015<br />
appartenenza e di gerarchia di specie.<br />
In un certo senso, il discorso di Marchesini presenta una continuità con quello<br />
di Zini: anche il suo è un discorso su identità e relazionalità, anche se il punto<br />
d’approdo è sul piano ontologico ed epistemologico (e va da sé, anche etico)<br />
diametralmente opposto. Marchesini presenta un tema già abbondantemente<br />
affrontato altrove, ossia la critica dell’idea che l’uomo sia essere carente per<br />
natura e che questa incompletezza costitutiva determini lo stimolo e la spinta a<br />
produrre cultura e tecnica che, dall’esterno, procurano i rimedi a questa imperfezione.<br />
In filosofia, l’idea di incompletezza attraversa una linea cronologica che<br />
dal XVIII secolo (J.G. Herder) arriva fino al XX secolo (A. Gehlen), ma essa non<br />
trova cittadinanza nella prospettiva post-umana di Marchesini. Cultura e tecnica<br />
non sono mondi estranei alla natura ma propaggini che producono feedback sul<br />
sostrato biologico e generano esse stesse la percezione di incompletezza. La<br />
manchevolezza è sempre intenzionale, nel senso che è sempre manchevolezza<br />
di x, ma occorre avere avuto esperienza di questo x per affermare che esso ci<br />
manca. Senza l’esperienza della cultura, non si può essere carenti di cultura:<br />
essa di fatto stabilisce lo “standard” e immaginare la sua assenza ci fa avvertire<br />
come incompleti. L’azione di cultura e tecnica è ancora più sovversiva: come<br />
sostiene Marchesini, esse («cultur-morfema») non rivestono come un guanto la<br />
corporeità ma vi penetrano come un virus riorganizzando le strutture fondamentali<br />
del telos umano.<br />
Nella prospettiva umanistica, l’uomo utilizza la tecnica per completarsi ma<br />
quest’attività rimane confinata in un universo chiuso, che tende a separare l’umano<br />
dal naturale, e soprattutto ha carattere perfezionistico (si realizza la reale<br />
natura umana). Nella prospettiva post-umanistica, i confini del mondo umano<br />
vengono spezzati: la tecnica non completa né realizza, ma ha potere di modificare<br />
retroattivamente il sostrato biologico. L’apertura dell’universo si realizza<br />
nella consapevolezza che l’uomo-così-come-è sia l’esito di lungo processo determinato<br />
anche e soprattutto dall’incontro con ciò che umano non è. L’ibridazione<br />
con l’alterità (sia essa animata o non-animata) è il reale marchio dell’identità<br />
umana. Nel postumanesimo di Marchesini non vi è una vera e propria rinuncia<br />
all’identità, ma una sua riformulazione in termini relazionali 3 ; non si trova<br />
un’eliminazione del “soggetto” (termine filosoficamente impegnativo, soprattutto<br />
dopo le sue vicissitudini novecentesche a partire da Ricoeur), ma semmai una<br />
sua estensione oltre i confini angusti del microcosmo umano e previa una debita<br />
liquidazione di numerosi dualismi.<br />
Complessivamente la proposta di Marchesini mi pare convinca di più, perché<br />
(a prescindere dai dettagli) ispirata a un approccio che fa leva sulle molte<br />
conoscenze che abbiamo sulla storia evolutiva dell’uomo e degli animali, senza<br />
avere manie di riduzionismo. Il punto non è la riduzione, mi pare, ma la contaminazione.<br />
Da questo punto di vista, sembra allora che una certa rigidità accomuni<br />
invece tanto l’anti-specismo utilitaristico di Singer, quanto l’ontologismo<br />
fenomenologico di Zini, di contro ad una maggiore duttilità del postumanesimo<br />
di Marchesini.<br />
Quello che rimane da chiarire, nel postumanesimo di Marchesini, sono le implicazioni<br />
etiche. L’identità relazionale e aperta non esclude sul piano etico la<br />
possibilità di specifici conflitti d’interessi ma sembrerebbe orientare verso un<br />
rifiuto di una risposta antropocentrata a tali conflitti. Mi chiedo se in quest’ottica<br />
sia ancora possibile individuare qualche criterio di demarcazione che aiuti a<br />
stabilire, nelle specifiche situazioni, quali interessi umani devono cedere inevitabilmente<br />
il passo a interessi di altre specie. In ogni caso, la prospettiva storica<br />
che il postumanesimo introduce sembrerebbe del tutto feconda anche per inquadrare<br />
dinamicamente la nascita di specifici conflitti e la natura degli interessi<br />
che li caratterizzano. Penso ad esempio al caso della sperimentazione animale<br />
scientificamente utile: non si contrappongono, genericamente, interessi umani e<br />
non-umani a vivere e non-soffrire, sterilizzati nello spazio vuoto dell’astrazione filosofica,<br />
ma interessi determinati, che hanno una genesi e una costituzione ben<br />
precisa, la cui esplicitazione può aiutare a chiarire (più difficilmente a risolvere)<br />
il conflitto 4 .<br />
Infine, ci troviamo in un’epoca di effettiva transizione, per cui non solo occorrono<br />
nuove prospettive, ma anche nuovi linguaggi e schemi interpretativi. Sul<br />
piano della bioetica mi sembra che le riflessioni di Marchesini vadano incontro a<br />
quanto diceva Maurizio Mori quasi dieci anni fa sull’immagine tradizionale della<br />
bioetica, pensata come un albero, dal cui fusto si distendono più rami, ciascuno<br />
dei quali simboleggia uno specifico ambito (medico, animale, ambientale, ecc.).<br />
Con una certa approssimazione si può constare che in realtà il dibattito morale<br />
ha fatto emergere almeno tre prospettive diverse, strutturate intorno a criteri di<br />
rilevanza morale diversi fra loro: l’antropocentrismo (a cui bene o male è riconducibile<br />
la posizione di Zini), il sensocentrismo (a cui corrisponde la posizione<br />
di Singer) e l’ecocentrismo (a cui ascriverei invece il postumanesimo di Marchesini).<br />
Assumere un criterio di rilevanza non significa quindi orientarsi in un certo<br />
modo su un particolare ramo dell’albero: significa, se vogliamo proseguire con<br />
la metafora vegetale, piantare un albero del tutto distinto 5 .<br />
In sostanza, Singer, Zini e Marchesini non stanno discutendo semplicemente<br />
di come affrontare certi temi epistemologici e/o etici nel campo delle relazioni<br />
con gli animali o con l’ambiente, ma stanno proponendo sguardi sul mondo ispirati<br />
a criteri (epistemologici ed etici) molto diversi fra loro. In questo modo credo<br />
che si apprezzi ancora di più la ricchezza del dibattito, le distinzioni rilevanti<br />
fra le varie posizioni e l’esigenza di individuare una terminologia più adeguata<br />
quando si traducono sul piano etico certi assunti.<br />
3 Più radicale mi sembra il discorso di R. Braidotti, Il postumano, Roma, DeriveApprodi, 2014.<br />
4 Cfr., ad esempio, T. Milligan, Beyond Animal Rights, London, Continuum, 2000, pp. 143-149.<br />
5 M. Mori, Il linguaggio della bioetica. Lessico e argomentazioni in un recente «Dizionario», in “Iride”, XVI, n. 40, settembre-dicembre<br />
2003, pp. 5433-543.<br />
72 73