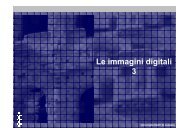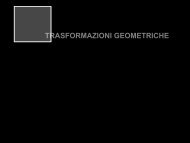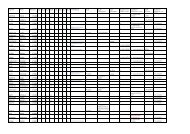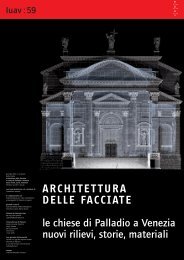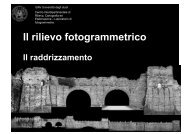Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
<strong>IL</strong> R<strong>IL</strong>IEVO <strong>DIRETTO</strong><br />
Tra le diverse tecniche di rilevamento architettonico, il rilievo diretto è senza dubbio<br />
quella più facilmente utilizzabile perché non necessita di strumentazione particolare<br />
se non dei tradizionali strumenti di misura facilmente reperibili ed a basso costo. Ciò<br />
presuppone comunque una profonda conoscenza sia del metodo operativo sia delle<br />
tecniche di acquisizione, e di restituzione poi, delle osservazioni.<br />
Viene definito diretto in quando le misure vengono prese direttamente sull’oggetto da<br />
rilevare ed è possibile il confronto diretto tra l’oggetto e un “campione” di dimensione<br />
nota.<br />
Data la sua versatilità esso viene utilizzato nella maggior parte dei rilievi architettonici<br />
ed inoltre è spesso usato a completamento di altri tipi di rilievi come quello<br />
topografico o strumentale. Inoltre può essere utilizzato per rilievi di porzioni intere,<br />
quali la planimetria o le sezioni di un edificio, oppure per il rilevamento di alcuni<br />
dettagli specifici.<br />
Fig 1: alcuni strumenti del rilievo diretto<br />
1
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Gli strumenti che vengono utilizzati più spesso sono:<br />
- doppi metri in legno a stecche ripiegabili con sensibilità al millimetro;<br />
- doppio metro a nastro d’acciaio arrotolabile<br />
- cordelle metriche di lunghezza variabile con sensibilità al centimetro o mezzo<br />
centimetro;<br />
- distanziometro laser;<br />
- filo a piombo per l’individuazione della verticale;<br />
- livella<br />
- …<br />
FASI DEL R<strong>IL</strong>IEVO <strong>DIRETTO</strong><br />
L’iter operativo consiste di due fasi distinte: una detta di campagna, in cui si<br />
raccolgono di dati; l’altra, da effettuare in un momento successivo, detta restituzione<br />
delle misure.<br />
Schematicamente si potrebbe riassumere tutto il processo del rilievo diretto in alcune<br />
fasi fondamentali:<br />
1. progetto<br />
2. eidotipi<br />
3. tracciamento della fondamentale orizzontale<br />
4. rilievo delle piante<br />
5. rilievo degli alzati<br />
6. eventuale integrazione con altre tecniche di rilievo<br />
7. restituzione.<br />
Indipendentemente dalla metodologia che si vuole utilizzare, la prima fase del rilievo<br />
corrisponde all’esecuzione di un PROGETTO in cui si prevede sia l’organizzazione<br />
delle operazioni da svolgere, in relazione al prodotto da ottenere, sia la suddivisione<br />
dell’oggetto da rilevare in parti. In particolare negli edifici con una notevole<br />
complessità dal punto di vista morfologico e distributivo, è necessaria la suddivisione<br />
in sottoparti e la contemporanea visione dell’insieme. La regola generale, per il rilievo<br />
diretto, ma condivisibile da tutte le forme di rilievo, è di procedere sempre dal<br />
generale al particolare.<br />
Dal punto di vista pratico, la suddivisione in sottoparti avviene dopo aver visionato<br />
tutta la documentazione grafica esistente come planimetrie catastali, vecchi rilievi<br />
anche in scale diverse,.. in modo da poter avere un’idea globale dell’edificio. Quindi si<br />
provvederà a suddividere l’organismo architettonico in sottoparti, di dimensioni<br />
contenute e con caratteristiche morfologiche o funzionali riconoscibili, avendo cura di<br />
fissare alcuni punti certi a cui ancorare tutte le diverse parti. Dovendo rilevare un<br />
appartamento, si possono considerare le stanze come elementi singoli da rilevare<br />
2
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
isolatamente, ma ancorate per esempio agli stipiti del corridoio che porta alle camere.<br />
La necessità di suddividere l’edificio da rilevare in parti minori è dovuta a diversi<br />
motivi sia di ordine pratico che teorico. Nella pratica è molto difficile con gli strumenti<br />
del rilievo diretto rilevare contemporaneamente l’intero edificio; se ad esempio è<br />
necessario misurare distanze molte lunghe, si osserva una notevole freccia nella<br />
cordella metrica che devia la misura finale. Ma soprattutto, dal punto di vista teorico,<br />
lavorando sulle singole parti, per poi riunirle, si evita di commettere errori rilevanti e di<br />
accumularli l’uno con l’altro. Si ha quindi un controllo maggiore sulla precisione del<br />
proprio rilievo, in quanto si possono commettere solo errori locali (legati quindi ad una<br />
singola parte dell’edificio) e non errori che inficiano l’intero rilievo.<br />
Nella fase di progetto di ogni rilievo vanno inoltre pensati i prodotti finali da realizzare.<br />
Il primo elemento da considerare è la scala nominale del rilievo.<br />
Definizioni:<br />
scala grafica di rappresentazione: è il rapporto tra le dimensioni della realtà e quella di una sua<br />
rappresentazione.<br />
categorie Scale normalizzate<br />
Scale di ingrandimento 50:1 20:1 10:1<br />
5:1 2:1<br />
Scala naturale 1:1<br />
Scale di riduzione 1:2 1:5 1:10<br />
1:20 1:50 1:100<br />
1:200 1:500 1:1000<br />
scala nominale: un disegno numerico avente scala nominale 1:n ha contenuto metrico e qualitativo di<br />
un corrispondente disegno disegnato di pari scala. La scala nominale rappresenta il rapporto<br />
di riduzione per cui è stato progettato e realizzato e, quindi, per cui è corretto stampare il<br />
disegno.<br />
Il rapporto di scala è un parametro necessario per dare informazioni quantitative e qualitative che<br />
connotano un disegno. Il rapporto di scala, causa l’errore di graficismo, determina automaticamente la<br />
precisione metrica (contenuto metrico), il dettaglio del contenuto qualitativo (contenuto semantico e<br />
simbolico) ed è pertanto l’elemento caratterizzante del disegno.<br />
Contenuto metrico: la parte geometrica del disegno<br />
Contenuto semantico: la parte che comunica il significato del disegno<br />
Contenuto simbolico: la parte di segni convenzionali<br />
3
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Come visto nel capitolo precedente la scala di rappresentazione comporta un valore<br />
di incertezza individuabile attraverso l’errore di graficismo (0.2 mm x denominatore<br />
della scala).<br />
Scala NOMINALE INCERTEZZA Campo applicazione<br />
1:1000 20 cm Inquadramento topografico<br />
1:500 10 cm Planimetrie di centri urbani e porzioni di<br />
territori<br />
1:200 4 cm Piante di insieme di edifici e di porzioni<br />
urbane<br />
1:100 2 cm Piante di insieme di edifici<br />
1:50 1 cm<br />
Piante e sezioni di edifici o di aree di<br />
1:20 0,4 cm (4 mm)<br />
scavo<br />
1:10 0,2 cm (2 mm)<br />
Dettagli architettonici, particolari,<br />
1:5 0,1 cm (1 mm)<br />
decorazioni<br />
N.B. la tolleranza di scala non deve superare l’errore di graficismo.<br />
Fig 2: progettazione di un rilievo: rapporto scala – incertezza<br />
LA MISURA<br />
Come insieme di<br />
<strong>IL</strong> NUMERO L’UNITA’ DI MISURA L’INCERTEZZA<br />
Nella<br />
progettazione di<br />
un rilievo<br />
Valutazione<br />
dell’incertezza<br />
NO CONFRONTO SI Restituzione<br />
grafica<br />
Effettuazione<br />
delle misure<br />
In funzione di: scala nominale<br />
precisione strumento<br />
Errore di<br />
graficismo<br />
Fig 3: progettazione di un rilievo: rapporto scala – incertezza<br />
4
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
La scala nominale da inoltre delle indicazioni pratiche per la fase di rilevamento delle<br />
misure, individuando il limite minimo rappresentabile. Se ad esempio il rilievo previsto<br />
deve essere consegnato alla scala 1:50, ciò comporta che non andranno rilevate tutti<br />
gli elementi inferiori a 1 cm (= incertezza della scala 1:50). Scelta la scala nominale,<br />
restano da definire quali saranno gli elaborati finali: piante, sezioni, profili, prospetti,<br />
modelli 3d,…In base al prodotto da restituire vanno anche prese alcune decisioni,<br />
ricordando che il disegno finale di rilievo deve fornire una descrizione esaustiva ed<br />
univoca dell’oggetto del rilievo. Per questo motivo, ad esempio, nelle piante il piano di<br />
sezione (la pianta non è altro che una sezione orizzontale a quota costante) dovrà<br />
passare ad un’altezza tale da poter “tagliare” il maggior numero di porte e finestre<br />
(generalmente la quota di sezione, che va indicata, è di circa 1.50 dal piano di<br />
calpestio). Allo stesso modo nelle sezioni verticali, il piano va posizionato in modo da<br />
rappresentare in modo compiuto gli elementi di distribuzione verticale, eventuali<br />
capriate delle coperture e tutti gli elementi che non risultano descritti completamente<br />
nelle piante. Buona norma è quella di realizzare, per le sezioni, le viste dirette e di<br />
controcampo per fornire la descrizione dell’intero vano.<br />
La seconda fase dell’operazione di rilievo consiste nella realizzazione degli EIDOTIPI.<br />
Con eidotipo si intende un disegno realizzato a mano libera, ma accurato, dell’area o<br />
dell’oggetto da rilevare, sul quale poi andranno segnate le misure rilevate. Esso non è<br />
però solo un supporto per le misure, può essere considerato un vero e proprio<br />
quaderno di appunti sul quale il rilevatore annota anche particolare e dettagli. E per<br />
questo motivo che per molti l’eidotipo non ha solo il carattere di documentazione<br />
provvisoria e di supporto, ma anzi parte integrante della restituzione grafica del<br />
manufatto.<br />
Il concetto teorico sotteso agli eidotipi è che essi devono rendere “discreto” ciò che è<br />
continuo, riproducendo con un numero limitato di segni, il soggetto che<br />
rappresentano. Questi segni saranno quelli necessari per rappresentare<br />
sinteticamente il soggetto, senza snaturarne l’essenza.<br />
Sull’eidotipo va riportato tutto quello che si deve rilevare, possibilmente facendo<br />
attenzione alle dimensioni e soprattutto alle proporzioni, e quelle informazioni che il<br />
rilevatore ritiene necessarie per la fase successiva di misurazione e poi di<br />
restituzione. Praticamente deve riportare tutte le murature che verranno sezionate, gli<br />
elementi che sono in vista, gradini e scale, eventuali cambi di quota, alcune<br />
indicazioni di massima sui materiali utilizzati, talvolta vanno riportate anche le<br />
proiezioni di quello che sta sopra il piano di sezione come le travi principali, lucernari,<br />
indicazioni schematiche delle volte.<br />
Viene realizzato a matita per permettere eventuali correzioni, frequenti in campagna,<br />
e generalmente utilizzando un supporto rigido visto che non sempre si hanno a<br />
disposizione piani di appoggio. Sono da evitare i disegni in cui le linee ed i segni<br />
siano sovrabbondanti. Allo stesso modo sono da evitare inutili concessioni al gusto<br />
5
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
pittorico. E’ buon norma indicare su ogni foglio l’indicazione dell’opera, la sua<br />
ubicazione rispetto allo schema generale, il numero progressivo del disegno, data del<br />
rilievo e nome del rilevatore.<br />
Fig 4: a) esempio di eidotipo con definizione delle aree di rilievo<br />
b) eidotipi di pianta e sezione<br />
L’eidotipo utilizza generalmente lo schema delle proiezioni ortogonali. Per cui per il<br />
rilievo delle piante, verrà realizzato a mano una sezione orizzontale, mentre per gli<br />
alzati si provvederà ad una sezione verticale. Negli eidotipi delle piante vanno<br />
riportate anche le indicazioni di eventuali sezioni che passano per quel vano. Per<br />
elementi complessi come modanature o nodi particolarmente complicati si dovranno<br />
realizzare eidotipi di dettaglio su cui andranno indicati in modo chiaro i riferimento per<br />
inserire l’oggetto nella giusta posizione.<br />
La terza fase prevede il TRACCIAMENTO DELLA FONDAMENTALE<br />
ORIZZONTALE. Con questa operazione si intende la materializzazione di una linea<br />
orizzontale, di quota costante, che percorre tutto l’edificio. In questa fase viene messo<br />
in luce l’atteggiamento corretto che il rilevatore deve tenere. Infatti non è corretto<br />
supporre piani di calpestio orizzontali, muri a piombo o angoli retti tra due pareti se<br />
non vi sono delle misure a comprovare tutto ciò oppure altre valide motivazioni.<br />
Questa operazione è assolutamente indispensabile quando gli edifici da rilevare<br />
6
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
hanno un sistema distributivo complesso, magari disposto su più livelli, oppure fanno<br />
parte di complessi storici per cui le pavimentazioni possono avere subito<br />
deformazioni o trasformazioni.<br />
Questa linea rappresenta inoltre il riferimento sul quale prendere tutte le misure.<br />
Fig 5: tracciamento della fondamentale orizzontale: schema e situazione reale<br />
Essa può essere tracciata in diversi modi. I vecchi testi di rilievo suggeriscono di<br />
utilizzare una livella ad acqua che per il principio dei vasi comunicanti ha la superficie<br />
dell’acqua allo stesso livello in entrambe le estremità del tubo. Questo sistema è<br />
ormai in disuso, ed è stato sostituito dall’utilizzo di un livello laser. Questo strumento,<br />
costituito essenzialmente da un puntatore laser rotante, attraverso un sistema di<br />
autolivellazione, emette un raggio individuando una quota costante che servirà da<br />
traccia per l’identificazione di piani orizzontali o verticali. E’ molto importante riportare<br />
la linea fondamentale da stanza a stanza, segnando delle tacche, ad esempio sugli<br />
elementi comuni a vani adiacenti (p.e. stipite delle porte), in modo di avere ovunque<br />
la stessa quota di riferimento.<br />
Fig. 6: Livello laser Topcon per la materializzazione di piani orizzontali e verticali<br />
7
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
R<strong>IL</strong>IEVO DELLE PIANTE<br />
La pianta (o planimetria) serve a rendere l’immagine dell’oggetto nella sua estensione<br />
e nelle sue dimensioni, rispetto ad un piano orizzontale. In rapporto alla posizione di<br />
questo piano, su cui si esegue la proiezione dei punti, si possono avere visioni<br />
planimetriche diverse. Quando il piano è posto al di sopra degli oggetti si ha una<br />
visione zenitale, completa delle superfici di questi; quando il piano è secante, cioè<br />
taglia gli oggetti, viene rappresentata anche una parte interna degli oggetti stessi,<br />
quella tangente al piano. In questo caso si ha una sezione condotta secondo un<br />
piano orizzontale.<br />
fig. 7: Posizione del piano di sezione orizzontale rispetto all’oggetto<br />
Per quanto riguarda il rilievo planimetrico gli schemi principali di rilevamento sono per<br />
Trilaterazione e per Coordinate Cartesiane.<br />
Trilaterazione La definizione della posizione di un punto nello spazio è nota solo<br />
quando sono individuate le sue tre coordinate cartesiane; nel caso della<br />
rappresentazione planimetrica, tuttavia, sono sufficienti le due coordinate X e Y,<br />
mentre la terza, relativa all’altezza del punto, può essere omessa.<br />
Il triangolo è l’unica delle figure geometriche elementari ad essere indeformabile e,<br />
pertanto, facilmente rappresentabile sul foglio di disegno utilizzando semplicemente<br />
le misure dei tre lati. Questa caratteristiche fa si che questa figura geometrica sia<br />
particolarmente comoda nel rilievo anche di forme complesse, in quanto si procede<br />
suddividendo l’oggetto da rilevare in triangoli, possibilmente equilateri, di cui<br />
andranno misurati tutti i lati. Fissato il primo lato, di misura nota, detto anche base,<br />
per rilevare la posizione nello spazio di un altro punto sarà necessario semplicemente<br />
misurarne la distanza dai vertici della base (vengono dette anche coordinate bipolari<br />
perché per individuare un singolo punto bastano le distanze da due poli).<br />
8
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Fig. 8: schema della trilaterazione teorico ed applicazione ad un caso<br />
reale. Dato un segmento noto di lunghezza nota AB, si misurano i<br />
segmenti A1 B1 A2 B2 e si costruiscono attraverso archi di cerchio<br />
le posizioni dei punti 1 e 2.<br />
Fig.9: metodo delle trilaterazione applicato in fase di campagna e di restituzione<br />
9
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Fig 10: errori nella trilaterazione dovuti allo schema geometrico delle osservazioni.<br />
Nella pratica operativa si fissa una base, quindi si misura la distanza tra due punti, e<br />
poi si misurano tutte le distanze di ogni punto da rilevare dai due punti assunti come<br />
riferimento. Se le pareti del vano da rilevare non presentano spanciature o<br />
irregolarità, si può procedere considerando le pareti come i lati dei triangoli e quindi di<br />
ogni stanza verranno rilevate tutte le misure delle pareti e le due diagonali. Misurando<br />
infatti entrambe le diagonali ci sarà una misura sovrabbondante che permetterà di<br />
eseguire una eventuale verifica [vedere paragrafo restituzione].<br />
Il metodo della trilaterazione viene utilizzato nei più diversi casi, ricordando però che<br />
con questa tecnica si individua la posizione di punti singolari coincidente con i vertici<br />
dei triangoli rispetto ad un piano.<br />
Fig. 11: errori nella trilaterazione<br />
Dovendo rilevare l’andamento di una linea curva qualsiasi, l’attendibilità nel rilievo<br />
sarà in relazione alla quantità e alla qualità dei punti che abbiamo selezionato e<br />
rispetto ai quali verranno rilevate le misure. Per rilevare ad esempio la forma di una<br />
piccola nicchia, ma abbastanza profonda, è possibile, considerando i due estrema<br />
come elementi noti, misurare i lati dei triangoli di base note e vertice opposto<br />
appartenente alla superficie concava. La quantità dei punti sarà in relazione, oltre che<br />
alle dimensioni della nicchia e alla finalità del rilievo, alla tipologia della nicchia e alla<br />
discretizzazione effettuata. Se l’andamento fosse schematizzabile ad un solo arco di<br />
circonferenza, basterebbero un solo punto oltre ai due di base.<br />
10
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Fig.12: schema di trilaterazione utilizzato per rilevare superfici curve sia in<br />
planimetria (nicchie) sia in alzato (volte);<br />
La tecnica della trilaterazione è applicabile anche per individuare profili verticali (o<br />
volte), a condizione che i triangoli di cui si misurano i lati appartengano a piani<br />
verticali.<br />
Infine può essere utilizzata per ricavare indirettamente, cioè a partire da misure<br />
lineari, l’ampiezza dell’angolo formato da due piani contigui.<br />
Coordinate cartesiane Questo schema di misurazione parte dalla conoscenza del<br />
sistema di coordinate cartesiane, in cui l’asse delle ordinate e delle ascisse sono<br />
ortogonali tra loro. Questo metodo consiste nel fissare una retta (ascissa), detta base,<br />
possibilmente parallela ad uno dei lati. Su questa retta, considerata come asse delle<br />
ascisse, si proiettano perpendicolarmente tutti i punti da rilevare, ottenendo i<br />
corrispondenti punti proiettati. Per effettuare la proiezione dei punti sulla base, è<br />
necessario accertarsi che essa avvenga perpendicolarmente; pertanto la retta<br />
proiettante e la base devono formare un angolo retto. La perpendicolarità può essere<br />
assicurata con l’uso di una squadra da muratore oppure più semplicemente<br />
incrociando la cordella metrica, che funge da ascissa di riferimento, con un metro<br />
rigido e valutandone l’ortogonalità. Si andranno a leggere quindi le misure sulla<br />
cordella metrica che fornirà la X e sul metro rigido che fornirà la Y.<br />
11
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Fig 13: Schema per coordinate cartesiane. Metodo delle misure progressive<br />
(in alto) o parziali (in basso)<br />
Queste misure potranno essere riportate sia con il metodo delle misure progressive,<br />
che con quello delle parziali. Il metodo delle misure progressive in allineamento<br />
prevede che per ogni punto venga letta la distanza sulla cordella da un punto detto<br />
polo o origine. Il metodo delle misure parziali invece registra le misure di ogni singolo<br />
elemento, senza fornire indicazioni sul totale. Tra questi due metodi è da preferire il<br />
metodo delle misure progressive in quanto se una misura è letta male, non andrà ad<br />
influire sulle successive, mentre ciò avviene nelle misure parziali.<br />
12
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
La tecnica delle coordinate cartesiane è in genere utilizzata nei rilievi planimetrici non<br />
troppo estesi, ma di configurazione complessa. Se per esempio si deve rilevare un<br />
profilo orizzontale di una superficie ad andamento curvilineo, a condizione che il<br />
pavimento sia orizzontale, è possibile assumere come base di riferimento un’asta<br />
rigida graduata poggiata a terra, come per esempio un triplometro. Un squadra di<br />
dimensioni opportune, fatta scorrere adagiata sul triplometro, servirà per<br />
materializzare le proiezioni ortogonali dei punti da rilevare. Per misurare le proiezioni<br />
dei punti sul triplometro può essere utilizzata una riga rigida graduata appoggiata sul<br />
cateto libero della squadra. Questa viene fatta scorrere fino a far coincidere lo zero<br />
con il punto da rilevare: la lettura sul triplometro fornisce la misura dell’ascissa, quella<br />
sulla riga la misura dell’ordinata. La stessa tecnica è abitualmente utilizzata nel rilievo<br />
dei profili di particolari architettonici come balaustre, basamenti e ordini; in questi casi<br />
i due assi apparterranno al piano verticale.<br />
Fig 14: rilievo di profili architettonici, orizzontali o verticali attraverso il<br />
metodo delle coordinate cartesiane<br />
Unione delle parti<br />
Descritti i due principali schemi del rilievo diretto e alcune occasioni in cui applicarli,<br />
resta il problema di collegare tra loro le parti rilevate singolarmente in dettaglio (i<br />
diversi ambienti di un edificio, i diversi piani, i diversi isolati,..) seguendo un<br />
procedimento che eviti il propagarsi dell’errore di un singolo tratto a tutto il rilievo.<br />
Questo modo di procedere viene detto inquadramento del rilievo, e consiste nella<br />
determinazione, particolarmente accurata della posizione di alcuni punti (detti<br />
caposaldi) in relazione ad un sistema di riferimento generale, a cui eventualmente<br />
connettere i necessari sistemi locali. I rilievi dimensionali delle singole parti saranno<br />
via via agganciati ai caposaldi e riferiti ai sistemi di assi o alle singole direzioni.<br />
Per condurre con particolare precisione le operazioni preliminari di inquadramento è<br />
13
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
opportuno far ricorso a metodi e a strumentazioni topografiche. Qualora ciò non fosse<br />
praticabile, o non fossero richieste particolari precisioni, è possibile procedere anche<br />
con il metodo diretto.<br />
La tecnica più utilizzata è la trilaterazione, ma bisogna porre attenzione perché si<br />
corre il rischio di trasportare l’incertezza amplificandone gli effetti negativi. Per ridurre<br />
al minimo gli errori è buona norma fissare delle rette basi o allineamenti ai quali<br />
riferire le singole misure dell’oggetto. La determinazione dei singoli punti dell’edificio<br />
viene desunta dalle trilaterazione appoggiate sull’allineamento preventivamente<br />
realizzato, senza che siano tra di loro concatenate.<br />
Per rilevare ad esempio il profilo esterno dell’edificio, la prima operazione consiste nel<br />
tracciare una base la cui direzione sia ovviamente relazionata all’andamento<br />
dell’edificio stesso. Successivamente si procede rilevando le distanze da ognuno<br />
degli estremi delle basi di tutti i punti necessari per descrivere il perimetro dell’edificio.<br />
Fig 15: Inquadramento mediante una rete di trilaterazioni esterne<br />
Qualora si debbano mettere in relazione le diverse parti dell’oggetto rilevato, o tra loro<br />
i diversi oggetti, è necessario predisporre più allineamenti, opportunamente<br />
individuati e relazionati gli uni agli altri , ai quali riferire tutte le misurazioni successive,<br />
14
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
qualunque sia la tecnica utilizzata. Nel caso del rilievo diretto, per evitare di incorrere<br />
in notevoli errori, è necessario realizzare il minor numero di allineamenti, magari con<br />
una disposizione tale da formare una maglia chiusa. Gli allineamenti infatti sono<br />
spesso fonte di errore perché non è così facile tendere uno spago o la cordella<br />
metrica. La disposizione ottimale è rappresentata da allineamenti consecutivi a due a<br />
due ortogonali. Ipotizzando sempre di non misurando angoli, operazione difficile nel<br />
rilievo diretto, sarà necessario bloccare ogni allineamento sul precedente e sul<br />
successivo attraverso coppie di trilaterazione, con i lati il più possibile ampi.<br />
Un problema simile si ripropone quando si desidera unire alcune stanze di un<br />
medesimo appartamento rilevate singolarmente. E’ consigliato infatti rilevare la<br />
posizione di alcuni punti significativi di due diversi ambienti, anche non contigui,<br />
attraverso delle trilaterazioni appoggiate a punti appartenenti all’allineamento. Nel<br />
primo ambiente si è determinato di rilevare la posizione dei quattro punti appartenenti<br />
agli spigoli verticali attraverso la misura delle distanze, ad esempio, dai vertici A e B<br />
della figura. Il secondo ambiente verrà determinato attraverso il rilievo dei punti<br />
necessari, ma riferito ai vertici C e D.<br />
Fig 16: Collegamento di singole parti rilevate appoggiandosi su un<br />
allineamento noto.<br />
Un secondo sistema prevede di collegare le diverse stanze tra loro rilevando lo<br />
spessore delle murature in corrispondenza delle aperture. Questo sistema, forse più<br />
veloce, ha però il difetto che non rappresenta in modo corretto l’oggetto se le<br />
murature non hanno spessore costante. Per cui questo metodo non è utilizzabile per<br />
l’edilizia storica, in cui le murature hanno spessore variabile.<br />
15
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Fig 17: alcuni esempi di rilievi:<br />
a) unione di singoli rilievi<br />
b) rilievo di un vano con misure parziali e totali<br />
c) rilievo di un vano dalla forma irregolare per coordinate cartesiane<br />
e) trilaterazione<br />
16
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
R<strong>IL</strong>IEVO DEGLI ALZATI (sezioni e prospetti)<br />
Il termine sezione indica la rappresentazione grafica degli oggetti secondo un piano<br />
verticale, secante gli oggetti, in modo tale da mostrare la parte interna. La definizione<br />
è analoga a quella data in planimetria, dato che l’unica differenza è data dalla<br />
disposizione del piano secante. I prospetti sono invece proiezioni di superfici verticali<br />
(alzati) condotti secondo piani a queste paralleli.<br />
Fig. 18: Relazione posizione del piano verticale di sezione - rappresentazione<br />
Dopo aver tracciato, come indicato in precedenza la fondamentale orizzontale, il<br />
rilievo degli alzati consiste nel riferire le quote dei singoli punti alla quota della linea<br />
fondamentale, misurando le distanze verticali da questo, con segno positivo verso<br />
l’alto e negativo se verso il basso, secondo la tecnica già vista delle coordinate<br />
cartesiane. La verticalità rispetto alla linea fondamentale deve essere assicurata<br />
mediante l’uso del filo a piombo. Il problema si complica quando i due punti di cui<br />
rilevare il dislivello sono distanti tra loro o vi sono degli ostacoli interposti. Si può<br />
procedere con la tecnica detta della costellazione o a gradoni. Questa consiste nel<br />
dividere l’intere lunghezza in più tratti orizzontali di cui si misureranno le singole<br />
distanze orizzontali e le relative differenze di quota. Per operare correttamente, a<br />
partire dal punto più alto, si dispone un primo triplometro dotato di livella di cui si<br />
proietta verticalmente l’estremo libero con l’ausilio del filo a piombo. Nel punto<br />
individuato dal filo a piombo si posiziona il successivo triplometro,di cui nuovamente<br />
si proietta l’estremo libero. La somma delle letture effettuate sul triplometro e la<br />
somma delle estensioni del filo a piombo rappresentano le misura cercate.<br />
17
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Fig.19: Realizzazione della fondamentale orizzontale come quota di riferimento<br />
per il rilievo e le misure verticali<br />
Per collegare correttamente il rilievo altimetrico di più ambienti sovrapposti in verticale<br />
è necessario costruire un riferimento esterno all’edificio al quale relazionare le quote<br />
dei piani orizzontali di riferimento dei singoli ambienti. La materializzazione di questa<br />
verticale può essere realizzata calando dal punto accessibile più alto dell’edificio un<br />
filo a piombo,o ancora metro una cordella metrica agganciata ad un filo a piombo. In<br />
questo modo è possibile ricavare tutte le quote dei davanzali dagli architravi delle<br />
finestre che si aprono su quella verticale. A queste quote sono poi riferibili quelle dei<br />
piano orizzontali utilizzati per il rilievo planimetrico dei vari livelli, e quindi anche le<br />
quote di tutti i singoli punti di dettaglio.<br />
In questo modo è possibile dimensionare elementi non misurabili direttamente. Ad<br />
esempio per ottenere lo spessore di un solaio essendo note le quote sia del<br />
davanzale della finestra posta al piano immediatamente superiore sia dell’architrave<br />
della finestra posta al piano immediatamente inferiore, è sufficiente misurare le<br />
distanze tra il davanzale e il piano di calpestio e tra l’architrave e l’intradosso della<br />
copertura. Una volta calcolato il dislivello tra il davanzale e l’architrave, a questo si<br />
sottraggono le distanza prima misurate ottenendo così la dimensione del solaio.<br />
Nel caso di ambienti coperti a volta, debbono essere rilevate sia l’altezza all’imposta,<br />
sia quella in chiave. In casi particolare il profilo della volta va rilevato con cura,<br />
misurando, oltre che l’imposta e la chiave, anche i punti intermedi. Questo tipo di<br />
rilievo può essere effettuato sia con il metodo delle coordinate cartesiane, sia con il<br />
metodo delle trilaterazione, per le quali si utilizzano come base due punti del<br />
pavimento, che devono essere scelti sullo stesso piano di sezione verticale dei punti<br />
da rilevare.<br />
18
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Fig 20: a) rilievo degli alzati mediante il riferimento al filo a piombo<br />
b) rilievo di un vano voltato mediante triangolazione<br />
c) rilievo di un vano sotterraneo mediante coordinate cartesiane<br />
riferite ad un piano di riferimento<br />
19
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
R<strong>IL</strong>IEVO DELLE SCALE<br />
Esso riveste una particolare importanza, sia per le difficoltà intrinseche sia per il ruolo<br />
di collegamento tra i diversi piani. Il rilievo planimetrico non comporta particolari<br />
problemi: prese le misure interne del vano, si prelevano il numero di alzate e pedate,<br />
la dimensione di tutte le pedate, le misure del pianerottolo di arrivo e di partenza, la<br />
lunghezza delle rampe. Generalmente le piante si eseguono facendo la proiezione<br />
delle rampe come se queste fossero viste dall’alto, possibilmente evitando di<br />
sezionare orizzontalmente la rampa. Il problema risulta più complesso se le scale<br />
sono rampanti o elicoidali; in tal caso per ogni pedata vanno rilevate due larghezze.<br />
Dal punto di vista altimetrico il rilievo va affrontato per coltellazione, avendo cura di<br />
rilevare se possibile l’altezza intercorrente tra i pianerottoli, per verificare la somma<br />
delle costellazioni parziali Per tale rilievo si utilizza un filo a piombo, calato all’interno<br />
del vano scala, sul quale, a mezzo di regoli muniti di livella, si riportano i punti che<br />
delimitano le quote dei vari pianerottoli. Si consiglia anche di rilevare, sullo stesso filo<br />
a piombo, l’altezza globale della scala.<br />
Fig.21: Rilievo delle scale in planimetria e in alzato mediante l’uso della<br />
coltellazione<br />
20
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
R<strong>IL</strong>IEVO DI DETTAGLIO<br />
Nel caso di rilievi di dettagli architettonici, ordini architettonici, cornici, i metodi da<br />
utilizzare sono quelli tradizionali per triangolazione e coordinate cartesiane. In molti<br />
casi il rilievo coincide con il rilevamento del profilo; esso infatti rappresenta in sintesi<br />
la forma, il modellato e la proporzione delle modanature che costituiscono la cornice.<br />
Il prelevamento delle misure si farà per quanto possibile con la massima esattezza e<br />
con particolare attenzione alla forma, per poter fissare le distanze che inquadrano le<br />
modanature e le collegano tra loro. Il rilievo di questi tipi di dettagli riuscirà meglio<br />
quando si possegga una adeguata conoscenza della forma caratteristica degli<br />
elementi architettonici.<br />
Fig 22: rilievo di una balaustra, dettaglio e insieme. Vista frontale, in pianta e<br />
sezione.<br />
21
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
RESTITUZIONE<br />
Questa fase, che è comune a tutti i tipi di rilievi che verranno affrontati, è suddivisa in<br />
due fasi ulteriori. Nella prima parte vengono restituite le misure, secondo diverse<br />
tecniche, mentre in seguito si procede ad una fase di editino grafico per rendere i<br />
disegni corretti anche dal punto di vista formale.<br />
Si deve porre attenzione in particolare alla fase di restituzione degli elementi rilevati<br />
per trilaterazione. Si procede disegnando la prima linea corrispondente alla segmento<br />
utilizzato come base. Per determinare tutti gli altri punti si procederà con archi di<br />
cerchio dei raggio pari alle distanze rilevate.<br />
Con riferimento alla figura, si disegni il segmento AB pari alla base. Poi si tracci, con<br />
centro in A, un cerchio di raggio AC, mentre con centro in B il segmento BC.<br />
All’incrocio dei due cerchi verrà fissato il punto C. Allo stesso modo, puntando in C<br />
con apertura CD e in A con apertura AD, si fissa il punto D. Abbiamo però visto che<br />
nel rilievo è importante avere sempre misure sovrabbondanti per effettuare dei<br />
controlli. In questo caso, se abbiamo misurato anche la seconda diagonale,<br />
realizziamo un cerchio con centro in B e raggio BD. Se tutte le nostre misure fossero<br />
precise il punto D si troverebbe all’incrocio dei tre archi di cerchio. Invece succede<br />
praticamente sempre che i tre archi non si incrocino e formino una specie di triangolo,<br />
visibile aumentando il fattore di zoom. In questo caso il tecnico restitutore provvederà<br />
a porre il punto D nel baricentro P del triangolo formato dai tre archi di cerchio.<br />
Questa compensazione pratica corrisponde, dal punto di vista teorico, all’applicazione<br />
dei minimi quadrati, ossia si cerca di distribuire l’errore su tutte e tre le misure e fare<br />
in modo che esso sia il più piccolo possibile. Il punto notevole che soddisfa queste<br />
richieste è appunto il baricentro.<br />
Fig 23: Esempio di restituzione di misure rilevate per trilaterazione.<br />
Compensazione empirica riportando il vertice da fissare nel<br />
baricentro P del triangolo formato dalle tre distanze osservate<br />
22
Capitolo 3 - Il rilievo diretto<br />
Considerando lo sviluppo, ormai assodato e diffuso, del calcolatore come strumento<br />
principale di disegno, la fase di restituzione verrà affrontata facendo riferimento a<br />
programmi di Computer Aided Design CAD. Per adeguarsi alla cartografia numerica, i<br />
file andranno sempre realizzati utilizzando come unità di disegno il metro. In questo<br />
modo, dovendo inserire il rilievo nella cartografia esistente, non si dovranno applicare<br />
trasformazioni di scala.<br />
Inoltre la logica interna dei software CAD permette di lavorare con layer diversi, in<br />
modo di attribuire ad ogni layer (paragonabile ognuno ad un foglio di lucido<br />
sovrapponibile) un particolare significato: linee di costruzione, indicazioni generali, ….<br />
Il disegno finale sarà strutturato in layer in modo da avere alcuni layer legati alla fase<br />
di restituzione, in cui saranno contenuti i cerchi per le trilaterazioni,…mentre altri layer<br />
per gli elementi già restituiti. La strutturazione in layer permette una rapida<br />
comprensione del disegno, ed un editing rapito in fase di stampa, scegliendo lo<br />
spessore della penna in relazione al colore.<br />
Ad esempio potranno essere utilizzati i layer.<br />
Vista per tutti gli elementi non sezionati e visibili dall’alto;<br />
Sezione per tutti gli elementi tagliati dal piano di sezione, sia orizzontale che<br />
verticale;<br />
Proiezioni per tutti gli elementi, che pur stando sopra la line a di sezione, devono<br />
essere riportati anche nelle piante (travi principali,…)<br />
Costruzione per linee e archi di costruzione<br />
Testo per gli elementi scritti<br />
Parametratura per gli elementi delle cornici e della parametratura del foglio.<br />
Restano inoltre tutti i layer collegati al materiale costruttivo (legno, pietra, laterizio,…)<br />
Per ciò che riguarda gli spessori e i tipi di linee tutti gli elementi sezionati ed in vista<br />
diretta cono rappresentati con linee continue di spessore differenziato, in modo da<br />
essere chiaramente distinguibili.<br />
Sebbene dipendano anche dalla scala di rappresentazione, generalmente si possono<br />
utilizzare per gli elementi sezionati spessori di 0.3 - 0.4 mm, mentre spessore 0.3 per<br />
gli elementi in vista. Qualora alcune parti non siano state rilevate, vanno segnate con<br />
un tratteggio. Con linee tratteggiate sottili vanno rappresentati gli oggetti proiettati<br />
dall’alto (travi principali). La posizione delle sezioni è indicata con linee a tratto e<br />
punto.<br />
Per evitare i problemi legati alla deformazione del supporto cartaceo nel tempo, è<br />
buona norma inserire una parametratura a passo fisso nel disegno in modo da poter<br />
sempre verificare eventuali distorsioni. Essa inoltre, assieme alla scala grafica,<br />
fornisce un’indicazione di massima immediata delle dimensioni dell’oggetto rilevato<br />
23