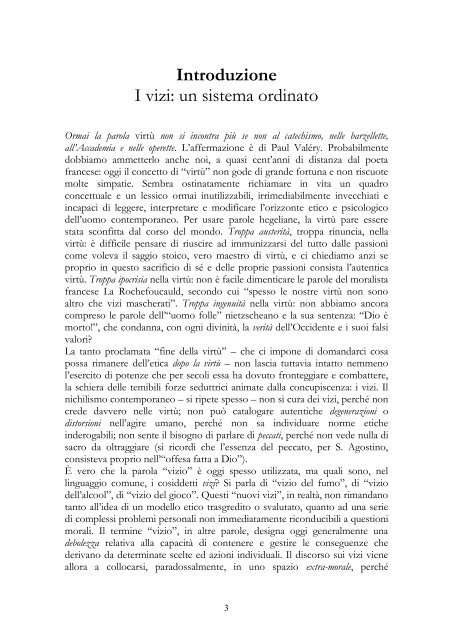Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Introduzione<br />
I <strong>vizi</strong>: un sistema ordinato<br />
Ormai la parola virtù non si incontra più se non al catechismo, nelle barzellette,<br />
all’Accademia e nelle operette. L‟affermazione è di Paul Valéry. Probabilmente<br />
dobbiamo ammetterlo anche noi, a quasi cent‟anni di distanza dal poeta<br />
francese: oggi il concetto di “virtù” non gode di grande fortuna e non riscuote<br />
molte simpatie. Sembra ostinatamente richiamare in vita un quadro<br />
concettuale e un lessico ormai inutilizzabili, irrimediabilmente invecchiati e<br />
incapaci di leggere, interpretare e modificare l‟orizzonte etico e psicologico<br />
dell‟uomo contemporaneo. Per usare parole hegeliane, la virtù pare essere<br />
stata sconfitta dal corso del mondo. Troppa austerità, troppa rinuncia, nella<br />
virtù: è difficile pensare di riuscire ad immunizzarsi del tutto dalle passioni<br />
come voleva il saggio stoico, vero maestro di virtù, e ci chiediamo anzi se<br />
proprio in questo sacrificio di sé e delle proprie passioni consista l‟autentica<br />
virtù. Troppa ipocrisia nella virtù: non è facile dimenticare le parole del moralista<br />
francese La Rochefoucauld, secondo cui “spesso le nostre virtù non sono<br />
altro che <strong>vizi</strong> mascherati”. Troppa ingenuità nella virtù: non abbiamo ancora<br />
compreso le parole dell‟“uomo folle” nietzscheano e la sua sentenza: “Dio è<br />
morto!”, che condanna, con ogni divinità, la verità dell‟Occidente e i suoi falsi<br />
valori?<br />
La tanto proclamata “fine della virtù” – che ci impone di domandarci cosa<br />
possa rimanere dell‟etica dopo la virtù – non lascia tuttavia intatto nemmeno<br />
l‟esercito di potenze che per secoli essa ha dovuto fronteggiare e combattere,<br />
la schiera delle temibili forze seduttrici animate dalla concupiscenza: i <strong>vizi</strong>. Il<br />
nichilismo contemporaneo – si ripete spesso – non si cura dei <strong>vizi</strong>, perché non<br />
crede davvero nelle virtù; non può catalogare autentiche degenerazioni o<br />
distorsioni nell‟agire umano, perché non sa individuare norme etiche<br />
inderogabili; non sente il bisogno di parlare di peccati, perché non vede nulla di<br />
sacro da oltraggiare (si ricordi che l‟essenza del peccato, per S. Agostino,<br />
consisteva proprio nell‟“offesa fatta a Dio”).<br />
È vero che la parola “<strong>vizi</strong>o” è oggi spesso utilizzata, ma quali sono, nel<br />
linguaggio comune, i cosiddetti <strong>vizi</strong>? Si parla di “<strong>vizi</strong>o del fumo”, di “<strong>vizi</strong>o<br />
dell‟alcool”, di “<strong>vizi</strong>o del gioco”. Questi “nuovi <strong>vizi</strong>”, in realtà, non rimandano<br />
tanto all‟idea di un modello etico trasgredito o svalutato, quanto ad una serie<br />
di complessi problemi personali non immediatamente riconducibili a questioni<br />
morali. Il termine “<strong>vizi</strong>o”, in altre parole, designa oggi generalmente una<br />
debolezza relativa alla capacità di contenere e gestire le conseguenze che<br />
derivano da determinate scelte ed azioni individuali. Il discorso sui <strong>vizi</strong> viene<br />
allora a collocarsi, paradossalmente, in uno spazio extra-morale, perché<br />
3