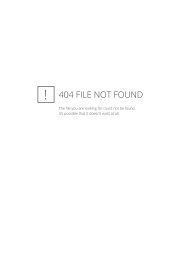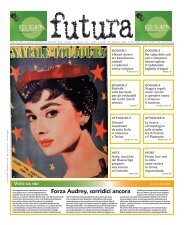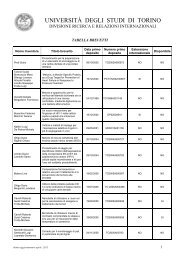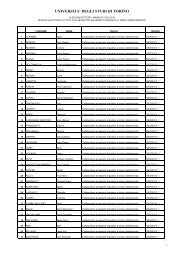Marzia Ponso, Il Sonderweg tedesco: nazionalismo o federalismo?
Marzia Ponso, Il Sonderweg tedesco: nazionalismo o federalismo?
Marzia Ponso, Il Sonderweg tedesco: nazionalismo o federalismo?
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
IL SONDERWEG TEDESCO:<br />
NAZIONALISMO O<br />
FEDERALISMO?<br />
<strong>Marzia</strong> <strong>Ponso</strong><br />
1'·""<br />
\ J ••<br />
. .. .<br />
••<br />
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO<br />
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI
Working Papers n. 11 – Ottobre 2008<br />
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI<br />
Torino, Italy
© DSP DSP DSP – (Dipartimento (Dipartimento di di Studi Studi Politici)<br />
Politici)<br />
Università di Torino<br />
Via Giolitti, 33<br />
10123 Torino - Italy<br />
Tel. +39 011 6704101/6704102<br />
Fax +39 011 6704114<br />
http://www.dsp.unito.it<br />
2
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI<br />
Università degli Studi di Torino<br />
Via Giolitti, 33 - 10123 Torino - Italy<br />
Tel. +39 011 6704101 / 6704102 Fax +39 011 6704114<br />
http://www.dsp.unito.it<br />
<strong>Il</strong> Dipartimento di Studi Politici ha carattere interdisciplinare e nasce dal<br />
progetto di studiare in modo integrato il mondo della politica in tutti i suoi<br />
aspetti: dalla riflessione teorica e storica sulla formazione delle idee e delle<br />
dottrine politiche, all'analisi comparata dei sistemi politici e delle forme di<br />
democrazia nelle società contemporanee, sullo sfondo dei processi di<br />
globalizzazione e di trasformazione delle relazioni internazionali.<br />
<strong>Il</strong> Dipartimento si è costituito l'8 novembre del 1982, per iniziativa di un<br />
gruppo di studiosi che intendevano raccogliere e sviluppare la tradizione di<br />
studi e ricerche fondata da maestri come Norberto Bobbio, Luigi Firpo e<br />
Alessandro Passerin d'Entrèves, che dalla metà degli anni cinquanta aveva<br />
trovato sede nell'Istituto di Scienze Politiche "Gioele Solari", nucleo della futura<br />
Facoltà di Scienze Politiche e successivamente disciolto in conseguenza della<br />
legge istitutiva dei dipartimenti universitari. In esso sono confluiti filosofi, storici,<br />
politologi e sociologi, che al di là del proprio ambito specialistico sono<br />
accomunati dall'interesse unitario per l'approfondimento della politica.<br />
All'interno del Dipartimento si possono distinguere varie aree di ricerca. La<br />
prima di esse concerne lo studio del pensiero politico in prospettiva storica,<br />
dai classici del pensiero antico e medioevale alle ideologie e dottrine politiche<br />
contemporanee. Una seconda area, di carattere politologico e sociologico,<br />
riguarda lo studio delle forme di stato e di governo, il funzionamento dei<br />
regimi politici, le trasformazioni della democrazia, la comunicazione politica e<br />
i media. Una terza area è dedicata allo studio delle relazioni internazionali e ai<br />
problemi della pace. Una quarta area si occupa dei problemi connessi<br />
all'integrazione europea e allo studio del pensiero e dei movimenti federalisti.<br />
Una quinta area si occupa dei problemi dello sviluppo e della storia dei paesi<br />
non europei, dall'America Latina all'Asia e all'Africa.<br />
<strong>Il</strong> Dipartimento di Studi politici cura la pubblicazione di una collana di<br />
working papers. Lo scopo della collana è di far conoscere tempestivamente<br />
alla comunità scientifica ipotesi di lavoro, interventi, materiali di ricerca, in<br />
attesa di pubblicazione o giunti ad una fase finale di elaborazione.<br />
DSP<br />
DSP<br />
http://www.dsp.unito.it/wrkpaprs.html<br />
3
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
4
Sommario<br />
Sommario<br />
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
IL IL IL SONDERWEG SONDERWEG SONDERWEG TEDESCO:<br />
TEDESCO:<br />
NAZIONALISMO NAZIONALISMO O O FEDERALISMO? FEDERALISMO?<br />
1<br />
Lo scopo del saggio è indagare uno dei temi-chiave della storia della<br />
Germania moderna: la tesi del <strong>Sonderweg</strong>. L’idea di una “via particolare”<br />
implica l’assunzione di carattere teleologico che questa è la strada che la<br />
Germania ha seguito in virtù della sua (più o meno) recente storia. Ma di<br />
questa tesi si danno più versioni. Originariamente, l’idea di una via<br />
particolare fu intesa in senso positivo (per dar conto di numerosi aspetti del<br />
primato <strong>tedesco</strong>). Sulla scia di Marx e di Weber, molti storici del dopoguerra<br />
hanno ripreso la vecchia tesi del <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> e l’hanno capovolta. Lo<br />
sviluppo occidentale (anglo-americano o francese) veniva ora assunto a<br />
metro di paragone per giudicare la storia tedesca come una deviazione.<br />
<strong>Il</strong> ritardo nello State-building e le forme aberranti del <strong>nazionalismo</strong> <strong>tedesco</strong><br />
sono state al centro di estesissime ricerche e di accese controversie,<br />
specialmente dopo la fine della seconda guerra mondiale. La ragione della<br />
mancata democratizzazione è stata individuata nel fatto che la Germania non<br />
ha conosciuto una rivoluzione borghese che abbia avuto successo nel<br />
diciottesimo e diciannovesimo secolo. Alla luce di tutti i recenti dibattiti<br />
storiografici sembra si possa dire che Luteranesimo, prussianesimo e<br />
autoritarismo bismarckiano non possano essere ridotti a prologo<br />
dell’ideologia estremista (sciovinista, antisemitica e razzista) della Germania<br />
hitleriana. E la visione della rivoluzione borghese come via occidentale alla<br />
democratizzazione si è rivelata essa stessa un mito. <strong>Il</strong> <strong>federalismo</strong> e non il<br />
<strong>nazionalismo</strong> deve essere considerato, più propriamente, come la via<br />
particolare dello sviluppo politico <strong>tedesco</strong>.<br />
1 Questo lavoro anticipa a grandi linee i risultati di una ricerca che confluirà nella<br />
monografia Una storia particolare. <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> e identità europea.<br />
5
Abstract<br />
Abstract<br />
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
The aim of the paper is to explore a main issue in the political history of<br />
modern Germany: the so-called <strong>Sonderweg</strong>-thesis. The idea of a “special<br />
path” implies the deterministic assumption that given the particular shape of<br />
German (more or less) recent history no other path was available and<br />
possible. But we have many versions of this thesis. Originally, the idea of a<br />
special path was meant in a positive sense (in order to explain several aspects<br />
of German primacy). Following Marx and Weber, many post-war historians<br />
have taken over the old view of a special German development and turned it<br />
on its head. It was western (Anglo-american or French) development that were<br />
taken as a yardstick against which German history was measured and found<br />
deviant.<br />
The delayed State-building and the aberrant forms of German nationalism<br />
have become the focus of many research and generated a vast critical debate,<br />
especially since the end of the Second World War. The reason of failed<br />
democratization has been identified in the fact that Germany didn’t experience<br />
a successful bourgeois revolution in the eighteenth and nineteenth century. But<br />
taking all the recent historical debates in consideration, it seems that Luteranism,<br />
Prussianism, and Authoritarianism under Bismarck cannot serve as a<br />
prologue to the extremist (chauvinist, antisemitic and racist) ideology of Hitler’s<br />
Germany. And the view of the bourgeois revolution as western path to<br />
democratization has revealed itself as a myth. Federalism rather than<br />
nationalism should be regarded as the special path of German political<br />
development.<br />
Autore Autore: Autore <strong>Marzia</strong> <strong>Marzia</strong> <strong>Marzia</strong> <strong>Ponso</strong> <strong>Ponso</strong> ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia del<br />
Pensiero Politico e delle Istituzioni Politiche, Dipartimento di Studi Politici<br />
Università di Torino; assegnista Fondazione CRT.<br />
6
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
INDICE<br />
INDICE<br />
1. Vie normali e vie eccezionali:<br />
il problema della storia comparata .............................................. 9<br />
2. La versione positiva della tesi del <strong>Sonderweg</strong> ............................. 15<br />
3. La versione negativa della tesi del <strong>Sonderweg</strong> ............................ 19<br />
4. <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> luterano ................................................................ 24<br />
5. <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> prussiano .............................................................. 29<br />
6. <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> bismarckiano ........................................................ 33<br />
7. Una nazione normale? .............................................................. 42<br />
8. <strong>Il</strong> modello federale ..................................................................... 49<br />
7
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
8
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
<strong>Il</strong> <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong>: <strong>tedesco</strong>: <strong>tedesco</strong>: <strong>nazionalismo</strong> <strong>nazionalismo</strong> o o <strong>federalismo</strong>?<br />
<strong>federalismo</strong>?<br />
1. 1. Vie Vie normali normali e e vie vie eccezionali: eccezionali: il il problema problema della della storia storia comparata compar<br />
ata<br />
Storiografia e scienze sociali hanno sviluppato nella seconda metà del XX<br />
secolo un programma di ricerca comune incontrandosi sul terreno della<br />
comparazione. Del metodo comparativo l’una e le altre si sono avvalse, da<br />
un lato, per superare i limiti della storia evenemenziale a carattere<br />
prevalentemente politico, dall’altro per porre rimedio all’astrattezza delle<br />
generalizzazioni di una sociologia di scuola struttural-funzionalista. Pur nella<br />
condivisione di alcuni presupposti di fondo e nel convergere di molte<br />
acquisizioni, storia comparata e sociopolitologia storica si sono sviluppate<br />
entro contesti culturali, tradizioni nazionali e quadri interdisciplinari piuttosto<br />
differenti, per cui risulta indubbiamente arduo proporre un profilo unitario del<br />
loro sviluppo 2 . Scopo di questa ricerca è pertanto, più limitatamente,<br />
contribuire alla ricostruzione del dibattito metodologico su un problema,<br />
quello del <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong>, che ha condizionato in modo significativo la<br />
riflessione su uno dei nuclei teorici della storia sociale e della sociologia<br />
storica, la teoria della modernizzazione.<br />
La storia comparata ha radici lontane. Ma è all’indomani della seconda<br />
guerra mondiale, sollecitata dalla riflessione sulle esperienze totalitarie ed<br />
autoritarie delle società sottoposte alla maggiore spinta modernizzatrice – la<br />
Germania, la Russia, la Cina, il Giappone – che essa ha elaborato, davanti<br />
all’evidente confutazione dell’irresistibilità e dell’irreversibilità del progresso<br />
nelle istituzioni politiche, il costrutto del <strong>Sonderweg</strong>, riconoscendo che le<br />
2 Affrontano la questione M. Kossok, Vergleichende Geschichte der neuzeitlichen Revolutionen.<br />
Methodologische und empirische Forschungsprobleme, Akademie, Berlin 1981; C.<br />
Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Russell Sage Foundation, New<br />
York 1985; H. Schnabel-Schüle (a cura di), Vergleichende Perspektiven - Perspektiven des<br />
Vergleichs. Studien zur europäischen Geschichte von der Spätantike bis ins 20. Jahrhundert,<br />
von Zabern, Mainz 1998; J. Osterhammel, Gesellschaftsgeschichte und Historische<br />
Soziologie, in J. Osterhammel / D. Langewiesche / P. Nolte (a cura di), Wege der<br />
Gesellschaftsgeschichte, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, pp. 81-102. In lingua<br />
italiana: P. Rossi (a cura di), La storia comparata: approcci e prospettive, <strong>Il</strong> Saggiatore,<br />
Milano 1990.<br />
9
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
differenze nei percorsi di modernizzazione delle società europee rimandano<br />
innanzitutto ad un paradigma unitario, all’interno del quale molte variabili<br />
incidono sui processi di burocratizzazione, industrializzazione e<br />
democratizzazione. Nella contingente combinazione di questi fattori è<br />
possibile identificare peculiarità dei diversi percorsi nazionali 3 .<br />
In generale, ogni discorso intorno alla problematica del <strong>Sonderweg</strong><br />
implica due assunti: che vi siano vie normali e che si diano comparazioni.<br />
Non è difficile rendersi conto che questi assunti sono insieme presupposto e<br />
portato della storia sociale e della sociologia storica: solo dove l’interesse per<br />
la comparazione diventa centrale nella ricerca storica si può sviluppare la tesi<br />
del <strong>Sonderweg</strong>. Ma è bene tener conto anche della specifica dialettica che<br />
attiene alla comparazione: essa prende le mosse dall’ipotesi che vi siano casi<br />
paradigmatici, contribuisce alla loro costruzione in termini di «tipo ideale»,<br />
mette alla prova tali costrutti per poi approdare alla conclusione che non vi<br />
sono vie o modelli normali, bensì solo eccezioni e vie particolari 4 .<br />
Non una ma due sono, notoriamente, le vie europee alla modernità che la<br />
storiografia ha assunto come normali: quella inglese e quella francese.<br />
L’Inghilterra è paradigma di assolutismo monarchico e di precoce formazione<br />
delle istituzioni statali, ma anche culla del costituzionalismo e del<br />
3 Barrington Moore, nel suo lavoro di storia sociale comparata Social Origins of Dictatorship<br />
and Democracy ha distinto nel processo di modernizzazione mondiale tre modelli di<br />
“rivoluzione”: la rivoluzione borghese (avvenuta in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti)<br />
ha imboccato la strada del capitalismo e della democrazia; la rivoluzione contadina ha dato<br />
origine ai regimi comunisti sovietico e cinese; la «rivoluzione dall’alto», attuata in Germania<br />
e in Giappone, ha tratti tipicamente autoritari e sfocia nel fascismo (B. Moore, Social<br />
Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the Making of the Modern<br />
World, Lane, London 1966; trad. it. Le origini sociali della dittatura e della democrazia:<br />
proprietari e contadini nella formazione del mondo moderno, Edizioni di Comunità, Torino<br />
1998, p. 465 e segg).<br />
4 Cfr. B. Weisbrod, Der englische „<strong>Sonderweg</strong>“, in “Geschichte und Gesellschaft”, n. 16<br />
(1990), pp. 233-252; L. Mees, Der spanische <strong>Sonderweg</strong>, in “Archiv für Sozialgeschichte”,<br />
n. 40 (2000), pp. 29-66. Oggi il termine appare piuttosto inflazionato, giacché si è parlato<br />
di «via peculiare» a proposito della Romania (R. Wagner, <strong>Sonderweg</strong> Rumänien: Bericht aus<br />
einem Entwicklungsland, Rotbuch Verlag, Berlin 1991), della Russia (L. Luks, Der russische<br />
„<strong>Sonderweg</strong>“? Aufsätze zur neuesten Geschichte Russlands im europäischen Kontext, Ibidem,<br />
Stuttgart 2005) e non è mancata una «via peculiare italiana», come i tedeschi hanno<br />
riformulato il titolo del volume di P. Ginsborg, Silvio Berlusconi: Television, Power and<br />
Patrimony, Verso, London 2003 (trad. it. Berlusconi: ambizioni patrimoniali in una<br />
democrazia mediatica, Einaudi, Torino 2003) e come attesta la raccolta di saggi a cura di J.<br />
Schmid, Italien - <strong>Sonderweg</strong> oder Modell?, Friedrich, Seelze 2003.<br />
10
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
parlamentarismo, attraverso il quale, con la legittimazione dell’opposizione<br />
politica, vengono poste le basi per la realizzazione della prima moderna<br />
democrazia parlamentare; ed è infine, e soprattutto, il paese della rivoluzione<br />
industriale. In opposizione a questo sviluppo, la Germania apparirà il paese<br />
della tardiva unificazione politica, della parlamentarizzazione bloccata e dell’industrializzazione<br />
a tappe forzate. L’Inghilterra, prototipo di una costruzione<br />
statale che precede l’unificazione nazionale, diventa, a partire dalla<br />
rivoluzione del 1688, un modello di stabilità del sistema istituzionale,<br />
contrassegnato dalla legittimazione dell’opposizione parlamentare e<br />
contenuta radicalizzazione sociale, caratteri che assai meno riscontrabili<br />
nell’altro caso esemplare della storia costituzionale europea, la Francia postrivoluzionaria<br />
5 .<br />
Per ragioni parzialmente diverse, la Francia è spesso assunta a modello di<br />
State-building e Nation-building europei. Proprio il riferimento alla sua storia è<br />
servito a delineare tante ricostruzioni dicotomiche della vicenda istituzionale<br />
dell’Europa continentale: da un lato la Francia, patria dello Stato sovrano<br />
centralizzato, della Rivoluzione, della Repubblica democratica, delle<br />
codificazioni dei diritti civili e politici, dall’altro la Germania, paese del<br />
policentrismo cetuale, del <strong>federalismo</strong>, della Riforma, del principio<br />
monarchico, del potere autocratico della burocrazia e dell’esercito, in una<br />
parola: dell’autoritarismo politico 6 . Ad ogni buon conto, la differenza rispetto<br />
5 D. Elazar, Idee e forme del <strong>federalismo</strong>, Edizioni di Comunità, Milano 1995, p. 33: «Gli<br />
stati nazionali moderni sono di due tipi: quelli che danno identità politica a nazioni<br />
preesistenti e quelli che hanno sviluppato un senso di identità nazionale in concomitanza<br />
con l’acquisizione dell’identità politica, il che rende necessario che gli abitanti del territorio<br />
dello stato acquisiscano una cittadinanza comune come individui. La Germania è un buon<br />
esempio del primo caso. I tedeschi sentivano di essere una nazione prima di avere un unico<br />
Stato <strong>tedesco</strong> (così come lo sentivano nel periodo della divisione tra Est e Ovest); essi si<br />
sono sforzati di raggiungere l’unità politica in modo da poter esprimere meglio i propri<br />
legami nazionali. La Gran Bretagna, invece, ha raggiunto l’unificazione politica come stato<br />
ben prima che la sua popolazione sviluppasse una identità britannica comune; i suoi<br />
governanti hanno usato il legame politico comune per alimentare questo sentimento». Cfr.<br />
H. Berghoff / D. Ziegler (a cura di), Pionier und Nachzügler? Vergleichende Studien zur<br />
Geschichte Großbritanniens und Deutschlands im Zeitalter der Industrialisierung,<br />
Brockmeyer, Bochum 1995.<br />
6 Per un ampio quadro comparativo, diacronico e sincronico, C. Tilly, European Revolutions<br />
1492 – 1992, Blackwell, Oxford 1993 (trad. it. Le rivoluzioni europee 1492-1992, Laterza,<br />
Roma / Bari 1993); Id., Contention and Democracy in Europe, 1650-2000, Cambridge<br />
11
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
alle nazioni-modello occidentali, Francia e Inghilterra, consiste nel fatto che<br />
fino alla seconda metà del XIX secolo l’idea di «nazione tedesca» non si sia<br />
concretizzata in una forza politica capace di vincere la concorrenza per il<br />
dominio e fare della nazione uno Stato unitario.<br />
Spesso il <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> è stato contrapposto sommariamente al<br />
modello occidentale, comprensivo di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti: qui,<br />
come ha osservato Lutz Niethammer, la comparazione appare però<br />
asimmetrica, perché da un lato si opera con un caso concreto, dall’altra con<br />
un tipo ideale 7 . Anche in questo caso, a sostegno della tesi della peculiarità<br />
della Germania rispetto all’insieme delle «democrazie occidentali», si afferma<br />
che in Francia, Inghilterra e Stati Uniti la cultura politica a difesa dei diritti<br />
individuali si è fondata su una tradizione storica dominante, mentre in<br />
Germania, pur non essendo del tutto assente, sino al 1945 è risultata<br />
soccombente rispetto all’autoritarismo politico 8 . In questa specifica accezione,<br />
la tesi del <strong>Sonderweg</strong> serve a concettualizzare il disagio nei confronti di una<br />
dissociazione interna all’Occidente. Tuttavia, più che di <strong>Sonderweg</strong>e si<br />
dovrebbe parlare di percorsi evolutivi distinti, benché dotati dal punto di vista<br />
tipologico e analitico della stessa legittimità; e più che insistere sulla<br />
particolarità dei <strong>Sonderweg</strong>e si dovrebbe riconoscere il carattere eccezionale<br />
della pretesa via normale britannica 9 .<br />
University Press, Cambridge 2004 (trad. it. Conflitto e democrazia in Europa, 1650-2000,<br />
Mondadori, Milano 2007).<br />
7 L. Niethammer, Geht der deutscher <strong>Sonderweg</strong> weiter?, in Id., Deutschland danach.<br />
Postfaschistische Gesellschaft und nationales Gedächtnis, Dietz, Bonn 1999, pp. 201-224.<br />
8 Cfr. H. A. Winkler, Der lange Weg nach Westen, 2 voll., Beck, München 2000 (trad. it.<br />
Grande storia della Germania: un lungo cammino verso Occidente, 2 voll., Donzelli, Roma<br />
2004).<br />
9 H.-J. Puhle, Das atlantische Syndrom. Europa, Amerika und der „Westen“, in J.<br />
Osterhammel / D. Langewiesche / P. Nolte (a cura di), Wege der Gesellschaftsgeschichte<br />
cit., p. 184. Anche un tipico esponente della tesi del <strong>Sonderweg</strong> come H.-U. Wehler,<br />
Deutsches Bildungsbürgertum in vergleichender Perspektive – Elemente eines<br />
„<strong>Sonderweg</strong>s“?, in J. Kocka (a cura di), Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, Klett-Cotta,<br />
Stuttgart 1989, vol. IV, p. 235, ha dovuto convenire: «La via inglese e americana nel mondo<br />
moderno non rappresenta il “caso normale” – inteso come “normativo” –, rispetto al quale<br />
la modernizzazione tedesca, in un qualche momento, è deviata. Piuttosto, è proprio la<br />
particolarissima “via peculiare” inglese ad essere un caso unico da lungo tempo non ancora<br />
chiarito in modo sufficiente».<br />
12
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
Per il suo approdo al totalitarismo nazista, il caso <strong>tedesco</strong> è tuttavia<br />
apparso come l’eclatante anomalia nel corso della civilizzazione occidentale.<br />
La ricerca delle ragioni di quella frattura traumatica del processo di<br />
civilizzazione ha condotto la storiografia a interrogarsi ripetutamente, e in una<br />
certa stagione ossessivamente, sulle peculiarità di tale sviluppo. Si è giunti<br />
così alla conclusione che la via tedesca alla società capitalistica e allo Stato<br />
moderno diverge da quella assunta come «Normalweg» ― il cammino che<br />
conduce alla società di mercato e alla democrazia rappresentativa ― e, in<br />
considerazione del suo esito totalitario, è apparsa non soltanto un<br />
«<strong>Sonderweg</strong>», una via particolare, ma anche un «Irrweg», una via che conduce<br />
all’errore, una «Fehlentwicklung», uno sviluppo deviato 10 .<br />
E’ noto che tale tesi ha rivestito un ruolo centrale nella definizione del<br />
programma di ricerca di quell’indirizzo storiografico che nella Repubblica<br />
Federale di Germania del secondo dopoguerra ha trovato in Hans-Ulrich<br />
Wehler il suo mentore più autorevole 11 , ma che nella storiografia tedesca si<br />
rifaceva ad una tradizione risalente a Weimar (tra i suoi esponenti Hans<br />
Rosenberg, Dietrich Gerhard, Eckart Kehr), che sarebbe proseguita con<br />
Werner Conze, Theodor Schieder, Gerhard A. Ritter e in particolare con<br />
Jürgen Kocka e la cosiddetta “scuola di Bielefeld”. Gli assunti centrali di<br />
questa teoria della modernizzazione deviata, che ha avuto larga fortuna<br />
anche all’estero, riguardano l’assenza o il fallimento di una rivoluzione<br />
borghese; il ritardo nella formazione dello Stato nazionale; la potenza sociopolitica<br />
della burocrazia; la debolezza delle istituzioni parlamentari; lo<br />
strapotere dell’apparato militare; il carattere antipluralistico e illiberale della<br />
cultura politica. Alla luce di questi assunti la Germania si contraddistingue per<br />
10 B. Faulenbach, Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der<br />
Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, Beck, München 1980; Id.,<br />
„Deutscher <strong>Sonderweg</strong>“. Zur Geschichte und Problematik einer zentralen Kategorie des<br />
deutschen geschichtlichen Bewusstseins, in “Aus Politik und Zeitgeschichte”, B 33/81 (1981),<br />
pp. 3-21; H. Grebing, Der «deutsche <strong>Sonderweg</strong>» in Europa 1806-1945. Eine Kritik,<br />
Kohlhammer, Stuttgart 1986.<br />
11 L’opera di riferimento è H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 5 voll., Beck,<br />
München 1987-2008.<br />
13
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
essere divenuta troppo tardi una nazione e uno Stato nazionale, troppo tardi<br />
una società industriale moderna, troppo tardi una democrazia 12 .<br />
Più che per il suo valore euristico, la teoria del <strong>Sonderweg</strong> va del resto<br />
valutata in virtù della sua funzione di auto- ed eterorappresentazione politica<br />
della nazione tedesca. Vi è così chi ha preferito l’uso del concetto<br />
Sonderbewußtsein a quello di <strong>Sonderweg</strong>, proprio per indicare che dietro il<br />
mito di un’oggettiva peculiarità tedesca vi è la realtà di una coscienza<br />
collettiva segnata dall’idea della propria diversità 13 . Alla fine degli anni<br />
Sessanta, ad esempio, il ricorso al concetto di <strong>Sonderweg</strong> è servito a<br />
denunciare la presunta involuzione autoritaria della Bundesrepublik. La<br />
controversa questione delle motivazioni e delle implicazioni politiche<br />
soggiacenti all’interpretazione storica ha poi toccato il culmine nel corso del<br />
cosiddetto Historikerstreit. Le ragioni per le quali negli anni Ottanta si<br />
riaccendeva e divampava un vecchio dibattito risiedevano inequivocabilmente<br />
nel rapporto che si voleva instaurare con il presente. Una parte degli storici<br />
tedeschi intendeva emanciparsi da quella che ormai era divenuta<br />
un’ossessione della storiografia dalla fine del secondo conflitto mondiale;<br />
dopo più di trent’anni, era giunto il momento di tornare alle tradizioni dello<br />
storicismo <strong>tedesco</strong> e domandare non più come si fosse giunti al dominio<br />
nazista, ma cosa fosse effettivamente accaduto. Un’altra parte, per contro,<br />
teneva ferma la tesi della «via peculiare» al fine di mantenere un<br />
atteggiamento critico nei confronti della Bundesrepublik e della domanda di<br />
normalizzazione nazionale.<br />
12 Cfr. R. Dahrendorf, Demokratie und Sozialstruktur in Deutschland, in Id., Gesellschaft und<br />
Freiheit, Piper, München 1961, pp. 260-299; M. R. Lepsius, Demokratie in Deutschland als<br />
historisch-soziologisches Problem, in T. W. Adorno (a cura di), Spätkapitalismus oder<br />
Industriegesellschaft, Enke, Stuttgart 1968, pp. 197-213; J. Kocka, Sozialgeschichte in<br />
Deutschland seit 1945. Aufstieg – Krise – Perspektive, Bonn 2002; T. Welskopp,<br />
Westbindung auf dem „<strong>Sonderweg</strong>“. Die deutsche Sozialgeschichte vom Appendix der<br />
Wirtschaftsgeschichte zur Historischen Sozialwissenschaft, in W. Küttler (a cura di),<br />
Geschichtsdiskurs, vol. V: Globale Konflikte, Erinnerungsarbeit und Neuorientierungen seit<br />
1945, Fischer, Frankfurt a. M. 1999, pp. 191-237.<br />
13 Cfr. l’intervento di Karl Dietrich Bracher all’incontro seminariale tenutosi presso l’Insitut für<br />
Zeitgeschichte di Monaco e riportato in Deutscher <strong>Sonderweg</strong> — Mythos oder Realität?,<br />
Oldenbourg, München 1982, pp. 47-53.<br />
14
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
2. 2. 2. La La La versione versione versione positiva positiva positiva della della tesi tesi tesi del del del <strong>Sonderweg</strong> <strong>Sonderweg</strong><br />
<strong>Sonderweg</strong><br />
In virtù della sua caratterizzazione teleologica, la versione positiva della<br />
tesi del <strong>Sonderweg</strong> ha conosciuto particolare fortuna entro la storia delle idee<br />
e delle ideologie. In quest’ambito può essere utile distinguerne analiticamente<br />
tre dimensioni. La prima individua nel nesso tra Riforma luterana e modernità<br />
la fondamentale cesura della storia sociale e culturale tedesca. La seconda<br />
riconosce invece la grande svolta nazionale nelle guerre di liberazione<br />
antifrancesi, quindi nella stagione dell’Idealismo e nel processo di<br />
autonomizzazione e differenziazione della cultura tedesca dal ceppo<br />
dell’<strong>Il</strong>luminismo europeo. La terza individua nella superiore capacità di<br />
organizzazione socio-politica e di razionalizzazione istituzionale che si<br />
dispiega nel corso dell’Ottocento, soprattutto con la fondazione del Secondo<br />
Reich, la ragione del primato della nazione tedesca in Europa.<br />
Ad inaugurare una nuova epoca, attribuendo pertanto alla Germania<br />
protestante un ruolo centrale nel processo di modernizzazione, è Lutero. La<br />
razionalizzazione, formale e materiale, della società imbocca, in virtù della<br />
Riforma, una via che non implica il ricorso alla violenza rivoluzionaria. Risale<br />
in effetti alla prima modernità il primato della Germania nel processo di<br />
razionalizzazione, che riguarda l’ambito religioso (il Protestantesimo<br />
contrapposto alla “superstizione” cattolica), quello economico (l’apporto della<br />
religione riformata alla razionalizzazione dell’agire economico), quello<br />
politico-amministrativo (con lo sviluppo dell’amministrazione burocratica<br />
poggiante sulla differenziazione istituzionale) e quello scientifico (un tratto<br />
specifico dell’Occidente medievale, l’istituzionalizzazione della scienza nella<br />
forma specifica dell’Università tocca in Germania nel XIX secolo il suo<br />
massimo sviluppo). In particolare, la Germania è il paese della<br />
massimizzazione della razionalità dell’agire amministrativo «tramite la<br />
giuridificazione di norme di comportamento e la verifica delle modalità di<br />
comportamento in base all’adeguamento formale delle norme al diritto<br />
vigente» 14 . E’ nella rottura del Protestantesimo che affondano del resto le loro<br />
14 Così, riprendendo la diagnosi weberiana, M. R. Lepsius, Modernisierungspolitik als<br />
institutionelle Differenzierung, in W. Zapf (a cura di), Probleme der Modernisierungspolitik,<br />
Hain, Meisenheim am Glan 1977, pp. 17-28; trad. it. La politica di modernizzazione come<br />
15
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
radici quelle dicotomie di comunità e società, cultura e civilizzazione,<br />
interiorità ed esteriorità, spirito e politica, che avrebbero profondamente<br />
segnato le Weltanschauungen della nazione tedesca.<br />
<strong>Il</strong> teorema del <strong>Sonderweg</strong> ha poi le sue origini nella storiografia e nella<br />
filosofia del XIX secolo, a partire dalle guerre di liberazione antinapoleoniche,<br />
quando la coscienza nazionale tedesca assume una compatta configurazione,<br />
definendosi in contrapposizione al modello culturale e politico della Francia<br />
postrivoluzionaria. Sulla contrapposizione al modello francese Meinecke<br />
avrebbe fondato la sua ricostruzione dello sviluppo della Kulturnation<br />
tedesca 15 . Nel caso <strong>tedesco</strong> la Kulturnation non è prodotto del Nation-Staat<br />
ma, al contrario, ciò che lo produce. <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> si manifesta nella<br />
genesi dello Stato nazionale non da una storia ed una costituzione comuni,<br />
ma sulla base di un comune patrimonio culturale. E’ opportuno sottolineare<br />
che Meinecke illustra una fondazione “impolitica” della nazione, che, più che<br />
fare riferimento a idioma, religione, costumi ed usi (elementi etnico-culturali),<br />
si basa su progetti e visioni elaborati in circoli letterari o scientifici,<br />
anticipando così una tesi della più recente ricerca sul <strong>nazionalismo</strong>: non tanto<br />
criteri oggettivi come lingua, territorio e provenienza etnica, ma l’«invenzione<br />
di tradizione» da parte delle élites intellettuali costituiscono l’origine delle<br />
nazioni moderne. Si genera qui il topos della nazione di «poeti e pensatori», in<br />
cui la distanza dalla politica ha poco a che fare con il carattere e molto con<br />
la storia tedesca. Allargandosi la forbice tra ristagno politico e vitalità<br />
intellettuale, la cultura sarebbe diventata in Germania, eminentemente, il<br />
«luogo di compensazione per la mancata partecipazione politica» 16 .<br />
All’affermazione del primato della cultura si accompagna l’idealizzazione<br />
della burocrazia come elemento impolitico, sottratto alle bassezze delle fazioni<br />
e del particolarismo. Poiché l’apparato amministrativo si era rivelato la<br />
formazione di istituzioni, in Id., <strong>Il</strong> significato delle istituzioni, il Mulino, Bologna 2006, pp.<br />
59-71, qui p. 63.<br />
15 La contrapposizione, tutt’oggi corrente, tra Kulturnation e Staatsnation risale all’opera di<br />
Friedrich Meinecke Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen<br />
Nationalstaates (1908), in Id., Werke, vol. V, Oldenbourg, München 1962 (trad. it.<br />
Cosmopolitismo e stato nazionale. Studi sulla genesi dello stato nazionale <strong>tedesco</strong>, La Nuova<br />
Italia, Perugia / Venezia 1930). Cfr. G. Schmidt, Friedrich Meineckes Kulturnation. Zum<br />
historischen Kontext nationaler Ideen in Weimar-Jena um 1800, in “Historische Zeitschrift”,<br />
284 (2007), pp. 597-621.<br />
16 W. Lepenies, Kultur und Politik. Deutsche Geschichten, Hanser, München 2006, p. 46.<br />
16
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
grande risorsa dello Stato prussiano, la teoria moderna dello Stato<br />
burocratico razionale, da Hegel a Hintze e Weber, ha sempre rivolto<br />
particolare attenzione all’evoluzione dell’amministrazione. Della sintesi di<br />
statalismo, idea nazionale ed etica luterana la filosofia politica hegeliana offre<br />
la più alta espressione. Nei Lineamenti di filosofia del diritto (1821), Hegel<br />
teorizza uno Stato compiutamente razionale nella forma della monarchia<br />
costituzionale e centrato sulla burocrazia, cui si deve accedere per merito. Al<br />
ceto dei funzionari, quale «classe universale» capace di ricondurre gli interessi<br />
particolari della società all’interesse generale dello Stato, spetta non soltanto<br />
il potere governativo, ma anche quello giudiziario e di polizia 17 . Da Hegel a<br />
Treitschke, la convinzione della superiorità del modello della monarchia<br />
costituzionale ha dominato l’Ottocento <strong>tedesco</strong>. Anche un critico<br />
dell’autoritarismo bismarckiano e della monarchia guglielmina come Max<br />
Weber avrebbe fino alla fine affermato la superiorità dell’amministrazione<br />
burocratica rispetto al dilettantismo delle democrazie.<br />
Contro la corruzione parlamentare, contro gli eccessi giacobini, contro la<br />
democrazia dei partiti il modello <strong>tedesco</strong> viene configurandosi come<br />
laboratorio di mediazione dei conflitti sociali centrato sulla statualità. Questa<br />
<strong>Sonderweg</strong>sthese è d’impronta conservatrice, anzi si può dire che faccia<br />
tutt’uno con l’interpretazione conservatrice della storia tedesca e la sua<br />
polemica con il liberalismo anglosassone e la democrazia plebea dei paesi<br />
latini: fra i suoi capisaldi la teoria di uno Stato forte come Stato etico, la<br />
fondazione del Reich “dall’alto”, la subordinazione del Parlamento, la<br />
marginalizzazione dei partiti. Ma anche per gli storici nazional-liberali<br />
«<strong>Sonderweg</strong>» significava la via “alternativa”, ma feconda, percorsa dai<br />
tedeschi verso la modernità: lo sviluppo successivo alla rivoluzione del 1848<br />
17 <strong>Il</strong> pluralismo delle associazioni politiche è considerato da Hegel mero particolarismo a<br />
fronte della legittima funzione unificatrice dello Stato, la sola in grado di garantire<br />
l’integrazione della nazione. «<strong>Il</strong> mantener fermo l’interesse universale dello Stato e della<br />
legalità nei diritti particolari e la riconduzione dei medesimi a quell’interesse universale<br />
richiede una cura da parte di delegati del potere governativo, gli impiegati esecutivi dello<br />
Stato e le superiori autorità deliberanti, in quanto costituite collegialmente, che convergono<br />
nei culmini supremi aventi contatto con il monarca» (G. W. F. Hegel, Grundlinien der<br />
Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse (1821), in Id.,<br />
Werke in zwanzig Bände, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1970, vol. VII; trad. it. Lineamenti di<br />
filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello Stato in compendio, Laterza, Roma / Bari<br />
2000, § 289, p. 233).<br />
17
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
era inteso come un processo finalizzato alla realizzazione del modello<br />
monarchico-costituzionale ideato da Bismarck, ritenuto migliore del<br />
parlamentarismo inglese; l’ethos prussiano del servizio veniva contrapposto<br />
all’eudemonismo occidentale; anche sul versante economico si riteneva che<br />
la Germania avesse imboccato una strada più proficua dell’Inghilterra,<br />
mettendo il paese al riparo dalle patologie sociali che avevano<br />
accompagnato la prima rivoluzione industriale; la precoce istituzione di uno<br />
Stato sociale scongiurava i rischi del laisser-faire e della plutocrazia di altri<br />
paesi occidentali.<br />
Dopo la fondazione del Secondo Reich, la storiografia elaborò una<br />
teleologia della storia tedesca per la quale i secoli XVIII e XIX rappresentavano<br />
un processo finalizzato alla costruzione del 1871. Soprattutto nell’epoca<br />
guglielmina, in risposta alle tensioni socio-politiche, ciò si accompagnò<br />
all’ideologizzazione della struttura del Reich: il sistema monarchicocostituzionale<br />
venne consacrato come modello costituzionale tipicamente<br />
<strong>tedesco</strong>, superiore al parlamentarismo occidentale inficiato dal particolarismo<br />
egoistico dei partiti. Al tempo stesso si diede una chiara definizione della<br />
cultura tedesca, incentrata sull’esaltazione dell’Idealismo, del Romanticismo e<br />
dello Storicismo. Anche Thomas Mann, il cui giudizio sul passato sarebbe<br />
mutato radicalmente a seguito della tragica esperienza del regime<br />
nazionalsocialista, s’inserisce nella tradizione della Selbstdeutung tedesca,<br />
ossia dell’interpretazione di sé come autorappresentazione nazionale.<br />
Un’idealizzazione del <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> in chiave positiva sono le<br />
Considerazioni di un impolitico, che egli scrisse e pubblicò nel corso della<br />
prima guerra mondiale, sostenendo in nome del Kulturpatriotismus la<br />
superiorità dello spirito <strong>tedesco</strong> sullo spirito politico delle democrazie<br />
occidentali 18 . La peculiarità ideologica va inquadrata nell’ambito della<br />
contrapposizione tra Kultur tedesca e Zivilisation occidentale, che troverà,<br />
come è noto, in Spengler la sua codificazione definitiva 19 .<br />
18<br />
T. Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Fischer, Berlin 1918 (trad. it. Adelphi,<br />
Milano 1997).<br />
19<br />
Sulla contrapposizione Kultur-Zivilisation nella Germania prima e durante la prima guerra<br />
mondiale, B. Beβlich, Wege in den “Kulturkrieg”. Zivilisationskritik in Deutschland 1890-<br />
1914, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2000.<br />
18
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
La tesi di un <strong>Sonderweg</strong> positivo persistette anche dopo la «catastrofe<br />
nazionale». Lo storico Rudolf Stadelmann respinse il giudizio espresso dalle<br />
altre nazioni nei confronti della Germania come «il popolo senza rivoluzione»,<br />
individuando la ragione dell’immunità tedesca ai sommovimenti rivoluzionari<br />
non nell’arretratezza politica, bensì, al contrario, nel vantaggio storico<br />
costituito dall’Assolutismo illuminato dei principati tedeschi. Ad essi si doveva<br />
il «più onorevole e irremovibile contributo alla storia costituzionale moderna,<br />
ma al tempo stesso, il marchio incancellabile che escluse i tedeschi dalla<br />
condivisione degli ideali dell’Europa occidentale. Detto in forma paradossale:<br />
non la reazione tedesca, bensì il progresso <strong>tedesco</strong> ha respinto la Germania<br />
dall’Occidente» 20 . Gran parte della storiografia costituzionale dell’ultimo<br />
cinquantennio avrebbe in fondo preso le mosse di qui per ricostruire l’apporto<br />
della storia e della dottrina tedesche alla costruzione dello Stato di diritto<br />
europeo 21 .<br />
3. 3. La La versione versione negativa negativa della della tesi tesi del del <strong>Sonderweg</strong><br />
<strong>Sonderweg</strong><br />
Anche per la definizione della tesi del <strong>Sonderweg</strong> nella sua accezione<br />
negativa si può risalire molto indietro nel tempo, forse alla definizione<br />
pufendorfiana del Reich come «mostro» giuridico. Ma un’elaborazione<br />
sociologicamente articolata della tesi – il nucleo del teorema della storia<br />
sociale della seconda metà del XX secolo – la si ritrova nella sinistra hegeliana<br />
e in particolare negli scritti di Marx ed Engels. Dall’Ideologia tedesca in avanti<br />
ricorre nei loro scritti una diagnosi dei rapporti sociali tedeschi che insiste sui<br />
tratti dell’arretratezza feudale, del filisteismo borghese e dell’idealizzazione del<br />
dominio burocratico (anche se negli anni Cinquanta ad essa si affiancherà,<br />
relativizzandola, l’analisi del bonapartismo non tanto come <strong>Sonderweg</strong><br />
francese, ma come tentativo di ricondurre ad uno schema unitario di<br />
20 R. Stadelmann, Deutschland und Westeuropa, Steiner, Schloß Laupheim 1948, p. 28.<br />
21 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, Beck, München 1999 (trad. it. Storia del potere<br />
politico in Europa, il Mulino, Bologna 2001); H. Fenske, Der moderne Verfassungsstaat. Eine<br />
vergleichende Geschichte von der Entstehung bis zum 20. Jahrhundert, Schöningh,<br />
Paderborn 2001.<br />
19
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
spiegazione le modalità di evoluzione politica delle società capitalistiche<br />
divergenti dal modello inglese).<br />
Nell’esame della rivoluzione fallita del 1848, Marx ed Engels<br />
richiamarono l’attenzione sul fatto che la classe mercantile e industriale<br />
tedesca era troppo debole per governare in prima persona e pertanto era<br />
rimasta subordinata all’aristocrazia terriera e alla burocrazia regia, in cambio<br />
del diritto di fare denaro. Osservando che la Germania aveva condiviso le<br />
«doglie» dello sviluppo capitalistico europeo senza tuttavia goderne i frutti, il<br />
giovane Marx profetizzò che il suo paese si sarebbe un giorno trovato «al<br />
livello della decadenza europea senza essersi mai trovato al livello dell’emancipazione<br />
europea» 22 . Ed Engels, alla vigilia del ’48, osservava che «l’ordinamento<br />
attuale della Germania non è altro che un compromesso fra la<br />
nobiltà e i piccoli borghesi, il quale finisce per lasciare l’amministrazione nelle<br />
mani di una terza classe: la burocrazia. […] La nobiltà, che rappresenta il<br />
settore più importante della produzione, si riserva i posti più alti, mentre la<br />
piccola borghesia si contenta di quelli più bassi, e solo di rado riesce a<br />
portare i suoi candidati negli alti ranghi dell’amministrazione». Ma gli interessi<br />
della piccola borghesia, che si sentiva tutelata da una burocrazia potente,<br />
erano in contraddizione con quelli della borghesia industriale, impedita nel<br />
suo decollo dalle vessazioni dello schiacciante apparato amministrativo 23 .<br />
La tesi dell’immaturità politica della borghesia tedesca sarebbe stata<br />
ripresa a fine secolo da Max Weber. Nella celebre prolusione Lo Stato<br />
nazionale e la politica economica tedesca, tenuta a Friburgo nella primavera<br />
del 1895, Weber osservava: «in ogni epoca è sempre stato il conseguimento<br />
della potenza economica ciò che ha fatto nascere in una classe l’idea della<br />
sua candidatura alla guida politica. E’ pericoloso e alla lunga inconciliabile<br />
con l’interesse della nazione il fatto che una classe economicamente<br />
declinante conservi il potere politico. Ma ancora più pericoloso è il caso in cui<br />
le classi verso le quali si sposta la potenza economica e con ciò l’aspirazione<br />
al potere politico, non siano ancora politicamente mature per guidare lo<br />
22 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, in Id. / F. Engels, Werke, Dietz,<br />
Berlin 1988, vol. I, pp. 378-391; trad. it. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico,<br />
Editori Riuniti, Roma 1983, p. 431.<br />
23 F. Engels, Der Status quo in Deutschland (1847), in MEW cit., vol. IV (1990), pp. 44-45;<br />
trad. it. parziale in I. Fetscher (a cura di), <strong>Il</strong> marxismo. Storia documentaria, Feltrinelli, Milano<br />
1970, pp. 39-41.<br />
20
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
Stato. Al momento, tutte e due le cose minacciano la Germania ed in verità è<br />
questa la chiave per comprendere i pericoli che attualmente corriamo in<br />
questa situazione» 24 . Max Weber criticava la cosiddetta «feudalizzazione» della<br />
borghesia tedesca, secondo cui ampi settori dell’alta borghesia accettavano il<br />
dominio aristocratico nella sfera politica e culturale, anziché avanzare una<br />
domanda di potere contro nobiltà e burocrazia.<br />
A partire da Weber la specificità della condizione tedesca è stata<br />
tematizzata in riferimento al Secondo Reich. Nel corso di pochi decenni il<br />
Secondo Reich divenne una potenza industriale dominante nel continente,<br />
mantenendo, però, un ordinamento sociale in larga misura preindustriale,<br />
egemonizzato dall’aristocrazia prussiana e da una borghesia con tratti ancora<br />
feudali, amministrato da una burocrazia paternalistica e ispirata da una<br />
morale pubblica autoritaria. Integrando la spiegazione marxiana con quella<br />
weberiana, Ralf Dahrendorf ha individuato le ragioni del fallimento <strong>tedesco</strong><br />
nella debolezza delle forze sociali progressiste, borghesia e classe operaia 25 .<br />
Questa tesi di un <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> ha quindi una duplice implicazione: il<br />
carattere autoritario del processo di unificazione nazionale e l’incapacità, per<br />
così dire genetica, del “giovane” Stato nazionale di avviare con successo il<br />
processo di democratizzazione, il che lo distinguerebbe dal modello delle<br />
nazioni occidentali.<br />
Una variante di questa linea interpretativa ha tematizzato il rapporto tra<br />
Nation-building e State-building, ovvero l’asincronicità (Ungleichzeitigkeit) tra<br />
la nazione culturalmente intesa (il sentimento di comunanza condiviso dai suoi<br />
membri e radicato in esperienze storiche, nella lingua e nella letteratura, in<br />
tradizioni e usanze) e la costruzione di un’organizzazione politico-statale. <strong>Il</strong><br />
modello interpretativo che ha plasmato l’autorappresentazione dei tedeschi è<br />
qui quello proposto dal filosofo Helmuth Plessner, secondo il quale la<br />
24 M. Weber, Lo Stato nazionale e la politica economica tedesca, in Id., Scritti politici, Roma,<br />
Donzelli 1998, p. 22. Cfr. W. J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik 1890-<br />
1920, Mohr, Tübingen 1959 (trad. it. Max Weber e la politica tedesca 1890-1920, il<br />
Mulino, Bologna 1993).<br />
25 R. Dahrendorf, Demokratie und Sozialstruktur in Deutschland cit., p. 269: «la borghesia<br />
classica aveva bisogno della democrazia per potenziare e garantire con l’egemonia politica<br />
la posizione economica ottenuta con le proprie forze. Essa si trovava in conflitto con<br />
l’aristocrazia feudale e il suo Stato paternalistico-autoritario. Ma la storia tedesca non<br />
conosce una tale borghesia classica».<br />
21
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
Germania è una «nazione in ritardo» rispetto agli Stati nazionali occidentali, in<br />
particolare Francia ed Inghilterra, e il cui distacco divenne impossibile da<br />
colmare a partire dalla guerra dei Trent’anni 26 . Tutti i tentativi successivi di<br />
modernizzazione, in particolare durante l’industrializzazione, non riuscirono<br />
mai a sviluppare quella cultura politica che si richiama ad uno Stato<br />
nazionale. <strong>Il</strong> ritardo storico dei tedeschi consisterebbe dunque nell’aver<br />
acquisito un’identità nazionale soltanto nel XIX secolo, mancando così di<br />
edificare lo Stato nazionale sulle fondamenta culturali dell’<strong>Il</strong>luminismo: «La<br />
differenza essenziale tra i tedeschi e i popoli del vecchio Occidente, che<br />
hanno trovato la base del proprio Stato nazionale nel XVI e XVII secolo e<br />
possono guardare (a differenza di noi) ad un’“epoca d’oro”, consiste in<br />
questo slittamento temporale, che ha impedito una connessione interna tra le<br />
forze dell’<strong>Il</strong>luminismo e la formazione dello Stato nazionale in Germania» 27 .<br />
Durante la prima guerra mondiale, quando già appare chiara la<br />
dimensione della sconfitta, prende forma sociologica, in particolare con l’impietosa<br />
diagnosi weberiana del Reich guglielmino, la tesi di una anomalia<br />
patologica della Germania. Questa consapevolezza della propria diversità<br />
acquista particolare rilevanza dopo il crollo dell’Impero nel novembre 1918.<br />
Nell’età weimariana l’idea di uno sviluppo culturale e politico non soltanto<br />
diverso, ma opposto a quello delle nazioni europee occidentali appartiene<br />
ormai all’autointerpretazione della cultura politica tedesca 28 . Negli ambienti<br />
conservatori, la sconfitta viene compensata dall’avversione nei confronti del<br />
sistema di norme e valori affermato dai vincitori e quindi anche della<br />
Repubblica di Weimar, la cui forma costituzionale viene percepita come la<br />
brutta copia dei sistemi politici occidentali. Con l’inasprimento della polemica<br />
contro l’ideologia democratica occidentale sorge una storiografia critica nei<br />
26<br />
<strong>Il</strong> saggio fu scritto nel 1933 per un ciclo di lezioni tenute a Groningen e fu pubblicato nel<br />
1935 con il titolo «Das Schicksal deuschen Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche».<br />
Nella riedizione, attualizzata, del 1959, il filosofo definì la sua opera «un contributo alla<br />
storia culturale del <strong>nazionalismo</strong> <strong>tedesco</strong>» (H. Plessner, Die verspätete Nation. Über die<br />
politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1974).<br />
27<br />
H. Plessner, Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen Geistes<br />
cit., p. 14.<br />
28<br />
Cfr. R. Vierhaus, Die Ideologie eines deutschen Weges der politischen und sozialen Entwicklung,<br />
in R. v. Thadden (a cura di), Die Krise des Liberalismus zwischen den Weltkriegen,<br />
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1978, pp. 96-114; B. Faulenbach, Ideologie des<br />
deutschen Weges cit.<br />
22
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
confronti della teoria apologetica del «deutscher <strong>Sonderweg</strong>». Eckart Kehr<br />
vede nella cristallizzazione delle vecchie élites e nella mancata<br />
democratizzazione la causa del militarismo della politica tedesca e il suo<br />
sbocco nella prima guerra mondiale. Non è un caso che alle sue tesi si<br />
sarebbe rifatto Fritz Fischer in quel libro del 1961, Assalto al potere mondiale,<br />
che avrebbe dato vita al primo Historikerstreit del dopoguerra e avrebbe<br />
inaugurato una stagione di ricerche sul militarismo <strong>tedesco</strong> culminata nei<br />
volumi sui crimini della Wehrmacht nella seconda guerra mondiale.<br />
Ma è a partire dal secondo dopoguerra che la variante critica della<br />
<strong>Sonderweg</strong>sthese domina il dibattito storiografico. Se la sconfitta del 1918 era<br />
stata inclusa nel quadro di un complessivo «tramonto dell’Occidente» 29 , la<br />
capitolazione del 1945 pareva annunciare persino la «fine della storia» 30 , o<br />
meglio, di quella storia. Trova qui collocazione la volontà di “riscrivere” la<br />
storia nazionale come parte integrante di un progetto politico-pedagogico che<br />
va sotto il nome di Vergangenheitsbewältigung ossia rielaborazione, intesa<br />
come superamento, del passato. La versione critico-negativa del <strong>Sonderweg</strong><br />
tenta ora di rispondere alla domanda del perché la Germania, a differenza<br />
degli altri paesi europei, fosse degenerata in una dittatura totalitaria. L’esito di<br />
questa riflessione sul tragico destino dello Stato nazionale <strong>tedesco</strong> è il<br />
nocciolo del teorema del <strong>Sonderweg</strong>.<br />
<strong>Il</strong> dibattito degli anni Sessanta e Settanta si è concentrato in particolar<br />
modo sulle condizioni specifiche in cui è avvenuta la modernizzazione in<br />
Germania e sul ruolo svolto in questo sviluppo dalla classe borghese. Ralf<br />
Dahrendorf ha colto le ragioni della debolezza del liberalismo <strong>tedesco</strong><br />
principalmente nelle modalità del processo di industrializzazione, la quale<br />
anziché produrre la trasformazione delle strutture politiche e socio-culturali<br />
tradizionali, vi ha aderito. Storici come Dietrich Rüschemeyer hanno parlato a<br />
questo proposito di «modernizzazione parziale»: ad uno sviluppo economico e<br />
tecnologico non è corrisposto in Germania un analogo sviluppo politico e<br />
29 O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der<br />
Weltgeschichte (1923), Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999 (trad. it. <strong>Il</strong> tramonto<br />
dell’occidente, Longanesi, Milano 1957).<br />
30 Cfr. L. Niethammer, Posthistoire: ist die Geschichte zu Ende?, Rowohlt, Reinbeck 1989.<br />
23
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
sociale 31 . Riprendendo questa argomentazione, Hans-Ulrich Wehler ha<br />
dedicato gran parte della sua opera a mostrare come la struttura sociale e<br />
politica della Germania mantenne essenzialmente le sue forme pre-industriali:<br />
la borghesia non soltanto aveva rinunciato alla trasformazione della sua<br />
superiorità economica in dominio politico, ma si era sottomessa al potere<br />
tradizionale di Junker, burocrazia ed esercito; a fronte di una rapida<br />
modernizzazione tecnologico-economica permaneva l’arretratezza sociale e<br />
politica 32 .<br />
4. 4. <strong>Il</strong> <strong>Il</strong> <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>Sonderweg</strong> luterano<br />
luterano<br />
La storiografia moderna ha a lungo insistito, com’è noto, sulla centralità<br />
della Riforma per spiegare caratteri e fenomeni considerati tipici del mondo<br />
<strong>tedesco</strong> moderno. In primo luogo, al Luteranesimo si deve quella che è stata<br />
chiamata «l’invenzione dell’interiorità» 33 . Diversamente dal Calvinismo e dal<br />
Cattolicesimo, la fede è indipendente dall’agire esteriore, dalla prestazione,<br />
dal mondo delle istituzioni e del diritto. La persuasione che si forma nella<br />
lettura delle Scritture è per il luterano l’istanza decisiva. Al posto dell’eteronomia<br />
ecclesiastica (la Chiesa come «istituzione per la salvezza») interviene<br />
l’autonomia della coscienza individuale, che si orienta sulla parola di Dio. Per<br />
l’autodefinizione cultural-religiosa del Protestantesimo <strong>tedesco</strong> sono<br />
determinanti concetti che riflettono una forte tendenza alla spiritualizzazione,<br />
all’interiorizzazione, all’individualizzazione: «fede del cuore», «coscienza»,<br />
«interiorità» e — dal XVIII secolo — «personalità», «soggettività», «autonomia».<br />
31 D. Rüschemeyer, Partielle Modernisierung, in W. Zapf (a cura di), Theorien des sozialen<br />
Wandels, Kiepenheuer & Witsch, Köln / Berlin 1970, pp. 382-396; Id., Modernisierung und<br />
die Gebildeten im kaiserlichen Deutschland, in P. C. Ludz (a cura di), Soziologie und<br />
Sozialgeschichte: Aspekte und Probleme, Westdeutscher Verlag, Opladen 1973, pp. 515-<br />
529.<br />
32 H.-U. Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen<br />
1973 (trad. it. L’impero guglielmino 1871-1918, De Donato, Bari 1981); Id., «Deutscher<br />
<strong>Sonderweg</strong>» oder allgemeine Probleme des westlichen Kapitalismus? Zur Kritik an einigen<br />
„Mythen deutscher Geschichtsschreibung“, in “Merkur”, 35 (1981), pp. 478-487; Id., Wie<br />
„bürgerlich“ war das Deutsche Kaiserreich, in: J. Kocka (a cura di), Bürger und Bürgerlichkeit<br />
im 19. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1987, pp. 243-280.<br />
33 F. W. Graf, Der Protestantismus. Geschichte und Gegenwart, Beck, München 2006, pp.<br />
71-73.<br />
24
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
Con il «principio dell’interiorità», quale fondamento della religione<br />
protestante, Hegel indicava una indisponibilità del soggetto credente verso<br />
qualunque approccio che tenti di oggettivarlo 34 .<br />
In secondo luogo, con il suo carattere intellettualistico il Luteranesimo ha<br />
dato un impulso essenziale all’istruzione. Nei paesi riformati la scolarizzazione<br />
è sempre stata molto elevata, promossa dallo Stato con l’introduzione dell’obbligazione<br />
scolastica. A partire dal XVIII secolo il sistema d’istruzione<br />
protestante era all’avanguardia, mentre il mondo cattolico registrava un<br />
deficit formativo. Specificamente luterano era lo stretto legame con<br />
l’Università e la scienza: i pastori erano teologi dalla formazione universitaria;<br />
giuristi e funzionari ricevevano un’educazione dalla spiccata impronta<br />
teologica. Per questo, la connessione tra teologia, Università e Stato<br />
burocratico-amministrativo è un tipico fenomeno <strong>tedesco</strong>. L’assenza di una<br />
Chiesa istituzionale a difesa della tradizione, che impone i limiti<br />
dell’ortodossia e censura il dissenso, come è avvenuto nei paesi cattolici, ha<br />
favorito enormemente lo sviluppo scientifico 35 . Già dal XVII secolo i paesi<br />
protestanti rappresentavano la punta più avanzata della scienza moderna. «<strong>Il</strong><br />
fatto che in Germania i professori universitari abbiano esercitato un ruolo<br />
guida, che appartenga al carattere dei tedeschi avere anzitutto una<br />
34 «L’antica intimità del popolo <strong>tedesco</strong>, serbatasi intatta, deve attuare questo<br />
sconvolgimento a partire dal cuore semplice, schietto. Mentre il resto del mondo partiva alla<br />
volta delle Indie Orientali, dell’America […] ecco un semplice monaco trovare questa cosa<br />
che la cristianità aveva cercato una volta in un sepolcro terreno, di pietra, e trovarla in un<br />
altro sepolcro, nel sepolcro più profondo dell’assoluta idealità di ogni cosa sensibile,<br />
esteriore, trovarla nello spirito e mostrarla nel cuore […]. La semplice dottrina di Lutero è<br />
che questa cosa, la soggettività infinita, ossia l’autentica spiritualità, Cristo, non è in nessun<br />
modo presente e reale in una fattispecie esteriore, bensì è attinta come cosa spirituale» (G.<br />
W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1837), in: Id., Werke in<br />
zwanzig Bände cit., vol. XII (1970); trad. it. Lezioni sulla filosofia della storia, Nuova Italia,<br />
Firenze 1963, p. 339).<br />
35 Già Benjamin Nelson aveva stabilito una connessione tra la religione protestante e il<br />
moderno ideale di scienza basato sulla certezza logico-empirica (B. Nelson, On the Roads<br />
to Modernity: Conscience, Science, and Civilizations. Selected Writings, Rowman & Littlefield,<br />
Totowa 1981). Lepsius ha ribadito che «nel XIX secolo la Germania cattolica partecipava al<br />
discorso culturale e al processo scientifico in misura assai più ridotta di quella protestante»<br />
(M. R. Lepsius, Bürgertum als Gegenstand der Sozialgeschichte, in Id., Demokratie in<br />
Deutschland, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993, p. 298).<br />
25
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
convinzione, un’opinione, una visione del mondo, è una conseguenza della<br />
cultura luterana» 36 .<br />
In terzo luogo, il Luteranesimo ha soppresso l’ascesi monacale e,<br />
diversamente da Calvinismo e Puritanesimo, ha concepito il lavoro quotidiano<br />
come servizio reso a Dio e al prossimo, senza rimanere condizionato dal<br />
raggiungimento del successo. Al contrario che nel Cattolicesimo, la vita<br />
contemplativa non vi ha alcuna preminenza e la povertà non gode di<br />
legittimazione religiosa; anche la riscossione inoperosa di rendite viene<br />
discreditata. <strong>Il</strong> lavoro svolge una funzione sociale e morale, in quanto forma<br />
alla disciplina, al senso del dovere, alla scrupolosità. La concezione del<br />
lavoro come vocazione nella quale l’esistenza trova senso, adempimento,<br />
soddisfazione ha intensificato l’apporto dei luterani al mondo dell’industria e<br />
della tecnica.<br />
Ora, questa connessione tra Riforma e modernizzazione sociale e politica,<br />
affermata sulla base della «libertà protestante», ha faticato a perdere la sua<br />
presunta ovvietà, messa in discussione dalla sociologia della religione e dai<br />
teologi della «Lutherrenaissance». Sarà, fra i primi, Ernst Troeltsch a sostenere<br />
che «una gran parte dei fondamenti del mondo moderno nello Stato, nella<br />
società, nell’economia, nella scienza e nell’arte è sorta in modo<br />
completamente indipendente dal Protestantesimo, in parte semplicemente<br />
come prosecuzione di sviluppi tardomedievali, in parte come conseguenza del<br />
Rinascimento» 37 . A partire da qui la storiografia è venuta evidenziando una<br />
discontinuità tra Lutero e il mondo moderno della razionalità,<br />
dell’individualismo, della democrazia, che sposta il momento di cesura nel<br />
XVIII secolo. La storicizzazione della Riforma e la dissoluzione di un quadro<br />
storico normativo ha così finito per rendere sempre più difficili i richiami ai<br />
grandi fondatori del Protestantesimo in funzione di legittimazione politicoteologica,<br />
sottolineando invece gli aspetti di continuità della storia<br />
ecclesiastica, ponendo in evidenza le analogie strutturali con i movimenti di<br />
riforma nell’alveo del Cattolicesimo.<br />
36 T. Nipperdey, Luther und die moderne Welt, in Id., Nachdenken über die deutsche<br />
Geschichte. Essays, Beck, München 1986, pp. 31-43, qui p. 38.<br />
37 E. Troeltsch, Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt<br />
(1906/1911), in Id., Kritische Gesamtausgabe, de Gruyter, Berlin 2001, vol. VIII, pp. 199-<br />
316, qui p. 223.<br />
26
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
A partire dagli anni Settanta la svolta riformista del XVI secolo non appare<br />
più come specificità della storia tedesca, ma come vicenda che riguarda<br />
l’Europa; non è più solo oggetto della storia della Chiesa, ma della storia<br />
culturale, sociale, politica; non è più un evento cronologicamente circoscritto,<br />
bensì parte di quel mutamento di lungo periodo che ha dato luogo alla<br />
modernità, nel senso di Max Weber o Norbert Elias 38 . <strong>Il</strong> paradigma scientifico<br />
della «confessionalizzazione», introdotto dagli studiosi tedeschi negli anni<br />
1980-90, è inteso come processo sociale all’interno del quale il<br />
consolidamento dogmatico e istituzionale delle Chiese ha agito quale motore<br />
per la trasformazione profonda della vita culturale, politica e sociale. Tale<br />
processo di trasformazione — riconoscibile in tutte le confessioni e a ogni<br />
livello sociale a partire dal XVI secolo — è consistito nel tentativo di imporre<br />
una burocratizzazione e un disciplinamento dei fedeli e dei sudditi nel<br />
processo di formazione e consolidamento dello Stato 39 .<br />
La tesi secondo cui il <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong> ha la sua radice nell’eccezionalità<br />
del Luteranesimo ne risulta profondamente ridimensionata in due sensi.<br />
Anzitutto, come avevano già sostenuto Nietzsche e Troeltsch, Lutero non può<br />
essere considerato il padre della modernità, perché, pur anticipando le<br />
istanze individualistiche dell’uomo moderno, per molti aspetti del suo pensiero<br />
resta legato al mondo medievale. Se Lutero tuonava contro il Medioevo del<br />
papato e della Scolastica, non meno veementemente combatteva contro<br />
l’Umanesimo, il razionalismo, la secolarizzazione dello Stato e della società.<br />
Inoltre, la Riforma non può essere considerata l’inizio di una nuova era<br />
perché rappresenta il culmine di un processo di trasformazione ecclesiasticoreligiosa<br />
cominciato molto tempo prima. <strong>Il</strong> tardo Medioevo e i primi due<br />
secoli dell’età moderna sono apparsi un’epoca di mutamento per molti aspetti<br />
38 H. Schilling, Am Anfang war Luther, Loyola und Calvin, ein religionssoziologisch-entwicklungsgeschichtlicher<br />
Vergleich, in: Id., Ausgewählte Abhandlungen zur europäischen Reformations-<br />
und Konfessionsgeschichte, Duncker & Humblot, Berlin 2002, pp. 3-10.<br />
39 Amplissima la letteratura a riguardo, tra cui: H. R. Schmidt, Konfessionalisierung im 16.<br />
Jahrhundert, Oldenbourg, München 1992; H.-C. Rublack (a cura di), Die lutherische<br />
Konfessionalisierung in Deutschland, Mohn, Gütersloh 1992; K. v. Greyerz,<br />
Interkonfessionalität - Transkonfessionalität - binnenkonfessionelle Pluralität: neue<br />
Forschungen zur Konfessionalisierungsthese, Mohn, Gütersloh 2003; W. Reinhard, Glaube<br />
und Macht: Kirche und Politik im Zeitalter der Konfessionalisierung, Herder, Freiburg i. Br.<br />
2004; G. Seebass, Spätmittelalter – Reformation – Konfessionalisierung, Kohlhammer,<br />
Stuttgart 2006.<br />
27
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
unitaria, tanto da venir denominati «fase della modernizzazione veteroeuropea»<br />
40 . Oggi molti storici sono concordi nell’affermare che non soltanto<br />
la Riforma, ma anche i movimenti religiosi tardomedievali e la stessa<br />
confessionalizzazione cattolica abbiano agito in chiave di rinnovamento. L’immagine<br />
del Protestantesimo come rottura rivoluzionaria nei confronti di una<br />
Chiesa romana superata dai tempi, incapace di mutamento, è stata<br />
rovesciata, al punto che la Riforma tedesca viene sempre più spesso intesa<br />
come «reazione ad una crisi di modernizzazione», provocata dai tentativi di<br />
rinnovamento compiuti dal papato a partire dalla metà del XV secolo.<br />
Superato il trauma della Riforma, nella seconda metà del XVI secolo la Chiesa<br />
cattolica poté rifarsi a quella esperienza per stare al passo della confessionalizzazione<br />
protestante, servendosi tanto degli strumenti offerti dalla<br />
riforma tardomedievale degli ordini (si pensi al ruolo dei francescani in<br />
Europa) quanto delle nuove forme di organizzazione e di spiritualità elaborate<br />
dai gesuiti 41 .<br />
In secondo luogo, se dal XVI secolo la storia delle Chiese europee è stata<br />
interpretata come storia della loro reciproca concorrenza e opposizione, oggi<br />
l’attenzione è rivolta non tanto alle differenze tra le singole confessioni,<br />
quanto piuttosto alle loro analogie funzionali e strutturali. Si tratta di definire il<br />
ruolo che ebbe la religione nel dare impulso o frapporre ostacoli al lungo<br />
mutamento al termine del quale è sorta la società borghese del XIX secolo.<br />
Lutero non è una figura atipica, ma simile ad altri riformatori: «all’inizio<br />
dell’Europa moderna […] vi erano Lutero, Loyola e Calvino». Si è dimostrata<br />
errata la contrapposizione, diffusa nella storiografia nazionalistica, tra la forza<br />
40 Tale denominazione è stata utilizzata dal medievista Peter Moraw e, soprattutto, dal<br />
modernista Heinz Schilling. Questa tesi di continuità elaborata in particolare dalla<br />
Sozialgeschichte contrasta con l’idea tradizionale che la Riforma rappresenti la linea di<br />
confine tra il Medioevo e l’epoca moderna: cfr. H. Schilling, Die Reformation – ein<br />
revolutionärer Umbruch oder Hauptetappe eines langfristigen reformierenden Wandels?, in<br />
W. Speitkamp / H. P. Ullmann (a cura di), Konflikt und Reform. Festschrift für Helmuth<br />
Berding, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1995, pp. 26-40.<br />
41 H. Schilling, Am Anfang war Luther, Loyola und Calvin cit., p. 7. Cfr. W. Reinhard,<br />
Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena einer Theorie des konfessionellen<br />
Zeitalters, in: “Archiv für Reformationsgeschichte”, 68 (1977), pp. 226-251; Id. / H.<br />
Schilling (a cura di), Die katholische Konfessionalisierung, Mohn, Gütersloh 1995; A. P.<br />
Luttenberger, Katholische Reform und Konfessionalisierung, Wissenschaftliche<br />
Buchgesellschaft, Darmstadt 2006.<br />
28
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
religiosa creativa di Lutero quale espressione della profondità dell’anima<br />
germanica, e il mero agire tattico-politico di Ignazio di Loyola (e, in qualche<br />
modo, anche di Calvino), come espressione della superficialità romanooccidentale:<br />
non soltanto il <strong>tedesco</strong>, ma anche lo spagnolo e lo svizzero<br />
erano “homines religiosi” innovatori. L’originalità del genio religioso di Lutero<br />
è stata fortemente relativizzata proprio nel cuore della sua teologia, essendo<br />
state evidenziate le corrispondenze tra le tre formule alla base del suo credo (i<br />
princìpi del solus Christus, della sola scriptura e della sola fide) e analoghi<br />
assiomi della teologia gesuita; pur restando salve innegabili differenze, è<br />
diventato difficile affermare una specificità del solo Protestantesimo.<br />
5. 5. <strong>Il</strong> <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>Sonderweg</strong> prussiano<br />
prussiano<br />
<strong>Il</strong> topos del “ritardo” rispetto all’Occidente, riferito alla costruzione dello<br />
Stato sovrano nazionale, rimane uno dei più insistiti nella letteratura sul caso<br />
<strong>tedesco</strong>. «A differenza di tutti gli altri paesi d’Europa, in Germania lo Stato<br />
moderno si è realizzato a livello dei singoli territori. Ma le sue basi furono<br />
definitivamente poste solo nel 1648» 42 . Nella formazione degli Stati territoriali<br />
un valido contributo alla coesione fu offerto dai ceti (Stände), promotori dei<br />
primi ordinamenti legislativi e di polizia; un’altra, più importante, spinta fu<br />
impressa dalla Riforma protestante, in quanto l’identità confessionale<br />
rafforzava quella territoriale. Tuttavia, di vera e propria sovranità si può<br />
parlare soltanto nei casi di signori territoriali come i duchi di Brandeburgo-<br />
Prussia, forti abbastanza da imporre proprie norme al di fuori del diritto<br />
imperiale.<br />
Così come è intrecciata alla vicenda della Riforma, così la questione del<br />
<strong>Sonderweg</strong> (tanto nella sua versione positiva quanto in quella critico-negativa)<br />
è indissolubilmente legata alla storia della Prussia, sulla base della corrente<br />
(ma impropria) identificazione tra «via tedesca» e «via prussiana» alla<br />
statualità. La tesi dell’identità tra Impero Tedesco e Regno di Prussia appare in<br />
tutta evidenza nelle parole che Thomas Mann scrisse all’inizio della prima<br />
guerra mondiale: «la Germania è oggi Federico il Grande. È la sua battaglia<br />
42 W. Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, trad. it. cit., p. 61.<br />
29
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
che porteremo a compimento, che dovremo combattere ancora una volta».<br />
L’«accerchiamento» del Kaiserreich alla vigilia della prima guerra mondiale<br />
rievocava il complotto delle potenze europee contro la Prussia federiciana: in<br />
entrambi i casi Mann non intendeva soltanto giustificare la guerra preventiva<br />
come necessità per la difesa, ma attribuire all’aggressore, «predestinato» ad<br />
una missione, una legittimazione superiore alla mera convenzione del diritto<br />
delle genti. Sin dal 1905, del resto, Mann aveva progettato un romanzo (mai<br />
compiuto) che avrebbe dovuto ritrarre Federico II come tragico eroe nazionale<br />
e simbolo della «questione tedesca» 43 .<br />
È indubbio che, a seconda che la storiografia abbia optato per una<br />
concezione positiva o negativa del <strong>Sonderweg</strong> <strong>tedesco</strong>, l’immagine della<br />
Prussia è oscillata tra glorificazione e condanna, tra l’idealizzazione del<br />
«Vernunftstaat» federiciano e la demonizzazione di uno Stato che, con il<br />
potenziamento dei suoi apparati repressivi, avrebbe costituito la pietra d’inciampo<br />
sulla strada della democratizzazione tedesca. Dal momento in cui si<br />
dà una compatta organizzazione statuale al momento della sua soppressione<br />
sul piano del diritto internazionale (25 febbraio 1947), la Prussia ha<br />
contribuito ad imprimere un marchio di unicità sulla storia tedesca. Ciò non<br />
equivale ad affermare che la tradizione vetero-prussiana sia sfociata<br />
necessariamente nella dittatura hitleriana, una tesi sostenuta dagli Alleati in<br />
pieno conflitto e ripresa nella Repubblica Democratica Tedesca (per quanto la<br />
stessa dirigenza di partito, in crisi di legittimità, a partire dagli anni Ottanta<br />
abbia poi abbandonato i toni della damnatio memoriae per riappropriarsi<br />
dell’eredità prussiana e del mito di Federico il Grande) 44 . Anche la<br />
storiografia tedesca occidentale ha ripetutamente puntato il dito contro il<br />
potere incontrastato degli Junker nell’amministrazione, nell’esercito,<br />
nell’economia agraria, adducendo come “patologia” prussiana la cultura<br />
43 T. Mann, Friedrich und die große Koalition, Fischer, Berlin 1915, p. 16. Cfr. Id.,<br />
Gedanken im Krieg, in: Essays, Fischer, Frankfurt a. M. 1993, vol. I, p. 194.<br />
44 Esemplificativo della linea interpretativa di condanna A. Abusch, Irrweg einer Nation: Ein<br />
Beitrag zum Verständnis deutscher Geschichte, Aufbau, Berlin 1946 (trad. it. Storia della<br />
Germania moderna, Einaudi, Torino 1951), in cui si sosteneva una continuità diretta dal<br />
militarismo prussiano, attraverso Bismarck, sino a Hitler. Sulla successiva riabilitazione della<br />
tradizione prussiana nella DDR, W. Schmidt, Das Erbe- und Traditionsverständnis in der<br />
Geschichte der DDR, Akademie, Berlin 1986; E. Kuhrt / H. v. der Löwis, Griff nach der<br />
deutschen Geschichte: Erbeignung und Traditionspflege in der DDR, Schöning, Paderborn<br />
1988.<br />
30
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
politica radicalmente conservatrice e la tradizione militarista. Con la<br />
fondazione dello Stato nazionale, si è detto, la Prussia aveva messo fuori<br />
gioco la cultura democratico-liberale degli Stati meridionali, spianando la<br />
strada all’estremismo di Destra con il suo autoritarismo e il suo culto<br />
dell’obbedienza.<br />
<strong>Il</strong> militarismo prussiano è stato tradizionalmente descritto come un sistema<br />
sociale integrato. Secondo Karl Mannheim, se in Francia la rivoluzione aveva<br />
prodotto un’alleanza difensiva tra nobiltà, monarchia e Chiesa, l’elemento<br />
caratteristico della Prussia, nel periodo successivo alla rivoluzione francese, fu<br />
«l’antagonismo tra le aspirazioni delle forze feudali e dei vecchi ceti e il<br />
razionalismo burocratico-assolutistico», che ebbe come temporaneo effetto<br />
l’indebolimento dell’alleanza tra monarchia assoluta e nobiltà 45 . Contro i<br />
propositi dell’aristocrazia di consolidare la società organica per ceti, la<br />
burocrazia fece proprio l’elemento dirigistico, meccanicistico e centralistico<br />
della rivoluzione. Ma già sotto Federico Guglielmo I, il “re soldato”, Stato e<br />
società erano stati subordinati alle esigenze dell’esercito. I contadini erano<br />
soggetti al reclutamento forzato e il servizio militare non aveva limiti<br />
temporali, benché venisse interrotto periodicamente per consentire lo<br />
svolgimento delle attività rurali. <strong>Il</strong> corpo degli ufficiali costituiva il più grande<br />
gruppo organizzato socialmente omogeneo della società prussiana,<br />
rimanendo per tutto il Settecento quasi interamente aristocratico nei suoi gradi<br />
più alti. In virtù di un sistema di diritti e doveri speciali, la condizione di<br />
ufficiale fu posta al vertice della scala sociale e separata dal resto dell’esercito<br />
e dalla società, creando una classe che sarebbe sopravvissuta alle riforme del<br />
1808/1814, alla rivoluzione del 1848 e alla fondazione del Deutsches Reich,<br />
e che fu tra le principali responsabili della conservazione delle strutture di uno<br />
Stato militare sino al XX secolo. Gli Junker erano la base sociale della<br />
militarizzazione dello Stato e la conservazione del loro potere determinava<br />
l’organizzazione socio-economica delle province tedesche orientali, dando<br />
con ciò origine ad un problema centrale del passato <strong>tedesco</strong>: la formazione<br />
di un dualismo tra Germania occidentale e orientale nella struttura del<br />
sistema economico, sociale e di dominio.<br />
45 K. Mannheim, Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens, Suhrkamp,<br />
Frankfurt a. M. 1984; trad. it. Conservatorismo. Nascita e sviluppo del pensiero<br />
conservatore, Laterza, Roma / Bari 1989, p. 137 e seg.<br />
31
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
L’interpretazione della storia prussiana in termini di militarismo ha<br />
notoriamente sollevato un ampio dibattito. La storiografia anglosassone<br />
sosteneva la tesi della continuità: per Gordon A. Craig il deficit democratico<br />
della società tedesca era imputabile al ruolo eminente rivestito dall’esercito<br />
nella storia della Germania 46 . Per un critico della <strong>Sonderweg</strong>sthese come<br />
Gerhard Ritter, invece, la disposizione militarista è stata erroneamente<br />
considerata una caratteristica propria della dinastia prussiana: «lo Stato<br />
autoritario e militare prussiano del XVIII secolo non era nient’altro che una<br />
forma, realizzata in modo particolarmente energico e coerente, dello Stato di<br />
tipo continentale, così come era stato creato per la prima volta sul suolo<br />
francese» nell’età da Richelieu a Colbert. Opposto al modello di Stato<br />
“continentale” era lo Stato “marittimo”, olandese e inglese, con il suo<br />
patriziato aristocratico-borghese, la grande incidenza degli interessi economici<br />
e la conduzione di guerre al di fuori del continente europeo. Dalla rispettiva<br />
condizione geopolitica derivava la contrapposizione tra la «politica<br />
continentale» e la «politica insulare»: la prima più proclive all’uso della forza<br />
(a costo di scatenare guerre preventive), la seconda più incline, per ragioni<br />
economiche, ad alleanze, pressioni diplomatiche, accordi 47 . Questa<br />
opposizione sarebbe apparsa in maniera ancor più netta nel corso del XIX e<br />
XX secolo tra l’Inghilterra e la Germania: e tuttavia, «chi si immagina lo Stato<br />
prussiano in età di pace come un’unica grande caserma, è assai lontano<br />
dalla realtà» 48 . La recente storiografia ha confermato, tuttavia, la specificità<br />
del militarismo prussiano nella forma della Sozialdisziplinierung come<br />
46 G. A. Craig, The Politics of the Prussian Army 1640-1945, Clarendon, Oxford 1955, p.<br />
12 (trad. it. <strong>Il</strong> potere delle armi. Storia e politica dell’esercito prussiano 1640-1945, il<br />
Mulino, Bologna 1984).<br />
47 Questa opposizione «naturale» tra politica continentale e politica insulare costituirebbe<br />
uno dei fattori fondamentali della storia moderna: cfr. G. Ritter, Die Dämonie der Macht.<br />
Betrachtungen über Geschichte und Wesen des Machtsproblems im politischen Denken der<br />
Neuzeit, Hannsmann, Stuttgart 1947; trad. it. <strong>Il</strong> volto demoniaco del potere, il Mulino,<br />
Bologna 1958.<br />
48 G. Ritter, Europa und die deutsche Frage. Betrachtungen über die geschichtliche Eigenart<br />
des deutschen Staatsdenkens, Münchner Verlag, München 1948 (ampliato sotto il titolo Das<br />
deutsche Problem. Grundfrage deutschen Staatslebens gestern und heute, Oldenbourg,<br />
München 1966), p. 28.<br />
32
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
assimilazione di valori e modelli comportamentali tipicamente militari da parte<br />
della società civile 49 .<br />
Va rilevato infine che un argomento centrale della <strong>Sonderweg</strong>sthese, la<br />
difformità tra lo sviluppo economico e sociale e il deficit nella<br />
modernizzazione politica, si addice particolarmente alla Prussia, mentre è<br />
meno appropriato per gli Stati meridionali, con i loro governi moderatamente<br />
liberali, le riforme costituzionali, un potere aristocratico più limitato, minore<br />
avversione per la socialdemocrazia, un autoritarismo e un militarismo meno<br />
accentuati. Anche nella comparazione europea, l’arretratezza tedesca nel<br />
processo di modernizzazione politica è da ricondurre principalmente alle<br />
strutture politiche e alla classe dirigente prussiana, senza con questo negare<br />
l’incidenza di altri fattori fondamentali, quali la frammentazione politica, la<br />
divisione confessionale, il tardo conseguimento dell’unità nazionale, la forte<br />
tradizione burocratica, l’accumulo delle problematiche nazionali, sociali e<br />
costituzionali.<br />
6. 6. <strong>Il</strong> <strong>Il</strong> <strong>Sonderweg</strong> <strong>Sonderweg</strong> bismarckiano<br />
bismarckiano<br />
Per quanto concerne l’ambito dell’amministrazione e della costituzione, le<br />
strutture portanti del sistema prussiano restarono immutate nel Kaiserreich 50 .<br />
All’indomani dell’unificazione né la Prussia né il Reich presentavano<br />
cambiamenti costituzionali rilevanti: le competenze del Cancelliere, dei<br />
parlamenti e dell’amministrazione restarono giuridicamente invariate. Studi<br />
recenti relativi ai vertici dello Stato prussiano e alla cultura politica elettorale<br />
hanno messo in luce la predominante avversione alle riforme politico-sociali<br />
49 Cfr. M. Messerschmidt, Preußens Militär in seinem gesellschaftlichen Umfeld, in: H.-J.<br />
Puhle / H.-U. Wehler (a cura di), Preußen im Rückblick, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen<br />
1980; O. Büsch, Militärsystem und Sozialleben im alten Preußen 1713-1807. Die Anfänge<br />
der sozialen Militarisierung der preußisch-deutschen Gesellschaft, Ullstein, Frankfurt a. M.<br />
1981. Per un bilancio della questione, M. Salewski, Preuβischer Militarismus. Realität oder<br />
Mythos? Gedanken zu einem Phantom, in: “Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte”,<br />
n. 53 (2001), pp. 19-34 .<br />
50 È quanto conferma David Blackbourn, pur critico del “deutscher <strong>Sonderweg</strong>”, in The Long<br />
Nineteenth Century. A History of Germany 1780-1918, Oxford University Press, Oxford<br />
1997, p. 418.<br />
33
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
dei gruppi dirigenti 51 . <strong>Il</strong> governo prussiano si avvalse a lungo di una<br />
coalizione composta dal partito conservatore e da quello liberale-nazionale,<br />
lasciando fuori il Centro cattolico e contrastando il partito socialdemocratico.<br />
Gli Stati tedeschi erano monarchie costituzionali che respingevano l’idea della<br />
sovranità popolare; pertanto si distinguevano dalle monarchie parlamentari<br />
come Inghilterra, Belgio, Italia, Danimarca e Norvegia. Esaminando il<br />
costituzionalismo monarchico <strong>tedesco</strong> in una prospettiva europea, si può<br />
sostenere, contro la tesi della progressiva «parlamentarizzazione», che i<br />
sovrani tedeschi hanno conservato sino al 1914 una posizione di forza, a<br />
malapena inficiata dal diritto costituzionale 52 . Risulta pertanto confermata la<br />
tesi di un «ritardo» del Reich rispetto allo sviluppo politico-costituzionale<br />
europeo, dovuto in special modo all’egemonia “frenante” della Prussia, ma<br />
anche alla peculiare «accumulazione di problemi» (questione nazionale,<br />
questione sociale, questione costituzionale) e al <strong>federalismo</strong> tedeschi.<br />
Per la storiografia dell’età bismarckiana, all’origine del <strong>Sonderweg</strong> prussiano<br />
non vi era tanto l’arretratezza politico-sociale quanto, al contrario, il<br />
fatto che alla Prussia fosse riuscita quell’opera di razionalizzazione degli<br />
apparati statali e di modernizzazione del sistema feudale nella quale la<br />
Francia aveva fallito, imboccando per ciò stesso la strada della rivoluzione. La<br />
questione sociale e lo Stato prussiano è il titolo di un saggio del 1874 di<br />
Gustav Schmoller, nel quale alla crisi e ai pericoli futuri della società si<br />
cercava rimedio in monarchia e burocrazia, «gli unici elementi neutrali nella<br />
lotta di classe» che, amalgamandosi con le istanze liberali e parlamentari<br />
potevano prendere «l’iniziativa per una grande legislazione di riforma<br />
sociale» 53 . Tale fiducia era fondata sulla consapevolezza della superiorità<br />
dell’organizzazione amministrativa di tradizione prussiana: «su terreno feudale<br />
51 Cfr. T. Kühne, Dreiklassenwahlrecht und Wahlkultur in Preußen 1867-1914, Droste,<br />
Düsseldorf 1994; H. Spenkuch, Das Preußische Herrenhaus: Adel und Bürgertum in der<br />
Ersten Kammer des Landtages, Droste, Düsseldorf 1998.<br />
52 M. Kirsch, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert: Der monarchischen<br />
Konstitutionalismus als europäischer Verfassungstyp – Frankreich im Vergleich, Vandenhoeck<br />
& Ruprecht, Göttingen 1999, p. 362.<br />
53 G. Schmoller, Die Soziale Frage und der preuβischer Staat, in “Preuβischer Jahrbücher”,<br />
33 (1874), p. 341. Ma su tutta la questione P. Schiera, <strong>Il</strong> laboratorio borghese. Scienza e<br />
politica nella Germania dell’ottocento, il Mulino, Bologna 1987 e, da ultimo, S. Amato,<br />
Aristocrazia politico-culturale e classe dominante nel pensiero <strong>tedesco</strong> (1871-1918), Olschki,<br />
Firenze 2008.<br />
34
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
era cresciuto un governo di funzionari antifeudale, la cui buona disposizione<br />
verso borghesi e contadini sarebbe poi stata giustamente celebrata» 54 . In<br />
queste tesi si evidenziava una continuità tra il moderno Stato sociale e<br />
precedenti forme di politica e legislazione sociale, che avevano le loro radici<br />
nella tradizione cameralistica. In Germania le scienze dello Stato e<br />
dell’amministrazione, la burocrazia e la legislazione hanno reagito in anticipo<br />
ai problemi della società industriale e capitalistica moderna. La legislazione<br />
bismarckiana sulla previdenza sociale, introdotta negli anni Ottanta del XIX<br />
secolo, costituì in effetti il primo sistema moderno di assicurazione sociale<br />
pubblica 55 .<br />
Con la crescente polarizzazione ideologica che seguì la sconfitta del<br />
1918, la valutazione del Kaiserreich oscillò tra la condanna (cui era<br />
complementare il sostegno alla Repubblica di Weimar) e la difesa<br />
incondizionata (a detrimento del nuovo governo democratico). Mentre alcuni,<br />
come Friedrich Meinecke e Hermann Oncken, presero a relativizzare la<br />
versione “borussica” del <strong>Sonderweg</strong>, riconoscendo luci ed ombre dello Stato<br />
nazionale <strong>tedesco</strong>, la Sinistra liberale e i socialdemocratici (tra cui Hans<br />
Rosenberg e Eckart Kehr) assunsero un atteggiamento radicalmente critico,<br />
scorgendo nel Reich del 1871 un regime “feudale” a protezione degli interessi<br />
di pochi a danno della classe lavoratrice; la politica inaugurata da Bismarck<br />
era accusata d’aver interrotto il processo di democratizzazione avviato nel<br />
1848, rendendosi responsabile del declino morale e politico del paese.<br />
Alla fine della seconda guerra mondiale, la «catastrofe tedesca» discreditò<br />
definitivamente la tesi del <strong>Sonderweg</strong> positivo. La revisione storiografica<br />
procedette ad una sorta di demonizzazione del Kaiserreich, che divenne l’epoca<br />
in cui i tratti del <strong>Sonderweg</strong>, già manifestatisi in rigidità e ritardi, si erano<br />
consolidati in un modello negativo 56 : qui affondavano le loro radici quei<br />
54 G. Schmoller, Die Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preuβens im<br />
18. Jahrhundert, in: Acta Borussica. Denkmäler der Preuβischen Staatsverwaltung im 18.<br />
Jahrhundert, Parey, Berlin 1894, p. 140.<br />
55 Sul processo d’integrazione nazionale dei lavoratori si vedano: H. Mommsen,<br />
Arbeiterbewegung und Nationale Frage, Göttingen 1979 e G. A. Ritter, Staat, Arbeiterschaft<br />
und Arbeiterbewegung in Deutschland. Vom Vormärz bis zum Ende der Weimarer Republik,<br />
Dietz, Berlin 1980.<br />
56 Per un bilancio della storiografia sul Kaiserreich: E. Fehrenbach, Die Reichsgründung in<br />
der deutschen Geschichtsschreibung, in T. Schieder / E. Deuerlein (a cura di),<br />
35
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
processi di destabilizzazione dell’ordine politico, costituzionale e<br />
internazionale della vecchia Europa, che avrebbero condotto, dopo la guerra<br />
mondiale e il fallito esperimento democratico di Weimar, al<br />
nazionalsocialismo. Nella Germania orientale, la percezione storica fu<br />
inizialmente dominata dall’idea che esistesse una linea diretta di continuità<br />
dal Secondo Reich al nazismo: quella bismarckiana sarebbe stata una<br />
«tradizione di violenza, menzogna e demagogia» sulla quale Hitler avrebbe<br />
edificato le basi del proprio regime. Dopo questa prima perentoria condanna,<br />
seguì tuttavia, in una fase in cui la DDR attraversava una crisi di<br />
legittimazione, la progressiva riabilitazione della figura di Bismarck nel ruolo<br />
di padre della nazione 57 . Nella Germania occidentale, alla fine degli anni<br />
Quaranta, sotto la pressione del programma di «rieducazione» degli Alleati,<br />
alla fondazione del Reich si imputava l’introduzione del germe del militarismo,<br />
della personalizzazione del potere e del culto della leadership. La storiografia<br />
che stigmatizzava l’illiberalità del Secondo Reich quale antefatto del nazismo<br />
denigrava la costituzione imperiale del 1871 come apparente<br />
(«Scheinverfassung») e il cancellierato dell’«autocrate» Bismarck come<br />
«Diktatur» 58 .<br />
L’idea di una «via peculiare tedesca» incentrata sul Kaiserreich fu, tuttavia,<br />
sottoposta a critica da storici angloamericani (David Blackbourn, Geoff Eley,<br />
David Irving), ai quali essa appariva (così come a Thomas Nipperdey, a Horst<br />
Möller, a Reinhart Koselleck) analoga ― già sul piano linguistico ― alla tesi,<br />
Reichsgründung 1870/71 cit., pp. 259-290; E. Frie, Das Deutsche Kaiserreich. Kontroversen<br />
um die Geschichte, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004.<br />
57 Sulla riabilitazione del Kaiserreich, che ebbe inizio nel luglio 1952 con un discorso di<br />
Walter Ulbricht durante la seconda conferenza di partito della SED, cfr. E. Kuhrt / H. v. der<br />
Löwis, Griff nach der deutschen Geschichte: Erbaneignung und Traditionspflege in der DDR,<br />
Schöningh, Paderborn 1988. Sulla storiografia tedesca orientale: A. Dorpalen, German<br />
History in Marxist Perspective. The East German Approach, Tauris, London 1985; A. Fischer<br />
/ G. Heydemann (a cura di), Geschichtswissenschaft in der DDR, Duncker & Humblot, Berlin<br />
1988.<br />
58 H.-U. Wehler, Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918 cit., p. 60, lo ha definito «un<br />
costituzionalismo apparente, autocratico e mezzo assolutistico», in quanto l’ideologia<br />
federalistica e il suffragio universale dissimulavano il persistente unitarismo egemonico della<br />
Prussia, che, oltre ad assicurare al primo ministro prussiano la carica di Cancelliere,<br />
deteneva anche il potere di veto sulla revisione costituzionale.<br />
36
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
altrettanto ideologica, dell’“eccezionalismo” americano 59 . Le loro obiezioni<br />
colpivano diversi aspetti della <strong>Sonderweg</strong>sthese: l’impostazione teleologica<br />
focalizzata sul 1933, l’idealizzazione della storia inglese e di altri paesi<br />
occidentali, l’adozione di formule storicamente inappropriate («manipolazione<br />
dall’alto», «feudalizzazione della borghesia», «Obrigkeitsstaat») 60 . Tale<br />
avversione contava tra le sue ragioni anche il fatto che la storiografia<br />
angloamericana aveva visto nel libro di Hans-Ulrich Wehler sul Kaiserreich<br />
l’esemplificazione di quell’interpretazione semplicistica del Reich che sostiene<br />
una continuità da Lutero a Hitler, ad esempio nella presunta “mentalità da<br />
sudditi” dei tedeschi 61 . Inoltre, proprio la storiografia angloamericana poneva<br />
in discussione la definizione di un concetto che era stato centrale, a partire da<br />
Marx, Thorstein Veblen e Max Weber, nell’argomentazione della specificità<br />
tedesca: la tarda «modernizzazione» del sistema politico (accanto ad una<br />
spinta all’industrializzazione e a significative trasformazioni sociali). In<br />
particolare, era contestato il carattere paradigmatico della connessione tra<br />
capitalismo, parlamentarismo e democrazia: in Inghilterra, si obiettava,<br />
l’aristocrazia resta fino alla prima guerra mondiale il gruppo politicamente<br />
egemone e anche lo sviluppo inglese è caratterizzato da forti tensioni. Per<br />
Blackbourn ed Eley la borghesia tedesca non era fallita, si era anzi integrata<br />
così bene nel sistema che non avvertiva la necessità della democratizzazione;<br />
nella Germania del XIX secolo si è verificata, contrariamente a quel che si è<br />
sempre affermato, una rivoluzione borghese, certamente non nella forma di<br />
una lotta tra nobiltà e borghesia al termine della quale quest’ultima assume la<br />
59 Cfr. G. M. Fredrickson, From Exceptionalism to Variability: Recent Developments in Cross-<br />
National Comparative History, in “JAH”, n. 82 (1995), pp. 587-604; G. Steinmetz, German<br />
Exceptionalism and the Origins of Nazism: the Career of a Concept, in I. Kershaw / M. Lewin<br />
(a cura di), Stalinism and Nazism. Dictatorships in Comparison, Cambridge University Press,<br />
Cambridge 1997, pp. 251-284, p. 253 e seg.<br />
60 <strong>Il</strong> dibattito prende avvio con la pubblicazione, nel 1980, di un volume in lingua tedesca<br />
sui Miti della storiografia tedesca, ad opera di due storici britannici: G. Eley / D.<br />
Blackbourn, Mythen deutscher Geschichtsschreibung. Die gescheiterte bürgerliche Revolution<br />
von 1848, Ullstein, Frankfurt a. M. 1980 (ediz. rielaborata inglese The Peculiarities of<br />
German History: Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany, Oxford<br />
University Press, Oxford 1984).<br />
61 H.-U. Wehler, Das deutsche Kaiserreich 1871-1918 cit. Cfr. T. Nipperdey, Wehlers<br />
«Kaiserreich». Eine kritische Auseinandersetzung (1975), in Id., Gesellschaft, Kultur, Theorie.<br />
Gesammelte Aufsätze zur neueren Geschichte, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1976,<br />
pp. 360-389.<br />
37
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
direzione dello Stato e sostituisce il governo monarchico con una democrazia<br />
parlamentare: questa concezione di rivoluzione borghese è un mito che non<br />
corrisponde a realtà. Se si intende per rivoluzione borghese, anziché un<br />
particolare processo politico di riforme democratiche, un complesso di<br />
mutamenti i quali, insieme, rappresentano le condizioni di sviluppo di un<br />
capitalismo industriale, allora vi sono fondate ragioni per considerare la<br />
«rivoluzione dall’alto» della seconda metà del XIX secolo come «la variante<br />
tedesca della rivoluzione borghese» 62 . Andava pertanto ridimensionata<br />
l’affermazione che la borghesia fosse politicamente debole nel Kaiserreich e<br />
incapace di salvaguardare i propri interessi di classe.<br />
Per questi autori la struttura particolare dello Stato imperiale ed i suoi<br />
problemi alla vigilia della prima guerra mondiale non derivavano dall’avere<br />
ereditato una certa arretratezza politica, bensì dall’assommarsi di<br />
contraddizioni congiunturali: la rapida espansione e concentrazione di capitali<br />
in una società nella quale l’aristocrazia occupava ancora una posizione<br />
rilevante nell’ambito statale; il fatto che la precoce organizzazione del<br />
movimento operaio in un partito socialdemocratico avesse impedito la<br />
ristrutturazione del blocco di potere a sfavore dei grandi proprietari terrieri;<br />
l’incapacità delle strutture partitiche esistenti di soddisfare tutte le istanze poste<br />
dall’accelerata trasformazione capitalistica e dal mutamento sociale 63 . Furono<br />
le particolari modalità dell’antagonismo tra capitale e lavoro ― dunque la<br />
capacità dei grandi complessi industriali di opporsi alle organizzazioni<br />
sindacali e, al tempo stesso, la loro debolezza politica ― a creare le<br />
condizioni per un’alleanza tra il grande capitale industriale e la grande<br />
proprietà fondiaria; ragioni strategiche, dunque, piuttosto che un particolare<br />
modello comportamentale di «staatsbürgerliche Unmündigkeit». E le ragioni di<br />
tale coercizione andavano ricercate nei tratti specifici della politica di<br />
Bismarck e dei suoi successori, piuttosto che nelle tradizioni autoritarie di<br />
élites preindustriali.<br />
Nondimeno, una certa storiografia liberal-democratica ha persistito nella<br />
tesi di un progressivo allontanamento dal modello di sviluppo delle<br />
62 G. Eley, Deutscher <strong>Sonderweg</strong> und englisches Vorbild, in Id. / D. Blackbourn, Mythen<br />
deutscher Geschichtsschreibung cit., pp. 7-58.<br />
63 Tali punti sono discussi dettagliatamente in G. Eley, Reshaping the German Right, Yale<br />
University Press, London 1980, pp. 1-16 e 349-361.<br />
38
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
democrazie occidentali. Ciò rispondeva all’esigenza ideologica di integrare la<br />
società tedesca del dopoguerra nel blocco occidentale, attraverso il rifiuto dei<br />
suoi antecedenti antidemocratici e l’attribuzione della responsabilità del<br />
nazionalsocialismo alle sole élites premoderne della nobiltà e dell’esercito. In<br />
un convegno dell’Institut für Zeitgeschichte di Monaco del 1981, autorevoli<br />
storici confrontarono le proprie argomentazioni in merito alla fondatezza<br />
storica e all’opportunità politica della <strong>Sonderweg</strong>sthese. In quell’occasione<br />
Kurt Sontheimer sottolineò che abbandonare o relativizzare la tesi di un<br />
deutscher <strong>Sonderweg</strong> significava incrinare il pilastro della coscienza politica<br />
tedesca dopo il 1945, dominata dall’imperativo di rompere ogni continuità<br />
con tutto ciò che era sospettato di aver contribuito al sorgere del Terzo<br />
Reich 64 . Ernst Nolte, al contrario, argomentò l’infondatezza della presunta<br />
eccezionalità del caso <strong>tedesco</strong>, osservando come tutti i casi nazionali possano<br />
essere considerati <strong>Sonderweg</strong>e. Proprio Inghilterra e Francia costituivano, nel<br />
XIX secolo, casi atipici nel panorama europeo. Per molti contemporanei, il<br />
processo di industrializzazione inglese, con i suoi effetti di incremento del<br />
pauperismo, non costituiva affatto un modello per il futuro del continente.<br />
Neppure i francesi si sarebbero sempre sentiti “à la tête de la civilisation”,<br />
temendo di non reggere la concorrenza con le nazioni “moderne”, inclusa la<br />
Germania. Per Nolte infine il concetto di «rivoluzione borghese» non era che<br />
una leggenda, frutto non di pura invenzione ma dell’assolutizzazione di singoli<br />
dati di fatto. La rivoluzione del 1640, così come la “gloriosa rivoluzione” del<br />
1688/89 miravano alla restaurazione delle libertà contro il potere arbitrario<br />
dell’Assolutismo; neppure la rivoluzione americana sarebbe stata immune da<br />
elementi antidemocratici e reazionari 65 .<br />
In posizione intermedia tra coloro che respingono la tesi della peculiarità<br />
tedesca e coloro che ne sostengono la validità piena o parziale, motivandola<br />
in chiave politico-morale o adducendo argomentazioni di carattere<br />
geopolitico, si può collocare Thomas Nipperdey. Accogliendo le osservazioni<br />
della critica inglese, l’autore della grande sintesi Deutsche Geschichte 1866-<br />
1918 ha proposto di circoscrivere e differenziare il concetto di <strong>Sonderweg</strong>,<br />
allo scopo di liberarlo da sovraccarichi ideologici e chiarirne il legittimo<br />
64 H. Möller, Deutscher <strong>Sonderweg</strong> — Mythos oder Realität? Ein Colloquium im Institut für<br />
Zeitgeschichte, in: “Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte”, 30 (1982), pp. 162-165.<br />
65 E. Nolte in: Deutscher <strong>Sonderweg</strong> — Mythos oder Realität? cit., p. 39.<br />
39
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
contenuto di realtà 66 . Anzitutto, sul piano logico-scientifico, la teoria del<br />
<strong>Sonderweg</strong> costruisce una continuità storica a partire da un punto finale — la<br />
Machtergreifung del 1933 — procedendo teleologicamente. Essa tradisce<br />
pertanto una tendenza al determinismo: presuppone l’inevitabilità del corso<br />
storico, trascurando la relativa “apertura” di situazioni, eventi, possibilità,<br />
alternative, disconoscendo l’incisività di eventi casuali o di influssi esterni,<br />
livellando discontinuità e rotture. La seconda debolezza che inficia la teoria<br />
del <strong>Sonderweg</strong> è l’eccessiva moralizzazione implicita in una lettura del corso<br />
storico che fa uso di termini quali «fallimento», «colpa», «deviazione». Oltre ad<br />
adottare come criterio di giudizio una discutibile “norma” — occupandosi,<br />
paradossalmente, di ciò che avrebbe dovuto essere e non è stato — tale<br />
impostazione trascura la forza delle condizioni date, la ristrettezza dei margini<br />
d’intervento, l’insolubilità di alcuni problemi, la finitezza e la fallibilità umana,<br />
la contraddittorietà del reale. In terzo luogo, al più tardi nella seconda metà<br />
del XIX secolo, la Germania era, per struttura socio-economica, per condizioni<br />
di diritto, per cultura, e in parte per istituzioni, assai più comparabile con le<br />
nazioni occidentali (pur tra loro differenti) di quanto non lo fosse con i paesi<br />
dell’Est e del Sud dell’Europa. L’alta complessità dei fenomeni storici ostacola<br />
una chiara attribuzione ad elementi comuni europei o a specifiche<br />
particolarità tedesche, rendendo ardua la distinzione tra ciò che è<br />
condizionato dalla situazione e ciò che è determinato dalla tradizione, sicché<br />
il lavoro dello storico non può che accontentarsi di una certa plausibilità,<br />
mancando di un criterio obiettivo per una netta delimitazione. La ricerca deve<br />
assicurare i propri risultati attraverso la “prova del fuoco” della<br />
comparazione, il solo metodo in grado di evidenziare la peculiarità, valutarne<br />
il peso, demistificare mitologie e luoghi comuni.<br />
Al di là delle questioni logico-metodologiche, Nipperdey ha richiamato<br />
l’attenzione su un altro problema, connesso all’esperienza del presente a<br />
partire dal quale si guarda al passato. In questo senso, due argomenti<br />
cardine della teoria del <strong>Sonderweg</strong> (il grado di democratizzazione e la cultura<br />
tedesca) appaiono assai più discutibili. In primo luogo, la condizione poco<br />
incoraggiante in cui versano le democrazie occidentali ha seriamente<br />
compromesso l’immagine del «Normalweg»: ingovernabilità, fragilità del<br />
66 T. Nipperdey in: Deutscher <strong>Sonderweg</strong> ― Mythos oder Realität? cit., pp. 16-26. Cfr. Id.,<br />
Deutsche Geschichte 1866-1918, Beck, München 1990/1992, 2 voll.<br />
40
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
sistema partitico, polarizzazione, distanza tra rappresentanti e rappresentati,<br />
crisi di legittimità, riabilitazione dell’impolitico, il sospetto che la lealtà ai<br />
sistemi democratici perduri solo finché siano assicurati e mantenuti certi<br />
standards di vita, tutto ciò pone l’interrogativo se il deficit di<br />
democratizzazione imputato alla Germania non sia dedotto da un’immagine<br />
fittizia del sistema democratico occidentale. In secondo luogo, allo storico<br />
appare discutibile misurare spirito e cultura, filosofia e arte sulla base della<br />
razionalità illuminista, del pluralismo liberale e della democrazia egualitaria,<br />
leggendo così la storia culturale tedesca — dal Romanticismo a Wagner e<br />
Nietzsche, sino all’espressionismo — in chiave di irrazionalismo o distruzione<br />
della ragione. Tali manifestazioni sono da considerarsi, piuttosto, la rivolta<br />
contro i postulati conformistici, tanto della democrazia quanto del liberalismo<br />
borghese.<br />
L’allontanamento dal paradigma marxiano e weberiano negli anni Ottanta<br />
si è accompagnato al ridimensionamento del modello interpretativo proposto<br />
da Plessner. Benché la formula della «verspätete Nation» fosse suggestiva ed<br />
efficace, dal punto di vista metodologico essa è incorsa in serrate critiche.<br />
Anche R. Koselleck ha osservato che la <strong>Sonderweg</strong>sthese suggeriva l’idea di<br />
un’ineluttabile catena causale ex ante, che doveva condurre, senza alternative<br />
o vie di scampo, alla catastrofe nazista. Ma in questo modo si finiva per<br />
indebolire proprio quella pretesa morale che si voleva avanzare con la teoria<br />
genetico-causale del <strong>Sonderweg</strong>, facendo ricadere interamente sulla Storia,<br />
ipostatizzata a Destino, la responsabilità di coloro che avevano compiuto i<br />
crimini 67 . Contro un tale giudizio moralizzante, si poteva in primo luogo<br />
obiettare che la categoria normativa temporale del “ritardo”, inserita nel<br />
complessivo contesto europeo, era destinata a perdere il proprio carattere di<br />
assolutezza: se i tedeschi erano giunti dopo i francesi, i britannici e gli<br />
olandesi ad istituire uno Stato nazionale, avevano condiviso gli stessi tempi di<br />
sviluppo degli italiani, ed anticipato polacchi, cechi ed altri popoli del centroest<br />
europeo. Inoltre, si sarebbe dovuto riflettere sul fatto che la costellazione<br />
tedesca era differente dalle condizioni in cui si trovavano i concorrenti<br />
occidentali. <strong>Il</strong> presupposto dello Stato nazionale, l’esistenza di un solo<br />
«popolo», empiricamente non era dato, in quanto si era sempre trattato di<br />
67 R. Koselleck, Deutschland — eine verspätete Nation?, in Id., Zeitschichten. Studien zur<br />
Historik, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2000, pp. 359-379.<br />
41
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
una pluralità di popoli, indubbiamente accomunati da lingua e cultura, ma<br />
politicamente divisi in Stati territoriali.<br />
7. 7. Una Una nazione nazione normale?<br />
normale?<br />
Fra gli assunti centrali della storiografia sul <strong>Sonderweg</strong> va annoverata la<br />
tesi che al ritardo nella costruzione dello Stato nazionale abbia fatto da<br />
contraltare lo sviluppo di un <strong>nazionalismo</strong> aggressivo ed estremistico, cui è<br />
toccato il compito di fungere da fattore d’integrazione di una realtà<br />
attraversata da una quantità insostenibile di fratture e divisioni – territoriali,<br />
sociali, confessionali, ideologiche. Questo <strong>nazionalismo</strong> avrebbe aperto la<br />
strada alla politica imperialistica, alla disintegrazione dell’equilibrio tra le<br />
potenze europee e, da ultimo, al delirio nazista. Anche su questo punto la più<br />
recente letteratura storiografica è intervenuta però per differenziare e<br />
ridimensionare la radicalità di una tesi siffatta 68 .<br />
Per valutare la particolarità della via tedesca allo Stato nazionale – si è<br />
detto – la comparazione non può essere limitata al solo modello considerato<br />
normale. Dieter Langewiesche ha riproposto nel dibattito recente una<br />
tipologia già delineata nel 1971 da Theodor Schieder, che distingueva tre<br />
modelli di State-building: 1) Stati antichi divenuti nazionali attraverso un’«integrazione»<br />
(Inghilterra, Francia, Danimarca, Svezia, Portogallo e Castiglia);<br />
68 Per l’impostazione storiografica secondo cui nazioni e Stati sono “artificio”, frutto del<br />
caso, della volontà sovrana e dell’«invenzione» di élites intellettuali, E. Gellner, Nation and<br />
Nationalism, Blackwell, Oxford 1983 (trad. it. Nazioni e <strong>nazionalismo</strong>, Editori Riuniti, Roma<br />
1985); E. Hobsbawm / T. O. Ranger (a cura di), The Invention of Tradition, Cambridge<br />
University Press, Cambridge 1983 (trad. it. L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino<br />
1987); E. J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality,<br />
Cambridge University Press, Cambridge 1990 (trad. it. Nazioni e <strong>nazionalismo</strong> dal 1780.<br />
Programma, mito e realtà, Einaudi, Torino 1991); B. Anderson, Imagined Communities.<br />
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso Editions, London 1983 (trad. it.<br />
Comunità immaginate: origini e diffusione dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma 1996); M.<br />
Hroch, Das Europa der Nationen. Die moderne Nationsbildung in europäischen Vergleich,<br />
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005; O. Zimmer / L. Scales (a cura di), Power and<br />
the Nation in European History, Cambridge University Press, Cambridge 2005. Sul<br />
<strong>nazionalismo</strong> <strong>tedesco</strong> come movimento intellettuale all’inizio del XIX secolo e sulla sua<br />
successiva trasformazione K. v. Beyme, Deutsche Identität zwischen Nationalismus und<br />
Verfassungspatriotismus, in M. Hettling / P. Nolte, Nation und Gesellschaft in Deutschland.<br />
Historische Essays, Beck, München 1996, pp. 80-99.<br />
42
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
2) Stati nazionali «da unificare», perché divisi in una molteplicità di Stati<br />
territoriali (Germania e Italia); 3) «Stati nazionali secessionisti», giacché<br />
derivano dalla dissoluzione di «grandi unità statali sovranazionali» (la<br />
monarchia asburgica, l’impero ottomano) 69 . Nel primo caso, lo State-building<br />
precede il Nation-building: i rivoluzionari francesi poterono «trasformare» la<br />
Francia in uno Stato nazionale raccogliendo i frutti dello Stato assolutistico.<br />
Negli altri due casi — lo Stato nazionale per unificazione e quello per<br />
secessione — non si dà il presupposto di uno Stato preesistente che abbia<br />
realizzato l’accentramento dei poteri; il Nation-building precede lo Statebuilding,<br />
perchè lo Stato nazionale sorge dall’accorpamento di Stati diversi,<br />
che si ritiene appartengano ad una nazione comune, oppure dallo<br />
smembramento di un impero composto da nazioni differenti. Entrambe,<br />
unificazione e secessione, sono (a prescindere da rare eccezioni) l’esito di una<br />
guerra; nell’atto di fondazione dello Stato nazionale viene recuperata quella<br />
violenza che aveva preceduto lo Stato nazionale di tipo nord-occidentale. Per<br />
l’Europa sud-orientale la prima guerra mondiale ha rappresentato il culmine e<br />
la conclusione di questa violenza generatrice. La fondazione «tardiva» dello<br />
Stato nazionale ha come conseguenza uno spostamento del fronte di guerra<br />
dalla politica interna alle relazioni internazionali: i conflitti che dall’età<br />
medievale avevano condotto allo State-building in Francia e Inghilterra erano<br />
combattuti tra dinastie competitrici, e non tra nazioni. Per questo secondo<br />
aspetto, Langewiesche adduce l’analogia che accomuna Germania e Italia,<br />
entrambe poste di fronte alla necessità di procedere all’unificazione di una<br />
pluralità di Stati con un atto di forza, compiuto dalle due maggiori potenze<br />
militari, Prussia e Piemonte. In ambedue i casi, il legame di determinati<br />
69 D. Langewiesche, Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert: Zwischen Partizipation und<br />
Aggression, Friedrich Ebert Stiftung, Bonn 1994; Id., Reich, Nation, Föderation. Deutschland<br />
und Europa, Beck, München 2008. Cfr. T. Schieder, Typologie und Erscheinungsformen des<br />
Nationalstaates in Europa, in H. A. Winkler (a cura di), Nationalismus, Athenäum, Königstein<br />
i. Ts. 1985, pp. 119-137. Una tipologia simile si trova in Michael Mann, che distingue<br />
«nation as state-reinforcing» (Francia e Gran Bretagna), «nation as state-creating» (Prussia-<br />
Germania) e «nation as state-subverting» (impero asburgico) ove l’accento cade su<br />
incremento, creazione o crollo del potere (M. Mann, The Sources of Social Power, vol. II:<br />
The rise of classes and nation-states 1780-1914, Cambridge University Press, Cambridge<br />
1993, p. 218).<br />
43
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
territori alla corona asburgica aveva condotto, tra il 1848 e il 1870, ad una<br />
serie di guerre di unione e parallela secessione 70 .<br />
Argomentando in maniera complementare, Thomas Nipperdey ha<br />
sostenuto che il <strong>nazionalismo</strong> romantico nel XIX secolo non fu estraneo alle tre<br />
grandi tendenze politiche della democrazia, del liberalismo e del<br />
conservatorismo. L’accento posto sul “popolo” aveva valenza democraticarivoluzionaria,<br />
perché implicava la dottrina della sovranità popolare contro lo<br />
Stato dinastico-autoritario ed era un concetto anti-elitario, egualitario contro<br />
una società divisa in ceti e classi. Inoltre, l’esaltazione della cultura nazionale<br />
aveva un carattere liberale: il richiamo alla storia era la memoria delle<br />
«libertà tedesche»; il concetto di Volksgeist era connesso alla richiesta di<br />
istituzioni liberali. Infine, il <strong>nazionalismo</strong>, con il suo orientamento alla<br />
tradizione, assunse progressivamente tratti conservatori: il popolo, come<br />
comunità naturale e organica, veniva contrapposto alla società degli<br />
individui; in assenza di uno Stato unitario, la questione dell’unità nazionale<br />
ebbe la priorità sulle questioni costituzionali di libertà e diritti individuali 71 .<br />
Jürgen Kocka, per parte sua, ha visto operare due forze contrarie nel<br />
<strong>nazionalismo</strong> <strong>tedesco</strong> del XIX secolo: una forza di integrazione, in favore<br />
dell’unità e della coesione nazionale, ed effetti di disgregazione,<br />
polarizzazione ed emarginazione; con il tempo il carattere distruttivo è<br />
prevalso sul primo, riducendo a un cumulo di macerie ciò che si voleva<br />
grande e potente. In una fortunata sintesi Kocka ha proposto un modello<br />
evolutivo per il quale, se è pur vero che la storia di ogni nazione segue un<br />
percorso differente, ciononostante ciascuna attraversa, in tempi diversi, le tre<br />
fasi che contraddistinguono lo sviluppo storico di ogni nazione: il<br />
<strong>nazionalismo</strong> «progressista», guidato da forze rivoluzionarie, emancipatrici,<br />
democratico-liberali; il <strong>nazionalismo</strong> imperialista, sostenuto da forze<br />
conservatrici e antidemocratiche; il <strong>nazionalismo</strong> democratico e aperto<br />
all’integrazione sovranazionale 72 .<br />
70 Cfr. O. Janz / P. Schiera / H. Siegrist, Centralismo e <strong>federalismo</strong> tra Otto e Novecento:<br />
Italia e Germania a confronto, il Mulino, Bologna 1997.<br />
71 T. Nipperdey, Romantischer Nationalismus, in Id., Nachdenken über die deutsche<br />
Geschichte cit., pp. 110- 125, qui p. 123 e segg.<br />
72 J. Kocka, Das Problem der Nation in der deutsche Geschichte 1870-1945, in: Id.,<br />
Geschichte und Aufklärung. Aufsätze, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1989, pp. 82-<br />
100. Kocka ha esposto questa sua tesi al pubblico italiano in occasione di una relazione<br />
44
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
1. La prima fase, coincidente con la gestazione e la nascita dello Stato<br />
nazionale, è contrassegnata da un <strong>nazionalismo</strong> “progressista”. L’idea di<br />
nazione è proclamata dal ceto medio emergente quale arma di lotta contro i<br />
poteri tradizionali e l’assolutismo, come dimostra esemplarmente il caso<br />
rivoluzionario francese. Anche in Germania, nei primi settant’anni<br />
dell’Ottocento, il progetto di unità nazionale era sostenuto particolarmente<br />
dalle forze liberali e democratiche, che avanzavano istanze di partecipazione<br />
politica e riforme costituzionali. Quando la frammentazione politica tedesca<br />
fu superata per iniziativa prussiana con la fondazione dell’Impero, il<br />
<strong>nazionalismo</strong> continuò a fungere da motore per il progresso, non più in<br />
chiave socio-politica, bensì come motivazione per la modernizzazione<br />
burocratica ed economica del Reich, nel tentativo di riguadagnare terreno in<br />
efficienza amministrativa e produttività industriale.<br />
In questo processo di formazione dello Stato nazionale, Kocka individua<br />
quattro tratti che distinguono la Germania dagli Stati occidentali. a)<br />
Riprendendo la tipologia di Schieder e Langewiesche, osserva che in Francia e<br />
Inghilterra la nazione si è formata in seno ad uno Stato unitario già esistente,<br />
mentre in Germania (e in Italia) la rivendicazione di auto-determinazione<br />
nazionale assume la forma di movimento di unificazione di una molteplicità di<br />
Stati. In ciò egli individua la ragione della diversità nel sentimento di<br />
appartenenza alla comunità nazionale, per i primi fondato sulla cittadinanza,<br />
per i secondi basato sulla comunanza di lingua, cultura e usanze. <strong>Il</strong><br />
movimento nazionale <strong>tedesco</strong>, pur mirando allo Stato-nazione, doveva far<br />
appello ad una unità pre-statale, creando miti d’origine a sostegno dell’idea<br />
di un solo, medesimo popolo. I criteri di appartenenza alla nazione<br />
apparivano dunque più arbitrari e discutibili rispetto a quelli chiaramente<br />
definiti da uno Stato unitario, in cui lingua, cultura e origini erano elementi di<br />
coesione secondari. In questo modo si spiegherebbe anche quel tratto<br />
problematico sin dall’inizio presente nel <strong>nazionalismo</strong> <strong>tedesco</strong>: l’intolleranza<br />
verso le minoranze etniche che venivano percepite come una minaccia per<br />
l’unità culturale interna. «Rispetto al concetto occidentale di Stato-nazione,<br />
l’idea di una nazione pre-statale, fondata su un popolo unito da un’unica<br />
tenuta a Palermo nel marzo 1993 in un ciclo di incontri sul tema «Quale Germania<br />
nell’Europa degli anni ’90?» (J. Kocka, Nazione e <strong>nazionalismo</strong> in Germania nella storia e<br />
oggi, Istituto Gramsci Siciliano, Palermo 1993).<br />
45
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
lingua e cultura, correva maggiori rischi di essere mitizzata e, in seguito,<br />
distorta nel senso del razzismo» 73 . b) In Germania, a differenza dell’Europa<br />
occidentale e degli Stati Uniti, la nazione non era nata (o non si era<br />
consolidata) da una rivoluzione borghese. Fallito il tentativo «dal basso» del<br />
1848/49, lo Stato nazionale era stato opera dell’autorità governativa<br />
prussiana e, nonostante la costituzione del 1871 avesse accolto non pochi<br />
elementi liberali, i poteri tradizionali della burocrazia, dell’esercito e della<br />
proprietà fondiaria conservavano la loro forza. c) Mentre gli Stati nazionali<br />
occidentali si erano formati prima della rivoluzione industriale, la situazione<br />
tedesca era complicata dalla compresenza di questione nazionale e questione<br />
sociale, che comportava, oltre ad una singolare polarizzazione del sistema<br />
partitico, la tendenza autoritaria-conservatrice del governo e delle<br />
maggioranze parlamentari. d) Infine, la creazione di uno Stato nazionale<br />
<strong>tedesco</strong>, forte e unitario, nel cuore del continente rappresentava un problema<br />
per gli equilibri internazionali. Fu l’abilità diplomatica di Bismarck, tesa ad<br />
assicurare l’estraneità tedesca da volontà di predominio, a permettere che le<br />
altre potenze europee tollerassero il nuovo rapporto di forza creatosi con il<br />
Secondo Reich.<br />
Riprendendo una polemica sollevata già dai contemporanei del<br />
Kaiserreich 74 , Kocka evidenzia un ulteriore aspetto della specificità nazionale<br />
tedesca. La fondazione del Reich nel 1871, oltre ad essere tardiva, manifesta<br />
una serie di rilevanti lacune nel processo d’integrazione nazional-statale. <strong>Il</strong><br />
Kaiserreich sorgeva, anzitutto, come unione di singoli Stati che avevano<br />
percorso la propria strada verso la statalizzazione. La nazione, sotto il profilo<br />
dell’unità amministrativa, esisteva all’inizio degli anni Settanta soltanto come<br />
possibilità da realizzare e non come realtà di fatto. Una larga parte della<br />
popolazione tedesca non percepiva ancora la propria appartenenza allo Stato<br />
nazionale. A prevalere nella quotidianità e nell’autopercezione erano piuttosto<br />
identità pre-politiche, familiari, locali, regionali, confessionali, nonostante la<br />
73 J. Kocka, Nazione e <strong>nazionalismo</strong> in Germania nella storia e oggi cit., p. 19.<br />
74 Un’esposizione delle reazioni che in Germania seguirono la proclamazione del Deutsches<br />
Reich si trova nel volume a cura di H. Böhme, Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien<br />
zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat während der Reichsgründungszeit 1848-1881,<br />
Kiepenheuer & Witsch, Köln 1966; trad. it. L’ascesa della Germania a grande potenza.<br />
Economia e politica nella formazione del Reich 1848-1881, Ricciardi, Milano / Napoli<br />
1970, pp. 1-39).<br />
46
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
comune esperienza delle guerre di unificazione. Dalla politica di potenza prenazionale<br />
della Prussia e dall’affermazione della soluzione klein-deutsch<br />
derivava poi un paradosso: popolazioni non-tedesche appartenevano,<br />
secondo la costituzione del 1871, al «popolo <strong>tedesco</strong>», mentre milioni di<br />
tedeschi si trovavano al di fuori dei confini del Reich. Si trattava di<br />
un’incongruenza con il principio della nazione culturale intesa come<br />
omogenea comunità linguistica. <strong>Il</strong> Reich comprendeva infine minoranze di<br />
nazionalità tedesca che manifestavano nei confronti dello Stato nazionale un<br />
atteggiamento di rifiuto: in particolare, la popolazione cattolica, molti<br />
democratici e il nascente movimento operaio. <strong>Il</strong> contrasto con la Germania<br />
cattolica, tenacemente radicata negli Stati meridionali, non derivava soltanto<br />
dall’opposizione fondamentale tra Stato nazionale e Chiesa universale,<br />
sopranazionale, ma dal carattere spiccatamente prussiano-protestante<br />
impresso al nuovo impero; il dissidio fu esacerbato dalla politica<br />
bismarckiana avversa al partito del Centro e alla Chiesa cattolica: il<br />
cosiddetto Kulturkampf era volto a imporre una serie di provvedimenti per<br />
sottoporre tutto il clero nazionale al controllo dello Stato e risolvere la<br />
questione della spaccatura confessionale.<br />
2. Gli Stati nazionali consolidati entrano nella seconda fase della loro<br />
evoluzione alla fine dell’Ottocento per uscirne con la seconda guerra<br />
mondiale. È la stagione del <strong>nazionalismo</strong> aggressivo e imperialista all’esterno,<br />
intollerante all’interno verso democratici e socialisti. Al volgere del secolo, con<br />
l’acuirsi delle tensioni sociali, in molti paesi il <strong>nazionalismo</strong> si va trasformando<br />
da principio progressista a ideologia di Destra, e tale svolta è particolarmente<br />
evidente in Germania, dove il connubio tra <strong>nazionalismo</strong> e liberalismo era<br />
sempre stato incerto, la predominanza della Prussia aveva conferito allo Stato<br />
un carattere spiccatamente autoritario e militarista, il consolidamento dello<br />
Stato nazionale era avvenuto con una propaganda manipolatrice contro i<br />
«nemici del Reich» (cattolici e socialdemocratici) 75 . L’ideologia nazionale cessa<br />
di funzionare come fattore integrativo e diventa strumento di separazione,<br />
esclusione e ostilità. <strong>Il</strong> governo imperiale utilizza il principio nazionale come<br />
75 Cfr. B. Vogel, Vom linken zum rechten Nationalismus. Bemerkungen zu einer<br />
Forschungsthese, in B. J. Wendt (a cura di), Vom schwierigen Zusammenwachsen der<br />
Deutschen. Nationale Identität und Nationalismus im 19. und 20. Jahrhundert, Lang,<br />
Frankfurt a. M. 1992, pp. 97-110.<br />
47
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
strumento per bandire quei partiti che chiedono la riforma o l’abbattimento<br />
del sistema politico (liberali di sinistra e socialdemocrazia) e per convogliare i<br />
conflitti d’interesse interni in aggressività verso l’esterno. L’integrazione<br />
nazionale deve essere ottenuta per vie diverse da quelle offerte dalla<br />
partecipazione rappresentativa al sistema politico. <strong>Il</strong> crescente <strong>nazionalismo</strong><br />
delle associazioni di propaganda mira non soltanto a far valere la potenza<br />
dello Stato <strong>tedesco</strong> sullo scenario mondiale, ma anche a disciplinare<br />
all’interno le forze liberali, democratiche, socialiste. Le tensioni sociali<br />
alimentano un <strong>nazionalismo</strong> in vario modo sempre più radicale: come<br />
autoconferma morale per i ceti medi posti in discussione, come risposta alla<br />
minaccia di declassamento, come mezzo per screditare un proletariato<br />
accusato d’essere anti-nazionale. Lo sciovinismo agiva anche tra le minoranze<br />
nazionali: ad esempio, nella Slesia superiore l’autoemarginazione e l’ostilità<br />
della popolazione polacca era la necessaria conseguenza del passaggio da<br />
una concezione dello Stato prussiana pre-nazionale ad una politica del Reich<br />
<strong>tedesco</strong>-nazionale.<br />
3. Per molta parte del mondo occidentale, la terza fase ha inizio con il<br />
secondo dopoguerra. Nonostante la fitta rete di rapporti e interdipendenze<br />
sovra-statali, lo Stato nazionale resta la forma di organizzazione politica su cui<br />
si fonda l’identità collettiva, benché nuovi regionalismi possano allentare il<br />
legame di coesione. Movimenti secessionisti come quello basco, irlandese e<br />
corso hanno temperato la propria violenza e imboccato la strada di trattative<br />
e compromessi. Lo Stato non ha più bisogno di ricorrere al <strong>nazionalismo</strong><br />
estremo come ideologia integrante: tensioni sociali e conflitti d’interesse<br />
vengono mediati e composti da parlamenti, sindacati, politiche di Welfare;<br />
manifestazioni di intolleranza e xenofobia restano episodi isolati. Nell’Europa<br />
orientale, invece, dopo la dissoluzione dell’impero sovietico, il <strong>nazionalismo</strong><br />
ha mantenuto ancora le caratteristiche esplosive della seconda fase, come si<br />
evince dalla recente guerra nei Balcani e dai conflitti nei territori dell’ex-<br />
Unione Sovietica.<br />
E’ particolarmente in questa fase più che nelle precedenti – sostiene ora un<br />
prevalente orientamento revisionistico della storiografia – che la Germania<br />
costituisce un’anomalia, sia rispetto alle nazioni occidentali più “mature”, sia<br />
nei confronti di quelle orientali. La sconfitta del 1945 ha significato la perdita<br />
dell’unità nazionale e la divisione in due blocchi ideologici contrapposti. A<br />
48
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
molti l’esistenza di due Stati tedeschi è parsa la logica conseguenza del fatto<br />
che nell’Europa centrale non fosse mai stato possibile coniugare uno Stato<br />
nazionale grande e potente, un ordinamento improntato ai principi liberaldemocratici<br />
ed una politica di pace. Quella vicenda nazionale dall’esito<br />
catastrofico suggeriva di percorrere la strada dell’integrazione europea<br />
piuttosto che la restaurazione di una nazione compromessa da un passato<br />
tanto illiberale. Ciò spiega anche la resistenza e le perplessità manifestate da<br />
una parte cospicua dell’opinione pubblica, attenta a mantenere vivo il ricordo<br />
dei crimini commessi, di fronte all’inarrestabile dinamica nazionale che era<br />
seguita al crollo del sistema socialista e che in tempi brevissimi — dal<br />
novembre del 1989 al marzo del 1990 — avrebbe condotto alla<br />
riunificazione. Con lo slogan «Siamo un solo popolo» i tedeschi dell’est non<br />
reclamavano soltanto la loro appartenenza all’unica nazione tedesca, ma<br />
intendevano rivendicare come proprio diritto la cancellazione della disparità<br />
economica, sociale, politica e culturale che li separava dai tedeschi<br />
dell’Ovest. La Repubblica federale, per quanto prevedesse nella propria<br />
costituzione l’obiettivo della riunificazione con la DDR, non salutò con<br />
particolare entusiasmo la riunificazione.<br />
8. 8. 8. <strong>Il</strong> <strong>Il</strong> modello modello federale<br />
federale<br />
In epoche diverse della storia la composizione federale della compagine<br />
politica tedesca (dall’ altes Reich alla Repubblica di Weimar) è stata oggetto<br />
di valutazioni divergenti: ma nel complesso, da Pufendorf al giovane Hegel a<br />
Carl Schmitt, sono prevalsi i giudizi negativi. Con il secondo dopoguerra, vale<br />
a dire con la costituzione della Bundesrepublik da un lato e con l’avvio del<br />
processo d’integrazione europea dall’altro, la tendenza si è invertita e la<br />
storiografia ha progressivamente riconosciuto nel <strong>federalismo</strong> il vero elemento<br />
di continuità nella storia tedesca 76 . In base a questo orientamento, la storia<br />
76 Sul <strong>federalismo</strong> come linea di continuità tedesca, T. Nipperdey, Nachdenken über die<br />
deutsche Geschichte cit.; H.-J. Becker, Der Föderalismus als Konstante der deutschen<br />
Verfassungsgeschichte, in J. Eckert (a cura di), Der praktische Nutzen der Rechtsgeschichte,<br />
Müller, Heidelberg 2003, pp. 23-38; D. Langewiesche / G. Schmidt (a cura di), Föderative<br />
Nation. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum Ersten Weltkrieg, Oldenbourg,<br />
München 2000; D. Langewiesche, Staatsbildung und Nationsbildung in Deutschland ― ein<br />
49
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
tedesca si distingue dal resto d’Europa non per le estremizzazioni del suo<br />
<strong>nazionalismo</strong> ma per la permanenza e l’efficacia delle sue strutture federali,<br />
che hanno impedito e rallentato la formazione di uno Stato nazionale.<br />
Per Reinhart Koselleck, la costruzione di una nazione tedesca era stata<br />
impedita per lungo tempo proprio dal fatto che «le strutture durature nella<br />
storia tedesca non erano mai state di tipo nazionale, ma da sempre<br />
federale» 77 . A suo giudizio, non si giunse mai ad una monarchia assoluta,<br />
centralizzata, perché i ceti godevano di una libertà d’unione che<br />
costantemente erodeva la gerarchia feudale culminante nel sovrano; i principi<br />
stessi si erano avvalsi di tale libertà (nel modo più efficace con la Lega dei<br />
principi nel 1785) per resistere alle ambizioni statuali degli Asburgo. Anche<br />
sotto il profilo giuridico, il <strong>federalismo</strong> rappresenta un elemento di forte<br />
continuità che lega tra loro Sacro Romano Impero, Confederazione del Reno<br />
(1806), Confederazione tedesca (1815), Confederazione tedesca del Nord<br />
(1867) e che, unendosi all’idea di Stato nazionale, ha condotto al modello di<br />
Stato federale di tipo liberale. Poiché l’Altes Reich non presentava una<br />
centralizzazione del potere sovrano ed era composto da una pluralità di Stati,<br />
l’unità nazionale tedesca fu concepita dall’Assemblea di Francoforte in forma<br />
federale, alternativa all’unità statale propria di una nazione centralizzata: la<br />
struttura di potere dell’Altes Reich e quella del suo erede, il Deutscher Bund,<br />
coniugavano unità della nazione e pluralità di Stati sotto un comune tetto<br />
istituzionale. Alla vigilia della prima guerra mondiale, ha sostenuto Thomas<br />
Nipperdey, il <strong>federalismo</strong> poteva esibire in Germania un bilancio positivo,<br />
essendo riuscito ad integrare il Reich in un’unità politica, preservando la<br />
pluralità e l’autonomia regionale; esso opponeva resistenza alla domanda di<br />
parlamentarizzazione e democratizzazione, che si sarebbe affermata con la<br />
sconfitta militare e il ridimensionamento dell’egemonia prussiana a Weimar,<br />
ma pur sempre nel quadro di un ordinamento federale 78 . Da più parti infine si<br />
è argomentato che il modello federale era ancorato così profondamente nella<br />
cultura e nella coscienza socio-politica tedesca da poter sopravvivere alla<br />
fondazione e al crollo del primo Stato nazionale ed affermarsi nell’assetto<br />
<strong>Sonderweg</strong>?, in U. v. Hirschhausen / J. Leonhard (a cura di), Nationalismen in Europa: West<br />
und Osteuropa in Vergleich, Wallstein, Göttingen 2001, pp. 49-67.<br />
77 R. Koselleck, Deutschland — eine verspätete Nation? cit., p. 370.<br />
78 T. Nipperdey, Nachdenken über die deutsche Geschichte cit., p. 87 e segg.<br />
50
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
istituzionale della Germania contemporanea, conservando fino ad oggi la sua<br />
forza. «La sconfitta in due guerre mondiali e la struttura federalista – si è<br />
sostenuto – possono avere per il momento risparmiato la Germania, a<br />
differenza di altri paesi, dalle tendenze disintegratrici del regionalismo<br />
etnico» 79 .<br />
E’ interessante rilevare qui come, sulle ceneri dell’ormai ripudiato teorema<br />
del <strong>Sonderweg</strong> (negativo), faccia la sua comparsa (o ricomparsa, in un<br />
contesto internazionale certo assai mutato) una più sobria versione di<br />
<strong>Sonderweg</strong> in senso positivo. A differenza dell’idea dei diritti fondamentali,<br />
della sovranità popolare, della divisione dei poteri, il <strong>federalismo</strong> è<br />
interpretato non come un principio universale della forma-Stato<br />
dell’Occidente bensì come «radizierte Staatsidee», una forma di<br />
organizzazione politica che, se si prescinde dal caso svizzero (di dimensioni<br />
per altro limitate), in Europa ha conosciuto durevole e stabile realizzazione<br />
soltanto in Germania 80 . A partire da questa sua identità federale la Germania<br />
è venuta discretamente ma progressivamente affermando una vocazione<br />
egemonica in Europa: questo <strong>federalismo</strong> non mira a dissolvere la sovranità<br />
tedesca nel dispositivo integrato delle competenze dell’Unione Europea, ma a<br />
germanizzare sotto il profilo amministrativo l’Europa.<br />
<strong>Il</strong> dualismo della costruzione europea, in tensione tra il principio della<br />
sovranazionalità dell’Unione e il principio della sovranità dei suoi membri 81 , è<br />
chiaramente prefigurato dalla storia del Reich tra XV e XVIII secolo. Quale<br />
alternativa allo Stato centralizzato e monocratico, il <strong>federalismo</strong> di quella<br />
costruzione appare nel dibattito recente come qualcosa di premoderno e, al<br />
79 W. Reinhard, Storia del potere politico in Europa cit., p. 619.<br />
80 J. Isensee, Idee und Gestalt des Föderalismus im Grundgesetz, in Id. / P. Kirchhof (a cura<br />
di), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Müller, Heidelberg 1990,<br />
vol. IV, p. 519: «Lo Stato federale della Legge fondamentale è una forma di Stato di origine<br />
tedesca e impronta tedesca». «La tradizione federale ha in Germania una profondità e una<br />
continuità storica maggiore della tradizione statale. L’organizzazione politica aveva il<br />
carattere di un “Bund” già all’epoca in cui non era ancora organizzata in forma statale. <strong>Il</strong><br />
Sacro Romano Impero di Nazione Tedesca, nel suo raggio d’azione sovranazionale, pur nel<br />
mutamento delle sue posizioni di forza, era sempre stato una federazione dei suoi ceti; ma<br />
non doveva trasformarsi mai in uno Stato in senso moderno» (pp. 523-24).<br />
81 Su questo dualismo M. R. Lepsius, Nationalstaat oder Nationalitätenstaat als Modell für<br />
die Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft, in Id., Demokratie in Deutschland<br />
cit., pp. 265-85; trad. it. Stato nazionale o stato delle nazionalità come modello per lo<br />
sviluppo della Comunità europea, in Id., <strong>Il</strong> significato delle istituzioni cit., pp. 363-390.<br />
51
DIPARTIMENTO DI STUDI POLITICI – UNIVERSITÀ DI TORINO<br />
tempo stesso, — alla luce delle odierne esperienze comunitarie europee — di<br />
postmoderno, al punto da giustificare la tesi dell’«asincronicità»<br />
(Unzeitgemäßheit) quale carattere peculiarmente <strong>tedesco</strong>. Lo stesso Plessner<br />
aveva già riconosciuto che la storia tedesca esigeva «una soluzione o nel<br />
senso dell’idea ecumenica prenazionale del Reich, o nel senso<br />
dell’organizzazione postnazionale degli Stati Uniti d’Europa, in ogni caso<br />
un’asincronicità perché dell’altro ieri o di dopo domani» 82 . Per questo la<br />
tradizione federalistica del Reich torna oggi ad essere considerata modello<br />
dell’unificazione europea, mentre da qualche parte si avanza il sospetto che i<br />
tedeschi vogliano tornare a dominare con l’organizzazione federalistica<br />
un’Europa modellata sulla propria tradizione 83 .<br />
Indubbiamente, il <strong>federalismo</strong> europeo ha nella Germania un modello<br />
rilevante in quello che è stato definito “<strong>federalismo</strong> asimmetrico”, dove un<br />
nucleo di Stati dominanti è affiancato da una serie di altri Stati di minore<br />
influenza 84 . La Bundesrepublik — a differenza degli altri due paesi membri<br />
con ordinamento federale, Austria e Belgio — è il solo che abbia aderito al<br />
sistema comunitario sin dalla fondazione di esso; in ragione della sua lunga<br />
esperienza, e dei suoi adattamenti ai mutamenti ambientali, più di altri paesi<br />
membri ha proposto soluzioni normative alle difficoltà poste da un’organizzazione<br />
complessa che prevede accentramento comunitario e pluralità di<br />
centri di governo 85 . L’Unione, per parte sua, pur essendo predestinata a<br />
82 H. Plessner, Die verspätete Nation cit., p. 40.<br />
83 Un giudizio per certi versi simile a questo è stato espresso nel maggio 2000 dall’allora<br />
ministro degli Interni francese Jean-Pierre Chevènement, il quale, in risposta alla visione<br />
europea esposta dall’ex ministro degli Esteri Joschka Fischer, affermò che i tedeschi<br />
sognano ancora il loro Sacro Romano Impero di Nazione Tedesca, alludendo con ciò ad<br />
un’ambizione di dominio: la Germania pretenderebbe il superamento degli Stati nazionali<br />
per poter dominare l’Europa come l’Altes Reich — secondo la sua mitizzazione ottocentesca<br />
— avrebbe fatto nel Medioevo e nella prima età moderna (cfr. “Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung”, 31 / 05 / 2000).<br />
84 Sul sistema federale <strong>tedesco</strong>, fondamentale K. Hesse, Der unitarische Bundesstaat, Müller,<br />
Karlsruhe 1962. Sulle asimmetrie, de jure e de facto, nello Stato Federale Tedesco, si<br />
vedano A. Benz, From Unitary to Asimmetric Federalism in Germany: Taking Stock after 50<br />
Years, in: “Publius”, 29/4 (1999), p. 56 e segg. e K. v. Beyme, Föderalismus und regionales<br />
Bewusstsein. Ein internationaler Vergleich, Beck, München 2007.<br />
85 Cfr. C. Baier, Bundesstaat und europäische Integration. Die „Europatauglichkeit“ des deutschen<br />
Föderalismus, Duncker & Humblot, Berlin 2006; D. Merten (a cura di), Die Zukunft<br />
des Föderalismus in Deutschland und Europa, Duncker & Humblot, Berlin 2007; C. B.<br />
Blankart, Föderalismus in Deutschland und in Europa, Nomos, Baden-Baden 2007.<br />
52
MARZIA PONSO – IL SONDERWEG TEDESCO: NAZIONALISMO E FEDERALISMO<br />
diventare uno Stato federale, resta un conglomerato di autorizzazioni da parte<br />
degli Stati membri. <strong>Il</strong> criterio per una chiara ripartizione delle competenze non<br />
è l’efficienza funzionale, bensì la divisione dei poteri, fondata<br />
normativamente. Ciò che è necessario in relazione all’ampliamento delle<br />
competenze è un notevole aumento del sistema, organizzato per Stati<br />
nazionali, delle organizzazioni intermedie e delle istituzioni per la mediazione<br />
del conflitto (partiti, sindacati, strutture di mediazione neocorporativa). Una<br />
politica industriale europea e, soprattutto, un’armonizzazione della politica<br />
sociale non è pensabile senza un sistema europeo di partiti di negoziazione<br />
capaci d’agire. Fintanto che queste strutture di intermediazione non si sono<br />
sufficientemente sviluppate resta necessario rafforzare la partecipazione degli<br />
Stati nazionali alle decisioni dell’Unione. Finché vige la regola della<br />
maggioranza, la partecipazione degli Stati membri è proceduralmente efficace<br />
soltanto in coalizione con gli altri, non indipendentemente da essi 86 . Sono<br />
questi gli aspetti in cui la struttura istituzionale tedesca, oltre a costituire un<br />
modello, presenta un vantaggio competitivo sugli altri paesi europei.<br />
86 M. R. Lepsius, Die Europäische Gemeinschaft und die Zukunft des Nationalstaates, in Id.,<br />
Demokratie in Deutschland cit., pp. 249-264, qui p. 261-263.<br />
53