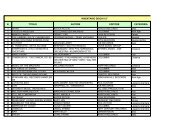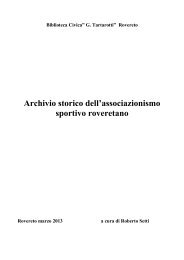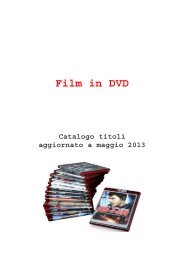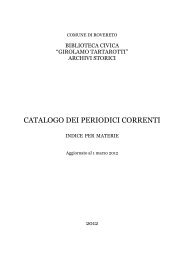11A Francesca da Rimini 1 - Biblioteca civica di Rovereto
11A Francesca da Rimini 1 - Biblioteca civica di Rovereto
11A Francesca da Rimini 1 - Biblioteca civica di Rovereto
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FRANCESCA DA RIMINI<br />
51<br />
Giorgio Barini, Riccardo Zandonai e la “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>”, “Nuova Antologia” L/1037, 1.4.1915 - pp.<br />
458-60<br />
Pochi anni fa, nel 1908, trovandomi a Milano, lessi nei giornali la notizia che al Politeama Chiarella, a<br />
Torino, an<strong>da</strong>va in scena un’opera nuovissima <strong>di</strong> un giovane sconosciuto, un trentino che aveva stu<strong>di</strong>ato nel<br />
Liceo musicale <strong>di</strong> Pesaro con Pietro Mascagni, e nel quale si avevano gran<strong>di</strong> speranze: l’opera era Il grillo del<br />
focolare, <strong>da</strong>l poetico racconto <strong>di</strong> Carlo Dickens; l’autore Riccardo Zandonai. L’impressione in<strong>di</strong>menticabile in<br />
me destata <strong>da</strong> quello spartito vivace, spigliato, elegantemente scritto, fu profon<strong>da</strong>: rare volte un esor<strong>di</strong>ente si è<br />
presentato al pubblico tanto sicuro del fatto suo, <strong>di</strong>mostrando subito <strong>di</strong> possedere un temperamento così<br />
felicemente dotato, come apparve fin <strong>da</strong>l primo momento lo Zandonai. Vennero poi Conchita e Melenis, due<br />
nuove eloquenti <strong>di</strong>mostrazioni del valore non comune del giovane maestro: e, all’Augusteo, due opere<br />
sinfoniche gustose e caratteristiche, una Serenata me<strong>di</strong>oevale ed un Poema sinfonico.<br />
Quest’anno, pure all’Augusteo, Riccardo Zandonai ha <strong>di</strong>retto una sua serie <strong>di</strong> impressioni sinfoniche <strong>da</strong>l<br />
titolo complessivo Primavera nella valle <strong>di</strong> Sole [sic]: ricor<strong>di</strong> della sua terra natale, visioni campestri, dolci alla<br />
memoria e al cuore e dolorose insieme perché non scin<strong>di</strong>bili <strong>da</strong>l pensiero angoscioso delle tristi con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
quella terra tormentata. Alba triste, Primavera nel bosco, Il ruscello, L’eco, Sciame <strong>di</strong> farfalle sono i titoli delle<br />
cinque parti in cui è <strong>di</strong>viso il ciclo sinfonico: cinque quadri, cinque paesaggi ricchi <strong>di</strong> colore magistralmente,<br />
organicamente composti, freschi e luminosi. Quadri ho detto: la forza pittorica che in essi è racchiusa è<br />
ammirevole; Riccardo Zandonai possiede una tavolozza musicale inesauribile; la sua orchestra ha una stupen<strong>da</strong><br />
varietà <strong>di</strong> tinte; la sua scrittura è sicura e scorrevole; il <strong>di</strong>segno nitido ed equilibrato. Pochi elementi tematici tra<br />
loro affini e spesso derivati l’uno <strong>da</strong>ll’altro gli bastano per un <strong>di</strong>scorso musicale sviluppatissimo.<br />
Nella facilità del comporre e nella molteplicità delle risorse armonistico-contrappuntistiche e strumentali si<br />
cela però qualche carattere negativo: premesso che il soggetto scelto e la forma con cui è attuato hanno un vizio<br />
d’origine consistente nel fatto che nei particolari e nell’insieme la ragione costantemente descrittiva esclude<br />
troppo risolutamente slanci passionali e momenti emotivi mantenendo in tutta la vasta composizione ciclica un<br />
certo carattere <strong>di</strong> impassibilità persistente che <strong>di</strong>ffonde nell’u<strong>di</strong>torio un senso <strong>di</strong> freddezza; d’altra parte il<br />
compositore nel calore della elaborazione musicale si lascia vincere <strong>da</strong>l suo temperamento ed è portato <strong>da</strong>lla sua<br />
stessa meravigliosa abilità a <strong>da</strong>re al pezzo uno svolgimento organico, quasi perdendo <strong>di</strong> vista a un certo punto lo<br />
stesso movente del suo lavoro: così lo schema formale si sovrappone quasi meccanicamente alla vaghezza<br />
indefinita della visione: il tema, inquadrandosi, assume atteggiamenti alquanto forzati ed esagerati, giungendo<br />
per ragioni esterne <strong>di</strong> euritmia a sonorità non rispondenti al significato iniziale. In tal guisa alla esteriorità<br />
sostanziale si aggiunge la esteriorità formale: ed è evidente che la genialità dello Zandonai è <strong>da</strong>vvero assai forte,<br />
visto che ciò non ostante egli è riuscito a scuotere e avvincere l’u<strong>di</strong>torio, che ha applau<strong>di</strong>to vivacemente queste<br />
impressioni sinfoniche colorite e fresche.<br />
Pochi giorni dopo al teatro Costanzi è an<strong>da</strong>ta in scena la più recente opera dello Zandonai, <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong><br />
<strong>Rimini</strong>, sulla trage<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio, che Tito Ricor<strong>di</strong> ha ridotto alle <strong>di</strong>mensioni volute per un libretto<br />
d’opera, sfron<strong>da</strong>ndola <strong>da</strong> moltissime superfluità descrittive, <strong>da</strong> molti tratti <strong>di</strong> colore non necessari allo sviluppo<br />
scenico-drammatico: sintetizzandola cioè e rendendola snella e sobria. Già fu scritto <strong>di</strong> questo spartito nella<br />
Nuova Antologia quando fu eseguito la prima volta al teatro Regio <strong>di</strong> Torino lo scorso anno: ora il pubblico <strong>di</strong><br />
Roma ha accolto con feste gran<strong>di</strong> il nuovo lavoro del maestro trentino, che è apparso solido, brillante,<br />
armonioso e a tratti <strong>di</strong> ammirevole efficacia drammatica. Certamente il poema influisce sensibilmente sulla<br />
musica: per ciò il primo atto è nella prima parte tutto colori e armonie vivaci, senza molta profon<strong>di</strong>tà fino<br />
all’ultima scena, allorché cioè con Paolo giunge amore e porta seco un alito <strong>di</strong> vita vera; una più cal<strong>da</strong> e<br />
fremente atmosfera invade la corte polentana; una nota <strong>di</strong> sentimento si leva al <strong>di</strong> sopra delle belle<br />
ornamentazioni e fa palpitare i cuori.<br />
Nel secondo atto il fragore della battaglia predomina: gli episo<strong>di</strong> che vi si intrecciano ne restano ombrati,<br />
quasi offuscati: v’è un gridore affannoso, sapientemente organizzato perché nell’apparente furiosa<br />
incompostezza giunga a poderosi effetti <strong>di</strong> sonorità prepotente: gli effetti sono trovati, ma in tanti suoni non<br />
molta è la musica. Più musica è nel terzo atto: musica delicata e gentile che si accoppia alla canzone <strong>di</strong><br />
calen<strong>di</strong>marzo cui presiedono le ron<strong>di</strong>ni... impagliate; musica affettuosa e talvolta ardente nella scena d’amore tra<br />
i due cognati: ma qui l’ombra <strong>di</strong> Dante ottiene il solito risultato smorzatore che fatalmente <strong>di</strong>minuisce tutte le<br />
Francesche e tutti i Paoli che <strong>da</strong> tempo immemorabile si aggirano sulle scene drammatiche e liriche: quell’amore<br />
che giunge <strong>da</strong>ll’uno all’altro cuore attraverso un libro, e nel libro per interposta persona; che va <strong>da</strong>ll’uno<br />
all’altro dei “duo cognati” non <strong>di</strong>rettamente, ma riflesso <strong>da</strong>lle pagine <strong>di</strong>stese sul tranquillo leggio, è<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/1
eccessivamente letterario, e per ciò anche la musica che ne riproduce gli atteggiamenti sa <strong>di</strong> letteratura: per<br />
fortuna è buona letteratura, e nei suoni delicati si rivela un sentimento che ha in sé calore e forza espansiva<br />
sufficiente per avvincere l’u<strong>di</strong>torio, che <strong>di</strong>mentica allora gli episo<strong>di</strong>etti (tutti letterari) intesi ad apportare colori e<br />
colori, senza che l’azione drammatica e psicologica se ne avvantaggino.<br />
Eccoci al primo quadro del quarto atto: qui veramente la letteratura e i riempitivi scompaiono: la scena tra<br />
l’insi<strong>di</strong>oso e perverso Malatestino e l’angosciata <strong>Francesca</strong> procede animosa e fiera, benché interrotta ad ogni<br />
momento <strong>da</strong>i lontani urli strazianti <strong>di</strong> Montagna de’ Parcita<strong>di</strong>: qui passioni ardenti cozzano forte tra loro, e la<br />
musica ha impeti e accenti vigorosi. Ancor più animato e tragicamente scan<strong>di</strong>to è ogni motto del <strong>di</strong>alogo tra<br />
Gian Ciotto e Malatestino: la gelosia feroce che tempestosamente <strong>di</strong>lania il cuore dello sposo tra<strong>di</strong>to e la<br />
viperesca arte torturatrice del minor fratello scattano con fremebon<strong>da</strong> violenza, commentate superbamente <strong>da</strong>lla<br />
musica, tutta spezzature subitanee e scorci affannosamente vibranti. Qui il temperamento drammatico <strong>di</strong><br />
Riccardo Zandonai si afferma in tutta la sua efficacia; ma il pubblico, malato <strong>di</strong> letteratura, preferisce l’amore<br />
librario e le ron<strong>di</strong>nelle pellegrine e rimane esitante e freddo al termine della scena poderosa. La secon<strong>da</strong> parte<br />
dell’atto si <strong>di</strong>lunga ancora nel chiacchierio delle ancelle, nei ricor<strong>di</strong> del passato, nei ragionamenti sulla piccola<br />
statura <strong>di</strong> Biancofiore e altre <strong>di</strong>vagazioni ornamentali; ma vien Paolo e con lui riappare il tema dell’amore, che è<br />
la più ampia e sentita frase melo<strong>di</strong>ca dello spartito, e vale a <strong>di</strong>ffondere luci subitanee e calde nel grigio<br />
minaccioso che avvolge gli adulteri: e rapi<strong>da</strong> piomba su loro la ven<strong>di</strong>catrice furia omici<strong>da</strong> <strong>di</strong> Gian Ciotto.<br />
Inutile è ripetere quanto ho già accennato circa la maestria ammirabile <strong>di</strong> Riccardo Zandonai e le qualità e<br />
attitu<strong>di</strong>ni straor<strong>di</strong>narie che fanno <strong>di</strong> lui uno dei più forti musicisti italiani viventi: inutile rilevare qualche neo,<br />
messo in maggior rilievo <strong>da</strong>gli episo<strong>di</strong> riempitivi che ancora rimangono nel dramma non ostante i coraggiosi<br />
morsi delle forbici affilate: né poteva esser <strong>di</strong>versamente perché se si eliminava tutto il superfluo non si arrivava<br />
a serbar vivi due atti. Basti ricor<strong>da</strong>re che con <strong>Francesca</strong> egli fa ancora un gran passo innanzi nell’arringo<br />
musicale drammatico: e questo suo procedere con passo sicuro alla conquista delle più alte cime dell’arte è<br />
nuova e vali<strong>da</strong> conferma delle speranze che in lui si ripongono per un nuovo rifiorire del teatro lirico italiano.<br />
NOTA. – La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> ha avuto al teatro Costanzi una esecuzione eccellente sotto ogni aspetto, e<br />
nel complesso e in ogni particolare <strong>di</strong> attuazione. Protagonista ammirabile Rosa Raisa per voce pura e cal<strong>da</strong> <strong>di</strong><br />
bellissimo timbro, per accento efficacissimo, per azione espressiva; buon Paolo il tenore Pertile <strong>da</strong>lla voce<br />
estesa, soli<strong>da</strong>, flessibile; ottimo Gian Ciotto il baritono Danise, eccellente cantante, attore coscienzioso;<br />
Malatestino eccezionale il tenore Nar<strong>di</strong> che impersona alla perfezione la torbi<strong>da</strong> figura del giovine malvagio.<br />
Impetuoso Ostasio il basso Berardo Berar<strong>di</strong> <strong>da</strong>lla voce cal<strong>da</strong> e robusta; delicata e finissima Samaritana la<br />
graziosa Olga Matteini; valente Smarag<strong>di</strong> Flora Perini; abili e <strong>di</strong>sinvolte le quattro ancelle <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>: Maria<br />
Verger, Maria Galeffi, Ines Serracchioli, I<strong>da</strong> Manarini; ottime le altre parti, e l’orchestra e il coro. Ammirato<br />
l’allestimento scenico nella sua complicazione forse non assolutamente necessaria; ottimi i costumi e gli attrezzi.<br />
52<br />
Nicola Cilenti, La “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” <strong>di</strong> R. Zandonai, “La Vittoria”, 11-12.3.1915 - p. 5, col. 1-2-3-4-5-6<br />
(con foto <strong>di</strong> Zandonai, E. Vitale, R. Raisa, A. Pertile, G. Danise)<br />
L’OPERA DI POESIA<br />
La trage<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio ha quin<strong>di</strong>ci anni <strong>di</strong> vita. Rappresentata per la prima volta al Costanzi il 9<br />
<strong>di</strong>cembre 1901, essa doveva tornarci, sulle stesse scene, iersera, nella nuova veste musicale creatagli <strong>da</strong>l maestro<br />
Zandonai, e nella quale ha trovato, a Torino come a Milano, a Londra come a Modena e a Pesaro, già quelle<br />
lietissime accoglienze che non s’ebbe al suo primo affacciarsi alla vita scenica.<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> tuttavia, pur contenendo in sé i <strong>di</strong>fetti <strong>di</strong> esuberanza e quelli più specifici del teatro<br />
<strong>da</strong>nnunziano, resta ancor oggi opera altissima <strong>di</strong> poesia, fra le meglio pensate ed espresse <strong>da</strong>ll’autore delle<br />
Lau<strong>di</strong> e della Figlia <strong>di</strong> Jorio. Sappiamo con quale amore, con quanta vigile <strong>di</strong>ligenza il poeta abbia frugato nello<br />
stu<strong>di</strong>o del costume, derivando la verità del senso storico e d’ambiente “<strong>da</strong>l padre Dante, <strong>da</strong>l Barberino, <strong>da</strong>i poeti<br />
bolognesi, <strong>da</strong>i cronisti, <strong>da</strong>i novellatori, <strong>da</strong>i miniatori, <strong>da</strong>i documenti più rari e più <strong>di</strong>versi”. E sappiamo quanto a<br />
lui piacque la parola d’elogio del suo giu<strong>di</strong>ce più onesto e più dotto, Isidoro Del Lungo.<br />
Alla <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong>nnunziana nocquero però la sua stessa vastità, la sua stessa ricchezza <strong>di</strong> particolari, la sua<br />
stessa paziente religiosità <strong>di</strong> ricerca, che la resero pletorica come opera <strong>di</strong> teatro, in un paese dove passano per<br />
autori fortunati <strong>di</strong> teatro Giannino Antona-Traversi, Alfredo Testoni, Domenico Tumiati, e dove un purchessia<br />
autore francese <strong>di</strong> pochades e <strong>di</strong> vaudevilles, a traverso la <strong>di</strong>tta <strong>di</strong> Dina Galli e Ci, può tenere innumerevoli sere<br />
il cartellone, mentre il pubblico oblia e <strong>di</strong>serta autori nostri forti e pensosi come Butti e Bracco.<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> ha inoltre un atto, il secondo, artificioso e convenzionale, che devia un po’ l’opera<br />
<strong>da</strong>l suo senso d’umanità e <strong>di</strong> verità. Ma anche nell’episo<strong>di</strong>o della battaglia il poeta ebbe intera la visione del<br />
quadro scenico; e via, <strong>di</strong>ciamolo forte, questa trage<strong>di</strong>a <strong>da</strong>nnunziana non è solamente opera originale e magnifica<br />
<strong>di</strong> poesia, ma opera schietta <strong>di</strong> teatro, in cui le figure centrali <strong>di</strong> Paolo e <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, <strong>di</strong> Gianciotto e <strong>di</strong><br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/2
Malatestino son vigorosamente scolpite e vivono la loro vita reale, drammatica: d’amore e <strong>di</strong> passione,<br />
d’angoscia e <strong>di</strong> vendetta. E chi non senta ancor oggi la bellezza essenziale del primo, del terzo e del quarto atto<br />
della <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> è destinato per sempre ad esser cieco <strong>di</strong> fronte alle più pure espressioni d’arte.<br />
Riccardo Zandonai, affrontando la nobilissima fatica <strong>di</strong> musicare l’opera <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio, trovò in<br />
Tito Ricor<strong>di</strong> il riduttore felice e sapiente del libretto. Dei quattromila versi all’incirca in cui la trage<strong>di</strong>a si<br />
componeva non ne son rimasti nella sua riduzione che un mille e duecento; e se molti episo<strong>di</strong> lirici e scenici<br />
sono stati aboliti o limitati, il centro vivo dell’azione è rimasto integro.<br />
I versi, le <strong>di</strong><strong>da</strong>scalie, le scene, se ben ridotte, non sono state toccate né offese. E il poeta vi parla ancora, col<br />
suo linguaggio inimitabile, ricco e armonioso.<br />
Delle persone del dramma non ritroviamo più Bannino né il mercatante, il fanticello, il me<strong>di</strong>co, l’astrologo,<br />
che formavan tanta parte episo<strong>di</strong>ca nel terzo atto. E così son spariti alcuni fra i partigiani <strong>di</strong> Guido Minore <strong>da</strong><br />
Polenta e altri <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> Malatesta e qualcuna delle donne <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>.<br />
Il primo atto si è quin<strong>di</strong> alleggerito <strong>di</strong> tutta la lunga scena <strong>di</strong> violenza fra Ostasio e Bannino; e la gente <strong>di</strong><br />
contorno e <strong>di</strong> sfondo ai quadri scenici <strong>di</strong>ce più brevi parole.<br />
Il terzo atto, senza gli episodî del mercatante, dell’astrologo, ecc. corre più spe<strong>di</strong>to. Anche la dolce,<br />
soavissima canzone <strong>di</strong> calen<strong>di</strong>maggio è stata abbreviata <strong>di</strong> qualche strofe.<br />
Il quarto e quinto atto ne formano uno solo <strong>di</strong>viso in due quadri, poiché l’antico atto quarto finisce ora con la<br />
breve, drammaticissima scena tra Gianciotto e Malatestino, essendo stata completamente tagliata via quella<br />
ultima fra Paolo, Malatestino e Gianciotto. Ma, nella nuova veste, sarebbe desiderabile l’abolizione pressoché<br />
completa dell’inutile secondo atto (che nulla <strong>di</strong>ce all’azione necessaria della trage<strong>di</strong>a, se se ne tolga l’episo<strong>di</strong>o<br />
cruento <strong>di</strong> Malatestino) e una più vasta rappresentazione del quarto atto, ch’è appunto il più vivo d’azione, il più<br />
tragico, il più fosco. Riccardo Zandonai non ha invece voluto rinunziare agli effetti sonori della battaglia e al<br />
comento orchestrale del “màngano” poderoso.<br />
Così come n’è risultato, il libretto della <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> è tuttavia agile, drammatico, liricissimo, atto ad<br />
ispirare veramente un’anima <strong>di</strong> musicista poeta. E Riccardo Zandonai ha senza dubbio, per questo lato, avuta<br />
più fortuna che non Pietro Mascagni con la Parisina, dove l’azione ristagna spesso in esuberanze verbali e pur<br />
dove molto invece il compositore avrebbe potuto tagliare e sorvolare se ingenuamente non avesse accettato il<br />
poema con de<strong>di</strong>zione assoluta.<br />
Come Riccardo Zandonai è riuscito a <strong>da</strong>re un’anima musicale a <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>? Come e fin dove è<br />
egli riuscito ad aderire al poema tragico <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio?<br />
LA MUSICA<br />
Il successo che l’ultima opera dell’autore <strong>di</strong> Conchita e <strong>di</strong> Melenis ha ottenuto dovunque si sia rappresentata<br />
e le critiche e le cronache abbon<strong>da</strong>nti che il successo determinò ci risparmiano ora una lunga analisi.Basterà<br />
dunque accennare, per la prima rappresentazione romana <strong>di</strong> iersera dello spartito <strong>di</strong> Zandonai, a qualche<br />
elemento specifico della musica dei quattro atti della trage<strong>di</strong>a e procedere poi sinteticamente a una conclusione<br />
generale dell’opera.<br />
La scena del primo atto rappresenta una corte nelle case dei Polentani, che si ravviva subito del gaio<br />
cicaleccio delle Donne <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> intorno al Giullare. Ma la musica <strong>di</strong> tutta la prima metà <strong>di</strong> quest’atto<br />
procede senza interesse, tagliata via in fretta <strong>da</strong>l compositore sopra recitativi informi che non <strong>da</strong>nno affatto il<br />
senso d’ambiente e non riescono a rappresentarci la vivacità scherzosa del <strong>di</strong>alogo. Il primo momento <strong>di</strong><br />
interesse sorge alla canzone accennata su la viola, <strong>da</strong>l Giullare: “Or venuta che fue l’alba del giorno...” che<br />
s’interrompe con l’irosa minaccia <strong>di</strong> Ostasio; e le parole <strong>di</strong> costui sono comentate <strong>da</strong>l musicista con indubbia<br />
efficacia. Ma il <strong>di</strong>alogo seguente fra Ostasio e Ser Toldo ci riporta a un recitativo noioso e scolorito che dura<br />
fino alla scena seguente, dove il coro delle donne annuncia l’entrata <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> e <strong>di</strong> Samaritana. Da questo<br />
momento sino alla fine dell’atto Riccardo Zandonai ci appare veramente compenetrato nello spirito della<br />
trage<strong>di</strong>a, coloritore sapientissimo e ricco <strong>di</strong> gusto. E se il canto <strong>di</strong> cui egli ha inteso <strong>di</strong> rivestire la giovanile<br />
dolcezza <strong>di</strong> Samaritana, su note esageratamente acute, non ci convince e ci sembra anzi inadeguato al soave<br />
personaggio, la figura <strong>di</strong> amore e <strong>di</strong> passione <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> è <strong>da</strong>ta intera e non ci abbandonerà più. Il finale<br />
dell’atto è mirabilmente suggestivo. La scena s’è coperta un poco d’ombra. Le donne annunziano la presenza <strong>di</strong><br />
Paolo che viene <strong>da</strong>lla parte del giar<strong>di</strong>no, mentre i tre donzelli sulla loggia suonano e comentano così il carattere<br />
dolce e triste <strong>di</strong> tutta la scena. E Paolo entra, quasi immobile, <strong>da</strong>l cancello, adesso che il coro s’attenua sulle<br />
parole della canzone Per la terra <strong>di</strong> maggio... L’atto si chiude sulla scena quasi muta dell’offerta della rosa.<br />
Samaritana risale alle logge piangendo; certo, basta qui la sola bellezza del dramma, e la liricità del quadro, a<br />
suscitare la più grande commozione; ma il musicista ha saputo seguire e sentire, appunto, tutta la bellezza del<br />
momento scenico e a<strong>da</strong>ttarvi i suoi colori sottili con raro senso <strong>di</strong> aderenza. La melo<strong>di</strong>a che in orchestra si<br />
sprigiona ad esprimere il fato d’amore e d’angoscia <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> e i motivi della canzone arcaicamente trovati<br />
sul violoncello e la viola sono perfettamente intonati ora a quel senso d’ambiente che sembrava prima smarrito o<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/3
evitato. Il finale del primo atto è dunque, fra gli episodî musicali della <strong>Francesca</strong>, uno dei più felici e dei più<br />
indovinati.<br />
Il secondo atto, com’era nella trage<strong>di</strong>a <strong>da</strong>nnunziana il più manchevole, lo è anche <strong>da</strong>l lato musicale. Qualche<br />
àttimo <strong>di</strong> sincerità nel <strong>di</strong>alogo fra Paolo e <strong>Francesca</strong> non basta a coprire il vuoto desolante ond’è espresso. Si<br />
accoglie quasi con un senso <strong>di</strong> liberazione quin<strong>di</strong> la apparizione irata <strong>di</strong> Gianciotto, che risulta significativa e<br />
ben definita. Ma la scena seguente <strong>di</strong> Malatestino, che dovrebbe far fremere e metter brivi<strong>di</strong> <strong>di</strong> drammaticità,<br />
non riesce a scuotere né ad avvincere. Riccardo Zandonai, se ha intesa la figura <strong>di</strong> Gianciotto, è passato accanto<br />
a Malatestino senza neppure sfiorarne il carattere e l’essenza drammatica. Non lo ha capito, non lo ha sentito<br />
affatto. Ed anche per ciò il secondo atto, che poteva avere in questo episo<strong>di</strong>o un valore notevole <strong>di</strong> arte, si<br />
conclude com’era cominciato: in mezzo a un fragore assor<strong>da</strong>nte <strong>di</strong> legni, d’ottoni e <strong>di</strong> timpani che, insieme alle<br />
gri<strong>da</strong> dei balestrieri e degli arcieri, vorrebbero significarci l’impeto e l’ardore della battaglia. La pagina<br />
orchestrale è indubbiamente scritta bene e le voci <strong>di</strong>ffuse della folla sulla scena son trattate <strong>da</strong> un maestro sicuro<br />
dei suoi mezzi; ma tutto ciò non basta a farci mutare il giu<strong>di</strong>zio generale sul secondo atto.<br />
L’atto terzo è il migliore, il più ispirato dei quattro musicati <strong>da</strong> Riccardo Zandonai. È tutto pervaso <strong>di</strong><br />
lirismo, ed è sempre contenuto in una linea purissima <strong>di</strong> melo<strong>di</strong>a e <strong>di</strong> strumentale. Il compositore ha tratto in<br />
parte <strong>da</strong>i nostri settecentisti quel vago sapore arcaico <strong>di</strong> cui frequentemente si compiace quando affi<strong>da</strong> la sua<br />
ispirazione in prevalenza agli archi: violini, viole, violoncelli con sapientissima combinazione dei clarini e<br />
dell’oboe, e quando ritma le cadenze in forma d’arpeggi sottili. Quest’atto ha due scene principali: quella delle<br />
donne echeggianti in ritmo <strong>di</strong> <strong>da</strong>nza la bellissima Canzone alla Primavera e quella del bacio <strong>di</strong> Paolo e<br />
<strong>Francesca</strong> sul leggìo dov’è aperto il libro della Historia <strong>di</strong> Lancillotto del Lago. La canzone è cosa<br />
delicatissima, piena <strong>di</strong> stile, tutta compenetrata della ingenua freschezza dei musicalissimi versi <strong>di</strong> Gabriele<br />
d’Annunzio; e meriterebbero maggior rilievo <strong>di</strong> quello che s’ebbe ier sera.<br />
Ma il momento <strong>di</strong> culminazione musicale, dove lo Zandonai aderisce perfettamente al testo e <strong>di</strong>mostra <strong>di</strong><br />
vibrare a contatto delle anime della trage<strong>di</strong>a, è tutto il duetto d’amore <strong>di</strong> Paolo e <strong>Francesca</strong>, così acutamente<br />
preparato <strong>da</strong>llo stato d’animo della donna.<br />
La frase <strong>di</strong> congedo <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> alle sue ancelle, Felice primavera!, smorza, in forma <strong>di</strong> perorazione, la<br />
scena precedente d’allegrezza canora e l’orchestra comenta appassionatamente l’episo<strong>di</strong>o, finché una nuova<br />
frase dell’oboe annunzia la venuta <strong>di</strong> Paolo. Segue il colloquio d’amore che, ripeto, è la pagina più efficace e<br />
ispirata <strong>di</strong> tutta l’opera. Ma, si ba<strong>di</strong>, la melo<strong>di</strong>a neppur qui si conclude nei confini dell’aria o del motivo vero e<br />
proprio; fluisce invece libera e densa d’emozione <strong>da</strong>l fluir medesimo delle parole del poema, le contrassegna e<br />
le accompagna; le rivive pienamente. È qui la <strong>di</strong>mostrazione più chiara della capacità <strong>di</strong> Riccardo Zandonai ad<br />
esprimere la materia lirica, con una eleganza e una sincerità <strong>di</strong> gusto che pochi dei moderni hanno, in confronto<br />
<strong>di</strong> lui. Peccato che la scena meravigliosa del bacio trovi, verso la fine dell’atto, attenuata in un momento la<br />
purezza della sua linea: quando l’orchestra riempie la pausa con eccessiva ed irritante sonorità!<br />
Nel quarto atto la materia drammatica incalza. Ma il musicista ci riappare stanco e scialbo. La scena infatti è<br />
qui tutta superata <strong>da</strong>l sarcasmo bieco e <strong>da</strong>lla ferocia tragica <strong>di</strong> Malatestino. Ma questi nemmeno ora riesce a<br />
caratterizzarsi, a specificarsi lucido e aguzzo come una spa<strong>da</strong>, tal quale il poeta lo ha visto e significato.<br />
L’episo<strong>di</strong>o del Montagna prigioniero non ci dà alcun guizzo <strong>di</strong> terrore; né, più tar<strong>di</strong>, in confronto dell’ira e della<br />
ven<strong>di</strong>cativa collera <strong>di</strong> Gianciotto, Malatestino trova mai veramente un accento <strong>di</strong> verità e <strong>di</strong> forza: ché anzi<br />
talora la musica, credendo <strong>di</strong> renderlo ironico e sottilmente maligno, lo veste d’un innaturale colore dolciastro<br />
ed elegiaco.<br />
Questa prima parte del quarto atto, se trova verso la fine qualche momento <strong>di</strong> forza e <strong>di</strong> vigor tragico, lo<br />
deve alla figura <strong>di</strong> Gianciotto che, come già <strong>di</strong>ssi, è stata <strong>da</strong>l musicista compresa e quasi sempre rivelata. Ed<br />
eccoci all’ultima parte della trage<strong>di</strong>a, che s’apre sul sonno angoscioso <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, mentre le donne parlano<br />
sommessamente vegliando nella sua camera. Il chiacchierio delle ancelle e il risveglio improvviso <strong>di</strong> Madonna<br />
non contengono nulla <strong>di</strong> notevole. Solo quando <strong>Francesca</strong>, avendo conge<strong>da</strong>te Donella, Garsen<strong>da</strong> ed Altichiara,<br />
s’indugia con Biancofiore a parlar <strong>di</strong> Samaritana, la musica si rifà soave e tenera e nell’orchestra trema<br />
veramente qualche lacrima, dopo che il violoncello ha accennato il tema intorno alle parole: O Biancofiore,<br />
piccola tu sei! Ma il nuovo duetto fra Paolo e <strong>Francesca</strong> e l’amplesso ardente che precede la uccisione degli<br />
amanti non convincono pel modo onde il musicista ha voluto renderli. Si torna all’artifizioso, all’enfatico,<br />
all’insincero. Perché tutta quella sonorità <strong>di</strong> strumentale? Il compositore ha creduto forse <strong>di</strong> significare la<br />
potenza ultima del dramma, e non è riuscito invece che a un superficiale clamore d’ottoni e <strong>di</strong> timpani. Si capiva<br />
un pieno vibrante d’archi sulla meravigliosa scena d’amore; ma non il fragore esasperato, che ricor<strong>da</strong> forse il<br />
<strong>di</strong>scepolo malaccorto <strong>di</strong> Pietro Mascagni. Tutto il resto dell’atto, quin<strong>di</strong>, e la finale vendetta dello Sciancato si<br />
perdono in questo fragore che può ottenere il suo effetto sul pubblico ma non s’eleva per nulla alla grandezza<br />
possente della trage<strong>di</strong>a.<br />
Da questa rapi<strong>da</strong> scorsa alla musica dei quattro atti della <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> possiamo conclusivamente<br />
stabilire che Riccardo Zandonai è riuscito assai meglio a ravvivare dell’opera sua le parti liriche anziché quelle<br />
drammatiche. Perciò la fine del primo e tutto il terzo atto rimangono affermazioni nobilissime d’un artista che<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/4
merita comunque il <strong>di</strong>ritto al consentimento del pubblico e della critica. E se il musicista non è stato altrettanto<br />
felice nella scelta dei mezzi al secondo e al quarto atto, bisogna tuttavia riconoscere che egli ha sbagliato ma<br />
non ha ceduto mai alle vecchie forme volgari, e veramente per lui superate, del melodramma italiano. Egli,<br />
questo giovane della nostra più seria e più colta e più attenta generazione, vale dunque ad in<strong>di</strong>carci una via<br />
nuova, poi che porta in sé i segni certi <strong>di</strong> una più chiara sensibilità e d’una più moderna elevazione delle forme<br />
dell’arte sua. Ché, s’egli si muove ancora nei limiti d’un sapiente ecclettismo, egli vuole pur manifestarlo con un<br />
raro talento e con una personale visione, scegliendo ed elaborando tra i vari elementi <strong>di</strong> coltura e <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o quelli<br />
che poi sa rivivere e trasformare a traverso il proprio temperamento. L’avere scelto intanto per soggetto della<br />
più recente fatica l’opera eccelsa <strong>di</strong> Gabriele D’Annunzio ed essere riuscito in gran parte a contenerla in sé e<br />
nella sua anima per riesprimerla musicalmente <strong>di</strong>mostra in Riccardo Zandonai l’assoluta potenzialità e la degna<br />
preparazione al compimento <strong>di</strong> altre così nobili fatiche d’arte, ma più totali e più organiche e più decisive.<br />
L’INTERPRETAZIONE<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> è tale opera che non abbisogna solo <strong>di</strong> cantanti valorosi ma <strong>di</strong> artisti<br />
intelligentissimi, si attori efficaci. Il cantante infatti non si trova <strong>di</strong> fronte al solito libretto melodrammatico in<br />
cui le parole abbiano valore soltanto se riferite alla musica, oltre <strong>di</strong> che sarebbero trascurabili, ma deve qui<br />
invece sentire continuamente la bellezza della forma onde s’esprime il contenuto della trage<strong>di</strong>a e <strong>da</strong>r quin<strong>di</strong> la<br />
massima vita scenica alle vicende dell’azione. Diciamo subito che la prova fu ieri sera quasi completamente<br />
vinta <strong>da</strong>i bravissimi interpreti del Costanzi.<br />
Rosa Raisa fu una <strong>Francesca</strong> perfetta. La sua voce bellissima, sicurissima <strong>di</strong> timbro e d’intonazione si<br />
contenne sempre in una linea <strong>di</strong> passionalità aderente al personaggio alto e <strong>di</strong>fficile. La sua figura fisica, il suo<br />
intuito mirabile <strong>di</strong> attrice, tutto, del resto, concorse a che la Raisa esprimesse con la più chiara forma il dramma<br />
profondo dell’eroina <strong>da</strong>ntesca. Nessuna esagerazione in lei, come nessun momento <strong>di</strong> assenza <strong>da</strong>lla visione<br />
totale del dramma. Fu soave e tenera, e angosciosa e fremente secondo lo richiedeva l’azione. Si vede, si sente<br />
ch’ella è innamorata della sua parte, che l’ha stu<strong>di</strong>ata con grande amore, con commossa anima, che l’ha<br />
accettata intera e intera le si è donata. E ciò è degno indubbiamente d’una grande artista. Chi, iersera, non s’è<br />
sentito penetrare il cuore alle parole <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> e Samaritana nel primo atto, Anima cara, piccola colomba; e a<br />
quelle del duetto del terzo atto, Paolo, <strong>da</strong>temi pace!, dette <strong>da</strong>lla Raisa con la più sincera emozione?<br />
Ottimo Paolo apparve il tenore Aureliano Pèrtile. La sua parte, specialmente nel secondo e nel quarto atto, è<br />
aspra <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà; ma il Pertile seppe superarla con onore. La sua voce ebbe momenti <strong>di</strong> grande efficacia nel<br />
magnifico declamato del terzo atto, Perché volete voi – ch’io rinnovi nel cuore la miseria – <strong>di</strong> mia vita?<br />
Il baritono Giuseppe Danise, cara conoscenza del pubblico del Costanzi, era nelle vesti <strong>di</strong> Gianciotto. La<br />
parte <strong>di</strong> Giovanni lo Sciancato, così piena <strong>di</strong> rilievo sia <strong>da</strong>l lato teatrale che <strong>da</strong> quello musicale, trovò in questo<br />
artista una magnifica espressione. Sin <strong>da</strong> quando lo Sciancato appare nel secondo atto per la botola, tutto in<br />
arme, su la scala della Torre Mastra, il Danise <strong>di</strong>mostrò <strong>di</strong> possedere a pieno il violento e feroce personaggio.<br />
Egli <strong>di</strong>sse con magnifico impeto la minaccia Per Dio, gente poltrona, razzaccia sgherra e fu efficacissimo nella<br />
breve serrata scena del quart’atto fra Gianciotto e Malatestino.<br />
Il quale Malatestino, già sacrificato <strong>da</strong>lla musica <strong>di</strong> Zandonai, non trovò nel tenore Nar<strong>di</strong> l’interprete<br />
adeguato. Manca al Nar<strong>di</strong> la figura fisica <strong>di</strong> Malatestino, che dovrebbe vivere d’una vita ardentissima sulla<br />
scena. Iersera il più scolpito dei personaggi della <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong>nnunziana era irriconoscibile: senza corpo e<br />
senz’anima. Però, ripeto, la colpa non è tutta del Nar<strong>di</strong> che, se anche fosse riuscito a lavorar astutamente <strong>di</strong><br />
scena, non poteva costruire una parte che il musicista non gli ha <strong>da</strong>to.<br />
Un magnifico Ostasio fu invece il Berar<strong>di</strong>. La parte è breve e dura quanto metà del primo atto, ma è chiara,<br />
decisa, vigorosa. Il Berar<strong>di</strong> la espresse con la sua maschia voce e con l’intuito scenico che lo <strong>di</strong>stingue. Giova<br />
poi notare che il valoroso basso si a<strong>da</strong>ttò a una parte scritta per baritono, per la sua viva deferenza al maestro<br />
Zandonai e alla Impresa. Ma il personaggio <strong>di</strong> Ostasio, mercé la sua vali<strong>di</strong>ssima opera, non fece che<br />
gua<strong>da</strong>gnarne.<br />
Bene la Matteini nelle vesti <strong>di</strong> Samaritana, che presenta non lievi <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> canto. E bene nelle loro parti<br />
secon<strong>da</strong>rie la Perini (una Smarag<strong>di</strong>, la schiava, assai dolce e piena <strong>di</strong> grazia), la Galeffi (Donella), la Verger<br />
(Altichiara), la Manarini (Garsen<strong>da</strong>), la Seracchioli (Biancofiore), il tenore Sabatano (Ser Toldo Berardengo) e<br />
il basso Gironi (il Giullare) e il Pastorelli e il Lanzi.<br />
Le masse apparvero ben fuse e <strong>di</strong>strubuite; forse troppo numerose e affollate <strong>da</strong> non potersi agevolmente<br />
<strong>di</strong>stricare nella scena del secondo atto (sulla cima della torre malatestiana), che in ogni modo riuscì d’un effetto<br />
gran<strong>di</strong>oso. Non molto armoniosa sembrò invece la <strong>da</strong>nza delle donne <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, nella canzone alla<br />
Primavera (terzo atto).<br />
Ma i costumi, ma gli scenarii: una gioia acutissima per gli occhi. Le scene non possono essere più sapienti,<br />
intonate più perfettamente al senso d’ambiente. E gli effetti <strong>di</strong> luce, specie nell’episo<strong>di</strong>o della battaglia,<br />
riuscitissimi.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/5
Di tutto ciò l’Impresa del Costanzi, coa<strong>di</strong>uvata <strong>da</strong> Tito Ricor<strong>di</strong>, <strong>da</strong> Carlo Clausetti e <strong>da</strong>i suoi migliori<br />
elementi <strong>di</strong> coreografia, <strong>di</strong> scena, <strong>di</strong> macchinari, merita la più sincera, la più alta lode. Questo spettacolo è stato<br />
allestito con degnissimo senso d’arte, con profusione completa <strong>di</strong> mezzi; e non poteva dunque non ottenere il<br />
caldo successo <strong>di</strong> ammirazione del grande pubblico <strong>di</strong> Roma.<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>di</strong> Riccardo Zandonai trovò il migliore dei suoi collaboratori nel maestro Edoardo Vitale, che<br />
la concertò con lungo e paziente stu<strong>di</strong>o, con sincerissimo amore; e la <strong>di</strong>resse iersera con tutta la sua anima <strong>di</strong><br />
artista coscienzioso e valorosissimo. Edoardo Vitale riuscì a comunicare il suo sacro fuoco all’orchestra, che se<br />
ne compenetrò perfettamente, e ci <strong>di</strong>ede un’esecuzione dell’opera veramente ammirevole per fusione e calore<br />
drammatico.<br />
LA CRONACA DEL SUCCESSO<br />
L’enorme folla convenuta in teatro si <strong>di</strong>mostrava, fin <strong>da</strong>ll’inizio dello spettacolo, ansiosa e impaziente.<br />
Ma non appena il maestri Vitale è comparso sul po<strong>di</strong>o, il silenzio s’è fatto religioso, solo interrotto <strong>da</strong>lle<br />
proteste contro i soliti pervicaci ritar<strong>da</strong>tarii.<br />
Lo spettacolo è cominciato alle 8.30 precise. Tutto il primo atto è stato ascoltato con appassionata<br />
attenzione, che s’è alla fine, dopo la scena meravigliosa che lo conclude, mutata in consentimento unanime,<br />
spontaneo, pieno. Vi sono tre chiamate agli interpreti valorosissimi, poi altre due al maestro Vitale che appare<br />
insieme a Riccardo Zandonai, acclamato fervi<strong>da</strong>mente; e ancora altre due chiamate in cui il musicista ritorna<br />
solo alla ribalta.<br />
Nell’intervallo, che dura più <strong>di</strong> tre quarti d’ora per metter sù la magnifica scena del secondo atto, è notata la<br />
presenza, in un palco <strong>di</strong> secondo or<strong>di</strong>ne, <strong>di</strong> Sua Eccellenza il presidente del consiglio on. Salandra, che si mostra<br />
sereno e attento. Ciò vale a determinare nella sala, fra le <strong>di</strong>scussioni sulla <strong>Francesca</strong>, i più varii commenti <strong>di</strong><br />
neutralisti e... interventisti. Ma in prevalenza si conclude con l’intuire che la situazione italiana si va...<br />
rischiarando.<br />
Il secondo atto, com’era <strong>da</strong> prevedersi, non è stato accolto con lo stesso entusiasmo del primo. Tuttavia,<br />
poiché il finale prende, se non per la musica per la originalità del momento scenico, si hanno tre chiamate: una<br />
agli interpreti, una in cui Zandonai si presenta col maestro Vitale, e l’ultima in cui il musicista torna solo.<br />
Il successo ha culminato grande e schietto al terzo atto. Il pubblico lo ha seguito e ne ha ammirata tutta<br />
l’intima bellezza.<br />
La Raisa e il Pèrtile hanno d’altra parte <strong>da</strong>to il rilievo più felice al grande duetto <strong>di</strong> Paolo e <strong>Francesca</strong>. Non<br />
si poteva far meglio; non si poteva meglio esprimere per virtù <strong>di</strong> canto e d’arte scenica il bellissimo squarcio<br />
lirico. Il Pèrtile è stato salutato <strong>da</strong> un grande applauso a scena aperta, che s’è rinnovato cal<strong>di</strong>ssimo, per lui e per<br />
la Raisa, alla fine dell’atto. Si numerano do<strong>di</strong>ci chiamate agli artisti, a Zandonai, al Vitale, che ha <strong>di</strong>retto con<br />
magnifico senso d’arte.<br />
L’autore è costretto infine a presentarsi solo, fra deliranti acclamazioni.<br />
Il quarto atto, se attenua un po’ il successo magnifico del terzo, non toglie nulla al fervore con cui<br />
generalmente la <strong>Francesca</strong> ha iersera trionfato.<br />
Alla fine della prima parte v’è stato un lungo applauso, e alla fine dell’opera altre cinque chiamate<br />
complessive agli artisti, al Zandonai, al maestro Vitale.<br />
Il successo è dunque stato completo. Lo spettacolo è finito alle 12 e tre quarti.<br />
53<br />
Alberto Gasco, <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Zandonai al Teatro “Costanzi”, “La Tribuna”, 12.3.1915 - p. 3, col. 3-<br />
4-5<br />
C’è <strong>da</strong> tremare nell’imprendere a rivestir <strong>di</strong> note un poema drammatico <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio. Si sa che<br />
canone fon<strong>da</strong>mentale <strong>di</strong> ogni buon libretto d’opera è la chiarezza dell’eloquio, l’incisività del periodo, la sintesi<br />
del pensiero. Sotto questo triplice aspetto un lavoro teatrale del d’Annunzio sembra precisamente l’opposto <strong>di</strong><br />
quel che deve essere un dramma per musica. Si sa infatti che il nostro massimo poeta vivente ama cesellare il<br />
verso adornandolo <strong>di</strong> parole peregrine, smaltandolo <strong>di</strong> aggettivi rari, e pro<strong>di</strong>ga senza freni le immagini, le<br />
similitu<strong>di</strong>ni, i ricor<strong>di</strong> storici e mitologici, anche quando il dramma giunge al parossismo e la necessità stringe le<br />
anime eroiche. La sua poesia, carica <strong>di</strong> fiori e <strong>di</strong> orpelli, obbliga il musicista ad un lavoro minuto <strong>di</strong> analisi: non<br />
basta rendere l’idea, il sentimento, bisogna mettere in rilievo ad una ad una le parole se non si vuol essere<br />
infedeli al testo prezioso. E allora si corre il rischio <strong>di</strong> fare come Pietro Mascagni per “Parisina”: comporre cioè<br />
un’opera <strong>di</strong> valore artistico non dubbio ma <strong>di</strong> effetto teatrale incerto.<br />
Il maestro Zandonai sarebbe forse annegato nel pelago letterario <strong>da</strong>nnunziano se l’e<strong>di</strong>tore Ricor<strong>di</strong>,<br />
assumendo l’ufficio <strong>di</strong> collaboratore del poeta, non fosse sopraggiunto in tempo a salvarlo. Tito Ricor<strong>di</strong> non ha<br />
avuto soverchi (e <strong>da</strong>nnosi) riguar<strong>di</strong> verso il testo della trage<strong>di</strong>a. Con un coraggio leonino ha tagliato via brani<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/6
interi, episo<strong>di</strong> lunghi a base <strong>di</strong> narrazioni desunte <strong>da</strong>lle annose cronache, geniali <strong>di</strong>vagazioni poetiche, scene <strong>di</strong><br />
colore e <strong>di</strong> ambiente, <strong>di</strong>ra<strong>da</strong>ndo la selva fitta sino a farne un’oasi nella quale le persone, non più celate <strong>da</strong>lle<br />
troppe fronde, potessero apparire in tutta l’avvenenza loro, agili e pronte all’opera <strong>di</strong> amore e <strong>di</strong> morte.<br />
Dalla opulenta e farraginosa “<strong>Francesca</strong>” <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio è stato così tratto un libretto <strong>di</strong> forza<br />
drammatica insueta e pur sempre dovizioso <strong>di</strong> bellezze poetiche. Non sarà facile allo Zandonai trovare un altro<br />
poema che possegga l’ideale armonia, la robustezza e la varietà <strong>di</strong> questo. Egli può ringraziare il sommo Id<strong>di</strong>o –<br />
e specialmente l’e<strong>di</strong>tore Ricor<strong>di</strong> – <strong>di</strong> aver potuto mettere le sue forze <strong>di</strong> operista a profitto <strong>di</strong> un’opera letteraria<br />
e teatrale <strong>di</strong> merito insigne. Il successo che la “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” ha ottenuto iersera sulle scene del<br />
“Costanzi” – successo non artificioso e duraturo – deve attribuirsi in parte assai ragguardevole alla trage<strong>di</strong>a. La<br />
musica del maestro trentino, applicata ad un libretto me<strong>di</strong>ocre, non avrebbe potuto conquistare l’applauso<br />
clamoroso che ieri suonò giulivo dopo la conclusione <strong>di</strong> ogni atto.<br />
Ad ogni modo, <strong>da</strong>lla “Conchita” e <strong>da</strong>lla “Melenis” alla “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” il cammino compiuto <strong>da</strong><br />
Riccardo Zandonai ci sembra assai notevole. Il compositore si è accorto del <strong>da</strong>nno derivante <strong>da</strong>l continuo<br />
frastagliamento del <strong>di</strong>scorso musicale e ha cercato <strong>di</strong> introdurre nelle scene capitali della nuova opera perio<strong>di</strong><br />
melo<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> buon respiro. In tal guisa quel senso <strong>di</strong> pena che si avvertiva ascoltando tanti e tanti brani <strong>di</strong><br />
“Conchita” e “Melenis”, costituite <strong>da</strong> una pluralità <strong>di</strong> frammenti industriosamente collegati fra loro, è <strong>di</strong>minuito<br />
<strong>di</strong> assai. Il <strong>di</strong>scorso asmatico permane soltanto in qualche scena <strong>di</strong>alogata che, appunto, riesce fred<strong>da</strong> e<br />
me<strong>di</strong>ocremente espressiva all’au<strong>di</strong>zione in teatro.<br />
Fra tutti gli episo<strong>di</strong> della “<strong>Francesca</strong>” quello che si innalza ai vertici dell’ispirazione è l’arrivo <strong>di</strong> Paolo<br />
Malatesta nella casa dei signori <strong>di</strong> Ravenna. In questa scena – che chiude l’atto primo – lo Zandonai ha cantato<br />
liberamente e con una emozione genuina. Il momento è squisito. L’ansia che stringe il cuore <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong><br />
nell’ora nuziale si <strong>di</strong>legua a un tratto e cede a un senso <strong>di</strong> voluttuoso abbandono quando il bellissimo Paolo<br />
appare, al <strong>di</strong> là della cancellata fra gli arbusti fioriti. Una “viola pomposa” – vetusto e <strong>di</strong>susato strumento che<br />
partecipa della “viola <strong>da</strong> gamba” e del violoncello, pur avendo una speciale risuonanza – inneggia a la sospirata<br />
felicità con una lunga melo<strong>di</strong>a che freme <strong>di</strong> tenerezza. L’orchestra accompagna morbi<strong>da</strong>mente il motivo senza<br />
adombrarlo: le donne della Ravennate, <strong>di</strong>sposte in corona su la loggia, mormorano insinuanti: “Per la terra <strong>di</strong><br />
maggio...” e il loro canto si <strong>di</strong>sposa a quello della viola. <strong>Francesca</strong> coglie una rosa <strong>da</strong>ll’arca scolpita e la porge a<br />
colui che ella crede il suo sposo... Quadro gentile e nuovo: festa d’amore e <strong>di</strong> poesia che la musica dello<br />
Zandonai colorisce d’incanto e che dà a chi guar<strong>da</strong> e ascolta una sod<strong>di</strong>sfazione intera.<br />
Lo Zandonai, con il suo accorgimento finissimo, ha saputo valutare in giusta misura la potenza espressiva<br />
della melo<strong>di</strong>a scaturita <strong>da</strong>ll’animo suo in un istante <strong>di</strong> estasi rara e non l’ha abbandonata. Così il motivo<br />
amoroso svolto nel finale del primo atto ricompare in ognuno degli atti successivi. Lo ritroviamo nella scena<br />
della battaglia quando i due cognati si scambiano le prime parole torbide, evocando il ricordo del loro incontro<br />
nel crepuscolo <strong>di</strong> maggio; lo riu<strong>di</strong>amo nella scena della de<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> e poi ancora nell’ultimo duetto<br />
mentre Gianciotto è all’agguato. Si può <strong>di</strong>re che questa melo<strong>di</strong>a rischiari magicamente tutta la vicen<strong>da</strong> d’amore:<br />
peccato che sia sola...<br />
Se nella “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” ci fossero state soltanto tre o quattro idee melo<strong>di</strong>che altrettanto belle, l’opera<br />
avrebbe in sé una forza vitale sorprendente.<br />
Invece (perché negare l’evidenza?) il materiale tematico della “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” non è cospicuo. Le<br />
scene iniziali del primo atto fluiscono rapide ma non avvincono perché la musica che [si] accompagna ad esse è<br />
povera <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni originali. Nel secondo atto il fragore persistente non riesce a nascondere l’assenza quasi totale<br />
<strong>di</strong> temi vibranti e scultori quali il dramma richiederebbe. Nel terzo episo<strong>di</strong>o, per gran ventura, lo Zandonai<br />
ritrova un soffio vivido <strong>di</strong> ispirazione e così la sua vittoria <strong>di</strong>venta sicura. Tutta la scena tra <strong>Francesca</strong> e le<br />
ancelle – che cantano e <strong>da</strong>nzano nel giorno in cui la Primavera ritorna con il suo corteo <strong>di</strong> ron<strong>di</strong>ni – ha grazie<br />
leggiadre <strong>di</strong> melo<strong>di</strong>a. Qui si respira a pieni polmoni: nell’aria è la frescura dell’Adriatico e il profumo delle<br />
prime viole. I musici intonano sui loro strumenti un ritornello incantevole: Biancofiore, Garse<strong>da</strong> [sic], Adonella<br />
e Altichiara ci regalano una “canzone a ballo” un po’ monotona ma piena <strong>di</strong> carezze. La scena è seducente, la<br />
musica spontanea. Dei tormentosi clamori <strong>di</strong> guerra appena resta in noi un ricordo ingrato...<br />
Il terzo atto termina con la famosa lettura del libro e il conseguente bacio <strong>di</strong> Paolo a <strong>Francesca</strong>. Lo Zandonai<br />
ha sentito profon<strong>da</strong>mente l’episo<strong>di</strong>o e lo ha reso con una <strong>di</strong>gnità degna della massima approvazione. Il<br />
progresso degli effetti, nello svolgersi della scena, è splen<strong>di</strong><strong>da</strong>mente ottenuto.<br />
Si giunge per gra<strong>di</strong> alla erotica conclusione che solleva in orchestra un’on<strong>da</strong>ta fragorosa, subito placata.<br />
Mentre <strong>Francesca</strong>, vinta, s’accascia, la musica si fa mite, suadente, perfi<strong>da</strong> consigliera...<br />
Non è possibile restare inerti <strong>di</strong>nnanzi alle vaghezze multiple della musica che avvolge questo terzo atto, nel<br />
quale la umana passione prorompe e Primavera esulta. E <strong>di</strong> fatti iersera, appena calato il velario, il pubblico con<br />
uno scatto sincero acclamò poderosamente il maestro e volle che egli si ripresentasse al proscenio sei o sette<br />
volte. Fu un successo schietto e giusto, al quale ognuno recò lietamente il proprio fervido contributo.<br />
Il quarto atto, per converso, non ebbe un esito smagliante. La scena tra Malatestino e <strong>Francesca</strong> e quella tra i<br />
due fratelli interessarono grandemente per la vigoria superba dell’accento e il cupo colore orchestrale, ma per la<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/7
scarsità <strong>di</strong> temi espressivi non consentirono un giu<strong>di</strong>zio entusiastico. I vari momenti drammatici <strong>di</strong> questo atto<br />
sono più coloriti <strong>da</strong>ll’orchestra che musicalmente tradotti. Il motivo <strong>di</strong> Gianciotto – motivo alquanto wagneriano<br />
ma <strong>di</strong>segnato fermamente – si trova a far <strong>da</strong> solo le spese <strong>di</strong> un lungo brano <strong>di</strong> musica e sopporta con fatica la<br />
dura bisogna. Tuttavia l’acerbo colloquio fra l’o<strong>di</strong>oso Malatestino e il tra<strong>di</strong>to Gianciotto lascia una impressione<br />
tragica indelebile per le appropriate sonorità strumentali [e] la incisività della declamazione. Il musicista, che ha<br />
saputo efficacemente commentare una tale scena, possiede in<strong>di</strong>scutibilmente le più belle qualità <strong>di</strong> compositore<br />
drammatico che si possano desiderare in un giovane operista.<br />
L’ultimo episo<strong>di</strong>o della trage<strong>di</strong>a, a nostro parere, mostra qualche segno <strong>di</strong> stanchezza. Il poetico motivo<br />
iniziale, soavemente susurrato a più riprese <strong>da</strong>ll’orchestra, piace immensamente; non altrettanto può <strong>di</strong>rsi della<br />
lunghissima scena tra <strong>Francesca</strong> e Biancofiore e dell’angoscioso duetto degli adulteri cognati. Il vero calore<br />
comunicativo non c’è che nell’a due finale condotto sul già sfruttato motivo dell’incontro <strong>di</strong> Paolo e <strong>Francesca</strong>.<br />
E la susseguente catastrofe tragica scatena nella massa strumentale un’acre tempesta <strong>di</strong> suoni e nulla più.<br />
Da quanto abbiamo scritto sin qui è facile concludere che la <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Riccardo Zandonai deve<br />
essere giu<strong>di</strong>cata come opera non perfetta ma sotto vari aspetti bella, fascinosa e significativa. Del resto anche là<br />
dove l’estro inventivo del compositore non dà frutti copiosi la bravura eccezionale del tecnico basta a tenere<br />
avvinta l’attenzione dell’ascoltatore.<br />
Lo Zandonai conosce l’orchestra intimamente e ne usa <strong>da</strong> saggio signore. A citare uno ad uno gli episo<strong>di</strong><br />
strumentali ammirevoli della nuova partitura si penerebbe non poco, tanto essi sono numerosi. Si può affermare<br />
che per quanto riguar<strong>da</strong> la veste orchestrale della <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> tutti iersera fossero concor<strong>di</strong> nel<br />
rilevarne la mirifica ricchezza e il buon gusto esimio.<br />
Resta a vedere qual posto convenga assegnare all’opera dello Zandonai nella produzione contemporanea. Su<br />
questo punto non sarà facile mettere d’accordo i critici i quali, se bene ugualmente affetti <strong>da</strong>lla mania <strong>di</strong><br />
classificare, hanno ciascuno per proprio conto un sistema <strong>di</strong> classificazione. E poi, in realtà, la trage<strong>di</strong>a lirica<br />
della quale an<strong>di</strong>amo <strong>di</strong>scorrendo, pur senza avere una in<strong>di</strong>vidualità piena, si <strong>di</strong>stacca alquanto <strong>da</strong>lle solite forme<br />
del melodramma italiano contemporaneo. Si nota in essa una maggiore <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> stile, una maggiore ricchezza<br />
sinfonica, oltre a un quasi totale abbandono delle viete formule retoriche...<br />
Wagner fa <strong>di</strong> tanto in tanto capolino ma non spadroneggia: nel tessuto armonico e orchestrale si avverte<br />
l’influenza dei modernissimi maestri tedeschi e francesi, ma tale influenza non <strong>di</strong>venta mai tirannica. Così lo<br />
Zandonai riesce a mantenersi abbastanza in<strong>di</strong>pendente e a conservare la fisionomia <strong>di</strong> musicista italiano,<br />
malgrado egli non si palesi come un vero e proprio innovatore. La “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>”, per chi ben ve<strong>da</strong>, è<br />
l’opera egregia <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> transizione. Melo<strong>di</strong>ca quanto basta per sedurre il pubblico, armoniosa senza<br />
ricercatezze peregrine, irrobustita ma non appesantita <strong>da</strong> una molteplicità <strong>di</strong> elementi sinfonici, essa ha un<br />
merito precipuo: quello <strong>di</strong> essere equilibrata ed euritmica. Nella “<strong>Francesca</strong>” tutto è dosato, calcolato con uno<br />
scrupolo meraviglioso del compositore, cauto e guar<strong>di</strong>ngo quanto altri mai.<br />
Si può criticare unicamente la tendenza dello Zandonai a sforzare le voci dei cantanti sino all’ultimo limite,<br />
costringendoli a gri<strong>da</strong>re, talora senza una plausibile ragione. V’è più <strong>di</strong> un passo che deve <strong>da</strong>r <strong>da</strong> pensare alla<br />
protagonista dell’opera, qualora essa non sia una cantatrice abile e resistente... Per fortuna iersera questa parte<br />
era affi<strong>da</strong>ta alla signorina Rosa Raisa, la quale seppe superare ogni ostacolo, ogni insi<strong>di</strong>a, rivelandosi artista<br />
destinata a certa gloria.<br />
La Raisa ha voce stupen<strong>da</strong> e cuore appassionato. Il suo canto è morbido, commovente, sicurissimo; la sua<br />
figurazione scenica è nobilmente espressiva e originale. Ella fu iersera una trionfatrice e il pubblico le <strong>di</strong>ede<br />
attestati solenni del suo favore.<br />
Il tenore Aureliano Pertile affrontò con successo la parte <strong>di</strong> “Paolo” e si fece largamente apprezzare per la<br />
chiarezza del timbro e la forza squillante della voce. Buono il Danise nella parte <strong>di</strong> “Giovanni lo sciancato”;<br />
valorose e soavissime le signore Olga Matteini e Flora Perini nelle rispettive parti <strong>di</strong> “Samaritana” e<br />
“Smarag<strong>di</strong>”. Il basso Berar<strong>di</strong> fu un “Ostasio” robusto ed anche il Nar<strong>di</strong> (Malatestino) e il Gironi (giullare)<br />
meritarono lode.<br />
Gli altri artisti – tra i quali ci piace rammentare Maria Verger, Maria Galeffi, Ines Serracchioli e I<strong>da</strong><br />
Manarini, le quattro ancelle <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> – cantarono efficacemente.<br />
L’orchestra, <strong>di</strong>retta <strong>da</strong>l maestro Vitale in modo magistrale, ebbe a volta a volta la maschia violenza e la<br />
squisita dolcezza desiderate <strong>da</strong>l compositore. Il Vitale fu un amico ingegnoso ed un alacre collaboratore dello<br />
Zandonai: a buon <strong>di</strong>ritto egli comparve al proscenio accanto al compositore, insistentemente evocato <strong>da</strong>l<br />
pubblico.<br />
I cori furono impeccabili, l’allestimento scenico, oltremodo lussuoso, parve superiore ad ogni previsione. In<br />
complesso, si tratta <strong>di</strong> uno spettacolo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne elevatissimo, al quale tutta Roma accorrerà plaudente. È <strong>da</strong><br />
sperare che la nostra citta<strong>di</strong>nanza non si lascerà sfuggire l’occasione <strong>di</strong> onorare Riccardo Zandonai, il forte<br />
musicista che rapi<strong>da</strong>mente incede verso la fama lusinghiera, scortato <strong>da</strong>lla sorridente fortuna.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/8
54<br />
Alberto De Angelis, La “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” <strong>di</strong> R. Zandonai al Costanzi, “Il Tirso” XII/11, 14.3.1915 - p. 1,<br />
col. 1-2-3-4-5-6 (con foto <strong>di</strong> Zandonai, A. Pertile, G. Danise, F. Perini, O. Matteini, R. Raisa, B. Berar<strong>di</strong>)<br />
Rileggendo prima della rappresentazione il libretto della <strong>Francesca</strong> tratto <strong>da</strong>lla trage<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Gabriele<br />
d’Annunzio, serrato, incisivo, drammaticissimo, io m’era doman<strong>da</strong>to sgomento se era possibile che un<br />
compositore avesse potuto aggiungervi una maggiore musicalità, raggiungere un più alto lirismo, trarre <strong>da</strong> quel<br />
profondo scan<strong>da</strong>glio <strong>di</strong> anime un più evidente <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> caratteri. Non era forse possibile – mi <strong>di</strong>ssi poi, dopo<br />
aver ascoltato la partitura dello Zandonai, la quale ha pure ottenuto <strong>da</strong>l pubblico del Costanzi un’accoglienza<br />
entusiastica, in alcuni momenti trionfale. Successo ben meritato, se si pensi alla meravigliosa sapienza del<br />
giovanissimo musicista trentino, all’innato dono del senso degli effetti e delle esigenze teatrali che nessun altro<br />
giovane musicista italiano certamente possiede al pari <strong>di</strong> lui. – Ma una maggiore efficacia era però possibile<br />
raggiungere. Critici e pubblico, pur <strong>di</strong>mostrandosi lieti ed orgogliosi <strong>di</strong> una sì alta affermazione del valoroso<br />
musicista irredento, quasi unanimemente riconobbero essere i pregi dell’opera più nella forma che nella<br />
sostanza, più nella sensazione della <strong>di</strong>namica esteriore dell’ambiente e dei personaggi che in quella intima<br />
spirituale, più nella descrizione che nella penetrazione, più nel colore che nel <strong>di</strong>segno. Sopratutto ammirarono<br />
dello Zandonai la ricchezza, la varietà, la spigliatezza dell’istrumentale, armonizzazione delle voci con<br />
l’orchestra <strong>di</strong> una costante eleganza.<br />
Trovare nell’opera dell’Autore <strong>di</strong> Conchita pretesti per una critica alla sua struttura teatrale e ai suoi<br />
proce<strong>di</strong>menti tecnici sarebbe quin<strong>di</strong> se non impossibile assai <strong>di</strong>fficile. La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> è anzi un’opera<br />
che dà un senso <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione compiuta. Ma essa non riesce quasi mai a destare nello spettatore una<br />
commozione profon<strong>da</strong>, a trascinarlo a mezzo <strong>di</strong> un atto all’applauso entusiastico. Gli è che la musica segue la<br />
trage<strong>di</strong>a quasi sempre nella sua superficie, <strong>di</strong>fficilmente la interpreta o la penetra; <strong>di</strong>rò <strong>di</strong> più: in alcuni punti la<br />
efficacia della poesia sorpassa quella della musica e pur ne è <strong>da</strong> questa svalutata.<br />
Questo giu<strong>di</strong>zio può riferirsi ad esempio alla scena del bacio alla fine del III atto, ed a quella della morte dei<br />
due amanti: scene culminanti della trage<strong>di</strong>a e che non trovarono interpretazione musicale adeguata. Non già che<br />
manchi adesione tra poesia e musica: la connessione è anzi fra <strong>di</strong> essi intimissima, ma è una intimità quasi<br />
esclusivamente <strong>di</strong> forma e <strong>di</strong> colore. Neppure vi serpeggia per entro una prepotente vena <strong>di</strong> ispirazione<br />
personale e <strong>di</strong> ideazione melo<strong>di</strong>ca la quale valga a sedurre <strong>di</strong> per sé stessa l’ascoltatore. Sarebbe arrischiato<br />
negare allo Zandonai una sua personalità musicale; ma sarebbe non meno facile non riconoscergliene una ben<br />
<strong>di</strong>stinta. Ricca <strong>di</strong> tutti i proce<strong>di</strong>menti tecnici <strong>di</strong> cui la musica s’è accresciuta <strong>da</strong>lla metà del secolo scorso in poi,<br />
lo Zandonai sa estrarre <strong>da</strong> essa i più vaghi ed i più efficaci, sa trasformarli, plasmarli, assorbirli, imprimendo<br />
anche loro un suo proprio carattere. Né <strong>di</strong>verso metodo egli usa nelle manifestazioni delle sue ideazioni.<br />
Stu<strong>di</strong>oso profondo ma sopratutto dotato <strong>di</strong> una intelligentissima e rara facoltà <strong>di</strong> assimilazione, ad ogni scuola,<br />
ad ogni autore specialmente del periodo <strong>di</strong> tempo sopra detto egli si abbevera; e pure, sebbene qualche sua<br />
speciale pre<strong>di</strong>lezione per questo o per quel sommo autore possa talvolta a sprazzi apparire, mai <strong>di</strong> nessuno egli<br />
reca le particolari stigmate impresse, mai <strong>di</strong> nessuno ripete non <strong>di</strong>co le idee ma neppure lo stile. Eppure la sua<br />
originalità è scarsa; <strong>di</strong>fficilmente egli offre all’ascoltatore impressioni <strong>di</strong> stupore per il carattere particolare <strong>di</strong><br />
un’idea; al contrario questo quasi s’acquieta nella sua musica come nella compagnia <strong>di</strong> fi<strong>da</strong>tissimi amici: la sua<br />
personalità, in quanto ispirazione, sembra se mai come l’estratto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sparate personalità e scuole d’arte<br />
accomunate in un crogiuolo e passate quin<strong>di</strong> in uno spesso filtro adoperato <strong>da</strong> un artefice onesto e scrupoloso ed<br />
espertissimo nella sua arte: non è musica <strong>di</strong> un’epoca.<br />
Questi giu<strong>di</strong>zi potranno sembrare un po’ duri, e potranno anche essere un poco esagerati – lo sono anzi come<br />
tutti quelli i quali tendono a incidere un’affermazione particolare – ma se anziché riferirli al brillantissimo<br />
successo <strong>di</strong> una serata essi sono attribuiti alla considerazione <strong>di</strong> un’opera in una epoca storica non sembreranno<br />
arrischiati, come non sono nelle intenzioni malevoli. Il <strong>di</strong>fetto dello Zandonai è il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> quasi tutti i giovani<br />
d’oggidì, ricercatori in ogni campo dell’arte: nutriti <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, tormentati <strong>da</strong>ll’ansia del nuovo, essi raggiungono<br />
spesso una invi<strong>di</strong>abile perfezione tecnica ma non sempre fa in essi egualmente riscontro la ispirazione, o la<br />
ispirazione è soffocata <strong>da</strong>gli stu<strong>di</strong>, <strong>da</strong>ll’amor della novità, <strong>da</strong>ll’attrazione <strong>di</strong> questo o <strong>di</strong> quel maestro. Essi<br />
<strong>da</strong>ranno complessivamente al nostro tempo il carattere <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> transizione, <strong>di</strong> preparazione dolorosa, <strong>di</strong><br />
una ricerca paziente <strong>di</strong> stati <strong>di</strong> spirito, <strong>di</strong> una rinnovazione <strong>di</strong> forme. Preoccupazioni lodevolissime, le quali<br />
impedendo però talvolta all’animo <strong>di</strong> espandersi liberamente ostacolano la creazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> bellezza<br />
assoluta o <strong>di</strong> secolare fama. Rallegriamoci nel constatare che lo Zandonai è in queste file fra i primi, fra i più<br />
valorosi.<br />
Se egli – la sua grande giovinezza ne dà ragione a sperarlo – cercando più a fondo nel suo animo riuscirà a<br />
raggiungere le fonti più pure ed intime della sua sensibilità, noi potremo in lui annoverare uno dei più gran<strong>di</strong><br />
musicisti dell’Italia moderna.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/9
L’esserci <strong>di</strong>lungati a considerare nel suo complesso la personalità <strong>di</strong> Riccardo Zandonai quale si manifesta<br />
nella <strong>Francesca</strong> ci impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> seguire l’opera nei suoi particolari.<br />
La esecuzione avutasene al Costanzi è stata perfettissima per merito del M. Edoardo Vitale, il quale ha<br />
<strong>di</strong>retto la partitura con vero amore, e degli artisti, alcuni dei quali avevano già rappresentato la loro parte nelle<br />
precedenti esecuzioni dell’opera in altre città d’Italia. Conoscenza nuova per Roma era la signorina Rosa Raisa<br />
la quale interpretò la parte della protagonista e che, efficacissima nella scena, fece sfoggio <strong>di</strong> una voce morbi<strong>da</strong><br />
e gagliar<strong>da</strong>. Nella stessa interpretazione la Raisa aveva già riportato un successo memorabile al Teatro<br />
Comunale <strong>di</strong> Modena, tanto che lo Zandonai stesso volle suggerirla come la più degna interprete per il nostro<br />
massimo teatro. Il Danise, un rude Gianciotto, si conquistò la intera ammirazione dell’u<strong>di</strong>torio per la sua arte<br />
interpretativa, a cui aggiunse carattere la sua voce robusta; e piacquero senza riserve il tenore Aureliano Pertile<br />
(Paolo), un giovane che possiede delle superbe qualità <strong>di</strong> voce, prescelto anch’esso <strong>da</strong>l Maestro Zandonai per<br />
avere eseguito la stessa parte al Regio <strong>di</strong> Torino riportando un successo caloroso e significativo; il basso Berar<strong>di</strong><br />
(Ostasio), attore correttissimo e cantante <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> mezzi; il Nar<strong>di</strong>, un Malatestino sghignazzante e sinistro; il<br />
giullare – Gironi – e le signore Olga Matteini, una giovane che ha <strong>di</strong>mostrato possedere dei mezzi vocali<br />
ecccellenti, e Flora Perini, simpaticamente nota al nostro pubblico, nelle rispettive parti <strong>di</strong> Samaritana e <strong>di</strong><br />
Smarag<strong>di</strong>. Anche bene le parti minori.<br />
La mise-en-scène, curata <strong>da</strong>l Cav. Clausetti venuto espressamente <strong>da</strong> Milano, non avrebbe potuto essere più<br />
signorile e gran<strong>di</strong>osa. Ogni particolare fu minuziosamente curato.<br />
Direttore d’orchestra ed artisti furono fatti segno alle più calorose <strong>di</strong>mostrazioni <strong>di</strong> ammirazione, ma<br />
naturalmente la mèsse maggiore degli applausi andò a Riccardo Zandonai, il trionfatore della serata, il quale,<br />
vivamente acclamato, comparve più volte alla ribalta a ringraziare con la sua simpatica aria serena e <strong>di</strong>sinvolta,<br />
ad<strong>di</strong>tando cor<strong>di</strong>almente al pubblico i suoi interpreti e facendo gesti come se egli, l’artefice principale <strong>di</strong> quel<br />
magnifico successo, non vi avesse contribuito e come a <strong>di</strong>re <strong>di</strong> non averne... colpa!<br />
55<br />
T[ommaso] Montefiore, <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio e Riccardo Zandonai, “La Concor<strong>di</strong>a”,<br />
12.3.1915 - p. 2, col. 3-4<br />
Il tragico caso <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> dei Polenta ha spesso tormentato il desiderio dei compositori musicali dopo che<br />
Silvio Pellico, destando largo sebbene brevissimo successo <strong>di</strong> popolarità, volle trasportarlo sulla scena. Le opere<br />
imbastite su quel soggetto sono infatti parecchie: se ne registrano una quin<strong>di</strong>cina, fra cui talune dovute a maestri<br />
illustri come il Generali, che aprì la serie nel 1829, Merca<strong>da</strong>nte, Cagnoni, Ambroise Thomas e Luigi Mancinelli.<br />
Nessuna <strong>di</strong> queste opere ebbe vita lunga e se ne imputò spesso la colpa alle <strong>di</strong>fficoltà dell’argomento, giacché<br />
tutto l’interesse si concentra nella scena d’amore e <strong>di</strong> morte così <strong>da</strong> scemare l’importanza dell’azione foggiata<br />
per giungere fin là. Gabriele d’Annunzio, affrontando come drammaturgo l’arduo compito, seppe condurre la<br />
trage<strong>di</strong>a con abile artifizio, vi introdusse possenti elementi <strong>di</strong> emozione; più ancora, la circondò <strong>di</strong> un’atmosfera<br />
suggestiva e conquistatrice, in guisa che l’on<strong>da</strong> armoniosa della parola sembra quasi attendere il suono musicale<br />
per completare il fascino sottile e misterioso.<br />
Per rendere a<strong>da</strong>tta la trage<strong>di</strong>a alla veste musicale occorreva sfron<strong>da</strong>rla. L’operazione fu compiuta senza<br />
risparmio e spesso vi si scorge la voluttà del chirurgo che non ba<strong>da</strong> a deformare qualche figura come ad esempio<br />
quella <strong>di</strong> Malatestino del quale il D’Annunzio ha cura <strong>di</strong> far conoscere l’animo perverso al primo presentarsi, o<br />
a mozzare qualche episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> cui rimane troppo evidente la manchevolezza.<br />
Per buona ventura la musica del Zandonai rende quasi invisibili tali <strong>di</strong>fetti, in parte forse inevitabili <strong>da</strong>te le<br />
vaste proporzioni della trage<strong>di</strong>a <strong>da</strong>nnunziana. Innanzi tutto egli ne ha penetrata tutta la poesia; ha circonfuso<br />
l’ambiente <strong>di</strong> un colore soave, tenero, appassionato, per cui i due principali personaggi Paolo e <strong>Francesca</strong><br />
effondono <strong>di</strong>ntorno una seduzione irresistibile. L’on<strong>da</strong> sonora si sprigiona <strong>da</strong>ll’orchestra fra mille trovate<br />
d’impasto spesso originali, avvolge il dramma e si fonde con esso per comporre opera d’arte <strong>di</strong> altissimo valore.<br />
Il nostro pubblico che apprezzò l’ingegno promettentissimo del Zandonai in “Conchita” e in “Melenis” ora<br />
con “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” lo saluta trionfatore in linea prima fra i più acclamati compositori del teatro lirico<br />
nazionale. Sopratutto lo saluta con gioia maestro schiettamente italiano, non inquinato <strong>da</strong> infiltrazioni o <strong>da</strong><br />
lusinghe straniere, quasi baluardo d’italianità fra le balze del suo Trentino. Il progresso della tecnica orchestrale,<br />
veramente pro<strong>di</strong>gioso, non impe<strong>di</strong>sce dunque alla voce <strong>di</strong> essere sovrana nel dramma in musica; la caratteristica<br />
fon<strong>da</strong>mentale della nostra scuola non dovrà dunque sommergere nella evoluzione dell’arte: l’opera del Zandonai<br />
è <strong>di</strong> ciò nuovo inoppugnabile esempio e, non fosse che per questo, si impone come modello ai giovani dubbiosi.<br />
Infatti l’orchestra non è mai sopraffatrice: essa incornicia l’azione, la commenta; sostiene, accenta il canto<br />
vocale. Non<strong>di</strong>meno la polifonia risulta sempre piena: fattore massimo del doppio risultato è l’impiego<br />
magistrale degli strumenti ad arco le cui risorse sono inesauribili.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/10
La novissima opera del Zandonai, che giunge al Costanzi dopo i brillanti successi riportati prima, un anno fa,<br />
al Regio <strong>di</strong> Torino, poi a Modena, a Pesaro, e confermati clamorosamente iersera tra noi <strong>da</strong> un pubblico<br />
elettissimo ed imponente, è cosparso <strong>di</strong> bellezze d’ogni or<strong>di</strong>ne.<br />
Nell’atto primo in cui si svolge l’antefatto della trage<strong>di</strong>a è ammirevole la scena che l’apre, scoppiettante <strong>di</strong><br />
gaiezza femminile; il <strong>di</strong>alogo fra Ostasio e Ser Poldo [sic], dove si ferma l’inganno teso a <strong>Francesca</strong>, va rilevato<br />
per l’opportunità <strong>di</strong> quella forma del “recitar cantando”, antica tra<strong>di</strong>zione italica istaurata <strong>da</strong>gli stessi inventori<br />
dell’opera, per cui si afferra ogni parola scan<strong>di</strong>ta <strong>da</strong>ll’attore-cantante. Dolcissima è l’affettuosità fraterna che si<br />
rivelano <strong>Francesca</strong> e Samaritana per il prossimo <strong>di</strong>stacco. La sopravvenienza <strong>di</strong> Paolo, atteso <strong>da</strong>lla corte dei<br />
Polenta fra festosi concenti, dà luogo a un quadro musicale pieno <strong>di</strong> suggestione commovente. Già la fatalità si<br />
<strong>di</strong>segna nell’on<strong>da</strong> armoniosa tenerissima che avvolge i personaggi. Un applauso scrosciante dà la misura<br />
dell’effetto prodotto sugli astanti <strong>da</strong>lla magnifica introduzione.<br />
L’atto secondo è un poco greve invece; l’affannosa descrizione della fervi<strong>da</strong> battaglia offusca le grazie<br />
profuse nella scena tra Paolo e <strong>Francesca</strong>, dove va notata una purissima frase melo<strong>di</strong>ca che la signoreggia.<br />
Il fragore e l’ansietà dei combattenti è schiacciante per la soverchia insistenza.<br />
Il terzo atto si offre come gemma preziosa: vago è il coretto delle donzelle salutanti il sole <strong>di</strong> marzo e la loro<br />
<strong>da</strong>nza leggiadra; la passione <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> è ritratta con angoscia penetrante; il duo <strong>di</strong> lei con Paolo contiene<br />
frasi vibranti <strong>da</strong> ricercare le intime fibre. Il maestro Zandonai è acclamato con entusiasmo e deve presentarsi più<br />
volte al proscenio coi collaboratori degnissimi <strong>di</strong> lui.<br />
Nell’atto quarto scoppia il dramma con una robustezza che fa contrasto felicissimo coll’atto precedente. La<br />
scena tra Gianciotto e Malatestino è <strong>di</strong> una violenza selvaggia e si segnala come una delle migliori pagine della<br />
nobilissima partitura. Le fa seguito il riboccante fremito dell’ultima scena d’amore, <strong>da</strong>lle frasi calde e quasi<br />
<strong>di</strong>sperate, poi la rapi<strong>di</strong>ssima catastrofe.<br />
Il Zandonai ha compiuto con la sua <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> un lavoro <strong>di</strong> grande bellezza e <strong>di</strong> grande sincerità,<br />
lavoro che sarà sempre più gustato nelle successive rappresentazioni. Il pubblico l’ha tuttavia interamente<br />
compreso manifestando il compiacimento con uno <strong>di</strong> quegli slanci che rendono palli<strong>da</strong> la solita claque<br />
importuna, per ventura quasi immota iersera. Fu insomma un successo pieno, ardente, un successo reale che<br />
onora l’artista e l’arte.<br />
Per <strong>di</strong>re dell’esecuzione basterebbe una frase: fu all’altezza dell’opera. Il maestro Vitali [sic] riuscì interprete<br />
sommo; i cantanti superbi per mezzi vocali e per valore scenico. Raramente s’incontra un insieme simile e siamo<br />
lieti <strong>di</strong> constatarlo senza le restrizioni cui tanto spesso siamo costretti. Avemmo nella Raisa (<strong>Francesca</strong>) e nel<br />
tenore Pertile (Paolo) due interpreti veramente insuperabili; voci fresche, bene educate: due artisti misurati che<br />
cantano e non strillano mai. Il Pertile possiede poi una mezza voce deliziosa e riesce spesso incantevole.<br />
Tutti gli altri ottimi nelle loro parti: il Danise (Gianciotto), il Nar<strong>di</strong> (Malatestino), il Berar<strong>di</strong> (Ostasio), la<br />
Verger, la Matteini colle donzelle del coro, il Gironi nella parte <strong>di</strong> Giullare.<br />
L’orchestra filò alla perfezione. Le masse corali, l’allestimento scenico concorsero alla riuscita dello<br />
spettacolo eccezionale.<br />
56<br />
Enrico Boni, “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” del M. R. Zandonai, “Il Popolo romano”, 11.3.1915 - p. 2, col. 3-4<br />
Il libretto della nuova opera del m. Riccardo Zandonai non ha bisogno <strong>di</strong> essere soverchiamente illustrato,<br />
ché a tutti è noto come codesta <strong>Francesca</strong> messa in musica <strong>da</strong>l maestro triestino [!] altro non è se non la<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong>nnunziana, alleggerita <strong>di</strong> una notevole quantità <strong>di</strong> versi e sfron<strong>da</strong>ta <strong>di</strong> tutti gli episo<strong>di</strong> secon<strong>da</strong>ri che<br />
non avevano vincolo <strong>di</strong> necessità con la vicen<strong>da</strong> drammatica.<br />
È sparito Bannino, scomparso l’astrologo; è stato soppresso quel mercatante che alla prima rappresentazione<br />
del poema sollevò le proteste del pubblico per la interminabile enumerazione <strong>di</strong> stoffe preziose, ed egualmente<br />
soppresse sono state le figure minori <strong>di</strong> partigiani <strong>di</strong> Guido e dei Malatesta.<br />
La parte <strong>di</strong> Smarag<strong>di</strong>, la schiava <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, è stata ridotta ai minimi termini. Quanto a una delle ancelle,<br />
Al<strong>da</strong>, è stata licenziata.<br />
Il libretto ha perduto magnifici versi e non poche sottigliezze. Sarà forse <strong>di</strong>ventato più agile; ma il sacrifizio<br />
ha giovato solamente in parte, ché codesta <strong>Francesca</strong>, pur ridotta ad una psicologia sommaria, rimane tuttavia,<br />
considerata musicalmente, opera <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni eccessivamente ampie.<br />
Ora non si scrive più come il cuore detta ma secondo le formule più astruse della scienza fonica. E come gli<br />
autori, anche perché a corto <strong>di</strong> idee, tendono a farsi sempre più complicati, l’an<strong>da</strong>re a teatro dopo una giornata<br />
<strong>di</strong> lavoro intenso al quale ci costringe la vita moderna e rimanervi per quattro o cinque ore per ascoltare musiche<br />
prevalentemente cerebrali finisce col <strong>di</strong>ventare una fatica vera e propria.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/11
Certo, il poema <strong>da</strong>nnunziano aveva in sé elementi tali <strong>di</strong> bellezza <strong>da</strong> tentare un musicista; e Riccardo<br />
Zandonai, scegliendolo, fu più felice che nello scegliere un soggetto <strong>di</strong> antipatico verismo come Conchita o una<br />
banalità come Melenis.<br />
L’opera non costituisce una novità nel senso assoluto della parola, poiché dopo la prima rappresentazione al<br />
Regio <strong>di</strong> Torino ha già percorso vari teatri dell’Italia e dell’estero. Ve<strong>di</strong>amo quin<strong>di</strong> brevemente quale sia stato il<br />
lavoro del musicista.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> non ha prelu<strong>di</strong>o. Pochi accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> viola e il velario si apre sulla corte della casa dei<br />
Polentani.<br />
La prima scena è formata <strong>da</strong>l gaio cinguettio delle donne motteggianti il giullare. L’arrivo <strong>di</strong> Ostasio con Ser<br />
Toldo è caratterizzato rudemente. Con l’uscita dei due la calma torna in orchestra, e il maestro si rivela coi suoi<br />
caratteristici tratti nel coretto delle donne, sorretto <strong>da</strong> un pe<strong>da</strong>le <strong>di</strong> liuto.<br />
La scena tra <strong>Francesca</strong> e Samaritana è improntata a una mestizia dolente. La musica tende ad assumere<br />
calore e spesso vi riesce. Il <strong>di</strong>alogo tra le due sorelle è interrotto <strong>da</strong>l coro che irrompe festosamente. Meno<br />
efficace è la ripresa del duetto, costruito su tessiture acutissime. E siamo alla parte più notevole dell’opera, il<br />
finale del primo atto.<br />
Il tramonto accende <strong>di</strong> bagliori il giar<strong>di</strong>no che si scorge al <strong>di</strong> là della corte. Dall’alto delle logge le donne <strong>di</strong><br />
<strong>Francesca</strong> si sono aggruppate graziosamente. Un musico svolge sulla viola pomposa una larga frase suggestiva<br />
– che riapparirà nei momenti capitali della trage<strong>di</strong>a – , sostenuta <strong>da</strong> pizzicati del liuto e <strong>da</strong>l piffero. Paolo appare<br />
<strong>da</strong>l giar<strong>di</strong>no e s’avanza. <strong>Francesca</strong> coglie per lui <strong>da</strong>l rosaio fiammeggiante ch’è nell’arca in mezzo alla corte<br />
una rosa vermiglia e che con gesto soavemente lento l’offre al sopravvenuto.<br />
La carezza della frase della viola passa come un fremito nell’orchestra e conchiude mirabilmente l’atto – il<br />
migliore dell’opera – comunicandogli una impronta <strong>di</strong> arte severa e nobilmente espressa.<br />
Azione e musica si fondono qui nella più perfetta resultanza, e il maestro raggiunge finalmente la<br />
commozione testimoniando ancora una volta della sua grande coltura e del suo buon gusto.<br />
Il secondo atto ci porta in piena battaglia sulla torre dei Malatesta.<br />
Dopo un breve <strong>di</strong>alogo <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> con l’Armigero, s’inizia col sopraggiungere <strong>di</strong> Paolo un lungo duetto<br />
che avrà più riprese.<br />
Specialmente notevole è la vibrante frase della donna: “Questo cimento è il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Dio per la saetta”<br />
che sarà poi riu<strong>di</strong>ta a traverso il fragore del finale. Ben colorito è l’irrompere del coro degli uomini d’arme e<br />
assai ben caratterizzata la rude figura dello Sciancato.<br />
La musica si fa tumultuosa con l’arrivo <strong>di</strong> Malatestino, e finalmente la rumorosità che a più riprese è apparsa<br />
in quest’atto si scatena nel modo più assor<strong>da</strong>nte, mentre la battaglia riprende con rinnovato furore.<br />
Atto, codesto, piuttosto debole. Ché se lo strepito può impressionare un ascoltatore superficiale, non trarrà<br />
certo in inganno uno che abbia qualche <strong>di</strong>mestichezza con l’arte della musica. Qui ci troviamo appunto nello<br />
stesso caso del secondo atto <strong>di</strong> Melenis, in cui il frastuono non riesce a mascherare la esiguità del contenuto<br />
musicale. L’episo<strong>di</strong>o finale della battaglia è condotto orchestralmente con grande perizia ma ha un valore<br />
musicale assai relativo.<br />
Per contro, il terzo atto contiene pagine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>scutibile bellezza, specie nella secon<strong>da</strong> metà.<br />
Dopo la canzone a ballo, contenuta in forme bene appropriate, l’arrivo <strong>di</strong> Paolo è preparato con sapienza.<br />
Il duetto s’inizia felicemente e subito si fa notare la frase <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>: “Paolo, <strong>da</strong>temi pace!”, cui fa<br />
degnamente seguito il leggiadro movimento che fiorisce con le parole <strong>di</strong> Paolo: “Inghirlan<strong>da</strong>ta <strong>di</strong> violette<br />
m’appariste ieri”.<br />
Il <strong>di</strong>alogo si svolge, nobilmente ispirato, con rari momenti <strong>di</strong> stanchezza, fino alla fine dell’atto, che rinnova<br />
la stessa commozione del primo episo<strong>di</strong>o e pel quale non si possono avere che parole <strong>di</strong> elogio.<br />
Nell’atto seguente il maestro non si mantiene alla stessa altezza. Il quarto quadro a malgrado <strong>di</strong> pregi<br />
orchestrali non risulta molto convincente. Il primo duetto tra <strong>Francesca</strong> e Malatestino interrotto <strong>da</strong>gli urli del<br />
prigioniero non ha grande evidenza, anche per la mancata figurazione musicale del tipo <strong>di</strong> Malatestino. Né<br />
molto persuasive appaiono le scene seguenti, a contrasti vivi <strong>di</strong> luci e d’ombre ma forse troppo inutilmente<br />
fragorose.<br />
Meglio è l’ultima parte dell’atto che ci riconduce nella stanza <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, e s’inizia con uno dei soliti<br />
proce<strong>di</strong>menti orchestrali cari al m. Zandonai.<br />
L’atto culmina nel nuovo duetto d’amore tra Paolo e <strong>Francesca</strong>, che si sno<strong>da</strong> con ricchezza <strong>di</strong> colore ma non<br />
con altrettanta sincerità <strong>di</strong> calore.<br />
Il finale, breve e tragico, è comentato <strong>da</strong> un nuovo scatenarsi <strong>di</strong> tutte le forze dell’orchestra.<br />
Che cosa rappresenta codesta <strong>Francesca</strong> nella produzione artistica del m. Zandonai? Senza dubbio un passo<br />
notevolissimo, un in<strong>di</strong>scutibile progresso. Il m. Zandonai è musicista <strong>di</strong> bella sapienza tecnica, e questa<br />
magnifica padronanza orchestrale egli riafferma brillantemente. Basterebbe il primo atto della nuova opera, il<br />
modo <strong>di</strong>gnitoso, bene appropriato col quale egli ha saputo rivestire musicalmente il quadro <strong>da</strong>nnunziano per<br />
meritare al giovine maestro gli onori della vittoria.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/12
Riccardo Zandonai, come abbiamo già accennato, si mostra anche qui con tutti i suoi caratteri essenziali:<br />
pregi e <strong>di</strong>fetti.<br />
Egli è sempre l’artefice esperto dei più svariati e au<strong>da</strong>ci impasti, delle più strane sovrapposizioni polifoniche.<br />
Nella <strong>Francesca</strong>, come in Conchita, come in Melenis, ricorrono frequentemente le spezzettature in piccoli<br />
perio<strong>di</strong>, quegli speciali <strong>di</strong>segnini d’archi scan<strong>di</strong>ti <strong>da</strong> pizzicati e avvivati qua e là <strong>da</strong> lievi tocchi <strong>di</strong> legni.<br />
Ma qui più che altrove, a causa della maggior mole del lavoro, si delinea quello che è sempre stato il punto<br />
debole del m. Zandonai: la povertà delle idee melo<strong>di</strong>che; o meglio la povertà <strong>di</strong> idee melo<strong>di</strong>che efficaci e<br />
persuasive.<br />
L’insolita rumorosità onde si riveste qua e là questa nova fatica d’arte del maestro non copre le<br />
manchevolezze melo<strong>di</strong>che dell’opera.<br />
Il <strong>di</strong>scorso si svolge con proce<strong>di</strong>menti preziosi, avvalorandosi <strong>di</strong> tutte le risorse <strong>di</strong> una tavolozza smagliante<br />
e <strong>di</strong> una capacità tecnica che non è comune; ma, ove si tolgano quegli episo<strong>di</strong> cui abbiamo accennato, questo<br />
<strong>di</strong>scorso appare meglio a<strong>da</strong>tto a suscitare il compiacimento nell’ascoltatore che a parlare alla sua anima.<br />
Non è qui il caso <strong>di</strong> tornare sulla questione estetica <strong>da</strong> noi già altre volte trattata: se cioè in un’opera<br />
moderna debba la melo<strong>di</strong>a palesarsi nelle forme tra<strong>di</strong>zionali o debba meglio ricercare quei mezzi espressivi che<br />
più le convengono. E quin<strong>di</strong>, nel caso specifico del m. Zandonai, se egli dovesse esprimersi in un modo<br />
piuttosto che in un altro, tenuto anche conto del libretto che s’era accinto a musicare.<br />
La questione <strong>di</strong> forma è per noi <strong>di</strong> secon<strong>da</strong>ria importanza. L’opera d’arte deve <strong>da</strong>re una commozione,<br />
qualunque sia il mezzo adoperato <strong>da</strong>ll’artista per conseguire questo fine essenziale.<br />
Ciò che nella musica del m. Zandonai, ad onta <strong>di</strong> pregi veramente peregrini, troppo raramente avviene.<br />
E allora, <strong>di</strong>nanzi a questo continuo affannarsi delle nostre più belle energie giovanili <strong>di</strong>etro delle forme<br />
d’arte meravigliose ma che possono considerarsi come tessuti smaglianti gittati a ricoprire vacuità <strong>di</strong> ossature<br />
troppo scheletriche, vien fatto a noi, che pur aneliamo con tutte le forze dell’anima a un rinnovamento artistico,<br />
<strong>di</strong> arrestarci sfiduciati e <strong>di</strong> chiederci se abbiano poi tutti i torti coloro che, riferendosi all’essenza <strong>di</strong>vina della<br />
musica, preferiscono quella commossa sincerità <strong>di</strong> espressione, vanto tutto italiano, la quale per un fato<br />
malevolo sembra non possa riuscire ad accor<strong>da</strong>rsi che imperfettamente con l’evoluzione delle forme musicali<br />
moderne.<br />
57<br />
A[driano] B[elli], Il successo della “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” <strong>di</strong> R. Zandonai al Teatro Costanzi, “Corriere<br />
d’Italia”, 11.3.1915 - p. 3, col. 1-2-3-4<br />
L’opera s’apre con un brevissimo brillante prelu<strong>di</strong>o in cui appare subito affi<strong>da</strong>to ad una viola <strong>di</strong>etro il velario<br />
il tema del giullare. La prima scena tra le quattro ancelle <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> e il Giullare procede rapi<strong>da</strong> e spigliata<br />
sotto forma <strong>di</strong> cicaleccio che si svolge sopra rapi<strong>di</strong> ed eleganti ritmi <strong>di</strong> <strong>da</strong>nza. È una pagina gaiamente<br />
spensierata che si segue con vero <strong>di</strong>letto e che mostra subito la mirabile mano <strong>di</strong> colorista nel suo autore. Nel<br />
<strong>di</strong>alogato, agli accenni dei personaggi principali della trage<strong>di</strong>a rispondono in orchestra come un presagio, cupi<br />
attraverso la garrula vivacità del cicaleccio, i temi dei protagonisti e delle situazioni salienti dell’opera.<br />
Attraverso la scena <strong>di</strong>alogata tra Ostasio e Messer Toldo in cui si rivela l’intrigo teso per il matrimonio <strong>di</strong><br />
Gianciotto, si giunge all’arrivo <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>.<br />
La pagina <strong>di</strong> delizioso sapore arcaico è formata <strong>di</strong> uno sfondo soave e squisito affi<strong>da</strong>to al coro interno delle<br />
donne sul quale si muove e si svolge il <strong>di</strong>alogo tra <strong>Francesca</strong> e Samaritana.<br />
Qui la melo<strong>di</strong>a ispirata e nobilissima assurge a una dolcezza <strong>di</strong> espressione veramente toccante specie<br />
quando sulle parole “E si vivrà, oimè – si vivrà tuttavia!” le voci delle due donne si riuniscono e si fondono con<br />
effetto magnifico. L’avvicinarsi <strong>di</strong> Paolo e il suo sopraggiungere dà modo allo Zandonai <strong>di</strong> continuare nella sua<br />
ascesa con pagine sempre più forti e complesse. Il tema incisivo <strong>di</strong> Paolo affi<strong>da</strong>to agli ottoni è quasi subito<br />
sopraffatto <strong>da</strong> un’on<strong>da</strong> travolgente <strong>di</strong> squisito e delizioso lirismo.<br />
È l’ora della gioia mista a profon<strong>da</strong> commozione. Le ancelle inneggiano alla bellezza degli sposi, <strong>Francesca</strong><br />
trepi<strong>da</strong> si avanza verso Paolo per offrirgli una rosa, Samaritana singhiozza <strong>da</strong> un lato. Il quadro suggestivo è<br />
commentato <strong>da</strong> un mormorio leggerissimo dell’orchestra che sorregge la melo<strong>di</strong>a affi<strong>da</strong>ta a tre istrumenti<br />
all’antica che sono in alto sulla balconata (una viola pomposa, un piffero e un liuto), mentre il coro delle donne<br />
mormora sommesso “A convito selvaggio – in contra<strong>da</strong> lontana – Uno cor si doman<strong>da</strong>...”. Il pezzo si svolge<br />
soavissimo fino alle ultime note che si perdono come un sospiro. L’effetto è irresistibile. Quando si chiude il<br />
velario, il pubblico che ha seguito tutto l’atto con crescente ammirazione scoppia in un applauso calorosissimo<br />
che si muta in vera ovazione all’apparire dello Zandonai. Si hanno tre chiamate agli artisti e quattro all’autore.<br />
L’impressione unanime è favorevolissima. Si nota il grande progresso fatto <strong>da</strong>l musicista, la nobiltà della<br />
forma, la ricchezza della sua tavolozza orchestrale. Il successo <strong>di</strong> questo primo atto è stato assolutamente<br />
trionfale.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/13
Il secondo atto è in forte contrasto col primo. È l’atto della battaglia. Se il primo era tutta serenità, questo è<br />
come una violenta chiazza scarlatta sulla quale si muovono tutte le principali figure del dramma.<br />
Alla scena realistica della battaglia in cui si palesa tutto il valore sinfonico del geniale maestro trentino si<br />
avvicen<strong>da</strong>no episo<strong>di</strong> non privi <strong>di</strong> valore come il duetto tra Paolo e <strong>Francesca</strong> con la impressionante scena del<br />
giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Dio, il sopraggiungere <strong>di</strong> Gianciotto e l’entrata <strong>di</strong> Malatestino sopra uno strano e insistente ritmo che<br />
caratterizzerà poi sempre durante tutta l’opera il tristo personaggio. Il quadro gran<strong>di</strong>oso si chiude con una<br />
violenta ripresa della battaglia resa attraverso la sinfonia orchestrale, il coro su declamato libero, il suono delle<br />
buccine, gli urli delle donne, gli insistenti rintocchi delle campane in modo violento e veramente<br />
impressionante. Al chiudersi del velario lo Zandonai è chiamato tre volte.<br />
L’atto, <strong>di</strong> grande ar<strong>di</strong>mento, è stato affrontato <strong>da</strong>l giovane musicista con sicura coscienza <strong>di</strong> riuscita.<br />
È stato costruito con una veduta <strong>di</strong> linea ampia e vigorosa. La prima volta appare però oscuro nei suoi<br />
proce<strong>di</strong>menti all’ascoltatore che rimane come abbagliato <strong>da</strong> una grande luce e stor<strong>di</strong>to <strong>da</strong>l grande fragore<br />
<strong>di</strong>ssonante; ma non esitiamo nell’affermare che questo atto dà la misura del valore <strong>di</strong> Riccardo Zandonai.<br />
Il terzo è pervaso <strong>da</strong> una profon<strong>da</strong> melanconia e <strong>da</strong> un indefinibile senso <strong>di</strong> dolore. Le prime scene scorrono<br />
rapide col canto delle ancelle, con le frasi tristi <strong>di</strong> Smarag<strong>di</strong> e i richiami <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> fino a giungere ad una<br />
delle pagine meglio riuscite del lavoro: la canzone della primavera, affi<strong>da</strong>ta a due soprani e due contralti e<br />
accompagnata <strong>da</strong> un’orchestrina all’antica posta sul coretto dei musici. La pagina è ispirata, fresca e <strong>di</strong> un<br />
indovinatissimo sapore arcaico, e propaga all’u<strong>di</strong>torio un grande senso <strong>di</strong> soave melanconia. L’episo<strong>di</strong>o appare<br />
però un po’ troppo lungo ripetendosi integralmente due volte. Tagliare tutta la ripresa affi<strong>da</strong>ta ai contralti<br />
cre<strong>di</strong>amo sarebbe <strong>di</strong> grande vantaggio alla scena. Il duetto finale tra Paolo e <strong>Francesca</strong> si svolge sopra frasi<br />
veramente ispirate. Qui il musicista si abbandona liberamente alla melo<strong>di</strong>a, una melo<strong>di</strong>a semplice, pura,<br />
italianissima. Non è un’on<strong>da</strong> melo<strong>di</strong>ca travolgente e impetuosa che s’imponga per larghezza <strong>di</strong> linee e che si alzi<br />
e si allarghi in un’imponente parabola: la melo<strong>di</strong>a dello Zandonai è intima, tenera e appassionata con un<br />
irresistibile e sempre sicuro effetto <strong>di</strong> commozione. Le frasi “Paolo, <strong>da</strong>temi pace!” e “Inghirlan<strong>da</strong>ta <strong>di</strong> violette<br />
m’appariste ieri” sono <strong>di</strong> effetto irresistibile. L’atto però <strong>di</strong>minuisce d’interesse alla lettura del libro ove il<br />
<strong>di</strong>alogato non ha la forza <strong>di</strong> rimanere all’altezza delle pagine precedenti; ma riprende poi alla chiusa<br />
commentata con grande abilità e profon<strong>da</strong> poesia <strong>da</strong>ll’orchestra e <strong>da</strong>lle voci in lontananza che ripetono<br />
“Primavera! Primavera!”.<br />
Al chiudersi del velario il pubblico prorompe in un applauso scrosciante, calorosissimo. Il maestro è evocato<br />
alla ribalta ben otto volte tra un’ovazione delirante. Il pubblico della platea è tutto in pie<strong>di</strong> inneggiando al<br />
musicista che ha vinto una grande battaglia. L’atto è giu<strong>di</strong>cato il migliore <strong>di</strong> tutti. Il successo dell’opera è ormai<br />
assicurato.<br />
Il quarto atto è <strong>di</strong>viso in due parti: la delazione <strong>di</strong> Malatestino e la morte <strong>di</strong> Paolo e <strong>Francesca</strong>. La prima è<br />
tutta <strong>di</strong> tinte fosche. Il dramma sta per scoppiare. Il duetto tra <strong>Francesca</strong> e Malatestino scorre rapido verso la<br />
scena principale dell’atto: la rivelazione <strong>di</strong> Malatestino a Gianciotto.<br />
La situazione drammaticissima è resa ancora più potente <strong>da</strong>lla musica. Il <strong>di</strong>alogato tra i due fratelli è<br />
commentato <strong>da</strong>ll’orchestra con effetto teatrale immancabile e il velario si chiude infatti tra applausi vivissimi.<br />
La secon<strong>da</strong> parte ci trasporta nella camera <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>. Il primo duettino tra <strong>Francesca</strong> e Biancofiore, soave<br />
nell’espressione e squisito nella fattura, appare un po’ lungo.<br />
La scena ultima tra Paolo e <strong>Francesca</strong> è piena <strong>di</strong> passione e <strong>di</strong> grande effetto, non solo per il valore della<br />
melo<strong>di</strong>a ma anche per il pregio del commento orchestrale. Le voci prima <strong>di</strong>sgiunte si avvicinano a poco a poco,<br />
si sovrappongono con <strong>di</strong>segni <strong>di</strong>versi per fondersi poi in un unisono gran<strong>di</strong>oso e travolgente. L’entrata <strong>di</strong><br />
Gianciotto è rapi<strong>di</strong>ssima e rapi<strong>da</strong> la catastrofe. L’atto si chiude con quattro chiamate all’autore.<br />
***<br />
Volendo far seguire all’analisi sommaria qualche impressione sul valore del nuovo lavoro, <strong>di</strong>remo anzitutto<br />
come con questa <strong>Francesca</strong> Riccardo Zandonai ve<strong>da</strong> consacrata definitivamente la sua fama <strong>di</strong> operista. Fino ad<br />
ora ci era apparso quasi esclusivamente come sinfonista; con questa nuova opera ha mostrato <strong>di</strong> saper anche<br />
toccare la cor<strong>da</strong> del sentimento e in alcune scene ha raggiunto infatti un irresistibile effetto <strong>di</strong> commozione. Il<br />
suo commento melo<strong>di</strong>co è tutto intimo e personalissimo. La frase – come sopra accennavamo – è breve, ma<br />
incisiva e convincente. È una melo<strong>di</strong>a plasmata sul dramma e sulla stessa parola, fino a raggiungere la più<br />
perfetta rispondenza. Il dramma <strong>da</strong>nnunziano, meravigliosamente ridotto <strong>da</strong> un grande competente: Tito<br />
Ricor<strong>di</strong>, ha trovato nella musica dello Zandonai una veste quale migliore non avrebbe potuto desiderare. Lo<br />
Zandonai è un aristocratico dell’arte musicale; e nel suo lavoro infatti tutto è squisito e rifinito, tutto eletto ed<br />
elevato <strong>da</strong>lla forma melo<strong>di</strong>ca all’istrumentazione, <strong>da</strong>lla armonizzazione all’espressione <strong>di</strong> ogni minimo<br />
dettaglio. Riccardo Zandonai ha <strong>da</strong>l Grillo del focolare a questa <strong>Francesca</strong>, attraverso Conchita e Melenis<br />
compiuto un cammino veramente colossale. Il giovane musicista trentino, che salutammo con entusiasmo fin <strong>da</strong><br />
Conchita, mostra <strong>di</strong> voler trovare una via propria e forse le è vicino. Egli procede <strong>da</strong> Wagner, <strong>da</strong> cui ha appreso<br />
la potente polifonia, e <strong>da</strong> Debussy alla cui smagliante tavolozza hanno attinto non pochi dei suoi colori; ma non<br />
volendo essere un imitatore ha saputo assimilare la virtù <strong>di</strong> quei gran<strong>di</strong> cercando <strong>di</strong> <strong>da</strong>re alla sua arte<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/14
un’espressione nuova e tutta personale. Ha usato il leit-motiv, non alla maniera wagneriana ma solo per<br />
rievocare rapi<strong>da</strong>mente e quasi istantaneamente un personaggio, un’idea, un motivo d’emozione; si è servito qua<br />
e là delle formule debussiane non per fare dell’impressionismo musicale ma per creare in certi determinati<br />
momenti una soavissima atmosfera armonica intorno ai suoi personaggi. Le formule <strong>di</strong> Wagner e <strong>di</strong> Debussy<br />
sono state italianizzate e riscal<strong>da</strong>te con una forma melo<strong>di</strong>ca veramente sentita e aristocraticissima.<br />
Lo Zandonai è riuscito a scolpire in modo magnifico i suoi personaggi; ogni figura – meno forse quella <strong>di</strong><br />
Paolo – ha i suoi mirabili e decisi contorni che non si perdono più in tutta l’opera; e così <strong>Francesca</strong>, Gianciotto,<br />
Malatestino e le donne balzano fuori musicalmente con un risalto stragrande. Ma (è strano!) <strong>di</strong> fronte a tutta<br />
questa perfezione <strong>di</strong> concezione e aristocrazia <strong>di</strong> forma si prova specie verso la fine dell’opera come un senso <strong>di</strong><br />
stanchezza. È la forma del <strong>di</strong>scorso melo<strong>di</strong>co e della sua veste armonica poco varia e uniforme che genera il<br />
fenomeno; o è invece la tensione <strong>di</strong> fronte alle molteplici bellezze che si presentano una dopo l’altra rapide, sì<br />
che appena si giungono a percepire? Non sappiamo; certo è che ad un certo momento l’attenzione dell’u<strong>di</strong>tore<br />
appare come satura e si genera un senso <strong>di</strong> stanchezza.<br />
In ogni modo questa <strong>Francesca</strong> rimarrà come un documento prezioso non solo per qualità tecniche ma per<br />
nobiltà, per <strong>di</strong>gnità, per elevatezza <strong>di</strong> concezione artistica. Le formule melodrammatiche <strong>di</strong> sicuro successo, i<br />
soliti effetti <strong>di</strong> immancabile riuscita sulle masse sono stati nobilmente aboliti <strong>da</strong>llo Zandonai il quale ha evitato<br />
ogni accenno a volgarità, e là dove il libretto glie lo consentì ha trovato anche accenti appassionati ed espressivi.<br />
<strong>Francesca</strong> non è ancora l’opera perfetta, qualcosa le manca; ma non ci fa velo la ammirazione per la squisita<br />
opera d’arte e per l’ingegno fervido del suo autore nello affermare che <strong>da</strong> Riccardo Zandonai l’arte italiana può<br />
a buon <strong>di</strong>ritto attendere il capolavoro.<br />
***<br />
L’esecuzione è apparsa sotto ogni rapporto pregevole. Protagonista era Rosa Raisa che è stata per tutti una<br />
vera rivelazione. Questa giovanissima artista possiede una voce cal<strong>da</strong>, intonata, che sale con facilità agli acuti e<br />
che sa modularsi con metodo mirabile a tutte le esigenze della parte. Ma quando la scuola è ottima la riuscita è<br />
sempre sicura, e la Raisa è allieva della celebre Barbara Marchisio! Scenicamente compose con bella linea la<br />
figura <strong>di</strong> “<strong>Francesca</strong>” e riuscì così nelle dolci e soavi scene del primo atto, come in quelle <strong>di</strong> sgomento, <strong>di</strong><br />
dolore, <strong>di</strong> passione e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sperazione del resto dell’opera sempre efficace e seppe farsi ammirare ed applau<strong>di</strong>re<br />
<strong>da</strong>ll’imponente ed esigentissimo u<strong>di</strong>torio <strong>di</strong> ieri sera. La sua è stata un’affermazione artistica che le aprirà la via<br />
per una carriera brillantissima.<br />
Nella parte <strong>di</strong> “Paolo” si affermò un artista anch’esso nuovo per Roma: Aureliano Pertile, che <strong>di</strong>sse tutta la<br />
sua parte con bella voce e con giusta espressione facendosi meritatamente applau<strong>di</strong>re.<br />
Il baritono Giuseppe Danise <strong>di</strong>ede per voce robusta e per vigoria <strong>di</strong> slancio un ottimo risalto alla parte <strong>di</strong><br />
“Gianciotto”, e così anche efficacissimo si mostrò Luigi Nar<strong>di</strong> in quella molto <strong>di</strong>fficile vocalmente e<br />
scenicamente <strong>di</strong> “Malatestino”. Il basso Berar<strong>di</strong> (Astasio) [sic] in una parte baritonale mostrò come sempre <strong>di</strong><br />
essere artista coscienzioso e dotato <strong>di</strong> voce bella e poderosa. Ottime le altre parti minori, la Matteini<br />
(Samaritana), la Seracchioli (Biancofiore); la Manarini (Garsen<strong>da</strong>), la Verger (Altichiara), la Galeffi (Donella),<br />
la Perini (la schiava), e così Sabatano (Ser Toldo), Gironi (il Giullare), Pastorelli (il Balestriere) e Lanzi (il<br />
Torrigiano).<br />
Edoardo Vitale ha concertato l’opera con grande coscienza artistica, con impegno e con vero entusiasmo<br />
riuscendo a <strong>da</strong>re grande ed efficace risalto a tutte le finezze armoniche e strumentali che costituiscono uno dei<br />
gran<strong>di</strong> pregi del lavoro. Ottimi i cori istruiti <strong>da</strong>l maestro Nepoti.<br />
Riuscitissime le scene dello Stroppa e <strong>di</strong> bellissimo effetto il movimento delle masse, specie al secondo atto;<br />
merito questo <strong>di</strong> Carlo Clausetti che ha curato con grande competenza e con energia inesauribile la messa in<br />
scena.<br />
[...]<br />
58<br />
T. O. Cesar<strong>di</strong>, <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> al “Costanzi”, “La Vita”, 11-12.3.1915 - p. 3, col. 1-2-3<br />
Bisogna risalire, io credo, nei fasti del Costanzi a venticinque anni ad<strong>di</strong>etro, alla prima rappresentazione <strong>di</strong><br />
Cavalleria rusticana, per trovare un termine <strong>di</strong> confronto al successo unanime, sincero, profondo <strong>di</strong> quest’opera<br />
<strong>di</strong> Riccardo Zandonai.<br />
Sì, unanime, perché tutto il pubblico è stato avvinto, preso, dominato <strong>da</strong>ll’alta poesia del dramma musicale, e<br />
trasportato come in un’atmosfera <strong>di</strong> sogno e d’ideali: sincero perché l’applauso prorompente veniva <strong>da</strong> ogni<br />
or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> palchi, <strong>da</strong> ogni or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni, <strong>da</strong> tutto insieme un pubblico commosso e maravigliato, e profondo<br />
altresì perché l’impressione che ognuno ha risentito <strong>da</strong> questa nobile manifestazione d’arte è <strong>di</strong> quelle che non si<br />
cancellano perché segnano un solco nell’anima.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/15
L’opera ha già avuto altri pubblici che l’hanno esaltata e la critica ha già lietamente constatato il passo<br />
gigantesco fatto <strong>da</strong>ll’autore <strong>di</strong> Conchita, quantunque a far passi <strong>di</strong> tali proporzioni le sue gambe non appaiano<br />
ciclopiche.<br />
Il maestro Zandonai con questa sua <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> è ormai entrato in prima linea nella scarsa pattuglia<br />
dei nostri maggiori che o sembrano stanchi o deviano come vinti <strong>da</strong> incertezze fasti<strong>di</strong>ose o <strong>da</strong> affannose e<br />
<strong>di</strong>sfortunate ricerche. La sua forte giovinezza lo <strong>di</strong>fende <strong>da</strong> questi pericoli che avvertono i primi segni<br />
dell’esaurimento e forse del deca<strong>di</strong>mento.<br />
La sua arte è vibrante, appassionata, la sua musica è sopratutto onesta e sincera.<br />
Impresa ardua quant’altre mai tradurre e comentare le mille imagini del poema <strong>da</strong>nnunziano, rendere la<br />
multiforme figurazione del suo pensiero: ma poiché il dramma è tutto nell’anima <strong>di</strong> Paolo e <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, i due<br />
atti più intensi <strong>di</strong> commozione e <strong>di</strong> sentimento musicale sono senza dubbio il primo ed il terzo. L’attesa per<br />
l’arrivo <strong>di</strong> Paolo<br />
vestito d’una veste che si chiama<br />
frode nel dolce mondo<br />
e il ritorno dell’amato con la prima ron<strong>di</strong>ne sono le due soste profonde dell’amore che nasce, che si rafferma<br />
e che finirà con la morte come quello <strong>di</strong> Tristano per Isol<strong>da</strong> sua.<br />
E in questi due atti la musica dello Zandonai è così profon<strong>da</strong>mente espressiva, ha una così viva ed imme<strong>di</strong>ata<br />
significazione umana, <strong>da</strong> aggiungere nuova magnificenza alla poesia <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio. Il secondo atto<br />
invece è una chiazza <strong>di</strong> colore, uno squillo <strong>di</strong> battaglia, un episo<strong>di</strong>o d’ambiente. Ma quale ricchezza <strong>di</strong><br />
tavolozza! Che barbaglio <strong>di</strong> colori, che freschezza <strong>di</strong> tinte, che vivacità <strong>di</strong> contrasti!<br />
Perché lo Zandonai, oltre ad avere pensiero eletto, è un musicista profondo, gran<strong>di</strong>ssimo signore<br />
dell’orchestra <strong>da</strong> cui trae polifonie maravigliose con instancabile opulenza. Ben potrebbe <strong>di</strong> lui ripetere il<br />
Carducci che “mille anime infonde ai sonanti metalli”. E l’orchestrazione è un po’ come la mo<strong>da</strong> dei vestiti: il<br />
pensiero è <strong>di</strong> tutti i tempi, essa invece invecchia e tra<strong>di</strong>sce [l’]età implacabilmente. Lo Zandonai, senza le<br />
astruserie dello Struss [sic], senza le ricercatezze del De Bussy, senza pe<strong>di</strong>ssequi servilismi a Riccardo Wagner,<br />
è <strong>di</strong> una squisita modernità unicamente perché sa riuscire nuovo, inattesamente, imprevedutamente nuovo.<br />
***<br />
Ma non è alle tre <strong>di</strong> notte che posso cominciare a rior<strong>di</strong>nare le mie modeste impressioni critiche: scrivo<br />
soltanto, e <strong>di</strong> fretta, note <strong>di</strong> cronaca sulla serata lieta e festosa, una <strong>di</strong> quelle serate come raramente accadono in<br />
teatro, quando una corrente imme<strong>di</strong>ata si stabilisce fra palcoscenico e u<strong>di</strong>torio, e allo spettacolo presiede un<br />
buon genio tutelare.<br />
Una interprete eccezionale è stata la signorina Rosa Raisa, magnifico temperamento lirico e superba<br />
figurazione della mesta eroina <strong>da</strong>ntesca. Ella ha cantato tutta la sua <strong>di</strong>fficile parte con la nobiltà <strong>di</strong> linee e <strong>di</strong> stile<br />
<strong>di</strong> una gran<strong>di</strong>ssima artista, mentre ha <strong>da</strong>to alla interpretazione drammatica tutta la eccellenza della sua figura,<br />
l’ampiezza del gesto, la squisitezza del sentimento. Vero e ammirabile soprano drammatico, la signorina Raisa è<br />
anche un attrice <strong>di</strong> altissima classe, <strong>di</strong> quelle che nobilitano ed elevano un personaggio. L’impressione <strong>da</strong> lei<br />
destata è stata profon<strong>da</strong>, e l’ammirazione suscitata si è tosto tradotta in fervido entusiasmo.<br />
Valoroso compagno le è stato il Pertile, un tenore <strong>da</strong>lla voce nervosa, che egli sa spendere con arte finissima,<br />
ottenendo effetti <strong>di</strong> forza ed insieme <strong>di</strong> dolcezza veramente deliziosi. Ebbe applausi a scena aperta nel grande<br />
duetto del terzo atto e <strong>di</strong>vise colla bellissima <strong>Francesca</strong> gli onori del trionfo.<br />
Di tutti gli altri interpreti non posso <strong>di</strong>re che bene. Occorrerebbe tutto il libro delle lau<strong>di</strong> del buon Gabriele...<br />
che nessuno ancora ha messo in musica.<br />
Il Danise ha cantato con potenza e con grande carattere la parte <strong>di</strong> Gianciotto e il Nar<strong>di</strong> è stato un magnifico<br />
Malatestino <strong>da</strong>ll’Occhio, così come il bravo Berar<strong>di</strong> ha saputo <strong>da</strong>re il più grande rilievo alla parte <strong>di</strong> Ostasio.<br />
Fresche e chiare e dolci le voci delle donne <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, tra le quali per gentilezza squisita cantava la<br />
Verger, così come la devota Smarag<strong>di</strong> era impersonata <strong>da</strong>lla valente ed elegante Perini.<br />
Non mi è possibile ricor<strong>da</strong>re tutti – ma tutti hanno fatto egregiamente il loro dovere, <strong>da</strong>l giullare (il buon<br />
Cironi [sic] che è un fedele del Costanzi) all’ultimo corista, all’ultima comparsa.<br />
Il maestro Vitale ha trasfuso tutto il fuoco dell’autore alla sua eccellente orchestra ed ha veramente meritato<br />
le feste che il pubblico gli ha largamente tributate.<br />
L’allestimento scenico sontuoso e ogni più minuta cura d’ogni più minuscolo particolare tra<strong>di</strong>va la <strong>di</strong>ligenza<br />
grande, lo stu<strong>di</strong>o gran<strong>di</strong>ssimo e l’amore infinito che Emma Carelli ha <strong>da</strong>to a questo magnifico spettacolo.<br />
Chi ha potuto numerare le chiamate all’autore? E a che vale la statistica <strong>di</strong> fronte a una sola parola che è la<br />
più lieta constatazione del risultato conseguito ed è insieme augurio amorevole e presagio sicuro <strong>di</strong> altre nobili e<br />
ugualmente fortunate battaglie?<br />
Quella parola si chiama trionfo – e, per una volta tanto, risponde a schietta verità.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/16<br />
59
f[ranco] rain[eri], Il grande successo della <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio e Riccardo Zandonai<br />
al Teatro Costanzi, “Il Piccolo”, 11-12.3.1915 - p. 3, col. 2-3-4-5 (con foto <strong>di</strong> Zandonai; foto <strong>di</strong> E. Vitale;<br />
<strong>di</strong>segno grande <strong>di</strong> R. Raisa in mezzo alla pagina e in basso me<strong>da</strong>glioni-caricatura <strong>di</strong> C. Clausetti e <strong>di</strong> G. Danise)<br />
I più vecchi frequentatori del Costanzi hanno dovuto far appello ai loro ricor<strong>di</strong> più lieti e più annosi per<br />
ritrovare un successo degno <strong>di</strong> star al paragone con quello che ha raccolto iersera la <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong><br />
Zandonai. Successo grande, pieno, completo, entusiastico nel quale la nota caratteristica si deve <strong>di</strong>re sia<br />
consistita nella assoluta unanimità dei consensi. E sì che gli applausi, alla fine <strong>di</strong> ogni atto, erano così prolungati<br />
<strong>da</strong> <strong>da</strong>r tempo ai meno persuasi <strong>di</strong> titubar nella fede...<br />
Fede la quale accoglieva in sintesi il parere e il sentimento – cervello e anima – <strong>di</strong> tutti gli spettatori adunati<br />
in folla nella sala sfolgorante <strong>di</strong> luci e <strong>di</strong> bellezza: assistere finalmente, e contribuire, al trionfo <strong>di</strong> un’opera<br />
italiana. Così, senza aggettivi: ché guasterebbero la purità e la semplicità della gioia iersera provata e trasparente<br />
<strong>da</strong> tutti i volti, oltre che lietamente espressa nel rapido e fitto scambio d’impressioni, consueto ad una prima<br />
rappresentazione.<br />
Si pensava in fondo, iersera, che il teatro sarebbe dopotutto una gran bella cosa se l’orizzonte del<br />
palcoscenico e della platea – cui l’arcoscenico dovrebbe servire <strong>da</strong>... arcobaleno – non fosse invece così <strong>di</strong><br />
sovente coperto <strong>di</strong> nuvole minacciose...<br />
Dunque serata solenne e solennemente trionfale. La cronaca, quella ch’è ricercata quando si riduce ad una<br />
semplice espressione aritmetica, segna un numero... imprecisabile <strong>di</strong> chiamate: saranno state, in complesso,<br />
trenta o più? Certo è che il nostro pubblico, prima sod<strong>di</strong>sfatto poi convinto poi commosso, si è abbandonato a<br />
manifestazioni tali <strong>da</strong> farlo rassomigliare – almeno se le cronache transoceaniche non mentono – ad un pubblico<br />
americano!<br />
Per essere esatti soggiungiamo che il momento culminante del successo fu dopo il terzo atto; il primo ebbe<br />
pure molte chiamate per gl’interpreti, per il maestro Vitale, per Zandonai.<br />
Vennero poi, per or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> suffragi crescenti, il quarto atto nelle sue due parti e il secondo, del quale peraltro<br />
si apprezzava altamente la poderosa struttura sinfonica e l’efficace e vivace evidenza del quadro scenico.<br />
Ma parlando del magnifico successo con una certa commozione, quale è <strong>da</strong>ta anche <strong>da</strong>lla rarità del fatto <strong>da</strong><br />
tempo in qua e <strong>da</strong>lla compiacenza per la nuova e questa volta clamorosa vittoria del più forte dei giovani<br />
compositori nostri, non si può esimersi – come accade appunto a chi... è commosso – <strong>da</strong>l rivolgere subito un<br />
pensiero alle persone che hanno contribuito ad ottenere quel successo e a <strong>da</strong>rci il raro go<strong>di</strong>mento artistico e<br />
spirituale che l’ha accompagnato e l’ha seguìto.<br />
E ricor<strong>di</strong>amo anzi tutto Vitale. Ecco un <strong>di</strong>rettore, già per tante ragioni stimato ed amato <strong>da</strong>l pubblico romano,<br />
che iersera – se fosse lecito <strong>di</strong>r così a chi della carriera artistica ha già percorsa tutta la flori<strong>da</strong> via – ha ancora<br />
fatto un passo innanzi: l’esecuzione impeccabile, <strong>di</strong>remo meglio l’interpretazione vivi<strong>da</strong>, colorita, smagliante,<br />
efficacissima <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> si deve per la massima e miglior parte a lui, e costituisce <strong>da</strong>vvero un titolo<br />
<strong>di</strong> merito insigne per un artista l’aver saputo condurre con così splen<strong>di</strong>do risultato al conspetto del pubblico<br />
giu<strong>di</strong>cante un’opera, una partitura complessa, spesso ardua nelle intime significazioni, sempre richiedente una<br />
cura minuziosa e intelligente in particolari, che la maggior parte delle volte accolgono delicate e sottili<br />
intenzioni artistiche, preziose per l’effetto dell’insieme.<br />
Di siffatti meriti si accorse del resto prima d’ogni altro il pubblico, che volle largamente, affettuosamente<br />
rimunerare l’illustre <strong>di</strong>rettore chiamandolo un’infinità <strong>di</strong> volte al proscenio e tributandogli gran<strong>di</strong> feste.<br />
Non vogliamo, dopo Vitale, graduare il conferimento dei premi e dei castighi (castighi per verità non ve ne<br />
possono essere...); ma tuttavia ci sembrerebbe <strong>di</strong> peccare contro un elementare senso <strong>di</strong> giustizia non rilevando<br />
subito che la signorina Rosa Raisa e il tenore Pertile furono entrambi protagonisti eccellenti della vittoriosa<br />
opera, veramente all’altezza <strong>di</strong> essa e della solenne circostanza. Erano, l’una e l’altro, sconosciuti al pubblico<br />
nostro. Non si potrebbe <strong>da</strong>vvero farsi conoscere meglio <strong>di</strong> così. La Raisa, che ha una voce bellissima, dolce e<br />
forte, vellutata e squillante, fresca ed estesa, intonatissima, la adopera con arte consumata, mirabile tanto più in<br />
una cantante giovane com’ella è; e per giunta <strong>di</strong>mostrò iersera d’aver inteso il personaggio dell’eroina <strong>da</strong>ntesca<br />
componendolo in una nobile linea d’interpretazione. Il Pertile è stato anch’egli una rivelazione gra<strong>di</strong>tissima,<br />
poiché canta con maestria e fraseggia con vigore d’intenzioni e con splen<strong>di</strong><strong>da</strong> chiarezza: si ebbe – ricor<strong>di</strong>amolo<br />
a cagion d’onore – un bell’applauso a scena aperta durante la scena d’amore del terzo atto.<br />
Ottimo a fianco dei protagonisti apparve il Danise nella parte importantissima <strong>di</strong> Gianciotto, ch’ebbe in lui<br />
specialmente magnifico rilievo vocale; dopo la prima parte dell’ultimo atto gli spettò col Nar<strong>di</strong> – Malatestino,<br />
buon cantante e coscienzioso artista – un particolare tributo <strong>di</strong> applausi.<br />
Assai apprezzate anche la Flora Perini nella parte della schiava Smarag<strong>di</strong>, la Matteini (Samaritana) e le<br />
quattro donne <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>; e poi il bravo basso Berar<strong>di</strong> (Ostasio) e il Gironi (Giullare).<br />
Bisogna infine lo<strong>da</strong>re senza riserve il coro, egregiamente istruito <strong>da</strong>l maestro Nepoti, e l’orchestrina <strong>di</strong><br />
strumenti antichi che suonava sul palcoscenico, nonché l’orchestra più vera e maggiore. Assai decorosi parvero<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/17
gli scenari e assai belli i costumi: il tutto, parte artistica e parte scenica, fatica particolare del cav. Clausetti, il<br />
ben noto animatore e... tutore <strong>di</strong> spettacoli.<br />
Ma... non si può terminare in buona coscienza un resoconto, sia pure affrettato, della serata <strong>di</strong> ieri senza<br />
avere assolto il dovere <strong>di</strong> <strong>di</strong>re esplicitamente una parola <strong>di</strong> lode – ciò che non siam soliti <strong>di</strong> fare – all’Impresa.<br />
La quale ha il merito d’aver voluto e saputo condurre alla scena, durante una stagione che si svolge in<br />
circostanze <strong>di</strong>fficili ed anormali come questa, e con grande decoro artistico, uno spettacolo <strong>di</strong> grande importanza<br />
artistica come questa <strong>Francesca</strong>.<br />
Non solo, ma ha il merito d’aver creduto nel talento e nella fortuna <strong>di</strong> Zandonai ai tempi men felici e men<br />
leggiadri per lui e per le opere sue, le quali, pur ricche <strong>di</strong> pregi, non costituivano certo allora una cospicua<br />
risorsa per la cassetta.<br />
È venuta ora <strong>Francesca</strong>, e il pubblico si propone <strong>di</strong> far larga ammen<strong>da</strong> della sua apatia. Farà benissimo.<br />
[...]<br />
60<br />
Franco Raineri, Il grande successo <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> d’Annunzio e Zandonai, al Costanzi, “Il Giornale<br />
d’Italia”, 12.3.1915 - p. 3, col. 3-4-5-6/p. 4, col. 1-2 (con foto <strong>di</strong> R. Zandonai, E. Vitale, R. Raisa)<br />
Mentre – calato il sipario su la duplice vendetta <strong>di</strong> Gianciotto – la bufera infernal che mai non resta menava<br />
già con la sua rapina gli spiriti <strong>da</strong>nteschi <strong>di</strong> Paolo e <strong>Francesca</strong>, la gran folla magnifica s’avviava alle uscite<br />
recando nel cuore e nella mente, per la prima volta dopo tanto tempo, una persuasione confortante e concorde:<br />
quella d’aver ascoltata una nuova opera italiana bella e commovente, d’essersi infine trovata <strong>di</strong> fronte un<br />
musicista giovane e geniale, cui la Provvidenza – e sia lode a Lei, per l’arte e per noi – ha voluto largire, oltre la<br />
sapienza, la scintilla.<br />
E <strong>da</strong>vvero che, per chi preten<strong>da</strong> i critici <strong>di</strong> mestiere sempre in contrasto nel giu<strong>di</strong>zio con la maggioranza del<br />
pubblico, questa volta il resoconto suscita un atroce <strong>di</strong>singanno. Perché mai forse così come oggi la critica<br />
spassionata deve procedere d’accordo con la cronaca lietissima dello spettacolo, per concludere insomma che<br />
iersera Roma, a un anno circa <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza <strong>da</strong>lla prima vittoriosa apparizione della “<strong>Francesca</strong>” a Torino, ha<br />
conferito meritatamente a Zandonai e a questa sua più recente e nobilissima creatura d’arte gli onori del trionfo.<br />
Onori, poi, che – si passi il bisticcio – onorano assai il nostro pubblico romano, <strong>di</strong>mostratosi iersera giu<strong>di</strong>ce<br />
sereno ed intelligente, <strong>di</strong>sposto sì alla severità ma anche al più commosso e sincero entusiasmo quando... ci sia<br />
qualcuno capace <strong>di</strong> destare nei petti la sacra fiamma <strong>da</strong> troppo tempo sopita.<br />
Così è avvenuto che – a traverso le melo<strong>di</strong>e fascinose <strong>di</strong> questo piccolo e fecondo maestro trentino cresciuto<br />
<strong>da</strong> pochi anni con tenacia <strong>di</strong> nobili sforzi nell’arringo del teatro musicale fino a conquistarsi un posto fra i<br />
primissimi – è avvenuto, <strong>di</strong>co, che si sia pienamente verificata, sotto il controllo <strong>di</strong> una moltitu<strong>di</strong>ne, una profezia<br />
apparsa su le colonne <strong>di</strong> questo giornale all’epoca <strong>di</strong> “Conchita” (88) , una profezia che torna tanto più opportuno<br />
ricor<strong>da</strong>re oggi, con i tempi che corrono...<br />
Disse allora il nostro Nicola d’Atri che non gli pareva lontano il giorno nel quale si sarebbe compiuta, sa un<br />
irredento, la redenzione del dramma musicale italiano. “Conchita” si è fatta seguire a breve <strong>di</strong>stanza <strong>da</strong><br />
“<strong>Francesca</strong>”, e “<strong>Francesca</strong>” è per l’appunto – o noi c’inganniamo (ma in tal caso saremmo in parecchi, anzi in<br />
moltissimi) – l’opera che segna, nel teatro italiano <strong>di</strong> musica, la redenzione del canto, antica e autentica gloria<br />
nostra, <strong>da</strong>lle soperchierie dello straniero, la redenzione del dramma lirico <strong>da</strong>lle influenze della nebbiosa<br />
concettualità moderna o, come si <strong>di</strong>ce ora <strong>di</strong> nuovo, <strong>da</strong>l giogo della “Kultur”. I destini politici della più grande<br />
patria, poi, sebbene si trovino in pieno fermento d’angoscia, fanno sì che Zandonai è oggi ancora un irredento.<br />
Per quanto tempo?<br />
Ma, poi che abbiamo citato una profezia, ci sia concesso <strong>di</strong> ricor<strong>da</strong>re anche dello stesso profeta – il d’Atri è<br />
stato <strong>da</strong>vvero, e non fu piccola au<strong>da</strong>cia qualche anno fa, il "profeta" del compositore trentino oggi illustre – un<br />
giu<strong>di</strong>zio sintetico su l’opera che iersera ha conseguito così clamorosa vittoria. In occasione della "'prima" <strong>di</strong><br />
“<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” al Regio <strong>di</strong> Torino il nostro eminente collega scriveva che “il temperamento musicale<br />
coloristico dello Zandonai, già rilevato nella “Conchita”, trova nella nuova opera esplicazione altamente poetica<br />
e si completa con l’affermazione <strong>di</strong> un altro temperamento che è in lui: quello del melo<strong>di</strong>sta, che lirizza e canta.<br />
Tutta la "<strong>Francesca</strong>", salvo alcune scene come quella della battaglia, è materiata <strong>di</strong> musica melo<strong>di</strong>ca e cantabile:<br />
le voci secondo la grande tra<strong>di</strong>zione italiana regolano la condotta musicale del dramma, non l’orchestra;<br />
l’orchestra <strong>di</strong>pinge, descrive con frammenti ad essa apprestati <strong>da</strong>lle melo<strong>di</strong>e vocali”.<br />
Tale giu<strong>di</strong>zio, sorto <strong>da</strong>lle impressioni del momento che la consuetu<strong>di</strong>ne ha ormai consacrato come l’unico<br />
giusto per le critiche teatrali – e cioè subito dopo la prima comparsa dell’opera in teatro – ci sembra ancor oggi<br />
esprimere felicemente, almeno in genere, i caratteri <strong>di</strong> questa “<strong>Francesca</strong>”, arrivata a noi dopo una serie <strong>di</strong><br />
sentenze, tutte favorevoli.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/18
Basterebbe, cre<strong>di</strong>amo, il primo atto della trage<strong>di</strong>a <strong>da</strong>nnunziana, così com’è stato visto <strong>da</strong>l musicista, per farci<br />
<strong>di</strong>re: ecco, veramente, un quadro musicale. E non intenderemmo riferirci affatto, con questo, a quel tipo <strong>di</strong><br />
musiche modernissime che specialmente all’estero si raccoman<strong>da</strong>no come “tableaux” o come “exquisses” alla<br />
buona volontà e alla fantasia dell’ascoltatore dopo averle eccitate con certi titoli stranamente naturalistici e <strong>di</strong><br />
gergo pittorico.<br />
No: questo primo atto <strong>di</strong> “<strong>Francesca</strong>”, tra la corte <strong>di</strong> logge e <strong>di</strong> cancelli delle case dei Polentani e il giar<strong>di</strong>no<br />
<strong>di</strong> maggio fiorito e solatio, è quadro nel senso che ci apparisce come una figurazione sonora delle immagini<br />
liriche ond’è intessuta la trama del paesaggio poetico <strong>di</strong>segnato <strong>da</strong> Gabriele d’Annunzio. Su quelle immagini lo<br />
Zandonai, con animo <strong>di</strong> musicista moderno, ha <strong>di</strong>pinto nei suoni un paesaggio musicale arcaico. Negate, se<br />
potete, <strong>di</strong> non aver rivissuto iersera, per virtù <strong>di</strong> suggestioni dolci e penetranti, una scena del duecento nostro<br />
misterioso e pittoresco, <strong>di</strong> non averla vista e <strong>di</strong> non averla sentita culminare nel quadro della rosa vermiglia<br />
offerta <strong>da</strong>lle mani della vergine sposa a Paolo il Bello, mentre la canzonetta gentile delle donne intona la sua<br />
cadenza sul ritmo della viola pomposa, del piffero e del liuto.<br />
Un paesista, dunque, <strong>di</strong> vera efficacia descrittiva; ma anche e soprattutto un lirico animato <strong>da</strong>lla voce<br />
fremente dell’estro e un drammaturgo capace delle più solide e più geniali strutture.<br />
Zandonai – si rallegrino quanto lacrimavano ormai la morte del canto melo<strong>di</strong>co – canta: se pure le sue opere<br />
precedenti non ce ne avevano convinti abbastanza, “<strong>Francesca</strong>” ce ne dà la prova invincibile. E canta con<br />
libertà, con sincerità, con italianità <strong>di</strong> sentimento; canta creando, senza averli preor<strong>di</strong>nati su schemi formali,<br />
perio<strong>di</strong> melo<strong>di</strong>ci che assumono valore drammatico e senso musicale <strong>da</strong> una fonte purissima <strong>di</strong> bellezza artistica:<br />
l’inspirazione. Perio<strong>di</strong> che s’accor<strong>da</strong>no mirabilmente sul sonante splendore dei versi <strong>da</strong>nnunziani e che,<br />
musicalmente, si <strong>di</strong>rebbe talora, e proprio quando la lirica è più alta e vibrante, si atteggiano finanche in rime,<br />
coi riflessi <strong>di</strong> certe caratteristiche risoluzioni e il reiterarsi strofico <strong>di</strong> determinate figurazioni e cadenze.<br />
Tutto ciò é, se non erriamo, poesia: poesia nella sua espressione più artistica, vale a <strong>di</strong>re in un momento che<br />
supera <strong>di</strong> gran lunga quel certo stato <strong>di</strong> vaga concitazione che serve a fantasticare poeticamente, ma non a<br />
concepire un poema e neppure soltanto un sonetto degni <strong>di</strong> tal nome. Poesia, insomma, che trascendendo in un<br />
mondo superiore, quello dei suoni, i mo<strong>di</strong> e le forme proprie ai poeti e ai gran<strong>di</strong> poeti, non nega né offusca gli<br />
uni e le altre, e anzi ne fa <strong>di</strong>sciplina al libero esprimersi dello spirito creativo.<br />
Del resto, qual meraviglia se un artista della tempra <strong>di</strong> Riccardo Zandonai venuto finalmente in contatto con<br />
un artista della tempra <strong>di</strong> d’Annunzio si sia lasciato tutto compenetrare <strong>da</strong>lla nobiltà formale e <strong>da</strong>lla bellezza<br />
ideale del poema <strong>di</strong> lui, conferendo a questo, “alitante deo”, il fascino d’una musica più che animatrice,<br />
integratrice? Non è in tal modo che si compie la fusione miracolosa della poesia e della musica, sognata troppo<br />
spesso invano <strong>da</strong> musicisti e poeti e... <strong>da</strong>l pubblico?<br />
E <strong>di</strong> elementi lirici che s’inseguono e si sviluppano e si sno<strong>da</strong>no con una freschezza e una esuberanza tali <strong>da</strong><br />
apparire come linfa vitale è percorsa tutta l’opera e n’è pervasa fin nelle fibre che si <strong>di</strong>rebbero più ascose, fin<br />
nelle persone che si <strong>di</strong>rebbero più secon<strong>da</strong>rie e meno significative: è l’ambiente che Zandonai ha liricamente<br />
visto, con sguardo acuto e penetrante d’artista, è l’atmosfera <strong>di</strong> quel dramma <strong>di</strong> ferocia e <strong>di</strong> lussuria in cui egli<br />
ha soffiato l’alito possente del suo lirismo, che accarezza e che scuote, che riscal<strong>da</strong> e che agghiaccia, che<br />
blan<strong>di</strong>sce e che trascina, nei sospiri d’amore, nelle fiamme del desiderio, nel tripu<strong>di</strong>o della passione: amore,<br />
desiderio, passione, tre volte amore come nelle tre terzine <strong>da</strong>ntesche, amore protagonista, dominatore fatale<br />
nella trage<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Paolo e <strong>Francesca</strong>.<br />
Ma se in tutto e per tutto, sempre, ciecamente, il musicista si fosse <strong>da</strong>to in braccio al suo spontaneo<br />
sentimento lirico, quello – tanto per intenderci – che iersera, com’era naturale, ha trovato più imme<strong>di</strong>ata<br />
rispondenza negli animi degli spettatori e che sprigiona <strong>da</strong>ll’opera tanto poter <strong>di</strong> fascino, l’opera, il dramma<br />
musicale non ci sarebbe stato. E la trage<strong>di</strong>a stessa <strong>da</strong>nnunziana sarebbe stata tra<strong>di</strong>ta nella ragione della sua<br />
<strong>di</strong>namica ed irresistibile potenza. Ond’è che lo Zandonai, cervello sereno <strong>di</strong> montanaro oltre che anima<br />
appassionata <strong>di</strong> poeta, ha posto a frutto le sue doti naturali e la sua tecnica <strong>di</strong> drammaturgo e ha concepito, ha<br />
organizzato il dramma, che pertanto risulta, in musica, mirabilmente chiaro ed efficace com’è in versi.<br />
Ché anzi questi, sfron<strong>da</strong>ti appunto per necessità della scena musicale e ridotti quantitativamente ad una<br />
classica solennità, appaiono essi stessi, così, d’assai più efficaci e più chiari <strong>di</strong> quel che sia il bellissimo testo<br />
originale...<br />
Prendete, se avete voglia <strong>di</strong> far passare al musicista... drammaturgo un esame, prendete il secondo atto –<br />
tutto, così com’è – e la prima parte dell’ultimo, cioè la scena nella quale Malatestino, bieco e brutale amante<br />
respinto, svela perfi<strong>da</strong>mente a Gianciotto la colpa dei due cognati. Ebbene: in quel secondo atto che sembra con<br />
le sue ru<strong>di</strong> sonorità e i suoi accesi colori quasi una stonatura fra le delicatezze del primo e il calor passionale del<br />
terzo, Zandonai ha riposto, come un nobile scultore che si vale d’ombre e <strong>di</strong> luci, il segreto della bellezza del<br />
primo e del terzo: ha trovato, in d’Annunzio, un quadro vasto e a fragorose tinte con nel mezzo un tenero<br />
episo<strong>di</strong>o fatto <strong>di</strong> gentilezza e d’intimità; e l’ha musicalmente sbozzato alla brava, mantenendo alla battaglia il<br />
ruolo <strong>di</strong> protagonista, affermando in orchestra la sua sapienza <strong>di</strong> sinfonista e <strong>di</strong> colorista e, infine, giovandosi<br />
abilmente del contrasto nell’economia del lavoro.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/19
La scena, poi, fra lo Sciancato e quel “<strong>da</strong>ll’Occhio” – ch’è, per il dramma, la scena necessaria <strong>da</strong> cui deriva<br />
la catastrofe – ha acquistato nella musica, per il gioco e lo sviluppo dei temi gagliar<strong>di</strong> e tipicamente ritmici dei<br />
due interlocutori, un rilievo <strong>di</strong> magnifica evidenza, al tempo stesso che in scena il musicista rivela un nuovo<br />
aspetto dell’arte sua, trattando il recitativo melo<strong>di</strong>co con intenzioni realistiche e con poderoso vigore.<br />
Tuttavia il paesista, il lirico, il drammaturgo che si contengono nell’esile e minuscola persona – ormai<br />
anch’essa avviata, proprio come persona, alla popolarità – non bastano a caratterizzare la figura del maestro né<br />
la sua musica, iersera così unanimemente applau<strong>di</strong>ta. Che dunque?<br />
Si è che la musica <strong>di</strong> Riccardo Zandonai, tutta ma specialmente “<strong>Francesca</strong>”, è – come accennavamo in<br />
principio – francamente e modernamente italiana nel sentimento, nel gusto, nella estetica stessa per cui<br />
s’esprime su la scena <strong>di</strong>visa finora fra ver<strong>di</strong>ani, wagneriani ed ora debussyani: musica d’un italiano che non<br />
ignora certo siffatti movimenti d’arte ma che <strong>di</strong> essi ha assimilato nel proprio temperamento originale le<br />
conquiste tecniche.<br />
È – penso – caso bizzarro o categorico ammonimento quello che rivela, proprio <strong>di</strong> questi giorni, alla capitale<br />
d’Italia, al cervello della nazione, una ricca, limpi<strong>da</strong>, impetuosa fonte d’italianità, scaturita là su le balze del<br />
fati<strong>di</strong>co Trentino? (89)<br />
61<br />
Edoardo Pompei, “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” <strong>di</strong> R. Zandonai al “Costanzi”, “Il Messaggero”, 11.3.1915 - p. 5, col.<br />
2-3-4<br />
La prima rappresentazione <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> del maestro Zandonai costituiva l’avvenimento più atteso<br />
dell’attuale stagione lirica al Costanzi, pertanto il miglior pubblico <strong>di</strong> Roma erasi raccolto ieri sera nella sala<br />
magnifica per intendere e giu<strong>di</strong>care la recente produzione del giovane e valoroso compositore trentino. Il<br />
successo che all’opera decretarono a suo tempo Torino, Pesaro, Modena, trovò pirna conferma ieri sera: ogni<br />
atto ebbe accoglienze festose e al calar del velario il maestro Zandonai e gli interpreti vennero evocati<br />
innumerevoli volte al peoscenio. Né il giu<strong>di</strong>zio del pubblico – pure attraverso le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> sorprendere in una<br />
sola au<strong>di</strong>zione le mille bellezze profuse nello spartito, e fra le inevitabili nervosità <strong>di</strong> una prima prova – poteva<br />
essere <strong>di</strong>verso: quel pubblico avvertiva nello svolgimento degli episo<strong>di</strong> musicali una grande serietà artistica, una<br />
sincera nobiltà <strong>di</strong> inten<strong>di</strong>menti, i segni squisiti <strong>di</strong> una tempra <strong>di</strong> musicista ricca <strong>di</strong> originalità, <strong>di</strong> buon gusto e <strong>di</strong><br />
coltura.<br />
Fra i giovani musicisti in Italia non v’ha alcuno che possa eguagliare lo Zandonai nel <strong>di</strong>fficile magistero<br />
strumentale. Egli possiede non solo il dominio assoluto della dottrina e la sapienza e la coscienza degli effetti<br />
orchestrali noti più o meno a quanti hanno consuetu<strong>di</strong>ne coll’orchestra, ma ha lo spirito au<strong>da</strong>ce della ricerca, la<br />
sicurezza della <strong>di</strong>namica del grande organo orchestrale. Egli conosce e sa tutte le forze strumentali, espressive<br />
ed intime <strong>di</strong> ogni singolo strumento, <strong>di</strong> ogni famiglia <strong>di</strong> strumenti; ha un criterio particolarmente a<strong>da</strong>tto a<br />
rendere ogni colore nelle infinite varietà dei toni, dei chiaroscuri, dei contrasti. Egli è sopratutto un colorista, e il<br />
suo strumentale saldo, vario, ricco <strong>di</strong> sfumature acquista nella trattazione, tutta personale, un carattere<br />
profon<strong>da</strong>mente suggestivo.<br />
E tutto è colore in questa <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>. Il maestro stesso così ha definito i suoi atti: il primo è<br />
serenità; il secondo, con la battaglia, i fragori, gli urli, le campane, è a forti tinte scarlatte; il terzo, quello della<br />
lettura e del bacio, è <strong>di</strong> colore azzurro; la prima scena del quarto, la delazione <strong>di</strong> Malatestino, è in grigio ferro; il<br />
quadro finale, dove la trage<strong>di</strong>a precipita, ha il colore dell’acqua stagnante. E chi ascolta la musica sente che<br />
queste definizioni coloristiche hanno veramente un significato.<br />
Altro segno particolare dell’orchestrazione dello Zandonai è questo, che le sonorità non raggiungono gra<strong>di</strong><br />
d’intensità soltanto per raddoppio <strong>di</strong> parti, per sovrapposizione <strong>di</strong> suoni, ma per peculiari atteggiamenti, per<br />
varietà <strong>di</strong> impasti e <strong>di</strong> timbri, per ingegnosissimi accoppiamenti. Vi è nello strumentale <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong><br />
un senso spontaneo <strong>di</strong> ricerca che dona ad essa freschezza e <strong>di</strong>rei quasi originalità, e per entro le figurazioni<br />
schematiche circola sempre in abbon<strong>da</strong>nte copia lo spirito che vivifica le movenze e i sentimenti, e l’orchestra<br />
racconta e <strong>di</strong>scorre, proietta luce e tenebre nelle persone del dramma a secon<strong>da</strong> delle significazioni psicologiche<br />
che esse hanno nella loro vita scenica.<br />
Ma in tutto questo ricco trapunto orchestrale, fra tanta bellezza <strong>di</strong> sottili <strong>di</strong>segni musicali l’idea melo<strong>di</strong>ca non<br />
ha quasi mai un respiro ampio e profondo, e si ha tutta la impressione che il compositore miri piuttosto,<br />
nell’abbon<strong>da</strong>nza esuberante dei mezzi a sua <strong>di</strong>sposizione, a trascurare <strong>di</strong> proposito o per una invincibile<br />
deficienza del suo temperamento il periodo largo, senza raggiungere nel declamato quella intensità <strong>di</strong><br />
espressione, quel soffio potente e largo della vera ispirazione che giustificano il voluto ostruzionismo <strong>di</strong> quelle<br />
idee melo<strong>di</strong>che che costituiscono e costituiranno sempre l’essenza <strong>di</strong> ogni opera destinata a vincere gli urti del<br />
tempo.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/20
Al primo atto l’entrata <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> è annunziata <strong>da</strong> un coro leggiadrissimo delle sue giovani donne. Ella<br />
appare sulla loggia insieme a Samaritana, la “piccola colomba” che implora la sorella <strong>di</strong> non an<strong>da</strong>re sposa, e tra<br />
una varietà <strong>di</strong> piccoli episo<strong>di</strong>, la delicatezza <strong>di</strong> taluni impasti orchestrali, il guizzare <strong>di</strong> qualche frase felice, si<br />
arriva all’apparizione <strong>di</strong> Paolo, appoggiata al suono <strong>di</strong> tre strumenti antichi: una viola pomposa a cinque corde<br />
con sotto altre corde metalliche <strong>di</strong> risonanza, un piffero e un liuto. Paolo non <strong>di</strong>ce parola, <strong>Francesca</strong> rimane<br />
immobile ed egli si ferma, e stanno l’una contro l’altro guar<strong>da</strong>ndosi senza parola e senza gesto. Poi ella si separa<br />
<strong>da</strong>lla sorella, coglie una grande rosa vermiglia e la offre a Paolo. E sulla scena – profon<strong>da</strong>mente suggestiva – e<br />
sul dolce canto che si sprigiona <strong>da</strong>lla viola e <strong>da</strong>ll’orchestra cade il velario.<br />
Il secondo atto è il meno felice dell’opera. La scena della battaglia, pure trattata con mirabile sicurezza, non<br />
ha musicalmente corrispondenza cogli episo<strong>di</strong> guerreschi.<br />
La padronanza <strong>di</strong> tutti i meccanismi, <strong>di</strong> tutti gli effetti istrumentali, <strong>di</strong> tutte le sonorità non rendono la scena<br />
immaginata <strong>da</strong>l poeta: tutti i valori particolari <strong>di</strong> ogni strumento, tutte le prepotenze del pieno orchestrale non<br />
dànno che frastuono, che rumore; manca, attraverso il poderoso lavoro orchestrale, la frase, il motivo che susciti<br />
l’impressione esatta del momento che si vuol descrivere. E nemmeno il duetto tra Paolo e <strong>Francesca</strong>, nel lungo<br />
declamato, ha ricchezza d’ispirazione geniale, quel senso <strong>di</strong> calore, <strong>di</strong> vigore e <strong>di</strong> passione che lo stato d’animo<br />
dei due personaggi farebbe supporre in quell’istante in mezzo al <strong>di</strong>vampare della battaglia.<br />
Il terzo atto è veramente superbo per la signorilità della forma e la bellezza del canto. Qui l’ispirazione si<br />
innalza e tutta la musica si anima e si riscal<strong>da</strong>. La leggiadra canzonetta delle quattro donne, ravvivata <strong>da</strong> squisite<br />
figurazioni <strong>di</strong> <strong>da</strong>nza, il canto appassionato <strong>di</strong> Paolo e la frase <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, dolcemente melo<strong>di</strong>ca, e tutto il<br />
duetto fra Paolo e <strong>Francesca</strong>, vibrante <strong>di</strong> passione e <strong>di</strong> impeto lirico, suscitarono nell’u<strong>di</strong>torio la più schietta<br />
ammirazione.<br />
Ed eguale successo ebbe la prima parte del quarto atto, così vigorosamente scultorio ed incisivo, e così pure<br />
l’ultima parte, riboccante <strong>di</strong> sentimento.<br />
Dal Grillo del Focolare, l’opera con ma quale iniziò la sua carriera <strong>di</strong> compositore, a questa <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong><br />
<strong>Rimini</strong>, attraverso la Melenis e la Conchita, lo Zandonai ha compiuto meravigliosi progressi. La sua personalità<br />
artistica si è affinata, in<strong>di</strong>vidualizzata, ed egli procede ormai sicuro nella sua via colla certezza magnifica <strong>di</strong> chi<br />
ha un nobile ideale <strong>da</strong> raggiungere. E del successo <strong>di</strong> ieri, successo sincero ed entusiastico, lo Zandonai, che ha<br />
un temperamento musicale <strong>di</strong> primo or<strong>di</strong>ne, virtù <strong>di</strong> sentimento, virtù <strong>di</strong> cultura, ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> an<strong>da</strong>re<br />
orgoglioso.<br />
L’esecuzione della nuovissima opera riuscì conforme all’avvenimento artistico. Tutti gli interpreti si<br />
rivelarono degni dell’ardua prova, e in singolar modo il maestro Vitale, che tutta la sua vigile cura, tutta la sua<br />
grande coscienza d’artista sereno e forte portò alla concertazione e alla <strong>di</strong>rezione dell’opera. E mai applauso fu<br />
più meritato <strong>di</strong> quello che con unanime consenso volle più volte decretargli l’u<strong>di</strong>torio imponente.<br />
Una gra<strong>di</strong>ta rivelazione fu per ognuno degli spettatori la signorina Raisa Rosa, un’artista sconosciuta al<br />
nostro pubblico ma meritevole veramente <strong>di</strong> figurare nel nostro massimo teatro. La sua voce bellissima, fresca,<br />
estesa, squillante ella profuse senza risparmio nei quattro atti, cantò con passione, con calore, con un senso<br />
d’arte mirabile, mentre nella espressione scenica riuscì ad essere un’interprete <strong>di</strong> non comune valore. E fu – è<br />
superfluo aggiungerlo – entusiasticamente applau<strong>di</strong>ta, insieme al tenore Pertile, anch’egli fin qui ignoto a noi<br />
ma per la potenza dei suoi mezzi vocali capace <strong>di</strong> superare le non lievi <strong>di</strong>fficoltà della partitura. Il Danise<br />
impersonò con grande arte la figura <strong>di</strong> Gianciotto e fu come sempre cantante nobilissimo; il Berar<strong>di</strong>, nella breve<br />
parte <strong>di</strong> Ostasio, dette una nuova prova della gagliar<strong>di</strong>a della sua voce; ottimo Malatestino per efficacia scenica<br />
il Nar<strong>di</strong>; squisita cantante ed interprete valorosa Flora Perini nella parte della “Schiava”. E poi tutti gli altri, e<br />
cioè: la Matteini, la Verger, la Seracchioli, la Menarini [sic], la Galeffi, il Sabatano, il Gironi, il Pastorelli, il<br />
Lanzi concorsero colla loro bravura al successo dell’opera.<br />
L’allestimento scenico, curato con particolare amore <strong>da</strong>l comm. Tito Ricor<strong>di</strong> e <strong>da</strong> Carlo Lausetti [sic], e i<br />
costumi sfarzosi apparvero degni del lietissimo avvenimento artistico.<br />
[...]<br />
62<br />
Fausto Torrefranca, La “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>”, “L’Idea nazionale”, 12.3.1915 - p. 6, col. 1-2<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Tito Ricor<strong>di</strong> e Riccardo Zandonai, che abbiamo sentita ieri sera al Costanzi, ha<br />
avuto successo. E aggiungiamo che <strong>da</strong> un certo punto <strong>di</strong> vista – che non è <strong>di</strong> certo il nostro, decisamente<br />
contrario al solito operismo commerciale <strong>di</strong> marca ricor<strong>di</strong>ana – merita il successo che ha avuto. Il quale non è<br />
stato per tutti gli atti entusiastico ed unanime né <strong>di</strong> uguale intensità, sebbene unanimemente si giu<strong>di</strong>chi che<br />
l’opera nel suo complesso sia vitale e possa correre, almeno per qualche tempo, le scene italiane e straniere. Ma<br />
è bene astenersi <strong>da</strong>l fare profezie, che con la critica non hanno mai avuto e non avranno nulla <strong>da</strong> fare. Più tosto è<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/21
necessario che io vi confessi che, nella mia qualità <strong>di</strong> critico musicale, ho assai poco <strong>da</strong> <strong>di</strong>rvi su questa<br />
<strong>Francesca</strong>.<br />
Avrei molto <strong>da</strong> <strong>di</strong>rvi se, uscendo <strong>da</strong>l mio campo – cosa che sarebbe assai <strong>di</strong> mio gusto – mi ritraessi all’anno<br />
nel quale sentimmo qui a Roma la <strong>Francesca</strong> nella sua genuina veste <strong>di</strong> pura poesia e... non la capimmo. Fu la<br />
letteratura, si <strong>di</strong>ce. Ma fu invece la – come <strong>di</strong>re? – la cafonaggine <strong>di</strong> gran parte del pubblico che non era capace<br />
<strong>di</strong> accettare tutte le squisitezze del lavoro <strong>da</strong>nnunziano e, se anche ne fosse stato capace, non avrebbe voluto a<br />
nessun patto fare a Dante Alighieri il torto <strong>di</strong> ammirare Gabriele D’Annunzio. Non so se siamo ancora un po’<br />
cafoni in quanto spettatori <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> poesia, non è mio compito <strong>di</strong> <strong>di</strong>rlo né tantomeno <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrarlo, ma so<br />
bene che siamo ancora tali in quanto ascoltatori <strong>di</strong> musiche; e so che fra qualche tempo, quando ci si accorgerà,<br />
migliorando, che questa è la dolorosa verità, si penserà con un pochino <strong>di</strong> simpatia a coloro che hanno il<br />
coraggio e, se meglio vi piace, la faccia tosta <strong>di</strong> <strong>di</strong>rlo.<br />
E allora forse ci accorgeremo che questa <strong>Francesca</strong> ha avuto successo perché essa è una <strong>di</strong> quelle finzioni<br />
drammatiche che, pur potendosi reggere <strong>da</strong> sé, possono comportare un accompagnamento <strong>di</strong> musiche in grazia<br />
<strong>di</strong> tutta la veemenza e <strong>di</strong> tutto lo struggimento dell’anima lirica che vi restano come sospesi fra parola e parola,<br />
fra verso e verso, tra momento e momento del fatale an<strong>da</strong>re dell’azione tragica.<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>da</strong>nnunziana è un lavoro <strong>di</strong> altissima stilizzazione poetica ma, a punto e per ciò che<br />
la stilizzazione <strong>di</strong> ogni elemento vi ha aggiunto la sua massima espressione, si sente ancora al <strong>di</strong> là del nitore<br />
della frase, al <strong>di</strong> là della chiarità dell’immagine, al <strong>di</strong> là dello splendore <strong>di</strong> ogni minima frattura del verso, tutta<br />
la complessa ed accesa intimità lirica, tutta la solare luminosità figurativa che hanno imperiosamente voluto<br />
quella stilizzazione. Stilizzazione può essere – anzi più spesso è – povertà, ma può anche essere, come qui,<br />
ricchezza, <strong>di</strong>rittura, densità. Neve delle cime che avvalla e forma ghiacciai, si rasso<strong>da</strong>, si addensa, si fa<br />
cristallina e trasparente, si fa verde come <strong>di</strong> una vaga nostalgia <strong>di</strong> prato, sonora, ma come degli echi dell’interno<br />
fervore musicale della terra, liscia e luci<strong>da</strong> come il più alto pensiero specchio del mondo; una si frantuma anche,<br />
si lacera per mille ferite e invita verso l’oscuro fondo dei suoi crepacci, là dove serpeggia la vena dell’acqua<br />
perenne, dell’acqua che anima <strong>di</strong> musica le cime silenziose e <strong>di</strong> vita le piane più lontane.<br />
***<br />
Diciamo dunque la verità vera. Gabriele d’Annunzio è stato il vero trionfatore della serata, proprio come,<br />
scusate il paragone che sembra e non è irriverente, il Sardou è il vero autore della Tosca pucciniana.<br />
Aggiungiamo che il grande Verga è quello della Cavalleria mascagnana. La giovane scuola italiana, <strong>da</strong><br />
venticinque anni a questa parte, non ha fatto altro che aggiungere della musica ad opere <strong>di</strong> poesia – o più<br />
semplicemente <strong>di</strong> teatro – che già si reggevano <strong>da</strong> sé e <strong>da</strong> sole avevano conosciuto il successo. Il fenomeno si<br />
ripete identico a se stesso ad ogni nuovo autore che casa Ricor<strong>di</strong> o casa Sonzogno mettono in valore. L’ultimo è<br />
lo Zandonai, e lo Zandonai non è sostanzialmente <strong>di</strong>verso <strong>da</strong>gli altri. È più colto del Puccini, più fine e più<br />
scaltro <strong>di</strong> orecchio per quel che ha riguardo all’orchestra, è meno proclive del lucchese ai motivetti ballabili; è<br />
meno istintivo del Mascagni ma anche <strong>di</strong> lui meno grossolano. Tuttavia è sempre, suo malgrado, “marca<br />
Ricor<strong>di</strong>”. E questo – faccia pure gli scongiuri <strong>di</strong> rito il giovane maestro trentino – questo lo rovinerà. Sappiamo<br />
ad esempio che il Finale del quarto atto era <strong>di</strong>versamente scritto e che il Ricor<strong>di</strong> non lo ha accettato; e sentiamo<br />
senza che nessuno abbia bisogno <strong>di</strong> <strong>di</strong>rcelo che certe cadenzacce, certi effettoni, certe banalità romanzettaie che<br />
troppo spesso intervengono a prendere per il collo gli spettatori o a solleticarli sotto il ganascino son “articoli <strong>di</strong><br />
smercio sicuro” voluti <strong>da</strong>l <strong>di</strong>rettore della casa Ricor<strong>di</strong>. E sino a quando avremo, come abbiamo, non due case ma<br />
una casa e mezza e<strong>di</strong>trice <strong>di</strong> musica in Italia le cose non potranno non peggiorare. Oggi come oggi non si può<br />
fare del nuovo in Italia. Un giovane musicista, fosse anche un genio, è sempre una vittima, mai e poi mai un<br />
trionfatore.<br />
Applau<strong>di</strong>telo, se vi piace, ma abbiate anche un po’ <strong>di</strong> compassione per lui che è “come lo schiavo al remo,<br />
nella galèa che ha nome Disperata”.<br />
***<br />
Voi capite benissimo come io non possa essere del parere <strong>di</strong> tutti quegli i<strong>di</strong>oti che giu<strong>di</strong>cano che in<br />
quest’opera dello Zandonai mancano il periodo largo, la frase italianamente melo<strong>di</strong>ca, il motivo commovente.<br />
Siccome è acquisito oramai, alle patrie tra<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cultura, che un critico non debba sapere un ette né <strong>di</strong><br />
tecnica musicale né tanto meno <strong>di</strong> storia, così è anche naturale che tanti egregi ed illustri colleghi pensino che la<br />
musica italiana sia stata sempre caratterizzata <strong>da</strong> quello che essi chiamano melo<strong>di</strong>a. Anzi, ingenuamente<br />
pensano che, all’infuori dell’opera, nulla ci sia stato <strong>di</strong> veramente notevole nella nostra storia, se si eccettui, per<br />
la musica sacra, il Palestrina.<br />
Provate, amici miei, a chieder loro se sanno <strong>di</strong> che tipo fossero le musiche, ad esempio, del trecento, ossia<br />
quelle che ieri sera lo Zandonai avrebbe voluto riprodurre negli episo<strong>di</strong> del primo atto (l’arrivo <strong>di</strong> Paolo) e del<br />
terzo (canzonetta delle donne), e se stessero bene insieme, per quell’epoca storica, la viola pomposa, il piffero e<br />
il liuto che le eseguivano.<br />
Provatevi a chieder loro se non sarebbe stato utile allo Zandonai stu<strong>di</strong>are un po’ le musiche dell’Ars nova<br />
fiorentina per trarne degli elementi stilistici <strong>da</strong> idealizzare; e fare con ciò il massimo onore all’opera poetica<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/22
<strong>da</strong>nnunziana nella quale lo stesso processo è evidente per quanto riguar<strong>da</strong> la lingua, ed ha raggiunto tanta<br />
efficacia espressiva.<br />
Ma a che pro aprire tutte queste questioni? Io non finirei più <strong>di</strong> parlarvene, voi vi annoiereste e poi sarebbe<br />
fatica buttata al vento: non avrei infatti nessun contrad<strong>di</strong>ttore.<br />
Ma riassumerò le mie impressioni <strong>di</strong>cendo che alla viola pomposa avrei preferito l’organetto portativo,<br />
l’organetto a tastiera con ventiquattro canne che, collocato sul ginocchio sinistro, si suonava con la destra,<br />
mentre l’altra mano si manovrava un piccolo mantice posto <strong>di</strong>etro le canne. È l’organetto che ve<strong>di</strong>amo nelle<br />
mani della Santa Cecilia del Raffaello, è l’organetto che adorna, insieme al salterio, al piffero, al monocordo,<br />
alcuni fregi dei della Robbia, strumento dolcissimo e intenso <strong>di</strong> suono, strumento casalingo che fa, nel trecento,<br />
quello che il liuto nel cinquecento, il cembalo nel sei-settecento e quello che il pianoforte oggi.<br />
E se a questi due episo<strong>di</strong> io penso, a preferenza degli altri <strong>di</strong> questa <strong>Francesca</strong>, non è soltanto perché io,<br />
facendo professione <strong>di</strong> storico della musica, sento e vivo queste cose più degli altri, ma perché si tratta delle<br />
scene meglio riuscite della partitura, ed esse mi fanno pensare a quello che lo Zandonai avrebbe potuto fare con<br />
il suo talento <strong>di</strong> assimilatore e <strong>di</strong> stilizzatore se si fosse deciso d’essere in tutta l’opera più umanista e meno<br />
uomo del suo tempo. Uomo del suo tempo non solo ma, ahimè, uomo della sua <strong>di</strong>tta.<br />
Sono queste le qualità che mi fanno sperare che lo Zandonai, povero e secco quale sinfonista, possa invece<br />
contribuire ad innalzare il me<strong>di</strong>o livello del gusto presso il pubblico dei teatri lirici: cosa che oggi importa assai<br />
più della creazione <strong>di</strong> capolavori. I capolavori sono sempre sorti <strong>da</strong> terreno lavorato <strong>da</strong> una finissima cultura o<br />
rinverginato <strong>da</strong> una fresca barbarie <strong>di</strong> vita; ma non possono sorgere in un’epoca <strong>di</strong> fiacchezza, <strong>di</strong> incertezza e <strong>di</strong><br />
cafonaggine quale è ancora la nostra.<br />
Per ciò io mi compiacerò nel vedere lo Zandonai abbandonare, sia pure per insufficiente ispirazione<br />
melo<strong>di</strong>ca, che del resto è segno, buon segno, dei tempi, le vie della facile melo<strong>di</strong>etta che sviene o che<br />
singhiozza. La melo<strong>di</strong>a pendolare che è la sola risorsa del Puccini in lui quasi non esiste più. Se casa Ricor<strong>di</strong><br />
gliene fa esplicita or<strong>di</strong>nazione egli vi regala quell’inghirlan<strong>da</strong>ta <strong>di</strong> violette m’appariste ieri che ha man<strong>da</strong>to in<br />
sollucchero tutta la beozia pucciniana della galleria e della platea e che è invece, per un uomo anche solo <strong>di</strong><br />
gusto me<strong>di</strong>ocre, semplicemente irritante. O vi infligge quella orribile cadenza <strong>di</strong>: mostrava ella nu<strong>da</strong>to al mio<br />
dolore, dello stesso atto.<br />
Egli invece preferisce il lavoro fitto e frequente delle allusioni orchestrali: giuoco <strong>di</strong> timbri, <strong>di</strong> brevi ritmi, <strong>di</strong><br />
passaggi rapi<strong>di</strong> o lenti che rinforzano volta per volta il tono <strong>di</strong> una parola, che rallentano o accelerano l’abbrivio<br />
<strong>di</strong> un verso, che sospendono talora una sola parola come in un centro <strong>di</strong> luci riflessa <strong>da</strong> cento specchietti.<br />
In questo lavoro <strong>di</strong> pure intenzionalità egli riesce assai spesso efficace, come nel brano Nemica ebbi la luce,<br />
dello stesso terzo atto. Ma a lungo an<strong>da</strong>re questo proce<strong>di</strong>mento induce un senso <strong>di</strong> sazietà. Gli è che lo Zandonai<br />
manca <strong>di</strong> qualità propriamente sinfoniche – ciò che abbiamo visto fin troppo nelle Impressioni sinfoniche <strong>di</strong><br />
fresca memoria – ossia manca <strong>di</strong> quelle qualità che sole potrebbero rendere continuative, logiche, <strong>di</strong>scorsive<br />
quelle intenzionalità e quei momenti allusivi e, se meglio vi [ ]gestivi che l’arte sua <strong>di</strong> orchestratore va<br />
sperperando in qua e in là.<br />
La sua declamazione è sempre stu<strong>di</strong>ata e ricca <strong>di</strong> una sensibilità specifica piuttosto rara a trovarsi: quella<br />
dell’intervallo melo<strong>di</strong>co, donde la frequenza <strong>di</strong> modulazioni più o meno passeggere. Ma anche qui l’arte <strong>di</strong><br />
connettere insieme in un tutto che non sia né puccinescamente banale né francesemente prezioso gli manca.<br />
Basti per tutti l’episo<strong>di</strong>o che avrebbe dovuto essere uno dei più intensi della lettura del libro, dove Paolo<br />
comincia col <strong>di</strong>re: Ah le parole che i miei occhi incontrano, e che è privo <strong>di</strong> carattere. Migliore è la lettura <strong>di</strong><br />
<strong>Francesca</strong>: Certamente, ella <strong>di</strong>ce, io vi [sic] prometto.<br />
Un’altra caratteristica assai significativa delle musiche dello Zandonai è questa, che certi elementi stilistici<br />
sono portati volta per volta all’esasperazione. Così, nel primo atto, il brano <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>: Anima cara, piccola<br />
colomba è tutto fatto <strong>di</strong> note lunghe attraverso le quali il ritmo si sno<strong>da</strong> stentatamente affaticando cantante e<br />
spettatori. È in tono con la poesia questa curiosa stilizzazione fatta tutta <strong>di</strong> tensioni? Rileggetela e vedrete <strong>di</strong> no.<br />
Ma insomma, riassumendo affrettatamente il buono e il meno buono che ci è <strong>da</strong>to <strong>di</strong> riscontrare in<br />
quest’opera dello Zandonai, conclu<strong>di</strong>amo col <strong>di</strong>re che noi lo vorremmo libero <strong>da</strong> due servitù: la prima quella <strong>di</strong><br />
casa Ricor<strong>di</strong>, la secon<strong>da</strong> quella dell’Austria che ancora domina la città che l’ha visto nascere. Noi lo vogliamo<br />
più nostro come artista e come citta<strong>di</strong>no. Come citta<strong>di</strong>no innanzi tutto: perché così vuole l’ora pregna <strong>di</strong> futuro<br />
che l’Italia attraversa. Nostro non per trattato ma con la guerra: con la guerra che varrà a rigenerare presso <strong>di</strong> noi<br />
tante cose decadute e degenerate e, prima <strong>di</strong> ogni altro, la musica.<br />
***<br />
Degli interpreti <strong>di</strong>rò brevemente. La signorina Rosa Raisa è ottima attrice e buona cantante. È un’allieva<br />
della Marchisio, del conservatorio <strong>di</strong> Napoli. L’autore deve esserle grato dell’arte con la quale riuscì a vivere,<br />
anche nei momenti meno felici, il personaggio <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>.<br />
Il tenore Pertile (Paolo) e il Danise (Gianciotto) furono anch’essi efficaci. Quest’ultimo non ha certamente<br />
superato tutte le <strong>di</strong>fficoltà mimiche delle quali è piena la scena con Malatestino (quarto atto) ma è doveroso<br />
riconoscere che la scena sarebbe <strong>di</strong>fficile anche per un attore.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/23
A tutti gli altri una parola <strong>di</strong> lode: se la meritano tutti. Buono l’allestimento scenico. Quanto al maestro<br />
Vitale, chi si contenta gode. Noi non go<strong>di</strong>amo. Perché siamo gli eterni scontenti? Già, proprio così.<br />
63<br />
Goffredo Bellonci, Impeto <strong>di</strong> musiche nuove sovra una passione eterna – “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” del M.<br />
Zandonai, “Orfeo”, 14.3.1915 - p. 1, col. 1-2-3-4 / p. 2, col. 1-2-3<br />
L’opera d’arte<br />
Riccardo Zandonai l’han salutato innovatore della nostra musica e del nostro melodramma, liberatore<br />
dell’Italia <strong>da</strong>lla schiavitù tedesca: e sono scherzi della retorica alla mo<strong>da</strong>, in questi giorni <strong>di</strong> furiosa rivolta<br />
dell’ignoranza contro la cultura. Bastava <strong>di</strong>re che la <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> è una bella opera, una sicura<br />
testimonianza <strong>di</strong> un prossimo, qui <strong>da</strong> noi, rifioramento musicale. Ma codesta faccen<strong>da</strong> dell’antitesi a Riccardo<br />
Wagner e ai musicisti <strong>di</strong> Germania incomincia ad essere insopportabile: un secolo <strong>di</strong> germanesimo, del pensiero<br />
e dell’arte, non possiamo liberarcene se non a patto <strong>di</strong> assimilarlo, <strong>di</strong> farlo nostro, <strong>di</strong> riviverlo in noi, <strong>di</strong><br />
ucciderlo in noi, e d’an<strong>da</strong>r oltre. È un momento spirituale, il germanesimo, che come tutti i momenti dello<br />
spirito umano saltarlo non si può: se volessimo ignorare il pensiero tedesco e la musica tedesca, a pensare e<br />
comporre come se il Kant e l’Hegel, il Beethoven e il Wagner non fossero stati al mondo, penseremmo e<br />
comporremmo assai poveramente, su la falsariga dei classici. Le idee e le musiche <strong>di</strong> codesti uomini sono state<br />
per un secolo le idee e le musiche <strong>di</strong> tutto il mondo civile: in esse il nostro spirito ottocentesco s’è manifestato<br />
intero, e non c’è dunque rime<strong>di</strong>o: occorre, ad an<strong>da</strong>re innanzi, rifar questa via con nuova lena e con nuovi<br />
propositi, e non veder il cammino chiusoci innanzi a codeste forme, anzi largo ed aperto. Il problema è qui: non<br />
rimanerci chiusi dentro, che sieno per noi un’alta siepe la quale ci nascon<strong>da</strong> la vista e ci argini in un errore<br />
ignoto; ma saperne l’ingresso e l’uscita, vederle <strong>da</strong>ll’alto della propria libertà spirituale, e potere liberamente<br />
segnar a sé la mèta senza paura e senza pericolo <strong>di</strong> restarci presi, <strong>da</strong> quelle forme, <strong>di</strong> restarci smarriti, in<br />
quell’errore. Spe<strong>di</strong>tezza <strong>di</strong> movimenti che non l’acquisti se non riesci a sentire lo spirito <strong>di</strong> quei filosofi e <strong>di</strong> quei<br />
musicisti <strong>di</strong>staccato <strong>da</strong> te, chiaro innanzi la tua conoscenza, se dopo averlo vissuto, codesto spirito, non riesci,<br />
con un atto <strong>di</strong> volontà, a veder nella tua coscienza te, che sei uno, ed esso ch’è un altro. Così anche si conosce il<br />
mondo, e nel mondo, avendolo conosciuto, ci si muove, e con tanta più libertà quanto più frequente fu la nostra<br />
adesione e il nostro <strong>di</strong>stacco <strong>da</strong>lle cose: che non si avrebbe se non volessimo conoscerle, le cose, e ci stessimo<br />
contenti alla nostra acci<strong>di</strong>a o se, desideratele e possedutele, ci lasciassimo dominare <strong>da</strong>lla passione e<br />
smarrissimo la coscienza <strong>di</strong> noi stessi. Voglio <strong>di</strong>re che la musica tedesca non si può ignorarla e non si deve<br />
praticarla: poveri coloro che non lo seppero, e poveri coloro che vivono prigionieri del suo spirito.<br />
Lo Zandonai non è <strong>di</strong> questi: il suo Wagner, e anche il suo Strauss, li conosce bene. Si sente ch’egli è <strong>di</strong><br />
quelli spiriti maschi, i quali si levano più forti <strong>da</strong> ogni abbraccio, <strong>da</strong> ogni abbandono; e vuol veder chiaro in quel<br />
che fece ieri, e il cieco istinto illuminarlo, e la sensitività bruta assottigliarla. Nelle sue opere c’è volontà, c’è<br />
ascesi; ha voluto al caos delle forme che egli aveva innanzi, alle reminiscenze, ai fantasmi d’altrui che facevano<br />
impeto nella sua anima <strong>da</strong>r or<strong>di</strong>ne, organismo proprio. Ha affermato sé stesso, con un atto <strong>di</strong> coscienza, contro<br />
codeste forme e codeste scuole. Certo, a volte in questa sua coscienza c’è buio, e c’è smarrimenti nel suo spirito;<br />
ma nessuno può negare allo Zandonai una <strong>di</strong>rittura artistica, uno sforzo continuo <strong>di</strong> ascensione, una progressiva<br />
conquista <strong>di</strong> uno stile ond’è singolarissimo tra gli altri musicisti italiani. In questa <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> lo stile è<br />
quasi raggiunto: se <strong>di</strong>cessi che è già formato e che si sno<strong>da</strong> coerente in ogni episo<strong>di</strong>o dell’opera mentirei: molte<br />
volte, troppe volte sentiamo che c’è soluzione <strong>di</strong> continuo, che il musicista, toccato un vertice suo, ricasca giù<br />
stanco e smarrito nelle foreste sapute, che insomma spesso dopo aver conquistato con uno sforzo supremo sé<br />
stesso (e che altro significa aver stile se non essere coerentemente e inimitabilmente sé stesso?) s’illude e ci<br />
illude con una mirabile ma intellettuale e superficiale sapienza tecnica. Ma che progresso! In Conchita e in<br />
Melenis i più <strong>di</strong>versi mo<strong>di</strong> d’arte, <strong>da</strong> quelli del Wagner a quelli del Mascagni, <strong>da</strong> quelli dello Strauss a quelli del<br />
Debussy, erano – <strong>di</strong>rei – sofferti <strong>da</strong>llo Zandonai: gli sgusciavan <strong>di</strong> mano e gli crescevano innanzi come il tema<br />
magico allo stregone novizio del Dukas; ed egli s’affannava invano a volerli ridurre sotto la propria potestà.<br />
Dunque, non c’era verso che egli in<strong>di</strong>viduasse un personaggio e sapesse <strong>da</strong>re al <strong>di</strong>scorso musicale una coerenza<br />
stilistica, poi che le <strong>di</strong>verse forme s’in<strong>di</strong>viduavano <strong>da</strong> sé e soverchiavano il suo spirito. Ma la sua esperienza era<br />
così vasta, e così pronta la sua forza d’assimilazione, e così impetuoso e parvente lo sforzo <strong>di</strong> non lasciarsi<br />
soverchiare, che si comprendeva ch’egli sarebbe giunto a <strong>da</strong>r or<strong>di</strong>ne alla sua orchestra e organismo alle sue<br />
melo<strong>di</strong>e. La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> non è già più una promessa.<br />
Trage<strong>di</strong>a, ch’è senza dubbio la meglio equilibrata del d’Annunzio, fu essa composta in quelli anni felici<br />
dell’arte d’annunziana che han nome <strong>da</strong>lle Lau<strong>di</strong>. Ed è ricca <strong>di</strong> abbandoni lirici ma povera <strong>di</strong> drammaticità: le<br />
persone non raccolgono nelle parole il loro spirito profondo, anzi si <strong>di</strong>stendono e si smarriscono nelle frasi e<br />
nelle strofe. C’è abbon<strong>da</strong>nza <strong>di</strong> architettura e <strong>di</strong> decorazioni: quadri, quadri, quadri, e poca sostanza d’anima:<br />
ricchezza <strong>di</strong> colori e <strong>di</strong> suoni, e miseria <strong>di</strong> parole; l’organismo <strong>di</strong> questa trage<strong>di</strong>a non si manifesta nei contrasti<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/24
delle persone, ma nelle strofe dei canti, nella <strong>di</strong>stribuzione dei colori, nella conchiusa levigatezza delle<br />
architetture. Non si ricor<strong>da</strong> una sola parola <strong>di</strong> quelle eterne, che, espressesi <strong>da</strong> un urto drammatico, rivelano una<br />
verità dello spirito, e nemmeno un personaggio nella sua viva umanità: non Paolo, non <strong>Francesca</strong>, non<br />
Malatestino: le scene, sì, quelle si ricor<strong>da</strong>no, le ancelle con il giullare, la battaglia, la canzone della primavera...<br />
E son belle <strong>da</strong>vvero, <strong>di</strong> una loro chiusa bellezza strofica, che dobbiamo ammirare anche noi, se bene desiderosi<br />
<strong>di</strong> altra più intima arte <strong>da</strong> questa. Ma il musicista, trovandosi innanzi un libretto così fatto, non avrebbe forse<br />
dovuto sminuirne i <strong>di</strong>fetti? metter la drammaticità dove mancava, e attenuar la lirica dove era troppa? Riccardo<br />
Zandonai ha invece seguito punto per punto Gabriele d’Annunzio, ed ha abbellita l’opera del poeta nei luoghi<br />
belli, senza rafforzarla nei luoghi deboli. Gli è che lo Zandonai ha un concepimento strofico dell’arte: la sua<br />
musica non può an<strong>da</strong>re innanzi per lungo tempo <strong>da</strong> sola, sorretta <strong>da</strong> una forza intima ond’essa sgorghi <strong>di</strong>versa e<br />
coerente, anzi c’è bisogno che ritorni armonici e ritmici le <strong>di</strong>eno <strong>da</strong> fuori una organicità che <strong>da</strong> dentro non<br />
potrebbe sempre avere. Difetto, codesto, che si muta in pregio quando lo Zandonai riesce a manifestare tutto sé<br />
stesso come nella secon<strong>da</strong> metà del primo atto e nella prima metà del terzo: allora sentiamo che egli può, che<br />
egli sa portare nel melodramma un senso nuovo della “scena” musicale, ben <strong>di</strong>verso <strong>da</strong> quello dei nostri operisti<br />
dell’ottocento, e tuttavia schiettamente italiano. Qui non abbiamo più le <strong>di</strong>stese melo<strong>di</strong>e romantiche che <strong>da</strong>van<br />
or<strong>di</strong>ne intorno alle “arie” a tutta l’opera musicale: c’è brevi melo<strong>di</strong>e, grande abbon<strong>da</strong>nza <strong>di</strong> modulazioni che le<br />
spezzano con molta delizia nostra, e mirabile ricchezza <strong>di</strong> ritmi. Tutte codeste cose, composte insieme <strong>da</strong> un<br />
uomo che possiede la tecnica modernissima come pochi e che ci si muove per entro senza impaccio, essendosi<br />
anche fatta una orchestra sua propria per virtù <strong>di</strong> accostamenti strumentali originalissimi, dànno all’opera un<br />
sapor nuovo e nello stesso tempo antico: s’ha l’impressione <strong>di</strong> un innesto della musica post-wagneriana sul<br />
tronco della nostra musica romantica.<br />
Il male è che un tale innesto, ad esser fecondo, ha bisogno <strong>di</strong> quella continuità che vi ho mostrata in<br />
principio; se no, se dunque si ricasca nei ricami tecnici o peggio ancora nei frusti schemi melo<strong>di</strong>ci dell’opera<br />
italiana, la struttura strofica mette in luce la povertà inventiva piuttosto che <strong>da</strong>re ad essa valore. Il secondo atto<br />
non persuade proprio per questo: il d’Annunzio l’aveva <strong>di</strong>segnato con arte superficialissima; e quei suoi uomini<br />
d’armi strillavano senza riuscir mai a comunicare un brivido della battaglia, comparse e non attori. Lo Zandonai<br />
ha rivestito i versi con una ricchezza armonica e ritmica <strong>da</strong> meravigliare, ottenendo effetti <strong>di</strong> sonorità molto<br />
belli; ma non ha saputo trovare un motivo, una frase che desse una vera sostanza musicale alla battaglia. Per<br />
giunta, ha costrutto l’atto con due riprese del pandemonio bellico, le quali lo serrano, sì, e lo conchiudono, e<br />
tuttavia non riescono che a far sentire <strong>di</strong> più il suo vuoto. E ba<strong>da</strong>te che la ripresa non può conferir in nulla<br />
all’effetto perché quella descrizione materialistica, estrinseca della battaglia, <strong>di</strong>spiegò la forza e la violenza dei<br />
suoi colori sin <strong>da</strong>l principio e appar anzi menomata <strong>da</strong>l ritorno strofico.<br />
Lirico piuttosto che drammatico, lo Zandonai ha una natura <strong>di</strong> sensuale e preferisce al <strong>di</strong>scorso intimo<br />
l’abbandono sensibile, che è sempre breve. La sua arte, <strong>di</strong> necessità, è dunque frammentaria, come l’arte del<br />
d’Annunzio, e deve cercar l’organismo in quella struttura strofica che ho detto: coerenza vera e propria,<br />
melo<strong>di</strong>ca o sinfonica non può averla, e con questo non voglio notare un <strong>di</strong>fetto ma <strong>da</strong>rmi ragione dei limiti <strong>di</strong><br />
codesto musicista nostro. La via che egli s’è <strong>da</strong>to a percorrere fu aperta gloriosamente <strong>da</strong>l Ver<strong>di</strong> con il Falstaff,<br />
dove le “arie”, le larghe frasi melo<strong>di</strong>che del melodramma mancavano affatto, ed era invece una meravigliosa<br />
collaborazione del canto e dell’orchestra: l’orchestra manifestava con ricchezza <strong>di</strong> ritmi e <strong>di</strong> temi inconsueta<br />
all’opera italiana, e con potente continuità, la pienezza spirituale dei personaggi, e la declamazione accentuava<br />
la parola con pro<strong>di</strong>giosa fusione del ritmo verbale col suo ritmo musicale. Lo Zandonai vuole anch’egli<br />
“parlare” le sue melo<strong>di</strong>e e intensificarle con un complesso lavoro armonico e melo<strong>di</strong>co; ma non sempre riesce: a<br />
volte nello sforzo esaspera le voci o l’orchestra senza ottenere nessun effetto profondo. Quando la sua vena<br />
s’apre più felicemente, allora sì egli ci dà pagine nuove e <strong>da</strong>vvero sue, le quali bastano a far della <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong><br />
<strong>Rimini</strong> la più singolare, forse, <strong>di</strong> tutte le opere della nostra giovane scuola: intendo, sovra tutto, della secon<strong>da</strong><br />
parte del primo atto e del terzo atto intero. Qui anche le influenze wagneriane, straussiane e debussiane non<br />
s’avvertono più, che pur si notano negli altri atti: anche se egli si giova <strong>di</strong> mo<strong>di</strong> che son propri a Wagner<br />
(progressioni annunciano Paolo come annunciarono Tristano) senti che si son fatti sostanza sua, si son fusi<br />
organicamente nello spirito dell’artista. Dal coretto delle donne “Oimè che adesso io provo...” sino alla fine del<br />
primo atto l’incanto non si rompe mai: le bellezze si succedono continue, in un’on<strong>da</strong> lirica larga e meravigliosa.<br />
Il canto lamentevole <strong>di</strong> Samaritana e il trepido declamato <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> rendono con evidenza, e comunicano a<br />
chi ode, il sentimento delle due creature che s’annuncia. Il <strong>di</strong>scorso volubile delle donne che gri<strong>da</strong>no l’arrivo <strong>di</strong><br />
Paolo e quella prorotta invocazione <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> alla sorella “Ah, tu ora, tu ora pigliami” mettono in tutta la<br />
scena un’ansia <strong>di</strong> attesa sovra la quale il bel tema d’amore proposto <strong>da</strong>lla “viola pomposa” si eleva con una<br />
improvvisa tenerezza, con un profondo calore che persuadono e trascinano. Ma guar<strong>da</strong>te: lo Zandonai ha<br />
raggiunto l’espressione compiuta in un momento lirico e per virtù <strong>di</strong> mezzi lirici, non drammatici. Lo<br />
svolgimento dell’atto è corale e sinfonico: la parola musicale, dove si <strong>di</strong>stende tutto lo spirito, tace. Il terzo atto<br />
è lo stesso: se ben considerate esso è racchiuso <strong>da</strong>lla canzone della Primavera che lo fiorisce nel mezzo e<br />
l’inghirlan<strong>da</strong> alla fine, quando ritorna lontana; e si svolge per gra<strong>di</strong>, crescendo, dopo pause ed arresti durante la<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/25
scena tra Paolo e <strong>Francesca</strong>, sino al prorompere <strong>di</strong> tutta l’orchestra nel bacio. Ed ogni episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
quell’appassionato <strong>di</strong>alogo d’amore non tanto vale per sé (e vi hanno certo bellezze inconsuete e nuove, specie<br />
nel canto <strong>di</strong> Paolo) quanto per l’insieme: elementi, sono, <strong>di</strong> una pagina lirica piuttosto che drammatica, che si<br />
giova anche qui <strong>di</strong> mezzi sinfonici e corali. Il punto più debole dell’atto è proprio quello che avrebbe dovuto<br />
essere, in una concezione drammatica, più forte, quello dove la parola avrebbe dovuto giungere alla sua<br />
massima virtù musicale: intendo la lettura del libro galeotto.<br />
La scena che mostra invece una notevole potenza drammatica è quella del quarto atto, tra Gianciotto e<br />
Malatestino: c’è violenza, c’è brutalità, ma ba<strong>da</strong>te che questa brutalità e questa violenza sono raggiunti meglio<br />
per forza <strong>di</strong> ritmi e colori orchestrali che per intima musicalità del <strong>di</strong>alogo tra i due fratelli. Lo Zandonai ha<br />
sentito, egli, il cupo orrore della scena infame e ce l’ha <strong>di</strong>pinto, ce l’ha reso sensibile con la sua tavolozza ricca e<br />
mirabile, ce l’ha insomma descritto.<br />
In questa analisi rapi<strong>da</strong> ho voluto piuttosto stu<strong>di</strong>are la natura del musicista che non la sua opera. La<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> non bisogna giu<strong>di</strong>carla secondo un ideale dramma musicale, che molti augurano e che il<br />
Pizzetti persegue: è un’opera concepita e resa liricamente, a larghi respiri, a lunghe onde strofiche; un’opera<br />
dove l’antitesi tra il melodramma italiano e il dramma wagneriano si parifica in una sintesi, che certo ha una<br />
vera e propria originalità, un suo proprio organismo. Ed è bella: c’è innumerevoli piccoli episo<strong>di</strong> orchestrali che<br />
fermano il nostro gusto e lo incantano un momento, anche in quel secondo atto che è il meno felice. E se le<br />
persone non si manifestano nella loro in<strong>di</strong>vidualità per una profon<strong>da</strong> virtù drammatica, sono ad ogni modo,<br />
ciascuna, descritte con molta evidenza: ciascuna ha suscitato nel musicista un <strong>di</strong>verso brivido musicale che egli<br />
risente e fa sentire a noi con i colori della sua orchestra e con i mo<strong>di</strong> della sua melo<strong>di</strong>a. Malatestino, Smarag<strong>di</strong>,<br />
Samaritana si in<strong>di</strong>viduano mirabilmente nel nostro spirito.<br />
Gli interpreti <strong>di</strong>edero del resto alle parti un forte risalto drammatico: la signorina Rosa Raisa non solo canta<br />
con morbidezza <strong>di</strong> voce e con forza straor<strong>di</strong>naria, ma anche recita <strong>da</strong> gran<strong>di</strong>ssima attrice: rare volte mi è occorso<br />
<strong>di</strong> vedere espressi con tanta intelligenza i più sottili trapassi drammatici. E bene cantarono e recitarono accanto a<br />
lei la signorina Olga Matteini (Samaritana) che ha una voce assai dolce e singolar gusto <strong>di</strong> atteggiamenti, e la<br />
signorina Flora Perini (Smarag<strong>di</strong>). Il tenore Pertile (Paolo), il basso Berar<strong>di</strong> (Ostasio), il Danise (Gianciotto), il<br />
Nar<strong>di</strong> (Malatestino) e il Gironi (giullare) furono applau<strong>di</strong>ti <strong>da</strong>l pubblico, e lo meritarono.<br />
E tutti seppe muovere, a tutto seppe <strong>da</strong>r vita piena – alle musiche e agli artisti – il maestro Vitale.<br />
Credo dunque che la <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> debba essere annoverata tra le nostre belle opere contemporanee,<br />
e che vi si riveli finalmente libero e compiuto Riccardo Zandonai. Dire che egli ha rinnovato la musica e aperte<br />
vie nuove al genio italiano non si può, senza ingiuria al più cotennoso buon senso; ma sarebbe <strong>da</strong> stoli<strong>di</strong> negare<br />
che codesto artista italiano si è conquistata una originalità, e la manifesta con sicurezza <strong>di</strong> mezzi. Egli è oramai<br />
su la via che conduce all’opera perfetta.<br />
La cronaca dello spettacolo – Il grande successo – Vitale – I cantanti<br />
Al geniale saggio critico <strong>di</strong> Goffredo Bellonci – che per l’occasione eccezionale <strong>di</strong> questo grande<br />
avvenimento d’arte ha accolto l’invito <strong>di</strong> scrivere per l’Orfeo una pagina d’impressioni e <strong>di</strong> osservazioni<br />
estetiche sulla <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>, nella quale non si sa se più ammirare la forma smagliante o l’acutezza e<br />
l’originalità della <strong>di</strong>samina <strong>di</strong> tutto lo spartito, riuscita severa e serena ad un tempo – facciamo seguire qualche<br />
breve nota <strong>di</strong> cronaca.<br />
La sala del Costanzi era sfolgorante, ricolma <strong>di</strong> pubblico magnifico e imponente: non un posto vuoto. Nelle<br />
alte gallerie una vera moltitu<strong>di</strong>ne; nel parterre e nei palchi tutto l’olimpo dell’aristocrazia, della politica, della<br />
letteratura. In un palco <strong>di</strong> secon<strong>da</strong> fila si notava il Presidente del Consiglio con la famiglia.<br />
Ogni atto si chiuse fra applausi, acclamazioni entusiastiche. Fin <strong>da</strong>l primo atto, col finale così suggestivo, si<br />
delineò il successo schietto e imponente, senza che una voce <strong>di</strong>scorde fosse sorta ad attenuare l’unanime<br />
consenso.<br />
[“]Bisogna risalire – scrive T. O. Cesar<strong>di</strong> – nei fasti del Costanzi a venticinque anni ad<strong>di</strong>etro, alla prima<br />
rappresentazione <strong>di</strong> Cavalleria rusticana, per trovare un termine <strong>di</strong> confronto al successo unanime, sincero,<br />
profondo <strong>di</strong> quest’opera <strong>di</strong> Riccardo Zandonai.<br />
Sì, unanime, perché tutto il pubblico è stato avvinto, preso, dominato <strong>da</strong>ll’alta poesia del dramma musicale, e<br />
trasportato come in un’atmosfera <strong>di</strong> sogno e d’ideale: sincero perché l’applauso prorompente veniva <strong>da</strong> ogni<br />
or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> palchi, <strong>da</strong> ogni or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni, <strong>da</strong> tutto insieme un pubblico commosso e maravigliato, e profondo<br />
altresì perché l’impressione che ognuno ha risentito <strong>da</strong> questa nobile manifestazione d’arte è <strong>di</strong> quelle che non si<br />
cancellano perché segnano un solco nell’anima[”].<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> del maestro Zandonai segna dunque una <strong>da</strong>ta memorabile nella storia del teatro<br />
d’opera italiano, tanto il nuovo melodramma ha una forma espressiva <strong>di</strong> carattere singolare e originale e una<br />
profon<strong>da</strong> e imme<strong>di</strong>ata significazione umana.<br />
Ogni pagina, ogni episo<strong>di</strong>o, <strong>di</strong>remmo quasi ogni nota, ebbe il suo risalto e suscitò quella somma <strong>di</strong> emozioni<br />
che sogliono rimanere incancellabili nella memoria e nella fantasia degli spettatori. Sicché alla fine dello<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/26
spettacolo, chiusosi con una ovazione magnifica, in una cal<strong>da</strong> esplosione d’entusiasmo, in una <strong>di</strong> quelle<br />
manifestazioni <strong>di</strong> solenne apoteosi, rimase in quanti vi parteciparono l’impressione <strong>di</strong> aver consacrato alla<br />
popolarità, e definitivamente, un altro giovane musicista italiano, del quale le prime prove come il Grillo del<br />
focolare, Conchita e Melenis facevano presagire la o<strong>di</strong>erna e grande vittoria.<br />
E dopo l’illustre compositore sia reso omaggio all’animatore dello spettacolo, a Edoardo Vitale, a cui<br />
dovette riuscir caro, insieme alle feste tributategli <strong>da</strong>l pubblico in una forma così solenne quale <strong>da</strong> tempo<br />
immemorabile non si aveva esempio, il giu<strong>di</strong>zio del comm. Tito Ricor<strong>di</strong>, il quale – dopo la prova generale –<br />
ebbe a significargli tutto il suo pieno consentimento per la mirabile e impeccabile concertazione. Fu quella <strong>di</strong><br />
Edoardo Vitale una nobile fatica, cui soccorse, oltre il vivido ingegno, una sensibilità squisita, un gusto<br />
aristocratico e una fraterna soli<strong>da</strong>rietà per il giovane musicista. L’orchestra parve trovare tutte le sue voci, tutti i<br />
suoi slanci, tutte le sue più dolci sfumature, in un’armonia e in una precisione ritmica, come <strong>da</strong>lle canne <strong>di</strong> un<br />
organo perfetto. Il maestro Vitale comprese e intese così profon<strong>da</strong>mente il poema d’annunziano e la musica<br />
dello Zandonai, che le mille imagini, le multiformi figurazioni, i <strong>di</strong>sparati stati d’animo ebbero una vivi<strong>da</strong><br />
rappresentazione, con magnificenza <strong>di</strong> contrasti e varietà <strong>di</strong> colori. Avendo <strong>di</strong>nanzi a sé una partitura complessa<br />
e meravigliosa per polifonia e per spunti melo<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> carattere schiettamente italiano, l’eminente <strong>di</strong>rettore volle<br />
esserne l’interprete severo e geniale, l’animatore sicuro e profondo. E il pubblico lo volle nelle venticinque<br />
chiamate al proscenio, a fine d’ogni atto, accanto a Riccardo Zandonai, come per significare la stretta<br />
in<strong>di</strong>ssolubile intimità tra il creatore e chi <strong>di</strong>ede forma e anima espressiva alla <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>. Ogni<br />
applauso a Edoardo Vitale era un saluto e un omaggio incon<strong>di</strong>zionato, un tributo d’onore e <strong>di</strong> stima, una prova<br />
<strong>di</strong> non comune simpatia.<br />
Rosa Raisa fu una protagonista come non cre<strong>di</strong>amo possa trovare emulazioni: una <strong>Francesca</strong> compiuta in<br />
atteggiamenti poetici e patetici e <strong>da</strong>lla voce morbi<strong>da</strong>, suggestiva, ampia, sicura, educata a quella scuola della<br />
Marchisio <strong>da</strong> cui uscirono tante insigni cantatrici. Pel suo temperamento versatile, privilegiato, squisito, ella<br />
cantò con nobiltà e con quel sentimento ch’è tanta parte dello stile <strong>di</strong> una musica.<br />
Il tenore Pertile, un Paolo <strong>di</strong> “stile” quale D’Annunzio lo scolpì nel poema, fraseggiò con arte deliziosa, con<br />
purezza d’accento, con impeccabile intonazione; e cantò con voce limpi<strong>da</strong> e squillante, così che i suoi acuti<br />
ebbero un risalto magnifico. Egli è, oltre che cantante magnifico, sicuro, vigoroso, interprete sovrano, signore<br />
nelle figurazioni sceniche, campione del bel canto.<br />
Il baritono Danise, un artista che in questa stagione al Costanzi ha <strong>da</strong>to la prova <strong>di</strong> quanto valga un vigoroso<br />
temperamento accoppiato a una bella voce, a traverso opere <strong>di</strong> carattere l’una <strong>di</strong>versa <strong>da</strong>ll’altra, fu un Gianciotto<br />
caratteristico. Nel quarto atto, nella scena con Malatestino, ebbe momenti truci e spiccatamente drammatici, a<br />
cui il canto, irto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà e profuso <strong>di</strong> note acutissime, accrebbe significazione.<br />
Tutti gli altri cantarono con slancio e sicurezza: Flora Perini, che cantò con la sua armoniosa cal<strong>da</strong> voce <strong>di</strong><br />
mezzo soprano, la Matteini, una Samaritana piena <strong>di</strong> dolore, <strong>di</strong> gentilezza, il Berar<strong>di</strong>, che cantò con la sua bella<br />
voce <strong>di</strong> basso, il Gironi, la Verger, il Nar<strong>di</strong>no [sic] caratteristico Malatestino, la Galeffi, la Seracchioli, la<br />
Manarini, il Lanzi, il Sabatano e il Pastorelli.<br />
La mesa in scena fu curata in tutti i suoi dettagli: una vera opera d’arte: vi presiedette con quell’autorità che<br />
ormai gli è universalmente riconosciuta il cavaliere Carlo Clausetti, venuto espressamente <strong>da</strong> Milano.<br />
La Casa Ricor<strong>di</strong>, oltre che <strong>da</strong>l Clausetti, era rappresentata <strong>da</strong>l comm. Tito Ricor<strong>di</strong>.<br />
E infine una parola <strong>di</strong> lode incon<strong>di</strong>zionata all’illustre signora Emma Carelli, che è riuscita a porre in scena la<br />
<strong>Francesca</strong> con vera munificenza.<br />
64<br />
“<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” <strong>di</strong> Zandonai al Costanzi, “Musica” IX/6, 15.3.1915 - p. 1, col. 4 / p. 2, col. 1-2 (con un<br />
ovale raffigurante Rosa Raisa)<br />
La nuova opera <strong>di</strong> Riccardo Zandonai, preceduta <strong>da</strong> due altri successi a Torino e a Pesaro, ha <strong>da</strong>to occasione<br />
al nostro pubblico <strong>di</strong> mostrare le sue simpatie e il suo gusto, sicuramente ed altamente, verso un tipo <strong>di</strong><br />
melodramma che non è lo straussiano, non è il debussiano, ma è l’italiano, il tra<strong>di</strong>zionale italiano che va <strong>da</strong><br />
Montever<strong>di</strong> a Ver<strong>di</strong>. La <strong>Francesca</strong> <strong>di</strong> d’Annunzio e <strong>di</strong> Zandonai è una schietta manifestazione d’italianità, con i<br />
suoi mezzi e meriti gloriosi, con i suoi pregi e <strong>di</strong>fetti irreducibili: una manifestazione che proviene <strong>da</strong>l vecchio<br />
ceppo, ma che nel nascere, crescere e maturare è an<strong>da</strong>ta raccogliendo quegli elementi <strong>di</strong> necessario progresso<br />
che la rendono vigorosa, efflorescente, vitalissima. Tali manifestazioni il maestro trentino ha sempre <strong>da</strong>to <strong>da</strong>l<br />
Grillo del focolare e prima ancora con i suoi nostalgici poemetti lirici; ma esse non erano compiute ed integrate<br />
<strong>da</strong> un dramma umano e <strong>da</strong> una poesia smagliante come questa <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio. Il quale, più che con gli<br />
altri poemi tragici <strong>da</strong> teatro, con la <strong>Francesca</strong> ha fatto opera musicale e musicabile. Senonché il penetrare e<br />
riprodurre ed esaltare la musicalità più che <strong>di</strong> verso <strong>di</strong> sentimento <strong>da</strong>nnunziano non era compito lieve, e averlo<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/27
assolto, anzi superato – come non è accaduto alla frigi<strong>di</strong>tà del Franchetti e al <strong>di</strong>sequilibrio (sebben talora<br />
geniale) del Mascagni – è titolo encomiabile <strong>di</strong> Riccardo Zandonai.<br />
Non esamineremo l’opera musicale segnalando le bellezze del canto, le intenzioni e la dovizia della<br />
strumentazione, e anche la caducità e qualche concessione al cattivo gusto: è già stato fatto largamente <strong>da</strong>lla<br />
loquacità dei quoti<strong>di</strong>ani. Diremo solo e a mo’ <strong>di</strong> conclusione che oggi, così stanti i valori musicali, Zandonai<br />
raccoglie tutte le ere<strong>di</strong>tà della nostra grande opera ed agita solo, nel suo pugno, la fiaccola che riprende e<br />
continua il cammino vittorioso della genialità latina.<br />
***<br />
La esecuzione è stata nel complesso efficace, in grazia del consueto amore ed acume col quale concerta e<br />
<strong>di</strong>rige Edoardo Vitale: la protagonista Rosa Raisa ha pro<strong>di</strong>gato, affermandosi artista <strong>di</strong> primissimo or<strong>di</strong>ne, tutta<br />
la sua dolce voce e la sua azione scenica, e gli altri han tutti sentito la varia importanza della parte.<br />
65<br />
f[ranco] rain[eri], “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” <strong>di</strong> Zandonai al Costanzi, “Il Giornale d’Italia”, 29.3.1916 - p. 3, col.<br />
5<br />
Quante volte è accaduto ad un’opera nuova <strong>di</strong> tornare appena a un anno <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza su le stesse scene,<br />
desideratissima, e – meglio ancora – <strong>di</strong> ritrovarvi più calde, più unanimi, più commosse le già magnifiche<br />
accoglienze che la salutarono un anno prima al suo apparire? Questa è stata – né più né meno – la sorte della<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>, la quale ieri sera, in virtù della sua meravigliosa avvincente bellezza e <strong>di</strong> una esecuzione<br />
quanto mai efficace, ha conseguito nuovamente, e per decreto concorde della folla adunata in teatro, un<br />
autentico grande successo.<br />
Qui, registrando con sincero compiacimento le fortune sempre più vaste ed ormai incontestate della<br />
splen<strong>di</strong><strong>da</strong> opera <strong>di</strong> Zandonai, saremmo tentati <strong>di</strong> ricor<strong>da</strong>re che le nostre previsioni d’un anno fa erano giuste:<br />
<strong>Francesca</strong>, scrivemmo, è piaciuta, ma più e meglio piacerà quando il pubblico, scendendo <strong>da</strong>l seggio riservato<br />
ai giu<strong>di</strong>ci togati, si lascierà persuadere <strong>da</strong>lla sottile e penetrante malìa <strong>di</strong> quella musica passionale e geniale,<br />
<strong>da</strong>lla potenza <strong>di</strong> quella trage<strong>di</strong>a <strong>da</strong>nnunziana che nulla invi<strong>di</strong>a ai greci, <strong>da</strong>l fascino <strong>di</strong> poesia e d’umanità, infine,<br />
che la trage<strong>di</strong>a musicale così com’è stata espressa <strong>da</strong>l Zandonai emana e che la circon<strong>da</strong> della luce propria ai<br />
capolavori. Era questa, per chi avesse già goduta l’avventurata sorte d’intuire le bellezze della meravigliosa<br />
creatura, una facile profezia. E il voto, formato l’anno scorso <strong>da</strong> una gran parte degli spettatori, <strong>di</strong> riavere presto<br />
<strong>Francesca</strong> era già un segno <strong>di</strong> ciò che iersera s’è avverato: il pubblico, sceso <strong>di</strong> cattedra, è <strong>di</strong>venuto, qual è,<br />
un’accolita <strong>di</strong> persone mortali dotate d’un’anima semplice e d’un cervello ben coltivato, accessibili ai più elevati<br />
sentimenti che l’arte possa suscitare, pronte ed anzi desiderose, innanzi all’opera celebrata [e] seppur<br />
deferentemente <strong>di</strong>scussa <strong>da</strong> critici e <strong>da</strong> musicisti, <strong>di</strong> riacquistar fede nell’asserita rinascita del melodramma<br />
nostro, italiano e genuino, vissuto <strong>da</strong>lla voce umana e sorretto e colorito <strong>da</strong>lla sinfonia orchestrale. Ridotto alla<br />
sua più nobile e più propria funzione, il pubblico iersera ha tratto – come l’unanime entusiastico consenso degli<br />
applausi e dei commenti <strong>di</strong>mostrava chiaro – go<strong>di</strong>menti artistici rari intensi profon<strong>di</strong> <strong>da</strong>ll’opera migliore del<br />
genialissimo musicista trentino: e l’opera, <strong>da</strong>lla serata trionfale <strong>di</strong> ieri, si è elevata, nella impressione comune,<br />
alle maggiori altezze che oggi siano concesse in teatro. Appunto ieri l’altro, a proposito <strong>di</strong> Primavera in Val <strong>di</strong><br />
Sole, la suite sinfonica del Zandonai rieseguita domenica scorsa all’Augusteo, preferivamo esprimere la nostra<br />
fiducia nel “uomo teatrale” per eccellenza: <strong>Francesca</strong> è sopraggiunta subito a confermare quanto quella fiducia<br />
sia ben fon<strong>da</strong>ta. E l’ar<strong>di</strong>tezza <strong>di</strong> quest’uomo teatrale, che innestando nel vecchio ma vivo tronco del<br />
melodramma italico il sangue giovane ed ardente dell’arte sua nobilissima ed austera ma tutta moderna e<br />
palpitante, ha aperto alle nostre speranze una vita nuova, ha assunto nelle valide sue mani la riaccesa fiaccola<br />
della tra<strong>di</strong>zione evoluta e trasformata, e proseguendo con cosciente bal<strong>da</strong>nza nel cammino sul quale già illustri<br />
maestri nostri han tanto progre<strong>di</strong>to in questi ultimi tempi, sta compiendo felicemente la non facile impresa<br />
d’elevare e nobilitare e rinvigorire il gusto del pubblico, del “popolo teatrale”, insomma, <strong>di</strong> ver<strong>di</strong>ana e gloriosa<br />
memorioa.<br />
Dell’esecuzione <strong>di</strong> iersera abbiam già detto che fu mirabile: <strong>di</strong> essa il merito precipuo, oltre che all’illustre<br />
maestro Vitale il quale a <strong>Francesca</strong> ha votato con vera anima d’artista un vivo amore e riesce a trasfonderlo in<br />
tutti gli elementi dello spettacolo, oltre che – insomma – al <strong>di</strong>rettore incomparabile, venne riconosciuto a Rosa<br />
Raisa, protagonista superba e magnifica per la bellezza della voce e il vigore dell’espressione scenica. Ella fu,<br />
iersera, una vera trionfatrice e il pubblico volle tributarle le più affettuose manifestazioni <strong>di</strong> incon<strong>di</strong>zionata<br />
ammirazione.<br />
Eccellenti compagni le furono, per ogni riguardo, il tenore Pertile e il baritono <strong>Rimini</strong>, quest’ultimo nuovo<br />
per Roma nella parte <strong>di</strong> Gianciotto; efficacissimo parve il Nar<strong>di</strong> nella parte del perfido Malatestino. Lodevoli le<br />
parti minori e cioè la Morano, la Lauri, la Martino, la Caravaglia [sic]; il Paci. Splen<strong>di</strong>do l’allestimento.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/28
Si tentò iersera una novità: al terzo atto, nella “canzone a ballo” ch’esalta l’avvento della primavera,<br />
dovrebbero le ancelle <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong>nzare mentre cantano; e invece esse iersera si limitarono a cantare, mentre<br />
Erminia Gerla, la leggiadra aggraziatissima <strong>da</strong>nzatrice, e quattro sue compagne componevano vaghi quadri<br />
d’una delicatezza e d’un gusto squisiti che ricor<strong>da</strong>vano, senza copiarli, i capolavori pittorici del nostro<br />
Quattrocento. La novità merita ogni più ampia lode perché oltre tutto le cantatrici, libere <strong>da</strong>lla preoccupazione<br />
della <strong>da</strong>nza, cantarono meglio e le <strong>da</strong>nzatrici <strong>da</strong>nzarono ch’era un piacere a vederle.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>, riconsacrata quest’anno <strong>da</strong>l più completo e più meritato dei successi, avrà numerose<br />
repliche.<br />
66<br />
A[lberto] G[asco], “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” al Teatro Costanzi, “La Tribuna”, 30.3.1916 - p. 3, col. 1<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>, apparsa fulgi<strong>da</strong>mente al “Costanzi” un anno fa, aveva lasciato <strong>di</strong> sé vivo desiderio.<br />
I molti schietti ammiratori della magnifica trage<strong>di</strong>a <strong>da</strong>nnunziana vestita <strong>da</strong> Riccardo Zandonai <strong>di</strong> musica spesso<br />
melo<strong>di</strong>osa e sempre ben colorita, vagheggiavano il ritorno dell’opera pre<strong>di</strong>letta. Il loro voto è stato felicemente<br />
sod<strong>di</strong>sfatto. <strong>Francesca</strong> si è ripresentata col marito sciancato e con l’amante bellissimo su quel palcoscenico<br />
romano che già era stato per lei un vittorioso agone. E il nuovo saluto rivolto alla gentile <strong>da</strong>ma <strong>da</strong>i suoi fedeli ha<br />
avuto un carattere <strong>di</strong> affettuosità assai particolare. Ogni atto del dramma lirico si è chiuso fra applausi più o<br />
meno calorosi, ma sempre ispirati a simpatia profon<strong>da</strong>.<br />
I consensi sono stati unanimi riguardo al delicato episo<strong>di</strong>o finale del primo atto – la gemma della partitura –<br />
e al terzo episo<strong>di</strong>o che termina con la fatale lettura del libro erotico. Il secondo quadro invece ha lasciato un po’<br />
freddo l’u<strong>di</strong>torio ed anche la prima parte dell’ultimo atto non ha sedotto il pubblico. Ma alla fine dell’opera<br />
l’ovazione rivolta agli interpreti ed al valoroso Vitale ha sanzionato il successo dell’importante e piacente<br />
lavoro.<br />
Non possiamo che accogliere il giu<strong>di</strong>zio dettagliato espresso <strong>da</strong>l pubblico: è un giu<strong>di</strong>zio saggio e ponderato.<br />
Le parti migliori dell’opera sono effettivamente quelle in cui predomina una nota <strong>di</strong> mite elegia. Per quanto egli<br />
ami grossir sa voix e scatenare bufere orchestrali clamorose, Riccardo Zandonai ci sembra sincero soltanto<br />
quando canta con semplice e flui<strong>da</strong> melo<strong>di</strong>a le soavi pene d’amore <strong>di</strong> una creatura eletta e il fascino sottile <strong>di</strong><br />
una snervante primavera. Egli appartiene alla famiglia dei Catalani e dei Puccini: anzi, precisamente come<br />
Puccini talora usa violenza al proprio stile, indugiando nella descrizione <strong>di</strong> scene torve che nell’anima sua <strong>di</strong><br />
sentimentale poeta non possono <strong>da</strong>re eccitazione fecon<strong>da</strong>. Malgrado la scena della tortura <strong>di</strong> Tosca e le risse<br />
violente della Fanciulla del West, il vero Puccini si trova soltanto nel tenero ad<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Mimì e <strong>di</strong> Rodolfo;<br />
malgrado gli urli degli armigeri malatestiani che rendono corrusco il secondo atto della <strong>Francesca</strong>, Riccardo<br />
Zandonai si svela a noi per intero soltanto quando dà a una “viola pomposa” una melo<strong>di</strong>a nella quale la dolcezza<br />
alquanto melanconica <strong>di</strong> un crepuscolo amoroso è magicamente espressa.<br />
L’atto della fragorosissima battaglia non solo è povero <strong>di</strong> musica realmente sentita e originale ma grava<br />
come un esorbitante carico <strong>di</strong> zavorra su la nave infiorata e armoniosa. È un vero peccato ch’esso non possa<br />
venire soppresso.<br />
Basta: le impressioni del pubblico e le nostre su questa <strong>Francesca</strong> sono perfettamente concor<strong>da</strong>nti e perciò<br />
non occorre insistere troppo in proposito. Si tratta <strong>di</strong> un’opera non ugualmente felice in ogni sua parte, non<br />
riboccante <strong>di</strong> ampie idee musicali ma, nell’insieme, attraente, nobile e composta con infallibile intuito teatrale:<br />
un’opera – insomma – che merita alti encomi e che la critica ha il dovere <strong>di</strong> collocare tra le migliori<br />
manifestazioni artistiche della giovane scuola italiana.<br />
Lieti del successo iersera decretato alla <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong>l pubblico più elegante <strong>di</strong> Roma, riconosciamo che non<br />
piccola parte <strong>di</strong> esso si deve all’interpretazione squisita degli artisti e alla vigorosa <strong>di</strong>rezione del maestro<br />
Edoardo Vitale. La signorina Rosa Raisa ha superato se stessa – è tutto <strong>di</strong>re! – nella grande scena d’amore<br />
dell’atto terzo. Il suo canto così pieno <strong>di</strong> malìe ha indotto a commozione tutti gli ascoltatori. Quanta grazia in<br />
ogni gesto <strong>di</strong> questa artista incomparabile ma pervenuta a celebrità dopo appena tre anni <strong>di</strong> carriera teatrale. Noi<br />
non riusciamo ad immaginare una “<strong>Francesca</strong>” <strong>di</strong>versa <strong>da</strong> lei. Alla Raisa iersera il pubblico rivolse approvazioni<br />
entusiastiche. Ella trionfò come una regina ammirata ed amata.<br />
Eccellente “Paolo” il tenore Aureliano Pertile, artista stimatissimo per robustezza dei mezzi vocali e il calore<br />
passionale dell’accento. Il Pertile, insieme con la Raisa, ebbe i primi onori. Quanto al baritono <strong>Rimini</strong>, possiamo<br />
affermare che la sua interpretazione del personaggio <strong>di</strong> “Gianciotto” abbia ottenuto lo<strong>di</strong> incon<strong>di</strong>zionate; ottimo<br />
“Malatesta” [sic] il tenore Nar<strong>di</strong>, a noi già <strong>da</strong> tempo favorevolmente noto.<br />
La parte <strong>di</strong> “Samaritana” ebbe <strong>da</strong>lla signorina Morano tutto il desiderabile rilievo e la Zinetti seppe essere<br />
una garbata “Smarag<strong>di</strong>”. La canzone delle ancelle <strong>di</strong> “<strong>Francesca</strong>” fu resa <strong>da</strong>lle signorine Martino, Lauri, Torelli<br />
e Garavaglia in modo delizioso.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/29
I cori del Costanzi si <strong>di</strong>mostrarono all’altezza della loro fama; ricca e <strong>di</strong> buon gusto la messa in scena. Uno<br />
spettacolo dunque <strong>di</strong> pregio elevato, la cui fortuna presso il gran pubblico appare sin d’ora sicura.<br />
67<br />
Bruno Barilli, La “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” <strong>di</strong> Riccardo Zandonai al Teatro Costanzio, “La Concor<strong>di</strong>a”,<br />
30.3.1916 - p. 3, col. 4-5<br />
La réprise della fascinosa <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Riccardo Zandonai al nostro Costanzi ha segnato un<br />
nuovo grande memorabile trionfo per il geniale maestro trentino.<br />
Nella sala sfolgorante, prima che Edoardo Vitale salisse al suo posto <strong>di</strong> battaglia e <strong>di</strong> vittoria, era il fremito<br />
dell’attesa; dell’attesa cal<strong>da</strong>, fervi<strong>da</strong> <strong>di</strong> alcune ore <strong>di</strong> oblio, <strong>di</strong> bellezza, <strong>di</strong> gioia; dell’attesa che ci arde l’anima<br />
nell’imminenza <strong>di</strong> rivedere una creatura amata. E quando <strong>Francesca</strong> apparve ai nostri occhi mortali nelle non<br />
mortali forme <strong>di</strong> Rosa Raisa, ci sentimmo presi nel cerchio d’amore che Riccardo Zandonai seppe foggiare nel<br />
raro metallo della sua ispirazione, del suo fervore d’arte e della sua sapienza.<br />
Non vogliamo qui riesaminare con critica meticolosità l’ultima opera dello Zandonai, che porta ormai<br />
impresso l’indelebile suggello della fama.<br />
Noi qui vogliamo soltanto con sincero cuore <strong>da</strong>re il tributo <strong>di</strong> cal<strong>da</strong> ammirazione ch’egli merita a questo<br />
giovine che reca nuovi lauri al nome italiano; a questo singolare artista che a trentadue anni si gloria <strong>di</strong> cinque<br />
opere, tutte belle e vitali; che nel volgere <strong>di</strong> poche settimane <strong>di</strong>ede qui, nell’eterna Roma, prova luminosissima<br />
<strong>di</strong> ciò ch’egli valga e possa, facendosi ammirare nei tre più <strong>di</strong>sparati generi della produzione musicale che sia<br />
<strong>da</strong>to immaginare: musica religiosa (90) , sinfonica (91) e teatrale: a questo grande figlio della nuova Italia, redenta<br />
con l’amore e col sangue.<br />
L’esecuzione dell’opera insigne fu superiore ad ogni elogio; superiore sotto certi riguar<strong>di</strong> a quella della<br />
decorsa stagione. E non vi è in ciò <strong>da</strong> stupirsi.<br />
Non è <strong>da</strong>to tutti i giorni, infatti, <strong>di</strong> trovare un’accolta <strong>di</strong> artisti del valore e della nobiltà <strong>di</strong> quelli che iersera<br />
impersonarono gli scultorei caratteri partoriti <strong>da</strong>l mito e <strong>da</strong>lla altissima fantasia <strong>di</strong> Gabriele D’Annunzio.<br />
Rosa Raisa, Aureliano Pertile, il <strong>Rimini</strong>, il Nar<strong>di</strong>! Nomi che avranno in arte un’eco perenne; spiriti che<br />
seppero vivere, rivivere la trage<strong>di</strong>a mirabile con una evidenza impressionante.<br />
La Raisa, a cui gli Dei consentirono i loro doni più rari, bellezza <strong>di</strong> volto e voce <strong>da</strong> meravigliare, celebrò<br />
iersera un altissimo trionfo. Con ineffabile soavità seppe rendere le ansie dell’anima amante del primo atto, così<br />
ricco <strong>di</strong> pro<strong>di</strong>giosa suggestione, così sottilmente languido e sensuale; seppe gri<strong>da</strong>re la passione tumultuosa<br />
nell’atto secondo, mirabile prototipo <strong>di</strong> trage<strong>di</strong>a corale, pagina magnifica della partitura, purtroppo incompresa<br />
<strong>da</strong>l pubblico; fu immensamente grande nell’atto terzo, materiato <strong>di</strong> dolcezza, <strong>di</strong> voluttà e <strong>di</strong> frenesia; fu sublime<br />
nel quarto, così denso <strong>di</strong> contrasti, così profondo nell’esaltazione dell’Amore <strong>di</strong> donna mortale.<br />
Degno compagno le fu il Pertile, la cui voce meravigliosa ha ancora acquistato in limpidezza e in forza.<br />
Attore corretto se non sempre <strong>di</strong>sinvolto, dette della sua parte un’interpretazione <strong>di</strong>gnitosa e armoniosa. Divise<br />
con la Raisa gli onori del memorabile trionfo. Scultoreo, imponente, tout-à-fait <strong>da</strong>ns sa peau, il <strong>Rimini</strong>, baritono<br />
<strong>di</strong> grande stile, artista consumato, che della dura parte <strong>di</strong> “Gianciotto” seppe fare una vera creazione.<br />
Parea balzato su <strong>da</strong> una mischia me<strong>di</strong>evale; fortissimo cantante, raccolse anche egli larga mèsse <strong>di</strong> plausi e <strong>di</strong><br />
allori. Prezioso cantante, genialissimo attore il Nar<strong>di</strong> (Malatestino) così caro al maestro Zandonai che<br />
giustamente ne apprezza le elette e rare qualità d’artista. Nella mirabile scena tra i fratelli all’inizio del quarto<br />
atto, squarcio drammatico che basterebbe <strong>da</strong> solo a <strong>da</strong>re la misura del singolare ingegno <strong>di</strong> Riccardo Zandonai,<br />
egli raggiunse non comuni altezze e fu freneticamente applau<strong>di</strong>to. Eccellenti il Paci (Ostasio), la signora Zinetti,<br />
deliziosa “Smarag<strong>di</strong>”, la signorina Morano, soavissima “Samaritana”, le donne <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> (signore Lauri,<br />
Martino e Garavaglia), Arturo Pellegrino, ottimo giullare.<br />
Maestro e donno fra cotali artisti Edoardo Vitale, che a questa novella esecuzione <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> de<strong>di</strong>cò tutto<br />
il suo fervore, tutta la sua sapienza e probità, fu evocato alla ribalta ad ogni fine d’atto fra applausi interminabili,<br />
doveroso tributo d’ammirazione, d’affetto e <strong>di</strong> stima per la sua infaticabile attività.<br />
Belli gli scenari – gli stessi dell’anno scorso – e splen<strong>di</strong><strong>di</strong> i costumi, specie quelli della Raisa, degni delle<br />
Mille e una notte; molto <strong>di</strong>scussa e, secondo noi, a ragione con<strong>da</strong>nnata l’introduzione delle <strong>da</strong>nzatrici nella<br />
canzone a ballo del terzo atto: stonatura <strong>di</strong> pessimo gusto, cacciata non si sa perché in un quadro <strong>di</strong> suprema<br />
bellezza.<br />
Facciamo voti perché le cose tornino in pristino, come l’anno scorso.<br />
Numerose repliche avrà certo questa <strong>Francesca</strong> trionfale, che segna una <strong>da</strong>ta memoran<strong>da</strong> nell’aureo libro<br />
dell’arte italiana.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/30<br />
68
d. o., <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Riccardo Zandonai al Teatro Costanzi, “L’Idea nazionale”, 30.3.1916 - p. 3, col.<br />
4-5<br />
Il felice successo che conseguì lo scorso anno quest’opera <strong>di</strong> Riccardo Zandonai iersera ebbe a rinnovarsi:<br />
alcuni spettatori affermavano essa piacesse ancora <strong>di</strong> più: certamente piacque assai e i frequenti e cal<strong>di</strong> applausi<br />
assunsero quel carattere <strong>di</strong> convincimento che si riconosce subito e non inganna alcuno. Il destino dell’opera è<br />
dunque segnato e la <strong>Francesca</strong> del giovane maestro trentino è fra le poche contemporanee che sopravviveranno<br />
alla tumultuosa stagione dell’esor<strong>di</strong>o? La cosa pare probabile, i lieti presagi cominciando ad avverarsi, quei lieti<br />
presagi innanzi ai quali si trovarono <strong>di</strong>sarmati persino i critici che hanno fama <strong>di</strong> severità grande e invitta.<br />
Qualche dubbio può far sorgere il secondo atto, quello del bellicoso episo<strong>di</strong>o dell’alta torre, in cui il<br />
fragorosissimo motivo descrittivo della battaglia soffoca i partiti drammatici e passionali e necessari all’azione:<br />
il dramma è nello sfondo e non nella prima linea, o almeno i due drammi, il principale e il sussi<strong>di</strong>ario, non sono<br />
così fusi come dovrebbero essere: la musica poteva forse correggere e superare l’errore evidente della trage<strong>di</strong>a<br />
ed è <strong>da</strong> supporre che il senso teatrale <strong>di</strong> Giuseppe Ver<strong>di</strong> avrebbe risoluto l’arduo quesito. E ancora, dopo<br />
l’ammirabile scena d’amore colla quale si chiude il terzo atto, il dramma musicale scema <strong>di</strong> pregio, cioè è<br />
sempre pieno <strong>di</strong> vita e robusta, ma non <strong>di</strong>ce più quello che aveva detto “la pietà dei due cognati”. Pare che<br />
Dante vieti eternamente <strong>di</strong> procedere oltre, dopo che scrisse:<br />
Quel giorno più non vi leggemmo avante.<br />
Tuttavia il Zandonai volle mostrarsi scrupolosamente fedele al poema del d’Annunzio e la sua è stata<br />
definita, e con perfetta giustizia, un’opera <strong>da</strong>nnunziana, un’interpretazione <strong>di</strong> quello ch’era l’arte del nostro<br />
poeta allorché concepì ed espresse la <strong>Francesca</strong>, interpretazione che si rivela nell’elegantissimo e profondo e<br />
melanconico sensualismo <strong>di</strong> queste note, nella cura paziente d’ogni elemento <strong>di</strong> descrizione, nell’affetto a ogni<br />
particolare, nell’analisi instancabile <strong>da</strong> cui risulta la ricchezza del quadro, in quel tanto <strong>di</strong> prezioso, <strong>di</strong> raffinato,<br />
<strong>di</strong> esteticamente compiuto che pare attenui la sanguigna violenza delle persone e del tempo evocato in<br />
un’atmosfera <strong>di</strong> bellezza. Quest’aria si respira negli istanti salienti del dramma musicale: la fine del prim’atto<br />
ch’è incantevole, la scena d’amore del terzo che ha reale potenza dominatrice. Ed è vano <strong>di</strong>re che questa non è<br />
quella <strong>di</strong> Dante; lasciamo Dante <strong>da</strong> parte; la <strong>Francesca</strong> che qui si vede non è la <strong>Francesca</strong> <strong>di</strong> Dante, è un’altra<br />
donna, ed è altra cosa la scena che narrano le quattro immortali terzine del quarto [sic] canto dell’“Inferno”.<br />
Dimentichiamo: <strong>di</strong>mentichiamo persino che lo spunto <strong>di</strong> questo momento drammatico è nella Divina Comme<strong>di</strong>a.<br />
Consideriamo questi due innamorati, che non sono nemmeno più due colpevoli, quasi si presentassero a noi per<br />
la prima volta: quanta tenerezza e che fremito <strong>di</strong> desiderio non <strong>di</strong>segna e non canta la nuova musica e con quale<br />
dolcezza e con quale passione le voci non s’alternano e non cospirano e come l’orchestra le secon<strong>da</strong> e le<br />
colorisce!<br />
Questa se non è la scena <strong>da</strong>ntesca è veramente la scena del d’Annunzio, elevata alla potenza massima:<br />
questo è il dramma musicale del tempo nostro, una schietta cooperazione, geniale talvolta, come nel caso nostro,<br />
e pertanto dobbiamo fissarne anzitutto il tipo artistico, <strong>di</strong>ciamo pure letterario, rinfrescando l’antico precetto:<br />
omnes artes cognatione qua<strong>da</strong>m inter se continuantur.<br />
Rosa Raisa, in tutto il fulgore della sua giovane bellezza slava, riebbe il trionfo con quale <strong>di</strong> già fu salutata<br />
quando la canora <strong>Francesca</strong> cominciò a vivere fra noi: alla fresca sua voce, al suo magnifico accento ch’è<br />
veramente quello <strong>di</strong> questa musica declamata, si raccoman<strong>da</strong> in grande parte la fortuna dell’opera, il cui valore<br />
ella intende mercé la forte intelligenza e la rara squisitezza dell’anima.<br />
Esagererei se <strong>di</strong>cessi che gli altri interpreti sono <strong>di</strong> tempra eguale, tuttavia sarei anche ingiusto se negassi al<br />
tenore Pertile e al baritono <strong>Rimini</strong> il contributo che hanno recato a questa prima sal<strong>da</strong> confermazione dell’opera<br />
vittoriosa: il canto del Pertile e il vigore drammatico del <strong>Rimini</strong> parvero e sono degni <strong>di</strong> encomio. Così col<br />
maestro Vitale loderò l’orchestra e gl’interpreti delle parti minori: il Nar<strong>di</strong>, selvaggio Malatestino, e la Martino,<br />
la Lauri, la Garavaglia, la Torelli, la Zinetti, ch’erano le ancelle, buone cantatrici e donne graziose.<br />
Il pubblico fu contento, anche s’era occupato <strong>da</strong> pensieri maggiori, ché le notizie le quali giungevano <strong>da</strong>l<br />
campo sotto Gorizia lo richiamavano ad altra realtà: tuttavia plaudendo al d’Annunzio e al Zandonai, al poetasol<strong>da</strong>to<br />
e ferito [e] al maestro che oggi rappresenta pel suo ingegno italiano e per le speranze che suscita la<br />
patria comune, gli spettatori erano sempre nel glorioso e tragico clima della guerra liberatrice.<br />
69<br />
“<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” del M. Zandonai al “Costanzi”, “Il Popolo romano”, 30.3.1916 - p. 2, col. 3<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> del m. Zandonai era attesa e desiderata.<br />
Oramai l’opera si è soli<strong>da</strong>mente affermata tra le più significative e vitali apparse in questi ultimi anni ed ha<br />
ammiratori numerosi e ferventi: sì che cotesta ripresa costituì un successo largo e spontaneo, decretato <strong>da</strong> un<br />
u<strong>di</strong>torio folto ed elegantissimo.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/31
L’esecuzione fu impeccabile.<br />
I due maggiori interpreti erano gli stessi, ammiratissimi, dello scorso anno: la signorina Raisa e il tenore<br />
Pertile, ed a loro spettarono le maggiori feste.<br />
Rosa Raisa, insuperata creatrice del personaggio della protagonista, destò ancora una volta grande<br />
ammirazione. La bellezza della voce si completa con una interpretazione scenica delle più felici. Ell’è una<br />
<strong>Francesca</strong> deliziosa, volta a volta illangui<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> melanconia o ingenuamente soave o vibrante <strong>di</strong> passione, ma<br />
sempre personale, sempre efficacissima.<br />
Accanto alla signorina Raisa trionfò Aureliano Pertile, l’acclamato tenore salito rapi<strong>da</strong>mente a grande<br />
rinomanza. Il Pertile, che in questa stagione ha avuto largo campo <strong>di</strong> sfoggiare le sue ottime qualità<br />
interpretando con grande successo parecchie opere, riportò il più lusinghiero giu<strong>di</strong>zio nella parte <strong>di</strong> Paolo, che è<br />
uno dei suoi cavalli <strong>di</strong> battaglia.<br />
Egli è cantante <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> mezzi, che sa tuttavia <strong>di</strong>sciplinare con una ottima scuola, tanto <strong>da</strong> potere ottenere<br />
bellissimi effetti così nel declamato drammatico come nel canto piano, susurrato a mezza voce, colorito ed<br />
animato <strong>di</strong> commosso sentimento.<br />
Il geniale artista, seguito <strong>da</strong>l pubblico con costante interesse, ebbe lunghi e meritati applausi.<br />
Il racconto del terzo atto gli valse speciali feste, che si rinnovarono calorosamente al chiudersi del velario,<br />
dopo lo squisito duetto d’amore.<br />
Il <strong>Rimini</strong>, e vocalmente e scenicamente risultò un ottimo Gianciotto, come il Nar<strong>di</strong> fu un caratteristico<br />
Malatestino.<br />
La signora Zinetti seppe farsi ammirare nella parte <strong>di</strong> Smarag<strong>di</strong>, e la signorina Morano rese con grazia quella<br />
<strong>di</strong> Samaritana.<br />
Le donne <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong> formarono una fresca e simpatica corona. Ricor<strong>di</strong>amo le signore Martino, Lauri,<br />
Garavaglia e Torelli.<br />
Lo spettacolo fu gui<strong>da</strong>to con altissimo intelletto d’amore <strong>da</strong>l m. Vitale, il quale a questo nuovo vittorioso<br />
cimento ha <strong>da</strong>to tutto il fervore della sua anima d’artista. Il pubblico volle esprimere al maestro illustre la<br />
propria ammirazione e lo evocò numerose volte alla ribalta tra scroscianti applausi.<br />
Magnifico l’allestimento scenico e bene affiatate le masse.<br />
Nell’o<strong>di</strong>erna riproduzione abbiamo notato due piccole novità, entrambe <strong>di</strong>scutibili. L’una, quei quattro<br />
trombettieri che nell’infuriare della battaglia si presentano col loro bravo passo <strong>di</strong> musica applicato sulle trombe<br />
come se si trattasse <strong>di</strong> una parata, e l’altro la visione coreografica nel terzo atto la quale, pure essendo eseguita<br />
benissimo, svisa non<strong>di</strong>meno tutto il carattere della canzone a ballo che deve essere svolta con gaia semplicità<br />
<strong>da</strong>lle donne <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, e in tutti i casi mai con quei costumi non rispondenti al tempo né all’ambiente.<br />
[...]<br />
70<br />
g[iuseppe] m[aria] v[iti], “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” al “Costanzi”, “La Vittoria”, 29-30.3.1916 - p. 2, col. 5<br />
Le “prime” – prima nella stagione – si seguono e s’inseguono al Costanzi con un ritmo <strong>di</strong>sperato. Non si ha<br />
tempo <strong>di</strong> assaporare una Manon che l’altra viene a <strong>da</strong>rle lo sgambetto: non appena Puccini crede <strong>di</strong> aver messo<br />
ra<strong>di</strong>ci nel repertorio ecco che il glorioso Ver<strong>di</strong> gli contende... la percentuale. Ma nemmeno Ver<strong>di</strong> può dormire<br />
tranquillo. Fra l’Ai<strong>da</strong> e l’Otello, Zandonai ha fatto capolino. Un saluto <strong>di</strong> sfuggita: il tempo <strong>di</strong> stringergli la<br />
mano per esprimergli ancora una volta la nostra ammirazione per il suo nobile sforzo <strong>di</strong> innestare sulle gran<strong>di</strong> e<br />
innegabili conquiste fatte <strong>da</strong>i genii autentici d’oltralpe – in fatto <strong>di</strong> polifonia e <strong>di</strong> colorito musicale – il buon<br />
ramo della melo<strong>di</strong>a <strong>di</strong> nostra razza. L’innesto Zandonai ha verzicato che è un piacere. I germogli hanno una<br />
soavità primaverile che innamora. Si presenta la fioritura. Lasciate che questa terribile tormenta della guerra si<br />
<strong>di</strong>legui, lasciate che ritorni un poco <strong>di</strong> calma nell’atmosfera, e il roseto non tarderà a <strong>da</strong>re le sue più rosse rose.<br />
Del resto, il tenero verde dei germogli ci piacque pur ieri: ci piacque ancora. Segno buono.<br />
Ci sono delle opere che dopo due anni <strong>da</strong>lla nascita portano rughe nauseose. Non è la veneran<strong>da</strong> vecchiaia: è<br />
il deca<strong>di</strong>mento brutale per libertinaggio senza amore.<br />
La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Zandonai non ha altre rughe che quelle prodotte <strong>da</strong>lla me<strong>di</strong>tazione profon<strong>da</strong> sulle<br />
giovani fronti pensose. La me<strong>di</strong>tazione profon<strong>da</strong>: ecco già un buon correttivo per il ramo troppo selvaggio della<br />
melo<strong>di</strong>a nostrana. La sorveglianza severa sulle sorgenti abbon<strong>da</strong>ntissime delle melo<strong>di</strong>e nostrane: ecco già un<br />
innesto <strong>di</strong> sicura riuscita. Bastò questa <strong>di</strong>sciplina su sé medesimo perché Giuseppe Ver<strong>di</strong> potesse giungere al<br />
capolavoro perfetto <strong>di</strong> Ai<strong>da</strong>, <strong>di</strong> Falstaff, <strong>di</strong> Otello.<br />
Ma i giovani hanno voluto tentare un altro correttivo: le applicazioni su vasta scala delle nuove conquiste nel<br />
campo della tecnica musicale. Non hanno avuto torto. Zandonai ne ha <strong>da</strong>to, ripeto, una prova luminosa con<br />
questa <strong>Francesca</strong> che il pubblico ha apprezzato fin <strong>da</strong>l suo primo apparire e apprezza e ama e, in fondo,<br />
pre<strong>di</strong>lige ancora oggi.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/32
Ieri sera, per questa reprise, il miglior pubblico <strong>di</strong> Roma s’era <strong>da</strong>to convegno al Costanzi per applau<strong>di</strong>re il<br />
giovane maestro, mirabilmente servito (servire è un verbo che qui va preso nella sua migliore e più religiosa<br />
accezione: è il servire <strong>di</strong> Kundry) <strong>da</strong>i suoi interpreti.<br />
I quali, ad eccezione del baritono <strong>Rimini</strong>, erano poi quelli che già u<strong>di</strong>mmo lo scorso anno su queste stesse<br />
scene, con lo stesso identico piacere.<br />
La parte della protagonista è stata ancora una volta affi<strong>da</strong>ta a Rosa Raisa. L’altr’anno ella fu una rivelazione:<br />
quest’anno ella non ci fece pentire delle nostre lo<strong>di</strong> osannanti. C’è sempre pericolo <strong>di</strong> cadere sull’iperbole<br />
quando ci si trova <strong>di</strong>nnanzi a un fatto nuovo. Non poche “montature” trovano la loro spiegazione in questa<br />
psicologia della critica. Rosa Raisa ha rinnovato in noi la fresca meraviglia.<br />
Gli è che la Raisa ha delle qualità essenziali: ha una voce che può contare fra le più belle del nostro teatro<br />
lirico. Nulla le manca: limpidezza, espressione, ampiezza. Il gesto, forse, è ancora un poco troppo stilizzato.<br />
Nell’Ai<strong>da</strong> ella rievoca una figura <strong>di</strong> Mestrovic. Ieri sera nella <strong>Francesca</strong> ella ebbe la rigidezza d’una figura<br />
preraffaellita.<br />
Del resto, il leggen<strong>da</strong>rio personaggio del dugento può bene sopportare una riproduzione scenica<br />
squisitamente arcaica.<br />
Il tenore, Aureliano Pertile, è un cantante correttissimo. Egli sa animare con un soffio <strong>di</strong> passione travolgente<br />
il suo “ruolo” d’ardore. A volte, col canto e col gesto egli seppe trascendere i limiti della figura umana <strong>di</strong> Paolo.<br />
Seppe essere l’Amore irresistibile: il fato d’amore. Fu un’on<strong>da</strong>ta <strong>di</strong> soavità avvolgente.<br />
Il baritono <strong>Rimini</strong> è stato magnifico nella parte <strong>di</strong> Gianciotto, in cui egli ha pro<strong>di</strong>gato le sue qualità <strong>di</strong><br />
cantante e <strong>di</strong> interprete.<br />
Efficacissimo il Nar<strong>di</strong> che fu tutto ferocia e perversità. Qualche suo accento ci agghiacciò.<br />
Tutte le altre parti furono “tenute” a meraviglia.<br />
Vitale fu, come al solito, un collaboratore fraterno <strong>di</strong> Zandonai.<br />
71<br />
[Giuseppe Maria] Viti, “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>” de M. Zandonai au Costanzi, “L’Italie”, 30.3.1916 - p. 5, col. 2<br />
Les premières – premières <strong>da</strong>ns cette saison lyrique – se suivent et se poursuivent d’un rythme désespéré.<br />
Une des deus Manon chasse l’autre et tous les deux se font flanquer à la porte par un opéra de Ver<strong>di</strong>, qui à son<br />
tour est vaincu par un autre opéra de Ver<strong>di</strong>. Mais l’Immortel Chantre ne réuissit pas non-plus à rester maître du<br />
camp.<br />
Entre Ai<strong>da</strong> et Othello, M. Zandonai fait son apparition: le temps de se faire applau<strong>di</strong>r par ses admirateurs<br />
enthousiastes, qui sont déjà une légion. Désormais M. Zandonai est au nombre des personnalités les plus<br />
marquantes du monde musical. Il a droit de cité <strong>da</strong>ns l’Olympe artistique: <strong>da</strong>ns cette partie de l’Olympe, du<br />
moins, où habitent les Muses Lyriques.<br />
C’est pourquoi le public d’élite, habitué des premières romaines, s’était donné rendez-vous, hier soir, au<br />
Costanzi, pour la première de <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>.<br />
Nous avons déjà eu l’occasion de parler de la valeur esthétique et musicale de cette œuvre remarquable lors<br />
de ses représentations à Rome, l’an dernier. Nous nous contenterons donc de faire la chronique de cette soirée<br />
exceptionnel qui a confirmé les succès déjà obtenus par le drama de MM. d’Annunzio et Zandonai.<br />
Le rôle de la protagoniste avait été confié, encore une fois, à Mlle Rosa Raisa. L’année dernière elle fut une<br />
révélation pour le public. Hier elle ne nous fit pas repentir de nos applau<strong>di</strong>ssements enthousiastes. Lorsqu'on fait<br />
nous éblouit pour la première fois, nous risquons presque toujours d’exagérer nos impressions admiratives.<br />
Nombre d’emballements n’ont d’autre source que <strong>da</strong>ns cette psychologie collective. Or, Mlle Raisa, hier soir,<br />
nous a ravi tout comme l’annér dernière. la charmante artiste a une voix qui peut compter parmi les plus belles:<br />
rien ne lui manque: limpi<strong>di</strong>té, harmonie, ampleur, justesse, expression, école impeccable, viennent s’ajouter à un<br />
jeu parfait et à une élegance et une grâce exquises. Peut-être son geste est-il quelquefois un peu stylisé. Dans le<br />
rôle d’Ai<strong>da</strong> elle nous rappellait Mestrovic. Dans le rôle de <strong>Francesca</strong> elle évoquait quelques tableaux de<br />
préraphaélite. D’ailleurs le personnage légen<strong>da</strong>ire qu'elle incarnait pouvait bien supporter la stylisation si chère<br />
aux peintres primitifs. Mlle Raisa est bien en tout cas l’héroïne légen<strong>da</strong>ire telle que nous nous l’imaginons el te<br />
public, qui a compris encore une fois qu'il se trouvait en présence d’une grande artiste, le lui a prouvé par ses<br />
ovations enthousiastes.<br />
Le ténor, M. Aureliano Pertile, est un chanteur des plus corrects, qui a animé d’un souffle de passion ardente<br />
le rôle plein de <strong>di</strong>fficultés de Paolo. Il a remporté le même succès que l’an dernier, <strong>da</strong>ns ce même rôle.<br />
M. <strong>Rimini</strong> a été excellent <strong>da</strong>ns le rôle de Gianciotto, où il a pro<strong>di</strong>guè ses grandes qualités de chanteur et<br />
d’interprète.<br />
Mlle Morano a été une exquise Samaritana et ella a brillamment surmonté toutes les <strong>di</strong>fficultés techniques<br />
dont son rôle est [ ]mé.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/33
M. Leone Paci a été très apprécié <strong>da</strong>ns le rôle d’Ostasio, ainsi que Mme Zinetti <strong>da</strong>ns celui de Smarag<strong>di</strong> et M.<br />
Nar<strong>di</strong> <strong>da</strong>ns celui de Malatestino. Un bon point aux “donne” de <strong>Francesca</strong> que le public a fort admirés.<br />
La mise en scène était splen<strong>di</strong>de, les chœurs excellents.<br />
Le maestro Vitale a <strong>di</strong>rigé l’orchestre avec beaucoup d’entrain et de virtuosité. Il a été un collaborateur<br />
fraternel de M. Zandonai.<br />
72<br />
f. c., La stagione al Costanzi, “Musica” X/7, 10.4.1916 - p. 3, col. 1<br />
[...]<br />
È an<strong>da</strong>ta poi in scena la <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Zandonai, non troppo desiderata dopo questa e<strong>di</strong>zione, che è<br />
peggiore <strong>di</strong> quella dell’anno scorso. Valenti interpreti ne sono stati la Raisa e il <strong>Rimini</strong>, sempre a posto nelle<br />
parti selvaggie e violente. Non così il Pertile il cui timbro <strong>di</strong> voce non si a<strong>da</strong>tta all’alto e talvolta possente<br />
lirismo dell’amante infelice. Le masse, corale e orchestrale, che ben conoscono dopo i cimenti <strong>di</strong> un anno fa la<br />
<strong>di</strong>fficile partitura dello Zandonai, hanno assolto egregiamente al loro compito sotto la esperta <strong>di</strong>rezione del<br />
maestro Vitale<br />
[...]<br />
73<br />
“<strong>Francesca</strong>” e R. Zandonai al Costanzi, “Il Giornale d’Italia”, 25.12.1921<br />
L’inaugurazione della stagione lirica al “Costanzi” avverrà dunque lunedì prossimo alle 20.30 precise, nella<br />
sera tra<strong>di</strong>zionale <strong>di</strong> Santo Stefano, con la <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> <strong>di</strong> Riccardo Zandonai, opera che è tra le più<br />
acclamate <strong>di</strong> questi ultimi tempi e che per la bellezza della concezione artistica e l’ampiezza delle sue linee<br />
teatrali costituisce uno spettacolo <strong>di</strong> grande attrattiva.<br />
La scelta <strong>di</strong> quest’opera, così italiana nella musica, il soggetto stesso, i nomi degli autori – Riccardo<br />
Zandonai, nativo <strong>di</strong> <strong>Rovereto</strong> ora redenta e <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio che ideò la magnifica trage<strong>di</strong>a – <strong>da</strong>ranno<br />
all’inaugurazione quel carattere d’italianità che era <strong>da</strong> tante parti invocato: poiché, mentre nei teatri dell’estero<br />
si fa ora un’aspra guerra ad opere ed artisti nostri, è giusto che in Italia almeno avvenga la “valorizzazione”<br />
della produzione italiana. E l’inaugurare la grande stagione lirica della Capitale con la <strong>Francesca</strong> vuol <strong>di</strong>re<br />
consacrare anche <strong>da</strong>vanti agli occhi degli stranieri la continua vitalità dell’opera italiana, che si rinnova ed<br />
assume, come appunto in <strong>Francesca</strong>, le forme più moderne senza <strong>di</strong>venire astrusa per il gran pubblico; e<br />
significa anche consacrare il nome del nuovo e genialissimo operista che viene, giovane, ad aggiungersi al<br />
gruppo famoso che fa capo a Pietro Mascagni, a Giacomo Puccini, a Umberto Gior<strong>da</strong>no, al Cilea, al<br />
Montemezzi.<br />
Valori d’arte e valori teatrali sono questi nomi, che molto significano all’estero. Se altri nomi, come questo<br />
<strong>di</strong> Riccardo Zandonai si aggiungono, ascriviamolo a fortuna. Ed è necessario che il massimo teatro della<br />
Capitale assuma anche questa funzione <strong>di</strong> utile propagan<strong>da</strong>, quando le circostanze lo consentano.<br />
Così lunedì sera il pubblico <strong>di</strong> Roma saluterà sul po<strong>di</strong>o del “Costanzi” Riccardo Zandonai – che si affermerà<br />
anche come <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> singolari attitu<strong>di</strong>ni, del resto già rivelate altrove – subendo il fascino della sua musica; e<br />
saluterà in lui il giovane ed operoso artista vissuto finora lungi <strong>da</strong> ogni scalpore, solo intento al proprio lavoro.<br />
E nel corso della stagione il pubblico <strong>di</strong> Roma, come già per quasi tutte le nuove opere dei nostri più amati<br />
ed acclamati autori viventi, fino al Trittico <strong>di</strong> Puccini, fino al Piccolo Marat, sarà chiamato giustamente a <strong>da</strong>re il<br />
primo giu<strong>di</strong>zio sulla novissima opera dell’autore <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, l’opera che s’intitola anch’essa italianamente<br />
alla nostra popolarissima ed affascinante leggen<strong>da</strong> <strong>di</strong> Giulietta e Romeo.<br />
74<br />
R[affaello] De Rensis, “La <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> ” <strong>di</strong> Zandonai, “Il Messaggero”, 28.12.1921 - p. 3, col. 4-5-6<br />
All’inaugurazione solenne e austera dei concerti all’Augusteo è seguita l’inaugurazione solenne e brillante<br />
del teatro Costanzi. Intorno all’uno e all’altro una fioritura rigogliosa <strong>di</strong> canti, suoni e balli, ovunque.<br />
Navighiamo in pieno oceano musicale e la nostra barchetta si lascia dolcemente trascinare <strong>da</strong>lle on<strong>da</strong>te<br />
incessanti. I tormenti della esistenza sociale, politica, intima, specie dopo il già troppo prolungato dopo guerra,<br />
sono stati investiti <strong>da</strong>lla marea musicale che li attenua, li annulla letificando animi, spiriti e corpi.<br />
S’aggiunga che tanto l’Augusteo quanto il Costanzi, i due massimi istituti della vita artistica romana, hanno<br />
riaperti i loro battenti con lavori <strong>di</strong> autori nostri sod<strong>di</strong>sfacendo un desiderio generale. Nulla <strong>di</strong> più logico, del<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/34
esto, perché non si comprende la ragione <strong>di</strong> inaugurare, come si faceva per il passato sospinti <strong>da</strong> un falso<br />
snobismo, le nostre più cospicue cerimonie artistiche con il riconoscimento e l’esaltazione del genio altrui,<br />
quando <strong>di</strong> genio la nostra razza ne ha ancora <strong>da</strong> vendere. Né sostenendo e tutelando questo <strong>di</strong>ritto dell’arte<br />
nostra, come noi abbiamo fatto in ogni occasione e <strong>da</strong> quando l’infatuazione esotica annebbiava le menti della<br />
generazione <strong>di</strong> cui facciamo parte, facevamo del conservatorismo servile <strong>da</strong>l quale, vivad<strong>di</strong>o, eravamo e siamo<br />
ancora lontani; ma si trattava <strong>di</strong> una sensibilità natìa (non usiamo a bella posta l’aggettivo nazionale o<br />
patriottico) ottusa nei più ed oggi per virtù reattiva decisamente trionfante.<br />
In un giro non lungo <strong>di</strong> anni abbiamo avuto la fortuna <strong>di</strong> assistere alla nascita e al deca<strong>di</strong>mento dell’anzidetta<br />
infatuazione esotica, col sano ritorno ad un sentimento <strong>di</strong> razza invano conculcato e rinnegato.<br />
Per circostanze in<strong>di</strong>pendenti <strong>da</strong> ogni volontà si stava per iniziare le rappresentazioni al Costanzi con i<br />
Maestri Cantori. Noi <strong>di</strong> quest’opera siamo ammiratori cal<strong>di</strong> e convinti, ma ci sarebbe immensamente <strong>di</strong>spiaciuto<br />
se avesse dovuto prendere il posto della <strong>Francesca</strong> <strong>di</strong> Zandonai, la quale, a parte ogni paragone non possibile,<br />
aveva il compito <strong>di</strong> caratterizzare la cerimonia inaugurale, appunto come l’ha caratterizzata e significata.<br />
E poi, guar<strong>da</strong>te un po’ com’è interessante la figura <strong>di</strong> questo nostro rude montanaro trentino: tozzo e<br />
quadrato, con l’occhio acuto e fisso verso un punto lontano, forse non percettibile, cammina calmo, sereno,<br />
senza soste, senza tornare in<strong>di</strong>etro preoccupandosi appena quanto basta <strong>di</strong> ciò che avviene intorno a lui,<br />
gua<strong>da</strong>gnando terreno, attingendo vertici; baldo e sicuro <strong>di</strong> giungere. Dove e quando, egli non lo sa e forse non<br />
vuol saperlo: sa soltanto che cammina <strong>di</strong>ritto.<br />
Guar<strong>da</strong>te invece gli altri nostri maestri giovani e <strong>di</strong> eterne belle speranze: corrono e toccano un primo<br />
scalino, si arrestano, cadono, ricorrono e ricadono, esercitando questo loro acrobatismo sempre nello stesso<br />
cerchio... o circolo vizioso. E poi si piegano a destra e a manca, innanzi e in<strong>di</strong>etro, cogliendo e raccattando la<br />
materia o gli elementi <strong>di</strong> materia per riempire la bisaccia e riversarla un bel giorno, in forma <strong>di</strong> note e accor<strong>di</strong>,<br />
sul paziente pentagramma. Vi sono altri maestri ancora che logorano il loro talento nella ricerca laboriosa del<br />
nuovissimo, lasciandosi abbagliare <strong>da</strong>i trovati senza dubbio geniali ma altrettanto personali e <strong>di</strong> natura<br />
eccezionale provenienti d’oltr’Alpe. Essi si tengono deliberatamente <strong>di</strong>scosti <strong>da</strong>ll’anima e <strong>da</strong>l canto del popolo e<br />
perciò partoriscono un’arte <strong>di</strong> eccezione e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> decadenza. Sono i cosiddetti avveniristi e internazionalisti,<br />
in buona o mala fede non importa, che si scalmanano per importare una merce ostica al nostro palato e che <strong>da</strong><br />
venti anni (ormai l’esperimento dura <strong>da</strong> troppo tempo per insistervi) non ancora ottengono una sola vibrazione<br />
della psiche collettiva.<br />
Zandonai invece è della stirpe evoluzionista tipo immortale Ver<strong>di</strong>, e <strong>da</strong>l tenue romanticismo del Grillo del<br />
focolare alla passionalità luminosa <strong>di</strong> Conchita, <strong>da</strong>lla coreografia ellenica <strong>di</strong> Melenis alla tragica umanità <strong>di</strong><br />
<strong>Francesca</strong>, è tutto un procedere verso la conquista dell’espressione, che a traverso un magistero tecnico<br />
in<strong>di</strong>scutibilmente formi<strong>da</strong>bile deve accostare l’opera d’arte alla folla. E questo accostamento, questa<br />
penetrazione, avvengono lentamente, sicuramente. La personalità in germe, latente nelle prime opere, va man<br />
mano crescendo, fiorendo e <strong>di</strong>ramandosi, e con <strong>Francesca</strong> quasi carpisce quella fiaccola del genio musicale<br />
italiano... che per buona ventura non è ancora spenta.<br />
Zandonai, tra i suoi colleghi e coetanei <strong>di</strong> cui abbiamo fatto cenno, è il solo o quasi che della rinascita in<br />
Italia della musica strumentale – fenomeno importantissimo e nobilissimo – con tendenze decisamente e<br />
giustificatamente moderniste (perché nessuno oggi s’azzar<strong>da</strong> più a sostenere che si debba retrocedere nel<br />
passato) abbia saputo profittare con senso squisito <strong>di</strong> misura e <strong>di</strong> equilibrio. Questa rinascita della musica<br />
strumentale doveva influire fortemente sull’in<strong>di</strong>rizzo dell’opera teatrale; ma che il sinfonismo sia proprio quello<br />
destinato a risolvere l’eterno conflitto fra la parola e la musica sovrapponendosi e dominando, non abbiamo mai<br />
creduto neppure quando il fanatismo degli strumentatori in Italia inneggiava vittorioso all’egemonia<br />
dell’orchestra.<br />
Ora questa fase è per nostra fortuna superata e la necessità <strong>di</strong> un’arte più rispondente all’indole <strong>di</strong> nostra<br />
gente va affermandosi giornalmente. Chi questa necessità istintivamente sentì subito e praticò è appunto il<br />
maestro Zandonai che, se nel momento acuto dell’orgia strumentale per poco non venne ricacciato nel branco<br />
dei passatisti, oggi si trova, perché ha camminato rapido, anche più innanzi <strong>di</strong> coloro che per voler saltare su<br />
secoli <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zioni si sono spezzati l’osso delle reni.<br />
Egli ha sempre ascoltato la voce immensa e multiforme del popolo, pur non sapendola o volendola<br />
riprodurre: vi si opponeva la crisi tormentosa <strong>di</strong> una musicalità in fieri.<br />
L’opera<br />
Anche <strong>da</strong>lla <strong>Francesca</strong> emerge evidente il <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o tra la materia ancora poco duttile e il sentimento umano<br />
schietto, ingenuo e profondo. Ed il <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o non è <strong>di</strong> facile risoluzione, poiché dove il dramma d’anime leva il<br />
suo grido più alto e trova più <strong>di</strong>ritte le vie del cuore delle masse, è là che l’artista ricorre, inconsapevolmente o<br />
trascinatovi <strong>da</strong>ll’istinto, a forme meno libere, più strofiche e, <strong>di</strong>ciamolo pure ché nessuno più ormai se ne<br />
offende, tra<strong>di</strong>zionali. Così alla fine del primo atto, in quasi tutto il terzo atto, nel recitativo <strong>di</strong> Gianciotto e nel<br />
duetto <strong>di</strong> questi col Malatestino, ecc.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/35
Ma noi non dobbiamo giu<strong>di</strong>care in appello l’opera, che rivede per la terza volta le scene del Costanzi e che<br />
gira per tutti i teatri. Non dobbiamo segnalare nuovamente la bellezza poetica <strong>di</strong> tutto il primo atto e <strong>di</strong> tutti [i]<br />
numerosi quadri descritti con mano maestra e irresistibilmente seducenti.<br />
Quella signorile gentilezza <strong>di</strong> ambiente ricondotta sul teatro <strong>da</strong> Gabriele d’Annunzio non solo è stata<br />
perfettamente intesa <strong>da</strong> Zandonai ma intensificata, illuminata con i suoi smaglianti e delicatissimi ricami sonori.<br />
Non dobbiamo notare la manchevolezza del secondo atto, in cui è stato ripetuto ed aggravato l’errore<br />
<strong>da</strong>nnunziano che nella riduzione del poema drammatico a libretto avrebbe potuto essere evitato con la<br />
successione dei due episo<strong>di</strong>: ma si capisce come anche a Zandonai, che non <strong>di</strong>sdegna le au<strong>da</strong>cie, abbia sorriso la<br />
sovrapposizione del colloquio dei due cognati sullo sfondo fragoroso della battaglia, fecondo <strong>di</strong> effetti<br />
musicali... però non raggiunti. Né, infine, dobbiamo in<strong>di</strong>care all’ammirazione del pubblico, che li ha compresi,<br />
ammirati, l’intero delizioso terzo atto, la scena impressionante tra l’orbo e lo sciancato del quarto atto, quella<br />
angosciosa e sensuale tra Paolo e <strong>Francesca</strong>. A noi non resta che il gra<strong>di</strong>to compito <strong>di</strong> registrare la lieta<br />
accoglienza fatta all’opera e all’autore e la cronaca dell’esecuzione. La quale è apparsa assai accurata sia <strong>da</strong>l<br />
lato musicale che <strong>da</strong> quello scenico. Il maestro Zandonai è anche un’eccellente bacchetta che sa scoprire e<br />
mettere in rilievo non solo le ossature tematiche e strumentali ma anche i dettagli, gli ornamenti e i colori più<br />
tenui. E la sua opera che è, per quanto finemente e limpi<strong>da</strong>mente, assai elaborata ha bisogno appunto <strong>di</strong> una<br />
bacchetta in<strong>da</strong>gatrice, sicura, scrupolosa come la sua. Aggiungasi che la falange orchestrale, pronta e agguerrita,<br />
gli ha ubbi<strong>di</strong>to con mirabile esattezza.<br />
Anche gl’interpreti hanno gareggiato per valentia e volontà, a cominciare <strong>da</strong>lla protagonista Gil<strong>da</strong> Dalla<br />
Rizza, che sebbene afflitta <strong>da</strong> una lieve in<strong>di</strong>sposizione ugolare si è mantenuta, tranne nel primo atto, all’altezza<br />
della non facile incarnazione. Nel terzo atto, per gentilezza e stile <strong>di</strong> movimenti, per dolcezza <strong>di</strong> canto emesso<br />
con vigile <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> respiri, ella ha <strong>da</strong>ta novella prova della versatilità interpretativa che le ha reso la<br />
rinomanza <strong>di</strong> cui gode.<br />
La voce tersa, vigorosa, roton<strong>da</strong> del tenore Michele Fleta si è effusa con flui<strong>di</strong>tà ed ha perfettamente seguite<br />
le ondulazioni della sua parte; mentre non sempre il carattere <strong>di</strong> Paolo il bello, che ce lo immaginiamo<br />
contenuto e pensoso anche nei momenti <strong>di</strong> fervi<strong>da</strong> passionalità, è stato reso tale <strong>da</strong> lui. Piccola men<strong>da</strong>, alla quale<br />
se vuole il Fleta, che è intelligentissimo, può facilmente riparare.<br />
Una figura fortemente scolpita è stata quella <strong>di</strong> Gianciotto, riprodotta <strong>da</strong>l giovane baritono Maugeri con<br />
opportuna brutalità e violenza. Nel colloquio, che non vogliamo chiamare duetto, tra lui e Malatestino la<br />
drammaticità della scena si è scatenata col più turbinoso vigore.<br />
Degni <strong>di</strong> encomio il tenore Palai nei panni <strong>di</strong> Malatestino perverso e feroce, e il baritono Besanzoni nella<br />
parte <strong>di</strong> Ostasio: meritevoli <strong>di</strong> menzione il Malfatti (ser Toldo), De Vecchi (il Giullare), la Vitulli, dolcissima<br />
Samaritana.<br />
Le donne <strong>di</strong> <strong>Francesca</strong>, corrette, vivaci, rispettose, malinconiche a secon<strong>da</strong> delle situazioni, hanno<br />
contribuito vali<strong>da</strong>mente alla riproduzione storica e politica dell’ambiente. Le lievi <strong>da</strong>nze del terzo atto non son<br />
sembrate rispondenti e intonate al momento psicologico; mentre i piccoli e deliziosi cori sparsi qua e là per la<br />
partitura e il gran coro finale del secondo atto (che però per la <strong>di</strong>stribuzione delle masse hanno un po’ del<br />
vecchio melodramma) si son <strong>di</strong>ffusi nell’aria armoniosi e affiatati, del che va <strong>da</strong>ta lode all’istruttore maestro<br />
Consoli.<br />
Quando avremo nominati il régisseur Francioli e il <strong>di</strong>rettore scenico Ansaldo avremo forse non <strong>di</strong>menticato<br />
alcun cooperatore del riuscitissimo spettacolo inaugurale della stagione, che in tal modo si apre sotto i più<br />
favorevoli auspici.<br />
Alla fine <strong>di</strong> ogni atto il maestro Zandonai <strong>da</strong> solo e insieme ai principali interpreti è stato ripetutamente<br />
evocato ed acclamato.<br />
[...]<br />
75<br />
R[oberto] Forges-Davanzati, La “<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> ” al Costanzi, “L’Idea nazionale”, 28.12.1921 - p. 3, col.<br />
2-3-4<br />
Di aver finalmente scrollata l’inesplicabile consuetu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> inaugurare la stagione d’opera con Wagner o con<br />
altro repertorio straniero, l’impresa del Costanzi può esser sod<strong>di</strong>sfatta. Senza <strong>di</strong>scutere qui del cosmopolitismo<br />
in arte, e anche accettandolo, si può esser facilmente d’accordo nel <strong>di</strong>re che in casa nostra per far bene gli onori<br />
<strong>di</strong> casa dobbiamo cominciare con rispettare noi stessi.<br />
Di avere scelta <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>, lo spartito più giovanilmente sano della nova generazione musicale,<br />
come spettacolo <strong>di</strong> inaugurazione, può essere ancor più sod<strong>di</strong>sfatta.<br />
Iersera, nella sala del Costanzi, il gran pubblico che si ritrovava non soltanto col desiderio <strong>di</strong> ascoltare e<br />
riascoltare <strong>Francesca</strong> ma con la affettuosa <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> celebrare un rito d’arte e <strong>di</strong> buona mon<strong>da</strong>nità, s’è<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/36
accolto volentieri con slancio spontaneo nell’applauso cor<strong>di</strong>ale e ripetuto al maestro Zandonai che era sul po<strong>di</strong>o<br />
a <strong>di</strong>rigere la sua musica.<br />
Iersera nella sala c’è stato buon calore <strong>di</strong> italianità. L’ovazione piena e pronta che ha salutato il Re, la<br />
Regina, il Principe ere<strong>di</strong>tario; le salve d’applausi che hanno accompagnato la musica fragorosa e sussultante<br />
dell’inno reale, si sono mirabilmente fuse con tutto il sentimento del pubblico, felice <strong>di</strong> riconoscere nella<br />
<strong>Francesca</strong> i segni <strong>di</strong> nobiltà <strong>di</strong> un’arte italiana. Nel grido: viva l’Italia, ch’è stato gettato <strong>da</strong>lla galleria, non si è<br />
concluso un cerimoniale <strong>di</strong> acclamazioni ma è stato quanto era nei cuori.<br />
Quando <strong>Francesca</strong> era venuta sulle scene del “Costanzi”, il suo autore, italiano, italianissimo, aveva tuttavia<br />
nel petto l’amarezza dell’esule. La sua terra, il Trentino, era Italia ed era tuttavia un cuneo straniero <strong>di</strong><br />
prepotenza austriaca, a continua minaccia dell’Italia bella. Oggi Riccardo Zandonai sale sul po<strong>di</strong>o a inaugurare<br />
la stagione della Capitale, <strong>di</strong> Roma che è finalmente capitale anche per la sua terra: e, prima che il velario si apra<br />
sul fragore dell’antica contesa guelfa e ghibellina, egli può finalmente, attaccando le note dell’inno, salutare il<br />
suo Re che è Re anche sulla sua terra, fino al Brennero.<br />
Viva l’Italia! E nel grido era salutata la poesia <strong>di</strong> Dante, che primo <strong>di</strong>ede a <strong>Francesca</strong> l’immortalità, era<br />
salutata la poesia <strong>di</strong> Gabriele d’Annunzio, il poeta-sol<strong>da</strong>to, era salutata la musica dell’autore redento e che,<br />
appunto in questi accenti <strong>di</strong> italianità, aveva, prima della guerra vittoriosa, gettato un’altra voce della stirpe.<br />
Viva l’Italia! E tutte le cose dette e non dette, pensate e non pensate, consapevoli o istintive, sono state<br />
raccolte <strong>da</strong> quel grido, mentre <strong>da</strong>vano a questa prima rappresentazione un’intimità appassionata che altre volte<br />
era mancata.<br />
E non per questo è stato sforzato il valore artistico dell’opera, il valore dell’esecuzione. Gli applausi agli<br />
artisti e al maestro Zandonai, ripetutamente chiamato <strong>da</strong> solo al proscenio, sono stati quali dovevano essere:<br />
schietti, spontanei, calorosi. Per una musica che ha soprattutto una virtù <strong>di</strong> misura stilistica; che anche dove cede<br />
alla sonorità riesce a sfuggire la banalità retorica; che ha grazie <strong>di</strong> atteggiamenti canori, languori accorati <strong>di</strong><br />
passione, squisite tristezze <strong>di</strong> presentimenti.<br />
Fra Puccini, che aveva nella Fanciulla del West ceduto ad un esotismo violento, e Mascagni che con Isabeau<br />
s’era abbandonato ad una esasperazione sonora ed esteriore, questa contemporanea <strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong> del<br />
giovane trentino della nova generazione musicale si presentò con virtù proprie, innegabili. Virtù <strong>di</strong> espressione<br />
più che <strong>di</strong> inspirazione. Ché anche oggi, in una riposata e tranquilla accoglienza come quella <strong>di</strong> ieri sera, le idee<br />
e gli accenti e i sentimenti musicali dell’autore appaiono fragili, limitati. L’ampiezza sonora, alla quale, come<br />
nel primo e nel terzo atto è possibile abbandonarsi, è più <strong>di</strong> sviluppo decorativo che <strong>di</strong> intimità e <strong>di</strong> linguaggio<br />
melo<strong>di</strong>co, anche nei momenti <strong>di</strong> passione.<br />
La musica non raggiunge mai profon<strong>di</strong>tà vive <strong>di</strong> emozione, ché anzi perde le virtù <strong>di</strong> levità e <strong>di</strong> tenuità<br />
squisite dei momenti migliori dell’opera quando vuol essere travolgente come nella passione durante la<br />
battaglia, come nel colloquio finale dei due amanti prima della morte cru<strong>da</strong>. Ma quanta grazia <strong>di</strong> accenti<br />
luminosi, quanta dolcezza triste è nel femminile primo atto, tra le ancelle gaie e festose, l’attesa contenuta <strong>di</strong><br />
<strong>Francesca</strong>, l’improvviso tenerissimo sbigottimento <strong>di</strong> Samaritana! Quale vaghezza <strong>di</strong> canto, quale atmosfera <strong>di</strong><br />
amore e <strong>di</strong> morte è nel femminile terzo atto, nell’ingenuità <strong>di</strong> Biancofiore, nella misteriosa complicità <strong>di</strong><br />
Smarag<strong>di</strong>, nel colloquio d’amore in cui Paolo stesso è tutto languore e smarrimento!<br />
Queste virtù sono state iersera pienamente intese <strong>da</strong>l pubblico con una sensibilità <strong>di</strong> gusto veramente<br />
confortante. E l’opera ha avuto la riconsacrazione <strong>di</strong> un successo senza sottintesi.<br />
Sotto la <strong>di</strong>rezione esperta dell’autore ha prevalso, nel canto e nell’orchestra, l’elemento decorativo <strong>di</strong><br />
quest’opera, che si presenta ad affreschi chiari e trasparenti, dolci e armoniosi negli episo<strong>di</strong> d’amore, esteriore e<br />
fiacco in quello della battaglia, abile <strong>di</strong> luci e d’ombre nell’episo<strong>di</strong>o della denunzia rabbiosa <strong>di</strong> Malatestino.<br />
Questa <strong>Francesca</strong> più che dramma <strong>di</strong> persone vive, travolte <strong>di</strong> passione in un’ora <strong>di</strong> fosca vita e <strong>di</strong> duro<br />
battagliare, appare con una sua magia <strong>di</strong> antica istoria. Effigiata in quadri espressivi, che improvvisamente si<br />
anima e si muove in una luce lunare, così come Heine imaginava ripetersi il mito <strong>di</strong> Gianfredo Rudello su <strong>da</strong>gli<br />
arazzi del vecchio castello, fluttuanti al vento notturno.<br />
Riccardo Zandonai, cui l’orchestra ha obbe<strong>di</strong>to docilmente, è riuscito a mantenere sempre l’incanto <strong>di</strong> questa<br />
evocazione e <strong>da</strong>re carattere agli episo<strong>di</strong>, che pretendono a robustezza e incisione <strong>di</strong> accenti, come il soliloquio <strong>di</strong><br />
Gianciotto e <strong>di</strong> Malatestino, fortemente eseguito <strong>da</strong>l baritono Maugeri e <strong>da</strong>l tenore Palai. <strong>Francesca</strong> era Gil<strong>da</strong><br />
<strong>da</strong>lla Rizza, la cui voce roton<strong>da</strong> e <strong>di</strong>segnata era iersera velata nelle note alte per un’incresciosa in<strong>di</strong>sposizione.<br />
Paolo il tenore Fleta, un artista che ha accenti <strong>di</strong> forza e <strong>di</strong> grazia vocali <strong>da</strong> farlo piegare alle più <strong>di</strong>verse<br />
interpretazioni. Il pubblico li ha chiamati, con gli altri, ad ogni fine d’atto, salutandoli <strong>di</strong> applausi meritati. Né<br />
noi sapremmo rimproverare un <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> drammaticità nei protagonisti, poiché, se mai, lo stile decorativo<br />
dell’opera ci fa credere più interessante quella parte della loro interpretazione che è sobria <strong>di</strong> gesti, rifugge <strong>da</strong>lle<br />
espansioni canore e preferisce l’accentuazione armoniosa e la <strong>di</strong>zione scan<strong>di</strong>ta.<br />
Ci parvero una stonatura le <strong>da</strong>nze al terzo atto, soprattutto per quelle ballerine in maglia e scarpini rosa,<br />
anacronistici e fasti<strong>di</strong>osissimi. Possibile che non ne abbia per primo sentito il fasti<strong>di</strong>o il maestro Zandonai?<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/37
Tutti gli atti furono applau<strong>di</strong>ti; con maggior fervore il primo e il terzo e l’episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Gianciotto e<br />
Malatestino.<br />
È nel cuore <strong>di</strong> tutti che la nuova opera <strong>di</strong> Riccardo Zandonai, Giulietta e Romeo, sia quale merita l’arte<br />
italiana, né morta né moritura.<br />
76<br />
m[atteo] i[ncagliati], “<strong>Francesca</strong>” al Costanzi, “Il Piccolo”, 27-28.12.1921 - p. 3, col. 1<br />
[nb: l’articolo riproduce, con solo qualche piccola mo<strong>di</strong>ficazione, il paragrafo “Lo spettacolo” <strong>da</strong>ll’articolo,<br />
dello stesso Incagliati, riportato <strong>da</strong>l “Giornale d’Italia” del 28.12.1921 – cfr. n. 79]<br />
77<br />
La sala<br />
Ecco – per le lettrici che non hanno assistito a questo spettacolo del Costanzi, dove ogni anno nella serata <strong>di</strong><br />
Santo Stefano si celebra la maggior festa dell’eleganza – ecco com’erano vestite le signore che apparivano<br />
numerosissime in ogni or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> posti.<br />
Non farò una rassegna particolare delle personalità e delle loro toilettes – la sola lista dei nomi richiederebbe<br />
uno spazio grande. Contentiamoci <strong>di</strong> uno sguardo sintetico gettato nei palchi e nelle poltrone per fissare le<br />
caratteristiche degli abbigliamenti come appaiono nei loro colori e nelle loro linee generali. Nelle serate che<br />
seguiranno, a teatro meno affollato, avremo agio <strong>di</strong> rendere più interessante questa rassegna della eleganza con<br />
descrizioni particolareggiate.<br />
Ma incominciamo <strong>da</strong>l notare la presenza nei palchi <strong>di</strong> Corte della famiglia reale. Il Re e la Regina siedono<br />
nel palco <strong>di</strong> proscenio, ed alla fine del primo atto, quando il pubblico s’accorge della loro presenza, scoppia<br />
un’ovazione prolungata con evviva al loro in<strong>di</strong>rizzo: i Sovrani, il principe ere<strong>di</strong>tario e le principesse si alzano e<br />
s’inchinano. Il Re veste in borghese. La Regina aveva un abito <strong>di</strong> satin mauve chiaro e portava sulle spalle una<br />
volpe grigia. Semplice e modesto come sempre l’abbigliamento delle principesse nei loro corsages <strong>di</strong> tinte<br />
sobrie.<br />
Nella sala è tutto un luccichìo <strong>di</strong> paillettes, <strong>di</strong> perle <strong>di</strong> jais e <strong>di</strong> lamés nei colori nero, granata e grigio-perla<br />
su fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> tessuto nero e <strong>di</strong> toni armonizzanti.<br />
Erano drappeggiati <strong>di</strong> velluto, <strong>di</strong> satin, <strong>di</strong> crespo marocain, <strong>di</strong> chiffon, <strong>di</strong> mantilly che mostravano ornamenti<br />
<strong>di</strong> frangie <strong>di</strong> cordonetto o <strong>di</strong> perle <strong>di</strong> jeis, ornamenti costituiti in gran parte <strong>da</strong> panneaux ricamati <strong>di</strong> paillettes,<br />
pendenti <strong>da</strong>i fianchi e strascicanti. Erano centurati <strong>di</strong> nastro ciré, <strong>di</strong> fiori artificiali e <strong>di</strong> catene <strong>di</strong> metallo, e <strong>di</strong><br />
galaliithe.<br />
Nessun cappello, o pochissime toques minuscole, drappeggiate a turbante e portate specialmente nelle<br />
poltrone. Nelle pettinature predominava lo stile semplice, rotondo, a ondulazioni, con acconciature <strong>di</strong> verreries<br />
nere, bandeaux <strong>di</strong> perle e semplici nastri cingenti la fronte. Poche le pettinature artistiche drappeggiate a volute<br />
e adorne <strong>di</strong> pettini <strong>di</strong> ultima novità.<br />
Fra le signore che ricordo <strong>di</strong> avere veduto erano degne <strong>di</strong> ammirazione la P.ssa Giovannelli, in nero, Donna<br />
Elsie Torlonia in abbigliamento grigio, la marchesa Go<strong>di</strong> <strong>di</strong> Go<strong>di</strong>o. La marchesa Misciatelli. La contessa<br />
Antonelli, signora Pavoncelli, signora Ceresa marchesa <strong>di</strong> Bagno. Donna Ruspoli Maria Contessa <strong>di</strong> Samnuj.<br />
Marchesa Patrizi. La signora Nicolaj in un elegante abbigliamento <strong>di</strong> duvetyne bianco adorno <strong>di</strong> astrakan nero.<br />
La baronessa Compagna. Contessa Ceriano-Grazioli. Signora Falbo, Contessa e contessine Andreozzi.<br />
Marchesa Serlupi, donna Corinna <strong>da</strong>ll’Ongaro Fabris, donna Bianca Varvaro, Principessa Maria Antici-Mattei.<br />
Marchesa <strong>di</strong> Bagno, signora Vurtz, contessa Guar<strong>di</strong>, duchesse Sforza Cesarini. Contessa Ceresa. Signora<br />
Tabanelli, contessa Rossi, signora Montorsi, signorina Moglia, signora Romano, ecc.<br />
g. n.<br />
<strong>Francesca</strong> <strong>da</strong> <strong>Rimini</strong>/38<br />
(1 segue)