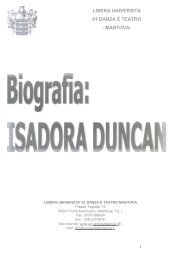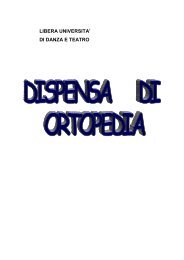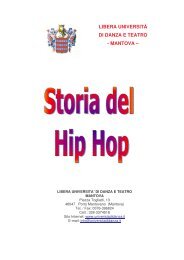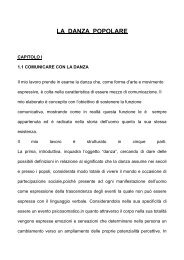PEDAGOGIA PREMESSA pag. 1 LA PEDAGOGIA ... - LUDT
PEDAGOGIA PREMESSA pag. 1 LA PEDAGOGIA ... - LUDT
PEDAGOGIA PREMESSA pag. 1 LA PEDAGOGIA ... - LUDT
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>PEDAGOGIA</strong><br />
<strong>PREMESSA</strong> <strong>pag</strong>. 1<br />
<strong>LA</strong> <strong>PEDAGOGIA</strong> FENOMENOLOGICO-ESISTENZIALE <strong>pag</strong>. 5<br />
o PROCESSI FORMATIVI E PROGETTAZIONE ESISTENZIALE<br />
o I VISSUTI DELL’ESPERIENZA FORMATIVA <strong>pag</strong>. 28<br />
o LE TONALITA’ EMOTIVE DELLO SPAZIO EDUCATIVO <strong>pag</strong>. 36<br />
o IL DIVENRE ESISTENZIALE <strong>pag</strong>. 62<br />
o ESSERE UN CORPO <strong>pag</strong>. 94<br />
KÖRPSEELE: IL CORPO ANIMA <strong>pag</strong>. 122
Premessa<br />
La pedagogia è la scienza che studia i processi educativi, o se si preferisce, l'evento educativo -<br />
come dice Piero Bertolini - nella duplice accezione: di trasmissione e trasformazione culturale, e<br />
nella qualità delle relazioni interpersonali che le rende possibili.<br />
La pedagogia si occupa, in particolare, degli aspetti di fondo, ovvero degli indirizzi educativi, dei<br />
valori, degli obiettivi perseguiti.<br />
Come afferma Cesare Scurati, la pedagogia è "la lettura della realtà sotto il profilo dell'educazione"<br />
e al tempo stesso, come sostiene Fausto Telleri, è il tentativo di progettare e realizzare un<br />
possibile mondo migliore.<br />
Il destinatario della pedagogia è innanzitutto il bambino, ma oggi si avverte anche la necessità che<br />
la scienza dell'educazione si occupi sia degli adulti (si parlerà allora di Andragogia) sia degli<br />
anziani (si parlerà di Geragogia).<br />
Il termine Pedagogia deriva dal greco παιδαγογια, da παιδος (paidos) « il bambino » e αγω «<br />
guidare, condurre, accom<strong>pag</strong>nare ».<br />
La pedagogia si fonda sul concetto di educabilità dell'uomo: in altri termini si ritiene che l'uomo sia<br />
educabile in ogni momento della sua esistenza e che sia possibile perseguire detto obiettivo in<br />
maniera intenzionale e scientifica. Tradizionalmente si è creduto che la pedagogia, in quanto<br />
scienza teorica, potesse pilotare in modo unidirezionale l'azione educativa e la didattica. Oggi,<br />
invece, si afferma l'esistenza di una circolarità delle informazioni che vanno a integrare e a<br />
modificare sia la pedagogia (teoria) sia la prassi educativa.<br />
Educare significa promuovere l'altro, promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione.<br />
Educare significa "tirar fuori" ciò che è dentro alla persona: significa cioè valorizzare quanto di<br />
meglio ci sia potenzialmente in un individuo. L'educazione consiste in un rapporto tra due persone:<br />
una matura, l'altra in via di formazione. La persona matura deve adeguarsi al livello dell'educando.<br />
Ciò significa assumere un linguaggio appropriato alla persona che si vuole educare.<br />
La pedagogia trasfonde contenuti e fornisce impianti teorici e metodologici all'educazione. Questa<br />
ha il fine di dare risposta al bisogno di adattarsi di fronte al mutamento, fornisce orientamento e fa<br />
leva sulla motivazione. Oggi, l'educazione, pedagogicamente intesa, mette al centro della sua<br />
analisi l'individuo nella sua totalità e nella sua globalità, ne conserva il punto di vista, e fornisce gli<br />
strumenti utili per giungere alla consapevolezza del proprio essere e del proprio agire.<br />
In specifico, la pedagogia costruisce teorie atte a comprendere e delineare il processo educativo.<br />
La Pedagogia si relaziona sempre ad una concezione filosofica dell'uomo (tipica dell'antropologia<br />
filosofica), dialoga quindi con la filosofia pur essendo da essa autonoma. Essa si avvale dei<br />
contributi di numerose altre scienze umane.<br />
Nella analisi/articolazione dei processi educativi fa riferimento ai dati culturali delle differenti etnie<br />
che ci fornisce l'antropologia, alle teorie dell'apprendimento e del comportamento elaborate dalla<br />
2
psicologia; alle analisi delle dinamiche sociali elaborate dalla sociologia; alle indicazioni emergenti<br />
della biologia.<br />
La verifica della sua efficacia viene, sempre più spesso, affidata alla operatività della "pedagogia<br />
sperimentale", sui grandi numeri, e su differenti tecniche di verifica e di valutazione di tipo<br />
qualitativo e quantitativo.<br />
Lo specialista di processi educativi (ricerca e applicazione) si definisce pedagogista.<br />
Il pedagogista è un professionista dotato di una formazione proveniente da più settori delle scienze<br />
sociali, quali la pedagogia stessa, la psicologia, l'antropologia, la sociologia.<br />
· Il pedagogista opera nei settori dell'educazione dei minori e degli adulti, nella prevenzione e nella<br />
formazione.<br />
· Il pedagogista come libero professionista opera grazie agli strumenti propri della pedagogia<br />
sperimentale, quali test, osservazione sistemica, colloqui, questionari, indagine statistica e clinico<br />
educativa.<br />
· Il pedagogista opera nei settori della sanità, della formazione, della scuola, nel sociale,<br />
assistenziale ed aziendale.<br />
Molti i pedagogisti del '900, fra i quali possiamo citare, in ordine sparso, Montessori, Dewey,<br />
Decroly, le sorelle Agazzi, Bruner, Claparède, Anton Semionovic Makarenko, Credaro.<br />
Alcune teorie pedagogiche<br />
In pedagogia si potrebbero contrapporre due modelli pedagogici, uno basato sull'individuo (con<br />
riferimento a Immanuel Kant e Rousseau) ed uno sulla società (con riferimento a Émile Durkheim).<br />
I due modelli di pedagogia non possono essere giudicati in modo univoco, poiché in ognuno si<br />
possono trovare elementi positivi ed elementi negativi. La teoria kantiana è basata su una forte<br />
spinta positiva nei confronti dell'uomo: la fiducia nell'essere umano porta il pensatore a vederlo<br />
come artefice di un miglioramento della sfera sociale. L'educare il fanciullo evitandogli<br />
completamente ogni rapporto con la realtà lo porterà ad una formazione tale da riuscire a cambiare<br />
in meglio la società che lo ospita.<br />
Durkheim, al contrario, è restio ad educare in completa astrazione dalla realtà sociale, poiché ciò<br />
porterebbe ad una ritorsione dei costumi contro il soggetto, se questi non li rispettasse. Ogni<br />
società ha delle regole che, se non conosciute, vengono innocentemente ignorate, causando<br />
situazioni "illecite" che possono ritorcersi contro l'autore.<br />
Jean-Jacques Rousseau, nell'Emilio o dell'educazione, tratta anch'esso di un'educazione del<br />
fanciullo fuori dalla società, con molta analogia con la teoria kantiana. A ciò si può tuttavia<br />
controbattere che la completa astensione dalla società da parte del fanciullo, porta ad una non<br />
conoscenza diretta della società stessa. L'educatore può insegnare ad Emilio tutto ciò che riguarda<br />
i costumi, leggi e quant'altro, ma questo rimane solamente nella sfera teorica. La pratica è tutta<br />
un'altra cosa, che, senza una diretta esperienza di cosa voglia dire vivere immersi nella società,<br />
3
non può portare ad un successo. Durkheim, a questo punto, giustamente parla di un'educazione<br />
interna alla società stessa. Dopo la Rivoluzione industriale, le caratteristiche della società hanno<br />
subito un enorme cambiamento e senza un rapporto diretto con esse non si potrebbe vivere in<br />
modo conforme a questi moderni usi e costumi. Ciò in cui Durkheim è criticabile è nell'attribuire<br />
maggior peso all'educazione impartita dalla società in confronto a quella che possono dare gli<br />
insegnanti.<br />
Immaginando astrattamente un figlio che vive totalmente immerso nella società (e quindi educato<br />
dalla società stessa) e privato della presenza dei genitori, che potrebbero avere il ruolo di<br />
insegnanti, egli non avrebbe le capacità per comprendere la società stessa e quindi non<br />
riuscirebbe a cogliere l'insegnamento che questa gli offre. Il rapporto che un educando ha con il<br />
proprio insegnante non è paragonabile a quello che ha con la sfera civile in cui è immerso. È un<br />
rapporto stabile, protetto da possibili traumi che la società può causare, ma soprattutto è un<br />
rapporto diretto tra due persone, delle quali una, dall'alto della sua esperienza, dona all'altra<br />
conoscenze teoriche che le saranno utili nella vita pratica. Con la sfera sociale si ha un rapporto<br />
più violento e turbolento, che poco giova alla crescita interiore dell'educando. Inoltre, l'educazione<br />
imposta dalla società può avere molte strade ed è il fanciullo a dover scegliere quale<br />
intraprendere, avendo il 50% di possibilità di percorrerne una sbagliata. Cosa che non può<br />
accadere nel rapporto personale con l'insegnante, poiché è l'educatore stesso che indica all'allievo<br />
la strada da prendere.<br />
4
INTRODUZIONE<br />
PROCESSI FORMATIVI E PROGETTAZIONE ESISTENZIALE<br />
L’orientamento seguito in queste <strong>pag</strong>ine è quello di una pedagogia fenomenologico-esistenziale. In<br />
tale prospettiva sono delineate le questioni epistemologiche legate ai processi formativi, nella<br />
convinzione che scientificità ed esistenza debbano incontrarsi per rispondere a quella esigenza di<br />
senso che l’agire educativo richiede.<br />
La prima parte è principalmente teoretica, e fornisce il lessico propedeutico ed i concetti essenziali<br />
per una pedagogia fenomenologico- esistenziale.<br />
Particolare attenzione sarà dedicata a sottolineare lo sguardo e l’esigenza di senso che<br />
contraddistingue ogni relazione formativa fondata sull’autenticità esistenziale. Gli intenti, i pensieri,<br />
i gesti, il sentire che accom<strong>pag</strong>nano i processi formativi sono attraversati da un legame di senso<br />
che orienta, nei sentieri dell’esistenza, lo sguardo pedagogico. Ed è la domanda di senso a<br />
suggerire la direzione delle risposte. Dove manca tale direzione si smarrisce la possibilità di uno<br />
sguardo autentico sulla relazione educativa.<br />
Accade allora che i luoghi comuni, le ambiguità semantiche o il pregiudizio scientifico<br />
s’impossessino della realtà formativa, incapaci di vederla nel suo manifestarsi effettivo,<br />
attribuendole invece caratteristiche scontate e previste.<br />
La fenomenologia husserliana ci consegna, attraverso l’epochè, la possibilità di guardare la realtà<br />
come appare, sottraendola all’ovvietà e vedendola come per la prima volta. Così si presenta infatti<br />
l’esperienza formativa, sempre nuova e sempre da inventare.<br />
Lo sguardo fenomenologico conduce a cogliere anche ciò che è in penombra, oscuro, il sentiero<br />
non percorribile, tralasciato dalle varie prospettive scientifiche indirizzate verso l’esattezza che<br />
illumina a tutto tondo. Questo sguardo riporta nell’apertura e resta perennemente aperto a cogliere<br />
tutti i modi in cui si manifesta il processo formativo.<br />
Questa apertura all’imprevedibile assume il carattere di principio metodologico in quanto, per<br />
cogliere la realtà stessa nei suoi aspetti imprevedibili e originali, occorre saper epochizzare le<br />
consuetudini mentali e l’ovvio.<br />
L’importanza di questo sguardo che coglie la realtà formativa nel suo manifestarsi instabile e<br />
mutevole si traduce primariamente nell’assumere la responsabilità del vedere. E dunque una<br />
pedagogia dello sguardo fenomenologico assume l’etica della responsabilità come fondamento.<br />
Nello sguardo eidetico, che coglie l’essenza dell’evento formativo, si può esprimere la modalità<br />
dello stupore verso ciò che l’incontro può rivelare. Così la modalità della contemplazione dischiude<br />
i sentieri dell’esistere, anche nel loro manifestarsi a volte tortuoso e pur sempre sorprendente.<br />
Successivamente si attraversano i principali nuclei tematici di spazio, tempo e corpo vissuto. Lo<br />
spazio vissuto, con riferimento agli elementi di prossimità e distanza, affronta i temi della spazialità<br />
5
interiore e dell’intimità, allargandosi progressivamente agli spazi esterni, al contesto familiare e<br />
sociale, fino all’ecosistema planetario.<br />
Il tempo vissuto, considerato nelle tre dimensioni di passato, presente e futuro, (intesi come<br />
fondamento, situazione e progettualità dell’educare), affronta i nessi con gli spazi nella memoria<br />
autobiografica, soffermandosi poi sui transiti dell’esistenza e sulla dimensione progettuale,<br />
costitutiva della formazione.<br />
Il corpo vissuto, interpretato nella prospettiva fenomenologica di Leib (corpo esistenza) è visto nei<br />
suoi processi di cambiamento (dall’adolescenza alla vecchiaia) e come matrice originaria<br />
dell’identità di genere.<br />
PROCESSI FORMATIVI E PROGETTAZIONE ESISTENZIALE<br />
Secondo una visione fenomenologico-esistenziale, la pedagogia non è uno studio, una definizione,<br />
una constatazione di fatti sui quali si sostiene il processo formativo; non è una ricerca e analisi<br />
delle cause che hanno prodotto determinate manifestazioni; non può essere costruita e verificata<br />
soltanto nel particolare, in laboratori di situazioni pro-vocate e pre-disposte per un’interpretazione o<br />
un intervento: rischierebbe così di essere una metafora della situazione, una parodia del rapporto<br />
formativo. La pedagogia dell’esistenza si attiene all’esperienza vissuta. Il suo punto di partenza e<br />
criterio epistemologico di base è “la cosa stessa”, cioè l’esperienza formativa, con il patrimonio che<br />
emerge dai sentimenti, dai vissuti, dalla biografia.<br />
Ciò che ha valore di “atto” conserva il rapporto con la vita (e perciò anche in parte con il mistero)<br />
invece di essere rinchiuso e fissato all’interno della sua spiegazione.<br />
Una scienza pedagogica fenomenologicamente fondata non si propone come oggettiva e neutra,<br />
ma assegna dignità scientifica alla soggettività della persona, perseguendo una comprensione del<br />
soggetto umano che ne rispetti la specificità e la dignità.<br />
L’importanza di non perdere di vista la soggettività della persona umana nella conoscenza<br />
scientifica riecheggia anche nelle parole di Heidegger quando afferma che “la persona non è né<br />
una cosa, né una sostanza, né un oggetto” e che per questo “pretende per l’unità della persona<br />
una costituzione essenzialmente diversa da quella delle cose naturali”. Ogni prevalere del<br />
tecnicismo porterebbe infatti a dis-umanizzare le relazioni e i processi formativi.<br />
Il poter essere di ogni persona costituisce la dimensione strutturale costitutiva dell’Esserci che, in<br />
quanto esistente, è sempre proiettato davanti a sé, nella sua relazione con gli altri, nel mondo.<br />
L’Esserci esiste sempre “in vista di”. L’esistenza è sempre progettuale. La conoscenza e la<br />
progettazione di sé consentono quel diventare se stessi che si esprime nella Cura.<br />
La metodologia esistenziale avvicina le strutture del sé alle strutture dell’alterità, tanto che non può<br />
essere compresa la persona umana se non nel suo essere con gli altri.<br />
Una pedagogia fenomenologico- esistenziale nasce da un modo nuovo di concepire l’essere con<br />
l’altro, di guardarlo, di comunicare con lui nella ricerca di senso. La progettazione esistenziale è<br />
6
protesa verso quel divenire ciò che si è che orienta ogni processo formativo nella cura di sé, degli<br />
altri, del mondo.<br />
Il processo formativo, inteso come incontro di progetti, mantiene aperta la direzione intenzionale<br />
del progetto di sé anche quando qualcun altro ha costruito “per noi” un progetto concepito al di<br />
fuori o al di sopra o contro di noi. La progettazione esistenziale assume significati diversi e<br />
molteplici implicazioni emotive e concettuali. Vi è una progettualità più materiale, legata al<br />
quotidiano raggiungimento di beni (agiatezza, fama, salute); una progettualità personale, legata<br />
alla sfera affettiva e sentimentale (amore, amicizia, emulazione, solidarietà, ma anche odio,<br />
disprezzo, rancore, invidia); ed infine una progettualità volta al senso stesso dell’esistenza che<br />
chiama in causa i valori, l’etica, la metafisica, la politica, la religione, spingendosi nella progettualità<br />
fin oltre la morte.<br />
Il volto attivo del progetto, che dipende dal volere e dall’io, dalla spinta e dalla decisione, si<br />
incontra/scontra con i progetti altrui, che noi percepiamo come consoni o contrastanti con i nostri.<br />
Le emozioni che emergono nella tonalità emotiva del progetto diventano vie di accesso alla<br />
conoscenza dell’altro e alla relazione interpersonale attraverso cui il progetto di sé si intona ai<br />
vissuti esperienziali.<br />
È in questo senso che acquistano rilevanza decisiva i vissuti che entrano in gioco nella<br />
formazione, non relegabili a dimensione marginale, oscura, insignificante, ma avvalorati come<br />
espressione autentica di ciò che costituisce una Bildung.<br />
L’esperienza formativa si può giudicare “riuscita” quando si conserva nell’apertura fondamentale al<br />
mondo e alla relazione con gli altri come possibilità inesauribile, quando si realizza equilibrio tra<br />
affermazione del sé e apertura all’alterità, quando cioè il soggetto riesce a trovare la via per<br />
“rinunciare a sé” affermando sé; quando si rende libero per la propria decisione, senza perdere la<br />
consapevolezza della propria originaria condizione di deiezione.<br />
Si possono invece giudicare esperienze educative mancate sia quelle in cui il soggetto non sa<br />
rinunciare al sé e rimane nella chiusura al mondo circostante o, al contrario, disperde il proprio sé<br />
nel Si impersonale e pubblico. In ogni caso si ha una perdita della propria libertà per l’educazione,<br />
una schiavitù verso l’io o verso il mondo dovuta alla rottura dell’unità originaria soggetto-mondo.<br />
Formazione e pedagogia<br />
Ogni processo formativo si presenta come un procedere complesso a cui concorrono più<br />
dimensioni, contesti, contenuti, obiettivi che, nel corso dell’esistenza umana, si aprono al nuovo e<br />
si alimentano dell’esperienza passata. Come una barca a vela ha bisogno delle acque su cui<br />
scivolare, ma anche del vento, del timone, della bussola, della vela, delle conoscenze tramandate<br />
e della capacità di affrontare l’imprevisto, così la formazione deve avere un orientamento e<br />
strumenti per rilevarlo, tecniche per dirigersi, valori che sappiano gonfiare le vele e sospingere<br />
verso gli obiettivi della progettazione esistenziale.<br />
7
Non può quindi essere focalizzata su un solo aspetto, né riferita a un solo momento dell’esistenza,<br />
né riguardare un unico ambito.<br />
Non basta costruire la barca perché questa possa solcare le acque, né il navigatore più esperto<br />
può essere in grado di affrontare con sicurezza il mare in tempesta; così la formazione integrale<br />
deve tener conto delle componenti psicologiche, ambientali, sociali, storiche, etiche, dialetizzando i<br />
diversi punti di vista ma anche cercando gi scoprire nuovi orizzonti.<br />
La metafora della navigazione a vela esplicita la dimensione di complessità della formazione intesa<br />
come Bildung. È possibile dunque gettare uno sguardo fenomenologico che sappia individuare in<br />
questa molteplicità di elementi, quali sono le caratteristiche che rendono formativo un rapporto?<br />
Per cercare di rispondere a questi interrogativi si possono innanzitutto indicare, schematicamente,<br />
alcuni tratti essenziali che ci conducono a definire, da un lato, una regione ontologica<br />
dell’educazione, dall’altro, a indicare lo specifico punto di vista pedagogico nell’interpretazione<br />
degli eventi formativi.<br />
Educazione, Bildung, paideia<br />
Educazione, formazione, sviluppo, istruzione, insegnamento, apprendimento: molti sono i termini<br />
utilizzati per indicare i processi formativi, a seconda degli aspetti diversi su cui si posa l’attenzione.<br />
L’esigenza di significato ha un ruolo unificante dei diversi contenuti e dei modi che tendono alla<br />
costruzione del senso unitario e complesso dell’esistenza. L’esperienza fragile e straordinaria della<br />
formazione snoda tra le infinite possibilità e i molti vincoli dell’esistenza umana che rendono<br />
percorribile una via e ne precludono altre.<br />
La paideia greca, tradotta dai latini con humanitas, è quella formazione umana che comprende e<br />
unifica armonicamente le diverse dimensioni dell’esistenza: è educazione a pensare, a giudicare, a<br />
scegliere. La paideia è il presupposto dell’azione educativa, è l’ideale che ispira la formazione.<br />
Il concetto tedesco di Bildung si riferisce analogamente al processo continuo del prender-forma nel<br />
quale ha un rilievo prioritario l’esperienza del soggetto in formazione, in una prospettiva socratica<br />
di “epimèleia heautou” (cura di sé). La formazione, intesa come Bildung, è la possibilità dell’essere<br />
umano di divenire sé stesso.<br />
Al centro della formazione vi è sempre l’esistenza umana, e quindi la persona, non astrattamente<br />
intesa, ma nella sua concretezza esistenziale e storica.<br />
La formazione non è mai un evento che riguarda una sola persona, ma presuppone sempre una<br />
relazione. Occorre tuttavia subito affermare che nessuno dei soggetti coinvolti può essere<br />
considerato indipendentemente dal sistema di relazioni in cui è inserito. Dunque ognuno porta con<br />
sé, nella relazione formativa che si costruisce, la sua storia culturale, biologica, i valori del contesto<br />
di appartenenza, andando così a costruire la relazione come un incontro tra sistemi.<br />
Si può inoltre parlare di rapporto formativo riuscito soltanto quando i sistemi si modificano;<br />
altrimenti non vi è che una formale parvenza di educazione, poiché la formazione è tale se è anche<br />
trans-formazione.<br />
8
Questo rapporto interumano è sempre espressione di un’intenzionalità orientata verso determinati<br />
fini (dimensione teleologica) e sorretta da valori (dimensione assiologia). Come nella navigazione a<br />
vela è necessario individuare la destinazione, la rotta, l’approdo verso cui dirigersi, calcolare la<br />
direzione del vento e la sua intensità, ma soprattutto essere animati dal desiderio o dal bisogno di<br />
raggiungere una meta ritenuta significativa, così anche l’educazione si orienta secondo una<br />
direzione intenzionale verso la realizzazione di un telos.<br />
I valori non sono principi di giudizio astratti ma hanno un carattere concreto, fungono da principi<br />
ispiratori del contesto formativo. Essi possono essere universalmente intuiti nella loro essenze e<br />
divenire fondamenti per la scelta. La visione delle essenze avviene mediante l’intuizione e<br />
l’esperienza vissuta: non è quindi meramente concettuale o teoretica o puramente razionale. Le<br />
dimensioni assiologia e teleologica connotano la valenza etica dell’azione formativa, conferendole<br />
significato, consapevolezza, responsabilità e autenticità esistenziale.<br />
In quanto intenzionale, la formazione è sempre fondata su un progetto. E dunque è volta a<br />
trasformare la situazione iniziale in una nuova condizione in cui sia i formatori sia i destinatari<br />
dell’intenzionalità formativa si modificano nel percorso comune verso un fine.<br />
Ciò significa che la temporalità è dimensione costitutiva essenziale del processo formativo in<br />
quanto cambiamento. Pur essendo necessaria la consapevolezza dei limiti, la formazione è<br />
orientata al loro superamento, alla possibilità, al poter-essere, alla volontà dell’oltre e pertanto è<br />
orientata al futuro.<br />
Uno scopo e un progetto richiedono la messa in opera di valutazioni, aggiustamenti di rotta,<br />
progettazione di nuove strategie. L’attività formativa è infatti anche un’arte e una tecnica. Elementi<br />
di artisticità sono certamente necessari, così come lo sono le competenze tecniche, peraltro<br />
indispensabili anche in ogni pratica artistica.<br />
Gli strumenti per raggiungere le finalità formative sono da condurre alle tecniche, ma non devono<br />
risolversi in tecnicismo, come purtroppo spesso accade quando si perde di vista la Bildung e si<br />
ripiega sulle procedure e sulle consuetudini. Le pratiche formative implicano un fare artigianale in<br />
cui tecnica e arte non sono separabili.<br />
La pratica formativa è infine sempre connessa con una teoria; l’agire non può infatti prescindere da<br />
teorizzazioni, più o meno scientifiche e formalizzate, a cui ispirare scelte e direzioni d’intenti.<br />
Anche quando appare privo di principi scientifici, l’educare fa sempre riferimento a un patrimonio di<br />
valori e obiettivi, di modelli e principi ideali che appartengono al contesto culturale di riferimento.<br />
Tutte le qualificazione formative fin qui indicate riguardano il come, ma non il perché della Bildung,<br />
il suo fondamento, la possibilità stessa del suo verificarsi, ovvero ciò che la rende possibile.<br />
Pedagogia e scienze dell’educazione<br />
Se la formazione è sempre relazione, questa sarà densa della complessità di fattori che la<br />
sostanziano: i modi, le aspettative, i luoghi, i tempi, il contesto. I processi formativi possono perciò<br />
essere interpretati secondo molte prospettive disciplinari e metodologiche. Essendo oggetto di<br />
9
molti saperi si prestano a più letture da parte delle varie competenze e punti di vista che ne<br />
analizzano i diversi aspetti: dalla filosofia alla psicologia, dalla sociologia alla religione,<br />
dall’economia all’architettura.<br />
Molti ambiti disciplinari possono avere per oggetto di conoscenza i diversi aspetti della realtà<br />
formativa. In particolare è oggi riconosciuto un ruolo privilegiato a quelle scienze della formazione<br />
che sono in grado di fornire un contributo non occasionale ma significativo alla conoscenza della<br />
realtà educativa, secondo un approccio multidisciplinare. Occorre tuttavia segnalare che c’è una<br />
sola area di sapere che ha per oggetto specifico l’educazione e la formazione, ed è la pedagogia.<br />
Le altre scienze, infatti, quali la sociologia e la psicologia, per citarne alcune, quando si occupano<br />
di educazione, devono esplicitare che si tratta di una branca del loro sapere che si applica alla<br />
formazione come particolare oggetto della più generale conoscenza psicologica e sociologica. Tali<br />
scienze assumono perciò denominazioni quali “psicologia dell’educazione” o “psicologia dei<br />
processi formativi”, “sociologia dell’educazione” ecc.<br />
La pedagogia è dunque la sola area che non deve specificare la sua declinazione particolare<br />
quando si occupa dei fenomeni formativi; essa si presenta come l’area privilegiata del sapere<br />
educativo- formativo.<br />
Una concezione della pedagogia come sintesi critica dei risultati delle diverse ricerche settoriali,<br />
come sguardo privilegiato sull’educazione, dotato di un suo rigore concettuale, conduce a definire<br />
la pedagogia come scienza autonoma, che non si confonde con le altre scienze per la specificità<br />
del suo oggetto, ma interagisce continuamente con esse e si arricchisce dei loro apporti.<br />
Le varie scienze della formazione interagiscono dunque fra loro e concorrono, ciascuna secondo le<br />
proprie modalità, alla realizzazione del valore comune e del fine comune costituito dalla<br />
formazione del soggetto umano in senso critico ed etico- valoriale.<br />
Quali siano le interazioni tra le varie scienze, e quanto sia complessa la dialettica articolazione di<br />
problemi, si evince dalle diverse aree di specializzazione interna della pedagogia, dove le<br />
demarcazioni sono difficili per la fitta rete di rimandi reciproci fra le pedagogie.<br />
Pedagogia<br />
Una volta chiarita la posizione della pedagogia tra le scienze dell’educazione e della formazione, è<br />
necessario chiarire anche la fisionomia della stessa nella sua dimensione teorico- pratica. È ormai<br />
riconosciuto che l’etimo greco (pais, paidos = fanciullo; e ago = conduco) è divenuto troppo<br />
riduttivo rispetto alle concezioni che sempre più tendono a identificare la formazione come un<br />
evento permanente dell’esistenza umana, non riferita soltanto all’età evolutiva, ma a tutte le fasi<br />
della vita; secondariamente i concetti di condurre e guidare esprimono prevalentemente il<br />
momento pratico dell’azione educativa, mentre non si può ignorare l’intrinseca valenza teoretica.<br />
L’esperienza formativa, per arricchirsi di consapevolezza e competenze e per non ridursi a<br />
improvvisazioni estemporanee, fa sempre riferimento ad una riflessione che rielabori l’esperienza<br />
concreta e consenta un’ulteriore progettazione. La pedagogia, nelle sue varie articolazioni<br />
10
disciplinari e nelle relazioni interdisciplinari è precisamente quell’area di sapere avente il carattere<br />
di riflessione teorica “sulla” e “per la” pratica formativa volta a renderla meno incerta, e quindi a<br />
modificare la situazione data, presente, verso una crescita esistenziale.<br />
La pedagogia non è mai astratta, poiché non può mai prescindere dall’esperienza viva e concreta,<br />
la si può definire dunque una scienza volta alla prassi. Teoria e prassi sono legate da un vincolo di<br />
perenne circolarietà: qualsiasi azione formativa presuppone una scelta che sarà dettata da una<br />
riflessione, cioè da una teorizzazione. Allo stesso modo la formazione, nel suo concreto e<br />
multiforme dispiegarsi, offre materia di riformulazione dei presupposti teorici.<br />
In realtà la metafora più corretta per definire questo rapporto, è quella della spirale ascendente:<br />
l’esperienza alimenta la riflessione e quest’ultima nutre l’azione. Sicché le pratiche formative<br />
possono acquisire sempre maggiore consapevolezza e la teoria diventa sempre meno retorica,<br />
astratta, infondata. Le pratiche diventano sempre più strutturate, efficaci, consapevoli e la<br />
riflessione teorica diventa sempre più complessa. La pratica, senza la teoria, risulterebbe cieca,<br />
priva di fondamento, incapace di progettazione; la teoria senza una verifica nella pratica, sarebbe<br />
vuota di senso.<br />
La pedagogia è in tal senso una scienza “poietica” in quanto il conoscere è generativo di nuove<br />
produzioni. In questa accezione la pedagogia è quindi una teoria dell’educazione, dove il gesto ed<br />
il pensiero, alimentandosi reciprocamente, accrescono e nutrono il procedere della storia dei<br />
processi formativi.<br />
Un’ulteriore valenza del concetto di pedagogia è quindi quella trascendentale di riflessione su sé<br />
stessa. Oltre che sul suo oggetto, la pedagogia riflette sui suoi fondamenti scientifici: in questa<br />
dimensione metateorica è stata definita metapedagogica.<br />
La pedagogia è quindi una riflessione teorica di primo grado, quando studia l’evento evolutivo, e di<br />
secondo grado quando produce riflessioni sulla teoria pedagogica e cerca di analizzare il suo<br />
statuto epistemologico.<br />
Proprio per la pluralità di aspetti presenti nella formazione, la pedagogia è un’area di sapere che,<br />
al suo interno, comprende settori specifici e si esplica in diverse declinazioni: può sviluppare temi<br />
di storia dell’educazione o sperimentare metodologie, può orientarsi in una dimensione teoretica o<br />
sociale, assumendo di volta in volta diverse denominazioni: “pedagogia sociale”, “pedagogia dei<br />
processi evolutivi”, “pedagogia della devianza”, ecc.<br />
Tra scienza e filosofia<br />
Il livello teoretico della pedagogia, divenuto sempre più ampio e profondo, chiama in causa sia la<br />
dimensione filosofica sia quella scientifica. Per meglio comprendere la scientificità della pedagogia<br />
e delle scienze della formazione, occorre ricordare che soltanto dagli ani Settanta la pedagogia<br />
affronta l’obiettivo di proporre un proprio statuto scientifico e di perseguire rigore e sistematicità di<br />
ricerca, in una sorta si emancipazione dalla tradizionale dipendenza dalla filosofia.<br />
11
L’intento di eliminare il retaggio di astrattezza e di retorica, ha talvolta trattenuto la ricerca<br />
pedagogica entro modelli e terminologie spesso mutuate dalle scienze naturali. Anche se si può<br />
parlare di un’epistemologia pedagogica antropomorfa e non esatta.<br />
L’epistemologia pedagogica oggi non cerca di assicurare fondamenti scientifici omologando la<br />
pedagogia alle regole delle scienze naturali, ma assume piuttosto il significato di riflessione critica<br />
volta proprio a sottrarre la scienza pedagogica a quel riduttivismo naturalistico che ha avuto<br />
spesso come conseguenza una visione tecnicistica, empiristica e didatticistica.<br />
I confini tra la dimensione teoretico- filosofica e quella scientifica appaiono sempre più articolati e<br />
la contrapposizione tra scientificità e filosoficità risulta artificiosa, poiché una dimensione non può<br />
prescindere dall’altra. la riqualificazione scientifica della pedagogia è individuabile nella sua<br />
capacità di ravvivare e stimolare il recupero dei suoi fondamenti epistemologici e quindi non nella<br />
negazione del rapporto tra filosoficità e scientificità, ma nel potenziamento di quel rapporto.<br />
La questione del rapporto con la filosofia da parte della pedagogia condusse, verso la metà degli<br />
anni Settanta, alcuni pedagogisti, a pronunciarsi sul senso e sulla validità di una filosofia<br />
dell’educazione, sulla sua prospettive e sulle sue accezioni. Da tali rassegne di posizioni e<br />
orientamenti diversi risultò comunque confermato un elemento comune: il riconoscimento unanime<br />
dell’importanza del momento filosofico e i rischi di una ricerca educativa privata della riflessione<br />
filosofica.<br />
Anche nella successiva ricerca di Granese (1986), l’apporto della filosofia è apparso irrinunciabile<br />
non solo per ogni riflessione assiologia e teleologica, ma anche per la scientificità stessa, poiché<br />
ogni indagine epistemologica si pone sempre sullo sfondo di una filosofia di riferimento.<br />
La conclusione è, in definitiva, che l’apporto della filosofia è decisivo per l’autoriflessione<br />
pedagogica.<br />
Lo sguardo fenomenologico<br />
Le chiarificazioni preliminari sui concetti fondamentali del discorso pedagogico e della sua<br />
collocazione tra scientificità e filosoficità hanno condotto alla possibilità di esplicitare l’orizzonte di<br />
riferimento per una prospettiva di pedagogia fenomenologico- esistenziale.<br />
Il ruolo della filosofia e degli esistenzialismi si configura legata alla critica rigorosa e sistematica di<br />
ogni dogmatismo scientista e si oppone alla pretesa della scienza, positivisticamente intesa, di<br />
oggettivare l’esperienza formativa.<br />
L’istanza di un metodo di indagine che apra il discorso pedagogico dal determinismo alla<br />
possibilità postula il riferimento a una scientificità rinnovata, comprendente anche il sentire,<br />
accanto alla ragione, intesa comunque come istanza criteriale e problematica. Il metodo<br />
fenomenologico ha aperto nuove vie ad una pedagogia che, anziché spiegare il processo<br />
formativo, cerchi di fornire ad esso un senso.<br />
12
La lettura fenomenologica dei processi formativi non si limita ad una comprensione logico-<br />
razionale, a spiegare causalisticamente dall’esterno i dati di fatto, ma si apre al possibile, a quella<br />
comprensione che conferisce senso, derivata dall’esperienza vissuta, dall’intuizione, dall’empatia.<br />
La difficoltà di guardare la realtà in maniera libera da pregiudizi e la tentazione costante di<br />
sovrapporre la teoria alla realtà è assai frequente in ambito pedagogico, dove è più che mai<br />
necessario imparare l’atteggiamento fenomenologico per gettare uno sguardo rinnovato<br />
sull’esperienza formativa.<br />
Un’incessante autochiarificazione induce a vedere ciò che, secondo Jaspers, può essere penetrato<br />
metodicamente con lo sguardo al fine di perseguire l’accesso alla conoscenza della realtà.<br />
Il vedere fenomenologico non fa riferimento solo allo sguardo esplicativo della ragione, ma a uno<br />
sguardo di senso davanti al dispiegarsi della realtà che lascia attraversare nella sua essenza,<br />
poiché l’essere e l’apparire sono la stessa cosa.<br />
Lo sguardo fenomenologico sa cogliere le luci ma anche le ombre, sa vedere i chiaroscuri come<br />
accade nei sentieri del bosco di Maria Zambrano (2004). Questa visione comporta un<br />
atteggiamento scientifico opposto a quello di afferrare ciò che attraversa la formazione e<br />
costringerlo entro una spiegazione che ordina alla realtà di corrispondere allo schema predisposto<br />
per la sua interpretazione.<br />
Ciò che non è spiegabile, nel senso che non è addomesticabile entro uno schema di riferimento<br />
predisposto, viene tralasciato come confine oscuro, non percorribile, insondabile.<br />
La scientificità naturalistico- matematizzante, nella pretesa di possedere conoscenze definitive e<br />
certe, fissa l’apertura all’arricchimento incessante di scoperte e novità. Vi è qualcosa di<br />
radicalmente diverso tra la spiegazione scientifica intesa come Deuten, l’interpretazione che<br />
contiene implicitamente il concetto di Befehlen (comandare), e l’interpretazione fenomenologica<br />
che rimanda invece un metter fuori, all’Auslegung, lasciare in una continuità di apertura, lasciare<br />
che la cosa si riveli in una possibilità di conoscenza che non ha fine se non viene chiusa all’interno<br />
di una fissità del dato oggettivo.<br />
Lo sguardo fenomenologico non si sofferma sulle certezze delle cose che “sono” e “non sono”, ma<br />
le lascia essere nel loro mutarsi e divenire, persino nel loro declinare. “Per scoprire la verità non<br />
c’è miglior luce che quella del tramonto”, scriveva Miguel de Unamuno.<br />
Questo sguardo conduce alla relazione autentica, poiché il vedere rinvia da una parte al tema più<br />
generale della manifestazione, dall’altra, alla dinamica della relazione.<br />
In tal senso il vedere è strumento di un’etica della responsabilità; ed è a questo concetto che si fa<br />
qui riferimento, assegnando un rilievo privilegiato allo sguardo ed al vedere. Il veduto impedisce di<br />
passare oltre: come nella parabola evangelica del samaritano, tanto guardano e passano oltre, ma<br />
egli vede e per questo si ferma. In prospettiva pedagogica questo significa che il gesto educativo è<br />
legato alla capacità di gettare uno sguardo non indifferente o distratto sulle persone che si<br />
incontrano nel rapporto educativo. Vedere è accorgersi dell’altro la cui presenza non è<br />
13
insignificante, ma costantemente ci interpella ad un corrispondere che implica assumere<br />
responsabilità della relazione.<br />
Pedagogia, fenomenologia, esistenzialismi<br />
È necessario, prima di tutto, puntualizzare il significato dei concetti di pedagogia, fenomenologia,<br />
ed esistenzialismi .<br />
È arduo definire che cosa si intende per fenomenologia, dal momento che questo orientamento di<br />
pensiero raggruppa autori e sviluppi di pensiero molto differenti tra loro. La difficoltà nel definire<br />
un’ortodossia fenomenologica spiega perché tale indirizzo non sia mai diventato una vera e propria<br />
scuola di pensiero. Del resto lo stesso iniziatore, Edmund Husserl, non sviluppò il suo percorso<br />
filosofico attorno ad un’idea univoca, ma in una continua evoluzione, sicché gli stessi allievi<br />
rimanevano legati ai concetti elaborati in una certa fase, mentre Husserl proseguiva modificando<br />
alcuni temi e modi in forme nuove.<br />
La filosofa Roberta DeMonticelli osserva che il termine fenomenologia è diventato insapore a furia<br />
di essere rivendicato da pensatori e correnti che pure non ne condividono neppure un aspetto, o<br />
non condividono quelli fondamentali.<br />
Occorre poi segnalare che l’esistenzialismo non è concordemente ritenuto uno sviluppo della<br />
fenomenologia, anche se la maggior parte degli studiosi di filosofia ritiene legittimo parlare di<br />
orientamento fenomenologico- esistenziale, poiché vi è un’innegabile continuità di pensiero e<br />
connessioni tra alcuni autori dichiaratamente ispirati alla matrice husserliana, anche se con esiti<br />
molto diversi.<br />
Si può quindi parlare di movimento fenomenologico e affermare che le filosofie si Scheler,<br />
Heidegger, Hartamann, Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur, Marcel non si capirebbero senza tener<br />
presente la componente husserliana.<br />
L’importante e ingente volume di Herbert Spiegelberg, che cerca di ricostruire la storia del<br />
movimento fenomenologico, mostra la pluralità degli autori e la diversificazione delle filosofie che<br />
possono essere ricondotte alla fenomenologia. Egli rende evidente, da un lato, la vasta influenza<br />
husserliana sul pensiero contemporaneo, dall’altro, la difficoltà di definire i confini della<br />
fenomenologia.<br />
Rimandi reciproci sono ravvisabili negli allievi di Husserl più noti. Max Scheler sviluppa l’etica dei<br />
valori, che possono essere oggetto di intuizione dell’esperienza emozionale pura, colti attraverso<br />
l’intenzionalità. La persona è capace degli atti di simpatia e pietà nell’apertura all’Altro.<br />
Profondamente influenzata dal pensiero di Scheler, Edith Stein, che fu allieva ed assistente di<br />
Husserl, analizzò fenomenologicamente i temi della ricerca di senso, della verità delle cose e della<br />
persona umana nella sua apertura intenzionale all’Altro.<br />
Martin Heidegger per molti anni collaborò con il maestro fino a quando le divergenze apparvero<br />
irriducibili.<br />
14
Tra gli sviluppi di questo orientamento sono poi da segnalare gli allievi di Heidegger; Hans-Georg<br />
Gadamer è il fondatore di quell’ontologia ermeneutica in cui si attribuisce un ruolo primario al<br />
linguaggio custode della verità nell’interpretazione del mondo che sempre si modifica nei suoi<br />
orizzonti di senso. Emmanuel Lévinas, discontandosi da Heidegger, attribuisce il primato al punto<br />
di vista etico su quello ontologico; egli oppone alla totalità l’alterità. L’Altro non può essere colto<br />
con la ragione ma con l’etica: l’esperienza dell’Altro avviene nel riconoscimento e nel rispetto<br />
dell’alterità in cui siamo implicati. Hanna Arendt sviluppa un’antropologia politica sull’importanza<br />
della sfera pubblica nell’identità umana. Assegnando un ruolo decisivo sull’agire, approfondisce<br />
anche i temi del pensare, del volere e del giudicare che consentono di decidere del proprio legame<br />
con il mondo.<br />
Sono poi da segnalare, in area francese, l’esistenzialismo marxista di Jean Paul Sartre e di<br />
Maurice Merleau-Ponty e il contributo importante del personalismo cattolico, rappresentato da<br />
Gabriel Marcel e da Emmanuel Mounier.<br />
Dunque autori diversi furono effettivamente legati tra loro in quanto a temi e prospettive,<br />
nonostante le innegabili discordanze di vedute. Un solido denominatore comune è identificabile<br />
nella centralità della persona. Attorno a questo tema si svilupparono i concetti di libertà, di<br />
impegno, di opposizione all’alienazione e all’inautenticità.<br />
La fecondità dei risultati prodotti dall’applicazione del metodo husserliano e delle intuizioni<br />
heideggeriane si è manifestata anche in ambito psicologico- psichiatrico, attraverso le correnti<br />
dell’antropoanalisi e delle psicologie umanistiche.<br />
Si tratta di una prospettiva aperta dalle intuizioni di Karl Jaspers, medico e psicologo, cattedratico<br />
di filosofia a Heidelberg, ampiamente sviluppata nell’opera di Ludwig Binswanger, e richiamata da<br />
numerosi altri autori.<br />
È in questa cornice sommariamente delineata che si collocano quindi gli studi e le ricerche<br />
pedagogiche orientati in prospettiva fenomenologico- esistenziale: un non elevato numero di studi,<br />
tra questi pochi italiani. Ai primi lavori di, sviluppati nella cultura tedesca sotto l’impronta di Aloys<br />
Fischer negli anni Venti, seguono gli studi di Herman Röhrs che procedono dalla convinzione che<br />
la scienza dell’educazione mostri una naturale apertura alla fenomenologia.<br />
Molti dei temi sviluppati successivamente sono già presenti nella Pedagogia descrittiva di Fischer,<br />
che intende procedere da una descrizione fenomenologica dell’evento educativo, respingendo le<br />
teorie pre-formulate e le opinioni nate da giudizi infondati, per evidenziare la struttura<br />
fondamentale di quella realtà stessa che è l’evento educativo, disdegnando ogni soggettivismo<br />
irrazionalistico, e perseguendo una scientificità fenomenologica volta a superare il riduzionismo<br />
positivistico per una comprensione essenziale e obiettiva, senza escludere il soggetto del<br />
comprendere.<br />
Questa tematica volta alla descrizione del fenomeno educativo è sviluppata nell’ambito<br />
dell’epistemologia pedagogica tedesca. Rudolf Lochner riprende il tema del recupero della<br />
15
soggettività, a fronte di un predominio dell’oggettivismo positivista. Ma è soprattutto l’opera di<br />
Martin J. Langeveld che riveste particolare rilevanza epistemologica segnalando il rischio, per una<br />
pedagogia che voglia liberarsi della componente filosofica, di una nuova dipendenza dalle scienze<br />
matematico- naturalistiche.<br />
Più attenti ai temi dell’esistenza sono Otto Friedrich Bollnow, che fornisce un importante contributo<br />
affinché la pedagogia si orienti verso la prospettiva della filosofia esistenzialista, e Karl Renner,<br />
che descrive le correnti della pedagogia esistenziale in Germania, individuando alcuni temi<br />
significativi, incentrati soprattutto sugli aspetti educativi del pensiero di Jaspers e Heidegger.<br />
Il tratto comunque di questa pedagogia filosofica esistenzialista è quello di cercare di aprire lo<br />
sguardo sul soggetto umano in quanto esistente, con particolare riferimento ai temi della decisione,<br />
della responsabilità, della chiamata, della corrispondenza empatica. Sempre in area tedesca si<br />
segnalano Käte Meyer-Drawe e Wilfried Lippitz che approfondiscono le tematiche del mondo della<br />
vita come orizzonte originario di ogni esperienza educativa, in quanto è il mondo entro cui<br />
collocare il senso dell’esperienza della quotidianità e dell’informale nell’educazione.<br />
Anche in area nordamericana sono sviluppati i temi dell’autenticità esistenziale, della libertà e<br />
autorità, con particolare attenzione alla realtà educativa scolastica. Questi elementi erano già<br />
presenti nell’opera originale di Kneller pubblicata a New York (1958), dove si propone il valore<br />
educativo dell’esistenzialismo contro il pragmatismo e lo sperimentalismo che dimenticano<br />
l’individuo- soggetto per disperderlo nell’anonimato.<br />
Oggi gli esponenti più noti sono il canadese Maz van Manen, che affronta i temi dell’esperienza<br />
vissuta, del tempo e dello spazio vissuti, dell’intenzionalità e del mondo della vita, e lo statunitense<br />
Clark E. Moustakas che approfondisce gli aspetti metodologici della ricerca empirica con<br />
metodiche di derivazione fenomenologica applicate ai temi della scuola e dell’insegnamento e<br />
dell’apprendimento scolastico.<br />
Per quanto riguarda l’area italiana, occorre segnalare che, in un lontano saggio del 1947, Luigi<br />
Stefanini già indicava nella pedagogia esistenzialista la direzione di un lavoro che avrebbe già<br />
dovuto essere compiuto dai pedagogisti per scardinare gli schematismi e liberare la possibilità<br />
dell’automanifestazione umana come un venire dell’essere a se stessi.<br />
La pedagogia dell’esistenzialismo diviene poi oggetto di un saggio di Flores d’Arcais che affronta in<br />
modo originale le questioni connesse alla responsabilità, alla temporalità, alla finitezza, alla libertà<br />
come condizione per l’educazione al rischio. Anche il problematicismo di Giovanni Maria Bertin è<br />
debitore, per molti aspetti, ai filosofi esistenzialisti laddove egli propone l’istanza di un’educazione<br />
alla ragione in senso critico e problematico.<br />
Ma una più consistente ripresa della prospettiva fenomenologico- esistenziale si ha, sul finire degli<br />
anni Ottanta, con Piero Bertolini e gli autori di Encyclopaideia, collana editoriale e rivista di<br />
pedagogia fenomenologica. Bertolini, che già dagli anni Cinquanta aveva orientato i suoi studi in<br />
senso fenomenologico, propone una scienza eidetica dell’educazione ispirata ai temi husserliani<br />
16
dell’intenzionalità e dell’Einfühlung; egli individua e sviluppa le direzioni intenzionali originarie<br />
dell’esperienza educativa: sistematicità, relazione, possibilità, irreversibilità, socialità.<br />
Altre recenti ricerche prodotte in questa prospettiva hanno messo in luce argomenti e percorsi<br />
significativi che saranno indicati nelle <strong>pag</strong>ine seguenti. I temi che verranno illustrati saranno infatti<br />
sottesi da questo sfondo di questioni e propriamente dai nodi dove si connettono gli interrogativi<br />
pedagogici verso l’istanza di una scientificità che intenda inoltrarsi nei sentieri dell’esistere.<br />
Occorre tuttavia ribadire che il pensiero sull’educazione si mantiene all’interno di un discorso<br />
pedagogico, in quanto, pur essendo per molti aspetti debitore alla filosofia, è da una prospettiva<br />
originaria certamente pedagogica che interroga la filosofia.<br />
La pedagogia fenomenologica non è quindi una semplice trasposizione dall’ambito filosofico a<br />
quello pedagogico di categorie e concetti adatti alle questioni dell’educare.<br />
L’orientamento fenomenologico- esistenziale deve essere inteso come un ambito di riferimento a<br />
cui la pedagogia può attingere strumenti da elaborare e sviluppare secondo il proprio punto di<br />
vista.<br />
L’Erlebnis e l’empatia nel non essere educativo<br />
La scientificità fenomenologica consegna innanzitutto alla pedagogia la responsabilità di<br />
recuperare la soggettività nella scienza pedagogica e nell’agire formativo. Si tratta di un obiettivo<br />
complesso, poiché la svalutazione della soggettività affonda le sue radici nel forte<br />
condizionamento cartesiano che ancora domina la concezione di scientificità: “oggettivo” è<br />
generalmente ritenuto sinonimo di scientifico, mentre “soggettivo” richiama l’opinabile e l’incerto.<br />
Per la pedagogia questo recupero costituisce una difficoltà tanto maggiore quanto più la<br />
costruzione di una scientificità pedagogica è avvenuta all’insegna di un rafforzamento della<br />
dimensione oggettiva.<br />
Il pedagogista più importante nell’ambito dell’orientamento fenomenologico, Langelved, si oppone<br />
a quel ritorno al positivismo che ha contribuito a generare modelli di riflessione e di lavoro propri<br />
delle scienze naturali, con la relativa metodologia di ricerca.<br />
Occorre quindi interrogarsi sulla possibilità di una pedagogia capace di perseguire un significato<br />
per l’esistenza umana, e individuare l’orizzonte di senso per una nuova scientificità pedagogica<br />
che abbia al suo centro il soggetto umano.<br />
La fenomenologia ha messo radicalmente in discussione l’oggettivismo del paradigma cartesiano e<br />
la separazione- contrapposizione tra il soggetto e l’oggetto (res cogitans e res extensa). Non è, sul<br />
piano fenomenologico, ingannevole la conoscenza soggettiva, poiché non riveste il carattere di un<br />
soggettivismo irrazionalistico, incomunicabile e non verificabile. Il tale prospettiva il termine<br />
oggettivo assume un’accezione diversa da quella ereditata da Cartesio e radicalizzata nel<br />
positivismo: oggettivo è ciò che ha validità universale non in quanto fondato sulla realtà oggettuale<br />
esterna al soggetto, ma in quanto evidente, comprensibile e comunicabile tra soggetti. La<br />
17
verificabilità è nel senso e il senso non è soggettivistico ma oggettivo. Questa verificabilità<br />
intersoggettiva è resa possibile dalla comune appartenenza allo stesso mondo della vita<br />
(Lebenswelt).<br />
Il recupero della soggettività alla scienza rappresenta una svolta decisiva nell’ambito delle scienze<br />
della formazione dove il soggetto umano è al tempo stesso soggetto ed oggetto di conoscenza.<br />
In una simile prospettiva è necessario segnalare due strumenti metodologici che la fenomenologia<br />
offre per una conoscenza non oggettivante: l’epoché e l’Erlebnis.<br />
L’epoché<br />
Tramite l’epochè è possibile lasciar emergere i contenuti della coscienza così come si manifestano<br />
nell’immediatezza dell’intuizione delle essenze, e quindi conoscere intuitivamente la realtà<br />
formativa. L’epochè consente un’interpretazione che si mantiene nell’apertura a cogliere la vita con<br />
la vita, senza ricondurla agli schemi precostituiti, secondo il dettame scientista che persuade a<br />
ritenere che la teoria sia la vita. Dunque è possibile concepire una teoria pedagogica libera<br />
dall’eccesso di teorizzazioni precostituite sui modelli delle scienze naturali e formali, praticare<br />
quello sguardo che conduce alla formazione stessa, vedendola per ciò che è. Gli elementi<br />
segmentati e classificati del processo formativo diventano significativi in quanto assunti all’interno<br />
di un processo esistenzialmente dotato di senso.<br />
La messa in parentesi riguarda tanto i dati scientifici quanto le opinioni correnti. I primi sono costituiti dai<br />
pre-giudizi accreditati, dal sapere pedagogico fondato sulle certezze acquisite, dagli stereotipi scientifici che<br />
ostacolano l’autentico disvelarsi della realtà educativa. Dall’altro lato, occorre mettere in parentesi le<br />
opinioni banali, le credenze diffuse ed i luoghi comuni che derivano dall’interpretazione media del Si<br />
impersonale. Epochizzare non significa eliminare ma mettere sullo sfondo: tutte queste realtà restano, ma il<br />
pedagogista fenomenologo non ne fa alcun uso, pur non ignorandole.<br />
Il vissuto esperienziale<br />
Dopo aver liberato, attraverso l’epoché, una possibilità di conoscenza autentica, occorre<br />
individuare la via per cogliere la realtà stessa che rimane. Fin dalle prime righe della sua opera<br />
sull’empatia, Edith Stein scrive che “ciò che non posso mettere fuori circuito, ciò che è fuori di<br />
dubbio, è la mia esperienza vissuta”.<br />
Ebbene, la visione originaria, intuitivo- categoriale che consente di vedere con l’immediatezza il<br />
fenomeno nella sua essenza è resa possibile attraverso l’Erlebnis (l’esperienza vissuta). Il vissuto<br />
esperienziale dischiude una rinnovata attenzione al dire e al vedere l’evento educativo stesso.<br />
L’Erlebnis assume validità oggettiva dall’evidenza, in quanto è esperienza vissuta, mia, ma anche<br />
condivisa, aperta in una continua esperienza del mondo da cui trae origine e delle relazioni con gli<br />
altri soggetti che condividono con me il mondo comune della vita. L’esperienza, nel suo significato<br />
di vissuto, è soggettiva ma presente n me con caratteri oggettivi, perché è intersoggettiva, esperita<br />
in comune con altri soggetti.<br />
18
Il vissuto esperienziale apre alla conoscenza dei concetti cardine per la pedagogia: tempo vissuto,<br />
spazio vissuto, corpo vissuto. Il rapporto educativo, come rapporto di reciprocità, incontro fra<br />
“alterità”, si significa sempre da uno spazio, un tempo, un essere corpo, un collocarsi nella storia:<br />
risultano pertanto pedagogicamente determinanti le forme di spazialità, temporalità, corporeità.<br />
Il metodo fenomenologico, accanto all’esperienza razionale empirico- verificativa, attribuisce al<br />
vissuto esperienziale soggettivo un ruolo di prioritaria importanza. È opportuno segnalare che il<br />
termine Erleben ha il significato di vivere, di sentire, ma anche di vedere: ritorna dunque quel ruolo<br />
dello sguardo che appare un motivo ricorrente nella fenomenologia. Ma l’Erlebnis è collegato<br />
anche al concetto di esistenza, condividendo la radice leben, e rinviando perciò al concetto di<br />
Lebenswelt (mondo della vita), che è esperito nel proprio percorso esistenziale come mondo<br />
dell’evidenza originaria. Il mondo della vita è anche il mondo relazionistico dove confluiscono e si<br />
incontrano la conoscenza di sé e la conoscenza degli altri.<br />
Mettendo in parentesi, sullo sfondo, i dati di fatto misurabili oggettivamente, è possibile rivolgersi al<br />
mondo delle essenze che si rendono conoscibili nel vissuto intenzionale della coscienza attraverso<br />
quel “vedere con immediatezza” che rappresenta il fulcro della visione originaria dell’Erlebnis<br />
educativo.<br />
Tramite la coscienza intenzionale, flusso di esperienze vissute, l’esperienza esterna e oggettiva<br />
del mondo risuona nell’autoriflessione soggettiva, strumento conoscitivo fondamentale per<br />
comprendere i fenomeni umani senza ridurli a spiegazioni derivate da nessi estrinseci e<br />
precostituiti di causa- effetto.<br />
L’Erlebnis è quindi uno strumento scientifico idoneo non solo per l’interpretazione delle relazioni<br />
che sostanziano i processi formativi, ma anche per indicare un orientamento a stare<br />
nell’esperienza relazionale formativa con la vita.<br />
I vissuti vengono così sottratti all’ambito soggettivistico e incomunicabile e sono riconosciuti come<br />
validi procedimenti scientifici.<br />
L’Erlebnis costituisce un decisivo superamento della contrapposizione soggetto/oggetto,<br />
prefigurando una pedagogia che riflette sul suo senso, ma è anche sempre compromessa nella<br />
pratica educativa. Ne consegue un modo originale di intendere sul piano teorico un rapporto<br />
formativo, in quanto si determina una comprensione profonda che si colloca sul piano dell’umana<br />
esistenza e precede ogni tecnica di intervento. Il formatore ed il destinatario dell’intenzionalità<br />
formativa si riconoscono e si comprendono, prima di ogni altra determinazione di ruoli e<br />
competenze, come umane esistenze che si incontrano nella relazione. Su tale base è possibile<br />
arginare il prevalere dei ruoli nel rapporto, le contrapposizioni rigide tra le maschere dell’io<br />
pubblico, deporre le difese per assumersi nella reciprocità di persone, tacitare il rumore delle<br />
parole illusorie, per costruire insieme un’autentica comunicazione.<br />
19
In particolare questa comunicazione educativa sottrae gli uni e gli altri alle barriere erette sulle<br />
differenze delle asimmetrie relazionali tra chi insegna, guida, istruisce, orienta, cura e chi<br />
apprende, è accom<strong>pag</strong>nato, orientato.<br />
Einfühlung<br />
La formazione si fonda su una relazione di “communio” indicata da Binswanger come la condizione<br />
di un incontro nella “noità” che supera la contrapposizione io/tu. La “communio” può assumere la<br />
forma del “modus amicitiae” o del “modus amoris”, sempre sostenute da quella fiducia che<br />
consente di fidarsi l’uno dell’altro.<br />
Nel recupero di sé verso possibilità esistenziali, nella ricerca di senso originata dal “poter essere<br />
insieme” in una situazione di interpersonalità in cui è consentito deporre le maschere del Si ed<br />
essere autenticamente se stessi, un requisito indispensabile, e di grande rilevanza pedagogica, è<br />
l’Einfuhlung, tradotto come empatia, o più propriamente, entropatia, che consente di conoscere i<br />
vissuti esperienziali altrui, presenti in me attraverso il rapporto con l’altro, nel mondo dell’esistenza<br />
comune.<br />
L’empatia, secondo quanto scrive Edith Stein, “è infatti un atto che è originario in quanto vissuto<br />
presente, mentre è non originario per il suo contenuto. E tale contenuto è un vissuto che come<br />
tale può attuarsi in molteplici modi, come avviene nella forma del ricordo, dell’attesa, della<br />
fantasia”.<br />
Mentre vivo la gioia di un altro, io non provo alcuna gioia originariamente mia, e non è neppure una<br />
gioia ricordata o fantasticata; quella gioia “non originaria” si annuncia in me e si manifesta nella<br />
mia esperienza vissuta attraverso la quale posso cogliere un altro io attraverso un atto di<br />
conoscenza sui generis. L’empatia non è quindi una sensazione o un sentimento, o una proiezione<br />
di sé, ma un atto concreto attraverso cui è possibile cogliere il vissuto estraneo.<br />
È quindi una componente essenziale del lavoro formativo, perché è un’espressione di quel<br />
ragionamento del cuore che rende possibile la comprensione del vissuto dell’altro: mentre<br />
empatizziamo, arricchiamo il nostro sentire e “noi” avvertiamo ora una gioia diversa da quella<br />
avvertita singolarmente dall’ “Io”, dal “Tu” e da “Lui”.<br />
Empatizzare significa stare in prossimità dell’altro, anche se con un vissuto non originario delle<br />
emozioni: l’Einfuhlung è superamento dell’atteggiamento oggettivante, si espone però al rischio di<br />
un’immedesimazione unilaterale nell’altro, affidata al solo soggetto, in cui l’alter è assorbito<br />
nell’ego. In realtà il dolore dell’altro non diventa mio, poiché in tal caso si avrebbe unipatia, ma in<br />
questa prossimità nella distinzione consente di trovare insieme a lui una risposta. Né l’empatia è<br />
da intendersi some una molteplicità di individui psicofisici, ma come quell’esperienza non originaria<br />
che si può tuttavia conoscere dall’interno attraverso un processo di immedesimazione nella<br />
situazione dell’altro.<br />
L’Einfuhulun diviene strumento su cui si fonda l’intersoggettività nella formazione: le esperienze<br />
degli altri possono essere conosciute anche da me (pur rimanendo originariamente esperienze<br />
20
altrui) attraverso i vissuti, i sentimenti, le percezioni che sostanziano in modo del tutto particolare e<br />
specifico il rapporto educativo.<br />
L’empatia consente di affacciarsi sull’esistenza dell’altro e sui suoi vissuti. Ma questo affacciarsi<br />
non è retto dalla curiosità, dalla manipolazione, da un atteggiamento utilizzante, inquisitorio, bensì<br />
dall’ascolto nella comprensione che rispetta l’alterità nella sua originaria differenza.<br />
I processi formativi, nei sentieri dell’esistere, traggono senso dall’incontro con l’esistere dell’altro.<br />
In ogni percorso esistenziale l’altro è indispensabile: l’esistenza umana è, nella sua essenza,<br />
sempre relazionistica.<br />
Il processo formativo, in quanto relazione intersoggettiva vissuta e agita sullo sfondo del mondo<br />
comune, è una specifica modalità di essere nel mondo, che è la costituzione fondamentale<br />
dell’Esserci, ha il carattere esistenziale del “con” ed è sempre un “essere con gli altri”.<br />
È da questa coappartenenza al concreo con-mondo dell’esistenza comune che è innanzitutto<br />
possibile comprendere la relazione che si sperimenta nei processi formativi.<br />
Essere per l’educazione<br />
Sulla scorta dell’intenzionalità è possibile individuare un esistenziale strutturale che dà senso al<br />
rapporto educativo e all’interpretazione pedagogica: l’essere per l’educazione. La formazione può<br />
darsi (essere realizzata nelle concrete forme dell’esistere) e dirsi (con parole della pedagogia e<br />
delle scienze della formazione) solo in virtù di questa peculiarità esistenziale a priori e inesauribile:<br />
ogni essere umano è per l’educazione.<br />
Martinus Langelved afferma che l’essere umano, in quanto animal educandum, è fatto apposta per<br />
essere educato, è addirittura destinato ad essere educato. Ma, aggiunge, “l’educazione è qualcosa<br />
di più del semplice coesistere e cooperare, ha bisogno, come conditio sine qua non, di qualcuno<br />
che non voglia soltanto vivere, ma vivere come essere speciale che io sono; pertanto che l’uomo<br />
sia un essere che educa, viene educato, e deve ricorrere all’educazione, è una delle caratteristiche<br />
fondamentali della figura umana. È evidente che proprio la pedagogia debba ricercare in questo<br />
fenomeno il suo punto di partenza.<br />
L’educabilità è una dimensione dell’umano indicata da tutti i pedagogisti. Utilizzando l’espressione<br />
“essere per l’educazione” si intende sottolineare non solo una qualità semplicemente connaturata<br />
all’essere umano, quanto anche un atto di responsabilità e di scelta.<br />
Nell’essere umano esiste la possibilità di formarsi e di formare, ma è soltanto quando questa<br />
possibilità diventa scelta, quando la persona decide per questa sua possibilità, che si ha autentica<br />
Bildung. L’essere per l’educazione non è quindi possesso passivo di una potenzialità che può o<br />
meno essere tradotta in atto, ma è un perenne porsi attivamente nell’essere per questa possibilità.<br />
Nei diversi modi e possibilità, per l’Esserci, di trascendersi nel mondo attraverso un progetto, la<br />
possibilità formativa rischiara e rende possibile la progettazione esistenziale.<br />
21
Attraverso la decisione e la scelta, ascolto l’appello che viene dall’Altro e mi predispongo alla<br />
risposta. Quest’appello attraverso cui l’Altro mi interpella ha il significato di richiamo al comune<br />
tragitto per attuare la trascendenza della condizione di impersonalità verso il proprio poter essere<br />
autentico, dove il Si impersonale non sottragga la persona alla propria autenticità.<br />
Binswanger osserva che la progressiva mondanizzazione dell’esistenza conduce la persona<br />
umana a rinnegare sé stessa come autentica possibilità di sé, e quindi a cadere e ad essere<br />
consegnata ad un determinato progetto di mondo.<br />
La prospettiva che abbiamo definito “essere per l’educazione” è espressione di questa tensione<br />
verso ciò che ogni soggetto umano non è ancora, ma può diventare: sono gli orizzonti di quella<br />
libertà per l’educazione che sottende la possibilità dello scegliersi per l’educazione nell’incessante<br />
scegliersi per la vita.<br />
Nella struttura fondamentale dell’essere per l’educazione sono presenti sia l’effettualità del dato,<br />
sia la possibilità di trascenderlo. I processi formativi sono sempre limitati dai precondizionamenti<br />
dell’essere “così” e non altrimenti, ma sono anche sempre aperti alla possibilità di realizzazione dei<br />
sentieri esistenziali, ossia di scegliere e scegliersi per un progetto di sé che si espande nel mondo,<br />
con gli altri.<br />
Ciò significa che è sempre possibile, ed è anzi fondamentale compito formativo, individuare in<br />
qualunque situazione una possibilità di pro-iezione nella libertà per un progetto.<br />
Nella prassi quotidiana, spesso agita nelle penombre dove si accom<strong>pag</strong>nano i percorsi esistenziali<br />
dei soggetti più fragili (bambini, anziani, diversamente abili, malati poveri), occorre dare rilievo al<br />
lavoro di molti educatori che quotidianamente non rinunciano a scoprire in queste persone la<br />
condivisione esistenziale che accomuna, anche al di sotto di ogni apparenza contraria.<br />
Chi resta intrappolato negli ingranaggi della routine rinuncia invece, talora troppo presto, davanti a<br />
situazioni d apparente irrecuperabilità educativa, a cercare, nelle persone con cui si rapporta,<br />
quella matrice esistenziale che, pur ricoperta da diverse sovrastrutture, rivela il tratto umano<br />
dell’essere per l’educazione. Questa rinuncia educativa è generata da una visione pedagogica<br />
oggettivante e priva di risposte di senso.<br />
Guidati dall’Einfuhlung, dall’amore (in senso esistenziale) o dalla Cura, gli educatori potranno<br />
gettare uno sguardo privo di pregiudizi sulla realtà che li coinvolge e saranno in grado così di<br />
vedere davanti a sé un’esistenza umana, libera da tutto ciò che il sapere precedente aveva<br />
costruito su di essa. E in questa esperienza formativa l’educatore che si attiene al criterio<br />
pedagogico dell’essere per l’educazione, può far emergere il progetto esistenziale, proprio in<br />
quanto rifiuto dell’oggettivazione dell’altro e dell’allontanamento da “se stesso”.<br />
L’intenzionalità educativa è l’elemento che trasforma “l’essere assieme” dall’ “essere l’uno accanto<br />
all’altro” in un incontro, rendendo possibile un’autentica reciprocità. Non si ha percorso formativo<br />
quando gli educatori non investono intenzionalità esistenziale, non si aprono all’incontro con<br />
l’esistenza dell’altro. In questo caso essi si mantengono sempre accanto agli altri, ma non sono<br />
22
con gli altri. L’oggettivazione, il plagio, la coercizione sono rischi sempre presenti nel “prendersi<br />
cura incurante” heideggeriano, in quell’indifferenza che si esprime nei modi di essere l’uno con<br />
l’altro senza essere per nulla toccati dall’altro.<br />
Il daisen , l’Umano Esserci, problema centrale della filosofia heideggeriana, è sempre un<br />
Mitdasein, un con-esserci. Nell’avvertimento della nostra presenza nel mondo scorgiamo altre<br />
presenze; un mondo comune ci accoglie. Qualunque progetto che ci riguardi ha origine dal mondo<br />
e si incontra con altre presenze esistenti in un’esperienza di esistenza comune.<br />
È quindi possibile comprendere la relazione intersoggettiva autenticamente pedagogica se si<br />
rapporta l’intersoggettività al progetto di sé, al bisogno di essere sé stessi e progettuarsi per le<br />
proprie possibilità.<br />
Ma ogni progetto formativo è sostenuto dall’alterità: non ci si forma senza l’esempio o l’aiuto o<br />
l’attenzione di un altro. Nello stesso tempo è innegabile che ogni percorso formativo è vissuto da<br />
un soggetto nella sua singolarità. Queste due dimensioni non sono separabili in quanto non esiste<br />
un processo formativo che avvenga esclusivamente nella soggettività né, al contrario,<br />
esclusivamente nella relazione. La formazione si qualifica piuttosto come un pendolo, un<br />
movimento incessante dal sé al mondo degli altri e dagli altri al sé.<br />
Nella tensione verso il proprio progetto di mondo ognuno compie un cammino assolutamente<br />
individuale, nel senso che nessuno può compierlo al posto di un altro, né è auspicabile che<br />
l’educatore convinca i soggetti con cui entra in relazione ad aderire al suo progetto. Egli dovrà<br />
invece cercare di far emergere il progetto di sé che è presente in ognuno, affinché possa<br />
perseguire la sua piena umanità indicata con il concetto di Paideia.<br />
La verificabilità del percorso non sarà quindi affidata a strumenti quantificanti e classificatori, che<br />
potrebbero ridurre a oggetti le persone cui è destinata l’azione formativa: oggetti che possono<br />
essere manipolati e persino messi da parte, ai margini della società e della cultura, qualora non<br />
rispondano a determinate richieste.<br />
Il MitDaisen è una condizione esistenziale costitutiva che deve però essere sempre realizzata,<br />
voluta, scelta, cercata, assunta in prima persona da entrambi i soggetti coinvolti nel processo<br />
formativo.<br />
La riuscita potrà essere verificata a partire dall’esistenza stessa, cioè dal comune movimento, dal<br />
tragitto esistenziale in cui l’educatore entra con tutto sé stesso nel rapporto, sperimentando fino al<br />
limite della problematicità e della precarietà, mantenendosi aperto a sconvolgere le proprie<br />
certezze, senza trincerarsi dietro un ruolo, una tecnica, un programma. Solo per questa via<br />
l’educando potrà a sua volta scoprirsi coinvolto nel con-esserci e provare fiducia nella disponibilità<br />
dell’educatore, sperimentando la gioia di apprendere, di crescere, di esistere. Di conseguenza<br />
l’essere in un mondo comune acquisterà, nel percorso formativo, una nuova intensità espressiva e<br />
nuova ampiezza spazio/temporale, oltre il tempo e il luogo deputato all’incontro formativo.<br />
23
I modi e le tecniche: esigenza di senso<br />
In un’area scientifica volta alla prassi è di importanza decisiva esplicitare come debba essere<br />
intesa la tecnica. La questione degli strumenti, delle competenze e delle abilità messe in opera<br />
rivela e, al tempo stesso, dispone l’azione intenzionale. La fenomenologia e gli esistenzialismi<br />
offrono più di uno spunto per un’epistemologia pedagogica che includa i criteri di un rinnovato<br />
modo di concepire e usare la tecnica nel non-essere formativo, in una prospettiva non<br />
oggettivante. Secondo Gadamer infatti l’interpretazione dell’altro e delle sue manifestazioni è<br />
qualcosa di alquanto specifico e originale che chiama in causa l’indagante con tutta la sua<br />
persona. E ogni comprensione dell’altro chiama in campo anche la comprensione di se stessi.<br />
L’azione formativa ha lo scopo di favorire il dis-velamento di quel progetto esistenziale che ancora<br />
non si è manifestato e non si può manifestare da se stesso, senza una tecnica che lo favorisca.<br />
La tecnica, intesa come l’insieme degli strumenti atti a formare nel senso di “dare forma”, include<br />
sempre il rischio di trasformarsi in strumento di manipolazione e di estromettere dalle modalità del<br />
rapporto educativo la naturalezza di base dell’essere con l’altro.<br />
Un concetto decisivo, nel parlare di tecniche atte a formare, è quello di dis-velamento nel senso<br />
della alètheia. La tecnica ha il ruolo principale di portare alla luce il progetto esistenziale che era<br />
nascosto, sollevare il velo, rivelare il soggetto in formazione per il proprio poter essere.<br />
Questo agire tecnico richiama il significato del fare artistico e artigianale, che non può prescindere<br />
dalla conoscenza dei principi e dei metodi. Per Heidegger “il conoscere da apertura; in quanto<br />
aprente esso è disvelamento”. Egli richiama il significato etimologico della tecnica che non<br />
appartiene solo al fare artigianale, ma anche alle arti superiori, alla poiesis, alla produzione<br />
artistica: “l’elemento decisivo della techne non sta perciò nel fare e nel maneggiare, nella messa in<br />
opera di mezzi, ma nel disvelamento menzionato. In quanto tale, non però intesa come<br />
fabbricazione, la techne è produrre.”<br />
La tecnica è quindi necessaria e non deve assolutamente essere svilita o disdegnata; ma a<br />
condizione di intenderla sempre come mezzo che apre e disvela. Quando invece essa sia intesa in<br />
modo preminente, assuma un modello di interazione fisso e predefinito, allora diventa il fine.<br />
La tecnica si configura dunque come mediazione delicata e indispensabile. Il tecnicismo invece si<br />
frappone, anziché come mezzo d’incontro e avvicinamento, come allontanamento e presa di<br />
distanza, divenendo ostacolo all’azione formativa e prendendo il posto dell’umano con-essere.<br />
Il formatore che si affidi più alle metodiche oggettivanti che all’esistenza umana potrà far nascere<br />
soltanto risposte ritualizzate, fissate dalla codificazione, dalla standardizzazione, perdendo<br />
l’accesso alla singolarità unica e irripetibile di ogni incontro formativo, poiché non resta da<br />
disvelare nulla.<br />
La tecnica può e deve quindi variare a seconda della situazione, le metodiche oggettivanti<br />
finiscono per adattare la situazione alla tecnica che si intende applicare, anche se non si tratta<br />
della più idonea a quella persona, a quel momento, a quella situazione. La subordinazione della<br />
24
persona alla tecnica nasce dall’assunzione acritica delle competenze operative e finisce molte<br />
volte per far perdere di vista il “chi” della formazione, la persona a cui una tecnica estranea è<br />
destinata.<br />
La questione diventa allora quella di individuare quali siano le tecniche che possano essere adatte<br />
alla situazione. Ed è necessario, per fare questo, spostare l’attenzione dal procedimento, dal<br />
modello, dal curriculum, dal formale, al senso del rapporto fra tecniche e persone umane.<br />
Innanzitutto occorre saper valutare la situazione, cioè i soggetti destinatari, il contesto, se stessi e<br />
se stessi in relazione. Secondariamente occorre saper scegliere la tecnica più adatta, con la<br />
consapevolezza del rischio di sbagliare. La scelta presuppone poi che si conoscano e si<br />
padroneggino più tecniche, per poter correttamente scegliere, senza la supponenza di chi,<br />
possedendo pochi strumenti, li utilizza in ogni situazione, e senza la faciloneria di chi utilizza<br />
dilettantescamente qualsiasi tecnica, anche se posseduta superficialmente. Infine occorre<br />
problematizzare continuamente la scelta iniziale ed essere in grado anche di modificarla in itinere<br />
qualora si dimostri inadeguata.<br />
Avvalersi di tecniche e tecnologie in modo non coercitivo e non violento, rispettoso della<br />
soggettività e del poter essere, significa aprirsi alla possibilità che l’azione formativa possa ri-uscire<br />
secondo più di un risultato.<br />
Il formatore che si attenga ai codici prefissati è costretto a minimizzare o ignorare tutti gli aspetti<br />
che non rientrano nello stupore (in senso fenomenologico), ovvero tutti gli elementi non conformi<br />
agli schemi pre costituiti; egli dovrà trovare strategie per far rientrare l’imprevisto nelle griglie<br />
interpretative del previsto. Chi opera nella formazione sa bene che le situazioni impreviste si<br />
incontrano spesso, e sono tanto più spiazzanti quanto più l’operatore si affida soltanto a questa o<br />
quella tecnica ed è invece povero di quella competenza esistenziale che apre anche alla<br />
consapevolezza del turbamento, del trovarsi a mani vuote davanti al fallimento e all’errore.<br />
Risvegliare interrogativi di senso, problematizzare, aprire spiragli di progettazione esistenziale<br />
sono atti essenziali per ogni autentico percorso formativo che non può ignorare l’imprevedibile.<br />
L’imprevisto non è un ostacolo, un incidente, un elemento di disturbo o il frutto di un errore come<br />
potrebbe essere giudicato in una logica rigidamente programmatoria. Ogni formatore che proceda<br />
in modo non dogmatico sa quanto sia importante aspettarsi qualcosa di inaspettato, e quanto sia<br />
necessario essere in grado di suscitare l’imprevisto, attivando quella competenza artistica in grado<br />
di risolvere situazioni di stallo.<br />
Se si pretende di prevedere tutto, l’evento imprevisto crea sconcerto, mette in difficoltà, costringe a<br />
mettere in crisi e rivedere tutte le tecniche programmate. Ma propriamente questo è il valore<br />
positivo dell’inatteso: spingere e concepire e praticare una nuova tecnica quando le situazioni, i<br />
saperi e le tecniche precedentemente elaborate si rivelano insufficienti o inadeguati.<br />
Il senso dell’artisticità, dell’inventiva, della creatività e persino della trovata del formatore richiede<br />
molta competenza, intuizione e abilità per trovare in sé le risorse adeguate a far fronte all’inatteso,<br />
25
e per inventare risposte efficaci. La trovata o “ispirazione”, come la definisce Binswanger, richiede<br />
la capacità di epochizzare tutte le tecniche apprese. Le trovate non sono da confondersi con<br />
l’estemporaneità, poiché derivano da un duro e paziente lavoro, una lunga esperienza e una<br />
pratica riflessiva sul lavoro formativo.<br />
Il valore dell’improvvisazione è importante della formazione e non significa occasionalità dovuta a<br />
impreparazione.<br />
Il formatore e l’educatore sanno che un margine di capacità di improvvisare è necessario per non<br />
isterilire nella ripetizione del gesto formativo, nella sua imprenscindibile artisticità.<br />
26
I VISSUTI DELL’ESPERIENZA FORMATIVA<br />
Il Mit-Daisen (con esserci), è l’a priori di ogni esperienza formativa. Se concepita a prescindere da<br />
questo legame di esistenza comune, la formazione si espone ai rischi del disinteresse o della<br />
manipolazione e della coercizione. L’alterità diventa una presenza scontata, anonima e<br />
indifferente, relegata in uno spazio freddo e distante; può diventare persino “l’inferno”. (Sartre<br />
1965). Se lo sguardo non sa vederlo nella sua incessante novità, l’altro non è un testo da<br />
codificare, ma è il risaputo e lo scontato.<br />
Lo sguardo che si posa sul volto dell’altro lo coglie, secondo Lévinas, come volto nudo che si dà a<br />
noi, in modo estensivo, senza le mediazioni degli apparati pre-interpretanti. La presentazione del<br />
volto, l’espressione, chiama all’apertura, al decentramento della soggettività verso l’assolutamente<br />
Altro dell’esteriorità. In tal senso si ha l’unica possibilità di dire Io, poiché rispecchiandomi nel volto<br />
dell’Altro, rispondendo al suo sguardo, riconsegno la possibile ricomposizione della mia identità.<br />
L’umanizzazione del rapporto consente di recuperare la pienezza della paideia. La dis-<br />
umanizzazione, attraverso un’interpretazione deterministico-oggettivante, preclude la<br />
comprensione di qualsiasi progetto di autentico poter-essere.<br />
È necessario che gli operatori possano accom<strong>pag</strong>nare gli altri con discrezione nei percorsi<br />
esistenziali, senza sovrapporsi, salvaguardandone l’alterità e l’inalienabile diritto a non essere<br />
interpretati dal mero sapere catalogante che archivia le persone come cose.<br />
L’umanità della comunicazione educativa si rende comprensibile sulla base delle modalità<br />
dell’essere nel mondo e dell’umano con- esserci in quanto Cura. L’essere in una relazione di cura<br />
contraddistingue il modo di essere con gli altri “Esserci”, modo che è costitutivamente “Cura”.<br />
Come suggerisce Binswanger, riferendosi a Jaspers e Buber, la possibilità di un autentico rapporto<br />
interumano nei processi di formazione si fonda su un aspetto fondamentale della struttura<br />
dell’esistenza umana: l’essere con gli altri e l’essere per gli altri. Le diverse modalità relazionali<br />
della con- presenza si estrinsecano nei modi del “poter essere”, “avere il permesso di essere” e<br />
“essere costretto ad essere” entro cui si snodano i diversi vissuti emotivi che sostanziano la<br />
formazione: l’amore, l’aggressività, l’odio, il rancore, l’invidia, la confidenza, l’ammirazione, il<br />
timore, il disprezzo, l’indifferenza.<br />
Queste e molte altre tonalità emotive, compresa l’indifferenza, sono sempre presenti nell’esistenza<br />
in quanto aperta in una determinata situazione emotiva. L’Esserci esiste sempre emotivamente ed<br />
è sempre immerso in una determinata tonalità emotiva. Per questo la cura educativa non può<br />
prescindere dall’affettività che accom<strong>pag</strong>na il suo manifestarsi.<br />
28
La cura educativa<br />
Il concetto di epiméleia (cura, sollecitudine) è indicato da Platone nell’Apologia come il primo<br />
insegnamento di Socrate ai giovani: aver cura di sé e della propria anima, piuttosto che delle<br />
ricchezze e degli onori.<br />
Aver cura di sé significa aver cura della propria vita emotiva, dei propri pensieri e dei propri<br />
sentimenti, conoscere se stessi per conoscere gli altri, poiché la cura è l’essere dell’Esserci. Lì è<br />
dunque l’origine della formazione.<br />
Cura e formazione sono sempre intrecciate ma il legame è tutt’altro che privo di ambiguità, anzi è<br />
forse un incessante rimando alle rispettive ambiguità quello che lega le due esperienze di cura e<br />
formazione.<br />
La cura in quanto costitutiva dell’esistenza umana, abita le relazioni e conferisce senso all’essere<br />
nel mondo. La cura non può essere interrogata con i moduli raziocinanti; può essere ascoltata e<br />
vissuta nella relazione con se stessi e con gli altri. Il concetto di “aver cura”, inteso come<br />
dedizione, premura, sollecitudine, prendersi a cuore, si manifesta nel lavoro formativo in antitesi al<br />
disinteresse e all’indifferenza. Quando la routine disperde l’attenzione verso l’altro- persona nei<br />
gesti anonimi e nei comportamenti standardizzati rivolti all’altro- utente, si opacizza l’aver cura.<br />
Il noto mito di Cura, narrato da Igino, mostra il legame originario tra cura e formazione:<br />
“ Mentre Cura stava attraversando un fiume, vide del fango argilloso. Lo raccolse pensosa e<br />
cominciò a dargli forma. Ora, mentre stava riflettendo su ciò che aveva fatto, si avvicinò Giove.<br />
Cura gli chiese di dare lo spirito di vita a ciò che aveva fatto e Giove acconsentì volentieri. Ma<br />
quando Cura pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che<br />
fosse imposto il suo nome. Mentre Cura e Giove disputavano sul nome intervenne anche Terra,<br />
reclamando che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché essa, la terra, gli<br />
aveva dato parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice, il quale comunicò ai<br />
contendenti la seguente giusta decisione: “Tu Giove, che hai dato lo spirito, al momento della<br />
morte riceverai lo spirito. Tu Terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu Cura che<br />
per prima diede forma a questo essere, fin che esso vive lo possieda Cura. Per quanto conceda la<br />
controversia sul nome, si chiami homo poiché è stato tratto da humus”. (Higynus, Liber<br />
Fabularum).<br />
Cura “dà forma” al fango e, così facendo, gli conferisce dignità umana. La formazione (Bildung),<br />
per essere realizzata, ha bisogno di cura. Inoltre la creatura formata, che ha preso la forma dal<br />
fango argilloso, rimane presso Cura fin che vive: non c’è limite alla cura ed alla formazione, fino<br />
alla fine dell’esistenza.<br />
La Cura, come condizione originaria dell’essere al mondo dell’Esserci, si manifesta secondo due<br />
modalità: nel prendersi cura incurante rivolto agli oggetti e nell’aver cura rivolto agli altri esseri<br />
umani. La prima modalità è quella del possesso, dell’utilizzo, del commercio, della<br />
29
strumentalizzazione nella dimensione quotidiana inautentica, mentre l’aver cura risponde alla<br />
sollecitudine autentica dell’aver a cuore.<br />
La tutela dell’alterità presuppone un atteggiamento disinteressato e moralmente responsabile<br />
verso il diritto alla cura. La formazione autentica non giustifica la deresponsabilizzazione che<br />
relega chi è in formazione entro una posizione di dipendenza, ostacolando la pienezza del suo<br />
poter- essere, ma crea piuttosto le condizioni per favorire il diventare sé stessi, liberi di assumere<br />
la propria cura.<br />
In tal senso la cura rappresenta una dimensione pedagogica su cui fondare la formazione. Tutti gli<br />
altri enti, tranne l’essere umano, sono chiusi nella situazione intrascendibile, mentre la persona<br />
umana è aperta alla possibilità, alla trascendenza, al progetto. Ciò che rende possibile la<br />
realizzazione del poter- essere autentico è affidato principalmente alla Cura. La progettualità è nel<br />
tempo, in quanto è sempre aperta al futuro: cura e tempo sono indicati da Heidegger come<br />
costitutivamente collegati.<br />
In una prospettiva di Cura pedagogica il carattere ontologico della Cura, intesa come esistenziale<br />
fondamentale, indica l’essere sempre nell’oltrepassamento entro cui si schiude un mondo come<br />
pro- getto. Il poter essere è la condizione pedagogica che rimanda ai concetti correlati di progetto,<br />
possibilità, scelta, ed esprime cioè la possibilità di realizzare il proprio “aver da essere”<br />
nell’orizzonte esistenziale costitutivo della propria esperienza del prendersi cura.<br />
La formazione è un dare tempo all’esistenza altrui, prospettando una comune ricerca di senso che<br />
non esclude il coinvolgimento affettivo, l’accoglienza, la legittimazione della vita emotiva sempre<br />
messa in gioco nell’incontro formativo.<br />
L’assunzione della responsabilità nell’incontro presuppone quel rispetto dell’alterità che non varca<br />
il margine (sempre da ridefinire e preservare dal rischio della strumentalizzazione) tra la cura-<br />
sollecitudine e l’intromissione che prende il posto dell’altro. Anche il discorso sulla Cura chiama in<br />
causa il “vedere” e la responsabilità del formatore nel valutare, vagliare le possibilità che l’altro è in<br />
grado di affrontare, per accom<strong>pag</strong>narlo nel suo percorso di crescente autoconsapevolezza. Il<br />
formatore deve lasciar emergere l’altro, così come si offre al suo sguardo, ma anche aiutare lo<br />
sguardo di colui che è in formazione senza coartazioni, distorsioni, presbiopie o miopie che<br />
ostacolino una corretta e sostenibile visione.<br />
Lo sguardo pedagogico è orientato alla cura in quanto è pronto a cogliere quale sia il tempo di cui<br />
l’altro ha bisogno per trovare risposta all’appello a esistere. La cura formativa è protesa a favorire<br />
l’ascolto di sé per rispondere a questo appello. La risposta può essere favorita, facilitata, ma non<br />
pretesa o imposta.<br />
30
Il genere e la cura<br />
Il mito di Cura ci presenta una divinità femminile: il legame tra l’appartenenza al genere femminile<br />
e la cura è molto importante nei percorsi formativi e nelle attività del formare. Perciò ogni discorso<br />
sulla cura contiene, sullo sfondo, il tema della “differenza di genere”.<br />
La massiccia presenza femminile nelle professioni dove si svolgono mansioni appartenute alle<br />
donne (l’educazione, l’assistenza, la salute) esprime, da un lato, la vocazione femminile alla cura,<br />
dall’altro è fonte di fragilità sociale ed economica per queste professioni. Vi è infatti un indubbio<br />
valore aggiunto nelle competenze acquisite dalla millenaria attività femminile: capacità di ascolto,<br />
apertura all’altro, accoglienza, attenzione alle relazioni, ecc. Ma al tempo stesso le donne<br />
occupano ruoli subalterni ed esecutivi entro strutture e servizi governati generalmente da uomini.<br />
La cosiddetta gender segregation mantiene per il lavoro femminile di cura retribuzioni basse e<br />
carriere ostacolate, scarso riconoscimento sociale e diffusa invisibilità di quei servizi ritenuti la<br />
prosecuzione, fuori casa, di ciò che le donne hanno svolto, gratuitamente, per secoli in casa:<br />
educare, curare, aiutare, sostenere i soggetti deboli.<br />
L’attitudine a occuparsi dei bambini, degli anziani, dei malati è ancora ricondotta alla natura<br />
femminile e pertanto ritenuta espressione di un naturale istinto femminile: rispondere ai bisogni<br />
degli altri. Di questo sapere si avvale il lavoro sociale, pur senza che venga alla luce come<br />
patrimonio di pensiero. Il sapere femminile sulla cura viene ricondotto abitualmente solo alla sfera<br />
dell’intuizione, della sensibilità, di tutte quelle dimensioni antitetiche alla ratio.<br />
Competenze, abilità, risorse che le donne hanno potuto sviluppare nella loro secolare<br />
frequentazione della “Cura” si manifestano indubbiamente in una maggiore apertura al rapporto,<br />
all’ascolto, alla comunicazione, nella maggiore capacità di identificazione con l’altro, nell’attenzione<br />
alla concretezza.<br />
L’etica della cura esprime quella voce diversa e quel sapere eversivo della cura attraverso cui le<br />
donne, le madri, danno luogo alla connessione tra le generazioni, creando vita e conoscenza,<br />
assumendo una funzione molto più vasta di quella biologica: riprodurre l’umanità, proteggere,<br />
custodire e portare al suo sviluppo l’umanità vera.<br />
Le relazioni che si instaurano nella Cura sono la prima delle modalità di con- essere come essere-<br />
per. Nel “partecipare qualcosa a qualcuno” o nel “parteciparsi qualcosa l’uno con l’altro” si<br />
focalizza la qualificazione primaria dell’evento educativo: lo scambio di contenuti, gesti, parole,<br />
sentimenti e tutto ciò che ha a che vedere col comunicare.<br />
Pertanto l’Esserci, nel suo particolare modo di essere nel mondo, si presenta nella sua unicità e<br />
differenza, pur nella costitutiva coesistenza con i suoi simili.<br />
Centrati su se stessi si è incapaci di accogliere l’altro, di offrirgli del tempo per raccontarsi, di<br />
comunicargli messaggi di disponibilità. Poiché gli educatori sappiano assumersi il piacere e la<br />
responsabilità di essere tramite per la crescita esistenziale, occorrerà quindi accrescere e<br />
31
alimentare i valori della cultura di cura e di ascolto di ogni alterità. Questi valori sono risorsa etica,<br />
politica, professionale, culturale riconducibile al pensiero ed all’agire delle donne.<br />
L’esistenza è un prendere forma: ciò richiama al primario compito pedagogico che definisce la cura<br />
formativa come originaria qualificazione dell’esistenza.<br />
Emozioni e sentimenti<br />
L’Essere umano vive sempre in qualche stato emotivo. Ciò non significa che egli ne sia<br />
consapevole; al contrario, la negazione e la fuga da questa consapevolezza sono gli atteggiamenti<br />
più diffusi davanti al proprio sentire.<br />
Le radici esistenziali dell’essere nel mondo in quanto gettati sono sempre emotivamente<br />
connotate, noi siamo nel mondo sempre secondo una certa tonalità emotiva; tuttavia il “come” di<br />
queste tonalità emotive rimane, per il soggetto umano, generalmente misterioso, anche se<br />
cerchiamo di dominare con la volontà le nostre emozioni.<br />
Nell’interazione formativa, accanto a una comunicazione fondata sulla ratio, sullo scambio di<br />
messaggi dal contenuto logico e razionalmente comprensibile, vi è uno scambio di messaggi a<br />
livello emotivo, una comunicazione che segue una logica affettiva. I due piani non sono mai<br />
separabili, se non a prezzo di forzature astratte; e il confine tra questi due terreni comunicativi è<br />
assai indefinito e incerto, poiché i comportamenti cognitivi hanno quasi sempre una componente<br />
affettiva.<br />
Per una sana comunicazione è indispensabile non mascherare i sentimenti, accettare la presenza<br />
di ambiguità e incertezze, conoscere le proprie reazioni e imparare a riconoscere quelle altrui,<br />
parlarne, avere una sede interiore dove elaborare e lasciare decantare gli inevitabili accumuli<br />
emotivi. È questa una modalità essenziale del rapporto che si realizza nel reciproco parteciparsi<br />
sentimenti, oltre che informazioni.<br />
Le dimensioni emotive e affettive, indispensabili supporti nell’attività di cura educativa, sono state<br />
per molto tempo considerate un limite per la professionalità. Oggi è in atto una profonda revisione<br />
volta a valorizzare la portata delle risorse emotive nelle professioni, la capacità di attenzione agli<br />
altri e l’abilità relazionale.<br />
Aver cura della vita emotiva consente di accogliere la dimensione affettiva nella propria identità<br />
professionale, esprimere i sentimenti e assumerne la responsabilità, anziché tentare di negarli in<br />
nome della razionalità. Non si tratta certamente di cadere nella retorica dei buoni sentimenti, ma di<br />
accrescere la consapevolezza emotiva nell’ascoltare l’intelligenza del cuore come fonte di<br />
saggezza.<br />
Coltivare la vita emotiva significa attribuirle un ruolo attendibile per l’esistenza nel suo dispiegarsi<br />
fatto di conoscenza, di azione, di progettazione. Le tonalità emotive devono essere nominate,<br />
riconosciute, per sapere orientarsi nella formazione con quell’intelligenza del cuore che, con<br />
32
apparente ossimoro, cerca di rendere significativo l’inscindibile legame che lega la vita emotiva e<br />
vita intellettiva.<br />
Scrive Edith Stein che “il soggetto non vive solo degli oggetti, ma vive sé stesso e vive i sentimenti<br />
come provenienti dalla profondità del suo Io”. Questa disposizione ad ascoltare e lasciare<br />
emergere la vita profonda è resa sempre più rara dall’inautenticità dei rapporti interpersonali. I<br />
sentimenti ci coinvolgono nella finzione televisiva o filmica, mentre spesso la vita e i problemi<br />
dell’altro, vero e vicino, non ci coinvolgono. Il Si impersonale disperde e banalizza la dimensione<br />
emotiva dell’esistenza.<br />
Il Si inautentico che disperde i sentimenti, li “dice” per espropriarli della loro prorompente verità. Il<br />
diffuso analfabetismo emotivo e sentimentale si riverbera nell’esperienza formativa, tramutando il<br />
sentire in parola vuota, in chiacchiera. La banalizzazione della vita emotiva è data dalla diffusione<br />
attraverso la parola inautentica che parla dei sentimenti senza la preoccupazione di coglierli<br />
attraverso un atto di comprensione originaria ed essenziale. È il parlare del sentimentalismo<br />
sdolcinato, è il parlare che occulta in diverso modo questa dimensione dell’esistenza.<br />
Nella coesistenza l’Esserci è sempre preoccupato di una contrapposizione commisurante che fa sì<br />
che egli si ponga in una soggezione nei confronti degli altri.<br />
L’Esserci sottoposto alla “dittatura del Si”, adegua la sua vita al modello astratto del comune “si<br />
dice”, “si è”, e dunque fa quel che “si fa”. Nella dimensione del “Si” impersonale la medietà livella<br />
tutto, distoglie ogni originalità nel risaputo. Il Si è nel modo dell’inautenticità, stabilisce il modo di<br />
essere della quotidianità ed ha già sempre anticipato ogni giudizio ed ogni decisione. Perciò<br />
sottrae al singolo Esserci ogni responsabilità concreta: nessuno è responsabile.<br />
Nel vivere inautentico questo Si che domina quotidianamente le nostre esistenze,<br />
contrapponendosi all’essere se stesso autentico, trasforma in chiacchiere le emozioni e ne fa<br />
oggetto di curiosità e di equivoco. La chiacchiera già tutto sa, nella sicurezza che le deriva dal “si<br />
dice”, si preoccupa della diffusione o della ripetizione di ciò che è stato detto, e da tale diffusione<br />
acquisisce una crescente attendibilità.<br />
Un sapere inconsistente si consolida: anche ciò che è infondato può ricevere valore pubblico di<br />
verità.<br />
Una rinnovata modalità del “dire” nasce dunque da un nuovo modo del “guardare” ai sentimenti<br />
che agiscono nella formazione: un modo non distratto, ma profondo, attento, e anche meravigliato.<br />
Penetrando nei meandri della formazione neppure intravisti dal Si, ap<strong>pag</strong>ato dei suoi stereotipi,<br />
può rivelarsi il nuovo che incrina il “già saputo” dello sguardo superficiale, curioso ma incapace di<br />
approfondire e soffermarsi perché è distratto dalla fretta di riportare altrove ciò che ha udito. Alla<br />
curiosità non interessa nulla, la curiosità non vede veramente nulla.<br />
L’autenticità è la condizione che dischiude alla possibilità di ascoltare il linguaggio dei sentimenti e<br />
delle emozioni, requisito per la conoscenza di sé in relazione.<br />
33
La comunicazione equivoca non si cura di ciò che ha udito, di ciò che è stato dis-velato, di ciò che<br />
sembra compreso e forse non lo è. Nell’incontro inautentico tra soggetti la parola si struttura<br />
secondo le modalità del sapere della convenzionalità. Mentre la parola che manifesta la presenza<br />
altrui resta nascosta sotto le macerie della chiacchiera. Dunque è la presenza stessa dell’Altro che<br />
resta nel nascondimento. Il linguaggio medio nasconde, anziché farsi tramite di una co-presenza, e<br />
diviene ostacolo, anziché strumento del reciproco rivelarsi.<br />
La formazione è spesso intesa come un’attività dominata da regole e metodi a cui attenersi e viene<br />
perciò estromesso la dimensione emotiva. I sentimenti restano invisibili, sono rimossi o taciuti,<br />
nonostante l’alta densità di emozioni che coinvolge, in tutte le sue forme, l’esperienza formativa. Le<br />
ore e i giorni trascorsi insieme, la qualità del tempo e delle relazioni, la significatività esistenziale di<br />
ciò che intercorre rende ineludibile una riflessione sulla vita emotiva. Ma è significativo di questo<br />
silenzio sugli aspetti emotivi la scarsa letteratura pedagogica sull’argomento. Non solo, il<br />
riferimento alle emozioni è spesso legato alle ricerche sul burn-out.<br />
La vita emotiva è indagata più come disturbo, fonte di malessere, che come dimensione<br />
strutturalmente connaturata alla formazione e potenzialmente fonte di benessere, ove venga<br />
correttamente legittimata e valorizzata nella sua ricchezza. Tramite le spiegazioni causalistiche<br />
non potremo mai comprendere i nostri simili “dall’interno”.<br />
Il timore diffuso di esporsi al rischio di essere coinvolti dai sentimenti non controllati dalla ragione<br />
nell’attività formativa induce comportamenti difensivi, prese di distanza, fino ad atteggiamenti freddi<br />
e indifferenti. Non si piò certo negare che, in mancanza di una formazione adeguata, sia sempre<br />
possibile il rischio di un’inutile ( e persino dannosa) emorragia di emozioni. Ma entrambi gli eccessi<br />
(troppa distanza o troppa vicinanza) sono l’espressione di un’assenza di equilibrio nel lavoro<br />
formativo e nell’investimento emotivo che richiede, invece, la continua ricerca della giusta distanza<br />
nel posizionamento reciproco relazionale.<br />
Ridare dignità ai sentimenti, riconoscerli, pensarli e agirli nei luoghi della formazione è quindi il<br />
requisito fondamentale per attuare relazioni sane ed emotivamente significative. Ma questo<br />
obiettivo è reso alquanto difficile per una duplice ragione. Innanzitutto a causa del contesto<br />
culturale attuale che svilisce i sentimenti nel sentimentalismo e nella spettacolarizzazione o li tace<br />
per la mancanza di una grammatica, o li riconduce alla sfera del privato e del segreto.<br />
Secondariamente per l’eredità culturale che ha assegnato un indiscusso primato alla logica<br />
matematizzante del ragionamento e ha relegato i sentimenti nella sfera delle conoscenze inutili e<br />
accessorie, quando non potenzialmente dannose; in ogni caso oscure e minacciose per la ragione.<br />
Le nozioni di sentimento e ragione sono state sottoposte a una crescente contrapposizione nel<br />
nostro universo “logocentrico”, già al termine di quella cultura pre- platonica in cui ancora non si<br />
era operata la scissione tra pensare e sentire, tra lògos e pàthos. Le emozioni (moti dell’anima)<br />
sono state progressivamente separate dal pensiero, viste come pericolose e perturbanti qualora<br />
sfuggissero all’istanza ordinatrice della mente.<br />
34
Nonostante l’ostracismo filosofico nei confronti della vita emotiva, va segnalato che alcuni filosofi<br />
hanno dedicato attenzione privilegiata ai sentimenti. Pascal aveva affermato: “ Noi conosciamo la<br />
verità non solo con la ragione ma anche con il cuore”. E anche l’opera di Rousseau ha rivendicato<br />
la “virtù del cuore” nella pedagogia dell’Emilio affermando che troppo spesso la ragione ci inganna.<br />
Ma è la prospettiva fenomenologica, recuperando il valore della soggettività e dell’Erlebnis, a<br />
legittimare la vita emotiva. Come afferma Umberto Galimberti, “nella nostra cultura non si è mai<br />
data tanta rilevanza alla comprensione della mente e delle produzioni della mente”, mentre ciò che<br />
interessa alla fenomenologia è “comprendere dall’interno i vissuti esistenziali”.<br />
La cultura educativa è stata fortemente condizionata dal relazionismo di eredità piagetiana che ha<br />
individuato il livello superiore delle facoltà psichiche nello stadio dell’elaborazione logico- formale e<br />
ipotetico- deduttiva, depurate dalle ingerenze emotivo/affettive. (Piaget, 1968).<br />
Le ricerche di Erik Erikson, John Bowlby, David Rappaport, Berry Brazelton hanno evidenziato<br />
l’importante ruolo della vita emotiva. Howard Gardner ha elaborato una teoria delle intelligenze<br />
multiple indicando, tra queste, l’intelligenza emotiva. Daniel Goleman sviluppa la nozione<br />
nell’intento di insegnare e gestire il controllo di sé. Stanley Greenspan, recuperando il concetto<br />
fenomenologico di “tonalità emotive”, parla di “intelligenza del cuore” che ha il compito di<br />
valorizzare e, soprattutto, di dare senso all’esperienza emozionale.<br />
Coltivare la vita emotiva è quindi indispensabile nella formazione per accom<strong>pag</strong>nare gli altri ad<br />
aver cura dei loro sentimenti, a elaborarli per farne strumenti di lettura dell’esperienza, a sentirsi<br />
cioè a saper conoscere, accettare, ascoltare, elaborare, esprimere il proprio mondo interiore, e a<br />
sentire l’alterità e la sua prossimità rispettandone e accogliendone la dignità ed il valore.<br />
Il recupero de sentimenti dall’oblio pedagogico può riqualificare il concetto di professionalità nella<br />
formazione, mostrando che l’anaffettività non è un codice che garantisca maggior rigore.<br />
I comportamenti che opacizzano le risorse affettive svuotano di senso la formazione.<br />
35
Lo spazio interiore<br />
LE TONALITÁ EMOTIVE DELLO SPAZIO EDUCATIVO<br />
Fuori nevica, i fiumi si sono fermati per l’acuto gelo; dentro, un convito intimo, una conversazione<br />
accanto al fuoco: per sciogliere il freddo deponi abbondante legna sul fuoco e versa il vino vecchio,<br />
permitte divis cetera, lascia agli dei tutte le altre cose che sono al di fuori di questo momento, e<br />
non cercare di conoscere che cosa ti riserverà il domani (quid sit futurum cras fuge quaerere).<br />
Nelle riflessioni sul senso dell’esistenza nasce l’invito alla saggezza (sapias), a troncare una<br />
speranza troppo lontana nel tempo e a non contare troppo sul domani poiché la vita fugge via in<br />
fretta, già ora, mentre noi parliamo. Educazione oraziana ai sentimenti della quieta confidenza con<br />
la vita e con la morte.<br />
L’intimità è sempre un “dentro”, un interno protetto che ha il carattere di ciò che è più interno, ciò<br />
che sta più dentro di tutto (intra, comparativo interior, superlativo intimus). Il “fuori” è estraneità,<br />
esclusione, dispersione nella lontananza (extra, comparativo exterior, superlativo extremus). Il<br />
luogo dell’intimità è sempre concavo: una concavità emotiva, simbolica, fisica, architettonica, che<br />
raccoglie, avvolge, unisce, accomuna. L’esterno è il mondo della convessità.<br />
L’intimità è un luogo interiore. L’educazione ai sentimenti che l’accom<strong>pag</strong>nano (che non vanno<br />
confusi con l’intimismo) si fonda sulla capacità di scoprire, riconoscere o creare questo spazio<br />
interiore, simbolico o concreto in cui si incontra con se stessi o con gli altri senza maschere e<br />
senza competizioni. È educazione al raccoglimento, al radicamento, al rifugio, al tepore, al riposo;<br />
si raccolgono i vissuti, le memorie, le esperienze, i pensieri, le idee. È coraggiosa contrapposizione<br />
educativa alla attuale preoccupante dispersione in esistenze continuamente distratte dell’intra<br />
verso l’extra. Questo spazio personale più profondo si costruisce nell’infanzia ma deve essere<br />
coltivato per tutta la vita: è l’ultima difesa contro i tentativi esterni di invasione ed espropriazione<br />
della nostra dimensione esistenziale. L’equilibrio emotivo ha bisogno di momenti di solitudine e di<br />
sosta per comprendere e dotare di senso le esperienze del nostro agire quotidiano, i sentimenti, le<br />
emozioni. Anche la ragione trae la forza dal ritirarsi a pensare, a giudicare autonomamente, a<br />
rimembrare per rielaborare. Nell’intimità si recuperano le energie esistenziali necessarie per la vita<br />
personale e pubblica.<br />
L’intimità è quindi anche un tempo interiore, tempo della pausa, della sosta, contrapposto al mito<br />
della velocità e dell’ossessiva corsa contro il suo scorrere. Le antiche pratiche delle preghiere sono<br />
nate anche per questa funzione, così come il rigore del sabato ebraico.<br />
L’educazione all’intimità è tanto più importante quanto più affrontiamo esperienze emotivamente<br />
profonde. Il distacco e l’abbandono hanno bisogno di tempi per essere elaborati; tempi per vivere<br />
fino in fondo l’amore, il dolore, per ritrovare la forza di combattere un’ingiustizia o un sopruso, per<br />
irrobustire un concetto o un’intuizione. Tempi della corrispondenza d’amorosi sensi che nasce da<br />
36
una laica religione della con-fidenza anche nella lontananza: dopo la morte delle persone care, con<br />
un autore che ci corrisponde attraverso le parole, la sua musica, i suoi colori.<br />
Il guscio di noce<br />
L’interno è il luogo del “bene”, il nostro angolo del mondo, luogo del riposo o della pace; se<br />
nell’educazione manca questo luogo fisico e interiore il soggetto non ha dove stare. La condizione<br />
di sradicamento nasce dalla perdita del proprio posto al mondo “…ma da quel nido rondini tardive/<br />
tutti tutti migrammo un giorno nero” (G. Pascoli). Il nido, il ventre materno, la capanna, la tana sono<br />
immagini di grande forza simbolica in quanto avvolgono, raccolgono, come il guscio di noce, la<br />
conchiglia, il bocciolo di rosa, il camino, l’uovo ecc. Bachelard rileva come sia spazioso lo spazio<br />
interno nell’intimità: pur essendo chiuso e raccolto, non è stretto, poiché in esso partecipiamo alla<br />
funzione della miniaturizzazione, alla rêverie lillipuziana che, con prospettiva rovesciata, rende<br />
grande anche l’interno dell’oggetto piccolo, quanto dentro ci si sente in pace. Un guscio di noce<br />
può quindi essere spazioso per chi possiede il tesoro di una familiarità accogliente dove sia dolce<br />
abitare.<br />
Una nota filastrocca infantile, “Filo di voce”, rimata con il guscio di noce, evoca l’atmosfera di gioia<br />
racchiusa dove si parla a bassa vice, non si grida, si bisbiglia ciò che può essere soltanto<br />
sussurrato. Vi può essere anche assenza di parole per quei sentimenti che si comunicano con il<br />
silenzio, o per quelle esperienze personali che hanno bisogno di silenzio per avere voce nella<br />
centralità della nostra vita.<br />
L’uovo o cerchio è rotondità e centralità insieme; è sostanziale compiutezza pur nella disposizione<br />
ad accogliere in sé l’altro; è armonia e sacralità. Mentre il quadrato è stabilità e difesa dall’esterno,<br />
il cerchio è riferito all’interno, al centro, al contenuto, a ciò che si raccoglie dentro. L’intimità è<br />
dunque una dimensione che fa riferimento agli archetipi femminili. Il cerchio evoca la sacralità<br />
dell’interno: il tempio esprime nella cupola le architetture religiose del mediterraneo, accom<strong>pag</strong>nate<br />
da campanili e minareti come equivalenti simbolici del maschile). La tana, l’antro, la cripta hanno in<br />
comune i sentimenti legati all’intimità nascosta e segreta.<br />
Nelle simbologie più antiche e diverse il cerchio indica il femminile e la freccia indica il maschile. La<br />
freccia è movimento verso un bersaglio lontano, una meta esterna, un centro che si trova altrove,<br />
mentre il cerchio ha in sé il proprio centro. Oggi la cultura dominante e i modelli educativi<br />
perseguiti sono molto più vicini alla direzione della freccia, alla velocità del movimento fisico e<br />
mentale, in un’educazione volta all’esterno, alla conquista, mentre la dimensione della circolarità e<br />
dell’interno è poco valorizzata nelle pratiche educative, quantunque se ne affermi teoricamente il<br />
valore. Di fatto l’esterno e il pubblico veicolano maggiori progetti educativi che incentivano alla<br />
socializzazione piuttosto che a trovare un senso nella dimensione privata o semiprivata.<br />
37
Topologie interiori dell’intimità<br />
Luogo primario nella topologia intima è il corpo. Il neonato inizia a conoscere il mondo dal proprio<br />
corpo: le sue prime esperienze sono la sicurezza dell’utero materno e del corpo che lo nutre, e<br />
successivamente cerca il proprio posto nel mondo attraverso le numerose esperienze di<br />
segretezza e riparo che egli ricostruisce. Lo spazio corporeo costituisce infatti il nostro perenne<br />
“qui”, lo spazio assoluto che non percorriamo in quanto, a livello fenomenologico, noi siamo il<br />
nostro corpo. La costituzione spaziale dell’esistenza umana corporea nell’unità soggetto- mondo è<br />
fondamentale per un positivo rapporto con gli altri. L’intimità è il primo territorio dell’essere un<br />
corpo esistente, il centro stesso da cui si dispiega la distanza prossima o remota dagli altri.<br />
La casa (reale, onirica, simbolica, mitica) è un importante luogo interiore delle relazioni: il luogo<br />
della solidarietà in contrapposizione al luogo del possesso e del commercio. Il luogo in cui i<br />
soggetti conoscono il sentimento dell’abitare nella confidenza. La casa è la grande culla dove<br />
localizzare spazialmente la nostra familiarità contrapposta all’estraneità sconosciuta del mondo<br />
esterno. Se la casa è il rifugio dove si recupera la propria privacy, lasciando fuori dalla porta la<br />
dimensione del sociale e del pubblico.<br />
Anche l’angolo è un luogo interiore della protezione massima, è il riparo protetto dove nessuno può<br />
prenderci alle spalle o ai lati. La tridimensionalità è nell’angolo l’avvolgimento di uno spazio fisico<br />
ancor più piccolo in cui si restringe il germe del raccoglimento.<br />
Altra topologia del sentimento del raccoglimento con se stessi è l’albero: il rifugio naturale della<br />
capanna sull’albero è emblematicamente espresso nel romanzo di Ian MacEwan Bambini nel<br />
tempo in cui Charles, adulto ricco e famoso, si rifugia in un mondo infantile e, significativamente,<br />
costruisce una capanna/nascondiglio in cima a un faggio gigantesco.<br />
Più ancora della capanna, la barca, che come una culla dondola sulle acque, rappresenta il vissuto<br />
di interno in quanto recide il legame con la terraferma, è sulle acque, non appoggia. Tutto<br />
l’universo è in quella concavità sospesa.<br />
È estremamente importante tenere conto di questi vissuti e simbologie per comprendere i giochi<br />
dei bambini, i loro disegni, le loro fantasie, i loro sogni; per educarli a familiarizzare con i propri<br />
sentimenti. E tuttavia il difficile recupero di queste topologie interiori richiede un’indispensabile<br />
educazione all’epoché dei significati che questo concetto ha assunto nella semantica banalizzante<br />
del linguaggio medio, dove l’Intimità è diventata un settimanale femminile, e intimi sono la<br />
biancheria, l’igiene, i rapporti e i desideri: si riduce l’intimità a ciò che è proibito nominare<br />
espressamente, a ciò che si spia dalla serratura. Mentre si esige, giustamente, un riserbo sulla<br />
propria vita sessuale, la riservatezza esistenziale non è esigenza altrettanto forte, non è<br />
considerata un’opportunità decisiva per la qualità dell’esistenza. Molte persone hanno quasi paura<br />
della privacy esistenziale, rifuggono il contatto con se stessi, hanno bisogno di mettere fra il loro Io<br />
ed il loro Sé qualcosa o qualcuno: tv, cibo (l’andare a cena fuori), presenze virtuali (Internet) ecc.<br />
38
Il calore<br />
L’atmosfera determinante nell’intimità è il calore, e più precisamente il tepore, il caldo buono<br />
ungarettiano; non la fiamma che brucia ma la delicata fiammella delle candele. Il fuoco è<br />
un’esplosione vitale che si mostra all’esterno, maschile. Il fuoco non si nasconde, si mostra, non si<br />
racchiude, si espande, guizza in superficie. Il tepore è invece nascosto, concentrato, interiorizzato,<br />
costante, sicuro, profondo. Il fuoco è la passione che brucia, è mobilità instabile e imprevedibile,<br />
agitazione, fermento, schioppettio luminoso e molteplicità. L’agitazione non fa parte dell’intimità.<br />
Nell’intimità il fuoco è contenuto entro la concavità del camino, non vi è piena luce, ma penombra,<br />
semmai le ombre che il fuoco proietta contro le pareti della stanza. Le situazioni di confidenza<br />
sono evocate dalla presenza stessa del camino acceso. L’architetto Wright assegna al camino<br />
un’importanza decisiva nell’individuare il luogo più accogliente della casa.<br />
Nei luoghi familiari vi sono le amicizie, le relazioni significative, anche le ombre e le voci dei nostri<br />
fantasmi che riappaiono principalmente quando siamo soli. Ma la solitudine non è<br />
necessariamente una condizione priva di calore, è talvolta la sola condizione che ci consente di<br />
recuperare il coraggio di esistere. Il calore è una condizione interiore che può scaldare la nostra<br />
solitudine e può pro<strong>pag</strong>arsi agli altri.<br />
La casa illuminata nel bosco della notte è un archetipo ricorrente nelle fiabe del perdersi: una<br />
lucina in fondo al sentiero rappresenta la speranza di una presenza umana, il camino acceso,<br />
l’accoglienza, il dissolversi delle paure del freddo e del buio. Il bosco e la notte sono tanto paurosi<br />
all’esterno quanto accrescono il calore degli interni. La baita è ancora oggi evocatrice di questa<br />
calda protezione, della vita appartata, della protezione e del riparo, e al tempo stesso del<br />
confortante ritorno.<br />
Per riguadagnare il più vasto valore pedagogico dell’intimità occorre recuperare un contesto di<br />
elementi, di pensieri, sentimenti, relazioni inattuali o perduti. Il silenzio, per esempio, che non è<br />
soltanto freddo e non è il semplice tacere, ma consente l’ascolto autentico dell’ipseità e del’alterità,<br />
delle voci che abbiamo conosciuto nella nostra esistenza, anche quelle che si sono spente. Nel<br />
calore delle relazioni umane avviene una conoscenza di sé e degli altri che ci rivela nella<br />
dimensione autentica, del perderci e del ritrovarci, prima di ogni deformazione esteriore e sociale.<br />
L’intimità è calore in quanto è sempre relazione, con se stessi o con gli altri.<br />
Le presenze<br />
L’intimità con gli altri è un reciproco consentire libero accesso al proprio territorio, una deposizione<br />
delle difese per abitare il comune territorio dell’intimità, dove la protezione e la difesa non si<br />
manifestano nel porsi l’uno contro l’altro ma nel vivere insieme una comune protezione da<br />
un’alterità esterna. Nella familiarità si sviluppa una introiezione del territorio del “tu” nello spazio<br />
comune: la presenza dell’altro da esterna diventa interna, condivisa e fonte di riconoscimento.<br />
39
Il sentimento del rifugio rinvia alla rêverie del nido dove ci si ritira, ci si rannicchia, ci si nasconde in<br />
un abitare amoroso, nutritivo, procreativo. Nel nido ci si accoppia, si depongono le uova, si<br />
alimentano i piccoli e si vive il calore affettivo della relazione con gli altri.<br />
La prossemica mostra che le distanze personali diminuiscono se tra soggetti esistono affinità,<br />
attrazione, relazione amorosa o amichevole, mentre tali distanze tendono ad aumentare in<br />
presenza di sentimenti negativi o di ostilità. Lo spazio personale è inteso da Moles come “il luogo<br />
del mio corpo” dove la pelle è l’involucro/frontiera che separa il corpo dal mondo; ma attorno a<br />
questo primo guscio il soggetto umano ne costruisce progressivamente altri, allargando le sue<br />
zone personali a strati successivi. Ma si può essere in intimità anche senza toccarsi fisicamente.<br />
Sono infatti principalmente gli sguardi, le parole, i silenzi a stabilire di attimo in attimo lo stato<br />
d’animo ed i sentimenti che si esprimono in modalità differenti nelle diverse persone e nei diversi<br />
momenti. La distanza vissuta è il contatto che ci unisce con le altre presenze ed è la condizione<br />
stessa dell’intimità come spazio esistenziale. La vicinanza intima è regolata dai vissuti e dai<br />
sentimenti tra i soggetti, anche nella distanza fisica. Se manca lo spazio della noità, la relazione<br />
intima si impoverisce in una semplice vicinanza.<br />
Nell’intimità non vi è nulla che debba essere spiegato o dimostrato; non vi sono contenuti di<br />
conversazione che abbiano importanza in sé; vi è uno stato d’animo che non si basa sui contenuti,<br />
ma sulle presenze, sull’essere insieme in uno spazio ed in un tempo comune a cui si attribuisce un<br />
senso condiviso.<br />
Il piccolo spazio protetto non è necessariamente raccolto se non è abitato dai sentimenti della<br />
confidenza. L’ascensore, per esempio, è uno spazio piccolo e talvolta affollato di presenze, ma il<br />
trovarsi a stretto contatto fisico con altre persone non suscita intimità, poiché le relazioni tra le<br />
persone non sono emotivamente intime: la vicinanza o il toccare stesso non sono segnali di<br />
confidenza. L’ascensore, anche se strettissimo, non evoca affatto il vissuto del guscio di noce.<br />
Il perimetro<br />
Dove si traccia il perimetro che circonda l’intimità? Qual è il confine che la delimita? Esso non è<br />
visibile e tuttavia non è indefinito, è un confine invisibile e avvolgente che ha un fuori e un dentro:<br />
si è nell’intimità quando ci si sente compresi entro quel confine che assume senso per noi, pur<br />
senza isolarci. L’esperienza quotidiana dei non luoghi ha finito per renderci difficile de-finire i luoghi<br />
di senso e i luoghi intimi rispetto alla onnivora dimensione sociale e pubblica. E inoltre la perdita<br />
dell’intervallo, della pausa, dell’elaborazione delle distanze interiori induce a confondere la<br />
distanza reale con la vicinanza virtuale, l’isolamento con l’intimità.<br />
Oggi molte persone sono sole, pur senza conoscere l’intimità. L’isolamento produce sentimenti di<br />
freddezza, insignificanza, smarrimento, laddove l’intimità produce sentimenti di calore, significato,<br />
ritrovamento.<br />
La “massa” è isolante e genera il desiderio di calore umano e di intimità, ma poiché l’intimità è<br />
difficile e sconosciuta, si restringe oggi sempre più il concetto alla sola sfera sessuale. Ed è in<br />
40
questa sola accezione che si parla di intimità. È dunque di grande importanza pedagogica<br />
custodire zone interne nella nostra esistenza, anche se è sempre più difficile individuare il confine<br />
tra la sfera intima e la sfera pubblica, per una crescente erosione del perimetro.<br />
Il brulichio e il sovraffollamento non consentono la relazione intima e comportano deformazioni<br />
psicopatologiche e aggressività. Dagli esperimenti condotti da Calhoun nel 1958 su alcune colonie<br />
di topi costrette a vivere troppo addensate, emerse che il comportamento si disgregò, eliminando<br />
tutte le regole sociali: il corteggiamento, l’allevamento della prole e la gestione degli istinti<br />
aggressivi vennero completamente capovolti, le femmine subirono mutamenti endocrini e<br />
divennero sterili. Pur senza voler far corrispondere un esperimento animale al comportamento<br />
umano, si può affermare che le condizioni di sovrappopolamento comportano un disagio anche per<br />
gli esseri umani, privati della propria possibilità di spazio vitale senza il quale la stessa vita viene<br />
messa in pericolo. La perdita della possibilità di spazi interiori è pericolosa per la sopravvivenza<br />
stessa, come è stato tragicamente evidenziato n situazione estrema fra gli internati dei campi di<br />
concentramento nazisti, dove la sopravvivenza dei prigionieri fu più alta fra coloro che trovarono<br />
nel loro spazio interno un luogo proprio, inviolabile, in grado di persistere anche in situazioni di<br />
totale espropriazione della personalità.<br />
Un angolo privato è assai importante per prevenire i rischi della spersonalizzazione derivati<br />
dall’ubiquitarietà del soggetto umano, che comporta l’assenza di confini e l’incapacità di de-finire<br />
ambiti intimi per l’ascolto, la tenerezza, il calore, il sentirsi accolti.<br />
È questo, un fenomeno legato al telepolismo, il sistema delle telecomunicazioni che trasforma il<br />
privato in pubblico e i cittadini in passivi spettatori della propria vita.<br />
Lo sguardo<br />
Stiamo lì, fermi al semaforo, dentro l’automobile. Divenuti sempre più incerti e indefiniti i confini<br />
interno/esterno, l’intimità finisce per essere ridotta all’abitacolo (l’abitare abituale) dell’automobile,<br />
moderno spazio/tempo privato, occasione di solitudine, possibilità di ascoltare sé stessi, anche<br />
immersi nel fluire del traffico. Viviamo una sorta di intimità temporanea. È sufficiente che un’auto ci<br />
si affianchi e qualcuno dalla sua auto, ci guardi, per provare un sentimento di intrusione,<br />
distoglierci dai nostri pensieri, per avere un breve sussulto che ci riporta improvvisamente sul<br />
palcoscenico. Sapersi osservati provoca un senso di rottura dell’incantesimo. Il confine dell’intimità<br />
è un incanto che può essere rotto innanzitutto dallo sguardo.<br />
Se qualcuno ci guarda nel momento in cui siamo soli con noi stessi o in una relazione di<br />
confidenza con gli altri, ci sentiamo sorpresi nell’intimità e, come davanti ad un’inattesa cinepresa,<br />
modifichiamo il nostro comportamento ed il nostro atteggiamento mentale ed emotivo. Tutto ciò è<br />
reso più complesso dalla cultura delle immagini e dal primato del vedere.<br />
Gli sguardi possono toccarci e violare l’intimità; il pudore o la vergogna nascono infatti dalla<br />
situazione di corpo indifeso dagli sguardi. L’interiorità privata, quando si trova esposta all’occhio<br />
altrui, diventa visibile e genera un sentimento di vergogna legato all’irruzione dell’alterità nella<br />
41
nostra intimità. La dialettica tra il visibile e l’invisibile è la dialettica della percezione del confine<br />
intimo/pubblico. Essere nella visibilità vuol dire perdere la protezione in quanto la visibilità espone<br />
all’esterno. Lo sguardo dell’altro mi rivela a me stesso nella mia dimensione esterna e scoperta.<br />
L’essere guardati di nascosto, spiati, suscita vergogna, risentimento o divertimento. Mentre, se<br />
abbiamo consapevolezza di essere guardati possiamo aggiustare o regolare i nostri<br />
comportamenti. Ma il nostro corpo è molto più esposto alla violazione della privacy se è visto da<br />
uno sguardo ignorato. Non solo siamo diversi se sappiamo di essere osservato, ma anche se<br />
pensiamo di essere invisibili mentre osserviamo.<br />
L’esperienza dell’essere “sulla scea2, sul palcoscenico può assumere anche i caratteri della paura,<br />
del panico, del terrore, della vertigine, descritti da Binswanger in Ellen West e in Suzanne Urban,<br />
dove il mondo al di là del perimetro dell’intimità diventa inquietante e si connota di orribile.<br />
Il confine tra interno ed esterno è sempre definibile attraverso uno sguardo: è dunque un vedente<br />
che con suo vedere squarcia il cerchio che avvolge l’intimità e, penetrando con l’occhio l’intimità, la<br />
dissolve.<br />
Lo sguardo che avvolge l’intimità l’accarezza senza disvelarla, in una dialettica che assume la<br />
forma del chiasmo indicato da Merleau- Ponty come modello ermeneutico interpretativo aperto<br />
all’intreccio tra vedente e visibile che sottende il chiasma più radicale tra visibile e invisibile.<br />
Per una fenomenologia della domiciliarità: la casa e il territorio<br />
Il concetto fenomelogico di Lebenswelt (mondo della vita) che interpreta la persona come centro di<br />
un mondo circostante, rimanda a un mondo/situazione (lo spazio vissuto) non oggettivisticamente<br />
dato e fisso, ma processuale, dinamico, trasformativo, entro un tempo della vita (il temo vissuto)<br />
che dà senso alle esperienze.<br />
Abitare significa sentirsi domiciliati in uno spazio/territorio relazionale, appartenere a un mondo e<br />
trovare n esso il senso per la propria storia .<br />
L’abitare è qualcosa che ha a che vedere con la vita stessa. Lo spazio dell’esistenza non esiste “in<br />
sé”, con caratteristiche soltanto oggettivamente date, ma è sempre connotato in base alle<br />
relazioni, alla cultura, alla società, alla storia: sullo spazio si proiettano tutti i simboli della società<br />
che lo abita, modellandolo. È uno spazio largo e stretto, buio e luminoso, caldo o gelido in base<br />
alle relazioni che lo rendono tale.<br />
Domiciliarità significa allora concepire la casa (e i legami familiari) in relazione con il<br />
mondo/ambiente, il territorio e la comunità sociale per continuare a riconoscersi in essa.<br />
La cultura e le pratiche di domiciliarità sono un elemento qualificante per una prospettiva di<br />
sviluppo sociale, di collegamento alla globalità del contesto territoriale: dalla famiglia alla comunità<br />
locale.<br />
La dimensione della domiciliarità si basa sui rapporti, sulle reti di relazioni, sull’appartenenza al<br />
territorio, in senso fisico, emozionale, culturale e sociale. Domiciliarità significa: comunicare,<br />
42
condividere, compartecipare, incontrarsi, conoscersi, scambiare. Implica, per le famiglie ed i<br />
servizi, un’apertura all’esterno, una valorizzazione delle differenze, poiché ciascuna famiglia è<br />
portatrice di diverse prospettive ed esperienze.<br />
La domiciliarità così intesa ha bisogno di attivare le risorse plurime presenti nella società civile, nel<br />
volontariato, nei nuovi soggetti delle risorse informali.<br />
Un sistema di welfare-mix fondato sulla collaborazione tra i servizi può alimentare una rete di<br />
relazioni che non si appiattisca su risposte standardizzate, ma sappia rispettare le differenze<br />
all’interno della concezione di un territorio/laboratorio.<br />
Il territorio come mondo circostante<br />
Un approfondimento concettuale sulla domiciliarità, come fonte di appartenenza al territorio e di un<br />
“abitare abitato”, significativo per l’esistenza, mostra la peculiare dimensione relazionale di tale<br />
prospettiva. In quanto espressione di solidarietà e di responsabilità sociale, essa è l’elemento<br />
cardine del welfare comunitario e chiede di ripensare il lavoro sociale.<br />
La domiciliarità non è da intendersi come chiusura o, peggio, segregazione entro le mura di una<br />
casa/prigione; al contrario, è da intendersi come apertura delle relazioni, con gli altri, con se stessi,<br />
apertura alle reti informali del vicinato, all’entrare/uscire di persone, di rapporti, di comunicazione,<br />
di aiuto, di risorse ricevute e offerte.<br />
La dimensione interno/privata si accom<strong>pag</strong>na sempre a quella esterno/pubblica, poiché sono<br />
inseparabili le due essenziali modalità costitutive dell’umana esistenza: l’essere nel mondo e<br />
l’essere con gli altri. Il soggetto umano è, per sua natura, relazionale, non è mai dato un io isolato,<br />
senza gli altri e l’Esserci è in se stesso essenzialmente con- essere.<br />
La condivisione di uno spazio comune non è da intendersi come una realtà fisico- geometrica<br />
sommativa, costituita dal semplice insieme di più soggetti presenti l’uno accanto all’altro, ma come<br />
una relazione in cui legami tra le persone qualificano l’appartenenza a un mondo comune.<br />
Il territorio, luogo primo dei vissuti della quotidianità e fondamento della cittadinanza, è innanzitutto<br />
possibilità di riconoscersi e di essere riconosciuti.<br />
La socialità diffusa<br />
Il territorio è il senso stesso dell’abitare. La valorizzazione della territorialità si esprime nel senso di<br />
appartenenza a un contesto che è, in primo luogo, quello abitativo, ma è, al tempo stesso,<br />
effettivo, relazionale, sociale, culturale. L’appartenenza è quindi il radicamento nel territorio, inteso<br />
come sentirsi partecipi di quella socialità diffusa che si traduce n responsabilità diffusa verso il<br />
contesto relazionale e in partecipazione alle politiche sociali.<br />
Per dare vita ad una relazionalità diffusa è necessario il superamento della frammentazione<br />
sociale che si è progressivamente acuita in questi anni, a causa della ridotta importanza dei luoghi<br />
di aggregazione tradizionali (partiti, bar, parrocchie), per la tendenza a rimanere più in casa, per la<br />
maggiore facilità a recidere le radici territoriali. L’accelerazione dei tempi della società provoca<br />
ripercussioni sulla partecipazione ed esige un nuovo atteggiamento culturale per comprendere la<br />
43
ilevanza delle problematiche relazionali e per creare le condizioni di una nuova partecipazione. In<br />
contrasto con la delega, la partecipazione è elemento decisivo per favorire una reale<br />
appartenenza, un’incentivazione del protagonismo dei cittadini come attori e responsabili delle<br />
politiche che li riguardano (empowerment).<br />
La casa e la città<br />
I significati dello spazio urbano sono legati alle diverse modalità secondo cui è usato e vissuto. La<br />
città “vissuta” è un racconto, un’autobiografia individuale e sociale. Il tema della domiciliarità e<br />
dell’abitare, nel suo senso più profondo, esprime la sicurezza , la condivisione, gli affetti, la libertà<br />
e la democrazia. Sentirsi a casa significa abitare l’abituale, godere delle cose che ci<br />
corrispondono, che abbiamo interiorizzato e reso parte di noi. Abitare ed abitudine hanno la stessa<br />
origine di habere, avere, possedere: sapere dove ci si trova anche quando si è al buio, conoscere i<br />
gradini, i percorsi.<br />
La casa si configura come un andirivieni di vissuti, di voci che vi abitano, di rumori, di emozioni, di<br />
una pluralità di forme che impregnano i muri di quello scientifico co-abitare costituito dalle relazioni<br />
interne familiari. I rumori familiari rendono abitata l’abitazione.<br />
La casa vissuta è essa stessa un racconto, un’autobiografia: racconta la nostra esperienza. Nella<br />
distribuzione degli spazi interni e negli arredi si esprime la vita che vi si svolge, i valori, i codici di<br />
comportamento e appaiono le tracce visibili di chi l’abita, la Stimmung (la tonalità emotiva) che<br />
contraddistingue la vita familiare, l’atmosfera che vi si respira. Il clima proprio di ogni casa è<br />
l’espressione delle persone che trascorrono lì la loro vita interpretando, in funzione dei propri<br />
vissuti, le forme predisposte dell’architettura.<br />
Nella famiglia, scrive Hanna Arendt, gli adulti fanno ritorno quotidianamente dal mondo esterno,<br />
per ritrovarsi al sicuro, nella vita privata, tra le quattro mura che costituiscono un riparo dall’aspetto<br />
pubblico del mondo, una protezione dell’intimità e della sicurezza senza le quali la vita stessa<br />
perde il suo carattere vitale.<br />
La casa fu originariamente luogo sacro, luogo delle divinità familiari, i Lares, luogo femminile, in<br />
quanto intimità protettiva dello spazio interno, punto stabile nell’universo a cui poter fare ritorno. La<br />
casa è lo spazio dell’abitare abitato, dell’abitare originario. È l’interno che esprime i molteplici<br />
vissuti di protezione, familiarità, rifugio, intimità, quotidianità. È lo spazio che ci rappresenta e ci<br />
accoglie non come cosa tra le cose, ma come presenza vivente, rivelatrice dell’esistenza del<br />
mondo.<br />
Bachelard definiva la casa “il nostro angolo del mondo” nel quale mettiamo le radici giorno per<br />
giorno, il primo universo dell’essere gettati nel mondo. La dimora dell’uomo è il centro della sua<br />
vita ed è uno dei più potenti elementi di integrazione per i pensieri, i ricordi, i sogni dell’uomo.<br />
44
Nomadismo<br />
Il tempo presente, caratterizzato da migrazioni e nomadismo, ha modificato il concetto di dimora e<br />
ha reso più difficile la costruzione della domiciliarità in seguito agli stili di vita fondati sulla<br />
competitività economica.<br />
La perdita di interesse per il contesto territoriale e la tendenza a instaurare relazioni superficiali è<br />
percepibile infatti dove vi è maggior nomadismo. Il fenomeno ha dimensioni macroscopiche negli<br />
Stati Uniti, ma è diffuso ormai anche nel nostro paese, dove il peso crescente dei valori del<br />
guadagno e della carriera spingono un numero sempre più elevato di giovani adulti al nomadismo<br />
lavorativo, per inseguire la realizzazione della dimensione economica a scapito di quella<br />
relazionale. Il nomadismo non mette radici e non alimenta quella cultura della responsabilità verso<br />
il territorio che è garanzia di scelte volte ad abitare e a sentirsi a casa nel proprio contesto.<br />
Il danno antropologico del nomadismo consiste nella perdita d’interesse per la domiciliarità e nella<br />
tendenza a instaurare relazioni superficiali. Poiché la vita del nostro tempo è retta sull’economia, ci<br />
trasforma da persone e cittadini in consumatori. Le aziende, i loro tempi e i loro prodotti sono le<br />
realtà regolatrici dell’esistenza, con una conseguente depoliticizzazione e spersonalizzazione. Se il<br />
progresso diminuisce in parte la fatica ed il tempo di lavoro, anche il tempo effettivamente libero è<br />
diminuito, poiché aumentano il consumo di altre attività imposte (esempio, il fitness) e gli obblighi<br />
sociali (come le cene di lavoro) che si svolgono nel tempo libero.<br />
L’enorme sviluppo tecnologico non ha quindi prodotto maggiore libertà. La mancanza di tempo per<br />
sé si traduce nella riduzione degli spazi di vita: prima di tutto lo spazio interiore, della riflessione,<br />
antidoto all’alienazione massificante; secondariamente, lo spazio per le relazioni. Nomadismo non<br />
è quindi isolamento, perdita di appartenenza. Sul piano psicologico e sociale ciò contribuisce a<br />
rendere meno sicura la percezione dello spazio urbano, alimenta violenze e microcriminalità, rende<br />
più difficile abitare, con saggezza, cioè umanizzare.<br />
Non va ignorato che lo stesso spazio interno alla famiglia, in quanto nido accogliente e nutritivo, è<br />
anch’esso pericolosamente a rischio di chiusura e autoreferenzialità. La perdita d’interesse per la<br />
domiciliarità favorisce il progressivo isolamento nella casa/guscio. E il guscio, ci ricorda Bachelard,<br />
è freddo e duro nella sua chiusura al mondo esterno, a differenza del nido che è caldo, nutritivo,<br />
relazionale, intimo.<br />
Il vicinato e la genitorialità<br />
Fino a pochi anni fa, esistevano numerose occasioni e spazi quotidiani di condivisione tra famiglie;<br />
il ruolo del vicinato si è oggi perduto a fronte della crescente privatizzazione della famiglia. Il<br />
passaggio dalla dimensione estesa alla sua progressiva nuclearizzazione ha prodotto un<br />
conseguente isolamento sociale ed abitativo che vede la famiglia rinchiusa nel suo appartamento.<br />
Questa insularità psicologica, affettiva, sociale e politica finisce per rendere l’interno sempre più<br />
autocentrato ed indifferente rispetto al contesto della comunità territoriale.<br />
45
Sono spariti gli spazi della transizione che svolgevano un’importante funzione di socializzazione e<br />
sono ormai privi di quelle presenze spontanee infantili ed anziane che animavano le strade e le<br />
piazze.<br />
È necessario perciò progettare e sperimentare la creazione di spazi intermedi di confronto, di<br />
condivisione, di sostegno alle famiglie per contribuire allo sviluppo di una “genitorialità sociale” che<br />
si esprima nella mutua assunzione di responsabilità educativa e sociale da parte delle famiglie e<br />
delle agenzie educative presenti nella comunità locale. Questa “genitorialità diffusa” può forse<br />
contrastare le nuove insicurezze urbane e familiari e favorire la costruzione di contesti in cui la<br />
contrapposizione tra la minaccia esterna e la protezione interna sia attenuata dal recupero del<br />
senso degli spazi intermedi.<br />
Interno/esterno<br />
La famiglia elabora oggi le proprie gioie e sofferenze entro la soglia materiale e psicologica della<br />
propria casa. La frattura tra spazio interno ed esterno è netta. La prospettiva della relazione<br />
assume quindi un rilievo particolare poiché ricrea la comunicazione tra l’interno e l’esterno.<br />
La soglia che separa/collega il privato ed il pubblico, il nascosto e l’esposto è il luogo primo della<br />
domiciliarità che chiude/apre lo spazio interno al suo interagire con la realtà territoriale circostante.<br />
L’esterno è lo spazio esposto, del pubblico, degli adempimenti professionali e sociali, è talvolta<br />
spazio dei non luoghi, è il palcoscenico dove ognuno recita un ruolo. Nei confronti dell’esterno le<br />
relazioni sono spesso contraddistinte dall’indifferenza, dalla sopraffazione, dall’inganno, dalla<br />
violenza.<br />
A casa ci si spoglia delle maschere , dei ruoli sociali e dei comportamenti formali, delle convenzioni<br />
che regolano le relazioni esterne.<br />
Per poter abitare l’esterno occorre poter dare voce alle attribuzioni di senso che regolano i nostri<br />
movimenti, le nostre percezioni, i nostri vissuti della territorialità. Nell’abitare vi è un’esigenza di<br />
riconoscersi nei luoghi che parlano della nostra appartenenza ad essi. La domiciliarità è<br />
espressione di rispetto per il mondo della vita, per i piccoli/grandi riti abitudinari che segnano la<br />
giornata e la restituiscono vivibile e a propria misura.<br />
La cultura della domiciliarità si propone come interpretazione e utilizzo di questi elementi di<br />
abitabilità, non solo per gli spazi interni, ma anche per quelli esterni. I modi di percepire,<br />
rappresentare e vivere il tessuto spaziale connotano luoghi ostili o amici. La relazione con lo<br />
spazio che ci circonda è molto più intensa di quanto non appaia nella frettolosa quotidianità: il<br />
legame affettivo, emotivo, protettivo con lo spazio/ambiente è il fondamento del sentirsi radicati in<br />
esso, percepire l’appartenenza, stabilire relazioni forti con le vie, i rumori, i colori, le atmosfere di<br />
un determinato territorio.<br />
46
La soglia<br />
Nella società di massa gli uomini sono divenuti totalmente privati, sono cioè stati privati della<br />
facoltà di vedere e di udire gli altri, di essere visti e di essere uditi da loro. Sono tutti imprigionati<br />
nella soggettività della loro singola esperienza.<br />
L’esterno prossimo e remoto, dalla zona immediatamente di là dalla soglia, dal pianerottolo al<br />
caseggiato, alla via, al quartiere, fino al più complesso spazio urbano, assume la connotazione di<br />
estraneità, e talvolta di ostilità.<br />
Nell’uscire dalla propria soglia e nell’allargare il proprio limen, si spalanca l’irriducibile connessione<br />
tra interno ed esterno, espressa fin dall’antichità classica. In latino l’avverbio foris, significa fuori di<br />
casa e pubblicamente; ma il sostantivo foris indica anche la porta di casa, l’entrata, l’ingresso il<br />
passaggio. Presso i Romani, la soglia di casa era presieduta da Giano bifronte che aveva il<br />
compito di custodire il passaggio e la mediazione tra l’interno e l’esterno.<br />
La soglia, il simbolo dell’armonizzazione tra il fuori e il dentro, non può e non deve essere fissa,<br />
statica, rigida, ma deve potersi modificare, arretrando o avanzando, per accogliere parti di esterno<br />
o per esporre parti di interno.<br />
La dimensione politica ed etica della domiciliarità<br />
La domiciliarità è un obiettivo, un progetto culturale e politico, un progetto di democrazia e libertà.<br />
Essa diviene perciò espressione sociale e politica di democrazia, contro la violenza che<br />
inevitabilmente si accom<strong>pag</strong>na alla necessità di dover subire scelte eterodirette, anche per quanto<br />
riguarda la vita quotidiana, gli orari, la scelta del cibo, i momenti di silenzio e di riposo, la scelta<br />
delle attività. La domiciliarità è garanzia di democrazia in quanto consente alle persone, quando lo<br />
desiderano e quando si trovano in situazione di malattia o disagio, di poter scegliere di conservare<br />
il diritto di decidere della propria vita.<br />
C’è dunque qualcosa di più ampio del semplice favorire la permanenza a domicilio dei soggetti<br />
anziani o malati: che le persone possano mantenere i loro spazi, le loro abitudini, i loro oggetti, la<br />
casa, la rete del vicinato, la consuetudine degli incontri, i luoghi che sono anche occasioni di<br />
relazione quotidiana: negozi, edicola, centro sociale, insomma la rete della spazialità vissuta, è<br />
fondamentale per il benessere delle persone e quindi per tutta la società.<br />
Numerosi studi di carattere psicologico, sociologico e urbanistico affermano che la casa riveste<br />
(soprattutto per gli anziani) un ruolo di rassicurazione primaria, in quanto luogo protetto. Spesso<br />
essa è luogo della vita, spazio delle mille memorie che rinsaldano e rassicurano l’identità<br />
personale.<br />
In tale contesto la casa assume il ruolo fondamentale di risorsa proprio in quanto è ricca di<br />
memorie vive e di prospettive future. La domiciliarità è quindi l’anello di congiunzione della<br />
temporalità e della spazialità.<br />
La domiciliarità esprime la possibilità di permanere all’interno di un contesto significativo per<br />
l’esistenza: la casa, le relazioni con le cose, il contesto territoriale che la circonda, l’esperienza, la<br />
47
memoria, la storia, le amicizie, ma anche il lessico ed il linguaggio, e pure i percorsi, le piazzette, i<br />
portici, i giardini, le panchine.<br />
Il diritto alla domiciliarità si pone quindi come un nuovo diritto da difendere politicamente e<br />
socialmente in quanto diritto di scelta.<br />
La possibilità di scelta è infatti ciò che caratterizza innanzitutto l’esistenza umana nella dignità della<br />
persona, poiché, come afferma Karl Jaspers, “sono quando scelgo, e se non sono non scelgo”.<br />
Per queste ragioni la domiciliarità non è quindi da intendersi come sinonimo di assistenza<br />
domiciliare: quest’ultima può essere anche uno dei possibili strumenti per la domiciliarità e la<br />
residenzialità, ma a condizione che venga intesa nelle accezioni sopra dette, ossia per integrarsi<br />
con la famiglia, offrire supporto psicologico, sociale e fisico, per fornire forme di<br />
affidamento/accoglienza da parte di un’altra famiglia. È cioè necessario l’intervento domiciliare<br />
integrato per aiutare, per supportare la famiglia nei suoi sforzi, spesso sconosciuti, perché non<br />
arrivi disperata ad un ricovero, ad un allontanamento della persona.<br />
Raccontare gli spazi di relazione tra famiglie e servizi<br />
Una conoscenza qualitativa orienta a comprendere come vivono le famiglie, quali bisogni e risorse<br />
vengono attivati al loro interno, quali le diverse difficoltà che esse devono affrontare nei momenti<br />
svolta del ciclo di vita familiare, quali le modalità ed i vissuti nei rapporti con i servizi in situazioni di<br />
criticità.<br />
In particolare risulta non semplice la conoscenza dei nuovi bisogni delle famiglie: sia quelli<br />
manifesti, immediatamente percepibili in situazioni di difficoltà forti e palesi, espressi ed esprimibili,<br />
sia quelli più nascosti, spesso mascherati, striscianti, intuiti ma inespressi, talvolta non consapevoli<br />
né verbalizzati, nascosti all’evidenza oggettiva eppure dolorosamente percepiti. Nel primo caso i<br />
bisogni sono espressi ed esigono risposte specifiche e integrate tra i servizi, rivestono spesso un<br />
carattere di eccezionale criticità e, nel ciclo di vita familiare, possono irrompere a seguito di eventi<br />
improvvisi ed imprevisti (separazioni, vedovanze, disabilità) o a problematiche connesse con<br />
l’indigenza economica, la presenza di familiari con handicap, tossicodipendenza o malattia. Nel<br />
secondo caso siamo in presenza di una zona grigia del disagio, generalmente connessa con<br />
l’ambito relazionale/educativo, che non assume le connotazioni di vero e proprio problema, non<br />
riveste carattere di eccezionalità quanto di normalità e quotidianità.<br />
Ci si riferisce, per esempio, alla solitudine, alle difficoltà ed alle paure non espresse riguardo<br />
all’assunzione delle responsabilità matrimoniali o procreative, al disaccordo genitori/figli, alle<br />
discussioni di coppia che precedono la separazione o alla conflittualità elevata e permanente<br />
anche quando non sfocia in una separazione, alle stratificazioni di carenze e difficoltà<br />
comunicativo/relazionali che mostrano l’ambiguità del normale disagio quotidiano.<br />
Le problematiche delle trasformazioni e dei bisogni educativi delle famiglie normali esigono però<br />
una precisazione: si tratta, in ogni caso, di una normalità le cui caratteristiche sono sempre<br />
eterogenee ed il confine tra norma e patologia è perennemente instabile ed incerto, sempre a<br />
48
ischio di diventare patologico e di essere assunto dagli esperti nella dimensione clinica e<br />
medicalistica, quanto le problematiche relazionali non sono più governabili dal nucleo stesso e la<br />
famiglia giunge alla richiesta di un intervento esterno da parte dello specialista.<br />
La socialità condivisa<br />
Se un’essenziale indicazione della domiciliarità riguarda la possibilità di aprire le porte del proprio<br />
spazio familiare a quello più vasto del territorio e dell’alterità, anche l’organizzazione dei servizi<br />
deve proporsi con modalità familiari, mantenersi a porte aperte e lasciar esprimere la multiforme<br />
configurazione di bisogni e risorse che un reale protagonismo dei cittadini mette in campo nelle<br />
strategie d’integrazione, di socializzazione e di responsabilizzazione reciproca.<br />
Le reti informali esterne sono il tessuto che sostiene la socialità diffusa, poiché modalità interattive<br />
caratterizzanti lo spazio pubblico come partecipazione richiedono la costruzione di legami<br />
significativi tra le persone. Le occasioni d’incontro possono portare a consapevolezza le risorse e<br />
promuovere le competenze che rendono cittadini e famiglie attivi protagonisti in grado di costruire<br />
insieme auto/mutuo aiuto e promozione di responsabilità. Sostenendo l’associazionismo, i gruppi<br />
d’incontro, la vita del quartiere, si costruisce la comunità locale il cui luogo peculiare nella<br />
promozione del benessere e della coesione sociale è indicato anche dalla legge 328, che individua<br />
nel lavoro di comunità il perno del lavoro con le famiglie e del lavoro sociale. Il territorio diventa<br />
così una realtà vissuta dove si può diffondere una apertura all’alterità, alla comunicazione,<br />
all’incontro, alla solidarietà sociale, dove l’etica della responsabilità presieda alla costruzione delle<br />
reti comunitarie.<br />
La domiciliarità, oltre alla dimensione sociale e politica, rinvia ad una dimensione etica per cui la<br />
persona non è più intesa passivamente come fruitrice di un servizio pensato da altri, bensì rivolto<br />
alla persona umana, nella sua globalità, co-protagonista di un servizio, rispettandone il senso di<br />
appartenenza ecosistemica al territorio. Il concetto di domiciliarità diventa così fulcro di<br />
cambiamento da una prospettiva di servizi che forniscono risposte statiche ad una concezione dei<br />
servizi flessibili, che sanno cambiare adattandosi alle diverse realtà e ai diversi bisogni, nel loro<br />
mutare diacronico e sincronico.<br />
Occorre che la rete informale del vicinato e le più strutturate reti territoriali rappresentino un solido<br />
fondamento nella costituzione del welfare locale, poiché il territorio non è soltanto un luogo<br />
geografico, fisico, da attraversare, ma è un luogo denso di vissuti, emotivamente significativi,<br />
determinati dalle relazioni.<br />
La solidarietà e il lavoro di rete<br />
Ci sono termini che costituiscono il lessico di riferimento di un determinato periodo socio- culturale.<br />
Tra questi, negli anni Novanta, si diffuse la parola “rete” (ma anche sinergie, promozione,<br />
empowerment, cura ecc.) che ha assunto un valore predominante come espressione di un<br />
pensiero e di strategie di collaborazione tra i servizi. Negli stessi anni andavano contestualmente<br />
dismesse parole come assistenza, che rinviavano ad una visione dei servizi passivizzante.<br />
49
Si affacciava inoltre sulla scena della politica sociale un soggetto nuovo dal punto di vista dei<br />
servizi sociali: la famiglia, intesa come soggetto co- protagonista di interventi direttamente volti alla<br />
sua promozione e non semplice destinataria indiretta di servizi rivolti a specifiche categorie di<br />
utenti. (anziani, minori, disabili ecc.)<br />
Per progettare politiche familiari innovative ed efficaci, adeguare alle veloci trasformazioni della<br />
fisionomia familiare, in una prospettiva di prevenzione del disagio e di promozione della risorsa<br />
famiglia, è necessaria l’attivazione di collaborazioni e sinergie tra i servizi che, a vario titolo e con<br />
diverse modalità, direttamente o indirettamente, operano con/per le famiglie.<br />
La volontà, la fatica, la determinazione comuni per costruire un retroterra di riferimento sono<br />
necessarie per la realizzazione di politiche sociali dove la collaborazione non s’improvvisi e dove il<br />
fare insieme sia il risultato di un pensare insieme, conoscere insieme, discutere, e quindi di una<br />
formazione comune.<br />
Purtroppo la storia dei servizi sociali e del volontariato è fortemente permeata di un senso di<br />
appartenenza e di identità che spesso induce ciascuno a ritenere di operare nel migliore dei modi<br />
possibile, in un atteggiamento mentale non esente da una certa diffidenza verso gli altri. Fino a<br />
quando non prestiamo occhi ed orecchi per vedere ed ascoltare che cosa fanno gli altri accanto a<br />
noi, non compiamo lo sforzo di uscire dalla soglia che delimita l’interno del servizio o del gruppo o<br />
dell’associazione per incontrare l’esterno, e non possiamo dire di esserci “messi in rete”.<br />
Questa è anche la bellezza, l’importanza, l’utilità del lavoro di rete: il confronto che si arricchisce<br />
dell’originalità di cui ciascuno è portatore. La differenza è un valore fondamentale che deve essere<br />
salvaguardato, senza temere di dover rinunciare alla propria identità, alla propria autonomia, alla<br />
propria specificità nello scambio di esperienze e di visione dei problemi.<br />
Il lavoro di rete deve essere interrogato e messo in questione riguardo alla proprietà del concetto<br />
stesso della parole chiave “rete”, che può essere in un certo senso riduttiva della ricchezza che si<br />
accom<strong>pag</strong>na alla reale esperienza di lavoro comune. La rete è infatti una maglia fatta di nodi ma<br />
anche di fori vuoti; è inoltre uniforme, statica, si può soltanto estendere in larghezza ma non<br />
modifica la struttura delle sue maglie.<br />
Inoltre la rete è foggiata per contenere o per irretire; non è viva, dinamica, feconda di azione. A ciò<br />
si aggiunga l’ambiguità semantica sopraggiunta in seguito alla diffusione della rete informatica,<br />
delle comunità artificiali originate dalla società telematica.<br />
A ben vedere quindi il concetto di rete non risulta adeguatamente rappresentativo di ciò che<br />
interagisce tra i servizi nel loro incontro, della ricchezza straordinaria di ampliamento di prospettive<br />
che ne consegue.<br />
Sarebbe forse più appropriato, in luogo del termine “rete”, parlare di lavoro condiviso e di strategia<br />
del creare connessioni, dove il con (cum) unisce i termini e concetti in una sequenza di parentele<br />
semantiche che hanno origine, anche etimologica, nel medesimo prefisso.<br />
50
Il cum rinvia infatti a ciò che è “in comune” ed alla “comunità”, al collaborare, al collegare, alla<br />
collettività, al connettere.<br />
Questione preliminare è allora capire che cosa è una comunità oggi, nella società telematica, in cui<br />
gli scambi di aiuto tra le persone e tra le famiglie sono sempre più decontestualizzati, che sappiano<br />
andare oltre protocolli d’intesa formali.<br />
Il diritto di cittadinanza e la coesione sociale<br />
Le trasformazioni sociali repentine e di forte intensità che stanno oggi attraversando la nostra<br />
società pongono all’attenzione irrinunciabile degli amministratori, de responsabili delle politiche<br />
sociali, degli operatori e di tutti i cittadini, i temi della coesione, della partecipazione e dei diritti di<br />
cittadinanza, per poter progettare politiche rivolte al continuo miglioramento della qualità della vita.<br />
L’incalzante trasformazione nella composizione sociale, nei rapporti intergenerazionali, nei nuovi<br />
media che hanno radicalmente modificato le tradizionali modalità comunicative, ripropone le<br />
tematiche relative alla coesione sociale, o meglio, alle possibili strategie per attivare nuove<br />
modalità di comunicazione e di coesione.<br />
Alcune esperienze di sviluppo di comunità hanno confermato l’importanza del coinvolgimento e<br />
della mobilitazione di una molteplicità di soggetti, in posizione anche molto diversa nel livello della<br />
gerarchia sociale, del pubblico e del privato, espressioni di realtà formali ed informali.<br />
Abitare la terra<br />
Rivoluzioni concettuali di enorme portata stanno attraversando, da quasi un secolo, il pensiero<br />
scientifico tradizionale, le leggi delle singole scienze, la tecnica ed i suoi strumenti. Interrogativi<br />
sulle interpretazioni di un habitat che si rivela sempre più complesso e sul senso degli interventi<br />
tecnologici sollecitano considerazioni e rappresentazioni nuove del rapporto tra il soggetto umano<br />
e l’ambiente che egli abita. Per comprendere la posizione della persona nel mondo/ambiente è<br />
necessaria una nuova visione della scienza e una filosofia ecologica, richiedenti coraggio, rigore,<br />
saggezza, pazienza, responsabilità, umiltà.<br />
La logica della manipolazione e dello sfruttamento ha progressivamente mostrato il suo fallimento<br />
e si è sempre acceso l’interesse a comprendere la complessità e l’incessante trasformazione di<br />
una terra sottoposta a continue, spesso imprevedibili e caotiche, trasformazioni che si ripercuotono<br />
sui modi della abitabilità ed esigono strumenti nuovi per pensare l’umanità ed il cosmo secondo<br />
una razionalità nuova.<br />
Per ripensare in maniera profonda e permanente queste tematiche, sono necessarie conoscenze<br />
(chimiche, fisiche, biologiche, geologiche, antropologiche, sociologiche, economiche, storiche,<br />
politiche) atte a intervenire, migliorare, correggere, prevenire, ma sono innanzitutto indispensabili<br />
una volontà ed un telos che orientino assiologicamente queste conoscenze. Occorre cioè<br />
individuare un orizzonte di senso che fornisca il fondamento a percorsi differenti, per area<br />
disciplinare e fornisca il fondamento a percorsi differenti, per area disciplinare e contesto,<br />
51
configurando la prospettiva etico- concettuale generale a cui ricondurre la specificità dei singoli<br />
argomenti che concorrono ad un progetto serio e organico di educazione ambientale.<br />
La conoscenza profonda delle ragioni intrinseche al determinarsi storico di questo stato di degrado<br />
non può essere un semplice sapere teorico, ma deve configurarsi come una conoscenza<br />
modificatrice, o comprensione trasformatrice che coinvolge il livello etico, scientifico, politico e<br />
quello pedagogico, poiché implica una modificazione radicale dei presupposti epistemologici e dei<br />
modelli scientifico- concettuali sui quali si fonda quel rapporto uomo- natura e uomo- società che<br />
ha condotto l’umanità all’attuale condizione.<br />
Physis e responsabilità<br />
Modificare l’atteggiamento generale nei confronti della scienza e della tecnica, e del loro uso,<br />
postula un nuovo modo di pensare che, prima di tutto, si domandi se la scienza e il progresso<br />
tecnologico siano per l’uomo o contro l’uomo. Tale interrogativo ne implica molti altri: ad esempio<br />
se la scienza persegua un orientamento o se essa sia neutrale, se le sue leggi siano oggettive,<br />
assolute, immodificabili, se l’uso che si fa della conoscenza sia sempre volto a produrre felicità e<br />
liberazione, o se non generi invece ulteriori schiavitù.<br />
Il primato di un’oggettività razionalizzatrice in senso classico si preclude numerosi aspetti di<br />
conoscenza del reale poiché lo interroga secondo parametri unidirezionali e precostituiti. Una<br />
razionalità aperta alle nozioni di possibilità e di cambiamento consente di affrontare la<br />
multidimensionalità. La complessità, comprensiva del caso e dell’imprevisto, apre nuove possibilità<br />
conoscitive della natura e degli aspetti del creato. Ulteriori prospettive sulle origini e sul mutare<br />
dello spazio e del tempo rendono conoscibili la physis ed i modi secondo cui l’umanità ha abitato la<br />
terra, attraverso una molteplicità di itinerari scientifici, vincolati dalle leggi della storia universale,<br />
ma non necessitati in modo predeterminato.<br />
Si è progressivamente incrinato, nelle epistemologie contemporanee, il radicato pregiudizio<br />
scientifico/culturale che aveva per secoli occultato le tematiche riguardanti il rapporto del soggetto<br />
con la scienza e la spiegazione lineare che ignorava la complessità. Riscoprire il valore della<br />
persona e della relazione soggetto/mondo, può favorire un diverso modo di accedere alla<br />
conoscenza scientifica e produrre comportamenti più saggi verso l’ambiente.<br />
Il soggetto umano non è una cosa tra le altre cose, né di fronte al mondo, ma è in una perenne<br />
apertura intenzionale al mondo comune n cui è posto a esistere. Il mondo- ambiente è mondo di<br />
noi tutti, essendo la persona centro di un mondo circostante. Nessuno può prescinderne e<br />
ciascuno ne è responsabile. La coscienza di appartenere al mondo della vita è responsabilità<br />
storicamente fondata perché consente una presenza nel mondo e una conoscenza non passiva o<br />
indifferente o avidamente saccheggiatrice, ma progettuale e responsabile. L’educazione<br />
ambientale autentica deve perciò alimentare la capacità di discernimento e la responsabilità di<br />
ognuno ne confronti dell’ambiente come realtà che ci riguarda.<br />
52
All’origine dell’interesse per l’educazione ambientale si situa la rottura dell’equilibrio biologico e<br />
dell’ecosistema planetario. Il problema è diffusamente conosciuto nelle sue dimensioni generali più<br />
palesi e immediate; sono inoltre generalmente condivisi gli obiettivi parziali attraverso cui risolvere<br />
la crisi.<br />
Tuttavia questi obiettivi, facilmente individuabili, sono in realtà ben lungi dall’essere attuati poiché,<br />
nella maggioranza dei casi, si continua a procedere secondo le medesime linee di scelte<br />
etico/politiche e di percorsi scientifici che hanno prodotto l’attuale situazione di crisi. Non bastano<br />
perciò le momentanee indignazioni o le occasionali proteste perché possa mutare il percorso di<br />
questo sistema che si ritorce contro la vita umana. Nonostante la consapevolezza diffusa dei<br />
problemi ambientali, non siamo in prossimità di una risoluzione ma, verosimilmente, di un ulteriore<br />
peggioramento, se non si affronta l’esigenza di ripensare i parametri interpretativi del rapporto<br />
soggetto- mondo.<br />
La scienza ha perduto il soggetto?<br />
La criticità della situazione ambientale, espressione della crisi che attraversa la società e la cultura<br />
contemporanea a vari livelli, può essere compresa e trasformata se è ricondotta alle ragioni della<br />
crisi del modello scientifico oggettivistico di conoscenza della realtà.<br />
La pretesa oggettività della conoscenza si fonda sul paradigma cartesiano che intende per metodo<br />
una precostituita strategia o procedimento controllabile e applicabile da parte di un soggetto (res<br />
cogitans) a un determinato oggetto (res extensa). Galileo, nella matematizzazione del mondo<br />
naturale, ha posto a fondamento del suo pensiero un universo oggettivamente misurabile,<br />
consolidando un’accezione di scientificità che è oggettiva in quanto polarizzata sulla realtà esterna<br />
al soggetto. L’eredità positivista ha infine consegnato al pensiero scientifico tale primato<br />
dell’oggettività, che esclude ogni ingerenza della soggettività. È invece necessario indicare i limiti<br />
dei paradigmi scientifici oggettivanti, innanzitutto perché nessuna obiettività può descrivere un<br />
oggetto nella sua complessità o, tanto meno, nel suo senso, ma solamente un suo aspetto. Si<br />
tratta perciò sempre di un’oggettività relativa, perché riferita allo specifico modo di vedere da cui si<br />
guarda l’oggetto. Di conseguenza, questa oggettività è sempre parziale. L’allontanamento del<br />
soggetto dall’oggetto è quindi una finzione scientifica, poiché la soggettività del ricercatore orienta<br />
la conoscenza, decide quali ipotesi seguire, quali strumenti di ricerca impiegare per le verifiche.<br />
Nessuna indagine può considerarsi totalmente a-valutativa. Il soggetto non può essere eliminato<br />
nella conoscenza oggettiva, la quale comporta, sì l’esserci di qualcosa, ma soprattutto l’esserci di<br />
colui che conosce.<br />
È doveroso sottolineare che la coincidenza della scientificità con l’oggettività è talmente radicata<br />
nella nostra cultura che, anche nel linguaggio corrente, i termini scientifico, oggettivo, neutro, sono<br />
addirittura reputati sinonimi. A ben vedere, però, ogni descrizione e definizione scientifica<br />
comprende sempre qualcosa di incerto o di arbitrario: vi sono sempre decisioni e scelte, e quindi è<br />
inevitabilmente richiamato in causa il soggetto che decide e sceglie.<br />
53
Queste premesse inducono a considerare la distruzione ambientale come conseguenza estrema<br />
della separazione e contrapposizione soggetto- mondo. Archimede, Leonardo, Galileo deposero<br />
l’uso della loro scoperte scientifiche e tecniche al servizio del potere, e, talora, della guerra, senza<br />
avvertire dubbi o contraddizioni. Con l’età della rivoluzione industriale e con il positivismo si venne<br />
anzi consolidando la concezione della scienza portatrice di progresso e l’equivalenza progresso-<br />
felicità.<br />
La scienza, in sé neutra, oggettiva, alimentava l’utopia di una progressiva liberazione dal lavoro,<br />
dalla malattia, dal dolore stesso. Per molti secoli il problema della neutralità scientifica non fu<br />
avvertito nella drammaticità con cui è stato proposto all’attenzione mondiale dopo la bomba di<br />
Hiroshima. Ed è solo dagli anni Sessanta in poi che le tematiche ecologiche hanno assunto<br />
un’importanza crescente in relazione a un crescente degrado ambientale, conseguente anche ai<br />
modi dell’industrializzazione. Si è iniziato quindi a porre le premesse per il passaggio dall’idea di<br />
dominio della natura all’idea di protezione dell’ambiente e al concetto di ecosistema comprendente<br />
anche il soggetto. L’ecosistema non è infatti un collegamento tra le parti che lo compongono,<br />
poiché esse interagiscono e si modificano in seguito alle interazioni., poiché esse interagiscono e<br />
si modificano in seguito alle interazioni, cambiando continuamente la fisionomia del sistema<br />
stesso. Un ecosistema, riprendendo la definizione di Morin, è da intendersi come l’insieme delle<br />
interazioni che si stabiliscono tra i componenti di quella unità complessa che è un sistema di<br />
viventi.<br />
Soggetto e mondo- ambiente<br />
La “pars destruens” fin qui configurata ha inteso porre in luce i limiti di una scientificità causalistica<br />
e oggettivante che ha perduto il soggetto. La critica non intende rivolgersi alle indiscusse<br />
possibilità aperte alla conoscenza dalle scienze esatte, quanto alla loro pretesa assolutizzazione o<br />
esaustività, all’universalità di un modello di esattezza al quale ricondurre (o ridurre) ogni altra<br />
conoscenza.<br />
Da queste scienze esatte derivano molti benefici e può dipendere la salvezza per l’umanità, purché<br />
sia eticamente orientato dal soggetto che sceglie quale uso fare delle conoscenze. Esse non sono<br />
in sé buone; è piuttosto l’uso che se ne fa a renderle buone o scellerate.<br />
La pars construes che segue intende delineare alcuni orientamenti culturali e modelli scientifico-<br />
valoriali che consentano di recuperare il soggetto nella conoscenza scientifica, poiché la posizione<br />
della persona umana nel mondo ambiente ed il suo rapporto con la natura e con gli altri sono il<br />
problema di fondo di un’autentica educazione ambientale. La ricerca di senso di una scienza che<br />
sfugge al soggetto o si ritorce contro di lui chiede di riconsiderare la funzione delle scienze per<br />
l’esistenza umana e il rapporto uomo- ambiente e uomo- natura in una prospettiva di reciprocità e<br />
interazione continua, superando i sovvertimenti che, nel suo cammino storico, hanno<br />
progressivamente alienato la scienza, rendendo l’uomo schiavo di quella tecnica da lui stesso<br />
disumanizzata.<br />
54
Tutto ciò ha evidenti risvolti politici e pedagogici, poiché l’educazione tende a fornire stimoli e<br />
aperture continuamente rinnovantisi, e non schemi prefabbricati entro cui chiudere le possibilità<br />
cognitive. L’educazione non può scindere la scienza dalla vita, poiché la vita sostanzia sempre di<br />
una relazione reciproca del soggetto nel mondo e con gli altri. Ne va della costruzione stessa dello<br />
sviluppo del pensiero scientifico e della storia dell’umanità. Un rapido accenno alle alternative<br />
epistemologiche più significative consente di individuare modelli di nuova scientificità utili alla<br />
comprensione del rapporto soggetto- ambiente.<br />
Dall’osservazione dei fallimenti di una scientificità che si presume infallibile, nacquero nuove<br />
epistemologie già verso la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Le scienze fisiche e<br />
matematiche attraversarono, intorno agli anni Trenta, una grande crisi che travolse le concezioni<br />
galileiano- newtoniane e la geometria euclidea. Si sviluppò un vasto rinnovamento di pensiero che<br />
ebbe la discussione più importante e feconda nell’ambito del Circolo di Vienna. Al verificazionismo<br />
si oppose il metodo di Popper, che individuava un più sicuro elemento di rigore scientifico nel<br />
criterio della falsificabilità: la scoperta scientifica non procede infatti soltanto attraverso la verifica di<br />
teorie, ma con i tentativi di falsificazione delle stesse. Includendo nel progetto scientifico la<br />
possibilità dell’errore, Popper propose una concezione nuova della scienza includente la fallibilità.<br />
Verso nuove concezioni della scienza<br />
Rigore e obiettività restano requisiti indispensabili ad ogni indagine scientifica; ma non possono più<br />
essere intesi in senso univoco. Nelle più recenti epistemologie si persegue un rigore rinnovato,<br />
soprattutto attraverso l’attenzione posta alle interazioni tra la scienza ed i contesti culturali, storici e<br />
sociali. Si afferma la necessità di un telos e il rifiuto di assolutizzazioni e dogmatismi scientifici, che<br />
finirebbero per ridurre la realtà a reticoli di catalogazioni. Si fa strada la necessità di allargare la<br />
scientificità salutari trasgressioni, le quali si aprano al valore dell’intuizione, della fantasia,<br />
dell’immaginazione e del caso.<br />
Per una rapida schematizzazione possono essere segnalati: a) gli orientamenti più significativi, e<br />
metodologicamente idonei alle problematiche dell’ambiente, della teoria sistematica di Bateson e<br />
Von Bertalanffy; b) le indicazioni scaturite dall’epistemologia francese e in particolare da Morin; c)<br />
la riflessione della fenomenologia, attenta ad una scientificità che abbia al suo centro la persona<br />
umana; d) le speculazioni formulate dai postpopperiani, culminati nell’anarchia metodologica di<br />
Feyerabend.<br />
a) La teoria generale dei sistemi<br />
Un ruolo decisivo nella dimensione del rinnovamento epistemologico ed ecologico è svolto dalla<br />
teoria dei sistemi che, contribuendo a superare il divisionismo ed il riduzionismo della scienza<br />
tradizionale e, aprendosi alla complessità, si rifà alla concezione di un ecosistema al cui interno,<br />
secondo quanto affermano Von Bertalanffy e Bateson, nessuno degli elementi può essere<br />
considerato singolarmente e disgiunto dal sistema. Gli infiniti corpi contenuti nel sistema- ambiente<br />
non sono indipendenti e quindi non è possibile pensare ad una conoscenza specialistica settoriale,<br />
55
divisionistica e statica che conosca le parti, ignorando il contesto, le modificazioni e le evoluzioni<br />
continue del sistema e dei suoi componenti.<br />
Se i parametri della spiegazione scientifica classica non potevano indagare la complessità, la<br />
contraddizione, il multiforme, ed escludevano il soggetto, la teoria sistematica avverte l’esigenza di<br />
una nuova comprensione della complessità, dell’indeterminatezza, della soggettività. Von<br />
Bertalanffy rifiuta le interpretazioni meccanicistiche e biologistiche della spiegazione dei<br />
comportamenti umani, e rifiuta altresì soluzioni irrazionalistiche, elaborando la concezione di un<br />
sistema in cui, modificandosi uno degli elementi che si trovano in rapporto al suo interno, si<br />
determina una modificazione di tutti gli altri. Il procedimento sistemico costituisce un notevole<br />
passo avanti, poiché i vari oggetti di studio non sono più considerati separatamente ma soltanto<br />
all’interno di complessi organizzati in cui gli elementi interagiscono: l’unità è non una semplice<br />
somma dei suoi elementi bensì un complesso dinamico e multiforme, significativo per i suoi<br />
componenti, ai quali cede e dai quali riceve significati. Questa concezione fonda i concetti decisivi<br />
di ecologia e di ecosistema.<br />
La conoscenza dell’ambiente risponde non solo alle leggi dell’oggettività dei dati di fatto ma anche<br />
alla dinamica interazione tra le varie componenti che lo costituiscono (ossia tra soggetti e oggetti,<br />
soggetti e dati, soggetti e soggetti, oggetti e oggetti). Il pensiero ecosistemico non solo mette in<br />
risalto le relazioni tra gli organismi viventi, ma consente anche il superamento di una visione<br />
dell’universo come realtà esterna, passiva, statica, inerte, oggetto di conoscenza.<br />
Ne consegue il superamento della frammentazione del mondo in una molteplicità di saperi irrelati.<br />
La settorializzazione dei saperi produce infatti un tipo di conoscenza strumentale, avente come<br />
fine la manipolazione, lo sfruttamento e la sottomissione dell’ambiente- natura, mentre la<br />
concezione ecologica prevede di sostituire all’atteggiamento di imposizione alla natura delle leggi<br />
dell’uomo, l’atteggiamento più cauto di chi pensa di avere da imparare dalla natura.<br />
b) L’epistemologia francese<br />
Il contributo dell’epistemologia francese sottolinea l’insufficienza dell’analisi logico- formale e del<br />
monismo metodologico che scaturisce dal neopositivismo. Duhem, Koirè e Bachelard forniscono<br />
riflessioni sulla scienza come percorso tortuoso, costellato d’incertezze e dubbi che mettono in crisi<br />
il continuismo nel percorso scientifico, aprendo la via ai successivi approfondimenti di Morin.<br />
Duhem pone in luce l’immenso potenziale scientifico contenuto nelle ipotesi, piuttosto che nel loro<br />
consolidamento attraverso le verifiche sperimentali. In tal senso, opera una grande innovazione<br />
epistemologica, aprendo l’attenzione scientifica sull’importanza del momento intuitivo-<br />
immaginativo, proprio della soggettività, da cui scaturisce l’ipotesi, tradizionalmente considerata<br />
meno importante rispetto all’esperimento ed alla verifica. Koirè e Bachelard, in contrapposizione<br />
con le impostazioni classiche, rifiutano il continuismo nel percorso scientifico e segnalano invece le<br />
discontinuità, le rotture, i ritorni, gli arresti e le inversioni. L’itinerarium mentis in veritatem non è<br />
56
lineare, solare e monorazionale; non segue una via diritta, ma fa esperienza anche di tortuosità,<br />
discontinuità, vicolo ciechi.<br />
Bachelard rifiuta poi l’astrattezza della logica matematizzante tradizionale, proponendo i concetti di<br />
ostacolo epistemologico, e di rottura epistemologica. Lo sviluppo del pensiero scientifico è fatto<br />
della capacità di operare anche salti, soste e inversioni di fronte agli ostacoli. Il procedimento<br />
scientifico chiama in causa tutte le complesse orme di produzione dell’intelletto umano: razionali,<br />
intuitive e immaginative.<br />
Morin, infine, mostra i limiti di una scienza oggettiva che ha perduto il suo soggetto, lamenta che la<br />
ricerca scientifica contemporanea si fondi sulla specializzazione esclusiva, su di un frammento la<br />
cui visione d’insieme deve sfuggire a tutti e ad ognuno. Nel domandarsi se possa esservi una<br />
conoscenza scientifica che non abbia soggetto, egli ripropone con forza la necessità, per la<br />
scienza, di ricollocare l’uomo nel mondo. A causa di un metodo che separa, isola, misura, le<br />
strutture dei singoli saperi sono dissociate tra loro, si toccano solo per qualche confine periferico.<br />
Così l’uomo si sbriciola, polverizzato in informazioni, dissociato tra le scienze e le discipline.<br />
Occorre quindi riapprendere ad apprendere, sulla base di un sapere che possa articolare e<br />
collegare la scissione soggetto/oggetto, fondata sull’illusione di una conoscenza soggettiva ed<br />
assoluta. Il metodo si fa allora un anti-metodo, la confusione è intesa come virtù, il dubbio è<br />
categoria della scienza.<br />
In tal senso l’opera di Morin, debitrice d’intuizioni husserliane e sistemiche, sfida la scientificità<br />
tradizionale, mettendo in mostra i limiti di una scienza oggettiva e giunge a proporre un non<br />
metodo, sottolineando la relatività e la parzialità di qualunque teoria.<br />
La semplificazione in quanto sintesi totalizzante, conduce all’eliminazione di tutto ciò che non è<br />
riconducibile allo schema comprensivo precostituito.<br />
c) La fenomenologia<br />
Il percorso compiuto da Husserl e dalla teoria fenomenologica è d’importanza fondamentale per<br />
superare la contrapposizione soggetto- oggetto. Attraverso la teoria dell’intenzionalità è resa<br />
possibile una conoscenza che non si rivolga all’oggetto- mondo in sé, come ovvio e dato, ma<br />
all’atto intenzionale che apre un nuovo e inesplorato spazio di esperienza al soggetto<br />
intenzionante. La conoscenza intenzionale è volta al mondo che è sempre mondo per una<br />
coscienza e non ha senso senza il soggetto che lo conosce.<br />
La fenomenologia prospetta la validità scientifica di un metodo in cui il soggetto non si ritragga per<br />
far posto all’oggetto, ma sia chiamato direttamente in causa per superare l’anonimato di una<br />
scienza senza soggetto. Se la conoscenza scientifica, imposta dalla tradizione, è passiva in quanto<br />
si polarizza sulla realtà esterna, la fenomenologia insegna un modo attivo e responsabile di vedere<br />
il mondo. Per conoscere il mondo- ambiente, la fenomenologia propone il superamento della<br />
contrapposizione tra soggetto e oggetto, e indica la perenne circolarità che li lega.<br />
57
Un’educazione ecologica passa necessariamente attraverso l’assunzione di consapevolezza che il<br />
soggetto è il suo stesso mondo e non è scientificamente significativo prendere in considerazione<br />
né il mondo senza il soggetto che lo abita, né il soggetto senza il suo mondo. Attraverso il metodo<br />
fenomenologico è quindi possibile riconsiderare il rapporto uomo- ambiente e uomo- natura in una<br />
prospettiva di reciprocità e d’interazione continua in cui non vi sia quella separatezza o<br />
contrapposizione dei due poli che conduce al rapporto di sfruttamento indiscriminato da parte<br />
dell’uomo e alle conseguenti possibili ritorsioni da parte della natura che incombono sull’umanità.<br />
Cadrebbe infatti il senso stesso dell’educazione ambientale se non fosse affrontata sulla base di<br />
un rapporto soggetto- mondo che sappia valorizzare il sentire e la volontà nell’assunzione di<br />
responsabilità per la natura.<br />
d) L’anarchia metodologica<br />
Da ultimo, sono da menzionare i cosiddetti “postpopperiani”, che hanno analizzato con particolare<br />
interesse gli aspetti storico- culturali condizionanti il cammino della scienza. Nel porre in risalto<br />
l’influsso delle visioni del mondo sulle ricerche scientifiche, e rifiutando la neutralità di un asettico<br />
ideale di rigore, essi hanno posto l’accento sulle implicazioni storiche, culturali, istituzionali, sociali<br />
della scienza.<br />
Lakatos ha aperto il modello di razionalità a un’interpretazione storicizzata. Kuhn afferma<br />
esplicitamente la non neutralità della scienza, inserendo i paradigmi scientifici nel più vasto<br />
processo sociologico e culturale, ed esaltando la stretta relazione tra lo sviluppo scientifico e gli<br />
sviluppi culturali e storici del contesto in cui questo si colloca.<br />
Più radicale è la posizione di Feyerabend contro una certa repressione metodologica, che ha<br />
ridotto ad alcune ristrette regole il mondo della ricerca. Egli concepisce un’anarchia metodologica<br />
attraverso la totale apertura a qualsiasi alternativa. Le violazioni ai principi fermi e immutabili sono,<br />
secondo Feyerabend, necessari per il progresso scientifico, poiché la scienza è un’attività piena di<br />
lacune e contraddizioni e l’ignoranza, l’ostinazione, il pregiudizio, la menzogna, lungi dall’impedire<br />
il progresso della conoscenza, ne sono presupposti essenziali”, mentre i requisiti tradizionali della<br />
scientificità oggettiva producono un ristagno progressivo della ricerca.<br />
Confutando le teorie fondate sulla spiegazione e sulla riduzione proprie del metodo deduttivo, egli<br />
rivendica una maggiore libertà e, provocatoriamente, auspica una proliferazione di alternative<br />
critiche rispetto ai canoni metodologici.<br />
Feyerabend rileva lo sviluppo contorto del pensiero scientifico, e denuncia la non neutralità della<br />
scienza che è invece alquanto condizionata dalle visioni del mondo e dalle ideologie. Nonostante<br />
gli eccessi di estremizzazione, il contributo epistemologico di Feyerabend contribuisce a<br />
ridimensionare, dialettizzare e rendere più caute nei loro assunti tutte le scienze, a evidenziarne i<br />
rapporti col potere, le strumentalizzazioni e le alienazioni. Ne conseguono posizioni pedagogiche<br />
che si oppongono all’introduzione dei metodi positivistici nei sistemi formativi, poiché questi<br />
incoraggiano l’uniformità di pensiero rispetto all’autentica libertà.<br />
58
Ecologia e assiologia<br />
Un’educazione ambientale che si avvalga dei nuovi orizzonti epistemologici è quindi da intendersi<br />
come educazione a un mondo di valori ed a una scelta nel proprio modo di porsi nel mondo. A<br />
conclusione di questo sguardo sui modelli scientifici in grado di fornire alcune indicazioni di senso<br />
sulla ricostruzione di una più equilibrata relazione tra la persona e l’ambiente va ribadita l’urgenza<br />
di progettare, attraverso una diversa educazione, un’inversione di orientamento.<br />
Ogni discorso di educazione ambientale chiama in causa non solo le scienze della natura, bensì<br />
tutte le scienze, umane e naturali, ed esige rinnovati paradigmi scientifici inerenti innanzitutto al<br />
rapporto uomo- ambiente. La conoscenza ecologica presuppone una scienza per l’umano e si<br />
oppone ad una scienza dis- umanizzata, alienata, volta allo studio di una natura oggettivamente<br />
data o di un ambiente esterno alla persona, “altro” da lei. L’educazione ambientale, nata dalla<br />
Conferenza di Stoccolma del 1972, si è via via sviluppata dagli aspetti fisici e biologici agli aspetti<br />
economici e socio- culturali, poiché l’ecosistema include necessariamente l’uomo. Dall’ambito delle<br />
scienze naturali si è venuto portando l’attenzione all’ambito delle scienze umane. L’educazione<br />
ecologica fa oggi riferimento ad un “ambiente” che non è soltanto quello della biologia o della<br />
geologia, ma è anche quello dei rapporti giuridici, economici, politici, sociali. In senso più vasto è<br />
l’ambiente con cui l’uomo è in rapporto di continua vitale relazione, in senso civico, emotivo,<br />
affettivo.<br />
Per progettare l’educazione ambientale si dovranno coerentemente individuare i fini generali a cui<br />
tendere ed i valori chiamati in causa, poiché l’ecologia non è separabile dalla teleologia e dalla<br />
assiologia. L’educazione ecologica non si può infatti limitare all’informazione sulla rimozione delle<br />
cause immediate e particolari, ma dovrebbe tendere alla ricerca di un senso nel rapporto del<br />
soggetto con il suo mondo, fondandosi su di una ecologia profonda.<br />
A differenza dell’ecologia “superficiale”, l’ecologia profonda pone l’attenzione ai rapporti etici e<br />
scientifici tra uomo e mondo, e richiama alla saggezza della terra, invita a non disgiungere i<br />
problemi delle scelte personali e dalle responsabilità collettive, la crescita spirituale da quella<br />
scientifica, l’approccio etico da quello tecnico, secondo una globalità di relazione soggetto- mondo<br />
che ha senso soltanto in quanto gli interventi umani sono improntati alla saggezza.<br />
Tra le fonti dell’ecologia profonda sono infatti individuati quei pensatori (come Needlman e<br />
Heidegger) che hanno formulato una decisiva critica alla filosofia occidentale ed al dominio della<br />
tecnocrazia, invitando ad abitare la Terra secondo la dimensione dell’autenticità.<br />
È questa una prospettiva individuabile nei fondamentali lavori di educazione ambientale di Mortari,<br />
che prende in considerazione le diverse prospettive di eco- etica con particolare riferimento<br />
all’ecologia profonda, indicando la messa in discussione dell’educazione etica come acquisizione<br />
di norme per declinarla, invece, come ipotizzato dalla deep ecology, nella forma di una<br />
59
idefinizione della cornice ontologica che fa da sfondo al pensare in quanto presupposto a un<br />
diverso sentire morale nei confronti del resto della natura.<br />
L’esempio di Agenda 21 Locale per lo sviluppo sostenibile<br />
Questo breve percorso all’interno dell’educazione ecologica, può essere ulteriormente calato in<br />
un’esperienza concreta che traduca le premesse epistemologiche e la cultura della domiciliarità, fin<br />
qui delineate, in una reale iniziativa che coinvolge numerosi Paesi europei ed italiani: Agenda 21 ,<br />
che è il Piano d’Azione dell’ONU per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile per il<br />
ventunesimo secolo, definito dalla Conferenza ONU “Sviluppo e Ambiente di Rio de Janeiro nel<br />
1992, e sottoscritto da 180 Governi.<br />
Per “sviluppo sostenibile” si intende uno sviluppo che risponda alle necessità delle generazioni<br />
attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Gli<br />
obiettivi dell’Agenda 21 costituiscono la base di riferimento per le scelte politiche comunitarie e<br />
nazionali.<br />
Numerose città italiane hanno aderito alla Carta di Aalborg della Cam<strong>pag</strong>na Europa delle Città<br />
sostenibili, impegnandosi nella costruzione di un progetto sulla sostenibilità urbana, da concretarsi<br />
nell’attivazione di un apposito forum, espressione del processo partecipato che coinvolga<br />
rappresentazioni delle varie realtà urbane. L’Agenda 21 Locale costituisce un processo partecipato<br />
in ambito locale che coinvolge i rappresentanti più significativi delle varie realtà di una comunità<br />
nell’elaborazione di un piano d’azione di lungo termine verso la sostenibilità ambientale, sociale ed<br />
economica del territorio. Ogni piano d’azione di Agenda 21 Locale riflette i valori, le aspettative, i<br />
bisogni, i metodi e gli strumenti operativi, i criteri di valutazione di ogni soggetto partecipante,<br />
favorendo la collaborazione nello sviluppo.<br />
Tale Progetto può essere quindi considerato un esempio operativo di un nuovo progetto<br />
territoriale, sociale e culturale locale inserito in un contesto nazionale, europeo e internazionale,<br />
nell’ottica del pensare globalmente ed agire localmente. Il processo comprende quattro fasi.<br />
La prima prevede la raccolta di tutti i dati di base sull’ambiente fisico, sociale ed economico, al fine<br />
di individuare gli indicatori di sostenibilità. Tale fase prevede un importante lavoro di ricognizione e<br />
coinvolgimento dei diversi attori locali, enti, associazioni e realtà significative che operano nel<br />
pubblico, nel privato sociale, nel volontariato.<br />
Si avvia quindi una seconda fase che prevede un processo di consultazione della comunità locale<br />
allo scopo di individuare i bisogni e le risorse presenti nella realtà territoriale. Nella terza fase tutti i<br />
soggetti coinvolti, nella specificità di ciò che rappresentano a livello locale, sono coordinati<br />
all’interno di un’assemblea che ha il compito di orientare il processo di elaborazione e verificarne<br />
costantemente la reale applicazione. Una quarta fase prevede la definizione di obiettivi concreti e<br />
verificabili secondo precisi criteri e scadenze. È cioè definito un programma di azione finalizzato al<br />
raggiungimento degli obiettivi, su progetto condivisi.<br />
60
L’Agenda 21 Locale è pertanto stimolo al rafforzamento e all’avvallamento delle conseguenze<br />
presenti nei vari attori della comunità locale, ed è un nuovo strumento di progettazione ambientale<br />
inteso come management urbano per produrre politiche di sviluppo sostenibile a livello locale,<br />
consentendo una partecipazione attiva di tutti gli attori locali nei processi decisionali,<br />
un’assunzione di maggiore responsabilità nella risoluzione dei problemi e delle scelte future del<br />
proprio territorio.<br />
L’avvaloramento della diversità di situazioni, di visioni, di prospettive culturali, di esperienze e<br />
progetto esistenti sul territorio locale si avvale dell’introduzione di un approccio sistemico e<br />
interdisciplinare ai problemi sociali, economici e ambientali. In tale prospettiva possono essere<br />
messi a confronto i diversi modi di vedere di ciascun settore, consentendo ai soggetti partecipanti<br />
di apprendere e scambiare conoscenze e concezioni della realtà circostante. Da tale processo di<br />
scambio e d’interazione progettante possono nascere idee e stimoli nella definizione di nuovi<br />
progetti sul territorio. In concreto, attraverso il progetto Agenda 21 Locale, è possibile affiancare gli<br />
enti locali nella pianificazione di un modello urbano sostenibile, dando efficacia, in una prospettiva<br />
di empowerment, alla volontà di porre l’ambiente come cardine dello sviluppo della comunità<br />
locale.<br />
61
Il vissuto del tempo<br />
IL DIVENIRE ESISTENZIALE<br />
La vita è nel tempo ed è essa stessa tempo. Il soggetto umano è tempo ed ha un tempo: l’enigma<br />
in cui egli avverte la possibilità e la speranza, ma anche l’inarrestabile flusso, e quindi l’angosci di<br />
quel “morire a poco a poco” leopardiano.<br />
Se oggi, dopo la teoria relativistica e quantistica che ci hanno consegnato una concezione del<br />
tempo come “pura illusione”, continuiamo ad interrogarci sul significato è perché esso non cessa di<br />
affiorare come grande mistero che ci sgomenta spalancandoci l’abisso del nulla: esperienza<br />
radicale ed inquietante dell’esistenza umana, affanno delle antiche epoche, assillo della nostra: da<br />
quando la voce della sirena delle fabbriche si è sostituita al suono della torre del borgo (“Viene il<br />
vento recando il suon dell’ora dalla torre del borgo” da Le ricordanze di G. Leopardi) è avvenuta<br />
quell’accelerazione dei tempo moderni che ha sottoposto ad una crescente parcelizzazione e<br />
standardizzazione il tempo urbano. La società postindustriale odierna è governata dal ritmo<br />
astratto, dai nanosecondi, dalla costrizione nella pluralità dei tempi socialmente regolati. Questa<br />
comprensione in un presente sempre più momentaneo distoglie il soggetto postmoderno dal<br />
sentimento della temporalità esistenziale.<br />
Gli interrogativi sul tempo e sul senso (mai raggiunto) hanno dato vita a riflessioni filosofiche e<br />
letterarie: dai miti arcaici alla letteratura greca, dal pensiero filosofico alla poesia, attraverso<br />
Goethe, Leopardi, Mann o Proust, mirabili <strong>pag</strong>ine esprimono pensieri non meno profondi delle<br />
meditazioni di Aristotele, Agostino, Kant, Kierkegard, Bergson, Heidegger, Newton, Einstein,<br />
Minkowski.<br />
La risposta che ci viene offerta dalla speculazione razionale, dalla fisica, dal tempo geometrico,<br />
spazializzato, non soddisfa la percezione che ogni persona ha di uno scorrere soggettivo<br />
sovrapposto alla constatazione razionale e convenzionale. Ciascuno ha fatto esperienza<br />
preriflessiva del passare del tempo. Entro lo scorrere convenzionale e oggettivo si situa un vissuto<br />
che riguarda il soggetto, il suo stato d’animo, la sua memoria, le sue attese.<br />
Il tempo soggettivamente percepito non coincide con lo scorrere misurabile scandito dalle lancette<br />
o dalla successione numerica degli odierni orologi digitali: può essere lento oppure veloce, “non<br />
passa mai” oppure “sfugge”. Il tempo vissuto è emotivamente connotato e scorre troppo in fretta<br />
quando siamo felici, ma sembra arrestarsi quando siamo in situazioni di angoscia o di attesa. E<br />
tuttavia siamo consapevoli che non vi sono differenze, oggettivamente misurabili, nel procedere<br />
dei secondi, che le date sul calendario o le <strong>pag</strong>ine dell’agenda sono tutte uguali. Quando diciamo<br />
“sono già le sette” o “sono appena le sette” mostriamo di avere consapevolezza del tempo<br />
62
comune, intersoggettivo, nel quale si situa la nostra esperienza, e mostriamo anche la discrasia tra<br />
quel tempo omogeneo ed il sentimento del tempo che scaturisce dal nostro vissuto esperienziale.<br />
È inoltre ambigua la stessa percezione della direzione dello scorrere del tempo: dal futuro al<br />
passato, o viceversa? Secondo l’esperienza immediata e secondo la fisica ciò che ci sta per<br />
accadere sarà tra poco gettato nel passato, ma la percezione del passare della vita procede dalla<br />
giovinezza alla vecchiaia alla morte. Il venir meno del tempo è il suo stesso spingerci verso il dopo.<br />
Che cosa dunque, scorre? E in quale direzione? E perché questo scorrere è, nei vissuti soggettivi,<br />
tutt’altro che uniforme e rettilineo? Quale “demone” incalza e brucia il tempo o ne arresta il fluire?<br />
E come tutto ciò risulta decisivo nell’esperienza formativa?<br />
Temporalità<br />
Nel celebre libro XI delle Confessioni, Agostino esprime la difficoltà di spiegare che cos’è il tempo.<br />
Egli asserisce che, quando ne parliamo, lo comprendiamo bene, che è un’idea nota e familiare, ma<br />
se cerchiamo di spiegarlo no lo sappiamo più. Tuttavia con sicurezza afferma di sapere che “ se<br />
nulla passasse, non ci sarebbe il passato; se nulla avvenisse, non ci sarebbe futuro; se nulla<br />
fosse, non ci sarebbe il presente” (Agostino, Confessioni, vol. XI, p.14).<br />
Ma come possono esistere questi due tempi se il passato non è più e il futuro non è ancora? Il<br />
tempo è una realtà che non può essere parcelizzata in segmenti, poiché esiste innanzitutto nei<br />
nostri sentimenti che “presentificano” memorie e attese; “non è esatto dire che i tempi sono tre:<br />
passato, presente, futuro. Forse sarebbe meglio dire che i tempi sono: il presente del passato, il<br />
presente del presente ed il presente del futuro. Essi esistono nell’animo e altrove non li vedo. Il<br />
presente del passato è memoria, il presente del presente l’intuizione, il presente del futuro<br />
l’attesa.” (ibidem, vol. XI p. 20).<br />
Il presente non è quindi un punto privo di dimensioni che sta “tra” il passato e il futuro, ma è il<br />
tempo che li comprende entrambi, poiché il passato è ciò che fu, così come mi appare ora, nel<br />
presente che lo riproduce, e il futuro è ciò che avverrà, così come me lo prefiguro ora. Il passato<br />
non è concluso e pertanto irrelato con il presente. Questo passato “che racchiude la strada<br />
percorsa, fino dall’origine, non tira indietro, ma spinge in avanti; e, a differenza di quanto si<br />
potrebbe credere, è il futuro a spingerci nel passato.” (Arendt, 1991, p.33)<br />
Lo smarrimento della memoria produce oblio della coscienza e perdita d’identità. La memoria non<br />
può prescindere da ciò che viene prefigurato per il futuro e assume il significato heideggeriano di<br />
“memoria del futuro”. È la forza e il fondamento del futuro in quanto gli offre i modelli, gli ideali, le<br />
direzioni, il significato. Lo scorrere dell’esistenza si snoda nel tempo e trae alimento dal passato<br />
della storia personale e pubblica per costruire un futuro in cui potere progettare il divenire: “il<br />
passato e l’avvenire esistono solo in rapporto al presente e non hanno altro senso” (Minkowski).<br />
Il già accaduto non può essere eliminato. I ricordi e la memoria conferiscono significato al futuro e<br />
rappresentano le tracce su cui costruire l’avvenire. Anche il mito greco aveva provveduto ad<br />
indicare l’impossibile separazione, nell’esistenza umana, delle tre dimensioni del tempo; la<br />
63
narrazione mitologica deriva dalla facoltà di ridimensionare presieduta da Mnemosyne: la<br />
Memoria, madre delle Muse. Leggiamo infatti in Esiodo: “ Le Muse ispirarono a me un canto<br />
divino, affinché celebrassi le cose future e le cose accadute nel passato”. Una simile impostazione<br />
si ritrova anche in Platone che pone la memoria in stretto legame con la poesia. Il poeta è un vate<br />
che ha memoria simultaneamente del passato e del futuro. È quando teorizzerà Rimbaud<br />
proclamando una definizione del poeta come veggente e indicando nella memoria la facoltà<br />
centrale per la poesia, come capacità di cogliere sensazioni e percezioni e di trasfigurarle.<br />
Il tempo non è quindi costituito dalla successione di attimi concatenati in una successione di un<br />
prima e un dopo, ma è sentimento avvertito con caratteristiche soggettive legate agli stati d’animo<br />
in cui ci troviamo. La lezione di Bergson e di Proust sottolinea come in ogni persona coesista,<br />
accanto ai tempi dei calendari, un tempo interiore, il tempo/durata che nella nostra intuizione<br />
coscienziale travalica i concetti di passato, presente e futuro, rendendoli emotivamente legati. Le<br />
<strong>pag</strong>ine agostiniane fondano quindi le successive riflessioni sul tempo: in particolare è rilevante la<br />
distinzione che egli pone tra un tempo interno/soggettivo e un tempo esterno/oggettivo. Questa<br />
prospettiva, contrastante rispetto alla visione aristotelico- newtoniana del tempo come “ordine<br />
misurabile del movimento”, sarà ripresa approfonditamente da Bergson nella distinzione tra il<br />
tempo durata e il tempo spazializzato. Quest’ultimo è omogeneo, indifferenziato, misurabile,<br />
esterno; ha un carattere convenzionale e si presta a un uso utitilitaristico. Il tempo durata è invece<br />
interno, esprime il continuo mutare della nostra vita interiore, il complesso processo di<br />
organizzazione dei fatti della coscienza. La filosofia bergsoniana è considerata una protesta contro<br />
un’organizzazione del mondo dominata dagli orologi, analoga ad altre simili che vengono formulate<br />
negli stessi: una protesta contro il tempo meccanico e artificiale che sembra predominare sugli<br />
individui e imporsi dall’esterno costringendo tutti a uniformarvisi.<br />
La percezione del tempo che trascina con sé possibilità irreversibili rappresenta lo sfuggire di<br />
mano della nostra stessa consistenza, talvolta delle nostre sicurezze, e del senso dell’essere al<br />
mondo. La fenomenologia husserliana non cerca di dare ordine e spiegazione ai problemi del<br />
tempo ma si pone come un tentativo di epochizzare tutte le conoscenze e le teorie costruite sul<br />
tempo per fare emergere “prereflessivamente” ciò che scaturisce dal vissuto del tempo. Husserl,<br />
nell’introduzione alle Idee, preannuncia che la fenomenologia postula un modo diverso di vedere la<br />
realtà, rispetto al modo naturale di pensare. E tale modalità di pensiero manifesta la sua difficoltà<br />
soprattutto di fronte alla visione dell’esistenza nel tempo.<br />
Orologi, calendari e temporalizzazione<br />
“Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce,<br />
ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura!”<br />
(G. Leopardi, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere)<br />
64
L’ironia leopardiana è rivolta ad almanacchi, lunari, calendari, mediatori dell’illusione che,<br />
nonostante un presente privo di felicità, conduce gli esseri umani alla lusinga di un futuro migliore.<br />
L’illusione e il rimpianto sono tonalità emotive del tempo vissuto. La memoria geometrizzata è priva<br />
di emozioni e sa calcolare quanti anni o minuti siano trascorsi, quale sia la durata degli intervalli,<br />
ma questi calcoli restano freddi e destinati all’oblio, poiché essi sono estranei alla risonanza<br />
interiore ed emotiva dello scorrere del tempo.<br />
La concezione abituale del tempo ci pone infatti nella tripartizione oggettiva e calcolabile per cui il<br />
nostro rapporto con gli altri e il nostro essere al mondo si dispiegano attraverso ciò che abbiamo<br />
fatto, ciò che intendiamo fare e la consapevolezza di ciò che stiamo facendo nel presente.<br />
Impegni, appuntamenti, decisioni, obiettivi, appartengono tutti a queste dimensioni così<br />
connaturate alla nostra esistenza da renderci difficile immaginare un’organizzazione della nostra<br />
vita al di fuori della scansione temporale di questi impegni. Anzi, questa dimensione è così<br />
importante per noi da essere ritenuta il bene più prezioso nella società postmoderna. Il districarsi<br />
quotidiano con i tempi e la loro organizzazione ci abitua a convivere con la fretta, con la mancanza<br />
di tempo, con il tempo che non basta mai: si pensi alla recente istituzione delle banche del tempo<br />
che esprimono assai efficacemente questo nostro uso del tempo velocizzato e produttivo.<br />
Heidegger supera sia le concezioni fisiche che quelle coscienziali per porre la questione della<br />
temporalità su un piano prettamente ontologico. La temporalità è il vissuto del tempo<br />
temporalizzato, cioè reso partecipe dell’esistenza. La temporalità non è per Heidegger (né per<br />
Biswanger) una dimensione cronologica oggettiva, ma non è neppure esperienza vissuta o<br />
coscienza del tempo, bensì dimensione ontologica. Il tempo non esiste in sé, ma esiste fuori di sé,<br />
e si temporalizza mediante l’assunzione, da parte del soggetto imano, nel dispiegarsi<br />
dell’esistenza. La temporalità è il fondamento ontologico dell’Esserci, inteso come un processo di<br />
temporalizzazione. La temporalità si rivela come il senso della cura più autentica. (Heidegger)<br />
L’Esserci è sempre un poter- essere e questo poter- essere è sempre in vista di, una possibilità<br />
che gli è propria. In questo essere- per il proprio poter essere l’Esserci è già sempre avanti rispetto<br />
a sé. Nell’essere avanti a sé, l’Esserci è sempre un non- ancora che determina il suo movimento-<br />
verso, la direzione del poter- essere.<br />
A differenza degli enti semplicemente presenti, l’Esserci umano ex-siste (nel significato di porsi<br />
fuori da) nella direzione della possibilità. L’esistenza è l’essenza dell’essere umano i cui modi non<br />
sono pertanto interpretabili attraverso le categorie che si addicono alle semplici presenze, ma<br />
attraverso gli esistenziali fondamentali che mantengono aperta la possibilità progettuale. Il divenire<br />
è perciò decisione e orientamento verso la realizzazione della possibilità futura. Il futuro verso cui<br />
si protende il progetto è la dimensione prima della temporalità esistenziale.<br />
Binswager, riprendendo fedelmente Heidegger, chiarisce che il tempo è l’orizzonte fondamentale<br />
di ogni esplicitarsi esistenziale: “per temporalità non intendiamo né un essente, né un accadere, né<br />
un divenire che si instauri unicamente da sé, bensì il temporalizzarsi della presenza come tale, la<br />
65
temporalizzazione.” La temporalità ha un significato ontologico e la presenza è unione dei tre<br />
fenomeni dell’esser- stato, dell’avvenire e del presente: avvenire, esser-stato, presente sono<br />
2estasi” in quanto indicano i fenomeni del verso-cosa, del su-cosa, del presso-cosa, cioè dell’ ad-<br />
sé-per, dell’indietro-su e del lasciarsi-venire-incontro.<br />
Il manifestarsi primo dell’originaria temporalità, in Binswanger, come in Scheler, in Minkowski, in<br />
Straus e in Von Gebsattel, è il futuro in quanto senso primario dell’esistenzialità e del progettarsi in<br />
vista di sé stessi. La presenza è quindi determinata in base al poter-essere futuro e all’esser-stato<br />
che si congiungono nel presente. Precisa però Binswanger che “il senso esistenziale del presente<br />
è il presentificare, in quanto risoluto dischiudersi, di volta in volta, della situazione dell’agire”. Il<br />
tempo è forma della presenza. Quando la presenza si consegna alla deiezione non ha più futuro,<br />
non tanto in senso cronologico, quanto in senso esistenziale.<br />
L’attimo presente<br />
In una visione dissipativa del tempo nella sua deperibilità, il presente è la dimensione più<br />
problematica da comprendere. Proprio all’interno di una cultura basata sul presente e<br />
sull’aspirazione a cogliere l’attimo fuggente, questo è interpretato in modo inautentico ed equivoco<br />
all’interno di un susseguirsi di attimi che costituiscono un presente senza sosta.<br />
L’atteggiamento ambivalente e paradossale del nostro tempo nei confronti della memoria si<br />
esprime nella tendenza, da un lato, a conservare tutto il passato, possedendolo attraverso gli<br />
strumenti messi a disposizione dalla tecnologia avanzata, dall’altro a svincolarsi dal passato in una<br />
rimozione perseguita come smemoratezza e libertà dal peso dell’antico. Vivere alla giornata,<br />
tuffarsi nell’attivismo incessante, avere come dimensione temporale unicamente il presente diventa<br />
una fuga dal passato, vissuto come troppo imponente per poter essere assorbito e metabolizzato,<br />
e dal futuro avvertito come sempre più minaccioso perché imprevedibile e non controllabile. La<br />
perdita della memoria accentua la condizione di sradicamento dell’uomo postmoderno, aumenta la<br />
distanza tra le generazioni contigue e ostacola la trasmissione del patrimonio culturale.<br />
L’attimo è già fuggito nel momento stesso in cui lo pensiamo e altresì il tempo futuro viene meno<br />
mentre noi procediamo verso di lui. Ciò che attendiamo dal futuro ci viene incontro o siamo noi a<br />
procedere verso il futuro colmando l’attesa della nostra intenzionalità? Secondo Maslow, “l’uomo<br />
ha in sé il proprio futuro, dinamicamente attivo nel presente”.<br />
La prospettiva fenomenologica mostra che il presente-oggetto non è identificabile con i molteplici<br />
“ora” che si susseguono nell’inautenticità fittizia dei momenti puntiformi, concepibili solo<br />
nell’astrazione.<br />
Cogliere il tempo significa cogliere l’angoscia che connota il passato come perduto ed il futuro<br />
come irrealizzabile. Che cosa resta? Resta l’attimo, momento del tempo autentico in cui si realizza<br />
l’apertura dell’Esserci alla situazione, sintesi massima delle tre dimensioni estatiche,<br />
perennemente riproponendosi nella sua unitaria completezza.<br />
66
Nell’attimo si consuma ogni consistenza oggettiva del tempo. In ogni attimo si rifondono e si<br />
ridefiniscono ricordi e progetti. L’attimo si propone come possibilità di essere scelto: la libertà di<br />
scegliersi nell’attimo supera, come valore di vissuto del tempo, la necessità di sentirsi in una<br />
continuità. Nella visione dell’attimo viene a cessare la soggezione del passato, la necessità del<br />
presente, la coazione del futuro. Il tempo si riferisce al nostro rapporto col mondo e trova il suo<br />
senso nella tonalità emotiva che ci rende presenti temporalmente nel mondo.<br />
L’attimo in senso fenomenologico è in un certo senso il contrario del momentaneo: prospettiva in<br />
cui sembra esplicarsi l’esistenza del soggetto della postmodernità. La momentaneizzazione<br />
esperisce il tempo presente nella modalità del non sapersi-trattenere-presso le cose e pertanto<br />
tende a temporalizzarsi in un nudo presente. Nessun futuro viene incontro al soggetto umano nella<br />
dimensione dell’attesa, e nessun passato nella dimensione del rimembrare. In questo lasciarsi-<br />
andare-incontro egli è soltanto nel momentaneo.<br />
Il futuro che non ha il carattere del progetto è privo di senso per il presente, risulta vuoto di<br />
fondamento, inautentico, pur nell’indaffarato organizzare di incontri ed impegni tramite cellulari, e-<br />
mail, e tutti gli strumenti che accelerano la comunicazione nella società telematica. Si tratta<br />
pertanto di un futuro frammentario e incerto cui non corrisponde alcuna effettiva valenza proiettiva.<br />
Il passato delle memorie e dei racconti<br />
Il passato, secondo quanto afferma Minkowski, “non è soltanto ciò che è svanito per sempre, ma è<br />
ciò che esiste nel passato o, se si preferisce, ciò che è stato presente un tempo e si è ritirato nel<br />
passato”. La memoria perciò produce il passato e la narrazione è la testimonianza che sottrae ciò<br />
che è stato all’oblio che lo travolgerebbe in quanto “ciò che non è più”, restituendolo<br />
all’intenzionalità che apre al futuro.<br />
L’esperienza della memoria racchiude il segreto del tempo. Ma subito avvertiamo che il cedere<br />
della memoria come facoltà psichica non annulla il tempo, né l’oblio dà luogo al non- tempo.<br />
“Quando lasciamo che il passato ci parli, per prima cosa dobbiamo dire che il suo principale valore<br />
non è da ricercarsi nel tempo in cui esso si svolse, ma nella nostra esistenza presente. [….] Il<br />
passato vissuto, importante e significativo per chi deve vivere con esso, è il passato così come<br />
appare a chi lo guarda dal presente” (Van de Berg)<br />
La corrispondenza reciproca fra esperienza del tempo e memoria, posta da Agostino con grande<br />
chiarezza, apre la strada alle recenti concezioni fenomenologiche in filosofia e in psichiatria.<br />
Rilevando che non esistono altre <strong>pag</strong>ine come quelle agostiniane nelle quali la fenomenologia<br />
della memoria abbia questa radicalità e indicibile vertigine descrittiva.<br />
Platone, nel Fedro, aveva indicato in Thot, il dio egizio dei numeri e dell’alfabeto, del calcolo e<br />
della scrittura, il responsabile della distruzione della memoria. Apparentemente la scrittura salva la<br />
memoria, ma in realtà induce gli uomini a depotenziare la facoltà del rimembrare, e a gettare<br />
nell’oblio le memorie vitali, allorquando essi sanno di poter richiamare alla mente ciò che sta<br />
scritto. Ma questa operazione si affida ad una memoria esterna, fondata sul calcolo, e non ha a<br />
67
che vedere con il memorizzare. In tal senso Platone aveva intuito il pericolo insito nel nostro<br />
tempo, dominato dalla fiducia nell’infallibile memoria elettroica, nelle banche-dati, nella capacità di<br />
ricordare insita nelle macchine, che assoggetta l’imperfetta memoria umana. L’enorme espansione<br />
della memoria coincide oggi con la sua esteriorizzazione: il ricordare è sempre più affidato<br />
all’accumulo acritico di dati non selezionati da parte della memoria artificiale che si costituisce al di<br />
fuori della memoria dei singoli e indipendentemente dalla loro capacità di ricordare. In tal modo la<br />
memoria, come pura conservazione di dati, scoraggia la memorizzazione.<br />
I benefici ed il piacere del ricordare sono efficacemente descritti da Duccio Demetrio che mette in<br />
evidenza più volte le emozioni del ricordare, dove la memoria assume le sembianze di una<br />
temporalità risorgente, sensitiva e sensuale di odori, umori, tattilità, fragranze.<br />
Il ricordare è la sorpresa di sentirsi capaci di dissotterrare istanti e circostanza che credevamo di<br />
aver perduto per sempre. Il ricordare umano, che non si affida alle macchine, ma a quelle emozioni<br />
crepuscolari o alle romantiche inquietudini dell’anima, mette in gioco noi stessi risvegliando<br />
emozioni e desideri, aprendoci l’accesso ad un mondo altro rispetto al presente, sospeso e lontano<br />
dai compiti che, nel presente quotidiano, ci chiamano invece ad essere presenti a noi stessi.<br />
(Demetrio, 1996)<br />
Il futuro: tempo della possibilità<br />
Il soggetto è, secondo Heidegger, un essere-là (Daisen), nel mondo, nella situazione in cui è<br />
gettato, ma è anche sempre un perenne aver-da-essere, proteso verso la possibilità e il poter<br />
essere. Il progetto è sostenuto dal poter-essere. Il Daisen è un progetto-gettato in quanto è nella<br />
condizione di “gettatezza” e di progetto. Corrispondenze etimologiche latine e tedesche del verbo<br />
“lanciare”, mettono in luce la stretta connessione tra la condizione dell’essere gettato e la<br />
dimensione del superamento di tale situazione. Al verbo latino proicere, corrisponde il tedesco<br />
werfen “gettare”. I rispettivi participi passati proiectum (progetto) e geworfen (gettato) da cui deriva<br />
Entwurf (progetto).<br />
Il progetto è la decisione stessa nella quale non è più possibile una separazione tra la scelta e l’io,<br />
perché “io stesso sono la libertà di questa scelta” (Jaspers). La scelta per il futuro avviene nella<br />
possibilità stessa della scelta. Tale possibilità si colloca tuttavia nel già scelto della situazione. La<br />
decisione e la scelta per il futuro non possono avvenire se non all’interno della possibilità.<br />
La possibilità di trasformazione e di superamento della situazione presente consente la perenne<br />
apertura la cambiamento. Aprendosi alla dimensione esistenziale della possibilità, il progetto è<br />
reso possibile dal poter- essere dell’umana esistenza. La possibilità di superamento della<br />
situazione è però sempre condizionata dai caratteri della situazione stessa, e comprende in sé il<br />
rischio del fallimento. La scelta è nelle nostre mani, ma ha necessità di quello “slancio verso…”<br />
individuato da Minkonwski come unico atteggiamento capace di creare l’avvenire davanti a noi:<br />
“Nella vita, tutto ciò che ha una direzione nel tempo, ha slancio, avanza, progredisce verso<br />
l’avvenire”, tuttavia solo con lo slancio vitale tutto comincia ad avere un senso, poiché è lo slancio<br />
68
vitale che svela l’esistenza dell’avvenire e gli dà un senso, lo apre e lo crea davanti a noi. Pensare<br />
l’avvenire di aprirsi davanti a noi.<br />
Il tempo vissuto, in quanto tempo del futuro e del passato, è anche tempo della speranza. La<br />
perdita della speranza chiude la possibilità: vivendo nel rimpianto e nella disperazione ci si ritrae<br />
dalla temporalità viva e si sopprime l’intenzionalità. Il tempo futuro, convenzionalmente ritenuto<br />
inesistente perché non è ancora , ci si fa incontro con il volto delle nostre speranze, dei desideri<br />
che proiettiamo in esso, ma è anche denso di minacciosità e angoscia.<br />
La minacciosità del futuro può esser legata ad eventi temuti e ritenuti ineluttabili o soltanto<br />
paventati come carichi di dolore per la nostra esistenza nel suo dispiegarsi affettivo, professionale,<br />
corporeo; sopra ogni altra angoscia l’esperienza umana incontra l’immagine terribile e inappellabile<br />
della morte.<br />
La temporalità costitutiva di ogni esperienza di formazione<br />
Tutte le considerazioni fin qui proposte palesano che il tempo non può essere trascurato dalla<br />
riflessione pedagogica, poiché l’educazione si presenta densa di memoria, di attese e di previsioni:<br />
è quindi sempre nel tempo ed è pure situazione fondamentale di elaborazione del tempo.<br />
La temporalità riveste un ruolo essenziale nella realtà formativa, ma è ben chiaro che il tempo<br />
formativo non è rettilineo. È trans-formativo e accom<strong>pag</strong>na i passaggi da una fase all’altra<br />
dell’evoluzione personale, secondo una dinamica che non riveste un andamento lineare né<br />
omogeneo. La formazione è trans-formazione poiché avviene nel susseguirsi di eventi mutativi su<br />
cui si focalizza, nel suo scorrere continuo, il processo di cambiamento. La formazione procede<br />
attraverso transiti che avvengono nel tempo e nello spazio, siano essi determinati dal ciclo<br />
biologico della vita o da scelte personali, da ineluttabili eventi, da incontri, da coercizioni sociali,<br />
dall’intervento intenzionale di un formatore o dall’imprevisto destabilizzante. La trasformazione di<br />
sé non procede in modo unidirezionale, conosce inversioni, arresti, riprese, svolte per avanzare in<br />
modo nuovo.<br />
La temporalità educativa è simultaneamente qui e oltre, è nel presente ma si trascende<br />
perennemente nel futuro attraverso un’intenzionalità modificatrice che sottende le azioni educative<br />
in quanto progettuali. Promuovere o perdere la progettualità è ciò che contraddistingue la riuscita o<br />
il fallimento dell’azione formativa nella sua dimensione temporale.<br />
Lo psichiatra fenomenologo Van Den Berg, ricorda l’aspra controversia tra Freud e Maeder<br />
quando quest’ultimo sostenne che il sogno poteva essere inteso non soltanto come prodotto del<br />
passato, dei fatti dell’infanzia, ma anche indice di ciò che sta per accadere. Van Den Berg osserva<br />
che tutta la psicologia, sotto l’influsso della psicoanalisi, si è occupata assai poco del futuro,<br />
attribuendo un’importanza notevole al passato per comprendere le nevrosi. Mentre si potrebbe<br />
ritenere che il continuo rimuginare sul passato esprima invece un incombere del futuro che appare<br />
minaccioso, confuso, buio.<br />
69
Il futuro determina la nostra condotta del presente: il futuro è contenuto nel presente e, pur<br />
essendo ciò che verrà poi, è un poi come lo vedo in questo momento; ognuno vive in esso prima di<br />
esservi entrato, poiché è ciò che verrò, così come mi si fa incontro ora, nel presente. (Van Den<br />
Berg)<br />
Proprio per questo farsi incontro del futuro nel presente, la dimensione pedagogica è<br />
necessariamente volta al futuro pur essendo un’esperienza radicalmente presente. Il tempo e lo<br />
spazio educativi sono infatti sempre concepiti in vista di un progetto pedagogico nel quale il<br />
presente si “infutura”, quale che sia il tempo ed il luogo in cui si esplica l’azione formativa.<br />
Oggi i luoghi dell’educare si fanno sempre più indefiniti e numerosi così come i tempi non sono più<br />
delimitati a determinate fasi dell’età evolutiva: una pluralità di luoghi corrisponde ad una pluralità<br />
dei tempi. La diacronicità della formazione comprende tutto l’arco della vita.<br />
Chiunque si trovi a dover progettare un percorso formativo sa che deve, simultaneamente ai<br />
contenuti, stabilire i tempi adeguati alla trasmissione di questi. L’organizzazione dei tempi<br />
scolastici e formativi assegna normalmente a determinate ore della giornata il lavoro d’aula,<br />
scandisce la durata dedicata alle varie attività, gli intervalli, il lasso di tempo del periodo formativo,<br />
li relaziona all’età, al ciclo degli studi, allo stadio evolutivo, stabilisce sequenze e momenti.<br />
A nessuno sfugge tuttavia che, entro questi tempi geometrici e spazializzati in base al ciclo della<br />
vita e all’organizzazione sociale, assumono un rilievo preminente i tempo personali dei soggetti<br />
che percorrono gli itinerari organizzati: i tempi stabiliti, intersoggettivi, assumono qualificazioni<br />
educative diverse in relazione alla risonanza emotiva e ai modi attraverso cui vengono vissuti dai<br />
soggetti in formazione. Il tempo soggettivo, vissuto, proprio di un determinato momento evolutivo,<br />
si sovrappone sempre al tempo oggettivo e interagisce con questo. Il superamento di una fase, il<br />
termine di un ciclo, la conclusione di un’attività e l’inizio di una nuova e successiva esperienza non<br />
sanciscono una cesura nel tempo dell’esperienza precedente ma si pongono nella continuità del<br />
tempo-durata.<br />
L’assenza di linearità è particolarmente manifesta di fronte all’imprevisto che irrompe inaspettato<br />
nello scorrere ordinario, o di fronte alle involuzioni che modificano i vissuti dell’esperienza<br />
presente, della memoria passata e delle aspettative future. Questo tempo imprevisto, che spezza<br />
la sequenzialità lineare preventivata, è spesso ignorato dai formatori, rimosso dalle istituzioni che<br />
si basano sulla tranquillizzante successione dei tempi anonimi e inautentici.<br />
Ogni dimensione del tempo interiore si intreccia con la quotidiana organizzazione dei tempi, si<br />
sottrae ai vincoli dell’irreversibilità e apre un varco ad un’intersoggettività di genere diverso<br />
dall’oggettività. Ogni processo educativo può dirsi tale quando l’educazione sottrae la possibilità<br />
alla situazione, il futuro al presente e li riorganizza in un racconto di sé che ci collochi nel fluire del<br />
tempo. Tale racconto non ha l’andamento rettilineo e cumulativo di una vita che si evolve con<br />
sequenzialità da una fase a quella successiva, ma si organizza sulla base del sentimento del<br />
70
tempo che ordina gli eventi nella nostra percezione, ricollocandoli in posizioni differenti con il<br />
procedere del nostro scorrere del tempo.<br />
Il tessuto temporale di ogni esperienza formativa comprende quindi simultaneamente presente,<br />
passato e futuro, attraverso vissuti di nostalgia, rimpianto, attesa, timore, speranza,<br />
preoccupazione, desiderio e progetto. Il tempo vissuto del passato (tempo della memoria), del<br />
presente (tempo dell’experiri) e del futuro (tempo del progetto) si sovrappongono nel fluire degli<br />
eventi formativi. I tre momenti non sono delimitabili oggettivamente poiché si fondono<br />
incessantemente in una temporalità vissuta che, assunta pedagogicamente, postula una<br />
destabilizzante, quanto salutare, apertura delle pratiche formative ai nuovi significati dell’irrazionale<br />
ridestato dalla visione dell’attimo.<br />
La libertà per la morte<br />
Nella mitologia omerica la Moira attribuisce il principio e la fine del tempo e della vita, la nascita e<br />
la morte. Essa è la forza imperscrutabile che sta al di sopra degli essere umani e scandisce per<br />
ciascuno la sua sorte. Alle divinità competono gli aspetti vitali, esse possono proteggere o<br />
perseguitare, ma devono sottomettersi al volere della Moira per ciò che attiene al tempo e alla sua<br />
durata. Nella versione di Esiodo le tre Moire o Parche filano la sorte dell’uomo. Cloto regge il filo<br />
dei giorni; Làchesi fila, poiché la filatura è nella mitologia greca il simbolo dello scorrere<br />
dell’esistenza umana ed i suoi strumenti girano avvolgendo per ciascuno il filo che gli è assegnato;<br />
mentre Atropo, l’inesorabile, è colei che taglia il filo quando giunge il momento di arrestare la vita.<br />
Nella psiche umana di tutte le culture e di tutte le età sono presenti tentativi illusori di sfuggire alle<br />
leggi che regolano il corso degli eventi, nell’ancestrale speranza di prolungare ognora la propria<br />
vita. Il tempo che incalza è percepito come inesorabile e genera angoscia nel suo galoppare<br />
portando in sella la morte. Non è da sottovalutare il riferimento all’oniromanzia popolare secondo<br />
sognare un cavallo è presagio di morte. Simbologia che appare anche nell’Apocalisse (VI, 8),<br />
nell’iconografia dei tarocchi, nelle raffigurazioni di Ade, dio degli Inferi.<br />
Gli atteggiamenti più diffusi davanti alla morte si sviluppano innanzitutto tra i due poli di paura e<br />
fuga, da un lato e di ricerca della spiegazione causalistica e scientifica, dall’altro. Entrambi<br />
allontanano dalla consapevolezza del limite e ostacolano quell’educazione alla morte che è<br />
indispensabile per un’autentica educazione alla vita.<br />
La fuga si traduce nei molteplici riti individuali e collettivi che esprimono questa fuga inautentica<br />
davanti alla morte, o meglio, davanti alla sua oggettivazione esorcizzandola, coprendola,<br />
allontanandola dalla nostra vita.<br />
La frettolosità che domina il nostro tempo ha reso anche i riti funebri sempre più sbrigativi, quasi<br />
che lo scorrere del tempo dei viventi non debba essere rallentato, che il pubblico non debba<br />
essere turbato. Non raramente si vede nella morte degli altri un disturbo sociale o addirittura una<br />
mancanza di tatto, nei confronti della quale la vita pubblica deve prendere le sue misure,<br />
occultandola.<br />
71
Corrisponde ad un atto di fuga e diniego della morte anche la sua spettacolarizzazione: è questa la<br />
morte che entra nelle nostre case attraverso immagini cruente dei telegiornali o attraverso un film,<br />
una morte in diretta suscita curiosità pur lasciandoci indifferenti nelle nostre vite, perché viene<br />
presentata come un fatto che riguarda altri, non ci tocca, che ci fa sentire al riparo rispetto alle<br />
immagini di sangue, di sofferenza, che scorrono, confuse tra fantasia e realtà, sotto i nostri occhi,<br />
dentro lo schermo, tra una pubblicità e l’altra, consentendoci comunque la possibilità di cambiare<br />
canale.<br />
Questa morte occultata o spettacolarizzata è sempre una morte non detta, che non ci consente di<br />
pensare veramente alla realtà di questo evento che fa parte ineluttabilmente della nostra vita.<br />
Questi modi della paura, dell’orrore, del cinismo, del pettegolezzo non ci mettono mai in contatto<br />
autentico con noi stessi di fronte all’interrogativo autentico sul perché della morte nell’esistenza<br />
umana. È questo un perché lasciato senza risposta dal parlare della morte nella dimensione<br />
quotidiana e autentica.<br />
Il secondo modo attraverso cui oggi si parla della morte è quello basato sulle spiegazioni razionali,<br />
o meglio, ragionevoli di chi la spiega come un fatto naturale, di fronte a cui auspicare una serena<br />
accettazione, dovuto a precise cause patologiche cliniche, dai nomi asettici e inappellabili come<br />
arresto cardiocircolatorio. Ma la spiegazione scientifica non placa l’arcaico interrogativo del perché<br />
morire, non può rispondere in maniera esauriente.<br />
Le nostre domande scomode e irrisolte sono ancora lì, al perché primitivo. Come mettono in rilievo<br />
gli studi di Lèvy-Bruhl, il primitivo non si ap<strong>pag</strong>a infatti di risposte inautentiche del tipo causa di<br />
morte o ragioni del decesso, non si ferma alla causa secondaria, al come si muore, egli va sempre<br />
al perché del morire.<br />
L’esigenza di indagare il perché ultimo è un interrogativo che la scienza respinge da sé, perché<br />
non le appartiene; le sue risposte riguardano la causa del decesso, spiegano quando un corpo-<br />
macchina ha cessato di funzionare correttamente, ma gli esseri umani continuano a cercare una<br />
causalità le cui risposte riguardano l’esistenza. E su queste la scienza oggettiva sorvola.<br />
La morte è imprescindibilmente legata alla temporalità anche nella più importante opera del<br />
Novecento dedicata a questo tema: Essere e Tempo. Il temporalizzarsi della presenza come tale è<br />
la possibilità che mantiene l’esserci nella progettualità, e dunque nell’apertura al futuro. A partire<br />
dalla situazione di Gewerfenheit in cui l’esser-ci è gettato è possibile fare proprio il proprio Essere<br />
come progetto. Il Daisen è temporale nel fondamento del suo essere e la morte è l’esperienza<br />
insuperabile, più propria e “assolutamente mia”, e quindi la più autentica che riguardi l’esserci nel<br />
suo ci. Quando l’esserci è morto, dice Heidegger, non ci è più, e al suo sopraggiungere cessa ogni<br />
poter- essere.<br />
Il futuro, assumendo il passato anonimo, anticipa la possibilità più propria che è la libertà per la<br />
morte ed esprime le molte possibilità dell’essere innanzi a sé, in vista del perenne poter-essere. Se<br />
l’esserci, nel suo rapporto con il mondo, è sempre avanti a sé nella preveggenza di una<br />
72
ealizzazione nel futuro, è anche sempre nell’incompiutezza. Il futuro ha in sé la fine di ogni<br />
preveggenza sul mondo: la morte è infatti presente nell’esperienza umana soltanto quando il<br />
soggetto non c’è più. Essa è al tempo stesso l’esperienza più radicale che manca alla<br />
realizzazione dell’uomo, ma anche l’unica esperienza che egli non potrà mai effettuare.<br />
Il Si<br />
Nella quotidianità inautentica la morte appartiene alla certezza esistenziale nella dimensione del<br />
“si” muore. Il Si ha già pronta un’interpretazione inautentica per la morte, considerandola un evento<br />
che prima o poi accadrà, poiché riguarda tutti genericamente, ossia gli altri, secondo<br />
l’interpretazione pubblica della morte. In realtà si tratta dell’evento più propriamente “mio”, perché<br />
nessuno può morire al posto di un altro, è sicuramente certo.<br />
Il Si, sforzandosi di nasconderla, banalizza l’angoscia esistenziale davanti alla morte e la tramuta<br />
in paura del decesso; ne conseguono comportamenti di fuga davanti ad un evento che avverrà,<br />
certamente, “ma non ora” e “non per me”. Soltanto l’angoscia, che non usa i linguaggi del<br />
turbamento esteriore o della paura ma del silenzio, apre alla libertà per la morte ineluttabile già<br />
presente nella nostra esistenza.<br />
Dunque il Si banalizza l’angoscia esistenziale in paura di fronte a questo evento che avverrà;<br />
riconosce in modo equivoco la certezza della morte, per dissimularla, coprirla, indicando come<br />
comportamento una tranquillità indifferente di fronte alla certezza che si muore.<br />
L’angoscia autentica della morte, piuttosto che la paura inautentica del decesso, trasforma la<br />
morte in vita. L’atteggiamento autentico assume l’angoscia nell’essere-per-la-morte come<br />
decisione. Trovarci davanti al nostro limite significa assumere come componente fondamentale<br />
della nostra esistenza la morte, già presente in noi nella sua ineluttabilità, e accettare il nostro<br />
destino di finitudine terrena, in quanto “gettati” nel mondo, significa assumere la morte come<br />
possibilità. Anzi, secondo Heidegger, la “decisione anticipatrice” consiste proprio nell’accettare il<br />
nostro destino come libertà per la possibilità più propria, incondizionata, insuperabile e certa che è<br />
la morte.<br />
Ma se la morte è già da sempre presente nella nostra vita, essa è già passata anche se deve<br />
ancora venire. Scoprendo nell’esistenza il tempo, non come somma di attimi legati tra loro da un<br />
susseguirsi concatenato di causa-effetto che dal passato va verso il futuro, ma come tempo<br />
interiore, ci appartiene allora la rinnovata libertà di costruire il passato nell’essere liberi per la<br />
morte. Ciò è percorrere il cammino inverso rispetto alle lancette degli orologi: dall’avvenire verso il<br />
passato.<br />
Perciò la libera accettazione della vita è anche accettazione del suo estremo poter-essere, la<br />
morte. Da questa accettazione del nostro essere-per-la-morte può divenire un atteggiamento di<br />
accom<strong>pag</strong>namento al morire che non sia di occultamento o di spiegazione causalistica, ma di<br />
libertà.<br />
73
Può apparire un paradosso, quello posto da Heidegger, ma la libertà più profonda è allora la<br />
libertà-per-la-morte. Rendendoci liberi per la morte ci rendiamo anche liberi per la vita.<br />
La libertà per la morte non è un’esperienza grettamente individualistica che isoli l’uomo e lo<br />
conduca al nichilismo; al contrario, è proprio nella consapevolezza interiore del nostro limite che è<br />
possibile entrare in sintonia con l’umanità tutta, comprenderla in termini non superficiali e banali,<br />
ma autenticamente aperti alla conoscenza ed alla condivisione.<br />
Di fronte al dolore ed alla morte è difficile trovare risposte all’eccesso di coinvolgimento o di<br />
distanza rispetto al turbamento emotivo che deriva dal Tu sofferente. La persona che soffre non è<br />
più, come afferma Frankl, la persona attiva e operosa (homo faber) e spesso perde anche la sua<br />
lucidità di pensiero intellettuale (homo sapiens) , ma è diventata homo patiens, persona che è nel<br />
dolore e può essere aiutata a mostrare a sé stessa e agli altri l’insopprimibile presenza del dolore<br />
nella vita umana, ma anche la possibilità di viverlo con dignità.<br />
L’angoscia, a differenza della paura, non parla in noi secondo i linguaggi del turbamento esteriore,<br />
ma secondo il silenzio interiore davanti al senso della morte che è la nostra più sincera scoperta.<br />
Da Kierkegaard a Jaspers queste esperienze limite della morte, dell’angoscia, della precarietà, del<br />
dolore, del tempo, del destino, sono le esperienze più profondamente soggettive e<br />
contemporaneamente le più universali; e si situano ad un livello di conoscenze vissute che<br />
precedono ogni intellezione.<br />
Se non si comprende la vita non si può interpretare la morte. E viceversa. L’una e l’altra non<br />
possono essere interpretate separatamente né possono essere comprese solo razionalmente,<br />
poiché i nostri quotidiani moduli di pensiero non concorrono a disvelare il mistero dell’umano.<br />
Sopravvive il bisogno di fondamenti e di senso di fronte alla morte, cui corrisponde il bisogno di<br />
una comprensione profonda più che di una semplice intellezione razionale sul senso dell’esistenza<br />
umana nel mondo.<br />
Gli interrogativi sulla finitudine e l’apertura all’angoscia diventano, in questo senso, degli strumenti<br />
della solidarietà umana e della pietas, in quanto consentono di ritrovare se stessi e di proporsi più<br />
positivamente e autenticamente nell’esistenza, in relazione con gli altri, nel condividere<br />
l’esperienza comune di un’esistenza contrassegnata dalla finitudine.<br />
Tendere alla propria autenticità esistenziale, conquistando progressivamente la propria<br />
progettualità, guadagnando spazi sempre maggiori alla scelta, alla decisione, all’impegno, rende<br />
possibile un progressivo itinerario verso l’infinito poter essere dell’esistenza umana, verso<br />
un’apertura alla dimensione relazionale dell’Io-Tu, nel modus amoris o nel modus amicitiae<br />
secondo gli sviluppi indicati da Binswanger.<br />
In questa modalità di fondo della progettualità nel mondo e con gli altri, tali riflessioni assumono<br />
una prospettiva esplicitamente pedagogica: il tentativo di risposta al perché più profondo della<br />
morte implica un problema di educazione alla morte come premessa per una possibile educazione<br />
alla vita autentica.<br />
74
Spaziare nel tempo: paesaggi delle autobiografie<br />
Lo spazio vissuto confluisce nelle autobiografie non solo laddove spazialità e temporalità si<br />
congiungono ma, più propriamente, laddove il tempo come durata e lo spazio come estensione si<br />
sottraggono ad ogni “misurabilità” oggettiva e si gettano nel fluire spazio-temporale dell’esistenza<br />
soggettiva.<br />
Infatti l’autobiografia è un racconto che si snoda nel tempo senza seguire le leggi dei calendari,<br />
degli orologi, che procede per salti, arresti, riprese, interruzioni, rallentamenti, inseguendo il<br />
rimembrare della propria vita. Così come il vissuto dello spazio non ha caratteri omogenei e isotopi<br />
della geometria o della fisica o del movimento meccanico, ma è largo o stretto, pieno o vuoto a<br />
seconda dell’esistenza nell’autobiografia dei soggetti così come lo spazio si spazializza nei loro<br />
vissuti.<br />
Non c’è un solo tempo né un solo spazio, ma molti. Nelle esperienze di racconti autobiografici<br />
questi spazi si dilatano o si restringono, si fanno grigi o luminosi, appaiono deserti o popolati di<br />
presenze. E il movimento in essi è orientato sulla base di un “essere respinti” o “essere attratti”.<br />
Tutte le storie di vita ( e non soltanto quando la ricostruzione del passato avviene in chiave<br />
psicoanalitica), assegnano grande rilievo ai luoghi dell’infanzia. Il narratore racconta sé stesso a<br />
partire dalla spazializzazione di un tempo carico di significati, di scoperte, di speranze.<br />
Ciascuno ha sperimentato la delusione del confronto tra i luoghi vissuti nell’infanzia e nella<br />
giovinezza e i luoghi del presente; le proporzioni delle case, delle porte, l’aspetto delle strade, le<br />
lampade accese, i rumori, i colori della luce: tutto, allora, era diverso.<br />
In Leopardi il ritorno a Recanati provoca un forte impatto emotivo per l’affluire dei ricordi legati al<br />
“natio borgo selvaggio” con i suoi mestieri, i fanciulli le ragazze….Tutto è come Leopardi l’aveva<br />
lasciato, ma egli non può continuare a guardarlo con gli stessi occhi, poiché nuove esperienze gli<br />
fanno rivedere le cose diversamente. Il ricordo, la rievocazione, il vissuto lo portano a ripensare la<br />
sua storia personale e a ribellarsi per le speranze deluse; i luoghi dei progetti giovanili, delle<br />
speranze si contrappongono al presente disilluso: ora gli resta soltanto la rimembranza acerba.<br />
Spazio e tempo non sono mai separabili nell’esperienza autobiografica che è sempre racconto di<br />
sé “a partire da” una situazione spazio-temporale. Vi è dunque, attraverso gli spazi, un raffronto<br />
passato/presente in cui i luoghi del passato rivivono nei nostri ricordi a seconda di come noi li<br />
abbiamo vissuti. Gli spazi del ricordo sono diversi perché diverso era quel tempo della nostra vita.<br />
Non necessariamente migliore.<br />
Le dimensioni soggettive del tempo autobiografico e dello spazio vissuto sono destinate<br />
nell’insondabile, estromesse da ogni possibilità di validazione scientifica? È questo un interrogativo<br />
epistemologico nodale sul quale è opportuno soffermarsi al fine di mettere a fuoco temi e aspetti<br />
del vissuto spaziale che emergono nelle autobiografie e nelle biografie formative.<br />
75
Soggettività e scientificità<br />
I presupposti epistemologici e metodologici su cui si basa l’approccio autobiografico agli spazi di<br />
vita richiamano innanzitutto l’esigenza di conferire legittimità scientifica alla soggettività.<br />
Questa istanza di scientificità può essere proseguita, nel vario intrecciarsi e sovrapporsi di aree<br />
disciplinari, correnti e indirizzi, secondo due modalità generali: o si riconduce la soggettività<br />
all’oggettività scientifica classica (interpretando gli aspetti soggettivi attraverso strumenti e<br />
categorie oggettivanti di derivazione naturalistica) o si riconduce l’oggettività alla soggettività e si<br />
conferisce dignità scientifica alla soggettività stessa attraverso nuovi strumenti di validità<br />
intersoggettiva.<br />
Nel primo caso, l’oggettività può garantire l’affidabilità scientifica di alcuni elementi, delle griglie per<br />
la loro comparazione o misurazione, ma deve esaurire la spazialità soggettiva nell’ordine e nella<br />
coerenza di un sistema fisico o geometrico, rinunciando necessariamente agli aspetti non<br />
riconducibili allo schema di lettura; eliminando cioè gli elementi anomali, indefiniti, indicibili,<br />
silenziosi o misteriosi che resteranno insondati.<br />
Nel secondo caso, una oggettività di nuovo genere, che recuperi una soggettività universalmente<br />
comunicabile, può consentire di conoscere proprio quegli aspetti della vita umana più indecifrabili<br />
quali l’inatteso, lo stupore, l’immaginario, il vissuto, salvandoli dalla scomparsa oltre la linea di un<br />
orizzonte matematizzato; ma deve rinunciare a formulare leggi, a classificare, e ad esporre<br />
enunciati che abbiano un elevato grado di rigore.<br />
Il primo orientamento intende l’oggettività in senso naturalistico e, assegnandole un primato<br />
assoluto, si fonda sulla ricerca delle spiegazioni razionali e delle cause intelligibili, privilegiando<br />
necessariamente la dimensione esteriore dello spazio: i dati, gli eventi, le dimensioni, le direzioni,<br />
oggettivamente quantificabili o catalogabili. L’autobiografia che accede all vita dall’esterno<br />
collaziona i fatti che possano fornire l’affresco complessivo del proprio percorso di vita, in quanto<br />
tale, visibile agli altri.<br />
Il secondo orientamento, riconsegnando il soggetto alla sua soggettività, rifiuta quelle metodiche<br />
oggettivanti che ridurrebbero il soggetto a oggetto, l’essere umano a cosa, disumanizzando la<br />
scientificità. I luoghi della vita non sono riducibili soltanto all’intellezione, alla concettualizzazione,<br />
alla formalizzazione. L’autobiografia che accede alla vita dall’interno ne accetta l’indeterminatezza<br />
e si affida alle tracce dello spazio interiore, ai fondamenti dell’esistenza e a quel comprendere dal<br />
di dentro che Jaspers distingue dal conoscere i nessi causali obiettivi che sono sempre visti dal di<br />
fuori.<br />
Questo secondo percorso conoscitivo consente di aprire la via alla pluralità delle esperienze<br />
spaziali, e alla pluralità delle storie di vita che ogni individuo può elaborare.<br />
Erlebnis<br />
Un primo strumento metodologico può essere individuato nell’Erlebnis, esperienza vissuta che si<br />
sottrae ad un soggettivismo incomunicabile e ha, nell’accezione che ne dà Husserl, quella validità<br />
76
intersoggettiva che assume il valore di nuova oggettività. Il pensiero di Husserl non è mai incline<br />
ad atteggiamenti irrazionalistici; è invece animato dall’esigenza di costruire un nuovo modello di<br />
ragione e di scienza come attività intersoggettiva, in quanto fondata sulla necessaria correlazione<br />
delle altre coscienze con la mia, nella comunicazione intersoggettiva.<br />
Lo spazio-mondo di cui faccio esperienza non è quindi un mondo ob-jectum, posto di fronte al<br />
soggetto, ma è un mondo circostante “per me”, a partire dal quale si generano i vissuti<br />
esperienziali sulle cose, ma anche sugli altri soggetti, che non possono essere vissuti come cose<br />
del mondo: l’Erlebnis dell’altro lo rivela alla mia coscienza come un soggetto, come me,<br />
appartenente allo stesso mondo con cui anche io sono in relazione. L’altro ha un corpo analogo al<br />
mio, si muove in uno spazio ed in un sistema di esperienze analoghe alle mie. Questo mondo<br />
comune, con-mondo, diventa perciò l’orizzonte di comunicazione interpersonale entro cui<br />
riconoscere e comprendere le esperienze vissute degli altri individui.<br />
Ogni esperienza vissuta supera così i limiti del soggettivismo e si apre alla possibile<br />
comunicazione con le esperienze soggettive altrui.<br />
La comunicabilità esperienziale e intuitiva è possibile sulla base dell’originaria struttura del mondo<br />
della vita accessibile universalmente, mondo circostante già sempre dato, prima di qualsiasi<br />
scienza.<br />
L’esperienza vissuta dello spazio è quindi soggettiva ma non soggettivistica perché è in continua<br />
relazione con la viva esperienza del mondo da cui tare origine. Perciò è presente in me con<br />
caratteristiche oggettive perché comuni e comunicabili con gli altri. Esperienza oggettiva che<br />
procede comunque sempre da un soggetto.<br />
Il metodo fenomenologico trasferisce così l’attenzione dalle conoscenze causalistiche-oggettive de<br />
dati relativi ai singoli momenti della vita alle modalità soggettive dell’esperire i fatti che assumono<br />
significatività in quanto vissuti.<br />
Attraverso l’Erlebnis la propria e l’altrui dimensione spaziale si presentano quindi come leggibili<br />
dall’interno, senza che questa operazione rimanga circoscritta al soggetto.<br />
La centralità epistemologica dell’Erlebnis in senso fenomenologico- esistenziale consente di porre<br />
il concetto di spazio vissuto sottraendolo all’astrazione e alla concettualizzazione, pur<br />
mantenendone con chiarezza la verificabilità intersoggettiva.<br />
Lo spazio vissuto e il tempo della vita<br />
Prima di ogni altra modalità dell’essere al mondo, il soggetto umano è al mondo secondo la<br />
modalità dell’abitarlo: l’umana presenza, l’Esserci heideggeriano è in sé stesso spaziale, poiché il<br />
–ci dell’Esserci indica appunto l’essere “là” nel mondo, di ogni soggetto. L’originario Daisen è<br />
sempre anche un essere nel mondo e un essere con gli altri. Il soggetto umano non ha uno spazio<br />
ma è uno spazio.<br />
77
Sulla base di queste premesse epistemologiche è possibile una lettura o un ascolto delle<br />
autobiografie, registrate o anche letterarie, per cogliervi il ruolo dello spazio e del vissuto spaziale<br />
nei ricordi e nella rievocazione dei ricordi.<br />
Il racconto autobiografico rende pertanto comunicabile la conoscenza dello spazio vissuto perché<br />
è lo spazio della relazione viva del soggetto con il mondo. Questo spazio vissuto si trasforma in<br />
relazione alla tonalità emotiva.<br />
Afferma Minkowski che, analogamente a un tempo vissuto, esiste anche uno spazio vissuto, a-<br />
matematico e a-geometrico. Egli distingue uno “spazio scuro” da uno “spazio chiaro”. Nello spazio<br />
oscuro siamo soli, smarriti, ma basta un profumo, una voce per richiamarci allo spazio chiaro.<br />
Minacciosamente invadenti, dolci o sgradevoli, gli spazi vissuti accom<strong>pag</strong>nano le voci e i silenzi del<br />
nostro fluire esistenziale. Lo spazio visivo si fonde nello spazio olfattivo e uditivo che costituiscono<br />
lo sfondo di ogni racconto di vita. L’olfatto soprattutto ha un forte potere evocativo: lo spazio è<br />
legato ai ricordi di un profumo di bosco, all’acre odore del cibo consumato in circostanze infelici o<br />
al profumo del buon cibo condiviso con l’affetto. L’odore piacevole o disgustoso che si è fissato<br />
nella nostra memoria; ci riempie di nostalgia o tristezza ogni volta che lo percepiamo perché ci<br />
riporta a quel luogo.<br />
Lo spazio vissuto è lo spazio del vivere, del vedere, dell’immaginare, dell’udire, dell’avvicinarsi e<br />
dell’allontanarsi, della contaminazione e del coinvolgimento con le cose e con gli oggetti in<br />
quell’incessante movimento che è il fluire della vita. Bachelard, riprendendo da Minkowski i<br />
concetti di risonanza e retentissement, cerca di descrivere come il soggetto abita il suo spazio<br />
vissuto e vitale, il suo angolo di mondo, gli spazi amati, l’immensità intima. Le misurazioni<br />
oggettive del geometra sono indifferenti alla risonanza interiore delle misure.<br />
Misura dello spazio vissuto non può che essere il tempo della vita con le sue Erlebnisse di<br />
profondità, di vuoto, di deserto o di abisso, di nido o di guscio, e con il movimento del volare o<br />
dell’arrancare, del perdersi o del ritrovarsi. Non esistono misure metriche per tutto ciò.<br />
Mnemosyne<br />
La seconda categoria epistemologica, che consente di descrivere gli spazi vissuti nelle storie<br />
autobiografiche, è la memoria. Ogni vissuto biografico è anche sempre rivissuto nella rimembranza<br />
e nel racconto.<br />
La ricostruzione autobiografica deve attivare la memoria, la rievocazione, l’estraniamento<br />
temporaneo dal “qui e ora”, protendendosi verso ciò che sembrava travolto dall’oblio. Lo spazio<br />
vissuto nella memoria autobiografica opera come un archivio interiore, un album di fotografie<br />
interiori in cui volti e luoghi hanno risonanza e rispecchiano ciò che l’oblio o la censura hanno<br />
consentito venisse salvato dalla corrosione del tempo. Ogni biografia, raccontata o scritta,<br />
riconduce alla matrice concettuale della rappresentazione, chiamando in causa il problema della<br />
memoria, e quindi dell’inconscio dell’esperienza soggettiva e delle relazioni con la società, la<br />
cultura, le istituzioni. Nelle autobiografie spazi e tempi minimi possono assumere proporzioni<br />
78
smisurate sulla base dell’importanza psicologica che assumono nella prospettiva della propria vita.<br />
Racconta Van den Berg di una signora che visitò, dopo la guerra, il carcere in cui era stata tenuta<br />
prigioniera durante l’occupazione; in quella visita era stata colpita soprattutto dalle dimensioni della<br />
porta che essa ricordava molto più grande. Ovviamente nel passato quella porta la separava dalla<br />
libertà e non poteva che apparirle enorme e spaventosa.<br />
La narrazione di una vita non si può immiserire in dati puramente oggettivi, in catalogazioni o<br />
ricostruzioni, senza lasciare spazio a quella ermeneutica che aprirebbe un autentico dialogo con il<br />
passato. Ogni percorso biografico, nel momento in cui si fa racconto, è filtrato dalle selezioni di ciò<br />
che si vuole o si può ricordare sulla base della prospettiva da cui si guarda alla propria biografa, e<br />
dalle autocensure, volontarie e inconsce. Il criterio di tale selezione è stabilito comunque nel<br />
presente. Ogni autobiografia o biografia, seleziona ciò che è destinato all’oblio e ciò che è invece<br />
importante rimembrare per costruire il proprio futuro.<br />
Spazi cronologicamente lontani contengono esperienze psicologiche ed esistenziali ri-memorabili<br />
continuamente perché appartenenti all’eternità dell’esistenza umana.<br />
La facoltà di ri-memorazione presieduta da Mnemosyne, la Memoria (divinità madre delle Muse)<br />
conferisce non solo la conoscenza del passato ma anche la divinazione del futuro. L’individuo<br />
rivive il passato, la sua storia, in vista del suo futuro.<br />
La memoria si fa racconto<br />
Poiché il soggetto umano è, riprendendo Heidegger, gettato a vivere innanzitutto in un mondo-<br />
ambiente e l’abitare è l’elemento connaturato all’esistenza umana, nelle storie di vita il racconto è<br />
sempre legato ai luoghi. Il terzo strumento metodologico è quindi il racconto. La narrazione è uno<br />
strumento privilegiato di conoscenza, essendo un cammino, un itinerario, un movimento che<br />
insegna qualcosa che non ha più soltanto a che vedere con i saperi della conoscenza scientifica o<br />
della tecnica, ma con elementi di un altro tipo di conoscenza: il desiderio, il mistero, il tempo, la<br />
memoria, il dolore, il segreto….<br />
Si possono misurare le lacrime? Gli sguardi? Con gli strumenti dell’esattezza no di certo. Ma chi<br />
potrebbe negare la possibile comunicabilità oggettiva di questi vissuti? Basti pensare alla<br />
conoscenza letteraria che ci fa commuovere con Omero o raggelare il sangue con Sofocle.<br />
L’intuizione, l’immaginazione, il sentimento sono a pieno titolo strumenti di conoscenza scientifica,<br />
laddove la scientificità sia da intendersi come rigorosa ma non esatta.<br />
Il racconto è una via d’accesso all’immaginario, è un accesso alla verità.<br />
La concezione di uno spazio verificabile e oggettivabile si consegna alla scienza, con le sue<br />
certezze. E tuttavia lo spazio rivissuto che ci consegna la letteratura trova in essa una fonte sicura<br />
di conoscenza, poiché nella narrazione è presente una grande aderenza agli spazi, ai luoghi, agli<br />
ambienti della vita reale esperita e vissuta dagli individui.<br />
Le narrazioni letterarie hanno sempre uno spazio, un’ambientazione, reale o simbolica, e<br />
conservano validità nel tempo. Testo letterario o romanzo di formazione, autoritratto, memoriale,<br />
79
icostruiscono frammenti di spazi autobiografici che diventano il proprio testo, il testo della propria<br />
esistenza. In tal senso, il racconto autobiografico recupera alcune esigenze formative fondamentali<br />
quali l’ascolto, la parola, il silenzio, il dialogo con se stessi, il dialogo con gli altri: ogni autobiografia<br />
è un incontro che si situa in un determinato luogo.<br />
Spaziare nella memoria<br />
“Fugaces labuntur anni” scrive Orazio: scorrono, scivolano, si dileguano…verso gli spazi dominati<br />
dalla memoria. E nel ricordo accade che un luogo ci si fa presente con una ricchezza di particolari<br />
non corrosi dal tempo.<br />
Ciò che accade nella nostra esperienza passata è legato sempre ad un ricordo spaziale, ad un<br />
luogo che acquista significato dalle relazioni ad esso legate. E che cambia con il mutare di quelle<br />
relazioni. L’evocazione dei ricordi si fonda sulla ricostruzione dei luoghi della memoria.<br />
Tutte le narrazioni di vita sono fondate sui dove, sui là e cui corrispondono gli allora, i quanto in un<br />
continuo rimando spazio-temporale.<br />
Come afferma Proust “ I luoghi che abbiamo conosciuti non appartengono solo al mondo dello<br />
spazio, nel quale li situiamo per maggiori facilità. Essi sono solamente uno spicchio sottile fra le<br />
impressioni contigue che costituivano la nostra vita di allora; il ricordo d’una certa immagine non è<br />
se non il rimpianto di un certo minuto; e le case, le strade, i viali, sono fuggitivi, ahimè, come gli<br />
anni”.<br />
Nella Recherche vi è un forte senso del ritorno, attraverso la memoria, di ciò che pareva perduto<br />
nell’oblio del tempo. Gli spazi della memoria riappaiono a volte per squarci improvvisi, sollecitati da<br />
una sensazione provata.<br />
Ripercorriamo le antichità, gli abbandoni, la desolazione dei luoghi legati alle esperienze di<br />
sofferenza, i labirinti della vita in cui si siamo persi. Vi è tutto un lessico spaziale che rimanda al<br />
dire autobiografico: la via come percorso del destino, l’esserci chiusi alle spalle una porta e il non<br />
averla più potuta aprire, l’avere varcato una soglia decisiva…<br />
Spaziando nella memoria possiamo imbatterci in luoghi luminosi o insignificanti, in prigioni paurose<br />
o in stanze dilatate dalla gioia. Molte strade che abbiamo percorso sembravano convergere in quel<br />
punto. Scorrono nella memoria direzioni, avvicinamenti, erranze verso un centro, un sogno<br />
abbandonato e pronto a ridestarsi nel ricordo.<br />
Noi che salivamo le scale, noi che credevamo di volare, noi che restavamo inchiodati…Nell’infinita<br />
galleria dei luoghi autobiografici compaiono i prodigiosi poteri evocativi dello spazio.<br />
La scena del ricordo<br />
Nella narrazione autobiografica lo spazio è, come il tempo, disomogeneo, discontinuo, sincopato e,<br />
prevalentemente, costituito da affreschi di scene.<br />
Molti luoghi sono perduti per sempre nell’oblio, ma il ricordo, significativo e vivo, è sempre<br />
ambientato in grandi scene che occupano un ruolo essenziale negli eventi narrati. La scena può<br />
essere una stanza soffocante o la gaiezza di un camino acceso, una strada, lo spazio sconfinato di<br />
80
una pianura o del mare. Talvolta è proprio lo spazio a reggere il senso del racconto autobiografico:<br />
le trincee de racconti di guerra, i paesi delle memorie di viaggio, la luce abbagliante dei campi o il<br />
buio della miniera nei racconti di lavoro, le indecifrabili città dei racconti di emigrazione ecc.<br />
Lo spazio nell’autobiografia è la scena del nostro essere sul palcoscenico della vita. Lo scenario si<br />
trasforma con la tonalità emotiva della gioia, dello smarrimento o del panico.<br />
Eravamo soli sulla scena? Dominavamo la scena? Eravamo semplici comparse?<br />
Il nostro sentirci al centro o dietro le quinte della vita ha il carattere di una vicinanza/lontananza<br />
che si esprime attraverso l’esclusione dal passato o l’autoesaltazione in un passato di glorie.<br />
Lo spazio della vita quotidiana è, per lo più, uno spazio insignificante, sfilacciato in giorni tutti<br />
uguali, in gesti ripetitivi, in un andirivieni per/da luoghi anonimi sempre uguali. Questi spazi non<br />
compaiono nelle storie di vita attraverso descrizioni di senso, essi sono riassunti brevemente e<br />
relegati sullo sfondo. Gli spazi che prendono corpo nelle storie di vita sono invece i luoghi di quegli<br />
eventi che hanno assunto pregnanza esistenziale, che hanno marcato scelte o rinunce, momenti<br />
terribili o l’irrompere di svolte, sottraendo lo spazio all’immobilità isocronica per trasformarlo in una<br />
scena indimenticabile.<br />
La regia della scena spaziale è data dalla tonalità emotiva. Le deformazioni che lo spazio<br />
attribuisce nella memoria possono produrre stupore nello stesso narratore che guarda ad oggetti e<br />
luoghi, luci e colori da prospettive continuamente mobili. I confini tra lo spazio, reale o immaginario,<br />
naturale o artificioso sono mobili. Le langhe di Pavese sono luogo geografico ma anche luogo<br />
interiore, il mare dei Malavoglia è la personificazione del Destino.<br />
La scena del racconto è sempre ambigua, mai univoca, poiché è impossibile liberarsi dai vissuti<br />
per assegnare un volto unico allo spazio del ricordo. Gabriel Garcia Marquez, in Cronaca di una<br />
morte annunciata, offre un esempio di come anche i dati atmosferici corrispondano nel ricordo agli<br />
stati d’animo: “Molti coincidevano nel ricordare che era una mattina scintillante percorsa da una<br />
brezza marina […]. Ma i più erano concordi nel dire che c’era un tempo funereo, con un cielo<br />
torbido e basso….”.<br />
Memorie dell’abitare<br />
Nei racconti di vita appaiono dominanti gli spazi dell’infanzia e lo spazio casa. Negli archivi della<br />
memoria ritornano i luoghi da cui veniamo. La casa è il grande archetipo universale della<br />
sicurezza, del rifugio, la tana, il nido, l’intimità. Ma nel ricordo la casa può anche essere spazio<br />
dell’esclusione, dell’allontanamento, della separazione, della nostalgia. Vissuti dell’intimità abitativa<br />
s mescolano quindi con vissuti di sradicamento e di estraneità.<br />
La dimora dell’uomo è un grande archetipo, il centro della sua vita è uno dei più potenti elementi di<br />
integrazione per i pensieri, i ricordi e i sogni dell’uomo. A casa troviamo le cose conosciute familiari<br />
che ci richiamano infondendoci sicurezza e irrobustendo la nostra identità. Il ricordo della casa è<br />
ricordo di suoni e brusii noti, di voci, di colori, di ombre, di odori che occupano un ruolo essenziale<br />
81
nella costruzione dei vissuti abitativi. Le storie degli spazi vissuti raccontano eventi e gesti che si<br />
mescolano con la quotidianità dei luoghi e degli oggetti di casa.<br />
Proust ci ha insegnato numerose possibili sfumature di cui è fatta la nostra memoria dell’abitare<br />
soprattutto nell’infanzia. Da queste memorie nasce l’abitudine, l’abituale che riceve attribuzioni di<br />
senso dai nostri vissuti. Nell’infanzia noi abitiamo i suoni, i profumi, le luci e le ombre della nostra<br />
casa ed esperiamo i vissuti abitativi dei muri, delle stanze, oltre che degli altri che sono con noi co-<br />
presenti, popolandola di voci e di parole: l’urlo o il bisbiglio affluiscono nei racconti come indicatori<br />
della spazialità.<br />
E nella casa la cucina domina con i profumi del cibo familiare. Intense rimembranze richiamano i<br />
luoghi meno frequentemente esplorati dell’infanzia: la cantina, la soffitta. Ma l’angolo di mondo più<br />
intimo è legato al ricordo di un dentro ancora più interno che protegge i ricordi: il centro del<br />
labirinto. La propria stanza, il proprio cassetto, proprio quel cassetto dove noi tenevamo gli oggetti<br />
più carichi di “mana”. In quegli spazi interiori che si strutturano e si destrutturano continuamente in<br />
rapporto ai processi di cambiamento.<br />
All’abitare è legato l’incompiuto, l’irrisolto, e anche l’inevitabile. Le cose depositate, gli oggetti, i<br />
mobili sono accolti in uno spazio vivo che veicola contenuti di progettualità e prospettive future, ai<br />
quali ritorniamo con la tenerezza malinconica del rimpianto, con la struggente onta del fallimento,<br />
con l’orgoglio degli ostacoli superati, con l’amarezza delle rinunce, con l’affanno di una meta.<br />
Topologia interiore e percorsi formativi<br />
Appare ormai evidente che la relazione del soggetto con i luoghi del suo passato non è<br />
determinata dai contenuti oggettivi dei ricordi ma dall’orizzonte di senso entro il quale egli<br />
esperisce il passato ed il presente.<br />
L’identità personale si costruisce ripercorrendo i modi e i luoghi del nostro abitare. I riferimenti<br />
spaziali diventano segni stessi della memoria e acquistano un significato simbolico che permane<br />
nel racconto della nostra vita.<br />
I luoghi narrati dalle autobiografie altro non sono se non la topologia interiore: il riflettere e il<br />
riflettersi, il sé e l’altro che è in sé, l’identità come disidentità o pluridentità. Ai diversi spazi<br />
corrispondono le diverse identità del nostro io multiplo.<br />
Lo spazio interiore è la nicchia identitaria dove riecheggiano le aspre voci del mondo che ci hanno<br />
ferito e dove le dolci parole amiche leniscono le ferite. Di tutte le atmosfere vissute che si fanno<br />
racconto autobiografico restano le dissolvenze delle Erlebnisse nella memoria.<br />
L’autobiografia ci mostra come la nostra storia possa modificare uno spazio o addirittura crearlo.<br />
L’autobiografia, in quanto ricordare, ripercorrere quei luoghi, non soltanto per abbandonarsi a un<br />
certo stato d’animo, ma per il valore che il ritorno a quel tempo e a quello spazio ha per la<br />
ricostruzione formativa volta al futuro.<br />
82
In tal senso la retrospezione è formativa, essendo comprensiva di una nostalgia come desiderio di<br />
un possibile ritorno e di un oltre che continuamente incalza verso il futuro e il rinnovato progetto di<br />
sé.<br />
Ogni autobiografia formativa è sempre spazializzata in quanto ha sempre un’origine nella<br />
reminiscenza di spazi divenuti, nel nostro spazio interiore, luoghi dell’appartenenza. Nel processo<br />
formativo saranno quindi i luoghi del passato, ed il loro rivelarsi, a modificare il presente; ma sarà<br />
soprattutto il presente a cambiare il passato richiamandolo dentro un progetto generale di<br />
esistenza.<br />
È sempre da uno spazio-luogo che prende vita il vissuto dell’attesa, della nostalgia o dell’illusorio<br />
ritorno, ma è anche da uno spazio-luogo che possiamo immaginare e progettare la partenza,<br />
l’avvenire, l’ignoto, il distacco. Le tracce del passato, in questo modo, si trasformano in tracce di<br />
futuro.<br />
Nell’atto di rimembrare e narrare la propria storia di vita il soggetto umano si pone nella duplice<br />
condizione di esser-ci e insieme esistere, superandosi verso la libertà.<br />
I transiti: costruzione di futuri<br />
La ruota dello zodiaco cigola dei suoi mille giri. In quel continuo susseguirsi di passaggi che è<br />
l’esistenza umana nessun giro è uguale all’altro e non si transita mai per lo stesso punto. E tuttavia<br />
non tutto ciò che è passato viene eliminato, ma viene ripreso per essere superato e integrato nel<br />
nuovo. Nulla può accadere conformandosi al già avvenuto, ma tutto accade trans-formandosi<br />
attraverso i transiti del tempo progettuale.<br />
Si tratta spesso di passaggi segreti, poco eclatanti, che avvengono passo dopo passo, in punta di<br />
piedi, che ci trattengono sulla soglia o ci conducono attraverso la precarietà di un guado interiore,<br />
negli stretti passaggi dell’anima, nelle uscite di sicurezza dei sentimenti, nei salti sopra i precipizi<br />
silenziosi dei nostri vissuti, negli spazi delle relazioni che stringiamo con gli altri, negli approdi di<br />
naufraghi sui lidi delle delusioni, dove il calcolo dei dadi più non torna.<br />
Trans-itum è movimento. In quanto participio passato di trans-ire unisce il concetto di oltre (trans)<br />
con quello di andare, assumendo le molteplici accezioni di passare, andare, scorrere, trascorrere,<br />
trapassare, sorpassare, mutarsi, e di passare attraverso, attraversare, trapassare, sorpassare,<br />
superare. Tutti questi aspetti sono presenti nei percorsi formativi in quanto tensione<br />
all’oltrepassamento della situazione presente attraverso successive modificazioni. Attraversare e<br />
oltrepassare hanno significati diversi ed esprimono momenti e dimensioni diversi. Non si ha<br />
oltrepassamento senza un attraversamento.<br />
Il senso del qui e ora, nel senso fenomenologico, si dispone a partire dal progetto, dal futuro, dalla<br />
speranza e dall’attesa, ma affonda inevitabilmente le radici nell’esperienza passata, nella memoria,<br />
nella storia personale e collettiva.<br />
83
Trans-formazione<br />
La formazione è trans-formazione poiché avviene nel susseguirsi di eventi mutativi su cui si<br />
focalizza, nel suo scorrere continuo, il processo di cambiamento. La formazione procede<br />
attraverso transiti che avvengono nel tempo e nello spazio, siano essi determinati dal ciclo<br />
biologico della vita o da scelte personali, da ineluttabili eventi, da incontri, da coercizioni sociali,<br />
dall’intervento intenzionale di un formatore o dall’imprevisto destabilizzante.<br />
La trasformazione di sé non procede in modo unidirezionale, conosce inversioni, arresti, riprese,<br />
svolte: il cammino non prosegue sempre linearmente ma, con un movimento a spirale, ritorna<br />
apparentemente al punto di partenza, sembra capovolgersi, per avanzare in modo nuovo.<br />
Quando le promesse e le speranze si sono rivelate illusorie, è allora indispensabile risorsa<br />
l’educazione al cambiamento, poiché non si ha trans-formazione nell’immobilità di un presente che<br />
non si vuole abbandonare. Né si ha trans-formazione quando si nega la situazione presente per un<br />
oltre de-responsabilizzante, irraggiungibile o velleitario. Non nell’arresto esistenziale che si<br />
ravvolge nel rimpianto.<br />
Il transito è contemporaneamente qui e oltre, come il fiume è contemporaneamente, nel suo<br />
scorrere, al monte e alla foce.<br />
Nell’attraversamento avviene un cambiamento che non mi trasforma in quanto “altro da me”, ma<br />
mi trasforma in un altro me: io cambio restando nella mia ipseità. Il transito è infatti un passaggio<br />
che comprende al tempo stesso il movimento del divenire e l’essere nell’attraversamento, il<br />
procedere verso il cambiamento e il permanere in esso, il camminare e il restare transitando.<br />
Divento soggetto maturo, libero o prigioniero, mi distacco per una destinazione e mi perdo o<br />
approdo dove non ero diretto e tuttavia conservo, anche lì, nel tragitto, la mia identità.<br />
Vi è, nel passaggio che fluisce e scorre, il momento del passare, che è un essere sulla via o sulla<br />
soglia o nel guado, nel limite. Le grandi svolte della vita umana sono spesso accom<strong>pag</strong>nate da riti<br />
di passaggio che rendono visibile l’attraversamento e ne sottolineano l’importanza, come accade<br />
per la nascita, il matrimonio, la morte.<br />
Infinite volte il transito è un’onda inconsapevole: il prima sfuma nel dopo, senza frontiere precise a<br />
demarcare territori. Non ci si accorge della trasformazione mentre essa è in atto, ma dopo che<br />
essa è avvenuta, volgendoci indietro.<br />
Se la pubertà è un’età di transito, essa è pur sempre anche un essere nella pubertà, dunque un<br />
permanere, più o meno lungo, nella condizione del transito. Un distacco, una separazione<br />
improvvisa, una morte ci fanno essere in lutto. Persino la nascita non è il nascere e la morte non è<br />
il morire. Mentre attraversiamo, siamo contemporaneamente qui e altrove poiché il transito è un<br />
non più e un non ancora, è il principio dionisiaco della trasformazione nella permanenza. Dioniso è<br />
infatti dio della liminarità, della fluidificazione dei confini, di uno spazio di mezzo in cui i contrari<br />
transitano e si intrecciano, offrendosi in strane e inedite configurazioni.<br />
84
Il transito è l’esperienza della precarietà, del labirinto, la perdita del luogo certo dove dispiegare la<br />
nostra esistenza ed è perciò molto spesso l’esperienza del vuoto, del nulla, del terrore<br />
dell’inconsistenza identitaria.<br />
Il transito si sottrae al rischio di condurre alla perdita del mondo, ma diventa il nucleo stesso della<br />
trans-formazione soltanto se si impara a stare nei transiti, a essere nel tragitto cogliendone e<br />
accettandone al condizione “viatoria” come condizione significativa per me, indipendentemente<br />
dalla meta. Il passaggio ha senso in sé, anche prima che siamo arrivati all’oltre, anche quando ci<br />
sembra di perderci nel labirinti dell’esistenza.<br />
Abitare la trasformazione<br />
Il transito è necessario al processo formativo/trans-formativo: educazione e formazione possono<br />
essere viste, in definitiva, come educazione ai passaggi da una situazione esistenziale ad un’altra.<br />
La formazione ha dunque come suo primo compito quello di preparare, favorire, accom<strong>pag</strong>nare,<br />
produrre, rielaborare i mutamenti. Essa si fonda sul costante invito a non uniformarsi al mondo<br />
presente ma a trasformarsi per trasformarlo. La decisione di cambiare e di trasformarsi in vista<br />
dell’autorealizzazione non è mai assoluta, cera, avvenuta una volta per tutte. Questa decisione è<br />
resa possibile da quella specifica disposizione fondamentale dell’umano che è il suo essere per<br />
l’educazione.<br />
L’educazione ai passaggi si può avvalere anche di tecniche di trasformazione, come la<br />
meditazione autobiografica, che possono rendere più consapevoli le esperienze vissute di<br />
oltrepassamento o favorire la preparazione all’attraversamento, o aiutarci a riconoscere e vivere<br />
consapevolmente anche i trapassi che accadono senza o contro la nostra volontà.<br />
I passaggi si collocano sempre, innanzitutto, nella dimensione della temporalità, della spazialità,<br />
della corporeità. La trasformazione del corpo non consiste infatti solo in un cambiamento esteriore<br />
e biologico ma in un cambiamento che coinvolge tutta la nostra persona nel nostro essere un<br />
corpo e nel linguaggio del corpo che siamo.<br />
Il passaggio è sempre trascendenza, possibilità, perenne poter essere che implica la<br />
chiarificazione di ciò rispetto a cui e ciò in vista di cui avviene il superamento.<br />
Nei processi formativi l’esperienza del transito può essere considerata secondo tre prospettive: in<br />
quanto attraversamento il transito si connota sia come un provenire da, sia come un passare oltre,<br />
sia come un passare attraverso.<br />
Vi è innanzitutto un prima, un al di qua che colloca ogni passaggio nell’insopprimibile effettività<br />
della concreta situazione fattuale di spazio, tempo, corpo, condizionamenti culturali, sociali,<br />
biologici.<br />
Vi è poi un durante che comporta un essere in transito, tra i due poli, un saper stare nel transito,<br />
nel difficile e precario equilibrio della durata, avvenga essa in un breve attimo o nell’arco di un<br />
periodo della vita.<br />
85
E vi è soprattutto una direzione del trascendimento, il verso dove dell’attraversamento: la meta<br />
vagheggiata, desiderata o temuta, spesso irreversibile, talvolta irraggiungibile, quasi sempre<br />
diversa da come ce l’eravamo prefigurata.<br />
Questi tre momenti comportano interrogativi importanti per la formazione: attraverso quali vie, in<br />
quali spazi, con chi affrontare i transiti? E in quale direzione? Che cos’è infine l’oltre, il dopo?<br />
Il passaggio si connota come lo spazio-tempo dell’attraversamento in cui si alternano e si<br />
mescolano il sentimento del limite e il sentimento dell’infinito. Il per dove, il passare attraverso, è<br />
comunque superamento dell’immobilità: averne consapevolezza è abitare la trasformazione.<br />
Da dove: la situazione<br />
Senza un passato da cui partire non ha senso alcun approdo. Da dove? È l’interrogativo iniziale<br />
che pone in questione la situazione da cui procede ogni transito. Da dove si proviene<br />
all’attraversamento?<br />
È questa la domanda del radicamento nella storia. A partire dalla fatticità della situazione si<br />
prepara il cambiamento. La fatticità è ciò rispetto cui avviene ogni cambiamento, preparato,<br />
progettato, atteso, come un evento desiderabile, oppure temuto, come un appuntamento<br />
inevitabile. È da un determinato essere corpo che proveniamo, è da quelle circostanze, da quei<br />
luoghi, e non da altri, che troviamo identità. Il pensiero autobiografico diventa in tale prospettiva<br />
strumento formativo privilegiato in quanto procura all’autore consapevole della propria vita<br />
emozioni di quiete, anche laddove si volga verso un passato personale doloroso di errori o<br />
occasioni perdute.<br />
Nessun atto formativo è veramente possibile se non radicandolo nell’effettività dell’esser gettati, lì<br />
e non altrove, così e non altrimenti. È in quella situazione che maturiamo, prepariamo, aspettiamo,<br />
paventiamo il nostro passaggio successivo. Ed è sempre lì che ci giunge inaspettato e<br />
indesiderato il transito verso i periodi bui e le zone d’ombra della vita. Ed è solo da quella<br />
situazione che potremo farvi fronte o arrenderci, trasformando in risorsa verso gli altri balzi o<br />
fermarci nell’immobilità.<br />
L’al di qua fondamento e origine di ogni superamento, è anche anteriore nel tempo e ciò che a noi<br />
è più vicino. Lo spazio-tempo che precede il transito è noto e familiare, e può generare la paura ad<br />
allontanarsi verso quel trans che ci chiama all’esplorazione, alla curiosità, alla scoperta. La paura<br />
può paralizzare la scelta. La paura della perdita, del fallimento, del distacco impedisce la trans-<br />
formazione, sia che la reprimiamo, sia che la rifuggiamo: i passaggi verso la libertà nascono anche<br />
dall’accettazione delle nostre paure. L’al di qua scorre tra paura dell’autonomia e desiderio di<br />
libertà.<br />
Trans-ire: passare per di là, attraversare<br />
Per dove? Il tempo-spazio del transito è il luogo della precarietà, dove si incontrano e sfumano<br />
l’attesa e il rimpianto, dove l’Erlebnis, l’esperienza vissuta del passato e del futuro si perdono<br />
dentro l’esperienza del presente e le tensioni si con-fondono nel tragitto.<br />
86
È questo il tempo decisivo per i modi e le forme del trascendimento. Tempo bisognoso<br />
dell’accom<strong>pag</strong>namento di una guida, tempo della ridefinizione delle mete, tempo dell’essere in<br />
cammino o nella navigazione con bussole e portolani, gli strumenti dell’attraversamento. Spazio<br />
del non luogo che si appresta a diventare luogo dell’oltre.<br />
Non sempre la meta diviene luogo; non per tutti il medesimo passaggio conduce agli stessi esiti.<br />
Nell’Antico Testamento, Dio consente l’Esodo degli Ebrei dall’Egitto trasformando il Mar Rosso in<br />
varco: separando le acque rende sicuro quel transito verso l’altra sponda che rappresenta una<br />
nuova vita nella terra promessa, una nuova fase della libertà, la fine della schiavitù. Quella stessa<br />
traversata di nuova vita per gli Ebrei divenuta tragitto di morte per gli Egizi che annegano nel mare<br />
richiuso.<br />
La trasformazione, nei riti antichi, avviene mediante il contatto con elementi naturali o persone, o<br />
mediante la parola o lo sguardo che illumina e trasforma. Il contatto che ha luogo nell’incontro<br />
trasforma noi stessi, il nostro percorso di crescita, e trasforma il rapporto. Io esco diverso da ogni<br />
incontro rispetto a com’ero quando vi sono entrato.<br />
Nelle fiabe e nei miti vi è una grande attenzione ai transiti, ai pericoli di annegare, di perdersi nel<br />
bosco, di essere divorati. Lungo il cammino verso l’altra sponda l’eroe deve superare prove e<br />
vincere draghi, orchi e streghe. Nel passaggio l’eroe esce rinnovato e trans-formato, ritorna sul suo<br />
cammino arricchito di nuove lingue ed entra in un nuova comunicazione con la vita. Dopo ogni<br />
salto vi è un nascere di nuovo che è sempre cammino di trasformazione.<br />
Il transito non riguarda solo una via straordinaria che si attraversa, un incontro eccezionale, ma<br />
anche la quotidianità. E persino il nostro sentirci a mani vuote. Il quotidiano scorrere della vita, la<br />
famiglia, il lavoro, il susseguirsi delle stagioni sono densi di passaggi che producono esperienze<br />
vissute di rinascita. La gioia, la sofferenza, la fatica, la delusione, la speranza stessa ci<br />
trasformano e sono esperienze di passaggi in cui il vecchio sé cambia nel nuovo: ogni esperienza<br />
è un transito.<br />
Il compito del formatore è quello di un accom<strong>pag</strong>natore che aiuta il processo di attraversamento e<br />
favorisce la trasformazione. A volte dovrà più propriamente provocarla, liberando, come nelle<br />
fiabe, dall’incantesimo che imprigiona e impedisce di valicare il bosco.<br />
L’intervento del formatore si pone perciò come un prendersi cura della trasformazione dei soggetti<br />
in formazione, accom<strong>pag</strong>nandoli nel cammino di crescita, indicando vie per il cambiamento e<br />
incoraggiando percorsi di cambiamento. Avendo ben chiaro che la trasformazione non è una<br />
tecnica che si può insegnare: la trasformazione è qualcosa che accade.<br />
Verso dove: la possibilità<br />
Alla certezza rassicurante o alla noia del noto o all’impazienza del cambiamento si oppone<br />
l’incertezza angosciosa o affascinante dell’ignoto. Verso dove? È allora la domanda sulla direzione<br />
che subito incalza.<br />
87
L’esperienza del cambiamento si intesse di numerose esperienze: due in particolare, antitetiche, la<br />
speranza e la morte. La prima presuppone il tempo dinanzi a sé, l’attesa, l’avvenire, la seconda è<br />
la chiusura e il venir-meno di ogni futuro.<br />
Purtroppo gran parte dei nostri processi formativi sono guidati esplicitamente o implicitamente da<br />
insegnamenti volti a sopprimere i nostri bisogni di autonomia e l’ascolto delle voci che ci chiamano<br />
verso il nuovo. Il timore della libertà, dell’avventura e della ribellione ci trattengono al di qua<br />
dell’attraversamento, ci impediscono si salpare.<br />
Tutto un passato di esperienze e di conoscenze qua ci si offre, ma al tempo stesso la dimensione<br />
del cambiamento ci sospinge là verso la trasformazione.<br />
L’educazione al cambiamento si fonda su un progetto che da questa sponda nota si protende<br />
verso la possibilità. Il transito è “l’in vista di” verso cui si direziona la progettualità.<br />
Il poter essere altrimenti e altrove rimarrebbe velleitario e astratto se il progetto formativo non si<br />
ancorasse al qui e ora della situazione. La trans-formazione è modificazione-superamento della<br />
situazione verso la propria realizzazione. Nella propria decisione per la libertà, per il superamento,<br />
per il trascendimento si trova il significato autenticamente trans-formativo del progetto. Il tempo<br />
non ha più il carattere di una autorealizzazione, di un divenire, quando il futuro si smarrisce e si<br />
dissolve nell’orizzonte o quando incombe come una minaccia imminente e inappellabile. La<br />
possibilità costantemente comporta il rischio del fallimento poiché il fallimento è insito nella<br />
possibilità stessa.<br />
Senza un futuro, senza un progetto gettato verso l’altra sponda non si produce transito formativo.<br />
Tutt’al più si può essere scagliati sull’altra sponda da un’onda più forte, o restare qua,<br />
consegnandosi alla fatticità della propria finitudine.<br />
L’oltre<br />
L’oltre è il “verso dove” tendeva la speranza o il “dove” di una meta immaginaria o progettata.<br />
L’oltre è la rottura avvenuta, il distacco compiuto, il nuovo che si situa nella continuità con un<br />
passato e si prepara a rinnovate aperture. Un “oltre” incalza continuamente il cammino formativo e<br />
lo sostiene nella tensione progettuale. Nel “dopo” si situa il compimento del tragitto, avviene la<br />
rielaborazione del passaggio medesimo. Dal punto di vista della formazione è fondamentale la<br />
capacità di guardare indietro e di valutare il carattere ed il senso del proprio percorso. La<br />
rielaborazione è infatti indispensabile per progettare i passaggi successivi e consiste nella capacità<br />
di riconoscere e leggere il proprio percorso, nella presa di consapevolezza del cambiamento che<br />
esso ha comportato, sia che si tratti di un guado scelto, sia che esso venga subito. È proprio<br />
quando il trans diventa un hic, un qui nell’essere oltre, dell’avere compito la traversata che si<br />
comprende il senso di ciò che abbiamo lasciato, del nostro sé precedente, del nostro essere stati.<br />
Il mito dell’oltre permea molti aspetti della nostra cultura: l’ebbrezza, l’estasi, lo sconfinamento, il<br />
superamento dei nostri limiti precedenti. L’oltre è il nuovo, l’inesplorato, l’impensato, e, come tale,<br />
può generare anche vissuti di spaesamento e sradicamento.<br />
88
Non sempre l’oltre coincide con una destinazione. Il trans, l’al di là, può rivelarsi anche un vicolo<br />
cieco, può assumere il carattere degli Holzwege di Heidegger, i sentieri che si perdono nel bosco e<br />
non portano da nessuna parte. Sono i sogni mai realizzati, le gioie mai raggiunte, i desideri<br />
incompiuti.<br />
Quando ci poniamo nell’oltre, quell’allora che aveva il carattere dell’attesa diventa un ricordo o un<br />
rimpianto. Il senso dell’irreversibile può diventare un tormento per gli adulti che non abbiano<br />
coltivato il cambiamento come risorsa e la capacità di affrontare i passaggi della vita come<br />
momenti di rottura che permangono nella continuità del fluire. Il luogo dell’infanzia che non<br />
rivedremo più, il tempo della giovinezza che non ritorna diventano un’aria d’altro tempo e d’altro<br />
luogo, che ha il carattere del mai più.<br />
Con lo sguardo della nostalgia verso l’origine, perdiamo il piacere del nuovo. Ma perdiamo anche il<br />
piacere di rimembrare il passato da cui veniamo.<br />
Quel che è finito è ancora in noi, quel che è scomparso è presente sotto le forme del ricordo e,<br />
anziché trasformarsi in struggimento dell’irreversibile mutamento compiuto, può trasformarsi in una<br />
sorta di “autonutrimento” che non avviene attraverso le semplici rievocazioni ma mediante la trama<br />
interiore che abbiamo costruito e che ha dato luogo a immagini, forme, nuove storie.<br />
L’oltre quando diviene risultato raggiunto o finalità conseguita, è già sempre ancora, secondo la<br />
logica a spirale, nuovo progetto e prefigurazione di nuovi transiti, nel perenne fluire del tempo della<br />
possibilità.<br />
È questo il destino di Siddartha. Le sue diverse e sconvolgenti esperienze di vita lo portano a<br />
errare a lungo nell’angosciosa ricerca di sé stesso e nella ricerca vana di nuovi maestri. Quando<br />
arriva, disorientato e deluso, al fiume, incontra lo stesso barcaiolo Vesudeva che lo aveva<br />
traghettato molti anni prima, quanto partiva verso una nuova vita che adesso è diventata vecchia e<br />
spenta. Vesudeva, il traghettatore che vive miseramente è un transito per Siddharta. Ora egli sa di<br />
poter ancora imparare. E impara dal fiume che anche la sua vita è un fiume. E riesce a cogliere<br />
l’unità nel divenire.<br />
La passione del progetto<br />
Ogni evento umano è un atto e non un fatto; ogni evento formativo è un atto progettuale. Intesa<br />
come “fatto” la formazione non genera “storia”, né personale né sociale, collocandosi in una fissità<br />
extra-temporale; intesa come “atto” è un evento dinamico che si colloca nella temporalità proprio in<br />
quanto si fonda sul progetto.<br />
Il progetto costituisce il fondamento vitale di ogni esperienza formativa radicata nell’esistenza.<br />
È infatti l’esistenza stessa che si dispone come progetto, poiché l’essere umano è posto in<br />
condizione di ex-sistere, cioè di oltre-passare, di trascendere, attraverso il progetto, la fatticità della<br />
situazione in cui è “gettato” a vivere. In soggetto, inteso come Esserci, è là, nel mondo, gettato,<br />
89
nella situazione insopprimibile di effettività e fatticità. La Geworfenheit (tradotta come deiezione o<br />
gettatezza) è quindi carattere costitutivo dell’Esserci.<br />
Ma la condizione esistenziale dell’Esserci in quanto “gettato” è quella di pro-getto poiché l’essere<br />
umano continuamente si supera, nella sua gettatezza, attraverso un perenne aver-da-essere; egli<br />
si progetta nel proprio mondo, si significa in esso, storicizzandosi nei diversi modi del poter-essere<br />
e del poter-essere-se-stesso.<br />
Il soggetto umano è progetto gettato<br />
È opportuno segnalare le corrispondenze tra il verbo latino proicio, proicere, gettare avanti,<br />
lanciare, il participio proiectum, il sostantivo proiectus e il verbo tedesco werfen “gettare”, lanciare,<br />
il participio heworfen, il sostantivo wurf. Queste consonanze etimologiche rivelano come la<br />
condizione di “gettato” e la condizione di “progetto” siano dunque tra loro inscindibili poiché l’Esser-<br />
ci si rapporta al mondo secondo la duplice relazione di abitarlo così come il progetto si dà nella<br />
Geworfenheit.<br />
L’essere gettato e il progetto in sé sono propri dell’esistenza umana. Il soggetto è quindi sempre<br />
un progetto gettato”.<br />
Ogni progetto è condizionato dall’effettività della situazione che ne costituisce il limite e al tempo<br />
stesso ne è lo sfondo: la dimensione concreta di spazialità, temporalità, corporeità, storicità che<br />
costituiscono la biografia stessa del soggetto.<br />
In tal senso il progetto è proprio dell’umano; è insito nella soggettività di ogni esperienza umana<br />
vissuta. Ogni storia esistenziale precede e sostanzia un progetto.<br />
L’essere umano si distingue dagli altri enti intramondani semplicemente presenti, poiché nel suo<br />
“ci”, egli non è, semplicemente, ma è un non ancora, cioè un aver da essere.<br />
Il senso dell’esistenza è infatti da ricercare nella temporalità del progetto. L’Esserci è possibilità<br />
progettuale, è poter essere, a partire da quell’esser gettato in cui l’essere umano assume il proprio<br />
passato e si dispone al futuro.<br />
L’educazione trova proprio per queste ragioni la sua centralità nel progetto. Ogni trasformazione è<br />
sostenuta da un progetto, si fonda nel presente, in vista di una proiezione nel futuro. Il progetto è<br />
sempre un’esperienza direzionata che si accom<strong>pag</strong>na a comportamenti e a sentimenti direzionati.<br />
L’esperienza dominante dell’esistenza è l’esperienza temporale. La fenomenologia husserliana ci<br />
insegna però a non intendere tale esperienza in senso oggettivo e materiale, ripartendo le nostre<br />
azioni e relazioni in un passato (i ricordi, ciò che abbiamo fatto), un presente (ciò che stiamo<br />
facendo) ed un futuro (ciò che progettiamo). Queste delimitazioni di momenti oggettivi corrisponde<br />
infatti ad una logica che non comprende il fluire dell’esistenza in cui le tre dimensioni temporali si<br />
fondono incessantemente. Il futuro della progettualità esistenziale non è il futuro oggettivabile, ma<br />
appartiene al tempo della vita, un tempo senza fratture, che continuamente riprende, attraverso i<br />
ricordi, un passato ancora presente, e sempre si progetta in un futuro che riceve significato del<br />
presente e del passato.<br />
90
Il progetto si presenta dunque filtrato attraverso il tempo vissuto: un tempo chiuso che imprigiona<br />
la possibilità di progettare o un tempo aperto che lascia passare il progetto come memoria del<br />
futuro.<br />
I modi del progettare<br />
Il progetto assume significati diversi e molteplici implicazioni emotive e concettuali corrispondenti a<br />
forme categoriali differenti. Vi è una progettualità più moderna, secondo l’accezione heideggeriana,<br />
legata al quotidiano raggiungimento di beni materiali. Vi è poi una progettualità personale, legata<br />
alla sfera affettiva e sentimentale che intenziona i nostri progetti verso gli altri. E vi è una<br />
progettualità volta al senso stesso della nostra vita che chiama in causa i valori, l’etica, la<br />
metafisica, la politica, la religione, spingendosi nella progettualità fin oltre la morte.<br />
Anche le diverse fasi della vita comportano modificazioni nella progettualità: si progettano cose<br />
diverse, secondo obiettivi diversi, individuando modalità diverse, secondo obiettivi diversi,<br />
individuando modalità diverse. La vecchiaia, in tal senso, è generalmente un tempo povero di<br />
progettualità di lungo respiro, ma non privo di progettualità. Non vi è soggetto umano che non<br />
possa concepire fino all’ultimo istante di vita un progetto, sia pure nella consapevolezza dei limiti.<br />
Così come vivere senza progetti, denunciato da più parti come uno dei mali delle giovani<br />
generazioni, implica l’impossibilità di “infuturarsi” e di perseguire possibilità di cambiamento.<br />
Vi sono inoltre diverse manifestazioni del progetto, a seconda che si tratti di un progetto interiore,<br />
intimo, che si vuole, o si deve, mantenere segreto, o di un progetto che si intenda manifestare o<br />
addirittura diffondere per convincere altri ad aderirvi.<br />
In ogni caso, strettamente connessi ai modi del progetto sono i concetti di scelta e possibilità. La<br />
possibilità rende perseguibile la progettualità. Il soggetto progettante si trova tra il superamento<br />
della necessità e il non poter tenere conto della necessità. I vincoli pongono al riparo da<br />
velleitarismi e astrattezze; ma la consapevolezza dell’intrascendibile non deve indurre alla rinuncia<br />
o alla rassegnazione. Il senso fondamentale del progetto richiede piuttosto la ricerca continua di<br />
margini di possibile progettualità, di ciò che possa essere scelto o agito affinché l’essere gettato<br />
non prevalga sul progetto.<br />
La possibilità costituisce quindi lo spazio di scelta rispetto alla fatticità, la condizione per il suo<br />
superamento. Il poter essere rimarrebbe astratto se non si traducesse in decisione e scelta.<br />
L’individuazione dei margini del progetto di fronte ai vincoli della fatticità richiede impegno, scelta,<br />
decisione: le condizioni per una progettualità concreta e reale.<br />
Il progetto è movimento, è cambiamento e ha bisogno di libertà. Qualsiasi coazione comporta<br />
quella rigidità esistenziale che inibisce il distacco dal “prima” verso un “poi”. La decisione può infine<br />
non raggiungere il suo scopo: essa implica infatti il rischio e la possibilità del fallimento, e anche la<br />
rassegnazione in cui la possibilità si consegna alla situazione.<br />
La decisione consente di gettarsi nel fluire del tempo senza farsi trascinare dallo scorrere<br />
cronologico.<br />
91
La tonalità emotiva del progetto<br />
“Basta non avere passioni” è il progetto dell’ingenuo Memmon di Voltaire che “concepì un giorno<br />
l’insensato d’essere perfettamente saggio”. Non c’è uomo al quale questa follia non sia passata<br />
qualche volta per la testa. Memmon disse: “ Per essere saggissimi, e di conseguenza felicissimi,<br />
basta non avere passioni; e nulla è più agevole, come si sa” (Voltaire, Memmon, o la saggezza<br />
umana). Basta non avere passioni è come dire: basta non avere progetti. Il progetto conferisce i<br />
caratteri della tonalità emotiva all’esistenza.<br />
Le diverse modalità della progettazione, dell’autoprogettazione o dei diversi schemi di<br />
trascendimento, attraverso cui il soggetto concepisce e vive il progetto, rivelano come egli è nel<br />
mondo, come la sua progettualità è radicata nell’esistenza. E in questo radicamento si situa<br />
l’apertura alla comprensione della tonalità emotiva che connota ogni progetto: attesa, sicurezza,<br />
pazienza, fiducia, ansia, distacco.<br />
Le emozioni e le passioni che si accom<strong>pag</strong>nano al progetto sono espressione della diversa<br />
temporalità vissuta: la speranza e la gioia si irradiano e si pro-tendono verso il futuro, mentre nella<br />
rassegnazione e nella disperazione domina il presente, e il futuro appare privo di attrattiva. Non c’è<br />
più alcun oltre verso cui spingersi curiosi o desiderosi. Il desiderio si trasforma in ripugnanza.<br />
Nel progetto sono impliciti sa la dimensione attiva del volere e dell’adoperarsi per.. (ogni progetto<br />
comprende qualcosa di prometeico in quanto amore del futuro), sia la dimensione più passiva, nel<br />
senso nobile di patior, della passione, del patire, del desiderio, della speranza, dell’attesa.<br />
La tonalità emotiva del progetto è principalmente connessa a sentimenti profondi dell’esperienza<br />
umana. La paura e la speranza collocano il progetto tra passato e futuro attraverso l’attesa,<br />
dimensione connotata di forti emozioni: fiducia, ottimismo, inquietudine, abbandono, sfiducia,<br />
panico. Il progetto è sempre anche sospensione, è restare il sospeso in attesa della realizzazione.<br />
Il volto attivo del progetto, che dipende dal volere e dall’io, dalla spinta e dalla decisione, si<br />
incontra/scontra con i progetti altrui. Le emozioni che emergono nella tonalità emotiva del progetto<br />
diventano allora vie di accesso alla conoscenza dell’altro e alla relazione interpersonale attraverso<br />
cui il progetto di sé si intona ai vissuti esperienziali.<br />
Il progetto ha bisogno della realtà concreta, della storia, della situazione, ma ha bisogno anche<br />
della passione, della fantasia, della speranza, dell’utopia. L’attesa e la volontà coesistono nella<br />
dimensione progettuale: c’è in essa sia lo sforzo e la tenacia sia il lasciarsi andare e l’affidarsi.<br />
Quanto più il desiderio si allontana dalla concretezza della situazione tanto più il progetto può<br />
configurarsi come sogno o come illusione o addirittura come delirio che non tiene conto della<br />
situazione.<br />
Quando “l’arido vero” leopardiano rivela l’impossibilità di realizzare il progetto, la tonalità emotiva si<br />
accom<strong>pag</strong>na a sentimenti di dis-illusione, di rassegnazione, o di ribellione. Quanto maggiore è<br />
stato l’investimento emotivo e fattivo, tanto più cocente è la delusione. La disperazione, infine,<br />
92
come perdita totale della speranza, chiude il progetto: nella disperazione il soggetto umano viene<br />
destituito dal suo stesso fondamento ontologico. La chiusura della temporalità sopprime la<br />
progettualità eliminandone la dimensione futura. La perdita di futuro è perdita dell’esistenza stessa.<br />
Progettarsi e progettare<br />
A conclusione, è opportuno segnalare la differenza tra il progettarsi e il progettare. La<br />
realizzazione di un progetto e la realizzazione di sé nell’esperienza progettuale assumono un<br />
rilievo esistenziale diverso poiché il progettarsi precede e comprende il progettare, orienta e<br />
direziona i progetti. Ogni “progetto di” è già compreso in quel progetto di sé, che dà vita alle<br />
scelte, ai sentimenti, alle decisioni. Lo scegliersi mantiene aperta la libertà e la direzione<br />
intenzionale del progetto di sé anche quando qualcun altro ha costruito per noi un progetto<br />
concepito al di fuori o al di sopra o contro di noi.<br />
Il progettarsi è ciò che riconduce all’esistenza, richiamandoci ad essa dalle dispersioni<br />
inautentiche, dall’essere costretti a progettare per timore o per desiderio opportunistico di<br />
ricompensa. Il progettarsi non è però un’attività che avvenga in una dimensione di isolamento, di<br />
egoismo, di fuga dalla realtà ma, al contrario, consente di orientarsi nelle situazioni di relazione<br />
con gli altri, nell’assunzione di responsabilità esistenziale e di libertà per la decisione di essere se<br />
stessi.<br />
La ripresa di sé, delle proprie potenzialità di scelta attraverso l’autoprogettazione, significa<br />
“scegliersi per la propria scelta”.<br />
Anche l’esperienza del proprio destino, nei suoi eventi ineluttabili della gettatezza quali la morte, la<br />
malattia, l’invecchiamento, il dolore, diventa suscettibile di progetto e di scelta. Il soggetto assume<br />
se stesso nella decisione che lo sottrae alla rassegnazione diventando libero per la situazione.<br />
Tutto ciò significa che anche il progetto concreto non è limitato, non si esaurisce nella<br />
realizzazione di un qualsiasi progetto preciso, essendo piuttosto un’istanza inesauribile che<br />
incessantemente si ricrea. Ciò comporta, per l’educazione, non ritenerla mai conclusa ma sempre<br />
“in atto”, aperta ad un futuro e ad un possibile che, nella dimensione utopica, conservi il senso<br />
reale della concretezza storico-sociale.<br />
Nella realtà quotidiana esterna, media e abituale, riceviamo continue sollecitazioni a negare il<br />
nostro progettarci per lasciare posto ai progetti inautentici entro cui dissolvere la nostra unicità per<br />
diventare nulla o nessuno.<br />
Progettarsi non riguarda la momentanea scelta, ma l’esperienza esistenziale della passione: il<br />
patire la fatticità e l’appassionante desiderio del “poter-essere”; progettarsi diventa norma<br />
regolatrice dell’esistenza tutta, dentro il “già scelto” della necessità.<br />
93
Corpo-cosa e corpo-Leib<br />
ESSERE UN CORPO<br />
Nella cultura fenomenologica è ravvisabile la possibilità di un modello diverso di razionalità<br />
pedagogica, finalmente aperto alle dimensioni etiche, affettive e soggettive della formazione. La<br />
fenomenologia rende possibile far valere una forma nuova di soggettivismo, più scaltrita e<br />
avveduta e quindi aprire un nuovo campo, anche se la perdita di valore teoretico riduce la<br />
soggettività a narrazione di vissuti individuali.<br />
Affinché il concetto di soggettività possa recuperare il suo valore teoretico, può essere utile<br />
riprendere in esame brevemente il campo semantico fenomenologico di alcuni concetti chiave che<br />
sottendono e sostengono la soggettività nella dimensione educativa.<br />
Gli slittamenti semantici dei termini “intenzionalità” e “progetto” mettono in evidenza una questione<br />
di fondo che da sempre accom<strong>pag</strong>na l’impostazione fenomenologica: il rischio, ove non ci si<br />
attenga al rigore tante volte richiamato da Husserl, di un uso della fenomenologia che,<br />
desemantizzando proprio i concetti chiave li banalizzi nell’uso logoro e quotidiano. La<br />
conseguenza di questa desemantizzazione è un inevitabile scivolamento verso dimensioni<br />
psicologicistiche, moralistiche, scarsamente scientifiche e persino estemporanee, che purtroppo<br />
hanno accom<strong>pag</strong>nato taluni epigoni della fenomenologia basati non di rado su una conoscenza<br />
indiretta e mediata delle opere di Husserl.<br />
Per tutti questi motivi, è importante dedicare qualche breve nota alla semantica fenomenologica<br />
della soggettività pedagogica.<br />
Corpo<br />
La riflessione sulla soggettività pone in questione, innanzitutto, la corporeità. Poiché la<br />
fenomenologia consente si riportare l’educazione alla vita, le esperienze, i vissuti, i sentimenti<br />
legati alla corporeità ci pongono in una relazione conoscitiva nuova e originale “del” e “nel”<br />
rapporto educativo. Il sé come soggettività propria, cioè come totalità vivente è corporeità. E<br />
proprio il concetto di corpo, tra quelli che sottendono la soggettività, è quello che ha subito un<br />
primo e maggiore deterioramento semantico.<br />
Molti ostacoli culturali e pregiudizi gravano sul concetto di corpo e si complicano in un inestricabile<br />
reticolato di rimandi alla biologia, alla psicologia, all’antropologia, alla sociologia, ecc. Non<br />
possiamo né vogliamo ignorarli, cercheremo di metterli sullo sfondo, per affrontare la questione<br />
della dignità originaria dell’essere corpo e del significato che ciò assume in ordine alla dimensione<br />
identitaria e progettuale nell’area del sapere pedagogico.<br />
Prima di ogni altra intuizione, ogni soggetto percepisce sé stesso esistente come corporeità. Come<br />
sottolinea Merleau-Ponty, “io non sono di fronte al mio corpo, ma sono nel mio corpo, o meglio,<br />
sono il mio corpo.”<br />
94
È molto diverso avere un corpo dall’essere un corpo: questa diversità comporta un rovesciamento<br />
radicale nel modo di intendere la soggettività come corporeità vissuta.<br />
Se ci muoviamo nella logica cartesiana della res extensa approdiamo inevitabilmente alle<br />
interpretazioni positiviste per cui il corpo è oggettivato come organismo naturalisticamente inteso o<br />
come macchina che può essere smontata, distrutta, guarita, manipolata, modellata ma anche<br />
violata, venduta, ridotta comunque al rango di cosa, privata della sua umanità.<br />
Se procediamo invece dall’esistenziale Daisen ci rendiamo conto che noi non abbiamo un corpo,<br />
ma siamo un corpo. Questa modalità di pensare il sé intende la corporeità come una delle<br />
dimensioni fondamentali del nostro essere al mondo.<br />
Il valore ed il rispetto del corpo richiamano il profondo significato pedagogica di ciò che implica e<br />
comporta essere un corpo, la fenomenologia, l’esistenzialismo e il personalismo ci indicano il<br />
valore della corporeità come una delle dimensioni fondamentali dello stesso essere al mondo della<br />
persona umana. Gabriel Marcel asserisce che “la categoria dell’avere non si addice in nessun<br />
modo alla corporeità”. Più volte ripete Binswanger che noi non abbiamo un corpo ma siamo un<br />
corpo.<br />
Ricordare questi significati della corporeità significa conservare la responsabilità, contro ogni<br />
possesso, appartenenza, e persino violazione e abuso.<br />
È evidente che una simile prospettiva educativa non riguarderà la sola educazione alla sessualità,<br />
ma s’inserirà in una prospettiva più generale, che comprende, ad esempio, la medicina, la bioetica<br />
e, in definitiva, l’intero nostro contesto socioculturale, dove assistiamo quotidianamente a una<br />
svalutazione del corpo come oggetto di divertimento o di sfruttamento o di violenze.<br />
La mancata riflessione, in pedagogia, sulla soggettività corporea sessuata ha inoltre comportato la<br />
mancata individuazione di strategie educative rispetto a ciò che significa crescere come soggetti<br />
sessuati nei percorsi formativi maschili e femminili. Per insegnare ai bambini e alle bambine,<br />
agli/alle adolescenti e agli adulti, il valore della propria specificità occorre aiutarli a crescere come<br />
soggetti maschili o femminili liberi di esprimere la propria unicità esistenziale, cercando di favorire il<br />
loro diventare se stessi, insegnando loro il difficile cammino di avere consistenza identitaria in<br />
quanto soggetto-corpo maschile o femminile.<br />
Possibilità<br />
Il corpo è dunque la prima effettività dell’esistenza, il primo radicamento nella datità della<br />
situazione umana, ma è al tempo stesso il primo luogo in cui si esprime la possibilità<br />
dell’esistenza. La possibilità non è mai da ritenersi disincarnata e estratta, poiché è sempre<br />
condizionata dalle modalità dell’essere quel corpo.<br />
Un fondamentale concetto fenomenologico che contribuisce a definire la soggettività in ambito<br />
educativo è quindi la possibilità: la soggettività è possibilità, è poter essere, poter essere<br />
“altrimenti” e “altrove” rispetto alla situazione data; è cioè la possibilità di trascendenza verso quel<br />
non ancora che caratterizza ogni cammino educativo.<br />
95
Heidegger, sviluppando le indicazioni della fenomenologia husserliana, rivolge la sua riflessione<br />
sul “chi” del soggetto stesso. In tale operazione la soggettività trascendentale husserliana è<br />
ricondotta all’esistenza umana concreta, ed è sviluppata da Heidegger come umano Esserci.<br />
Il soggetto umano, in quanto Da-isen, è sempre “là” (Da), nel mondo, ove di determina la<br />
situazione, che può essere trascesa attraverso il progetto. L’uomo si differenzia infatti dagli altri<br />
enti sulla base dell’esistenza: gli altri enti sono, mentre l’uomo esiste, si caratterizza per la<br />
possibilità di ex-sistere, cioè di uscire da, oltrepassare la situazione nella quale è gettato. E ciò che<br />
gli consente di trascendere la situazione è la possibilità.<br />
L’essere un corpo esistente significa quindi porsi nella dimensione della libertà per un progetto<br />
attraverso cui il sé-corpo, a partire dalla situazione di corpo biologico, assume il compito<br />
dell’esistenza. Qualunque progetto educativo si apre all’interno dell’effettività dell’essere corpo e<br />
può ignorarne i vincoli.<br />
Rispetto all’essere-gettato nella insuperabilità di un corpo-situazione, il soggetto umano esiste in<br />
quanto non si consegna alla propria biologicità corporea ma assume il corpo come il suo destino.<br />
La effettività ineliminabile, biologica, corporea, naturale è la situazione concreta e fattuale da cui<br />
procede il progetto. È da queste dimensioni che l’essere un corpo può porsi, sul piano<br />
psicopedagogico, nella dimensione della scelta per l’esistenza rispetto all’indifferenza, al<br />
disimpegno, alla rinuncia, all’abbandono.<br />
Alterità e interoggettività<br />
Il corpo-Leib incontra, nel suo vissuto d’esperienza, altri corpi con lui co-presenti nel medesimo<br />
mondo: ciò rende possibile quella comunicazione educativa senza la quale la soggettività<br />
resterebbe chiusa in un soggettivismo solipsistico.<br />
Se l’Esserci è sempre nel mondo con gli altri, il mondo stesso è la situazione della relazione con gli<br />
altri soggetti e con gli altri enti intramondani.<br />
L’in-essere è sempre anche un con-essere: non si è soli nella condizione di gettati, ma sempre con<br />
gli altri, e non si cresce da soli ma con gli altri che sono indispensabili al nostro cammino.<br />
Molte interpretazioni equivoche del linguaggio fenomenologico discendono da una fuorviante<br />
interpretazione dei concetti primi e fondamentali “soggetto” e “mondo” e della loro relazione<br />
intenzionale. La via intrapresa da Husserl per il recupero della soggettività non si limita a un<br />
comprendere o a un sentire di tipo intuizionistico-soggettivistico relegato nella incomunicabilità: egli<br />
ricollega soggetto e mondo in una relazione in cui nessuno dei due termini può essere compreso e<br />
avere un senso prescindendo dall’altro. Da questa relazione deriva un primo fondamentale<br />
elemento per la comprensione dell’evento educativo: l’intersoggettività. La comunicazione<br />
esperienziale tra soggetti è possibile sulla base dell’originaria struttura del mondo della vita<br />
accessibile universalmente, nel quale condivido con gli altri co-soggetti l’esistenza nello stesso<br />
mondo circostante comune. È evidente l’importanza pedagogica di una soggettività che, non<br />
potendo prescindere dall’intersoggettività, presuppone un’alterità che non assume i caratteri<br />
96
dell’estraneità contrapposta o addirittura ostile. L’evento educativo è innanzitutto evento<br />
relazionale che non può essere indagato al di fuori della complessità della relazione, poiché<br />
considerare il soggetto educatore e il soggetto educando singolarmente, al di fuori della<br />
intersoggettività educativa, significa sottrarli alla complessità che caratterizza invece e qualifica la<br />
relazione educativa. La formazione del singolo soggetto non può avvenire senza la relazione con<br />
l’alterità ed è questo incontro soggettività-alterità decisivo per l’ambito di sapere educativo.<br />
Cura<br />
Infine, il fondamentale ulteriore carattere della soggettività come intersoggettività è la Cura. In<br />
quanto essere nel mondo con gli altri, il soggetto è nella dimensione della Cura, intesa secondo le<br />
già citate indicazioni heideggeriane. Diversa è infatti la modalità attraverso cui il soggetto si rivolge<br />
alle cose o alle altre umane presenze: alle cose utilizzabili e alla mano si rapporta secondo la<br />
modalità del “prendersi cura incurante”, dell’indifferenza cosale verso gli oggetti, mentre il rapporto<br />
con gli altri dovrebbe avvenire secondo la modalità dell’aver cura di essi, dell’avere a cuore, sullo<br />
sfondo del mondo comune.<br />
L’avere un corpo richiama, come si è detto inizialmente, un possesso, e quindi la possibilità di<br />
commercio e uso, in un prendersi cura di sé secondo le modalità degli oggetti che mantiene il<br />
corpo al rango di cosa. L’essere un corpo implica invece una maggiore consapevolezza, un<br />
maggiore rispetto perché quel corpo è espressione della stessa persona umana esistenze a cui si<br />
addice l’aver cura.<br />
L’Esserci, nel suo essere nel mondo, si rivela innanzitutto come Cura: nella Cura trovano il loro<br />
fondamento i sentimenti, il desiderio, la tendenza, l’impulso.<br />
La Cura è una delle forme concrete dell’umana presenza, ripresa con particolare attenzione da<br />
Binswanger, che offre indicazioni molto importanti per la relazione educativa. Egli afferma che<br />
l’uomo si trova nel mondo nella condizione di “gettato” e che può trascendersi attraverso la scelta,<br />
secondo le modalità della cura e dell’amore.<br />
L’interpretazione biswangeriana del concetto di Cura indica un superamento della<br />
singolarità/solitudine del soggetto verso una dimensione duale/relazionale.<br />
È, infine, questa la dimensione della soggettività che maggiormente riguarda l’ambito educativo.<br />
Qualora ci si affidi al tecnicismo non ci si pone in una dimensione di “cura”. Ci si mantiene invece<br />
“accanto” agli altri, in quel “prendersi cura incurante” che riduce gli altri soggetti e sé stessi al<br />
rango di cose “semplicemente presenti” con le quali ci si rapporta secondo le modalità della<br />
“presa”, dell’aggressività, delle strumentalizzazioni e del commercio.<br />
La Cura è l’elemento che trasforma l’essere l’uno accanto all’altro in un essere-assieme<br />
nell’incontro, rendendo possibile la relazione tra i soggetti e l’autentica relazione educativa.<br />
97
Il corpo in movimento: preadolescenza e adolescenza<br />
La preadolescenza e l’adolescenza sono nodi critici nell’età evolutiva, passaggi cui concorrono<br />
fattori di ordine biologico, psicologico, antropologico, sociale e pedagogico. Sebbene non sia<br />
ancora consolidata una decisiva attenzione pedagogico-educativa, soprattutto verso la prima<br />
transizione tra l’infanzia e l’adolescenza, è necessario rilevare che si tratta di un momento<br />
fondamentale, che comporta caratteristiche e problemi specifici, determinati per la successiva vita<br />
adolescenziale e giovanile, oltre che per l’età adulta.<br />
Nel periodo puberale il corpo cambia in modo quasi improvviso e irreversibile; cambiano anche i<br />
processi intellettivi e si trasformano i rapporti con il mondo degli adulti e con i com<strong>pag</strong>ni.<br />
I legami con i genitori divengono più variegati e talvolta conflittuali; la famiglia resta fondamentale,<br />
ma al tempo stesso inizia a manifestarsi quel bisogno crescente di autonomia e di spazi propri che<br />
accom<strong>pag</strong>na il passaggio dall’identificazione all’identità. Le precedenti modalità relazionali sono<br />
percepite come superate e infantili. I preadolescenti cercano nuovi atteggiamenti e forme di<br />
comunicazione, rispecchiando i loro cambiamenti nelle nuove aspettative da parte degli adulti.<br />
Oltre al contesto socio-ambientale e familiare, anche i mass media, le mode, i prodotti di consumo<br />
destinati precisamente a tale età influiscono in vario modo sul linguaggio, l’abbigliamento, gli<br />
interessi, gli atteggiamenti.<br />
L’adolescenza è un momento dello sviluppo che si differenzia dalla preadolescenza sia sul piano<br />
della soggettività sia su quello relazionale. È un’età di esplosione vitale, di scoperta e di meraviglia,<br />
di capacità di stupirsi della bellezza, dell’amore, età degli interrogativi di fronte al dolore e alla<br />
morte, età della sete di esperienze, degli interrogativi sul corpo proprio e sulle relazioni. Se, come<br />
è indicato da più studiosi, questa è un’età dalla quale si attingono le esperienze più significative<br />
per le altre stagioni dell’esistenza, è soprattutto sul versante della vita affettiva e sessuale che le<br />
esperienze adolescenziali si rivelano decisive.<br />
Il tratto distintivo della preadolescenza è il processo d’individuazione di sé, laddove l’adolescenza<br />
è contraddistinta dai processi di costruzione dell’identità. Questo passaggio dall’identificazione<br />
all’identità si sviluppa attraverso una progressiva autonomia dai genitori e una crescente<br />
assegnazione d’importanza all’amicizia dei coetanei e alla vita di gruppo.<br />
L’adolescenza costituisce il tempo dell’esistenza dove più intensamente è vissuto il bisogno di<br />
conoscere e strutturare la propria immagine di sé, nel confronto con il patrimonio ideale e<br />
comportamentale ricevuto e nella contraddizione tra il bisogno di aderire alle norme della vita<br />
sociale e la tendenza opposta ad infrangerle.<br />
In particolare la progettazione esistenziale e la scelta degli orientamenti vocazionali e professionali<br />
iniziano a delinearsi in modo più definitivo. Tali percorsi di scelta sono fortemente legati<br />
all’esperienza scolastica e sociale e all’influsso degli ideali etici, politici e religiosi dell’ambiente di<br />
provenienza.<br />
98
Cambiamenti alquanto significativi tra la preadolescenza e l’adolescenza riguardano la dimensione<br />
affettivo-sessuale. Nella preadolescenza le modificazioni di carattere biologico e psicologico<br />
portano alla scoperta dell’alterità sessuale in modo ancora confuso e stupito, spesso segreto.<br />
Nell’adolescenza l’interesse per l’altro sesso si fa più importante e non riguarda più soltanto<br />
esperienze di infatuazione non comunicate, ma esperienze di innamoramento che si traducono in<br />
legami e relazioni. L’apertura di sé all’altro diventa emotivamente intensa, contrassegnata<br />
dall’oscillazione tra l’idealizzazione e l’erotizzazione, dell’oggetto del desiderio, quindi tra<br />
l’inclinazione a coltivare gli ideali prescelti e la spinta al soddisfacimento degli impulsi.<br />
Educazione alla sessualità e suo significato per l’esistenza<br />
In queste fasi dello sviluppo riveste un ruolo particolarmente rilevante l’educazione sessuale,<br />
poiché le metamorfosi bio-fisiologiche e psicologiche avvengono in modo assai più repentino che<br />
in ogni altra età, incidendo profondamente sul vissuto della corporeità, sulla formazione<br />
dell’identità e della differenziazione sessuale, sulle relazioni con i soggetti appartenenti all’altro<br />
sesso.<br />
I miti di perdita e di caduta legati alla sessualità testimoniano che si tratta, fin dalle origini della<br />
civiltà, di un’esperienza che attrae e spaventa gli esseri umani per gli elementi insondabili e<br />
inverificabili che la avvicinano per taluni versi all’esperienza della dissoluzione dell’io. Questo<br />
campo ineluttabile dell’esistenza è contraddistinto da forte ambivalenza tra le emozioni delle<br />
pulsioni e la loro repressione, la sublimazione, la razionalizzazione, la regolazione. Oggi, in tanto<br />
diffuso erotismo proprio della nostra civiltà, la sessualità rimane in larga misura misteriosa. Eppure<br />
essa è un’esperienza attraverso la quale ciascuno può conoscere qualcosa di sé, e al tempo<br />
stesso, qualcosa dell’alterità.<br />
Ogni soggetto mette in gioco, nell’esperienza sessuale, la propria identità; ma è anche l’intera<br />
società che, attraverso la rappresentazione dell’immaginario e le regole di comportamento, mette<br />
in gioco la sua struttura e la sua organizzazione.<br />
Oggi l’inizio biologico della pubertà si presenta sempre più precoce e diviene più incerta la<br />
delimitazione cronologica di tale età; ragazzi e ragazze possono riscontrare esperienze analoghe<br />
in coetanei appartenenti allo stesso sesso, ma possono anche trovarsi soli a vivere “anticipazioni”<br />
o “ritardi” rilevanti sul piano delle trasformazioni biologiche e psicologiche, poiché non esiste<br />
coincidenza tra i segnali esterni, sociali, di passaggio e i momenti diversificati del passaggio<br />
individuale verso l’adolescenza.<br />
Timidezze, conflitti, imbarazzi, vergogne, turbamenti che accom<strong>pag</strong>nano le metamorfosi bio-<br />
psicologiche e relazionali non sempre sono percepiti dagli adulti. Non sfuggono invece instabilità<br />
emotiva, prime ribellioni, mutevolezza di comportamenti. I genitori, frequentemente, di fronte a<br />
questi cambiamenti si sentono impreparati o inadeguati o addirittura colpevoli, scarsamente<br />
provvisti di strumenti educativi idonei alla situazione. Talvolta i nuovi comportamenti dei figli sono<br />
99
interpretati attraverso stereotipi correnti, senza interagire veramente con ciò che ogni ragazzo vive,<br />
esprime o intende comunicare, poiché è difficile parlare di sentimenti e sessualità in famiglia.<br />
Il ruolo educativo degli adulti è determinante, in quanto può favorire il processo evolutivo,<br />
l’autoconoscenza e l’autoaccettazione oppure ostacolare il processo equilibrato di costruzione di<br />
sé. Occorre che genitori, insegnanti, educatori sappiano favorire la serenità della transizione<br />
adolescenziale stando accanto ai ragazzi e alle ragazze, che aderiscano gioiosamente alla loro<br />
personalità sessuata, ne accettino di buon grado i ritmi; vi si conformino con sempre maggiore<br />
convincimento, pur nelle manifestazioni conturbanti di norma destinate a scomparire.<br />
È altresì importante che genitori e educatori siano sostenuti nello sforzo di prosecuzione del<br />
dialogo educativo attraverso momenti guidati di formazione e occasioni di confronto esperienziale<br />
che dovrebbero essere attivare dalla scuola, dalle istituzioni locali, dalla chiesa: formazione dei<br />
docenti, scuole per genitori, gruppi di auto-mutuo aiuto tra genitori,<br />
informare o educare? È questo un nodo preliminare. Il significato di educazione della persona<br />
sessuata in una prospettiva di senso per l’esistenza umana, non può ignorare la questione, più<br />
volte dibattuta, di ciò che significhi educazione alla sessualità, dove e come si differenzi<br />
dall’informazione e quali siano gli educatori più idonei a tale compito.<br />
Innanzitutto va ribadito che la sola informazione non è sufficiente per educare alla sessualità.<br />
Inoltre occorre sottolineare, a fronte di una pretesa scientificità a-valutativa, che non esiste una<br />
neutralità dell’informazione; la selezione degli argomenti e il modo di presentarli contiene sempre,<br />
esplicitamente o implicitamente, una valenza educativa, anche non intenzionale: la trattazione di<br />
particolari problemi risente, per via diretta o indiretta, dell’opzione assiologica del ricercatore.<br />
Infine, se non si assume una prospettiva educativa consapevole che provveda di senso le singole<br />
informazioni, queste si affastellano senza trovare un significato per l’esistenza dei soggetti.<br />
Naturalmente non si vuole negare il valore dell’informazione, che è assolutamente indispensabile,<br />
ma occorre guardarsi dal rischio di biologizzare l’argomento o dal ridurlo ad una serie di questioni<br />
meramente tecniche sulla fisiologia dell’accoppiamento e della riproduzione, oppure a norme<br />
igienico-sanitarie su come praticare il cosiddetto “sesso sicuro”.<br />
È, quest’ultimo, il solo aspetto a cui famiglie e adulti spesso riducono la loro azione informativa,<br />
ritenendo così di assolvere anche la funzione educativa. Né va dimenticato che, anche in contesti<br />
scolastici, si parla generalmente di educazione sessuale prescindendo sia dall’educazione ai<br />
sentimenti sia dall’educazione etica, asserendo che questi aspetti privati siano da rimandare a<br />
scelte private; per la scuola sembra cioè più scientifico perseguire un’educazione oggettiva e<br />
oggettivante che estrometta quanto di soggettivo sia significativo per l’esistenza.<br />
In particolare l’educazione all’amore che si accom<strong>pag</strong>na alla sessualità è oggi resa ancora più<br />
complicata dalla banalizzazione inautentica di tale sentimento, dal proliferare di modelli<br />
consumistici o erotici del sesso, alimentati dai mass media e da certa pubblicità, dalla facilità con<br />
100
cui i preadolescenti possono procurarsi materiale pornografico, dalla carenza di educatori attenti e<br />
preparati, dal confronto con com<strong>pag</strong>ni disinformati e privi di qualsiasi orientamento valoriale.<br />
Un’autentica educazione sessuale dovrebbe informare educando, ossia fornire informazioni chiare<br />
ed esaurienti, ma anche organizzarle nell’orizzonte di una altrettanto chiara progettualità educativa<br />
cui ispirare i contenuti ed i modi dell’informazione. Quest’ultima non può mai prescindere da una<br />
più generale prospettiva etico-valoriale che deve orientare le modalità d’impostazione delle stesse<br />
nozioni offerte fin qui dai primi anni di vita; né si può scindere sessualità e affettività, neppure nelle<br />
descrizioni più scientifiche.<br />
Le modificazioni legate alla maturazione biologica implicano trasformazioni sul piano psicologico,<br />
nuove pulsioni e una nuova attrazione verso l’altro sesso che necessitano di interventi<br />
educativamente orientati: altro è, infatti, assecondare gli impulsi, altro è reprimerli, altro ancora è<br />
orientarli secondo in una dimensione di consapevolezza di sé e di rispetto del corpo proprio ed<br />
altrui. Questo richiede ai preadolescenti e adolescenti le prime scelte ed un primo impegno<br />
nell’assunzione di responsabilità verso il corpo- persona; tale responsabilità è la premessa per i<br />
vissuti e i comportamenti sessuali della maturità.<br />
Libertà e responsabilità<br />
Vivere con serenità il proprio corpo nelle delicate fasi della preadolescenza e dell’adolescenza è la<br />
premessa per costruire un autentico progetto di sé nella libertà. La vera libertà sessuale non è<br />
infatti da identificare con una malintesa possibilità di concedersi ogni tipo di esperienza; al<br />
contrario, essa si manifesta dove vi è rispetto per il corpo e possibilità di opzione.<br />
La libertà per costruire il proprio progetto nasce nell’assunzione di consapevolezza e<br />
discernimento a partire dal proprio corpo esistente, nella pienezza del termine: ex-sistere indica il<br />
movimento della decisione per trascendere la situazione di corpo biologico e assumerne la<br />
responsabilità. Poiché ogni preadolescente e adolescente ha generalmente un rapporto non facile<br />
con il corpo che si trasforma, si trova in una situazione di grande difficoltà, a causa di tutti i<br />
condizionamenti culturali che intervengono nei suoi processi formativi, rispetto alla possibilità di<br />
esprimere una libertà autenticamente intesa.<br />
Un adeguato intervento educativo può insegnare che la persona e-siste in quanto non si consegna<br />
alla mera biologicità o all’insignificanza, ma, assumendo i mutamenti biologici come punto di<br />
partenza, sa decidersi per compiere le sue scelte. L'educazione sessuale è allora educazione alla<br />
scelta e all’impegno contro il torpore morale, o l’abbandono all’inautenticità eterodiretta.<br />
Quando la prima esperienza di innamoramento irrompe, spesso in modi inaspettati, nella vita degli<br />
adolescenti, coinvolge, nelle nuove emozioni del rapporto con l’altro, anche la famiglia che non può<br />
porsi in un atteggiamento di passiva rassegnazione o di ironia verso i sentimenti dei figli, ma deve<br />
cogliere la ricchezza e le potenzialità educative che derivano da questa esperienza.<br />
L’innamoramento richiede, più che mai, ai genitori di porsi come guida e punto di riferimento per<br />
l’educazione affettivo-sessuale dei figli.<br />
101
Mancano talora le occasioni per parlare, poiché agli adulti manca spesso il tempo di ascoltare.<br />
Attendere i tempi degli adolescenti e saperli ascoltare è invece loro di aiuto per costruire un’idea<br />
positiva di sé.<br />
Purtroppo oggi l’azione dei media, e si certa TV in particolare, rendono più ardua una reale<br />
educazione sessuale: la deresponsabilizzazione, la volgarità dei sentimenti, lo svilimento della<br />
sessualità a solo possesso rende gli adolescenti particolarmente vulnerabili sul piano della<br />
costruzione della propria identità maschile e femminile e del rapporto amoroso.<br />
Il mito della bellezza condizione fortemente le adolescenti, generando ansie di inadeguatezza ai<br />
modelli imposti di corpi avvenenti, di nudità esibite. Si tratta di ansie non estranee ai fenomeni, in<br />
aumento, della bulimia e dell’anoressia. Come è noto questi disturbi alimentari si manifestano<br />
soprattutto nelle ragazze in età adolescenziale, o nel passaggio dall’adolescenza alla giovinezza, e<br />
nascono da difficoltà relazionali. Ed è proprio agendo sulla capacità di instaurare nuovi modelli<br />
relazionali nella vita di gruppo che è possibile favorire la costruzione di una nuova immagine di sé<br />
e recuperare nuove modalità di rapporto con il proprio corpo. Mangiare troppo per compensare un<br />
vissuto di mancanza di affetto o mangiare troppo poco per esprimere una richiesta di attenzione: in<br />
ogni caso si manifesta una situazione che ha a che vedere con un bisogno di calore, di nutrimento,<br />
di amore, e soprattutto di attenzione.<br />
In questo disagio dai contorni ambigui e sfuggenti, quale l’anoressia, è innegabile il ruolo della<br />
attuale distorta cultura del corpo. Quei corpi scarnificati, risultanti dall’anoressia, sono il risultato di<br />
una contorta catena di meccanismi psicologici che partono dall’immagine ideale di un corpo<br />
snellissimo fino ai limiti dell’evanescenza incorporea.<br />
Ellen West, dice Binswanger, esprimeva nella sua anoressia il desiderio di essere invisibile nella<br />
sua corporeità, impenetrabile agli sguardi altrui. Questa immagine incorporea contraddistingue, da<br />
un lato, una fragilità che rifiuta ogni compimento di maturazione psicosessuale, dall’altro, l’idea di<br />
bellezza femminile oggi resa ancora più complicata dal proliferare dei modelli consumistici del<br />
sesso, o dalla visione estetizzante che, in modo implicito o esplicito, avverte che per essere<br />
accettati occorre essere belli, snelli, seducenti.<br />
Molti educatori si trovano oggi impreparati di fronte alle esigenze abbastanza nuove<br />
dell’educazione sessuale nella delicata fase dell’adolescenza e alla necessità di operare interventi<br />
di contrasto e decondizionamento rispetto ai messaggi della cultura dominante. In tal senso sono<br />
da considerare interventi di educazione sessuale anche quelli volti a facilitare ragazzi e ragazze<br />
nella possibilità di elaborare progetti di vita, di dedicarsi ad attività di gruppo, di sviluppare<br />
l’impegno sociale, di mantenersi nell’apertura al mondo e agli altri.<br />
Il senso del limite<br />
L’accettazione serena del proprio divenire corporeo, psicologico, relazionale produce educazione<br />
al cambiamento, aiuta i preadolescenti e adolescenti a cogliere la loro esperienza di evoluzione<br />
come necessario momento di ingresso nell’età adulta. Educare al cambiamento significa<br />
102
iconoscere la positività di essere un corpo in cambiamento. È certamente complicata la questione<br />
del rapporto tra le pulsioni di un corpo sottoposto a mutamenti marcatamente visibili e rispecchiati<br />
negli altri e la capacità di iniziare a costruire un progetto di vita comprensivo della propria<br />
corporeità. Questa fase in cui i ragazzi si trovano in balia dei primi e più marcati sconvolgimenti<br />
bio-psicologici della loro vita, può, opportunamente accom<strong>pag</strong>nata, renderli consapevoli che il<br />
cambiamento fa parte dell’esistenza umana e che non sempre siamo noi a governarlo, ma che<br />
siamo invece noi, in quanto persone, a decidere che cosa fare di fronte ai cambiamenti: se<br />
assumere la responsabilità di noi stessi o affidarci alle mode; se lasciarci cadere al livello di corpo-<br />
cosa o, pur nella consapevolezza del limite, sceglierci per la libertà.<br />
Molte esperienze possono favorire la libera espressione del proprio corpo e la sua conoscenza: lo<br />
sport, il gioco, la danza e tutte quelle attività che aiutano i ragazzi, e ancor più le ragazze, a<br />
cogliere la propria corporeità in modo gioioso e vitale. I cambiamenti vanno perciò assecondati con<br />
l’attenzione, l’amore e l’equilibrio degli educatori che, senza sottovalutare gli sconvolgimenti in atto<br />
nei ragazzi, indichino loro anche i modelli e valori alternativi a quelli dominanti.<br />
Il modello dominante si fonda sull’assenza di norma, su una pretesa libertà di comportamenti che<br />
insinua nei giovani l’idea che tutto possa essere lecito e che ogni regola o norma morale sia da<br />
considerare lesiva della loro autodeterminazione. Non si può ignorare che il distorto uso della<br />
libertà finisce per considerare l’altro un possesso, da impiegare per il soddisfacimento dei propri<br />
istinti. È forse superfluo aggiungere che norme e regole non vanno intese i senso puramente<br />
formale, esteriore, impositivo, ma devono essere oggetto di dialogo, di confronto, di dissenso, per<br />
produrre capacità di giudizio e di autonomia nelle scelte.<br />
La libertà è un bene fragile che va perseguito ogni giorno, secondo Edith Stein, “spetta soltanto<br />
alla persona come soggetto dotato di volontà, è immanente alle sue attività, ma non è una qualità<br />
perdurante”. Sottolinea inoltre Jaspers che nella decisione “sperimento quella libertà in cui non<br />
decido solamente su qualcosa, ma anche decido su me stesso, e in cui non è più possibile una<br />
separazione tra la scelta e l’io, chè io stesso sono la libertà di questa scelta. La libertà è scelta di<br />
me stesso.”<br />
In tal senso l’educazione sessuale, passando attraverso l’esperienza della volontà e della scelta,<br />
contribuisce ad uno stile di comportamento rispettoso di sé e degli altri. Dove la libertà coincide<br />
con la possibilità di accedere ad ogni tipo di esperienza non solo si perde la reale possibilità di<br />
scelta, di rispetto, di discernimento, ma paradossalmente si perde la possibilità di trasgressione,<br />
poiché, eliminata ogni norma, cosa trasgredire?<br />
Si cancellano così la vergogna, il pudore, la libertà di giudizio e di opzione, il senso di colpa per<br />
avere travalicato il margine.<br />
Non si può pensare che l’assenza di regole possa coincidere con una possibilità di esprimere una<br />
presunta ingenuità originaria, poiché la nudità degli schemi e dei rotocalchi, alle quali siamo<br />
quotidianamente abituati, non sono nudità ingenue dei corpi rappresentati nella loro naturalità,<br />
103
ensì sono nudità es-poste, messe in scena e perciò letteralmente “o-scene”: il corpo è ancora più<br />
nudo quando è ridotto a oggetto dello sguardo altrui, abbigliato secondo il cerimoniale erotico. Non<br />
è la nudità ad essere oscena, ma la nudità esposta senza pudore e vergogna.<br />
Il sentimento del pudore, come insegna Max Scheler, può essere inteso come un ritorno su sé<br />
stessi, una consapevolezza di sé, laddove l’assenza di pudore corrisponde ad una oggettivazione<br />
di sé.<br />
Pudore e vergogna appaiono oggi sentimenti fuori moda, considerati superati in una cultura che, al<br />
contrario, incentiva atteggiamenti ostentatamente disinibiti ed usa il corpo per suscitare il desiderio.<br />
Poiché gli adolescenti imparano dalla morale corrente che è legittimo, se non addirittura<br />
auspicabile, avere una precoce pluralità di esperienze sessuali o affettive con partner diversi,<br />
anche le richieste ai servizi sanitari riguardano prevalentemente la contraccezione o la<br />
prevenzione delle malattie veneree; meno frequentemente le richieste riguardano il mistero delle<br />
emozioni e dei sentimenti che sembrano essere celati sotto una maggiore riservatezza e taciuti per<br />
una mancanza di alfabeto.<br />
La principale agenzia di educazione sessuale finisce così per essere costituita dai mass media che<br />
forniscono messaggi improntati alla enfatizzazione di tutte le manifestazioni della sessualità, senza<br />
responsabilità e senza che venga assegnato alcun limite: il soddisfacimento sessuale è correlato al<br />
benessere economico e al culto del corpo.<br />
L’educazione al senso del limite si costruisce dunque individuando nella sacralità della persona<br />
umana il sommo valore. Questo è il principio che informa di sé tutte le regole che riguardano i<br />
comportamenti sessuali e le modalità per affrontare le specifiche singole questioni. Ispirata a<br />
questi principi la sessualità può esprimersi nell’amore e produrre atteggiamenti positivi verso sé<br />
stessi e verso gli altri. Senza una chiara consapevolezza di questo principio, saranno sempre in<br />
agguato le forme di violenza che in diverso modo si possono accom<strong>pag</strong>nare alle esperienze<br />
sessuali. La mancanza di norme etiche nel comportamento sessuale accresce i rischi di violenza<br />
psicologica, prima ancora che fisica, soprattutto nei confronti delle ragazze e rende sempre più<br />
ardue le sfide che esse devono affrontare per difendere la dignità del proprio corpo.<br />
Corpo e differenza di genere<br />
Si è più volte sottolineata l’importanza della differenza di genere in relazione alle diverse tematiche<br />
affrontate, può quindi essere utile approfondire tale questione, decisiva in materia di corporeità<br />
vissuta. La preadolescenza e l’adolescenza sono momenti di grande interesse, sotto il profilo<br />
psicologico e pedagogico, per la formazione dell’identità sessuata. Il processo bio-psicologico<br />
dell’appartenenza al proprio genere e della differenziazione dell’altro inizia certamente molto<br />
prima, ma ogni preadolescente è alle prese per la prima volta in modo ineludibile con la propria<br />
identità sessuata.<br />
104
L’identità non soltanto costituisce uno specifico momento di arrivo in cui si acquisiscono strumenti<br />
e capacità di scelte più consapevoli e più ampie, ma è anche un processo che si costruisce per<br />
tutto l’arco della vita, un continuum che coinvolge tutte le deliberazioni consapevolmente effettuate.<br />
L’identità, vista come cammino, costruzione, fenomeno processuale e dinamico, è espressione di<br />
un sé in continua evoluzione, giacché il nostro dire “io sono” è sempre un momento di questo<br />
processo che si alimenta nel confronto con gli altri. Le teorizzazioni pedagogiche sull’educazione<br />
sessuale non possono essere correttamente sviluppate, procedendo dalla dimensione sessuale,<br />
come momento a sé, circoscritto rispetto all’esperienza formativa globale, al divenire del soggetto.<br />
L’identità personale non può prescindere dall’essere sessuata. Nell’adolescenza si manifesta un<br />
punto focale di questa ricerca di uguaglianza e di differenza attraverso il passaggio<br />
dall’identificazione all’individuazione. Bambini e bambine iniziano la loro costruzione identitaria<br />
sessuata, identificandosi dapprima con i genitori, i fratelli e le sorelle maggiori, gli amici e le<br />
amiche: nel cambiamento accelerato di questa particolare età, passaggi, gli incontri, le esperienze<br />
ravvisano nuovi modelli da ammirare o idealizzare. A questi modelli si ispira la definizione<br />
dell’immagine di sé e la propria individuazione in relazione ai modi e alle funzioni della propria<br />
individuazione in relazione ai modi e alle funzioni della propria appartenenza al maschile e al<br />
femminile. L’identità si costruisce attraverso un continuo processo di rimandi tra “l’essere uguale a”<br />
e “l’essere diverso da” e si configura come un’autobiografia poiché inerisce i concetti di processo,<br />
differenziazione, movimento, relazione, aprendo alla consapevolezza di poter essere se stessi in<br />
rapporto all’altro da sé.<br />
Se l’identità personale è in cammino o un’autobiografia, anche l’identità sessuata lo è, dal<br />
momento che il processo attraverso cui si diventa maschi o femmine è legato alla progressiva<br />
stratificazione culturale di messaggi ed impulsi, di obblighi e divieti che si sovrappongono alla<br />
iniziale differenza morfologica dell’infanzia.<br />
L’essere maschi o femmine produce una serie di comportamenti, atteggiamenti, messaggi e<br />
modalità educative differenti che tendono a rafforzare l’identità sessuata. Il senso di unità e totalità<br />
della persona umana, nel suo divenire, comprende l’interazione di più fattori: sensazioni che<br />
derivano dal proprio essere un corpo, messaggi e aspettative familiari e sociali, assunzioni e<br />
attribuzioni di competenze e di abilità legate al genere.<br />
Le esperienze formative sono infatti da considerare momenti dell’educazione sessuata, poiché<br />
nessuna di queste avviene nella neutralità.<br />
Quanto, nei processi di identificazione, sia determinato dalla natura o dalla cultura è questione<br />
complicata: molteplici elementi, attraverso modalità che variano da soggetto a soggetto e da<br />
contesto a contesto, intrecciano la complessa realtà dell’evoluzione bio-psicologica con il<br />
patrimonio valoriale e comportamentale trasmesso.<br />
105
Identità e differenza di genere<br />
Per educare alla consapevolezza dell’identità e della differenza è opportuno produrre interventi di<br />
educazione sessuale rispettosi della soggettività maschile e femminile. Perseguire modelli<br />
educativi “sessuati”, non indifferenti ai generi, consente si ravvisare nella dualità elementi e valori<br />
differenti e complementari. Si tratta di un compito non facile per la difficoltà stessa di pensare la<br />
differenza e di individuare in essa un’importante categoria formativa. Il valore della differenza,<br />
afferma Heidegger, è ciò che il pensiero occidentale ha da pensare. Questa difficoltà di pensare il<br />
“due” affonda le sue radici nel principio aristotelico di identità e non contraddizione. (A è A e B è il<br />
non A). in tale prospettiva ogni differenza è condizionata da una connotazione svalutativa e<br />
negativa rispetto all’Uno che si pone come norma; pertanto il Due, il B, è il negativo di A..<br />
Concettualizzare la dualità è un passaggio necessario per poter assumere la propria parzialità<br />
rispetto all’altro/differente e per incontrarlo in una posizione di autentica reciprocità. Un universo<br />
concettuale improntato ad una presunta neutralità ha condizionato in passato la costruzione<br />
dell’identità, contribuendo al predominio degli stereotipi sessisti. Dalla differenza della morfologia<br />
genitale alla nascita ha inizio quel processo autobiografico che ci fa diventare maschi o femmine.<br />
Tale processo trova una sua “apicalità” nella preadolescenza-adolescenza, quando la differenza<br />
somatica tra il corpo femminile e quello maschile si fa più marcata e si inizia a diventare<br />
consapevoli del proprio appartenente al maschile o al femminile, anche sul piano psicologico, nella<br />
percezione di sé, nelle proprie decisioni, nei propri progetti. Diventare adolescenti nella differenza,<br />
ma non nella separatezza o nella contrapposizione, vuol dire crescere come soggetti maschili o<br />
femminili, liberi di esprimere la propria unità e unicità esistenziale nella reciprocità con l’esistenza<br />
degli altri.<br />
Il percorso della differenza di genere è educativamente articolato: non bastano competenze o<br />
nozioni di immediata applicabilità in famiglia o a scuola, ma è necessario attivare e liberare le<br />
potenzialità maschili e femminili, attraverso interventi e parole di donne e uomini educatori,<br />
provvisti di un’autorevolezza legata alla propria specificità maschile o femminile. Siamo purtroppo<br />
ancora lontani dalla piena attuazione di questa prospettiva, poiché gli stereotipi costituiscono<br />
ancora una solida impalcatura di norme e divieti.<br />
Educatori, insegnanti, e soprattutto genitori non sempre hanno essi stessi problematizzato la<br />
consapevolezza della propria identità sessuata e delle proprie modalità di vivere l’appartenenza al<br />
maschile o al femminile. Emerge, al riguardo, un bisogno formativo di educatori e educatrici che,<br />
individuando momenti di riflessione e di consapevolezza rispetto a ciò che rappresenta la<br />
costruzione dell’identità sessuata, sappiano incarnare, avvalorare, esprimere la propria<br />
“sessuazione”, senza occultarla. Gli educatori, oltre alla cautela richiesta dalla delicatezza<br />
dell’argomento e dalla particolare età dei soggetti a cui si rivolgono, dovrebbero porsi anche in<br />
posizione di umiltà e autointerrogazione nella loro dimensione di uomini e donne, per<br />
106
problematizzare, selezionare, eventualmente contrastare la trasmissione di comportamenti e i<br />
valori assegnati al sesso di appartenenza dalla cultura dominante.<br />
Il maschile e il femminile<br />
Nell’educazione all’identità sessuata sono chiamati in causa elementi che rimandano alla storia,<br />
all’organizzazione sociale, culturale e religiosa. La dicotomia maschile/femminile è un archetipo<br />
potentissimo che ha presieduto a moltissime costruzioni mitologiche e ha originato numerose altre<br />
antinomie: esterno/interno, pubblico/privato, esplorazione/intimità, forza/debolezza,<br />
libertà/sottomissione, ragione/sentimento. Questo archetipi influiscono profondamente<br />
nell’individuazione e nell’assunzione di alcuni tratti fondamentali assegnati al proprio genere.<br />
Si deve inoltre segnalare che il processo di identità sessuata avviene in termini di maggiore facilità<br />
per le femmine che per i maschi: le ragazze non esperiscono infatti la difficoltà della “frattura” con<br />
la madre nella costruzione dell’identità sessuata.<br />
La femmina ha nella madre il modello identificatorio, mentre il maschio deve sperimentare una<br />
difficile ma indispensabile separazione da lei, per individuarsi nel maschile: la lacerazione è resa<br />
inoltre, per i maschi, più difficoltosa dal fatto che i caratteri sessuali secondari maschili sono meno<br />
marcati e definiti di quanto lo sia la comparsa del menarca nelle femmine, e producono nei ragazzi<br />
maggiori ansie sulla propria virilità. Non a caso i maschi impiegano frequentemente il termine<br />
“femminuccia” per stigmatizzare debolezza o mancanza di coraggio o comportamenti<br />
dispregiativamente attribuiti al genere femminile, da cui si stanno differenziando. Mantenere legami<br />
con il materno-femminile nella costruenda identità è rimarcato come una minaccia per il maschile.<br />
Del tutto infrequente è invece la corrispondente accusa di “maschiaccio” tra le preadolescenti,<br />
poiché la loro identificazione sessuale manifesta un minore bisogno si rinforzi e conferme.<br />
Questo diverso passaggio sarebbe all’origine di un bisogno maggiore nei maschi che nelle<br />
femmine di confermare la propria identità sessuata attraverso elementi esterni quali le prove di<br />
forza, di coraggio, di velocità, di intelligenza, ecc. e di incrementare maggiormente l’identità<br />
sociale. In altri termini, mentre le femmine trovano nel proprio corpo chiari segnali del passaggio<br />
dall’infanzia all’adolescenza, i maschi, non avendo nel loro corpo segnali altrettanto marcati,<br />
cercherebbero di rafforzare la loro identità di genere attraverso il riconoscimento pubblico del<br />
dominio, del potere sociale, della competitività.<br />
Le diverse modalità di sviluppo dell’identità nei maschi e nelle femmine mostrano differenze<br />
nell’atteggiamento del corpo, nell’abbigliamento, nelle letture, negli argomenti di conversazione,<br />
ecc. Non sempre purtroppo i modelli della famiglia e della scuola sono in grado di fornire<br />
alternative educative alle immagini stereotipate dei media che condizionano queste scelte. Ed è<br />
arduo contrastare messaggi che quotidianamente presentano il corpo femminile principalmente<br />
come strumento di seduzione e di desiderio, riconducendo le ragazze all’idea implicita che la<br />
bellezza sia più importante dell’intelligenza.<br />
107
Fa quindi parte dell’educazione alla differenza di genere insegnare alle ragazze che anch’esse<br />
possono essere forti. In tal senso è davvero decisiva l’azione della famiglia, della scuola e la<br />
relazione educativa con donne autorevoli che possano costituire modelli significativi.<br />
Analogamente i maschi possono imparare da educatori autorevoli a contrastare gli stereotipi che<br />
vengono loro proposti in quanto maschi, imparando che si può essere ugualmente virili senza<br />
ricercare l’avventura nell’alcool, nel sesso, senza uniformarsi al modello convenzionale della “ratio”<br />
o della forza fisica.<br />
Un’utile esperienza educativa può essere, per formatori e insegnanti, cominciare a favorire<br />
percorsi guidati, volti a liberare dagli stereotipi, promovendo, ad esempio, occasioni di studio, di<br />
lavoro e di gioco tra maschi o tra femmine anche separatamente, in cui sia possibile confrontarsi<br />
con i coetanei, senza temere il giudizio dell’altro sesso, soprattutto su temi che costituiscono<br />
esperienze diversamente connotate per i due generi. Ciò non significa proporre classi separate ma<br />
includere nella programmazione anche moduli che prevedano esperienze di apprendimento<br />
separate.<br />
Autenticità di sentimenti nei ragazzi e nelle ragazze<br />
Poiché l’apertura al “tu” è una delle grandi avventure dell’uomo, l’attrazione reciproca tra ragazzi e<br />
ragazze, che inizia a farsi sempre più intensa dall’adolescenza e si accom<strong>pag</strong>na a sentimenti di<br />
infatuazione o innamoramento, richiede una particolare attenzione educativa che sappia arricchire,<br />
nell’educazione sessuale, l’educazione ai sentimenti.<br />
I nuovi atteggiamenti verso l’altro sesso si esprimono variamente nei maschi e nelle femmine, ed è<br />
necessario che entrambi possano imparare a cogliere ciò che stanno vivendo e siano orientati nel<br />
difficile processo di conoscenza ed elaborazione dei propri sentimenti, senza essere preda di<br />
inautentiche deformazioni sottoculturali.<br />
Ogni percorso formativo è un processo continuo e complesso sia in senso verticale o diacronico<br />
sia in senso orizzontale o sincronico: le varie fasi dello sviluppo non sono cioè rigidamente<br />
scandite dall’età cronologica, così come sono distinguibili, ma non separabili, le varie dimensioni<br />
educative. Ciò implica che la vita sessuale non può essere concepita indipendentemente dalle<br />
altre dimensioni e in particolare dalla dimensione morale o intellettuale, oltre che, ovviamente,<br />
dallo sviluppo dell’affettività e dei sentimenti.<br />
I sentimenti e le emozioni rivestono un enorme valore nell’esistenza di ogni persona, nonostante<br />
molta nostra tradizione culturale abbia assegnato alla razionalità un peso superiore. È quindi<br />
necessario un impulso negli studi dello sviluppo emotivo-affettivo, più problematico e meno<br />
studiato.<br />
L’educazione ai sentimenti è stata generalmente ritenuta qualcosa di aggiuntivo o di privato. Nel<br />
curriculum scolastico non è prevista esplicitamente un’educazione ai sentimenti e non fa parte<br />
della preparazione professionale dei docenti. Agli insegnanti non sono forniti strumenti per<br />
comprendere e favorire un consapevole sviluppo dell’affettività o per una gestione delle emozioni.<br />
108
E anche in famiglia l’affettività e i sentimenti sono dimensioni dell’esistenza che comunemente<br />
sentiamo di non padroneggiare totalmente; ne risulta spesso problematica la consapevolezza e la<br />
verbalizzazione stessa.<br />
Gli adulti hanno timore a parlare dei sentimenti; tendono a considerare la vita affettiva qualcosa di<br />
segreto. Paradossalmente genitori e insegnanti trovano talvolta meno impudico parlare della<br />
genitalità e della sessualità che dei sentimenti. Ciò è dovuto anche al fatto che, sia pure in termini<br />
e contesti diversi, sono oggi offerte più parole per nominare la sessualità che per nominare i<br />
sentimenti, con il conseguente pericolo che l’educazione sessuale, esonerata da ogni<br />
intenzionalità educativa, sia affidata a spiegazioni tecniche o delegata ai media o addirittura ridotta<br />
alla pornografia: in ogni caso i sentimenti sono ignorati o deformati.<br />
L’educazione sentimentale può invece rendere consapevoli che quello che i ragazzi sentono è<br />
rilevante, riconciliarli con il loro sentire, ma soprattutto aiutarli ad esprimere e a riservare un ruolo<br />
significativo ai sentimenti nella loro esistenza. Oggi vi sono molti adulti “intelligenti” che conoscono<br />
una gran quantità di alfabeti, ma che sono rimasti analfabeti sentimentali. L’educazione ai<br />
sentimenti richiede il coraggio dell’autenticità, la capacità di trovare le parole per esprimere i moti<br />
dell’animo, per assegnare un nome a ciò che si sente.<br />
Sotto l’aspetto educativo, per insegnare a esprimere i sentimenti e a legittimare il sentire, è<br />
necessario suscitare le condizioni perché i ragazzi imparino ad ascoltare ciò che sentono e a<br />
riconoscere i loro sentimenti. Spesso le prime pulsioni erotiche, le emozioni o i sentimenti di<br />
attrazione verso l’altro sesso sono vissuti con vergogna o senso di colpa. Compito dell’educazione<br />
sentimentale non è allora quello di perseguire interventi educativi volti ad abolire le pulsioni<br />
erotiche o le emozioni degli innamoramenti, ma quello di educare alla responsabilità della<br />
decisione assunta a seguito del sentimento provato nel rispetto dei propri ed altrui sentimenti.<br />
Tra sentimentalismo e razionalità<br />
Nell’educazione maschile si riscontra spesso uno sviluppo affettivo mancato per eccesso di<br />
repressione. In quella femminile si ha un altrettanto mancata educazione sentimentale per<br />
sovrabbondanza di sentimentalismo.<br />
Razionalità e fierezza dell’appartenenza al genere maschile non hanno consentito di leggere nelle<br />
pieghe delle proprie insicurezze, delle angosce, dei desideri, di mettersi in discussione, d’inventare<br />
nuovi comportamenti, valori e modalità di relazione con il femminile. La differenza di genere sta<br />
lentamente divenendo un percorso di pensiero anche per il maschile ed è forse divenuto<br />
improrogabile, anche per gli uomini, riflettere sulla propria parzialità.<br />
I modelli trasmessi da padri che spesso hanno scarsa consapevolezza di sé sul piano affettivo<br />
implicano che, nella formazione dei maschi, sovente si anteponga la razionalità alla saggezza, la<br />
tecnica alla compassione e alla confidenza. È tempo d’insegnare ai ragazzi che tenerezza, affetto,<br />
dolore, possono essere oggi nuove virtù eroiche.<br />
109
Nelle ragazze si trova maggiore capacità di ascoltare e di ascoltarsi per conoscersi e dialogare con<br />
sé stesse. Il modello formativo femminile conosce il sentimento della cura e della compassione<br />
come virtù che appartengono all’universo culturale materno. La centralità dei sentimenti nelle storie<br />
formative femminili è però talvolta eccessiva e questo può essere un ostacolo alla stessa crescita<br />
sentimentale delle ragazze che ricevono sollecitazioni ambivalenti verso l’enfatizzazione degli<br />
aspetti specifici della femminilità: da un lato l’educazione alla sollecitudine, al prendersi cura e alla<br />
maternità, dall’altro i modelli ipererotizzanti della cultura dominante saturi di narcisismo e di<br />
volgarità. Il rischio è che le ragazze vengano espropriate di un vissuto autentico del proprio essere<br />
un corpo e della possibilità di sentimenti autentici. Riguardo agli aspetti della vita sessuale e<br />
affettiva, le donne restano spesso preda dell’immaginario, alimentato dagli intrecci del romanzo<br />
rosa o della soap opera, specchio deformante della vita reale, che induce a chiamare “amore”<br />
anche il commercio o la seduzione. Un sentimento predominante nelle femmine è ancora<br />
l’insicurezza: esse sono sempre bisognose di conferme, incapaci di quella autostima che tante<br />
volte ostentano o credono di possedere, sotto la maschera pseudoemancipatoria di atteggiamenti<br />
trasgressivi o aggressivi.<br />
La consapevolezza della differenza e l’attenzione all’altro promuove l’educazione al pensiero di<br />
quell’alterità sessuale prossima e remota che è in sé stessi e fuori da sé, per attuare un’autentica<br />
reciprocità, dove il sentimento dell’amore sia legato all’incontro di esistenze reali nella loro<br />
pienezza, nella libera accoglienza reciproca, nel dono.<br />
Da un ascolto autentico della differenza, attraverso un’autenticità di sentimenti, può nascere un<br />
nuovo pensiero su di sé e sull’altro sesso, una nuova capacità, per i ragazzi e per le ragazze, di<br />
elaborare sentimenti sull’altro genere.<br />
Le ragazze elaborano i linguaggi dei sentimenti appresi dai mondi fittizi delle telenovelas o dei<br />
romanzi rosa; ragazzi fanno una grande fatica a parlare di donne, alla dissimulazione, alla<br />
finzione, alla maschera. Ma chi insegna ai ragazzi i sentimenti che possono accom<strong>pag</strong>narsi alla<br />
scoperta di questo “tu” dell’alterità sessuale? Molto spesso nessuno. Genitori assenti, zitti, distratti:<br />
le famiglie, anche quelle più attente, si limitano a metterli in guardia dai rischi connessi con<br />
gravidanze e malattie. Tutto qui; non il corpo, ancora meno i sentimenti.<br />
L’incontro con l’altro si pone perciò come un luogo del “noi” che non sia sdolcinato<br />
sentimentalismo, ma autentico completamento reciproco attraverso relazioni significative.<br />
Una contrapposizione maschile/femminile finirebbe per ricondurre i soggetti sessuati a una sterile<br />
competitività, dove il “sexum” sarebbe l’elemento che, etimologicamente, taglia in due, e si<br />
finirebbe per smarrire la possibilità che i due siano assieme in modo duale, ovvero nel “modus<br />
amoris” indicato da Binswanger come esistenzialmente autentico essere insieme nell’amore.<br />
Va infine segnalato che nel “noi” della relazione con l’altro non si deve tuttavia smarrire la<br />
dimensione della singolarità e che non c’è pensiero di genere senza la soggettività della persona<br />
nella sua unicità.<br />
110
Secondo Abraham Maslow una sana e piena maturità richiede, come caratteristiche psicologiche,<br />
“un sé reale, un’identità personale salda, autonomia, singolarità”, è perciò necessario che uomini e<br />
donne assumano la costruzione di questa singolarità come compito per l’esistenza. Genitori e<br />
formatori non devono dimenticare che i ragazzi sono diversi tra loro, l’uno diverso dall’altro, e le<br />
ragazze diverse tra loro, l’una diversa dall’altra, nel modo di attraversare il passaggio, nel<br />
percorrere i sentieri della formazione attraverso alcune consapevolezze comuni e altre singolari e<br />
incomunicanti, nel tradurle in pensieri, in vissuti, in scelte per declinare la propria identità di genere<br />
nella propria storia personale.<br />
L’età anziana<br />
In Italia è in continuo aumento il numero di anziani e s’innalza sempre di più la loro età. Un rapido<br />
ma indispensabile sguardo ai dati del censimento 2001 indica una presenza di quasi 11.000.000<br />
ultrassessantacinquenni, corrispondenti al 18,9% della popolazione complessiva, con un aumento<br />
di 2 milioni in dieci anni.<br />
Nonostante i recenti flussi di immigrazione controbilanceranno sensibilmente l’invecchiamento<br />
della popolazione, si continua a registrare un significativo aumento, in valori assoluti e percentuali,<br />
delle fasce di età più anziane. Questi dati si ripercuotono sull’intera struttura socio- economica<br />
della popolazione, determinando un progressivo aumento dell’indice di vecchiaia, passato dal 96,6<br />
nel censimento del 1991 a 131,38 nel censimento 2001. Oggi è di 132,6. Ciò significa che ogni 100<br />
minori di età compresa tra 0 e 14 anni vi sono oltre 132 ultra sessantacinquenni. La previsione<br />
Istat per tale indice al 2010 è di un aumento di 146,5.<br />
Su questa realtà demografica sono state formulate numerose ricerche di carattere sanitario,<br />
economico, sociologico e psicologico, e specifico ad un aspetto eclatante del fenomeno<br />
dell’invecchiamento: la differenza di genere. Tutt’al più è possibile reperire qualche breve capitolo<br />
che affronti la questione, ma nella maggior parte dei casi il tema non è neppure accennato.<br />
Tuttavia la dimensione del genere non è irrilevante, poiché la popolazione femminile invecchia in<br />
misura superiore a quella maschile e la componente numerica femminile, che fino si sessant’anni<br />
risulta essere circa equivalente a quella maschile, con il progredire dell’età aumenta sensibilmente<br />
fino a costituire oltre il 70% degli ultra ottantacinquenni. Il prolungamento della vita media ha<br />
portato nel 2002 la speranza di vita alla nascita a 76,8 anni per gli uomini e 82,9 per le donne. La<br />
differenza di genere appare quindi, anche in base al mero peso quantitativo, un tratto rilevante<br />
dell’età anziana, più che di ogni altra età.<br />
Non basta però rilevare il dato numerico; occorre anche approfondire la specificità della condizione<br />
femminile anziana e la femminilizzazione delle attività che circondano la vita anziana.<br />
Studi in tal senso non sono stati fatti né in ambito gerontologico, né dagli studi di gender, che<br />
hanno posto attenzione alle età precedenti.<br />
Un altro aspetto significativo, ai fini delle riflessioni sulla differenza di genere in età anziana, è<br />
l’elevata percentuale di queste donne che vivono sole, prevalentemente in condizione di<br />
111
vedovanza. Le anziane sole costituiscono quasi la metà di tutte le famiglie unipersonali in Italia: ciò<br />
significa che il cosiddetto single è in realtà prevalentemente donna, anziana, vedova.<br />
Si aggiunga poi che la scelta, da parte degli anziani, di vivere a casa loro, rinviando quanto più è<br />
possibile l’inserimento in strutture residenziali, è favorita dall’attività di cura svolta prevalentemente<br />
da donne: innanzitutto da figlie/nuore in funzione di caregiver; secondariamente dalle cosiddette<br />
“badanti”; in terzo luogo dall’attivazione di servizi socio-sanitari in risposta ai nuovi bisogni e a<br />
supporto della rete familiare.<br />
Molte di queste anziane, sole o con il coniuge, trascorrono lunghe ore della loro giornata<br />
nell’assenza di comunicazione e di relazioni con l’esterno. Ma non si può ignorare che le donne<br />
anziane stesse rappresentano anche una straordinaria risorsa nell’accudimento dei nipoti e, non di<br />
rado, dei pronipoti, fino a quando la salute o la lucidità lo consentono.<br />
La differenza di genere nell’età anziana appare quindi elemento degno di considerazione e studio,<br />
secondo molte prospettive. Di seguito, saranno prese in esame, in particolare, la dimensione<br />
pedagogica e le prospettive socio-educative.<br />
“Comporre una vita”: prospettiva pedagogica<br />
E’ possibile parlare in termini pedagogici della senescenza purché si sfatino gli stereotipi<br />
tradizionali che ci consegnano un’idea di vecchiaia come ultima parte, inutile e triste, della vita.<br />
L’incremento dell’incidenza percentuale degli anziani, uomini e donne, nella popolazione<br />
complessiva, resterà senza voce e marginale sul piano sociale e culturale se non si modifica la<br />
percezione della senescenza come triste declino della vita. La prospettiva pedagogica insegna a<br />
pensare in modo costruttivo, a guardare dentro i numeri, a preparare la società ai mutamenti, a<br />
promuovere le risorse degli anziani, piuttosto che abbandonarsi alle preoccupazioni sconfortanti o<br />
catastrofiste di una società oppressa da una marea di anziani visti come un peso economico,<br />
sociale e familiare.<br />
La prospettiva della lifelong education indica il superamento di una concezione sequenziale della<br />
formazione: se si presuppone una fase giovanile dello studio a cui segue la fase adulta del lavoro,<br />
si finisce per sottrarre ogni senso all’esistenza anziana, al di fuori di quello di decadenza. Questa<br />
visione è riferita principalmente alla vecchiaia maschile. È necessario che l’anziano non identifichi<br />
l’attività unicamente con il lavoro: esso non è la sola attività possibile nella vita dell’uomo e il<br />
pensionamento non coincide automaticamente con l’inattività. Possono esservi invece numerose<br />
attività da scoprire o riscoprire, degne di essere svolte ai fini della propria autorealizzazione ed ai<br />
fini del miglioramento della collettività. La vita anziana è ognora in fieri, progettuale, nei suoi<br />
bisogni ma anche nelle sue ricchezze, nelle opportunità e nei limiti, e perciò capace di atti<br />
volontari, decisioni, scelte. La senilità è quindi un cammino dove il valore della memoria produce<br />
una relazione con il mondo e con gli altri che soltanto una cultura utilitaristica e meschina può<br />
relegare nella reclusione fisica o affettiva.<br />
112
Gli studi della pedagogia sugli anziani sono tuttora assai esigui. Ed è la gerontologia a offrire<br />
maggiori spunti di riflessione sulle peculiarità educative che possono contribuire non soltanto ad<br />
accrescere la longevità, bensì soprattutto a migliorare la qualità della vita anziana, ossia a<br />
perseguire l’obiettivo di invecchiare bene. “L’oggetto della ricerca gerontologica non può essere più<br />
soltanto l’età avanzata, ma l’invecchiamento, l’intero processo del diventare vecchi.” Poiché la<br />
gerontologia si è servita di modelli di analisi e interpretazione che hanno trascurato la specificità<br />
femminile, ha parlato dei problemi della senescenza considerando la posizione dell’uomo che<br />
invecchia, piuttosto che quella della donna.<br />
Si è affermato che la crisi della vecchiaia investe soprattutto l’uomo e in misura molto minore la<br />
donna perché la centralità della famiglia la preserverebbe dalla situazione di frattura e crisi legata<br />
al pensionamento. La marginalità della donna rispetto al mondo del lavoro l’ha esclusa anche dalle<br />
analisi della crisi derivante dal pensionamento e le ha attribuito aprioristicamente un migliore<br />
adattamento alla vecchiaia.<br />
In realtà il ruolo della famiglia nell’esistenza della donna anziana non è stato oggetto di analisi<br />
approfondita, ma è stata semplicemente rispolverata la consueta vocazione sacrificale femminile<br />
secondo cui la donna vivrebbe meglio il processo di invecchiamento in quanto preparata da tutta<br />
una storia di vita fondata sulla dedizione alla famiglia, vissuta nella debolezza sociale, nella<br />
subalternità, dell’invisibilità culturale. È una concezione della vecchiaia femminile che,<br />
paradossalmente, trasforma i punti di debolezza dell’età precedente in punti di forza della<br />
senescenza. Quasi che la debolezza precedente si confacesse meglio ad un’età più vulnerabile, in<br />
una sorta di equivalenza tra sesso debole ed età debole.<br />
Si può invece affermare che i punti di forza dell’invecchiamento femminile non consistono tanto<br />
nella perpetuazione della tradizionale subalternità e dipendenza dall’organizzazione del mondo<br />
maschile, quanto al ruolo tradizionale della donna come anello forte nella trasmissione di sapere e<br />
di competenze tra le generazioni e di scambio di conoscenze, di competenze relazionali, di aiuto<br />
alla persona, proprio in virtù della capacità di cambiamento affinata nei percorsi interrotti delle loro<br />
storie di vita.<br />
Un’interessante prospettiva pedagogica per la vecchiaia femminile può essere infatti individuata<br />
nella flessibilità a cui la donna è chiamata, nel corso della sua esistenza, anche dai ritmi biologici,<br />
flessibilità che richiede creatività nel comporre la propria vita, attraverso le molteplici fratture e<br />
riprese a cui è sottoposta. Mary Catherine Bateson descrive la vita di cinque donne ricostruendo il<br />
loro rapporto con il passato per delineare la faticosa opera di armonizzazione da esse compiuta tra<br />
famiglia, lavoro, studio, entro i mutamenti sociali che hanno attraversato le loro esistenze. La tesi<br />
dell’autrice è che ogni vita possa essere interpretata come “un’opera d’arte”: apprendere quest’arte<br />
è possibile attraverso l’umiltà, l’intelligenza e soprattutto la capacità di reinventare i propri ruoli più<br />
volte nel corso del tempo. Ciò che caratterizza precipuamente le biografie femminili è individuato<br />
113
dall’autrice nella capacità di dividere la propria attenzione e di passare da un’attività di cura<br />
all’altra, di improvvisare in circostanze sempre nuove.<br />
Sulla scorta delle riflessioni poste dalla Bateson, l’educazione all’invecchiamento si configura come<br />
educazione alla discontinuità piuttosto che alla continuità. Ciò che aiuta le donne ad invecchiare<br />
meglio non è quindi, come affermerebbe la concezione diffusa, la continuità nell’attività di<br />
accudimento, bensì la discontinuità.<br />
Il ruolo riproduttivo delle donne rende il ciclo di vita femminile molto più complesso di quello<br />
maschile. È quindi la capacità di vivere nella discontinuità dell’esistenza femminile che si traduce in<br />
una risorsa per l’educazione all’invecchiamento, laddove invece una sostanziale continuità<br />
nell’identificazione maschile con il primato del lavoro rende più vulnerabile la frattura sancita dal<br />
pensionamento.<br />
La vecchiaia evolutiva<br />
Contro gli stereotipi della senescenza come età triste, cristallizzata, volta al passato e incapace di<br />
progettualità, è necessario perciò un nuovo sguardo esistenziale e pedagogico che interpreti<br />
l’ultima fase del ciclo della vita non solo come un periodo di declino, ma come un’età soggetta a<br />
cambiamenti in tutti gli ambiti in cui si dispiega l’esistenza umana. La vecchiaia non è soltanto “ciò<br />
che resta” di un percorso esistenziale ormai giunto al termine, immoto, ma un’età che, attraverso<br />
gli eventi della storia di vita, ha portato la persona anziana a comporre la sua vita. “Comporre una<br />
vita significa reimmaginare continuamente il futuro e reinterpretare continuamente il passato per<br />
dare un significato al presente […]. Il passato legittima il presente e le orme incerte che conducono<br />
al presente indicano i sentieri per il futuro.” (Bateson)<br />
Una buona vecchiaia deve essere preparata negli anni che la precedono ma può anche essere<br />
coltivata, una volta entrati nell’età anziana, attraverso l’ampliamento dei propri interessi intellettuali,<br />
un arricchimento interiore, una crescita cognitiva derivante, oggi più che in passato, dalla maggiore<br />
possibilità di viaggiare, conoscere, ecc. L’invecchiare con successo, secondo l’espressione di<br />
Havighurst, è il risultato di un’educazione all’invecchiamento che ha inizio già nell’età giovanile, e<br />
infantile addirittura.<br />
Tenersi attivi sul piano fisico e mentale è segnalato come la prima esigenza per gli anziani che<br />
vogliano invecchiare bene. Ma è evidente che il processo d’invecchiamento fisiologico è alquanto<br />
influenzato dalla situazione psicologica, affettiva, relazionale della persona anziana e dagli stili di<br />
vita adottati nelle età precedenti. Se l’invecchiamento non è un processo che avviene in modo<br />
omogeneo, la prima irrinunciabile eterogeneità riguarda l’appartenenza al genere maschile o a<br />
quello femminile.<br />
La prospettiva pedagogica implica un cambiamento di prospettiva, insegna a considerare gli<br />
anziani come persone, soggetti depositari di progettualità e risorse, oltre che di bisogni e di<br />
assistenza. A sua volta, la prospettiva della differenza di genere sottrae gli anziani agli stereotipi<br />
derivanti dal considerarli una categoria indifferenziata, cogliendo invece tutta l’eterogeneità dei<br />
114
processi di senescenza: dalle diverse competenze e potenzialità, alle condizioni fisiche,<br />
economiche, relazionali. Di tutte queste variabili dovrà tener conto un’educazione degli anziani che<br />
sappia cogliere le condizioni che rendono possibile un’attiva presenza e un’apertura allo scambio<br />
con l’esterno, con indubbio vantaggio per gli anziani e per la società.<br />
Nella composizione della vita entrano in gioco, secondo Laslett, diverse età che interagiscono: a)<br />
età cronologica (lo scorrere degli anni e dei giorni secondo il tempo dei calendari); b) età biologica<br />
(gli aspetti corporei e psicologici); c) età sociale (attribuita dall’esterno, dall’anagrafe, dal contesto<br />
familiare e professionale); d) età personale (la consapevolezza di trovarsi in un determinato<br />
momento del proprio corso di vita in base agli obiettivi che ci si è posti); e) età soggettiva (legata ai<br />
vissuti e alla percezione di sé, alla propria identità in movimento).<br />
L’età anziana non è più percepibile come un’età definita secondo segnali biologici e sociali<br />
facilmente identificabili, ma come un’età dai confini incerti che viene raggiunta in tempi diversi e<br />
con modalità differenti dai singoli soggetti. Knowles ha coniato, per indicare l’educazione in<br />
specifico riferimento all’età adulta, il concetto di andragogia, che indica l’insieme di competenze<br />
relative alla trasmissione culturale e alla relazione educativa in età adulta.<br />
Per indicare la specificità dell’educazione nell’età anziana è stato coniato, nel 1973, il termine<br />
geragogia, a indicare l’elaborazione di teorie e metodologie educative specificamente rivolte ai<br />
soggetti anziani, e alla preparazione ad una senilità vitale, efficiente, autosufficiente.<br />
La geragogia studia quelle attività educative aventi a oggetto la fase anziana dell’esistenza,<br />
riguardo alle condizioni fisiche, all’educazione alimentare, motoria, sanitaria. L’attenzione<br />
all’educazione degli anziani non nasce quindi in ambito pedagogico ma gerontologico.<br />
L’esigenza di precisare diverse specificità nella pedagogia della vecchiaia non può però ignorare la<br />
fondamentale necessità di una concezione dell’educazione che abbia al centro la persona, in<br />
continua evoluzione, capace di apprendere e di progettare in ogni fase della vita.<br />
Per chiarezza concettuale ed espositiva risulta necessaria una distinzione tra l’educazione<br />
all’invecchiamento, da attuarsi nelle fasi che precedono la senilità, e l’educazione degli anziani,<br />
rivolta propriamente a chi è già nell’età senile.<br />
L’educazione alla vecchiaia<br />
Le considerazioni fin qui poste rendono evidente la necessità di una cultura dell’età anziana<br />
destinata non soltanto alle stesse persone anziane, ma ad una formazione in tutte le età della vita,<br />
sicché la vecchiaia non sia percepita come una realtà da rimuovere nel proprio progetto di vita<br />
giovanile o adulta. Tale negazione produce infatti quella rimozione sociale e culturale della<br />
vecchiaia che rende invisibili gli anziani, i loro bisogni, ma anche le loro risorse. La miopia dei<br />
“Peter Pan” di oggi si traduce in una mancanza di attenzione ai “Matusalemme”.<br />
Compiti di una pedagogia dell’età anziana sono: contrastare la mentalità tendente a far coincidere<br />
senilità e declino, diffondere prospettive di prevenzione dell’isolamento e di promozione di<br />
cambiamenti nelle abitudini dei soggetti anziani e adulti. Si tratta certamente di un processo lento e<br />
115
graduale che non può apportare cambiamenti in tempi brevi, ma che riguarda soprattutto<br />
atteggiamenti, abitudini culturali e tradizioni. Un’educazione per tutta la vita si traduce in una<br />
preparazione senile in modo corretto ed efficace; ma anche nella responsabile consapevolezza<br />
delle potenziali risorse presenti nella vecchiaia.<br />
L’immagine dell’anziano come depositario di saggezza, autorevolezza esperienziale, equilibrio che<br />
possiamo ritrovare nella rappresentazione del “grande vecchio” è purtroppo oggi sempre più rara,<br />
in un’epoca che non vuole ricordare, che abbandona la memoria. La cultura giovanilistica<br />
dominante impone di sembrare giovani a tutti i costi, magnificando gli anziani che, a prezzo di farsi<br />
prendere dall’ansia di questo apparire, smarriscono la libertà di diventare anziani, perdendo anche<br />
i vantaggi che si accom<strong>pag</strong>nano a questa età.<br />
Per restituire dignità alla senescenza occorre attribuirle quella considerazione e quel valore che<br />
essa è venuta perdendo nel passaggio dalla società agricolo-artigianale (dove l’anziano era<br />
rispettato in quanto depositario di competenze da trasmettere) alla società industriale, dove il<br />
prodotto non è controllato dal soggetto che lo produce e quindi non consente accumulo di<br />
conoscenze trasmissibili.<br />
La concezione della vecchiaia come condizione “residuale”, stabilita da un punto di svolta preciso<br />
e repentino, il pensionamento, è ricalcato sul modello della vita maschile, ed è anche in parte<br />
superato. Nella società postindustriale si prospetta infatti un passaggio più complesso e articolato,<br />
meno evidente. Tuttavia la struttura socio-economica dell’età industriale ha consegnato alla cultura<br />
del nostro tempo lo stereotipo dell’anziano improduttivo e quindi spettatore della vita altrui, privo di<br />
protagonismo e della possibilità di decidere le piccole e grandi scelte che lo riguardano.<br />
Tale dimensione appartiene ancor più marcatamente alle donne, alle spettatrici spesso già in età<br />
adulta della vita altrui, custodi del focolare e perciò sottomesse da ogni protagonismo produttivo.<br />
La donna anziana può vivere una doppia emarginazione, in quanto donna e in quanto anziana, e<br />
forse i disagi vissuti sono meno evidenti più che meno presenti, in quanto trovano meno canali di<br />
esplicitazione. Poiché la storia femminile non consegna alle giovani o alle adulte modelli di anziane<br />
autorevoli, l’educazione alla vecchiaia femminile deve iniziare fin dall’infanzia, attraverso<br />
l’educazione ad assumere il proprio valore di persona, a fronte della inferiorità e dipendenza.<br />
Secondo Florea, la donne inizia la propria vecchiaia e il proprio deprezzamento da quando si<br />
distacca dall’immagine femminile proposta dalla cultura dominante: con la menopausa innanzitutto,<br />
che indica la conclusione della stagione feconda, fortemente identificata con la femminilità.<br />
Unitamente alla perdita dell’immagine di sé come virtualmente feconda, la donna vive, in molti<br />
casi, la fine dell’attività lavorativa. Tale fase si accom<strong>pag</strong>na spesso all’impoverimento economico o<br />
alla vedovanza, o al peso materiale e psicologico dell’accudimento al coniuge.<br />
La senescenza femminile è differente non solo per l’appartenenza al genere, ma anche in base<br />
alle diverse condizioni economiche, sociali e culturali delle singole donne, oltre che alla<br />
collocazione territoriale e alle opportunità di cui hanno potuto beneficiare, soprattutto sul versante<br />
116
dell’istruzione. Non è quindi corretto parlare della vecchiaia femminile senza ricordare che si tratta<br />
sempre di un “femminile plurale”, e che esistono tra le donne differenze e disuguaglianze nel<br />
diventare anziane.<br />
Il tempo storico, con le sue trasformazioni nei costumi, nella società, nei servizi sociali, pone poi la<br />
differenza tra le generazioni di anziane: il rapporto con il lavoro e con il ruoli familiari nelle donne<br />
che si avvicinano oggi all’età anziana è certamente vissuto in modo diverso rispetto alle donne che<br />
già vivono la vecchiaia, e prelude a modalità diverse di vivere l’età anziana di domani.<br />
Anche sul versante familiare si è fatta sempre più sfumata e articolata la scansione delle fasi nel<br />
ciclo di vita familiare e il passaggio dalla condizione adulta/genitoriale a quella del nido vuoto. La<br />
famiglia lunga (con la permanenza dei giovani adulti in casa) e le mutate condizioni sociali,<br />
lavorative e relazionali delle giovani coppie diluiscono nel tempo e rendono netto e meno<br />
irreversibile il passaggio da una fase a quella successiva.<br />
L’educazione alla senilità riguarda le singole persone nelle varie età della vita, ma si riferisce<br />
anche all’organizzazione familiare e sociale in senso lato. Risulta quindi evidente l’importanza di<br />
un’educazione alla propria senescenza da costituirsi nelle età precedenti, unitamente ad<br />
un’educazione al valore della vecchiaia altrui e all’educazione degli anziani e delle anziane<br />
affinché sappiano riscoprire la propria forza morale e la volontà di partecipazione attiva alla<br />
comunità di appartenenza.<br />
L’educazione nell’età anziana<br />
I cambiamenti nella società, nel lavoro e nelle informazioni hanno contribuito a evidenziare bisogni<br />
formativi permanenti, relativi a tutte le età della vita ed a molteplici settori. Per ciò che attiene<br />
all’educazione delle persone già entrate in una fase avanzata dell’esistenza, può essere opportuno<br />
riprendere un’ulteriore distinzione tra le attività di educazione degli anziani e l’educazione della vita<br />
anziana. Le prime possono includere tutte le esperienze educative intenzionalmente rivolte alla<br />
formazione in età anziana, e quindi implicano la volontà di perseguire un determinato progetto, di<br />
realizzarlo attraverso un certo programma in risposta a specifiche richieste. Le seconde fanno<br />
invece riferimento alle numerose occasioni di formazione in età anziana in quanto età educabile.<br />
L’educazione degli anziani potrà essere principalmente finalizzata al mantenimento di un buon<br />
standard di vita, qualora esso sia presente, o al recupero, per quanto lo consentano le capacità<br />
residue, nel caso in cui l’individuo si trovi già in una situazione di difficoltà.<br />
La crescente attenzione rivolta agli anziani da parte dei servizi socioassistenziali e sanitari ha<br />
focalizzato l’incremento di pratiche migliorative in fatto di igiene, alimentazione, attività fisica e<br />
farmaci.<br />
Tutto questo è assolutamente indispensabile. Ma non basta. Occorre innanzitutto aiutare gli<br />
anziani a individuare scopi esistenziali, a promuovere la volontà di significato.<br />
Oggi la condizione di pensionati connota un periodo dell’esistenza molto più lungo di quanto non<br />
avvenisse in passato. La vecchiaia, essendo liberata da attività lavorative, offre il vantaggio delle<br />
117
possibilità di rinunciare a quella cultura della produttività e della competitività che alimenta<br />
l’individualismo. Se non si coglie questo vantaggio si finisce inevitabilmente per scivolare in tutti<br />
quei vissuti di privazione e inutilità che derivano dal venir meno dell’attività lavorativa. Vissuti più<br />
accentuati negli uomini e tanto più deleteri quanto più la precedente fase dell’età adulta è stata<br />
identificata in modo prevalente o esclusivo con il lavoro.<br />
La pedagogia dell’età anziana ha allora da essere utilizzata a favorire un orientamento interiore<br />
alla scoperta di quelle dimensioni trascurate nella precedente fase produttiva dell’esistenza,<br />
quando l’efficienza e la carriera costituivano spesso i valori dominanti, per riscoprire la possibilità di<br />
essere sé stessi, attori del proprio tempo e delle proprie scelte: ludiche, motorie, socializzanti,<br />
culturali, religiose, artistiche e altro. In tale proliferare di attività per la terza età non si può ignorare<br />
che esistono numerosi aspetti che camuffano attività aventi lo scopo di sfruttare i nuovi anziani<br />
secondo le logiche di un mercato che si rivolge ad essi come consumatori di determinati prodotti.<br />
Nuove forme di marginalità possono poi derivare dalle difficoltà del confronto intergenerazionale.<br />
La tendenza a privilegiare i rapporti con i coetanei rischiano di produrre un distacco dalle<br />
generazioni più giovani e una crescente divaricazione culturale nei confronti del mondo che<br />
prosegue secondo le logiche non più comprensibili. L’accelerazione dell’autoesclusione è acuita<br />
dal veloce sviluppo delle tecnologie informatiche che appaiono incomprensibili o sono guardate<br />
con diffidenza dagli anziani, costituendo un ulteriore elemento di frattura intergenerazionale. La<br />
progressiva perdita dei coetanei, le malattie invalidanti, aggiungono esperienze di lutti e distacchi<br />
che rendono soli e tristi gli anziani più longevi e in buona salute.<br />
È quindi fondamentale progettare un’educazione agli anziani ricca di scambi intergenerazionali<br />
affinché ogni generazione possa avvalersi di reciproco arricchimento.<br />
È necessario estendere anche nell’età senile le azioni educative improntate alla differenza di<br />
genere che stanno da alcuni anni rivestendo crescente interesse nell’educazione relativa alle altre<br />
età della vita. Finché ciò non avverrà si continuerà a estendere al genere femminile<br />
un’interpretazione della vecchiaia di fatto ricalcata sui bisogni e le problematiche maschili e si<br />
offriranno opportunità educative che non rispetteranno differenze tra i generi.<br />
Destinatari di care e donatori di care<br />
Il rimando di immagine che gli anziani ricevono dalla società è connotato negativamente come<br />
inattivo, ignorato come inutile avanzo della società produttiva, un peso, un costo sociale e<br />
sanitario. Collocati in un tempo senza tempo in attesa della fine, sono privati della spinta<br />
progettuale. Questi stereotipi dominanti rendono difficile una positiva costruzione dell’immagine di<br />
sé e della propria dignità umana e sociale. “Chi rifiuta un anziano non sa cosa perde” recitava uno<br />
spot pubblicitario ministeriale, ma i media propongono prevalentemente notizie di anziani scippati,<br />
derubati, truffati, abbandonati, anziché mostrare esempi positivi di quanti anziani invece sono<br />
ancora attivi nel volontariato sociale o forniscono un indispensabile supporto alle nuove famiglie,<br />
nel prezioso ruolo educativo di nonni.<br />
118
Segnali di cambiamento nei comportamenti demografici aprono nuovi interrogativi sull’evoluzione<br />
della condizione anziana e costringono a rivedere i parametri interpretativi insieme alle prospettive<br />
politico-sociali, sanitarie, assistenziali e, ancora una volta, educative.<br />
Il dramma della solitudine è spesso causa e non la conseguenza della decadenza psico-fisica. È<br />
necessario pensare perciò ad una rete di servizi che integri la rete familiare primaria e sappia<br />
produrre un’offerta diversificata di stimoli relazionali, occasioni di incontro, impulso alla propria<br />
progettazione esistenziale, nella consapevolezza che sono assai numerosi gli anziani su cui si può<br />
contare come risorse vitali sia per la propria famiglia sia per la comunità.<br />
Il numero di anziani che vivono affettivamente soli, lontani dai figli e senza alcuna rete parentale<br />
vicina è in continuo aumento. Ma la solitudine non si identifica soltanto con la lontananza dei figli,<br />
che può essere fisica, culturale o affettiva. L’attuale famiglia nucleare, composta prevalentemente<br />
dai genitori e figli/o, non può accogliere, per ragioni di spazio fisico e di tempo, i nuclei anziani<br />
delle rispettive famiglie d’origine o i genitori eventualmente soli.<br />
La solitudine degli anziani nelle grandi città è poi aggravata per le paure connesse all’aumento<br />
della criminalità. Timorosi persino di uscire di casa ed aprire la porta agli sconosciuti, soli davanti<br />
alla televisione, nelle lunghe giornate di isolamento forzato, gli anziani finiscono per manifestare<br />
sintomi di patologie psicologiche quali depressione, confusione mentale, forme deliranti e demenze<br />
legate alla mancanza di comunicazione con altre persone.<br />
Segregati soli o in coppia tra le mura domestiche, trasformano la casa in rifugio e prigione. Le<br />
donne anziane in particolare restano tra le mura domestiche: cucinare, accudire, prendersi cura<br />
dei nipoti o del coniuge sono i compiti della quotidianità. Uscire di casa, anche in età anziana,<br />
rimane prerogativa maschile: il bar, il centro sociale, la bocciofila, o anche semplicemente la posta,<br />
la banca, <strong>pag</strong>are le bollette.<br />
Un tratto specifico della solitudine anziana femminile è la vedovanza, dovuta alla minore età<br />
rispetto al marito e alla maggiore aspettativa di vita. Ma tale divario si colloca in un contesto<br />
culturale patriarcale per cui la moglie si assume i compiti di cura del marito fino a tarda età, mentre<br />
piuttosto di ricevere cura dal marito cerca di contare su altre donne per ottenere a sua volta<br />
sostegno. I rapporti tra le generazioni sono dunque privilegiatamente matrilineari, poiché in<br />
massima parte sono le donne a farsi carico dei ruoli di caregivers.<br />
È necessario, sul piano educativo, favorire queste consapevolezze individuali e sociali, ovvero<br />
rendere manifesto che la vecchiaia, oltre a essere destinataria di cura ed assistenza, è anche fonte<br />
di cura e di assistenza, normalmente invisibile, silenziosa, gratuita, e rappresenta una grande<br />
risorsa affettiva, relazionale ed anche economica.<br />
Genealogie femminili come risorsa<br />
Il prolungamento ed il miglioramento della vita implicano un ingresso nella condizione anziana<br />
contraddistinto da caratteristiche del tutto nuove rispetto alle generazioni precedenti. Per esempio<br />
gli attuali anziani hanno in molti casi i loro genitori ancora viventi. E hanno figli, giovani adulti,<br />
119
spesso conviventi. Non solo. In molti casi hanno anche figli rientrati in famiglia dopo una<br />
separazione coniugale e nipoti da accudire. In tale contesto sono le donne anziane di oggi a<br />
essere caricate di una pluralità di ruoli e compiti.<br />
Le attuali “giovani anziane” continuano a condurre l’organizzazione quotidiana di una famiglia che<br />
si è fatta sempre più complessa, che fa riferimento a loro chiedendo di riuscire ad essere<br />
contemporaneamente madri, nonne, figlie.<br />
Una delle ragioni per cui le donne si impegnano tenacemente nell’accudire i figli ormai adulti o dei<br />
nipoti è anche perché, perdendo la dimensione dell’accudimento familiare, perdono sé stesse.<br />
Il corpo riveste un’importanza decisiva nella differenza di genere in età anziana. L’uomo vive con<br />
angoscia la perdita di forza e prestanza fisica. L’identificazione della donna con la funzione<br />
riproduttiva e la sessualità rimanda alla pubertà e alla menopausa come le tappe fondamentali di<br />
ingresso ed uscita dalla vita sessuale e riproduttiva; con la menopausa la donna perde il senso<br />
principale che viene attribuito alla sua esistenza, nonostante molte donne denuncino quanto sia<br />
insopportabile questo stereotipo che le rimanda nell’invisibilità sociale, proprio quando, in molti<br />
casi, esse sono appena a metà della vita adulta.<br />
Se da giovani le donne hanno puntato molto sulla corporeità e sulla maternità come elementi<br />
cardine dell’identità psicologica e sociale, può diventare drammatico accettare il decadimento<br />
dell’aspetto fisico, le rughe o la perdita di avvenenza, oppure può diventare luttuosa l’uscita di casa<br />
dei figli (il nido vuoto).<br />
Nel complessificarsi delle relazioni e dell’organizzazione familiare un’azione educativa volta a<br />
ridefinire i ruoli maschili e femminili potrà ridurre il sovraccarico che ancora svantaggia le donne<br />
ma anche rendere patrimonio comune, per uomini e donne, la ricchezza di pensiero e di azioni che<br />
la presenza delle anziane apporta alla società, qualora possa essere espressa e riconosciuta.<br />
Tra isolamento e reti territoriali<br />
Quando il bisogno di affetto e l’esigenza di comunicazione non trovano corrispondenza nei membri<br />
giovani e adulti della famiglia, gli anziani sono in condizione di solitudine, non perché vivono isolati<br />
e appartati, ma perché, pur inseriti in nuclei familiari, sperimentano paradossalmente l’isolamento<br />
affettivo e l’emarginazione sentendosi estranei e quasi intrusi nel contesto affettivo familiare, dove<br />
non possono estrinsecare la loro personalità e soddisfare le proprie esigenze di vita, di relazioni<br />
interpersonali, di partecipazione.<br />
La donna vive una quotidianità dello spazio delimitato e il desiderio di uscire resta inap<strong>pag</strong>ato<br />
anche perché spesso non c’è un “dove” e un “con chi”, un “per che cosa”. Tutto ciò rende la<br />
solitudine e l’isolamento tra le mura domestiche la situazione più diffusa tra le donne anziane oggi.<br />
Forse le anziane di domani potranno godere di una migliore condizione esistenziale, relazionale,<br />
culturale, ma perché ciò avvenga occorre anche che i servizi sociali sappiano riconoscere una<br />
specificità delle anziane derivante dal loro avere trascorso una vita “da donne”. Per esempio si può<br />
pensare ad interventi domiciliari che non si limitino a fornire prestazioni a domicilio, ma che<br />
120
favoriscano l’uscita stimolando motivazioni, suscitando relazioni di vicinato, attivando il caseggiato<br />
o il quartiere, valorizzando piccoli progetti di socializzazione informale.<br />
Per gli uomini, il tempo libero vagheggiato spesso durante la stagione lavorativa della vita, può<br />
trasformarsi, paradossalmente, in problema se è oppresso dal tedio e dalla malinconia. Questa<br />
inattività forzata può anche essere recuperata in tempo condiviso e donato per aiutare gli altri,<br />
anche attraverso piccoli gesti quotidiani di solidarietà che tengano vive le reti informali di vicinato,<br />
le attività dei quartieri, delle parrocchie, dei servizi sociali stessi e quindi contribuiscano a rendere<br />
viva la comunità, a sottrarre le famiglie, giovani e anziane, all’isolamento e alla solitudine che oggi<br />
le imprigiona.<br />
Allo stesso modo è importante continuare a circondare gli anziani e le anziane di una comunità<br />
territoriale in grado di garantire un ruolo di rassicurazione primaria. La casa e il territorio possono e<br />
devono interagire per salvaguardare l’esistenza degli anziani e preservarli dall’isolamento. La<br />
cultura della domiciliarità, intesa come valorizzazione della rete solidaristica allargata, del sistema<br />
di parentela, del vicinato, del cortile, del quartiere, costituisce una protezione per i soggetti anziani,<br />
per le loro famiglie, per i servizi sociali.<br />
La domiciliarità si riferisce alla possibilità di attribuire senso ai luoghi e agli incontri, accrescere i<br />
vissuti di familiarità e accoglienza, contrastare le paure legate ai vissuti di estraneità e di<br />
insicurezza.<br />
Costruire condizioni di comunità solidale è la principale prospettiva pedagogica perché gli anziani e<br />
le anziane abbiano la forza si esprimere un protagonismo nelle scelte che li riguardano e, al tempo<br />
stesso, vedere valorizzate le risorse di cui possono fare dono alle generazioni successive.<br />
121
KÖRPSEELE: IL CORPO ANIMA<br />
DI EUGENIA CASINI ROPA TRATTO DA “<strong>LA</strong> DANZA E L’AGITPROP”<br />
La riscoperta del corpo è stata alla base di un vasto e complesso movimento che, a<br />
partire dalla fine del XIX secolo, ha attraversato le ideologie e le separatezze delle modalità<br />
espressive. Fenomeno trasversale e fondante, troppo facilmente allontanato e rimosso dalla<br />
riflessione critica e dall'analisi storica, ebbe uno sviluppo preminente nei paesi di cultura<br />
tedesca.<br />
Alle sue origini contribuì in maniera determinante la Jugendbewegung, il Movimento<br />
giovanile tedesco. Nato dalla ribellione degli studenti borghesi di fine secolo ai moduli di vita<br />
stereotipati e soffocanti delle città create dai padri, vissuti ormai come segnale di decadenza<br />
civile e morale, il Movimento (di spirito vigorosamente nazionalista) si rivolse alla natura, in cui<br />
riconosceva una bellezza e una purezza originarie, fiere e incontaminate, adatte a forgiare per<br />
contatto spiriti e corpi sani e vitali. Escursioni e campeggi in cam<strong>pag</strong>na e sulle montagne,<br />
esercizi fisici all'aperto, sport individuali e di gruppo, libertà nell'abbigliamento e cameratismo<br />
nei modi furono le prime manifestazioni di una nuova consapevolezza e familiarità dei giovani<br />
tedeschi verso il proprio corpo (così come l'interesse per il folklore, l'amore per i racconti, i<br />
canti, le danze, le feste contadine, rivelavano il bisogno parallelo dell'immersione nel Volke,<br />
il mitico «popolo» originario).<br />
Su questo terreno la Jugendbewegung si incontrò del resto felicemente con il più<br />
generalizzato e meno chiaramente circoscrivibile - dal punto di vista dell'età e della condizione<br />
sociale degli aderenti - movimento per la Lebensreform, «che cercava di ritornare alle<br />
cosiddette forze genuine della vita e di rigenerare l'uomo e la società attraverso il<br />
vegetarismo, il rifiuto dell'alcolismo, la salubrità della natura, la riforma agraria e la difesa delle<br />
città-giardino» . La ripulsa della metropoli e il ritorno al «libero» rapporto con la natura divennero il<br />
simbolo di una vera cultura della liberazione, sfida alla morale borghese dell'ipocrisia e alla<br />
politica dell'industrializzazione che deforma l'uomo in macchina.<br />
Il mito neoclassico e intimamente tedesco della bellezza «olimpica» e della «grecità»<br />
alimenta la riscoperta del corpo che si manifesterà in modi e forme eclatanti nei primi decenni<br />
del Novecento. È in questi anni infatti che la grande ventata della Körperkultur, la cultura del<br />
corpo che porterà ad una vera e propria rivoluzione della mentalità, degli usi e del gusto<br />
nell'igiene, nell'impiego del tempo libero, nell'educazione, nell'espressione quotidiana e artistica,<br />
si concretizza in iniziative di ricerca e di sperimentazione individuali e collettive di nuovi sistemi e<br />
norme di vita e di educazione fisica. Il precisarsi e il primo diffondersi di tali iniziative si situa nei<br />
primi anni del secolo, quando altri, diversi apporti di pensiero contribuiscono ad arricchire e a<br />
caratterizzare la “via tedesca” verso una nuova formazione fisico-morale dell'uomo (il modernismo<br />
122
scientifico e artistico, il relativismo vitalistico di Simmel, il pessimismo culturale di Spengler). Vi si<br />
intersecano la psicologia e la nascente psicanalisi, ma anche l'interesse verso dottrine esoteriche<br />
come la teosofia e l'antroposofia e verso religioni esotiche e mistiche che, tutte, propugnavano un<br />
legame indissolubile dell'uomo con le forze e i ritmi cosmici e perseguivano una liberazione dello<br />
spirito nell'unione (da ottenere attraverso discipline anche fisiche) con trascendenze diversamente<br />
definite ma ugualmente universali e immanenti.<br />
Il movimento, l'azione fisica individuale e collettiva, fu visto non solo come il modo più<br />
idoneo per conferire al corpo energia e bellezza, ma anche come il mezzo privilegiato per collegare<br />
l'uomo al moto universale della natura, mentre il ritmo, come fondamentale elemento regolatore<br />
e armonizzatore del movimento del cosmo, divenne la base anche di qualsiasi attività fisica<br />
organizzata. Contemporaneamente il gesto, inteso nella sua accezione più lata di ma-<br />
nifestazione fisica del movimento, per la diretta connessione che venne sempre più acquisendo<br />
con la dimensione interiore dell'uomo, divenne ostensore sensibile di pulsioni e significati<br />
nascosti, si caricò di un'«espressività» che doveva farsi rivelazione della ritrovata armonia<br />
dell'individuo con se stesso e col cosmo. Salute e bellezza del corpo cominciarono quindi a venire<br />
indissolubilmente legati all'idea dell'ordine e dell'armonia nei tratti e nei movimenti, ordine e<br />
armonia fisici strettamente connessi con corrispondenti qualità morali e intellettuali, il cui<br />
raggiungimento doveva procedere parallelamente e congiuntamente a quelle del corpo.<br />
Alla base di tutto ciò stava la convinzione di natura filosofico-pedagogica che bellezza,<br />
armonia e ordine siano qualità primarie insite nella natura e dunque anche nell'essere umano, che<br />
può quindi essere messo in grado di riconquistarle, eliminando le storture e le repressioni<br />
dovute ad una errata educazione sociale, attraverso principi formativi nuovi ed idonei. La<br />
recente attitudine tutta novecentesca alla relativizzazione delle idee, a mettere in discussione i si-<br />
stemi dominanti per proporne di alternativi a cui si riconosceva analoga fondatezza, insieme alla<br />
profonda coscienza nazionalista che vedeva nel Volk e nella promozione della rinascita della sua<br />
forza e della sua virtù razziale il futuro della Germania, valsero a preparare un terreno<br />
speculativo e sperimentale accogliente, in cui questi principi poterono rapidamente far presa e<br />
germogliare in teoria e prassi pedagogica ed estetica.<br />
Come primo, generalizzato esito dei diversi apporti finora considerati si nota, a partire<br />
dai primi anni del secolo, il progressivo trasmutare del concetto di esercitazione corporea, sia in<br />
accezione ricreativa che formativa, in quello di «cultura del corpo» (Körperkultur). Fino ad allora i<br />
metodi ginnici praticati - il nazionale «metodo tedesco», severo e marziale, predominava rispetto al<br />
più dinamico e sportivo «sistema svedese» - esigevano un allenamento corporeo forzato sulla<br />
base di esercizi formalmente predeterminati ed erano finalizzati unicamente all'irrobustimento<br />
e alla disciplina muscolare e al raggiungimento della prestanza e dell'efficienza fisica,<br />
facevano cioè riferimento ad una sfera puramente «organica». Da quel momento in poi i nuovi,<br />
diversi metodi ginnici perseguiranno uno sviluppo congiunto ed armonico del corpo e della psiche,<br />
123
attraverso esercizi ritmici spesso molto liberi ed individualizzati, fondati sulla conoscenza delle<br />
leggi naturali del movimento nel corpo umano e sulla loro applicazione, e avranno spesso risvolti<br />
`artistici'. Si tratterà, per anticipare le parole di una delle più note personalità della ginnastica<br />
formativa dell'epoca, Bess Mensendieck, non più di «correggere la natura», ma di «scegliere il<br />
bello della natura nel proprio corpo», e di portarlo a completa maturazione.<br />
E sarà proprio la ricerca del «bello», sotto l'aspetto di valorizzazione della «grazia» e<br />
della bellezza nel movimento, insieme col rilievo dato all'espressività, a determinare la<br />
destinazione prevalentemente femminile delle nuove discipline di formazione fisica. Se da un<br />
lato infatti, a livello di communis opinio, era ovviamente la donna ad essere ritenuta<br />
costituzionale portatrice o destinataria di qualità come la grazia e la bellezza, dall'altro, a livello<br />
colto, gli studi sull'isteria di Charcot e Freud, che avevano contribuito ad individuare la<br />
liberazione espressiva dell'inconscio come forma terapeutica, restauratrice dell'equilibrio inte-<br />
riore, e quindi a legittimare l'espressione nel movimento dal punto di vista formativo,<br />
avevano indicato la donna come soggetto «isterico» per eccellenza e dunque naturalmente<br />
portato a (e bisognoso di) manifestare assai più liberamente dell'uomo emozioni e sentimenti.<br />
Occorre inoltre tener conto della concezione sociale della donna nella Germania dell'epoca, che la<br />
vedeva esclusivamente destinata al matrimonio e alla maternità, riconosciuta e ap<strong>pag</strong>ata nel<br />
suo ruolo di acquiescente reggitrice del focolare domestico: la salute, la grazia e l'equilibrio<br />
psicologico che le si offrivano attraverso la cultura del corpo, potevano venire considerati<br />
arricchimenti preziosi e del tutto funzionali al sistema, strumenti di un'emancipazione<br />
finalizzata e controllata, e tuttavia gratificante, volta a far di lei una com<strong>pag</strong>na più gradevole e<br />
una procreatrice più sana. D'altra parte, in campo maschile era radicato un concetto di virilità rude<br />
e cameratesca, sospettosa e timorosa di qualunque debolezza o mollezza, che, se ben si<br />
sposava con i modelli estetici delle statue greche proprio perché ne perseguiva l'impassibilità<br />
apparentemente scevra dai turbamenti del sesso e delle passioni, poteva difficilmente<br />
indulgere a discipline che richiedevano un abbandono al ritmo e alla libera espressività.<br />
Fu così che la donna divenne la destinataria privilegiata della grande riforma ritmico-<br />
educativa della Körperkultur, e che l'uomo ne assunse e ne gestì prevalentemente gli aspetti<br />
legati allo sport e alle manifestazioni collettive di carattere laico e militare, in cui il movimento co-<br />
rale e il senso del ritmo e dello spazio assumevano un grande peso, ma le forme del<br />
movimento si organizzavano in schemi rigidamente astratti e razionali.<br />
La cultura fisica nel suo complesso non conobbe invece distinzioni di carattere ideologico, e,<br />
almeno in parte, di classe nella sua diffusione. La riscoperta e l'educazione del corpo insieme<br />
con le attività fisiche e le forme estetiche ad essa legate vennero infatti assunte e praticate non<br />
soltanto dalla gioventù borghese, ma ben presto anche dalle organizzazioni dei lavoratori e dei<br />
giovani proletari. Negli anni Venti, poi, salute e prestanza fisica, come espressione di su-<br />
periorità anche morale, saranno coltivati tanto dalle sinistre, come un mezzo per la<br />
124
preparazione e l'affermazione della classe operaia, quanto dal nazionalsocialismo, che vi sosterrà<br />
dapprima il proprio credo nazionalista e quindi il proprio mito di superiorità razziale.<br />
Alla definizione dei principi della Körperkultur e alla loro traduzione in pratica pedagogica<br />
concorsero però anche - e in maniera spesso determinante - teorie, sperimentazioni e uomini<br />
provenienti da territori (di pensiero e di azione) teatrali, e più in particolare, per ciò che concerne<br />
la ricerca sul campo, dall'ambito della danza, arte elettiva del corpo umano. Distinguere con<br />
chiarezza i vari apporti di provenienza teatrale nel reticolo di influssi e suggestioni cha anima i<br />
fautori, gli artefici e gli esegeti della cultura del corpo, si rivela spesso arduo, per la fusione, a tratti<br />
totale, delle discipline artistiche con quelle formative che caratterizzò l'intero movimento. Si<br />
possono tuttavia individuare almeno le influenze più evidenti, quelle più frequentemente<br />
riconoscibili e dichiarate negli scritti dell'epoca, e che colorano con evidenza teoria e pratica.<br />
Due influssi teorici furono particolarmente determinanti alle origini nelle scelte speculative<br />
e sperimentali della nascente Körperkultur: quello di un ideale filone estetico che partendo da<br />
Schopenhauer unisce Wagner a Nietzsche (e che troverà in Adolphe Appia da un lato e in Georg<br />
Fuchs dall'altro i suoi esiti teorici più estremi e influenti) e quello del francese Francois Delsarte<br />
(1811-1871) e del suo «sistema di estetica applicata». Dai primi si attinse principalmente l'idea<br />
della priorità della musica (e quindi del ritmo) in campo estetico e della sua qualità di<br />
ispiratrice prima delle arti dell'uomo nel tempo e nello spazio; la rivisitazione in chiave di genesi<br />
creativa del mito greco incarnata nella definizione propositiva del principio dionisiaco, che esalta<br />
l'ebbrezza e la fusione mistica dell'artista nell'atto creativo; l'esaltazione della soggettività<br />
dell'individuo e delle sue qualità insite ". Dal secondo derivano l'applicazione all'arte della<br />
concezione unitaria e «trinitaria» dell'uomo, che permette al corpo di acquisire uguale dignità<br />
rispetto all'intelletto e all'anima; l'idea della connessione intima e necessaria di ogni movimento<br />
esteriore con un analogo moto interiore che ne determina I’espressività; l'enunciazione di leggi<br />
«naturali» del movimento (e pertanto dell'espressione umana) induttivamente dimostrabili e<br />
consapevolmente e volontariamente applicabili. Principi tutti fondamentali che vedremo<br />
costantemente alla base di ogni ricerca e sui quali si svilupperanno metodi e scuole formativi e<br />
creativi.<br />
Se Wagner e Nietzsche appartenevano intimamente al bagaglio culturale della nazione<br />
tedesca, Delsarte fu invece introdotto in Germania dall'esterno e venne presto assimilato in<br />
maniera originale e con sostanziali modifiche. Di rimbalzo dagli Stati Uniti, dove il «delsartismo»<br />
pro<strong>pag</strong>andato negli anni Settanta e Ottanta da Steele MacKaye, discepolo prediletto del<br />
maestro francese, aveva modificato profondamente il gusto e il comportamento degli americani<br />
in fatto di estetica del corpo e dell'espressione, la conoscenza di Delsarte si diffuse<br />
principalmente attraverso il libro di Genevieve Stebbins Delsarte System of Expression, che<br />
aveva visto la prima delle sue numerose edizioni nel 1885. Il volume, oltre alla trattazione<br />
dettagliata del sistema di espressione originale e di quello di «ginnastica armonica» degli allievi<br />
125
americani (la Stebbins fu la principale collaboratrice di MacKaye nel tradurre in metodo pedago-<br />
gico generalizzato gli esercizi elaborati inizialmente solo per gli attori), contiene il più compiuto<br />
intervento teorico che Delsarte abbia lasciato, la relazione svolta all'Associazione Filotecnica di<br />
Parigi nel 1858 sulla sua Estetica applicata . Da esso, in aggiunta ai principi generali già ricordati e<br />
che fondavano in sostanza la concezione espressiva del movimento quotidiano e teatrale (anima,<br />
intelletto e corpo interagenti e interdipendenti), filtrarono alcune importanti conoscenze teorico-<br />
sperimentali di base, che permettevano l'approfondimento pratico delle dinamiche fisiche e<br />
fisiologiche ad un livello preespressivo.<br />
In primo luogo la definizione di leggi «naturali» del movimento che venivano riconosciute<br />
nel parallelismo (o equilibrio armonico), nell'opposizione e nella successione dei vettori<br />
dell'energia e che derivavano direttamente da Delsarte, seguita dall'individuazione dei tre<br />
elementi primari su cui fondare l'educazione del corpo: il respiro, il rilassamento e la tensione<br />
muscolare, di derivazione più specificamente delsartista. Fondamenti, tutti, che passeranno<br />
inalterati alla ginnastica e alla danza tedesche, amalgamandosi ed arricchendosi con l'attenzione<br />
per il ritmo e il rapporto con lo spazio e con la tendenza alla coralità dinamica propri degli<br />
sperimentatori tedeschi.<br />
Accanto a questi apporti teorici sostanziali, occorre infine ricordare l'influsso sottile, ma<br />
potente, difficilmente definibile o quantificabile, ma pure suggestivamente presente non<br />
soltanto in ambito artistico, di alcuni eventi teatrali di inizio secolo che scossero la critica e<br />
l'opinione pubblica e aprirono con l'esempio la strada a inesplorate potenzialità del movimento.<br />
Ne furono principali protagoniste tre danzatrici assai diverse tra loro, ma che diversamente<br />
parevano concretizzare aspirazioni e tensioni presenti nell'aria.<br />
Nel 1902-3 Isadora Duncan effettuò la sua prima tournée in Germania attraversandola<br />
con la violenza di un ciclone, suscitando ovunque scandalo, turbamento, entusiasmo. La sua<br />
rottura totale con i canoni accademici della danza, la rivendicazione di un'assoluta libertà e<br />
«naturalità» del movimento, la sua immagine di «grecità» vivente riempita di carne e di sangue, il<br />
suo libero uso della grande musica classica come ispiratrice della danza e dei suoi contenuti<br />
emotivi, rimarranno termini di riferimento per ogni discussione teorica o applicazione pratica nei<br />
decenni successive.<br />
Nel 1904 diede una serie di dimostrazioni nelle principali città tedesche Madeleine G..<br />
Gli innumerevoli interventi scientifici, filosofici e critico-artistici sul suo caso ebbero l'effetto di<br />
portare in primo piano le potenzialità estetiche del corpo umano liberato dai condizionamenti<br />
della ragione e della società ed esaltarono la manifestazione diretta del sentire profondo<br />
(dell'anima, dunque, e dell'inconscio) attraverso l'espressione esteriore.<br />
Infine, negli stessi anni, ma ancor da molto prima, Loïe Fuller, americana trapiantata in<br />
Europa, ottenne larghi consensi nei music-hall con la sua originale e spregiudicata danza fatta di<br />
ampi veli agitati nell'aria e trasformati in movimento e colore dall'uso sapiente dell'illuminazione.<br />
126
La sua «danza della luce», pur se principalmente a livello di suggestione estetica, impose l'idea<br />
del movimento come creatore-animatore dello spazio e fonte di inedita bellezza ed emozione.<br />
Suggestioni e sperimentazioni teatrali che incidono nel sociale sulle teorie e le tecniche<br />
di formazione fisica, e correnti di pensiero, bisogni e utopie largamente diffusi nel sociale che<br />
indirizzano i percorsi della ricerca teatrale: elemento caratteristico della Körperkultur - e stimolo<br />
attivo al nostro interesse - è il rapporto insolito, lo scambio consapevole, continuo e reciproco di<br />
esperienze tra ricerca pedagogica e ricerca teatrale, tra tecniche formative dell'attore-danzatore e<br />
tecniche formative dell'individuo. Sarà difficile distinguere in questi anni scuole, metodi e<br />
laboratori di danza da quelli di ginnastica, e quelli rivolti genericamente a tutti da quelli diretti alla<br />
nuova professionalizzazione di attori e danzatori. Spesso vedremo questi ultimi studiare ed<br />
esercitarsi insieme ai bambini, oppure vedremo bambini e giovani utilizzare per la propria<br />
formazione personale tecniche di origine teatrale. La società pensa i suoi nuovi modi pedagogici e<br />
il teatro, nel suo rifiuto dell'istituzione e nella sua ricerca di senso non solo estetico oltre propri<br />
confini, pare votato ad esserne il luogo sperimentale privilegiato: li fa suoi, spesso li precede e li<br />
supera, li porta alle conseguenze estreme, li rende infine, collaudati e come filtrati, al sociale,<br />
trattenendone i fermenti più attivi che lo rigenerano e lo mutano.<br />
«Innalzate i vostri cuori, fratelli miei, in alto! più in alto! E non dimenticatevi le gambe!<br />
Alzate anche le vostre gambe, da bravi danzatori, e meglio ancora: mettetevi a testa all'ingiù!».<br />
Sotto l'egida di questa esortazione che Nietzsche mette sulle labbra del suo Zaratustra, prende<br />
avvio la grande stagione del corpo ritrovato.<br />
Ricostruire a grandi linee lo sviluppo teorico e pratico della Körperkultur, passando in una<br />
rassegna essenziale uomini, eventi e metodi educativi e artistici, esige un difficile orientamento: a<br />
livello teorico impone ripetuti passaggi di prospettiva dalla quotidianità all'arte, dalla formazione<br />
alla creazione, dalla pedagogia al teatro, senza poter mai annullare completamente il margine di<br />
incertezza e di sovrapposizione che intreccia tra loro questi vari livelli; allo stesso modo, in campo<br />
pratico, costringe a fare i conti con l'inusitato fervore ginnico di quel periodo, che vede<br />
un'eccezionale fioritura di scuole caratterizzate da un'imbarazzante ma sostanziale e proficua<br />
confusione e commistione tra igiene ed estetica, tra ginnastica e danza, tra «sistemi», «metodi»,<br />
creatori, seguaci, imitatori, oppositori e così via.<br />
Nel 1926, Fritz Böhme, forse il critico e studioso del momento più sensibile ai problemi<br />
dell'arte nel movimento, proporrà a posteriori, ripercorrendo la storia della moderna arte della<br />
danza, un criterio di base per distinguere tra scuole e metodi di ginnastica e di danza,<br />
individuando le prime per la loro finalizzazione primaria ad una formazione puramente organica<br />
dell'allievo, per la maggiore formalizzazione e staticità degli esercizi usati e per il loro minore<br />
o inesistente interesse per gli elementi estetico-espressivi. Ma se una discriminante di questo<br />
genere risponde bene anche a criteri puramente intuitivi e può sostanzialmente essere<br />
accettata, essa trae tuttavia consistenza da una situazione più matura e chiara come quella dei<br />
127
secondi anni Venti, e solo forzosamente si presta ad essere proiettata all'indietro ad<br />
inquadrare una realtà fluida e spesso indistinta come quella dei primi due decenni del<br />
secolo, che d'altra parte, proprio per il loro carattere di crogiuolo in cui prendono forma le<br />
idee, è per noi la più interessante da indagare. Qui, dove esperienze del tutto nuove<br />
maturano giorno per giorno, il margine d'incertezza è e rimane largo e un incasellamento<br />
forzato delle esperienze rischia di far perdere a loro la propria carica polivalente di vitalità e a noi<br />
il loro senso complesso e complessivo. Allo stesso modo risulta poco utile, per afferrarne il senso,<br />
stilare una storia dettagliata dei metodi e delle scuole secondo la loro apparizione cronologica,<br />
poiché le tante intrecciate e sfilacciate linee di filiazione e parentela confonderebbero e<br />
occulterebbero il filo rosso del pensiero che le anima.<br />
D'altra parte è pur vero che metodi e scuole ancora neonati si affrontano subito a<br />
poderosi colpi di trattati e manuali nell'intento di affermare ciascuno la propria originalità e<br />
inimitabilità, e di evidenziare diversità teoriche che, a distanza, appaiono in realtà molto<br />
spesso assai poco sostanziali. Frequentemente, infatti, questi testi che si moltiplicano<br />
progressivamente, pur prendendo in polemiche prefazioni risentite distanze l'uno dall'altro,<br />
finiscono alla lettura per sembrarci quasi gemelli: uguali sono le terminologie, anche se usate con<br />
cangianti sfumature di significato, molto simili sono le lunghe sequenze di esercizi, che spesso si<br />
distinguono, ad uno studio accurato, solo per minime varianti ritmiche, e apparentemente<br />
identiche sono, infine, almeno per i primi quindici anni, le tante, insistite immagini fotografiche di<br />
cui ogni testo è puntualmente e abbondantemente corredato. In esse, fanciulle che la tecnica e la<br />
convenzione fotografica dell'epoca ci fa parere sorelle, abbigliate di identiche tuniche alla greca o<br />
di pudichi ed ampi <strong>pag</strong>liaccetti, sono ritratte in posizioni apparentemente statiche e manierate, di<br />
una grazia demodée, che vengono solitamente definite altamente dinamiche ed espressive e<br />
spesso polemicamente confrontate tra loro e distinte in buone e cattive, senza che il nostro<br />
occhio troppo smaliziato riesca a coglierne la ragione. (Si dovrà in realtà attendere lo sviluppo<br />
della fotografia istantanea e la diffusione del nudismo o di abbigliamenti più succinti nella<br />
ginnastica e nella danza, oltre che l'effettivo precisarsi delle tecniche, perché gli apparati<br />
iconografici comincino ad acquistare valore di documento discriminante).<br />
Per riferire quindi dei diversi filoni, cercando di evitare sia rigide schematizzazioni che<br />
sofistiche differenziazioni, ci muoveremo analizzando soprattutto i livelli progettuali, tentando di<br />
rendere la densità dell'insieme, ma dando spazio solo alle esperienze iniziali più chiaramente<br />
differenziate e da cui si dirameranno i percorsi più frequentati, pur con tutti i loro intrecci di<br />
influenze e contaminazioni vicendevoli.<br />
Nel primo decennio del secolo si sviluppano pressoché contemporaneamente due scuole<br />
strettamente imparentate col delsartismo americano di Genevieve Stebbins, che, assimilato e<br />
rielaborato, si radica saldamente in Germania soprattutto nell'ambito della Körperbildung<br />
128
(formazione fisica) femminile: quella che fa capo alla già citata Bess Mensendieck e quella<br />
fondata da Hade Kallmeyer.<br />
Entrambe ottime conoscitrici dei metodi di ginnastica femminile introdotti nelle scuole<br />
americane sul finire dell'Ottocento e in particolare della «ginnastica armonica» della Stebbins,<br />
di cui erano state allieve negli Stati Uniti, la Mensendieck e la Kallmeyer si differenziano<br />
sostanzialmente per l'atteggiamento di fondo che imposta i loro metodi: più attenta ad un<br />
armonico sviluppo fisico su basi medico-igieniche la prima, principalmente interessata ad una<br />
formazione fisica su basi artistiche la seconda.<br />
Il «sistema Mensendieck», che imporrà per primo alla Germania intera il principio della<br />
Körperkultur der Frau, ossia dell'educazione fisica della donna (è questo il titolo del primo e più<br />
importante testo teorico-pratico sul «sistema», che vide la prima di almeno 9 edizioni nel 1906 ),<br />
si fonda sulla parola d'ordine «forza e bellezza del corpo», dove la seconda qualità è fatta<br />
chiaramente derivare dall'acquisizione della prima. La dottoressa in medicina Mensendieck, che<br />
ammette la sua conoscenza del metodo Stebbins ma ne prende le distanze, è infatti critica<br />
verso l'eccessiva, o almeno eccessivamente evidenziata ricerca della «grazia» che a suo avviso<br />
informa i metodi delsartisti, e si mostra anche molto diffidente nei confronti degli «indigeribili<br />
condimenti metafisici» che appesantiscono le pubblicazioni e il lavoro dei seguaci americani e<br />
tedeschi di Delsarte. Impostato saldamente sul terreno della «pratica» col solo soccorso<br />
dell'anatomia e della fisiologia, il suo metodo si compone di una serie progressiva di esercizi,<br />
prevalentemente statici, per il rafforzamento della muscolatura, la buona impostazione della<br />
respirazione e una dinamica sciolta e corretta del corpo, che si giovano dell'apporto di<br />
circostanziate norme igieniche riguardanti la pulizia, l'ordine e le abitudini di vita personali. È<br />
interessante notare, al proposito, che questo sarà il primo metodo organizzato a proporre,<br />
intorno agli anni Dieci, una pressoché totale libertà negli indumenti femminili, lottando contro<br />
busti e corsetti nell'abbigliamento quotidiano e giungendo a incoraggiare la completa nudità<br />
nell'esercizio fisico.<br />
Si tratta, come la sua stessa creatrice precisa, di una «ginnastica funzionale» studiata<br />
appositamente ed esclusivamente per l'educazione fisica della donna (e della donna tedesca in<br />
particolare), al contrario di altre che si rivolgevano, almeno progettualmente, ai due sessi, e intesa a<br />
rivalutare l'importanza del corpo femminile in una cultura che pareva privilegiare solo la<br />
formazione della mente. Il suo obiettivo era di formare donne sane e belle che potessero<br />
assolvere per il meglio alle loro funzioni di future spose e madri senza necessariamente<br />
«rimetterci le forme del loro corpo, i pregi del loro corpo», in perfetto accordo con quella visione<br />
dominante del ruolo femminile cui non solo si adeguava, ma che riusciva anche a rafforzare e<br />
pro<strong>pag</strong>andare. A chiusura della introduzione del suo manuale (il più diffuso dei suoi vari testi e<br />
forse anche in assoluto di tutti quelli dello stesso tipo) la Mensendieck finisce anzi per proporre<br />
«la lotta per la bellezza» attraverso l'educazione fisica come «un dovere verso la razza».<br />
129
Questa impostazione «funzionale», sia dal punto di vista fisico che da quello ideologico,<br />
dell'educazione fisica della donna diverrà, comprensibilmente, la più diffusa e istituzionalmente<br />
riconosciuta in ambito scolastico e sportivo e costituirà l'ossatura portante della ginnastica femmi-<br />
nile in uso durante il terzo Reich. I testi dell'igienista Mensendieck diverranno pietre miliari della<br />
cultura fisica e la sua scuola si diffonderà rapidamente in tutta Europa, con potenti associazioni<br />
in Olanda (che più tardi diventerà il principale centro del «sistema»), in Austria, Svizzera, Dani-<br />
marca e persino negli Stati Uniti, da dove la sua ispirazione era partita.<br />
Al contrario della Mensendieck, Hade Kallmeyer è orgogliosa di dichiararsi, nel suo manuale<br />
di «ginnastica armonica» edito nel esplicitamente debitrice e seguace della Stebbins, di cui<br />
riprende molto fedelmente principi e tecniche e perfino il nome della disciplina propugnata. «I<br />
miei fini, dichiara nell'introduzione, sono in breve i seguenti: A: sviluppo armonico dei corpi<br />
femminili e maschili ed educazione alla bellezza del movimento; B: addestramento del corpo come<br />
strumento dell'espressione: 1. nella vita quotidiana, 2. per la scena, 3. per la rappresentazione<br />
plastica di impressioni musicali». Questa dichiarazione d'intenti chiarisce già a sufficienza<br />
l'attenzione dell'autrice per l'espressione estetica attraverso il movimento del corpo e quindi per<br />
una formazione che privilegia la bellezza, come armonico specchio esteriore della sensibilità in-<br />
terna, sulla forza puramente fisica. In sintonia con le discipline delsartiste, il «sistema Kallmeyer» si<br />
compone di una serie di esercizi armonici e costantemente dinamici in cui respiro, tensione e<br />
rilassamento muscolare vengono esercitati nel rispetto delle tre leggi «naturali» del movimento<br />
corporeo: equilibrio, opposizione, successione; ad essi poi si accom<strong>pag</strong>nano esercitazioni<br />
espressive che consistono sostanzialmente nella traduzione dinamica di singoli sentimenti e<br />
stati d'animo, spesso stimolati e guidati dall'ascolto di brani musicali. Come fondamento e<br />
supporto dell'intero metodo, la teoria `filosofica' di Delsarte: la triplicità dell'essere umano, la<br />
dinamica dei rapporti tra corpo, anima e spirito, la supremazia del «gesto» come «agente diretto»<br />
del sentimento. E questo il primo prototipo europeo documentato da una trattazione di quei<br />
tanti, futuri metodi di educazione corporea di più ambigua collocazione tra ginnastica e danza<br />
tra educazione fisica, estetica e spirituale, che si propongono e si impongono proprio per la loro<br />
dichiarazione di completezza pedagogica soprattutto per la formazione di bambini e adolescenti. La<br />
scuola della Kallmeyer - così come quella similare fondata nello stesso periodo da Elisabeth<br />
Duncan, sorella di Isadora, e come molte altre che da queste discendono - costituiranno in<br />
breve una rete di istituti privati che saranno ritenuti essenziali, a livello propedeutico, anche per<br />
quei giovani (ma di nuovo soprattutto bambine) che intenderanno passare poi allo studio della<br />
danza e di discipline teatrali.<br />
Se la ginnastica «funzionale» della Mensendieck agisce nettamente nel sociale e quella<br />
«armonica» della Kallmeyer intrattiene rapporti solo mediati con l'espressione artistica, la<br />
«ritmica» di Jaques-Dalcroze, nata nell'ambito della pedagogia infantile, e la «danza libera» di<br />
130
Rudolf von Laban, frutto della ricerca artistica, avranno un peso determinante anche nel teatro<br />
della loro epoca.<br />
Viennese di nascita, svizzero per nazionalità, con studi svolti tra Ginevra, Parigi e Vienna<br />
ed esperienze giovanili di teatro, Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) nasce come musicista,<br />
compositore di canzoni e sonate spesso particolarmente dedicate al mondo infantile. La sua<br />
vocazione si rivela però ben presto prevalentemente pedagogica; professore al conservatorio<br />
ginevrino dal 1892, il suo interesse si volge subito alla ricerca dei metodi migliori per sviluppare il<br />
senso del ritmo e la musicalità nei ragazzi, il cui apprendimento della musica secondo i sistemi<br />
tradizionali gli pare forzato e di estrema lentezza. Prende così pian piano forma la sua idea<br />
della «ritmica», disciplina pedagogica che, per educare alla musica, coinvolge non più soltanto<br />
l'udito, ma l'intero corpo dell'allievo. Nel 1898 il suo pensiero deve ancora trovare la via<br />
consapevole dell'attuazione pratica, ma è già sufficientemente definito e risente chiaramente<br />
della lezione delsartiana appresa in Francia (e che rimarrà in lui ben viva e cosciente):<br />
“Ed eccomi a sognare un'educazione musicale nella quale il corpo farebbe la parte<br />
d'intermediario fra i suoni e il nostro pensiero, diventando così lo strumento diretto dei nostri<br />
sentimenti [...] Il fanciullo dunque, a scuola, non imparerebbe solo a cantare e ad ascoltare<br />
con giustezza ed in tempo, ma a muoversi e a pensare esattamente e con ritmo. Si<br />
incomincerebbe col regolare il meccanismo del passo, e si collegherebbero i movimenti<br />
vocali ai gesti del corpo intero; e sarebbe ad un tempo, un'istruzione per il ritmo, ed<br />
un'educazione per mezzo del ritmo ....”<br />
Nel 1904 i primi elementi della sua ginnastica basata sulla traduzione fisica dei ritmi<br />
musicali saranno già definiti e sperimentati e Dalcroze inizierà una lunga serie di conferenze e di<br />
dimostrazioni del proprio metodo che lo renderà presto ben noto in tutta Europa.<br />
Dalla primitiva serie di esercizi ritmici eseguiti con braccia e gambe per favorire<br />
l'affinamento dell'«orecchio interiore» dei bambini e la loro «presa di coscienza del ritmo»<br />
attraverso il «senso ritmico muscolare», fino a sfociare nel «sentimento estetico, generatore<br />
dell'emozione», egli passa ad elaborare un vero e proprio sistema pedagogico complessivo,<br />
l'«euritmica», che verrà perfezionata all'inizio del secondo decennio del secolo. Sulla base del<br />
ritmo e della metrica musicali essa si propone di «sviluppare il sentimento musicale (nel senso<br />
greco della parola) nell'organismo tutto intero; creare il senso dell'ordine e dell'equilibrio dopo<br />
aver risvegliato tutti gli istinti motori; sviluppare le facoltà immaginative ».<br />
Il ritmo è dunque a fondamento di tutto il suo metodo pedagogico:<br />
131
1. Il ritmo è movimento. 2. Il movimento è di essenza fisica. 3. Ogni movimento<br />
esige spazio e tempo. 4. L'esperienza fisica forma la coscienza musicale. 5. Il<br />
perfezionamento dei mezzi fisici ha per conseguenza la chiarezza della percezione. 6. Il<br />
perfezionamento dei movimenti nel tempo assicura la coscienza del ritmo musicale. 7. Il<br />
perfezionamento dei movimenti nello spazio assicura la coscienza del ritmo plastico. 8. Il<br />
perfezionamento dei movimenti nel tempo e nello spazio può solo essere acquistato con<br />
esercizi di ginnastica detta ritmica.<br />
La «ginnastica ritmica» sarà lo strumento principe per trasformare il ritmo in movimento<br />
cosciente, per conseguire «lo sviluppo degli istinti ritmici e metrici, del senso dell'armonia plastica,<br />
dell'equilibrio dei movimenti e per la regolazione delle abitudini del movimento», per sviluppare cioè<br />
sia il «senso del ritmo musicale» che il «senso del ritmo plastico», ottenendo «il perfezionamento<br />
della forza e della elasticità dei muscoli in proporzione al tempo e allo spazio (musica e plastica)». Il<br />
modello estetico è ancora, più che mai, quello greco; è quella mitica «orchestica» che, afferma<br />
Dalcroze, già prima di lui Grétry, Gluck, Schiller, Goethe e Wagner (e l'impronta di<br />
quest'ultimo informa alla base il suo pensiero) avevano tentato di creare, pratica sociale ed<br />
artistica, segno dell'equilibrio e dell'unione indissolubile presso i greci di spirito e corpo.<br />
Ma la concezione ritmica dell'educazione estetica di Dalcroze non avrebbe probabilmente<br />
raggiunto una così chiara definizione né inciso tanto profondamente in campo teatrale senza<br />
l'apporto, la cui portata è difficilmente calcolabile ma fu certo notevole, di Adolphe Appia. Dalcroze<br />
conobbe Appia nel 1906, dopo che già nel 1903, durante l'organizzazione da lui curata a<br />
Losanna dell'imponente Festival valdese, una grande festa popolare coreografico-musicale, aveva<br />
potuto intravvedere i rapporti profondi che la sua ricerca rivelava con i problemi della coreografia<br />
e dell'espressione attorica. Appia, che aveva assistito a Ginevra ad una dimostrazione di<br />
«ritmica», scrisse a Dalcroze di aver riconosciuto nel suo lavoro la prima autentica possibilità di<br />
«esteriorizzazione della musica [...] l'idea di cui io vivo da lunghi anni». Da quel momento si creò<br />
tra il musicista-pedagogo e l'autore de La musique et la mise en scène un sodalizio di idee e di<br />
studio singolare e intenso, in cui Appia fu l'interlocutore - consigliere e ispiratore - per lo più na-<br />
scosto e schivo, mentre Dalcroze fu lo sperimentatore audace, l'uomo pubblico e l'abile<br />
pro<strong>pag</strong>andista. La visione ritmica dello spazio di Appia contribuì fortemente alla definizione<br />
plastica di quei primi esercizi di movimento, che da supporto alla comprensione della musica<br />
nella sua dimensione temporale si andavano facendo strumenti sempre più consapevoli di una<br />
traduzione espressiva degli elementi musicali nello spazio attraverso il corpo umano, mentre la<br />
concezione totalizzante del teatro dell'ideatore del Worttondrama, fece sì che alla musica e al<br />
gesto si affiancassero nella ricerca, sempre con maggior organicità, il canto e la parola.<br />
La grande occasione di realizzare il loro sogno pedagogico e artistico si presentò ai due<br />
maestri con l'intervento di Wolf Dohrn, ricco intellettuale tedesco, segretario del Werkbund,<br />
132
un'associazione di artisti artigiani e industriali progressisti sorta in Germania nel 1908, sulla<br />
spinta della Lebensreform, per una riumanizzazione del lavoro industriato e la ricerca di una<br />
nuova dignità estetica e sociale delle arti applicate alla vita quotidiana". In questo ambito<br />
Dohrn aveva promosso la costruzione ad Hellerau, alla periferia di Dresda, di un insediamento<br />
residenziale modello per le maestranze operaie, la prima «città giardino» realizzata in Germania.<br />
Qui egli propose a Dalcroze di edificare una scuola, fornita di tutti i servizi e gli strumenti<br />
necessari, in cui egli potesse sviluppare ed applicare i suoi metodi pedagogici, facendo di Hellerau<br />
un centro culturale all'avanguardia, una sorta di utopia sociale realizzata (e il pensiero era fisso alla<br />
«provincia pedagogica» del Wilhelm Meister di Goethe), «il futuro centro per una rigenerazione<br />
spirituale e fisica, da cui procederebbe un vasto rinnovamento sociale»` Nella primavera del 1911<br />
l'edificio progettato dal giovane e promettente architetto Tessenow fu terminato e Dalcroze, che<br />
dimessosi dal conservatorio di Ginevra, dall'autunno precedente aveva tenuto i suoi corsi in una<br />
sede provvisoria di Dresda, vi si insediò con una solenne cerimonia pubblica. L'edificio, la cui<br />
facciata riprendeva quella di un tempio ellenico, comprendeva, oltre a parecchi spazi per le varie<br />
lezioni, una grande sala centrale rettangolare per la quale Appia disegnò un dispositivo modulare<br />
composto di una larga gradinata con piattaforme praticabili, che scandiva ritmicamente lo spazio<br />
per gli esercizi ritmici e le dimostrazioni pubbliche. All'edificio centrale era annesso un pensionato<br />
che comprendeva gli alloggi e le sale da pranzo e di ritrovo per gli allievi che venissero<br />
dall'esterno.<br />
Questi accorsero immediatamente da ogni parte della Germania e d'Europa: oltre alle<br />
classi per i bambini e i giovani di Hellerau e di Dresda furono infatti subito istituiti corsi per<br />
amatori e professionisti della danza, del teatro drammatico e lirico, della ginnastica, per artisti<br />
ed educatori. All'apertura della scuola esistevano corsi regolari di solfeggio, improvvisazione,<br />
anatomia, musica corale, plastica animata, danza ed euritmica, e ad essi presto si affiancarono<br />
insegnamenti che riguardavano anche la parola. La ritmica si era ormai molto organicamente<br />
sviluppata dal tempo dei primi tentativi ginevrini e continuava giorno per giorno ad affinarsi. Se<br />
allora si trattava in fondo di attuare una specie di solfeggio figurato, animato, che coinvolgeva<br />
fisicamente il ragazzo nella sottolineatura del tempo musicale, ora a questi esercizi iniziali se ne<br />
affiancavano molti altri più complessi e che soprattutto implicavano una sempre maggiore<br />
promozione di dinamiche fisiche e spirituali. Sempre seguendo scrupolosamente il ritmo e la<br />
metrica di piccoli brani composti dal maestro e suonati al pianoforte, gli allievi eseguono ora<br />
esercizi ritmici per la respirazione, il rafforzamento dei muscoli, l'analisi di ritmo tempo e<br />
spazio nelle andature, per lo sviluppo delle azioni spontanee e la regolazione dei movimenti<br />
inconsci, per l'espressione in tempo musicale dei sentimenti, per l'unione del canto e della<br />
parola al movimento. La libera improvvisazione ritmica guidata dalla musica è uno dei primi<br />
passi nell'addestramento euritmico e la danza ritmica espressiva ne è il risultato finale.<br />
Sempre, la musica regna sovrana, dirige, detta, ispira, forma.<br />
133
“Lo scopo dell'insegnamento della ritmica è di mettere gli allievi in condizione di dire<br />
alla fine dei loro studi non «io so» ma «io sento», e inseguito di creare in loro il desiderio<br />
di esprimersi. Poiché quando si prova fortemente un'emozione, si sente il bisogno di<br />
comunicarla agli altri nella misura delle proprie facoltà. Quanto più noi possediamo la vita,<br />
tanto più noi saremo in grado di diffondere la vita intorno a noi. Ricevere, dare; tale è la<br />
grande regola dell'umanità. E se tutto il sistema d'educazione per mezzo del ritmo si<br />
appoggia sulla musica, si è che la musica è una forza psichica considerevole, una risultante<br />
delle funzioni dell'anima e dell'espressione che, per il suo potere di eccitazione e di re-<br />
golarizzazione, può disciplinare tutte le nostre funzioni vitali”.<br />
Nel suo secondo anno di vita (1911-12) la scuola di Hellerau era già nota nel mondo; il<br />
pensionato traboccava di allievi e molti altri ne ospitavano le famiglie del villaggio. Nell'attuazione<br />
del processo pedagogico si rivelava importante anche il sistema di vita collegiale, che esaltava,<br />
accomunandoli, intenti e volontà. Nel pensionato, che ospitava una cinquantina di ragazze di<br />
ogni nazionalità, regnava, secondo i testimoni, un'atmosfera festosa, eccitata, piena di<br />
entusiasmo e di impegno. I pranzi, prevalentemente vegetariani, si consumavano insieme ai<br />
ragazzi, che pernottavano altrove, discutendo animatamente del lavoro comune. La sera si<br />
improvvisavano danze e canti nella sala da pranzo liberata dai tavoli; si leggevano gli stessi libri,<br />
si amavano le stesse cose e, soprattutto, si idolatrava il maestro che affascinava tutti col suo<br />
notevole carisma: un'esperienza comune davvero ap<strong>pag</strong>ante.<br />
Mentre gli allievi più maturi aprivano le prime scuole del «metodo Dalcroze» a Londra,<br />
Berlino, Francoforte, Praga, Budapest, Riga, Mosca, Pietroburgo (il patrono per la Russia fu<br />
l'entusiasta principe Volkonskij, soprintendente dei teatri imperiali, che organizzò una tournée<br />
russa di Dalcroze in cui egli conobbe Stanislavskij e poté vedere l'Amleto con la scenografia di<br />
Craig), i visitatori giungevano ad Hellerau da ogni dove quasi in pellegrinaggio. Tra il 1910 e il '13<br />
è forse sufficiente citare uomini di teatro come lo stesso Stanislavskij, George Pitoéff, Djaghilev e<br />
Nijinskj, Claudel, J. Rouché, Reinhardt, Jessner, Percy Ingham (che fonderà la scuola Dalcroze<br />
inglese), GranvilleBarker, scrittori come G.B. Shaw, Upton Sinclair ed Ernst Bloch, critici come<br />
Jean d'Udine, e ancora artisti, intellettuali, pedagogisti, autorità civili, che sarebbe troppo lungo<br />
enumerare.<br />
Nel 1912 e nel 1913, al termine dell'anno scolastico, Dalcroze organizzò con i suoi<br />
allievi due grandi «saggi» che sarebbero passati alla storia del teatro e avrebbero influenzato<br />
per anni registi e coreografi. Il punto più alto dell'elaborazione estetica di Dalcroze e di Appia<br />
verrà raggiunto con la presentazione al pubblico, nel giugno del 1913, dell’Orfeo di Gluck, di cui<br />
alcuni frammenti erano già stati mostrati l'anno precedente insieme con vari esercizi ritmici e<br />
con la pantomima Eco e Narciso. Avvalendosi dei dispositivi scenici e delle luci ideate da Appia (che<br />
pure non si mosse da Ginevra e non vide la propria opera), con due cantanti professionisti nei ruoli<br />
principali e il coro dei suoi allievi, Dalcroze seppe creare ciò che quasi unanimemente fu ritenuta la<br />
134
perfetta trasposizione scenica della musica di Gluck. Fu il trionfo della sua concezione di «plastica<br />
animata» o «plastica vivente», la disciplina più dichiaratamente estetica e`teatrale' tra quelle<br />
sperimentate nella scuola: quell'arte del movimento espressivo i cui elementi Dalcroze intendeva<br />
corrispondenti a quelli della musica (l'elevazione dei suoni alla direzione dei gesti, l'intensità alla<br />
energia, il timbro alle particolarità formali dovute al sesso, la melodia alla sequenza dei<br />
movimenti, e così via)". Tutti i maggiori critici teatrali d'Europa erano presenti all'evento<br />
insieme con molte delle personalità già citate, e i commenti si accesero di entusiasmo. Pochi<br />
stralci possono essere sufficienti a renderne il tono:<br />
“È un'unione di musica, senso plastico, e luce, di cui non avevo mai visto<br />
l'uguale [...] le tele dipinte, i puntelli, tutti i ridicoli ingombri del vecchio teatro sono<br />
spazzati via; ogni cosa è rimpiazzata da un'architettura che dà le linee essenziali all'azione<br />
drammatica e fissa il corso e la direzione lungo cui essa si sviluppa (Paul Claudel). Ci<br />
trovavamo di fronte alla vita reale, tradotta nella musica, splendida musica, che diveniva<br />
vivente. Non avrebbe potuto essere altrimenti, perché tutti gli esecutori erano posseduti<br />
dalla musica fisicamente ed emozionalmente: la musica era per loro un principio vitale come<br />
l'atto del respirare (Serge Volkonskij). Ci si dimentica facilmente che l'istituto di Hellerau è<br />
una scuola [...] ma questa è la loro attività quotidiana, il loro sforzo per un ideale di arte<br />
umana vivente; l'espressione sacra della loro anima individuale e collettiva [...] e da questo<br />
la rappresentazione di Orfeo riceve tutto il suo valore e significato umano (H.C. Bonifas).”<br />
Per almeno due decenni l'Orfeo di Hellerau sarà presente nella mente e negli scritti degli<br />
uomini di teatro come il momento memorabile e irripetibile in cui fu annientata la consunta ma<br />
tenace convenzione naturalista che dominava le scene contemporane e fu aperto per un<br />
attimo uno squarcio abbagliante sulla realtà, finora solo sognata, di un teatro nuovo e tuttavia<br />
capace di recuperare un'antica, mitica, obliata perfezione estetica: la fusione completa di tutti i<br />
suoi elementi sotto la guida di un unico principio ordinatore in un'opera d'arte totale.<br />
La travolgente e gloriosa stagione della «provincia pedagogica» di Hellerau, che<br />
parve a molti incarnare il vero spirito della riforma estetico-pedagogica di una nuova Germania<br />
traducendo in pratica tangibile l'insegnamento dei grandi maestri, da Rousseau a Lessing,<br />
da Goethe a Wagner, fu però assai breve. All'inizio del 1914 il mecenate Wolf Dohrn scomparve<br />
prematuramente e da parte sua Dalcroze si rese inviso al Reich per una dichiarazione pacifista: la<br />
guerra alle porte accelerò la chiusura dell'istituto ed egli tornò definitivamente a Ginevra, dove<br />
impiantò un centro tuttora esistente e funzionante. Di qui la sua ritmica si diffuse in tutto il<br />
mondo; molte scuole pubbliche e private l'assunsero a metodo per l'insegnamento della musica e<br />
della motricità e per la terapia dei disturbi dell'udito e del movimento, e il nome di Dalcroze<br />
cominciò ad essere citato tra quelli dei maggiori pedagogisti non soltanto del suo tempo (e con uno<br />
di loro, Edouard Claparède, egli collaborò attivamente).<br />
135
I suoi contatti col mondo del teatro continuarono per molti anni: intrattenne una lunga<br />
e fitta corrispondenza con Appia, benché il loro sodalizio intellettuale non desse più frutti<br />
chiaramente tangibili, ed ebbe, tra gli altri, rapporti con Copeau e con Craig, anche se mentre<br />
nel primo suscitò interesse ed ammirazione, il secondo mantenne sempre verso di lui un<br />
atteggiamento fortemente critico. Ma la sua influenza agì ancor più direttamente, come è facil-<br />
mente comprensibile, nel campo delle arti del movimento. In Germania soprattutto, dato il<br />
terreno particolarmente favorevole, il suo metodo si radicò profondamente nell'ambito della<br />
Körperkultur; dalla sua si staccarono altre scuole di «ginnastica ritmica» (definizione ormai acquisita<br />
nel linguaggio comune), che svilupparono proprie tendenze più o meno originali. La più famosa e<br />
più diffusa di esse sarà quella del dottor Rudolf Bode, che fondava la sua diversità su un contrasto<br />
evidenziato tra ritmica e metrica musicale (in Dalcroze pressoché coincidenti), su un uso della<br />
musica più «di accom<strong>pag</strong>namento», su una maggiore centralità del movimento e del ritmo<br />
individuali. Allievi più fedeli ed ortodossi diffusero il «metodo Dalcroze» in ogni città tedesca e un<br />
corso formativo di ritmica divenne ben presto non solo il fiore all'occhiello di ogni fanciulla della<br />
buona società illuminata, ma anche lo studio propedeutico più consono per gli aspiranti attori e<br />
danzatori dell'epoca. Non mancarono tuttavia insegnanti che coltivarono nei loro allievi<br />
autonome presunzioni artistiche, e questo provocò, nel dopoguerra, il dilagare sulle scene di<br />
giovani ritmiciennes che offrivano come danza le loro esercitazioni e improvvisazioni. Questo<br />
fece sì che una tecnica formativa di grande interesse (che aveva ad esempio trovato posto sta-<br />
bile nella com<strong>pag</strong>nia dei Balletti russi di Djaghilev e aveva guidato Nijinski nella sua coreografia<br />
della Sagra della primavera), snaturata in autonoma forma teatrale, incontrasse la dura<br />
opposizione di alcuni critici di danza (e non soltanto tra quelli legati alla tradizione accademica e<br />
alle nette divisioni dei generi) e contribuisse ad instaurare in loro un senso di diffidenza verso<br />
ogni moderna sperimentazione nel campo dell'arte del movimento. Il più accanito, con punte<br />
che sfioravano il sarcasmo, fu certo Andrej Levinson, forse il maggior critico istituzionale<br />
europeo del momento, che, se non discuteva la ritmica come metodo propedeutico, ne<br />
deprecava la confusione con una disciplina di alta professionalità (e per lui di intoccabile tradi-<br />
zione) come la danza. Nella sua caustica polemica - cui Dalcroze rispose personalmente -<br />
contro ciò che chiamava ”l'utopia ritmica», Levinson considerava un ritmico «simile ad un<br />
danzatore come lo è un metronomo ad uno strumento musicale», lamentava che la ritmica<br />
rendesse il movimento schiavo della musica anziché fare esattamente il contrario e rivendicava<br />
l'attributo di arte alla sola danza classica, l'unica con una «evoluzione organica, uno sviluppo lo-<br />
gico di un linguaggio organico di forme». E nelle sue parole troviamo riassunte in breve le<br />
obiezioni suscitate nella critica dalle nuove discipline ritmiche, soprattutto in Francia e in Italia,<br />
roccaforti della tradizione accademica; se da un lato esse rivelano l'incapacità di intuire dai<br />
primi suoni articolati la nascita di un nuovo linguaggio, dall'altro esprimono giusta insofferenza per<br />
l'equivoca confusione tra training e spettacolo, tra solfeggio del movimento e danza.<br />
136
Ma una nuova arte della danza stava tuttavia nascendo e si sarebbe affermata di lì a<br />
poco. Negli stessi anni di Hellerau, infatti, un'altra sperimentazione, che nasce questa volta<br />
dall'interno del teatro e ad esso fa ritorno dopo aver attraversato territori pedagogici, si<br />
impone all'attenzione. A guidarla è l'ungherese Rudolf Laban de Varalja (1878-1958), che in<br />
Germania assumerà il cognome di von Laban.<br />
Figlio di un alto ufficiale, cresciuto fra le marce e le parate militari da un lato e il mondo<br />
fantastico dell'immaginario popolare ungherese dall'altro, fu portato fin dall'infanzia alle attività<br />
artistiche. Si dedicò originariamente alla pittura, disciplina che non abbandonò mai<br />
completamente e che sviluppò in lui un'alta sensibilità figurativa e per il rapporto spazio-forma,<br />
ma ben presto sperimentò anche la poesia, la musica e il teatro drammatico. Organizzando fe-<br />
ste militari e paesane si accostò ai problemi del movimento corale, dell'uso dinamico dello<br />
spazio, della danza. Studente di belle arti a Parigi, ebbe per insegnante un allievo di Delsarte<br />
che lo iniziò all'«estetica applicata» del maestro; su questa scorta intraprese, già nel 1903,<br />
ricerche sulla dinamica e l'espressione del corpo e si interessò alle danze primitive, religiose,<br />
rituali, completando poi la sua formazione con studi di danza accademica a Vienna e a Monaco.<br />
In quest'ultima città a stretto contatto con l'ambiente culturale d'avanguardia dei<br />
«secessionisti», maturò le proprie scelte espressive individuando nella danza il proprio campo<br />
elettivo di esperienza. A questa scelta e alle sue motivazioni teoriche non fu certo estraneo<br />
l'influsso di Georg Fuchs che a Monaco agiva in quegli stessi anni al Künstlertheater e le cui<br />
radicali teorizzazioni in fatto di estetica teatrale agirono potentemente sul teatro, sulla nascita<br />
della «nuova danza» tedesca e sull'intera Weltanschauung della Körperkultur. Conviene<br />
richiamare brevemente almeno qualche punto di queste teorie forse ancora non<br />
sufficientemente acquisite da noi, per meglio comprendere la loro relazione con l'opera di<br />
Laban e indicare un possibile (pur se soltanto ideale) rapporto Fuchs-Laban accostabile a quello<br />
AppiaDalcroze (dove la collaborazione fu reale).<br />
Per Fuchs, erede diretto di Nietzsche, la danza, «movimento ritmico del corpo nello<br />
spazio, esercitato nell'impulso creativo a un'esperienza in sé armonica dell'universo» - di cui il<br />
teatro deve sostanziarsi per ritrovare la propria funzione - si realizza come arte in uno stato dioni-<br />
siaco di profonda estasi orgiastica, allorché l'abbandono totale al proprio io profondo permette<br />
una dilatazione mistica nel tutto universale. Perso nel ritmico fluire del proprio sangue, il<br />
danzatore/attore (quest'ultimo arricchisce la danza con la parola poetica che traduce in ritmo<br />
contenuti e valori spirituali) vive l'esperienza interiore (Erlebnis) della fusione con la «divina<br />
euritmia» cosmica, divenendo celebrante di un rito dinamico di ascesi e di comunione col divino,<br />
che trascina con sé chi vi assiste. Profondamente suggestionato dalle dimostrazioni di Madeleine,<br />
la danzatrice ipnotica, Fuchs aveva salutato in lei la prova vivente dell'efficacia creativa della<br />
trance, dimostrazione dell'origine dell'arte nel territorio sconfinato che inizia dove finisce la<br />
coscienza individuale, e la riproposta di un teatro «cultuale».<br />
137
Perché questa capacità ritmico-espressiva possa affermarsi di nuovo, Fuchs auspica<br />
l'avvento di una ancora sconosciuta «Körperkultur», una cultura del corpo liberato nel movimento<br />
così da divenire «mezzo di espressione cultuale e artistico».<br />
Poiché le opere fondamentali di Fuchs - da Die Schaubühne der Zukunft (1905) a Der<br />
Tanz, da Deutsche Form (1907) a Die Revolution des Theaters (1909) - vennero tutte pubblicate<br />
entro il primo decennio del secolo, furono conosciute e discusse non soltanto da Laban ma da<br />
tutti coloro che iniziavano ad operare, spesso proprio sulla loro scorta, nell'ambito della<br />
Körperkultur, anche se vengono citate nei loro scritti meno spesso di quanto ci si potrebbe<br />
aspettare.<br />
Rudolf von Laban, dunque, raccolto intorno a sé un gruppetto di giovani artisti e allievi, si<br />
dedicò alla ricerca di una nuova forma di danza pura, non descrittiva, che scaturisse come<br />
espressione dinamica organizzata dell'essere profondo dell'individuo e della collettività, dei<br />
loro bisogni, della loro fede nella vita. La sua ricerca perseguì infatti sempre due scopi<br />
paralleli: da un lato liberare l'individuo nel fisico e nello spirito, renderlo capace di esprimere diret-<br />
tamente e senza impedimenti, in un movimento che porti alle conseguenze estreme le<br />
proprie leggi naturali, la propria forma e il proprio essere elevati a poesia; dall'altro accordare gli<br />
individui così liberati in un grande «tempio danzante», un «coro di movimento» che<br />
armonizzasse e moltiplicasse in un tutto inscindibile le diverse individualità, sublimando in una<br />
unità trascendente gli elementi comuni.<br />
Deciso a raggiungere entrambi i suoi fini, prima ancora di fondare una scuola fondò una<br />
comunità, convinto che soltanto una vita davvero comunitaria, in cui ciascuno assolvesse ai suoi<br />
compiti per la collettività e condividesse con gli altri problemi e aspirazioni, avrebbe potuto creare<br />
la consonanza intima degli spiriti su cui fondare la nuova «poesia del movimento».<br />
Si insediarono, dall'estate del 1913, sul versante svizzero del lago Maggiore, a Monte<br />
Verità, luogo a noi già noto, dedicato alla Lebensreform. Negli stessi anni in cui Hellerau riempiva le<br />
cronache culturali accentrando su di sé l'interesse pedagogico, la scuola-colonia di Laban, che du-<br />
rante l'inverno agiva a Monaco, conduceva silenziosamente, in modo appartato e quasi<br />
inosservato, con l'assillo quotidiano della sopravvivenza, la sua esperienza fondante. A una vita<br />
semplice e povera a stretto contatto con la natura, si affiancava il lavoro gioioso ma rigoroso<br />
degli allievi sul corpo e sull'espressività svolto all'aria aperta, con tuniche leggere o in piena<br />
nudità, in armonia coi ritmi naturali e fisiologici. Nacque così la prima concretizzazione organica<br />
della ricerca labaniana, la «danza libera», prima matrice della danza moderna europea e fulcro di<br />
un'ulteriore, radicale visione pedagogico-teatrale: liberazione ed elevazione psico-fisica in cui il<br />
movimento è privilegiato come «agente diretto dell'anima» (secondo quanto aveva insegnato<br />
Delsarte) individuale e collettiva, e in cui l'intelletto, che Laban traduce in «volontà»,<br />
amministra in piena coscienza il rapporto fondamentale dell'energia fisica col tempo e con lo<br />
spazio.<br />
138
La danza «libera», non è secondo il suo creatore né anarchica, né velleitaria, ma obbedisce<br />
soltanto, e scrupolosamente, a leggi dinamiche e semiotiche proprie, da lei stessa dettate e<br />
rispettate; dopo un iniziale momento di liberatorio affrancamento dai condizionamenti delle<br />
convenzioni sociali e artistiche, costituisce, anzi, un'esperienza formativa intensa e<br />
totalizzante sia dal punto di vista professionale che da quello più genericamente pedagogico.<br />
Poiché non ha bisogno della musica come guida (e anzi sostanzialmente la rifiuta, come principio<br />
regolatore estraneo a se stessa), ma trae i suoi ritmi direttamente da quelli corporei<br />
dell'esecutore (battito cardiaco, respiro, flussi energetici), la danza libera pretende da lui una<br />
perfetta conoscenza e comprensione di se stesso, del proprio corpo e delle sue leggi. Solo<br />
così egli potrà condurre l'energia racchiusa nel movimento a produrre, nell'unità di spazio e<br />
tempo, una totalità dinamico-espressiva del tutto autosufficiente e significativa. Questo implica,<br />
per Laban, una rigorosa concezione della forma nella danza, che si sviluppa, come e persino<br />
meglio della musica, attraverso simmetrie, ripetizioni, inversioni, ritornelli, tempi, armonie e<br />
disarmonie, sfumature dinamiche, organizzazione architettonica (per citare solo alcuni degli<br />
elementi formali in gioco), dalla cui coerenza, purezza e rigore nasce la valenza (e il piacere) etica<br />
ed estetica della danza.<br />
Di qui la necessità sostanziale di una completa teoria del movimento (Kraft-Raum-Zeit,<br />
ossia Energia-Spazio-Tempo) che penetri le forze e le tensioni motorie che animano il corpo<br />
(Kraft), individui i criteri della loro direzione ed espansione nello spazio (Raum) - anche secondo<br />
principi semiotici derivati dalle leggi naturali dell'espressione gestuale (eucinetica) - e determini<br />
e fissi i ritmi dell'interazione energia/spazio e delle sue risultanti dinamiche (Zeit). L'indagine<br />
sull'energia e lo sforzo nel movimento, sui sistemi vettoriali di spinte e direzioni che esso crea e<br />
sul loro rapporto col tempo e con lo spazio, costituisce l'impegno più costante e noto di Laban che<br />
giungerà ad elaborare una «scienza» del movimento il cui portato più universalmente acquisito<br />
sarà un sistema di scrittura della danza (Labanotation) esatto come quello musicale.<br />
La laboriosa e complessa scoperta delle leggi proprie della nuova danza procede nella<br />
scuola di Laban di pari passo con l"invenzione' di un corpo `consapevole'. Improvvisazioni ed<br />
esercizi dinamici soprattutto collettivi permettono di comprendere e guidare i flussi di energia<br />
dominati dai fattori fondamentali di «tensione» e «rilassamento», di distinguere tra movimenti<br />
«centripeti» e «centrifughi», tra «impulsi», «tensioni» e «slanci», tra equilibri, disequilibri e<br />
successioni, di dominare cioè la creazione e l'uso di un articolato livello pre-espressivo del<br />
movimento. La dimensione corale delle esercitazioni contribuisce a sviluppare il senso dello spazio,<br />
della interazione dinamica, del disegno complessivo del movimento (coreutica), nonché a<br />
padroneggiare i ritmi personali e di gruppo. Il livello espressivo, l'immissione di «significati» (che<br />
nulla hanno a che vedere con concezioni pantomimiche o descrittive) si innesta su questa<br />
preparazione di fondo e trasforma il movimento in danza facendogli acquistare quella dimensione<br />
metaforica, poetica, che lo rende «forma trascendentale dell'essere umano».<br />
139
E un processo di graduale e costante introspezione e addestramento psicofisico<br />
dell'individuo, che deve imparare a liberare e trasfondere nel movimento la propria intera uma-<br />
nità. Per aiutare questo percorso Laban parte spesso da nuclei dinamici e simbolici primitivi,<br />
come i gesti del gioco, del lavoro manuale e della preghiera, ritenuti più antropologicamente<br />
idonei ad una amplificazione e stilizzazione spaziotemporale che si carichi di virtualità poetiche<br />
trascendenti.<br />
La musica intesa come misura dei tempi e ispirazione dei modi esterni all'individuo, che era<br />
il supporto fondamentale di tutta la ritmica, non può avere con questo processo estetico-<br />
pedagogico rapporti diretti, ma solo subordinati e anche assai tardivi. All'inizio infatti la ricerca<br />
si svolge in silenzio, attenta solo ai ritmi interiori; in un secondo tempo, quando l'allievo abbia<br />
ben acquisito la coscienza dei propri ritmi, essi possono essere accom<strong>pag</strong>nati e sottolineati da<br />
colpi di strumenti a percussione (di solito tamburelli) che incitano il movimento e aiutano la<br />
concentrazione; solo in una fase molto avanzata, quando l'allievo non rischia più di usare la<br />
musica «come una stampella», imitandola e lasciandosene guidare, può con prudenza<br />
esercitarsi con essa. Il danzatore completo farà nascere da se stesso la propria musica, che ri-<br />
fletterà non solo il ritmo, ma anche la tonalità e l'armonia della danza e che acquisirà così nuove<br />
possibilità tecniche ed espressive. Il traguardo da raggiungere è la fusione perfetta di danza e<br />
musica rigenerate da una nuova concezione globale dell'uomo.<br />
Un atteggiamento simile Laban mantiene rispetto alla relazione tra danza e parola. Il<br />
suo amore per le arti dell'uomo lo porta infatti costantemente a ricercare, accanto alla danza<br />
libera, una creazione espressiva totale che egli definisce con le parole Tanz-Ton-Wort, danza-<br />
suono-parola. In assonanza, e in contrasto, con i teorici dell'opera d'arte totale, da Wagner ad<br />
Appia, egli aspira ad un'arte teatrale che affondi le sue radici nella totalità triadica delle forze<br />
espressive umane (Delsarte), ma in cui l'elemento dominante e unificante sia la danza (Fuchs),<br />
regno precipuo di quell'energia umana e cosmica che non solo produce movimento e suono, ma si<br />
spiritualizza fino ad entrare nel mondo dei concetti producendo la parola. In vista di questa meta<br />
finale, dello sviluppo di capacità espressive globali che possano fondere corpo e intelletto,<br />
dionisiaco e apollineo, e tendano ad una nuova concezione drammatica e drammaturgica del<br />
teatro e, più in generale, ad una nuova pienezza etico estetica della vita umana, nelle scuole di<br />
Monte Verità e di Monaco si studiano, accanto alla danza, canto, dizione, musica, poesia, pittura e<br />
scultura, secondo principi similari.<br />
Il fine originario di Laban era, e rimaneva, il rinnovamento dell'arte teatrale, ma la<br />
ricerca gli aveva aperto possibilità e territori ben più vasti:<br />
“La nuova arte della danza dà la consapevolezza di produrre valenze etiche al contrario<br />
della valenza solo esteriormente estetica della vecchia danza teatrale. Inoltre viene<br />
perseguito e conquistato uno sviluppo armonico generale dell'organismo prettamente<br />
140
naturale, attraverso un sistema formativo del corpo e dello spirito non sentimentalistico. Certi<br />
quadri mostrano i concetti `abbigliamento, movimento, scena' come forme spaziali interagenti<br />
tra loro. Che qui, senza riferimenti pantomimico-letterari, si proponga soltanto il linguaggio<br />
della forma, del colore, dello spazio, del movimento può essere anche una caratteristica dei<br />
miei tentativi precedenti. Ora io passo all'uomo stesso e al gruppo. Il passato e il presente co-<br />
stituiscono uno sforzo verso la semplificazione e l'interiorizzazione dell'arte, che dipende<br />
strettamente dal nostro bisogno comune di rigenerazione culturale. [...] Io mi dedico alla<br />
direzione della scuola e insieme in particolare proprio all'arte del movimento e ai territori di<br />
confine. Ad Ascona tutti gli ambiti dell'espressione e dell'attività umana debbono venire<br />
liberati dalla zavorra di una concezione sentimentalistica della vita e dell'arte: la danza libera<br />
di una vita bella.”<br />
I primi allievi-com<strong>pag</strong>ni di Laban formarono ben presto la sua direzione e il suo apporto<br />
coreografico un gruppo professionale che costituiva un laboratorio di ricerca vivente sulla danza<br />
teatrale; ma alla sua scuola, che durante la guerra si spostò da Monaco a Zurigo, e a quelle che<br />
dopo il conflitto aprirono anche i suoi allievi, accorsero bambini e dilettanti di ogni età, verso i<br />
quali mostrò identica sollecitudine. Essi gli fornivano l'opportunità di concretizzare e sperimentare<br />
la sua grande vocazione “corale”, di tradurre cioè in pratica attiva e calare nel sociale la sua<br />
utopia etico-estetica di «tempio danzante»: una comunità umana rigenerata nel corpo e nello spirito<br />
che trovi nella danza l'espressione sublimata della sua essenza fisica, emotiva e intellettuale. In<br />
essa i singoli avrebbero dovuto fondersi umanamente ed artisticamente, rintracciando dentro di<br />
sé, in quella «terra del silenzio» in cui l'io individuale tace e regna la voce dell'umanità, le pulsioni<br />
comuni che, liberate in energia e ritmo nella danza, avrebbero fatto di loro l'autentica «cattedrale<br />
dell'avvenire», trasformando il teatro in rituale festivo (e le consonanze chiamano in causa tanto<br />
Fuchs quanto Appia col quale Laban condivide la terminologia).<br />
Nacque così il concetto e la pratica del «coro di movimento», il Bewegungschor che Laban<br />
sviluppò per anni, portandolo a singolari livelli di realizzazione e diffusione soprattutto tra i<br />
dilettanti. I cori di movimento costituirono negli anni Venti una delle forme più interessanti della<br />
Körperkultur, certo l'unica con caratteristiche espressive che fosse ampiamente praticata da<br />
adulti di sesso maschile, tanto nell'ambito del movimento giovanile borghese che in quello<br />
associazionistico dei lavoratori. L'efficacia spettacolare e sociale dei suoi cori fu sperimentata da<br />
Laban nella coreografia di grandi feste popolari in cui faceva muovere gruppi e masse (spesso di<br />
operai o artigiani) partendo dai gesti e dai ritmi del lavoro di ognuno, stilizzandoli e armo-<br />
nizzandoli tra di loro in enormi concerti semoventi, esperienza che si rivelò preziosa anche per il<br />
suo lavoro teatrale, particolarmente per le coreografie innovative che creò per i teatri d'opera,<br />
sulle tracce del suo Tanz-Ton-Wort, l'opera d'arte totale.<br />
141
Semiignorato e a volte stroncato dalla critica nei primi anni (fatta eccezione per il<br />
lungimirante e appassionato sostegno che fin dall'inizio gli offrì il giovane emergente Hans<br />
Brandenburg), soltanto alla fine della guerra Laban cominciò realmente ad imporsi nel mondo<br />
teatrale e in quello pedagogico, che, entrambi, avevano maturato nel frattempo nuove<br />
consapevolezze ideologiche e metodologiche. Proseguì e intensificò allora la sua doppia attività di<br />
ricercatore pedagogo e di creatore coreografo (egli stesso danzò per anni, finché un infortunio<br />
di palcoscenico glielo impedì), fondando e dirigendo scuole e cori e lavorando tra entusiasmi<br />
e incomprensioni presso molti dei maggiori teatri tedeschi, fino ad ottenere intorno agli anni<br />
Trenta una sorta di canonizzazione artistica nei due principali templi del melodramma: il teatro<br />
wagneriano di Bayreuth e l'Opera di Berlino. Giunse così ad imporre pian piano, anche<br />
attraverso gli allievi, la sua danza libera come la “nuova danza» tedesca e la sua concezione<br />
psicofisica del movimento nello spazio come principio pedagogico eminente. Trovò poi in alcuni<br />
dei suoi allievi, come Mary Wigman e Kurt Jooss - certo le figure di maggior rilievo della nuova<br />
danza - i traduttori e gli elaboratori più creativi delle sue teorie, la cui inevitabile dose di<br />
infedeltà metodologica era eclissata e superata da eccezionali capacità espressive ed artistiche<br />
individuali. Formò una schiera di ottimi insegnanti di danza e di danzatori, ma con lui<br />
assaporarono il gusto e il dominio del movimento espressivo anche interi villaggi, battaglioni<br />
militari, maestranze delle fabbriche, gruppi sportivi, oltre a migliaia di bambini in età scolare.<br />
Contrastato, anche per la sua dichiarata appartenenza alla massoneria, dalle istituzioni naziste con<br />
le quali aveva inizialmente tentato di convivere, emigrò nel 1936 dapprima in Francia e poi<br />
definitivamente in Inghilterra. Qui fondò a Manchester uno studio per l'arte del movimento, in<br />
cui si dedicò prevalentemente all'applicazione dei suoi principi formativi alla scuola e al<br />
mondo del lavoro, ambiti su cui riversava le sue grandi speranze in una vocazione popolare<br />
all'eucinetica, sviluppando ulteriormente la sua ricerca sullo sforzo e il ritmo nel movimento e<br />
perfezionando il suo metodo di scrittura della danza. Il Laban Centre per il movimento e la<br />
danza, con sede a Londra, amministra e diffonde tuttora la sua eredità.<br />
Dalcroze e von Laban sono fuor di dubbio i due teorici e ricercatori dell'ambito della<br />
Körperkultur che più incisero e influirono sul teatro del loro tempo e su quello futuro. Sono<br />
inoltre l'esempio più eclatante della connessione profonda tra pedagogia e teatro instauratasi in<br />
quegli anni e di cui essi stessi, l'insegnante e il teatrante che paiono scambiarsi i reciproci ruoli,<br />
furono tra i principali promotori. Le loro visioni del movimento espressivo come fulcro della<br />
formazione dell'uomo e dell'artista prima ancora che come linguaggio teatrale, pur nascendo dallo<br />
stesso bisogno di rigenerazione ed elevazione psicofisica, si divaricavano alla radice per gli inte-<br />
ressi diversi che guidavano i modi della loro attuazione.<br />
Dalcroze, che proveniva dagli studi musicali e rispecchiava con ortodossia quel pensiero<br />
estetico germanico che discende in linea diretta da Schopenhauer (attraverso Wagner e Appia)<br />
faceva derivare e dipendere il movimento dalla musica, che ne dettava i ritmi, i significati, le forme,<br />
142
ne scandiva lo spazio e ne prescriveva le leggi. L'uomo armonioso che sognava di creare era il<br />
perfetto traduttore nel tempo e nello spazio di un'essenza ritmica universale, trascendente, che la<br />
musica soltanto poteva distillare e trasmettergli come guida: uomo dunque come strumento<br />
sensibile e ben temperato ma reso vivo e vibrante solo attraverso la musica che lo anima e che<br />
egli trasmette, secondo un processo che subordina l'arte dell'espressione fisica a quella<br />
dell'espressione musicale. Von Laban invece, formatosi nella temperie delle avanguardie pre-<br />
espressioniste, erede di una linea estetica Nietzsche-Fuchs, poneva all'origine e al centro del<br />
processo dinamico espressivo solo l'uomo nella sua totalità psicofisica e da esso soltanto faceva<br />
discendere i modi, i significati e le leggi del movimento. Il suo uomo nuovo traduceva in<br />
manifestazione ritmica esclusivamente i propri impulsi e i propri ritmi fisiologici, emotivi e intellettuali,<br />
era creatore, mezzo e norma della propria danza, espressione non mediata dell'armonia della sua<br />
vita e strumento di accordo sintonico con quella universale.<br />
Queste diverse visioni, che si tradussero spesso banalmente in polemiche tra i seguaci, i<br />
critici e gli estimatori delle due scuole, che opponevano troppo semplicisticamente il primato<br />
della musica a quello della danza e viceversa, analizzate più da vicino mostrano alla base due di-<br />
versi atteggiamenti pedagogici e ideologici. Dalcroze, proveniente dall'insegnamento (e da quello<br />
della musica in particolare), persegue fondamentalmente una didattica per l'educazione<br />
all'armonia psicofisica dell'individuo e dunque sperimenta nuovi e creativi modi di trasmissione -<br />
, e funzionali alle nuove esigenze pedagogiche - di un patrimonio artistico e culturale di valore<br />
acquisito (la musica); Laban, proviene dall’arte (e dal teatro in primo luogo), si studia di provocare<br />
un processo pedagogico per la formazione dell'individuo nell'armonia psicofisica e quindi crea le<br />
circostanze, gli stimoli, le tecniche attraverso i quali possa nascere la manifestazione armonica<br />
di un nuovo patrimonio di conoscenze (la danza). Dalcroze pare di conseguenza esprimere una<br />
tendenza più sostanzialmente riformista: un illuminato e geniale riformismo, capace di rigenerare<br />
e rendere innovativamente fertili elementi della tradizione, mentre Laban fa trasparire un'ottica<br />
più decisamente rivoluzionaria, poiché si mostra orientato a fondare una nuova tradizione.<br />
In campo pedagogico queste tendenze divergenti si verificano con manifesta chiarezza nei<br />
risultati: da Dalcroze discende un vero e proprio «metodo» d'insegnamento, diffondibile su larga<br />
scala anche a livello scolastico istituzionale; da Laban un atteggiamento pedagogico che può<br />
fruttificare solo in situazione laboratoriale e assume caratteri diversi a seconda dei maestri che lo<br />
praticano.<br />
In campo teatrale si traducono in poetiche coerenti che trovano risonanza in ambiti<br />
diversi. Dalcroze si fece fautore di un principio ordinatore unitario per l'opera d'arte teatrale, di<br />
una scansione ritmica preordinata dell'espressione estetica, cui ogni elemento scenico deve<br />
duttilmente rispondere, che furono ideale e sostanziale punto di riferimento per il nascente<br />
teatro della regia. Von Laban fu il sostenitore di un'arte teatrale in sé globale e unitaria perché<br />
fondata sulla liberazione e l'autoregolazione della creatività individuale e collettiva, cui<br />
143
guardarono i movimenti di avanguardia (in primo luogo gli espressionisti, ma anche i dadaisti"<br />
prima, e i surrealisti poi) e tutti quegli artisti ricercatori che tentavano di rifondare il teatro come<br />
espressione diretta degli uomini che lo facevano (attori o danzatori). In ambedue i casi,<br />
comunque, la proposta per il teatro era estetica ed etica insieme, ma mentre nel primo la va-<br />
lenza etica si generava dalla adesione volontaria ad una concezione estetica totalizzante a priori,<br />
nel secondo era il valore estetico a nascere da una volontaria ricerca etica.<br />
Negli anni tra il '10 e il '20 il problema di una «kunstlerische Körperbildung», ossia della<br />
formazione fisica dell'individuo sotto il segno dell'arte, diviene in Germania un impegno<br />
pedagogico-sociale di importanza primaria. Lo stesso Ministero dell'educazione, pressato dalle<br />
richieste dei circoli giovanili e della parte più progressista del corpo insegnante, patrocinò varie<br />
iniziative, mentre le «province pedagogiche», quasi sempre autogestite e organizzate privata-<br />
mente e collettivamente, si moltiplicarono in tutto il paese. Nacquero così, decentrati nel verde<br />
delle cam<strong>pag</strong>ne, numerosi e specializzati centri di formazione e scuole sperimentali in cui<br />
ginnastica ritmica e danza ebbero ruoli fondamentali. Per citare soltanto gli esempi più illustri, a<br />
Wickersdorf Martin Luserke, pedagogista di vaglia e saggista, direttore della rivista «Freie<br />
Schüle», nel suo Freier Schulgemeinde (Libera comunità scolastica) sperimenta metodi<br />
pedagogici avanzati e utilizza la ritmica dalcroziana e la danza come indispensabile<br />
fondamento di espressione estetica del bambino nella sua formazione scolastica"; allo Schloss<br />
Bieberstein presso Fulda nasce il Seminar fur Klassische Gymnastik, centro di formazione che<br />
utilizza un metodo sviluppato sul modello greco e appoggiato ad un rigoroso studio anatomico;<br />
Rudolf Bode impianta a Monaco il suo istituto di ritmica in polemica col suo maestro<br />
Dalcroze; Elisabeth Duncan, dopo aver guidato fin dal 1904 una scuola sostanzialmente<br />
delsartista a Berlino, si trasferisce in provincia, fondando un istituto permanente in un castello nei<br />
pressi di Darmstadt.<br />
E non sono da dimenticare, per una visione più complessiva del fenomeno, altre esperienze<br />
contigue, pur se di ambito diverso. Proprio in quegli anni Rudolf Steiner andava definendo in<br />
Svizzera con gruppi di seguaci e allievi della Società antroposofica la nuova arte dinamica dell'Eu-<br />
ritmia, «parola visibile», in cui, come in Dalcroze la musica, la parola e il suo suono dettavano al<br />
corpo il ritmo del movimento, e, poco dopo, George J. Gurdjieff fondava un istituto-monastero in<br />
cui ginnastica e danza erano strumento di liberazione dalle emozioni individuali e di ascesi e che<br />
mantenne stretti legami con i dalcroziani. Queste discipline, entrambe di carattere esoterico,<br />
pur non conoscendo la diffusione generalizzata di quelle di origine pedagogica o teatrale, furono<br />
conosciute e seguite nel loro evolversi dai ricercatori della Körperkultur ed ebbero un influsso<br />
sottile ma penetrante soprattutto nella costruzione della vera e propria «filosofia della danza»<br />
che si sviluppò negli anni Dieci.<br />
La guerra interrompe soltanto brevemente, o meglio rallenta sensibilmente, la<br />
progressiva diffusione della cultura fisica in Germania, ma contemporaneamente ne favorisce,<br />
144
con la forzata emigrazione temporanea di molti maestri, la pro<strong>pag</strong>azione nei paesi limitrofi, in<br />
Svizzera soprattutto, la cui neutralità offre un asilo sicuro, ma anche in Olanda e nei Paesi<br />
Bassi, in Austria e perfino nel Nord America. Alla fine del conflitto tuttavia, nel clima democratico e<br />
aperto alla sperimentazione della cultura di Weimar, la Körperkultur, rafforzata e precisata<br />
dall'esperienza in terra straniera, esplode rigogliosa e durante gli anni della repubblica costituirà<br />
un punto di forza e una preoccupazione costante per chiunque si occuperà di problemi<br />
educativi e sociali. Il movimento giovanile poi, attraverso i suoi rami associativi come il<br />
Wandervogel e la Freideutsche Jugend ne farà il centro della propria azione, sviluppandone sia il<br />
versante formativo che quello artistico.<br />
Caratteristico di tutto il movimento per la cultura del corpo fu di essere accom<strong>pag</strong>nato e<br />
sostenuto da una vastissima letteratura, che avrebbe permesso ad alcuni editori non soltanto<br />
di fondare riviste o collane, ma addirittura di specializzarsi completamente in questo filone<br />
ottenendo successo economico e benemerenze sociali. A scrivere sono in primo luogo gli<br />
stessi protagonisti, i maestri e i pedagoghi di ginnastica e danza, che espongono le proprie<br />
teorie e illustrano i propri metodi; poi, attivi come raramente capita di vedere, i critici e gli<br />
studiosi, intellettuali che testimoniano fiancheggiano interpretano ordinano gli eventi e le<br />
esperienze, dialogano con gli sperimentatori, prendono partito per l'uno o per l'altro<br />
esponendosi personalmente, spesso partecipano alle attività o elaborano teorizzazioni, rivelando<br />
un atteggiamento davvero `organico' al movimento (e riesce difficile rintracciare voci<br />
dissenzienti di valore rilevante). Alcuni di essi, come Hans Brandenburg, Fritz Winther, Hans<br />
Hackman, risultano nei primi tempi fondamentali per la proposizione, la chiarificazione e la<br />
discussione di temi e problemi che nell'ambito della pratica non trovano sempre adeguata<br />
consapevolezza teorica; e questo benché sia consuetudine anche delle trattazioni più tecniche<br />
essere accom<strong>pag</strong>nate da dissertazioni di tipoteorico o addirittura filosofeggiante, comprensibili<br />
d’altronde là dove si elabora una disciplina che ambisce affondare le proprie radici in un campo<br />
speculativo universale come è quello della natura dell'essere umano e della sua formazione ed<br />
espressione.<br />
Alcuni dei primi studi diverranno veri e propri breviari, continuamente citati e quasi<br />
venerati da chi negli anni successivi operi o rifletta nel campo della Körperbildung (e fonti<br />
im<strong>pag</strong>abili per chi studia oggi); primo fra tutti, per il suo carattere teorico generale e la<br />
panoramica critica che imposta su tutte le esperienze e le idee pedagogiche contemporanee in<br />
fatto di ginnastica e danza, Körperbildung als Kunst und Pflicht (Formazione fisica come arte e<br />
dovere) di Fritz H. Winther, apparso nel 1914 e che conoscerà in seguito numerose edizioni<br />
rivedute ed aggiornate, affiancato, sul versante più decisamente artistico e teatrale, da Der mo-<br />
derne Tanz di Hans Brandenburg (prima edizione 1913, poi ampliato nel '17 e nel '21), che<br />
appassionatamente indaga e precorre l'evolversi della ritmica e della nuova danza tedesca<br />
attraverso una militanza personale e un'acuta sensibilità estetica epocale. Ad essi occorre<br />
145
aggiungere, in ambito speculativo-filosofico, Die Wiedergeburt der Tanz-und Gesangskunst aus<br />
dem Geiste der Natur (La rinascita dell'arte della danza e del canto dallo spirito della natura)<br />
di Hans Hackman, del 1918. È significativo osservare come quasi tutti i testi specialistici o<br />
divulgativi del primo periodo, dei quali pare superfluo dar conto qui dettagliatamente, sia che il<br />
titolo paia dedicarli espressamente alla cultura fisica, alla danza o alla ginnastica, trattino in realtà<br />
di ciascuno di questi filoni fertilmente unificati sotto la spinta di tensioni che, intrecciando il fine<br />
etico a quello estetico, impediscono ancora la forzata separatezza dei generi.<br />
Intorno al 1920 è infatti ormai consolidato nel pensiero pedagogico come in quello<br />
artistico (e anche sempre più comunemente accettato nella cultura media) il concetto di un<br />
legame indissolubile tra corpo ed anima (Seele), e tra espressione e formazione fisica e spirituale,<br />
specchio della connessione naturale della triade corpo-anima-intelletto. In particolare il movimento,<br />
riconosciuto ormai come manifestazione fisica diretta dell'anima oltre che strumento di<br />
consonanza con la natura, si fa sempre più mezzo espressivo, e il lavoro di ricerca e di<br />
perfezionamento artistico del movimento espressivo è insieme crescita spirituale e psichica.<br />
E del 1921 uno dei testi più significativi a questo proposito, forse quello più<br />
consapevolmente divulgativo di questi principi e da cui difficilmente la cultura del corpo<br />
prescinderà d'ora in poi in sede teorica, Die Entwicklung der Seelenkrafte als Grundlage der<br />
Körperkultur (Lo sviluppo delle forze spirituali come fondamento della cultura del corpo) di<br />
Hans Hackmann, che vi sviluppa in senso più strettamente pedagogico i temi già proposti nel<br />
suo precedente e già citato saggio. Viene qui ripreso il dettato delsartiano delle tre espressioni<br />
umane come manifestazione sensibile delle tre parti costitutive della persona; parola, voce,<br />
movimento, sotto le tre specie artistiche di recitazione, canto e danza (o ginnastica ritmica),<br />
sono strumenti fondamentali, in unione ad una contemporanea educazione del volere del<br />
sentire e dell'immaginare e all'esperienza delle leggi dello spirito, per il percorso verso<br />
l'agognata «verità» di una formazione fisica e spirituale «nel senso dello spirito della natura». Ciò<br />
comporta naturalmente una faticosa ricerca su se stessi, i cui fini appaiono in partenza lontani e<br />
incerti, che impone uno sforzo etico costante e che accomuna discepolo e maestro in una<br />
sorta di “educazione permanente” il cui valore risiede più nel percorso da compiere che nel<br />
raggiungimento di una meta. Le parole di Lessing, su cui il libro si chiude, possono costituire il<br />
motto di tanti laboratori e scuole di quegli anni e ne riassumono l'atteggiamento: «Non la verità,<br />
di cui un uomo è, o crede di essere in possesso, ma lo sforzo sincero che egli ha fatto per scoprire<br />
la verità, fa il valore dell'uomo. Perché non attraverso il possesso, ma attraverso la ricerca della<br />
verità si espandono quelle forze, nelle quali consiste la sua sempre crescente perfezione».<br />
Su queste basi si conia, all'inizio del nuovo decennio, la vera parola d'ordine della cultura<br />
del corpo per gli anni Venti, Körperseele, l'«anima del corpo» o, come ci piace tradurre, il<br />
«corpo-anima». E qui inizia a farsi davvero determinante l'influsso della «nuova danza»<br />
teatrale, che di questo neologismo si va configurando come espressione vivente.<br />
146
Dopo gli anni di guerra aveva infatti preso decise forme e consistenza quella nuova danza<br />
tedesca (cui la ricerca di Laban dava sostanza teorica e tecnica e una serie di talenti e<br />
personalità individuali la necessaria base psicofisica), che si autodefiniva «espressionismo<br />
dell'anima», dove il termine espressionismo sta per «la più concertata manifestazione della<br />
nostra intima e profonda esperienza interiore, la creazione dell'io che dà e prende forma»,<br />
secondo la definizione di Werner Shur, critico contemporaneo di estrema autorevolezza.<br />
Spesso, su queste basi, la danza rivendicava una vocazione mistica, un carattere di sacralità<br />
che ne esaltava il senso di ascesi spirituale, assumendo a volte il colore dell'estasi, a volte<br />
quello della magia". Fritz Böhme, critico sensibilissimo, nel suo importante Der Tanz der Zukunft<br />
del 1929, espone con grande lirismo e passione laWeltanschauung mistica della nuova danza nel<br />
momento della sua più matura definizione, condensando definitivamente in essa il filone più<br />
suggestivo del pensiero precedente. La danza ha un ruolo unico e primario tra le arti.<br />
«Nelle altre arti Dio si riversa nell'uomo; nella danza è l'uomo che fluisce dal suo interno<br />
verso Dio, che si eleva fino a Dio». A permetterglielo è il movimento, che mette in rapporto la sfera<br />
dell'Io attraverso l'adesione alle leggi naturali del moto e dello spazio, con il principio motore del<br />
cosmo. La danza è dunque «esperienza del cosmo come forma del movimento». Per questo nella<br />
vera danza (quella che egli auspica per il futuro e per la quale propone come punti fissi di<br />
riferimento la ricerca di Laban, la prassi della Wigman, il Triadische Ballet di Schlemmer e l'uso<br />
musicale della luce e dei colori da poco sperimentato col nome di Farblichtmusik) non può esistere<br />
pantomima, né mimesi, né virtuosismo, ma solo la capacità personale di farsi penetrare dal ritmo<br />
cosmico, elevarsi con esso e trascinare con sé gli spettatori. La danza diviene così un «servizio<br />
sacro» da compiere in tutta umiltà, mettendo a disposizione del rapporto dell'umanità con la<br />
divinità la propria anima e il proprio corpo.<br />
Sacrale o profana, al di là delle varie esecuzioni, delle tecniche e degli stili personali come<br />
dei contenuti emotivi e intellettuali, a danza è comunque il regno incontrastato della Körperseele, il<br />
corpo agito dallo spirito, l’espressione fisica dell'anima dell’individuo (Ausdrucktanz). E il teatro si<br />
fa in questo caso punta avanzata di una sperimentazione che ha le radici nel sociale, e campo di<br />
collaudo dei prototipi più perfezionati della progettazione di una nuova umanità. Tra teatro e<br />
sociale il rapporto tradizionale si modifica, muta la sostanza della loro dialettica. Non più soltanto<br />
teatro come rispecchiamento, interpretazione artistica o critica della realtà, ma proposta vivente di<br />
modi e strumenti per una nuova possibiile realtà, esperienza vissuta dell'artista e vivibile da ogni<br />
uomo. Nell’ansia del proprio rinnovamento il teatro attinge dal sociale, fondendosi in esso, una<br />
dimensione forse dimenticata o forse mai conosciuta prima in questi termini di pratica di vita, quella<br />
etica della ricerca, dell' autoripensamento e della rifondazione non solo nell' ambito delle forme e<br />
dei contenuti, ma soprattutto in quello del senso e dei fini del proprio esistere. Il sociale,<br />
d'altra parte, riceve dal teatro che si va rivitalizzando stimoli teorici ed esempi trainanti,<br />
tanto più efficaci in quanto emanazioni dirette e pro<strong>pag</strong>gini esplorative di una sua stessa tensione<br />
147
formativa.<br />
La nuova danza, nella sua accezione più propriamente teatrale, è di nuovo un fenomeno<br />
eminentemente femminile, e questo per almeno i due ordini di problemi già ricordati e legati<br />
all'intero senso della riforma della cultura fisica in atto: da un lato l'esclusione della donna dalle<br />
iniziative comitali della Jugendbewegung, che lasciava libere – o permetteva loro soltanto - di<br />
incanalare in direzione estetica e in termini maggiormente individuali le proprie pulsioni liberatorie<br />
e le proprie potenzialità creative; dall' altro lato la maggiore propensione della personalità<br />
femminile verso un tipo di attività espressiva che non teme di portare allo scoperto anche i risvolti<br />
istintivi e irrazionali dell' essere e anzi ne fa uso cosciente. Se dunque la teoria della danza fu<br />
appannaggio maschile, la più eminente pratica artistica - fatte le dovute eccezioni almeno per Max<br />
Terpis, Kurt Joos e Harald Kreutzberg - è legata a nomi di donna, dalle pioniere come Sent<br />
M'ahesa, le sorelle Wiesenthal, Gertrud Leistikow, alle sorelle Falke, a Niddy Impekoven a<br />
Charlotte Bara a Dussia Bereska a Valeska Gert a Gret Palucca, fino alla più grande di tutte, Mary<br />
Wigman.<br />
Coerentemente al carattere individualistico della danza espressiva, queste artiste danzano<br />
quasi esclusivamente come soliste, mostrano decise caratterizzazioni stilistiche, dispiegano forti<br />
personalità sceniche. Elaborano, sulla base dei fondamenti labaniani e/o dalcroziani, tecniche<br />
personali, colorandole dei riflessi visibili della propria 'anima' individuale: conoscenze, credenze,<br />
suggestioni, miti, tabù Ma nella danza dinamica ed emotiva di questo nuovo teatro dell'io si<br />
ripercuotono e affiorano di volta in volta come influenze e motivazioni primarie formali e<br />
contenutistiche anche i temi, le aspirazioni, le mode, le ossessioni della cultura artistica del<br />
momento, filtrati e trascelti dalla inclinazione personale, in una iridescente varietà ed eterogeneità<br />
di soluzioni che hanno in comune il credo della libertà espressiva.<br />
Convivono così sulle scene, in una stagione della danza e del teatro la cui fertilità e<br />
creatività è forse più presente nella prassi artistica novecentesca che nella riflessione critica,<br />
danze oscure e silenziose, popolate di fantasmi di: vita e di morte, irte di gesti spezzati e doloranti,<br />
che traducono il grido espressionista di una psiche generazionale lacerata dalle paure e<br />
dall'impotenza (Wigman); danze esoteriche o esotistiche che riprendono e manipolano i temi<br />
orientali o ricostruiscono la classicità estranea e bidimensionale delle immagini dell' antico danzare<br />
egizio o assiro, sull’onda della passione per i rituali alieni (M'ahesa, Hegesa); danze mistiche e<br />
spirituali, traboccanti di religiosità più o meno ortodossa, composizioni gotiche di estasi e<br />
rapimento che sfiorano appena il suolo e rispecchiano il bisogno di una sublimazione di una fisicità<br />
redenta (Bara); danze di puro dinamismo ed esuberanza fisica, scatenate nel salto e nella corsa,<br />
esaltazione estetica del mito del corpo liberato e sovrano (Impekoven, Palucca); danze ritmiche e<br />
composte, traduzione armonica e mitizzata della riconquistata grecità dei bassorilievi, regno di<br />
simmetrie aggraziate e di tuniche morbidamente ondeggianti (rhytmiciennes); danze aeree e<br />
luminose, palpitanti di gonne, sciarpe, veli iridescenti alla luce del sole o dei fari, voli di magiche<br />
148
farfalle e uccelli del paradiso avvolti in folate di walzer, sogno caramellato di un abbraccio con la<br />
natura (Wiesenthal, Leistikov). E, accanto a queste, le poche ma interessanti danze corali<br />
femminili o maschili, che riproducono scale di intensità del movimento espressivo simili a<br />
crescendo musicali, geometriche e scandite, percorse da vettori di spinte contrapposte, gioco dina-<br />
mico e statico di simmetrie e opposizioni, territorio sperimentale di nuove dinamiche collettive e di<br />
nuove ritualità sociali (cori Laban e Wigman).<br />
I pochi altri elementi, al di là del corpo del danzatore, chiamati in gioco nell' esecuzione<br />
teatrale sono altrettanto differenziati. La musica schiera tutti i generi e dispiega tutti i livelli: dall'<br />
assenza totale in molte danze del silenzio, al battito ritmico e primitivo di tamburi e percussioni, ai<br />
motivi popolari, alle nenie esotiche, ai «lieder», alle classiche sonate per pianoforte, ai romantici<br />
valzer viennesi, ai grandi brani sinfonici, alle musiche delle avanguardie, a quelle composte sui<br />
dettati ritmici del movimento. La scena è generalmente spoglia, nuda, contornata da panneggi o<br />
pannelli, spazio neutro da definire e far vivere attraverso le linee del movimento. Il costume<br />
rispecchia e sottolinea il carattere della danza, al servizio del corpo e dell' espressione: tuniche<br />
lievi che liberano ed esaltano i movimenti lunghe vesti ieratiche laminate d'oro e di porpora che<br />
propiziano misteriosi rituali, grotteschi paludamenti stregoneschi che deformano le membra, grandi<br />
ali lucenti e vibranti di gigantesche farfalle, fasce, drappeggi e acconciature uscite dalle tombe<br />
egizie, amplissime gonne plissettate e roteanti; abolito ogni armamentario tradizionale del balletto,<br />
le gambe sono nude e così molto spesso i piedi e le braccia. Quasi assolutamente assente dalla.<br />
scena il nudo integrale, ampiamente praticato invece dai danzatori, e forse ancor più dai dilettanti,<br />
negli esercizi all' aria aperta, e adottato spesso nei servizi fotografici. A volte, soprattutto in ambito<br />
più prettamente espressionista, vengono usate maschere per il viso, grottesche e deformi oppure<br />
immote e impenetrabili per lasciare tutta l'espressività al corpo.<br />
I modi tecnici ed esecutivi della nuova danza, pur se altamente personalizzati, derivano<br />
chiaramente dai maestriteorici, dall' esempio delle pioniere e da una ricerca individuale in cui<br />
spesso un ruolo determinante è lasciato all'autodidattismo, all'improvvisazione, alla spontaneità ad<br />
oltranza, soprattutto se sostenute dalla fantasia e da una forte presenza scenica. La ricerca<br />
accanita del nuovo, propria di tutta la sperimentazione artistica di Weimar, e dell"originario-<br />
naturale', tipica della Körperkultur, se offrono possibilità di manifestazione e di cimento a molti<br />
nuovi talenti anche giovanissimi e ricchi di Naivität, finiscono infatti col dare talvolta anche alimento<br />
a una certa approssimazione tecnica e stilistica e al cattivo gusto, mentre la facilità di effimeri<br />
successi nuoce in alcuni casi alla serietà della ricerca.<br />
I linea generale la nuova danza si compone di libere sequenze dinamiche che si avvalgono<br />
ampiamente delle leggi di opposizione e successione dei movimenti definite da Laban e del<br />
principio generale dell’ afflusso e riflusso dell'energia che Mary Wigman, la più rigorosa ricercatrice<br />
tra le danzatrici, esprimerà con i termini Anspannung/Ab-spannung (e che contemporaneamente in<br />
America Martha Graham definirà contraction-release) e che rimarrà a fondamento di tutta la danza<br />
149
moderna. E una danza spesso aspra e imprevedibile, di una forte emotività che .nasce dall'uso<br />
drammatico del corpo e dell’energia, ricca di salti, cadute, contrasti di direzione, gesti spezzati,<br />
disequilibri, aderente a terra ma all'improvviso scagliata verso l'alto, in cui ogni elemento statico,<br />
dinamico, semiotico e prossemico è mobilitato per la massima estrinsecazione espressiva del<br />
movimento in sé e in rapporto allo spazio, spazio sentito a volte come materia informe da<br />
plasmare, a volte come vero e proprio nemico da combattere.<br />
Forte della sua rispondenza a tanta speculazione estetica contemporanea, la nuova danza<br />
conquista presto una posizione di rilievo nel teatro. Nella seconda metà degli anni Venti compete<br />
ormai con quella accademica e la sua avvincente poetica teatral-rituale fa nascere persino progetti<br />
di edifici appositamente studiati per contenerla. Mary Wigman e la sua com<strong>pag</strong>nia femminile sono<br />
già un mito; Laban viene chiamato nel 1930 a Bayreuth (glorificazione di ogni coreografo) e al<br />
Teatro di stato di Berlino; la danza tedesca si esporta in Europa e nel mondo attraverso tournées<br />
artistiche e fondazione di scuole, particolarmente negli Stati Uniti dove l'incontro con la «modern<br />
dance» americana stimola scambi e influenze reciproche.<br />
La necessità di trasmettere e tramandare la propria esperienza professionalmente e su<br />
larga scala, oltre a incentivare il rigoroso lavoro di ricerca e di codificazione di Laban intorno ad un<br />
sistema di scrittura che permettesse di fissare creazioni tanto personali come quelle della danza<br />
libera, rese anche indispensabile la riflessione sulle tecniche usate e una loro definizione, insieme<br />
alla strutturazione di metodiche per l'insegnamento che, pur salvaguardando per quanto possibile<br />
la ricerca individuale, correvano necessariamente il rischio di soffocare una parte delle valenze au-<br />
tocreative della nuova danza. Danzatrici e danzatori della<br />
terza generazione seguivano ormai una scuola, uno stile, un genere. Una nuova tradizione<br />
teatrale era fondata e si insediava col suo supporto di norme, codici, convenzioni sempre meglio<br />
definentesi.<br />
Se il teatro tornava a staccarsi dal sociale, a ricostituirsi in istituzione artistica e culturale<br />
separata, si lasciava però dietro le spoglie di un grande incontro: tecniche soprattutto, a livello<br />
tangibile, ma anche atteggiamenti e bisogni pedagogici diffusi, ormai introiettati e quasi dimentichi<br />
dei principi e dei bisogni cui avevano originariamente risposto.<br />
La danza e la ginnastica formative, ormai divise come 'generi' ma ancora solidali nelle<br />
intenzioni, procedono di pari passo e si diffondono con progressione impressionante per tutti gli<br />
anni Venti. La cultura del corpo ha vinto la sua battaglia e la formazione fisica è ormai sentita come<br />
un dovere verso se stessi e verso le nuove generazioni, non solo in vista di un giovamento<br />
individuale ma come percorso verso il rafforzamento dell'umanità, della nazione, della razza o<br />
della classe, a seconda delle tendenze. Nel 1925/26 un film che subito divenne famoso, Wege zu<br />
Kraft und Schönheit, (Sentieri della forza e della bellezza) prodotto dall'UFA, la potente casa<br />
cinematografica nazionale tedesca, spazzerà via anche le ultime resistenze. In una sorta di<br />
150
esaltante apoteosi documentaria il film presentava ricostruzioni storiche dei giochi ginnici dell'<br />
antica Grecia accanto a moderne sequenze di sport, danza, ginnastica, escursionismo attraverso<br />
immagini popolate da una gioventù traboccante vitalità, da corpi nudi e dinamici immersi nella<br />
natura, da bambini pieni di salute e di allegria: una società modello offerta e imposta all'imitazione<br />
per un fiorente avvrnire del paese. La diffusione e il successo di questo film di pro<strong>pag</strong>anda che<br />
sanciva l'ufficializzazione anche statale della Körperkultur, toccarono ogni angolo della Germania e<br />
ogni classe sociale e valsero a conquistare definitivamente la pubblica opinione.<br />
Nel frattempo prendeva corpo il grande impianto organizzativo e commerciale della cultura<br />
fisica. I maestri delle sempre più numerose scuole di ritmica e danza ormai esistenti nel paese si<br />
univano in associazioni di carattere non più soltanto culturale ma anche sindacale; organizzavano<br />
corsi di specializzazione per l'insegnamento, seminari, pubblici dibattiti, convegni, ne pubblicavano<br />
gli atti e stampavano annuari e almanacchi di categoria spesso prestigiosi e dispendiosi. Le<br />
pubblicazioni divulgative continuavano a moltiplicarsi, nascevano e prosperavano riviste<br />
specializzate mentre molte altre inauguravano rubriche fisse.<br />
Possiamo tendenzialmente indicare intorno al 1926 lo zenith della traiettoria ascendente<br />
ideale dello spirito della Körperkultur nei termini finora individuati. Anche la riflessione teorica<br />
complessiva sembra raggiungere in questo momento il suo livello più maturo e lucido; in seguito gli<br />
studi svoltano significativamente verso la sistematizzazione dell'esistente, l'inquadramento storico,<br />
le rassegne retrospettive. D'ora in poi subentrerà la normalizzazione e la routine: la Körperkultur si<br />
istituzionalizza in una solida e sempre più efficiente rete di diffusione capillare di medio livello e in<br />
metodi ormai differenziati e consolidati dalla prassi.<br />
I capiscuola dell'anteguerra avevano generato allievi e allievi di allievi; le «scuole» principali<br />
possedevano, sul finire del terzo decennio, catene di istituti diramati un po' ovunque. Per avere<br />
un'idea approssimativa di questa diffusione, basta gettare un'occhiata all'elenco ufficiale delle<br />
scuole regolarmente autorizzate per l'anno 1929 alla «formazione fisica di bambini e adulti<br />
attraverso la danza» nella sola città di Berlino, pubblicato dal Collegio scolastico provinciale, che<br />
ne enumera ben 151 e non comprende le istituzioni più propriamente ginniche. Mentre avanza<br />
irresistibile l'efficientismo di mercato, decadono altrettanto irresistibilmente nella Körperkultur lo<br />
spirito di ricerca, il sentimento unitario, il bisogno d'isolamento, l'utopia esperienziale - artistica ed<br />
esistenziale - dei giorni delle origini; prendono il sopravvento la moda, la pro<strong>pag</strong>anda e un gene-<br />
ralizzato e massificante conformismo.<br />
Del resto la società andava cambiando i sogni, i bisogni, i progetti. Da un lato la grande<br />
stagione culturale delle utopie etiche ed estetiche dell' espressionismo, della Körperseele, era alla<br />
fine; la borghese Neue Sachlichkeit riportava l'accento sull’oggettività, su un nuovo realismo, e an-<br />
che il marxismo rivoluzionario sposava a normalizzazione opaca del realismo socialista. Dall' altro<br />
la nuova ritualità sociale elaborava forme di 'liturgia' di massa all'insegna di una crescente<br />
spersonalizzazione: iniziava l'epoca dei grandi raduni sportivi, delle grandi parate civili e militari,<br />
151
dei grandi spettacoli dl massa, delle grandi feste popolari, delle grandi manifestazioni ginniche, che<br />
coinvolgevano fino a decine di migliaia di persone in nuovi riti coreografici sotto il segno del corale<br />
e del colossale, dove lo spazio, il ritmo, la dinamica, la forza, l'armonia imperavano, ma i corpi e le<br />
anime, le persone, perdevano la propria individualità per assumere una personalità collettiva di<br />
difficile definizione.<br />
È questa un'evoluzione ambigua ma piena di fascino, che pareva promettere la<br />
realizzazione del sogno labaniano del «tempio danzante», ma che, prestandosi ad essere usata e<br />
riempita di senso da ideologie di segno diverso, avrebbe finito per culminare nelle inquietanti,<br />
ciclopiche celebrazioni di massa del nazismo. Laban stesso, la Wigman e molti altri dei maggiori<br />
danzatori e coreografi che, passata l'ondata individualista e formato un discreto numero di seguaci,<br />
stavano ormai dedicandosi anche in teatro all' elaborazione e allo sviluppo di forme di gruppo e<br />
corali, furono attratti, insieme ai tanti maestri di ginnastica, dalle enormi e inesplorate possibilità<br />
coreutiche che queste grandi liturgie espressa all'unisono ad alti livelli estetici. Anche i critici<br />
teorizzarono la necessità che la «danza tedesca» (questo era ormai il nome della nuova danza)<br />
assumesse forme corali e di massa. Nell'ultima pubblicazione collettiva dopo il cambio di regime,<br />
che raccoglie scritti prodotti in occasione dei Tanzfestspielen diretti da Laban nel 1934 ma che fu<br />
edita solo nel 1936, è evidente la concentrazione degli interessi su questo punto, ben riassunta in<br />
questa frase di Hans Brandenburg:<br />
[...] la nuova arte della danza sta sullo stesso fronte con i fenomeni del Laienspiel e dello<br />
Sprechchor [coro parlato] e con il nuovo senso della festa. Con loro vuole penetrare nel popolo,<br />
trasformando il teatro di società in teatro di comunità che unisce ai solisti professionisti il coro al<br />
posto delle comparse e che, come futuro teatro della nazione, può essere soltanto corale perché<br />
deve simbolizzare il rapporto tra massa ed eroe, tra Volk e Führer.<br />
Con questo ideale, anche i maestri della danza organizzarono feste popolari, sfilate,<br />
celebrazioni, sperimentando figurazioni e dinamiche di somma efficacia. Le memorabili Olimpiadi<br />
di Berlino del '36 toccarono l'apice coreografico di questa linea di ricerca, contribuendo a glorificare<br />
un'ideologia che aveva fatto della superiorità della propria razza - espressa anche attraverso la<br />
salute e l'armonia del corpo - uno dei suoi più pericolosi miti fondanti. Segnarono tuttavia, con<br />
l'indicare chiaramente i compiti e i limiti che le venivano attribuiti, anche la soglia di compatibilità<br />
della nuova danza col regime, che già mal tollerava l'indipendenza creativa che le era<br />
caratteristica. Delle personalità di maggiore rilievo alcune si adeguarono alla nuova realtà,<br />
barattando con l’acquiescenza il proseguimento di un’attività non certo esaltante ma continuativa,<br />
altre scelsero un volontario esilio.<br />
152