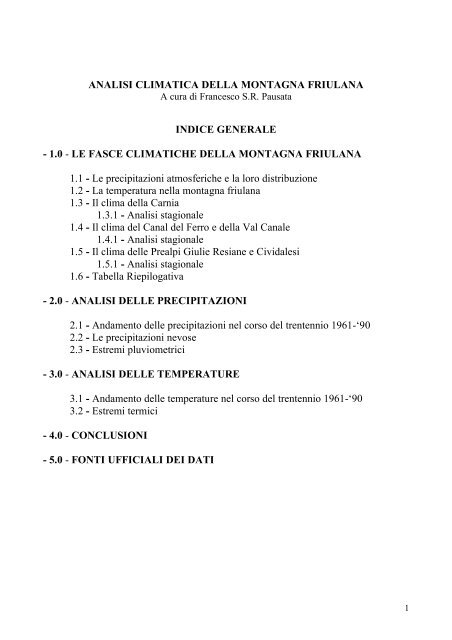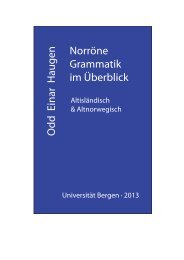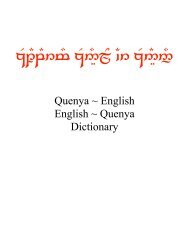ANALISI CLIMATICA DELLA MONTAGNA FRIULANA
ANALISI CLIMATICA DELLA MONTAGNA FRIULANA
ANALISI CLIMATICA DELLA MONTAGNA FRIULANA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>ANALISI</strong> <strong>CLIMATICA</strong> <strong>DELLA</strong> <strong>MONTAGNA</strong> <strong>FRIULANA</strong><br />
A cura di Francesco S.R. Pausata<br />
INDICE GENERALE<br />
- 1.0 - LE FASCE CLIMATICHE <strong>DELLA</strong> <strong>MONTAGNA</strong> <strong>FRIULANA</strong><br />
1.1 - Le precipitazioni atmosferiche e la loro distribuzione<br />
1.2 - La temperatura nella montagna friulana<br />
1.3 - Il clima della Carnia<br />
1.3.1 - Analisi stagionale<br />
1.4 - Il clima del Canal del Ferro e della Val Canale<br />
1.4.1 - Analisi stagionale<br />
1.5 - Il clima delle Prealpi Giulie Resiane e Cividalesi<br />
1.5.1 - Analisi stagionale<br />
1.6 - Tabella Riepilogativa<br />
- 2.0 - <strong>ANALISI</strong> DELLE PRECIPITAZIONI<br />
2.1 - Andamento delle precipitazioni nel corso del trentennio 1961-‘90<br />
2.2 - Le precipitazioni nevose<br />
2.3 - Estremi pluviometrici<br />
- 3.0 - <strong>ANALISI</strong> DELLE TEMPERATURE<br />
3.1 - Andamento delle temperature nel corso del trentennio 1961-‘90<br />
3.2 - Estremi termici<br />
- 4.0 - CONCLUSIONI<br />
- 5.0 - FONTI UFFICIALI DEI DATI<br />
1
1.0 - LE FASCE CLIMATICHE <strong>DELLA</strong> <strong>MONTAGNA</strong> <strong>FRIULANA</strong><br />
Il territorio montano del Friuli risulta climaticamente molto vario. Possiamo<br />
distinguere almeno tre zone climatiche differenti:<br />
• quella della Carnia;<br />
• quella del Canale del Ferro e della Val Canale;<br />
• quella delle Prealpi Giulie Resiane e Cividalesi.<br />
A loro volta queste zone climatiche presentano una molteplicità di microclimi.<br />
1.1 - Le precipitazioni atmosferiche e la loro distribuzione<br />
In Friuli la condensazione delle masse d’aria umida proveniente da sud non avviene<br />
in modo diffuso su tutta la catena, ma si concentra soprattutto sulla fascia prealpina<br />
(vd. Fig. 1.1).<br />
Ciò è dovuto all’effetto barriera costituito dalle lunghe catene montuose orientate in<br />
direzione est-ovest che si innalzano improvvise e, con notevole dislivello, dalla<br />
Pianura Friulana: si passa ad esempio dai 600 m di Musi e Uccea ai 1800 m delle<br />
cime retrostanti in meno di un paio di chilometri.<br />
Per avere un’idea precisa delle condizioni pluviometriche bisogna considerare non<br />
solo la quantità globale delle precipitazioni, ma anche la ripartizione delle piogge<br />
nel corso dell’anno, cioè il regime pluviometrico, che ha un gran interesse dal punto<br />
di vista pratico e in particolare per il regime dei corsi d’acqua e per l’agricoltura.<br />
Occorre stabilire, insomma, non solo quanto e come piove, ma anche quando piove.<br />
La stagione più “siccitosa” in Friuli risulta essere l’inverno, seguita, a distanza,<br />
dall’estate per la pedemontana e le Prealpi e invece dalla primavera per le Alpi.<br />
In ogni caso sono minime le differenze tra estate e primavera per la pedemontana e<br />
le Prealpi: non si superano i 20-30 mm in tre mesi. Invece è sensibile la differenza<br />
sulle Alpi dove raggiunge punte di 60 mm a Tarvisio e quasi 75 mm, sempre a<br />
favore dell’estate a Forni Avoltri.<br />
La stagione più piovosa è invece l’autunno ad eccezione che nell’angolo nordoccidentale<br />
che ha il massimo in estate. Sulle Prealpi Giulie da settembre a<br />
novembre cadono oltre 1000 mm, mentre sul settore settentrionale non si va oltre i<br />
450 mm.<br />
A livello stagionale il massimo dei giorni piovosi si ha comunque, sia su Alpi che<br />
Prealpi in estate e si aggira attorno 34-38 gg, toccando punte di 39 e 40 gg<br />
rispettivamente a Forni Avoltri e Sauris. In inverno invece si hanno in tutto 19-22<br />
gg con precipitazioni.<br />
2
A livello mensile quello con più giorni di pioggia risulta Giugno con 13-15 gg,<br />
mentre quelli meno piovosi variano da stazione a stazione e sono comunque quelli<br />
invernali con 6-8 gg di pioggia.<br />
Il mese più piovoso è Novembre per quasi tutte le stazioni alpine e prealpine, ad<br />
eccezione di Saletto (Ottobre). Nella pedemontana invece il mese con più<br />
precipitazioni coincide con quello con più giorni piovosi (Giugno).<br />
Il mese con meno pioggia è Febbraio, eccetto che per Sauris (Gennaio), con punte<br />
minime di appena 70-75 mm a Forni Avoltri e punte massime di 160-165 mm nelle<br />
Prealpi Giulie.<br />
Da questi dati se ne deduce che nelle zone più settentrionali a farla da padrone è<br />
l’instabilità estiva, mentre le zone più meridionali sono maggiormente influenzate<br />
dalle perturbazioni autunnali.<br />
[INSERIRE FIGURA FRIULI PRECIPITAZIONI]<br />
Fig. 1.1: Precipitazioni medie annuali relative al periodo 1951-‘70 (fonte Servizio Idraulico Dir.<br />
Reg., 1981).<br />
1.2 - La temperatura nella montagna friulana<br />
La catena alpina è in grado di costituire un valido scudo alle masse d’aria fredda<br />
provenienti dall’Europa settentrionale e in parte anche da quella centro-orientale, le<br />
quali possono traboccare solo dai pochi valichi esistenti per incanalarsi lungo le<br />
valli principali e raggiungere infine la pianura in quantità ben più modesta.<br />
La particolare orientazione delle catene montuose produce, inoltre, la spiccata<br />
asimmetria termica nei versanti opposti con uno scarto delle temperature medie<br />
annue che può raggiungere i 4°C circa .<br />
3
Le particolarità di questo clima sono alla base di alcune caratteristiche davvero<br />
singolari della zona: l’abbassamento dei limiti altimetrici della vegetazione (400-<br />
500 m) e l’abbassamento del limite delle nevi perenni lungo i versanti settentrionali<br />
delle catene montuose( • ).<br />
Le temperature medie annue (periodo 1961-‘90) sono comprese tra i 10-11°C della<br />
pedemontana (10.0°C a Vedronza, 325 m slm) e i quasi 6°C del Passo della Mauria<br />
(1298 m slm) e di Fusine 1 (770-854 m slm) agli estemi opposti della regione,<br />
occidentale e orientale rispettivamente.<br />
La zona prealpina risulta la zona più mite del territorio montano (vd. Fig. 1.2), a<br />
causa della mancanza di barrire orografiche a sud che impediscano l’arrivo diretto<br />
delle calde correnti meridionali.<br />
Man mano che ci si sposta verso le vallate alpine le temperature calano anche se in<br />
maniera asimmetrica: la parte occidentale risulta decisamente più mite rispetto a<br />
quella orientale, raggiungendo un minimo di freddo nel Tarvisiano (a Fusine).<br />
L’andamento delle temperature ha un minimo in regione nel mese di Gennaio che<br />
risulta essere in assoluto il mese più freddo, seguito da Dicembre e quindi da<br />
Febbraio (ad eccezione che a Montemaggiore dove Febbraio è più rigido di<br />
Dicembre).<br />
Il massimo si raggiunge in Luglio, anche se capita spesso che Agosto sia più caldo:<br />
infatti la differenza tra le media di questi due mesi è solo di pochi decimi di grado e,<br />
nel caso delle Prealpi Cividalesi, Luglio e Agosto nel trentennio 1961-’90 hanno la<br />
stessa temperatura media.<br />
[INSERIRE FIGURA FRIULI TEMPERATURA]<br />
• Per un’analisi dettagliata di come la vegetazione consenta di valutare empiricamente l’esito di indicatori che<br />
richiederebbero lunghi periodi di rilevazione, come quelli climatici cf.:<br />
Biasutti R., Il paesaggio terrestre, Torino 1947 , UTET.<br />
1 Per Fusine la media è di 6.1°C, ma si riferisce al periodo 1974-1990. Il decennio 1961-‘70 è stato per quasi tutte le<br />
località della regione più freddo dei decenni successivi, dunque è lecito pensare che la media trentennale sia inferiore ai<br />
6°C. C’è inoltre da tener presente che la stazione di temperatura nel corso degli anni è stata spostata da Fusine Laghi a<br />
854 m a Fusine in Valromana a 770 m che si trova a 2-3 Km a ovest.<br />
4
Fig. 1.2: Temperature medie annuali relative al periodo 1951-’70 (fonte Servizio Idraulico Dir. Reg.,<br />
1981 rielaborazione a cura di Adriano Giadrini). Le isoterme non sono riferite al livello del mare ma alle<br />
stazioni fornite dall’Idrografico: nella Carnia occidentale le stazioni si trovano ad una quota compresa tra i<br />
900 m e i 1300 m; in Carnia centrale tra i 500 e gli 850 m, nel Tarvisiano tra i 600 e i 900 m.<br />
1.3 - Il clima della Carnia<br />
Il clima della Carnia risulta particolarmente mite per trattarsi di una zona alpina, dato<br />
che risulta fortemente protetta dai venti dai quadranti nord orientali.<br />
La media della temperatura annua varia tra i 6°C e i 10°C (per quote inferiori ai 1300<br />
m), in genere più mite nelle valli orientate in senso meridiano e sui pendii riparati e<br />
volti a mezzogiorno, questo ad esempio è il caso di Paularo.<br />
La piovosità media annuale oscilla tra i 1400 mm circa di Forni Avoltri, sito<br />
nell’angolo nord-occidentale della Regione e i 2000 mm circa di Tolmezzo, che si<br />
trova nella Carnia meridionale al confine con le Prealpi .<br />
La parte centrale della Carnia al confine con l’Austria risulta in assoluto la più mite<br />
della Regione (vd. Fig.1.2), con temperature medie annue che a 700 m sono di poco<br />
inferiori a 10°C (9.6°C a Paularo, 648 m).<br />
Il motivo va ricercato nel fatto che la mole del massiccio del Coglians con i suoi 2780<br />
m costituisce uno schermo ai venti settentrionali e i pendii risultano rivolti a<br />
mezzogiorno, mentre nulla riesce a intercettare i raggi solari verso sud e<br />
l’orientamento meridiano delle vallate favorisce l’ingresso delle correnti meridionali.<br />
Già più fredda, specie in inverno risulta la Carnia occidentale: Forni di Sopra (907 m)<br />
giace quasi a fondovalle e il Monte Pramaggiore con i suoi 2479 m intercetta i bassi<br />
raggi invernali verso mezzodì, mentre il Cridola (2580 m) fa schermo verso ponente,<br />
cosicché le ore di sole in Dicembre e Gennaio sono poche e il clima si inasprisce.<br />
Tuttavia, trovandosi nell’ampia valle del Tagliamento l’aria fredda può circolare<br />
liberamente e scorrere verso il basso, non rimanendo così intrappolata nel paese.<br />
In questa zona la temperatura media annua a 700 m si aggira sui 8.5-9.0°C (7.5°C a<br />
Forni Avoltri, 888 m; 8.2°C a Forni di Sopra, 907 m).<br />
Tolmezzo (323 m) giace nel cuore dell’amplissima valle del Tagliamento e risulta<br />
riparato dai venti orientali grazie alla presenta del Monte Amariana (1906 m). L’aria<br />
fredda che la notte scende dalle valli circostanti può ristagnare nella zona, perché il<br />
pendio in questo punto è assai modesto, ma l’ampiezza della conca è tale che lo strato<br />
di aria fredda resta sottile e si disperde al primo sole.<br />
La temperatura media annua del capoluogo carnico è di appena 1°C superiore a quella<br />
di Paularo che ha una quota di oltre 300 m superiore.<br />
5
È soprattutto nelle belle giornate invernali che si nota la differenza tra le stazioni<br />
collocate nei pendii esposti a mezzogiorno (Paularo media massima di gennaio quasi<br />
5°C; Collina a 1200 m ai piedi del Coglians oltre 4°C – Gentilli • ) e quelli riparati<br />
dall’irradiazione solare (Forni Avoltri e Forni di Sopra circa 2°C e 3.5°C di media<br />
delle massime a Gennaio rispettivamente).<br />
La notte gli effetti della posizione in conca sono notevoli: a Paularo la temperatura<br />
media delle minime è sostanzialmente uguale a quella di Tolmezzo è risulta di circa<br />
–3.5°C.<br />
Neanche durante le ondate di freddo eccezionale si sono avuti valori particolarmente<br />
bassi in Carnia: nel gelido Febbraio del 1929 a Paularo non si scese oltre i –17°C,<br />
temperatura raggiunta anche nel Gennaio del 1987; al Passo della Mauria (1298 m)<br />
non si andò sotto i –20°C (–22°C nel Gennaio 1985) e a Sauris (1212 m) si scese al<br />
massimo a –21°C, valore in seguito uguagliato nel Gennaio 1985.<br />
Il periodo in cui è possibile superare i 30°C va da Giugno ad Agosto su tutta la<br />
Carnia. La soglia dei 35°C rappresenta una soglia insuperabile al di sopra dei 500 m,<br />
anche se forse dopo l’estate 2003 e il luglio 2006, questa barriera è stata superata.<br />
Stazione: TOLMEZZO<br />
Quota: 323 m slm<br />
TEMPERATURA (°C) -16°C 79, '85,'87 +35°C 62,'74,'88 PIOVOSITA' (mm) N. medio<br />
media min max media ext min aa ext max aa media max min gg.piov.<br />
1961-1990 5.7 15.5 10.6 8.7 1978 11.9 1961 1991.3 2902.2 1402.0 107.9<br />
G -3.6 4.8 0.6 -3.8 1979 3.6 1988 114.9 505.8 0.0 6.1<br />
F -2.1 6.9 2.4 -0.5 1978 5.8 1966 111.5 286.0 0.2 6.6<br />
M 1.0 10.6 5.8 2.1 1987 8.9 1961 135.6 505.9 1.8 8.1<br />
A 5.1 14.7 9.9 7.9 1979 13.6 1961 183.4 519.6 13.0 10.3<br />
M 9.2 19.7 14.5 11.0 1984 17.1 1986 192.2 371.8 43.6 12.1<br />
G 12.5 23.2 17.9 16.1 1974 20.6 1964 186.6 403.4 30.8 13.0<br />
L 14.4 25.9 20.1 17.8 1978 23.5 1983 160.2 338.2 46.6 11.1<br />
A 14.1 25.6 19.8 17.8 1978 22.4 1962 152.9 506.0 35.0 10.3<br />
S 11.0 21.7 16.4 13.5 1984 19.4 1961 169.4 773.6 22.4 8.3<br />
O 6.8 16.7 11.7 6.7 1974 14.5 1966 210.9 644.0 0.0 7.9<br />
N 1.6 10.1 5.9 2.6 1980 8.6 1963 243.3 689.8 3.0 8.0<br />
D -2.1 5.7 1.8 -0.8 1978 4.2 1978 130.5 347.4 7.6 6.0<br />
Tab 1.1: Temperatura e piovosità media 1961-’90 della stazione di Tolmezzo.<br />
Stazione: PAULARO<br />
Quota: 648 m slm<br />
-15°C 14/01/1968 +33°C 15/08/1962 PIOVOSITA' (mm) N. medio<br />
media min max media ext min aa ext max aa media 61-82 Max min gg.piov.<br />
1961-1970 4.5 14.6 9.6 8.1 1978 10.9 1961 1585.3 2022.8 1199.2 111.5<br />
G -3.7 4.9 0.6 -2.5 1979 4.5 1974 99.8 335.8 0.0 6.5<br />
F -2.6 6.9 2.2 -1.4 1986 5.3 1990 84.3 255.5 0.3 6.6<br />
M -0.2 10.0 4.9 1.1 1987 8.9 1961 115.0 449.1 1.0 8.1<br />
A 3.6 13.4 8.5 6.0 1980 11.9 1961 133.1 284.4 5.0 10.4<br />
M 7.5 17.9 12.7 8.5 1984 15.4 1986 148.4 263.6 67.8 12.9<br />
• Gentilli J., Il Friuli, I Climi, Udine 1964, Camera di Commercio Industria e Agricoltura.<br />
6
G 10.6 21.3 16.0 14.4 1985 18.2 1964 153.6 273.0 37.6 13.7<br />
L 12.5 23.9 18.2 15.8 1978 21.3 1983 142.8 230.8 62.4 11.5<br />
A 12.3 23.9 18.1 16.0 1976 20.8 1971 135.7 436.3 43.2 11.3<br />
S 9.7 21.2 15.4 13.1 1984 18.6 1961 135.2 672.2 15.2 8.3<br />
O 5.6 16.7 11.2 6.2 1974 13.5 1969 153.7 466.2 0.0 7.7<br />
N 1.0 9.5 5.2 2.5 1988 8.0 1963 182.6 485.8 4.0 7.9<br />
D -2.4 5.6 1.6 -1.3 1981 4.3 1971 101.0 239.0 3.7 6.6<br />
Tab. 1.2: Temperatura e piovosità media 1961-‘90 e ‘61-‘82 della stazione di Paularo rispettivamente.<br />
Stazione: FORNI AVOLTRI<br />
Quota: 888 m slm<br />
-20°C 07/01/1985 +34°C 28/07/1983 PIOVOSITA' (mm) N. medio<br />
media min max media ext min aa ext max aa media max min gg.piov.<br />
1961-1990 2.8 12.1 7.5 5.7 1965 8.7 1989 1414.0 2132.0 989.6 113.6<br />
G -5.2 2.1 -1.5 -6.8 1963 2.1 1974 73.5 296.2 0.0 6.5<br />
F -4.7 5.6 0.5 -2.3 1963 4.5 1990 72.4 200.3 0.0 6.0<br />
M -1.9 8.1 3.1 -0.5 1987 7.7 1961 85.7 420.0 3.6 7.9<br />
A 1.6 10.7 6.1 3.0 1970 9.7 1961 122.7 355.2 4.0 10.8<br />
M 5.7 15.2 10.4 7.4 1970 14.0 1986 146.1 301.6 35.4 13.4<br />
G 8.8 18.7 13.8 11.2 1971 16.4 1979 149.7 290.6 17.2 14.6<br />
L 11.0 21.5 16.3 13.7 1966 20.3 1983 142.9 327.0 51.2 12.4<br />
A 10.8 21.2 16.0 13.0 1968 18.9 1974 134.2 371.2 59.2 12.3<br />
S 8.3 18.4 13.3 10.3 1965 16.5 1987 110.8 599.8 15.6 8.6<br />
O 4.2 14.5 9.3 4.4 1974 11.5 1969 138.1 474.2 0.0 7.3<br />
N -0.9 7.2 3.1 0.6 1962 5.4 1978 160.5 555.6 2.0 8.1<br />
D -4.2 1.7 -1.2 -4.3 1962&1969 2.6 1971 77.6 204.4 4.0 5.8<br />
Tab. 1.3: Temperatura e piovosità media 1961-’90 della stazione di Forni Avoltri. Da notare come le<br />
precipitazioni diminuiscano spostandosi verso le vallate alpine più settentrionali.<br />
1.3.1 - Analisi stagionale<br />
L’inverno dunque non risulta particolarmente rigido e le temperature medie stagionali<br />
oscillano tra gli 1.5°C e i –1°C (–2.5°C al Passo della Mauria) e neanche<br />
particolarmente piovoso, ad eccezione che a Tolmezzo il quale benché sia la “capitale<br />
della Carnia” ha varie caratteristiche prealpine.<br />
Di conseguenza la neve non è abbondantissima anche perché gran parte del vapore<br />
acqueo precipita nelle antistanti Prealpi: al di sotto dei 1000 m non si raggiungono i<br />
200 cm annui: si va da un minimo di 49 cm di neve a Tolmezzo in 6 gg, a un massimo<br />
di 349 cm in 28 gg al Passo della Mauria. A Sauris che si trova quasi alla stessa quota<br />
la neve caduta arriva mediamente ai 246 cm in 23 gg.<br />
La primavera presenta caratteristiche ancora invernali nella prima parte di Marzo per<br />
poi mitigarsi decisamente agli inizi di Aprile quando le temperature medie minime<br />
non risultano più negative al di sotto dei 1000 m. Le medie stagionali sono comprese<br />
tra i 6 e gli 8°C (a 600-1000 m).<br />
Le precipitazioni sono vanno dai 350 mm ai 500 mm e sono distribuite in poco più di<br />
30 giorni.<br />
7
Le estati risultano abbastanza fresche con temperature medie che nei mesi più caldi<br />
non superano i 20°C: la media stagionale risulta compresa tra i 15°C e i 18 °C a quote<br />
comprese tra i 600 e i 1000 m.<br />
Le precipitazioni risultano abbondanti e ben distribuite; cadono mediamente dai 400<br />
mm ai 500 mm in circa 35-40 giorni e per la Carnia nord-occidentale risulta anche la<br />
stagione più piovosa.<br />
La stagione più piovosa per quasi tutta la Carnia è l’autunno dove nella zona<br />
meridionale si superano i 500-600 mm in tre mesi, anche se non ha il numero<br />
massimo di giorni piovosi.<br />
Le temperature risultano ancora relativamente miti fino agli inizi di Novembre<br />
quando la scarsa insolazione produce un netto calo termico: le temperature medie<br />
stagionali sono di 8-11°C.<br />
1.4 - Il clima della Val Canale e del Canal del Ferro<br />
La distinzione climatica principale tra Carnia e le Valli del Fella (Val Canale e Canal<br />
del Ferro) è la maggiore escursione termica di quest’ultima zona, dovuta con ogni<br />
probabilità alla presenza di un numero maggiore di pareti rocciose nude che<br />
aumentano il riscaldamento dovuto all’insolazione diurna e il raffreddamento dovuto<br />
all’irraggiamento notturno.<br />
Dunque questa zona presenta caratteristiche più continentali rispetto alla Carnia: in<br />
Val Canale, a Fusine, si raggiungono in Gennaio e Febbraio anche i 12-12.5°C di<br />
escursione termica e quasi 13.5°C nei mesi estivi. In Carnia in inverno non si<br />
superano i 10.5°C, mentre in estate si arriva al massimo a 11.5°C.<br />
Ne consegue che anche la differenza tra gli estremi di temperatura sia maggiore a<br />
est piuttosto che a ovest: a Fusine si possono raggiungere anche i 65°C di<br />
escursione annua, mentre a Paularo si superano appena i 50°C.<br />
Le Valli del Fella e la Val Raccolana hanno una temperatura media annua compresa<br />
tra i 6°C e i 9°C nei fondovalle.<br />
Nella Val Canale orientale a 750-800 m le temperature medie oscillano tra 6°C e i<br />
7.5°C (7.5°C a Tarvisio, 751 m slm).<br />
Per trovare valori di temperatura simili bisogna spostarsi, in Carnia, a circa 1100-<br />
1300 m (6.8°C a Sauris, 1212 m slm, 5.8°C al Passo Mauria 1298 m) oppure nel<br />
vicino Cadore a 900 m circa.<br />
Le precipitazioni medie annuali nelle Valli del Fella sono comprese tra i 1500 mm e i<br />
2000 mm con punte di 2200-2500 mm in Val Raccolana.<br />
8
Il periodo in cui è possibile superare i 30°C va da Giugno ad Agosto su tutta la zona.<br />
La soglia dei 35°C rappresenta una soglia molto difficile da oltrepassare, anche se<br />
eccezionalmente è stata superata 2 .<br />
Il periodo in cui è possibile registrare giorni di gelo in Val Raccolana e nel Canal del<br />
Ferro va da fine Settembre a fine Maggio a Tarvisio va da metà Settembre a metà<br />
Giugno e in Val Canale a 800-900 m da fine Agosto a fine Giugno.<br />
Da notare però che nella “Russia italiana”, cioè a Fusine ad appena 800 m si posso<br />
registrare temperature attorno allo zero in tutti i mesi dell’anno. Inoltre nella zona del<br />
Lago Superiore di Fusine a 928 m è riuscito a nevicare perfino alla fine di Agosto nel<br />
1967.<br />
Stazione: SALETTO in Val Raccolana<br />
Quota: 517 m slm<br />
-19°C 13/01/1987 +34°C 28/07/1983 PIOVOSITA' (mm) N. medio<br />
media min max media ext min aa ext max aa media max min gg.piov.<br />
1961-1990 3.1 12.3 7.7 6.6 1978 9.3 1989 2247.7 3096.9 1710.2 114.4<br />
G -5.7 -0.5 -3.1 -6.1 1964 0.2 1989 121.2 483.8 0.0 6.8<br />
F -4.7 1.9 -1.4 -4.2 1982 2.6 1989 112.3 352.4 0.0 6.5<br />
M -1.4 7.4 3.0 -0.9 1987 6.9 1985 135.6 482.1 6.7 8.7<br />
A 2.3 12.8 7.6 5.3 1973 11.2 1961 188.5 508.8 15.0 10.6<br />
M 6.3 17.8 12.1 9.7 1984 14.7 1986 240.6 497.7 49.6 13.3<br />
G 9.6 21.6 15.6 13.8 1974 17.6 1964 232.3 487.4 90.3 14.3<br />
L 11.5 24.4 18.0 16.1 1980 20.9 1983 191.3 384.8 57.8 11.6<br />
A 11.2 23.9 17.6 15.3 1976 20.0 1962 211.9 576.7 48.5 10.5<br />
S 8.4 20.0 14.2 10.7 1972 17.2 1987 205.3 820.9 61.1 8.9<br />
O 4.0 12.0 8.0 3.9 1974 12.2 1966 212.2 640.9 0.0 8.1<br />
N -0.6 4.9 2.1 -0.7 1983 6.3 1963 254.2 722.7 6.0 8.6<br />
D -4.3 0.2 -2.0 -5.2 1986 0.7 1982 142.3 378.3 9.4 6.5<br />
Tab. 1.4: Temperatura e piovosità media 1961-‘90 della stazione di Saletto in Val Raccolana. Da<br />
notare le temperature invernali estremamente basse per la quota dovute alla particolare posizione che<br />
impedisce ai raggi solari di fare capolino oltre le montagne da fine ottobre a fine febbraio.<br />
Stazione: TARVISIO<br />
Quota: 751 m slm<br />
-25°C 23/01/1963 +37°C 28/07/1983 PIOVOSITA' (mm) N. medio<br />
media min max media ext min aa ext max aa media max min gg.piov.<br />
1961-1990 2.1 13.0 7.5 6.0 1965 8.7 1982 1501.4 2114.3 1111.2 115.3<br />
G -7.4 1.1 -3.1 -8.3 1964 2.5 1975 84.7 299.8 0.4 7.4<br />
F -5.7 4.5 -0.6 -5.3 1965 4.0 1990 83.4 259.8 2.3 7.5<br />
M -2.4 8.2 2.9 -1.3 1987 6.2 1977 95.7 310.8 12.2 8.5<br />
A 1.1 12.5 6.8 4.5 1962 9.6 1961 136.1 357.3 18.0 11.1<br />
M 5.5 17.5 11.5 9.0 1970 15.8 1986 138.9 278.4 27.4 12.2<br />
G 8.9 21.1 15.0 12.6 1967 17.4 1982 144.0 255.0 58.4 13.4<br />
L 10.9 23.7 17.3 14.8 1961 21.7 1983 139.1 244.2 29.4 11.7<br />
A 10.2 22.9 16.5 13.8 1976 19.3 1980 147.4 343.4 49.9 10.4<br />
S 7.4 19.8 13.6 10.7 1972 18.3 1982 142.9 521.6 40.8 9.0<br />
O 3.3 14.8 9.1 5.0 1974 12.0 1966 133.3 480.4 0.0 7.9<br />
N -1.7 7.4 2.9 -0.7 1988 5.8 1963 155.9 411.4 5.0 8.9<br />
D -5.9 1.8 -2.0 -6.9 1968 2.7 1985 100.1 245.0 9.4 7.3<br />
2 Secondo i dati dell’Istituto Idrografico a Tarvisio si è arrivati fino a 37°C nel Luglio 1983, ma nel rovente Agosto<br />
2003 nella stessa località si è a malapena superata la soglia dei 34°C, secondo la stazione dell’Osmer.<br />
A Saletto sempre secondo l’Idrografico nel Luglio 1983 si arrivò a 34°C e nell’Agosto 2003 si sono raggiunti i 37°C.<br />
9
Tab. 1.5: Temperatura e piovosità media 1961-‘90 della stazione di Tarvisio. Da notare come le<br />
precipitazioni diminuiscano spostandosi verso le vallate alpine più settentrionali<br />
1.4.1 - Analisi stagionale<br />
L’inverno risulta piuttosto rigido con temperature medie stagionali, a parità di quota,<br />
anche di 3-4°C inferiori a quelle della Carnia e che sono comprese tra gli 0°C e i –3°C<br />
(-1.9°C a Tarvisio, 751 m vs 1.5°C a Paularo, 648 m) con punte di circa –3.5°C a<br />
Fusine a 800 m.<br />
A Gennaio solo le basse valli poste a solatìo sgelano, il resto della zona rimane al di<br />
sotto di 0°C anche nelle ore più calde del primo pomeriggio: Saletto in Val Raccolana<br />
ad appena 500 m di quota ha infatti una temperatura media massima di Gennaio di<br />
–0.5C° grazie alla presenza a meno di 2 km a sud del P.co di Mezzodì e a sud-est del<br />
Monte Sart che con i loro 1868 m e 2324 m rispettivamente impediscono da fine<br />
Ottobre a fine Febbraio ai raggi solari di penetrare nella valle.<br />
Molto esplicativa per capire i caratteri di continentalità alpina alquanto rigida (Polli<br />
S. • ) della zona dei Laghi di Fusine, dove si registrano i valori di temperatura più bassi<br />
della Regione, e non solo, risulta essere la Fig. 1.3.<br />
[INSERIRE FIGURA FUSINE]<br />
Fig. 1.3: I Laghi di Fusine: notare la cintura di montagne che circondano i laghi da est a ovest, lasciando la<br />
conca aperta soltanto a nord (scala 1:50.000 : 1 cm = 500 m).Elaborazione grafica a cura di Adriano Giardini.<br />
• Polli S., Il Clima. In: Il Parco di Fusine, Udine 1971, Az. Reg. For..<br />
10
Come si vede l’afflusso di aria mite dai quadranti meridionali è di fatto negato grazie<br />
alla presenza del Massiccio del Mangart; inoltre trattandosi di una conca decisamente<br />
poco ampia l’aria fredda che si deposita riesce a creare un cuscino piuttosto spesso.<br />
Il fatto che gli inverni siano più rigidi della Carnia è dato in parte dal fatto che la Bora<br />
riesce a penetrare facilmente in Val Canale attraverso la Sella di Ratece (900 m)<br />
scendendo poi mitigata per il Canal del Ferro.<br />
Meno fredda risulta la Bora, invece, in Val Raccolana perché le uniche vie d’accesso<br />
sono la Sella Prevala a 2066 m e la Sella Robon a 1802 m, ne consegue che<br />
scendendo verso valle il vento si scalda per compressione adiabatica.<br />
L’inverno ad eccezione della Val Raccolana, dove si superano i 400 mm non è<br />
particolarmente piovoso con valori simili a quelli che si registrano in Carnia, ma a<br />
parità di altitudine risulta più nevoso: ad esempio il Passo del Predil (1156 m) risulta<br />
più nevoso del Passo della Mauria (1298 m), Cave del Predil (906 m) con quasi 3 m<br />
annui supera di gran lunga Forni di Sopra (907 m) che risulta la zona più nevosa della<br />
Carnia al di sotto dei 1000 m con i suoi 200 cm, infine a Saletto ad appena 500 m<br />
cadono quasi 110 cm di neve poco meno che a Forni Avolti (888 m), anche se il<br />
numero dei giorni nevosi è quasi il doppio nella località carnica (10 vs 17 gg).<br />
La primavera è abbastanza piovosa con precipitazioni che si attestano attorno ai 350-<br />
450 mm a parte nella Val Raccolana che essendo la più vicina alle Prealpi Resiane ha<br />
valori che superano i 500-600 mm. Le notti risultano ancora abbastanza fredde con<br />
temperature medie minime stagionali comprese tra 0 e 3°C, mentre le giornate<br />
cominciano ad essere miti con temperature medie massime stagionali comprese tra i<br />
12 e i 14°C.<br />
L’estate risulta leggermente più calda o comunque con temperature analoghe a quelle<br />
della Carnia, con valori medi del mese più caldo inferiori a 19°C: a Pontebba Luglio<br />
sfiora i 19°C, mentre nella mitissima Paularo si superano di poco i 18°C; a Cave del<br />
Predil (906m) nello stesso mese è di poco superiore ai 16°C simile a quella che si<br />
registra a Forni Avolti (888 m).<br />
Le temperature medie stagionali hanno valori compresi tra i 15°C e i 18°C.<br />
Le precipitazioni sono più abbondanti che in primavera e sono comprese tra i 450 mm<br />
e i 600 mm ripartiti in circa 35 gg.<br />
L’autunno risulta la stagione più piovosa, anche se a Tarvisio si hanno valori analoghi<br />
all’estate, che risulta in tutte le zone quella con il maggior numero di giorni di<br />
pioggia: da Settembre a Novembre cadono circa 450-650 mm in 24-25 gg.<br />
Le temperature risultano decisamente gradevoli a Settembre per poi inasprirsi già alla<br />
fine di Ottobre: la temperatura media stagionale è compresa tra i 7°C e i 10°C.<br />
1.5 - Il clima delle Prealpi Giulie Resiane e Cividalesi<br />
11
La caratteristica saliente del clima prealpino resiano e cividalese è l’estrema<br />
piovosità, che nella valle dei Musi e in Val Resia supera i 3000 mm annui.<br />
La temperatura media annua non risulta particolarmente bassa e si aggira attorno ai<br />
9°C nei fondovalle e nelle colline fino a 900 m di quota.<br />
Nelle Prealpi Cividalesi a circa 1000 m di quota la temperatura è compresa tra gli<br />
8.5°C e i 9 °C (8.8°C a Montemaggiore, 954 m slm), valori che si registrano a circa<br />
600 m già in Val Resia, che fa da spartiacque tra Alpi e Prealpi Giulie (9.3°C a<br />
Oseacco, 490 m slm), a circa 800 m, invece sulle Alpi Carniche sud-occidentali<br />
(8.2°C a Forni di Sopra, 907 m slm) e sui 600-700 m nella Carnia nord-occidentale<br />
(7.5°C a Forni Avoltri, 888 m slm).<br />
Ad eccezione delle zone a topografia convessa l’escursione termica mensile risulta<br />
anche in quest’area piuttosto elevata con punte di 13°C nel periodo estivo.<br />
Il periodo in cui è possibile avere delle gelate va da fine Settembre a fine Maggio<br />
nella pedemontana e in Val Resia, sui Colli Orientali fino a 1000 m di quota va da<br />
inizio Ottobre a fine Maggio.<br />
Il periodo in cui è possibile superare i 30°C va da Giugno ad Agosto su tutta la zona.<br />
La soglia dei 35°C rappresenta una barriera che solo raramente può essere superata.<br />
Stazione: UCCEA Stazione: MUSI<br />
Quota: 645 m slm Quota: 635 m slm<br />
PIOVOSITA' (mm) N. medio PIOVOSITA' (mm) N. medio<br />
media media max min gg.piov. media media max min gg.piov.<br />
1961-1990 3100.7 4374.0 2030.5 125.3 1961-1990 3009.7 3966.4 1874.0 124.1<br />
G 222.1 540.7 0.0 7.8 G 200.9 585.2 0.0 7.4<br />
F 166.3 698.8 1.9 7.5 F 167.3 799.2 1.9 7.4<br />
M 229.4 771.0 17.0 9.8 M 231.4 747.2 11.7 9.7<br />
A 291.7 756.6 22.0 11.9 A 285.1 710.6 14.0 11.8<br />
M 299.2 711.2 55.6 14.3 M 301.5 692.5 75.4 14.6<br />
G 280.4 494.8 70.7 14.8 G 287.5 458.8 65.8 14.7<br />
L 208.3 408.5 40.7 11.9 L 197.5 393.2 34.8 11.8<br />
A 227.6 605.2 34.8 11.2 A 231.7 520.4 61.9 11.1<br />
S 283.3 1256.8 38.4 10.0 S 266.8 954.4 51.0 9.8<br />
O 301.2 961.4 0.8 9.0 O 285.6 900.0 0.0 8.9<br />
N 383.0 1189.7 10.0 9.6 N 349.8 961.0 3.0 9.5<br />
D 208.3 449.2 24.0 7.5 D 204.5 425.4 17.3 7.4<br />
Tab. 1.6: Piovosità media 1961-‘90 delle stazioni di Uccea e Musi.<br />
Stazione: MONTEMAGGIORE<br />
Quota: 954 m slm<br />
-16°C 1968,'78,'85 +31°C 1974,'83,'85,'88 PIOVOSITA' (mm) N. medio<br />
media min max media ext min aa ext max aa media ’61-‘90 max min gg.piov.<br />
1965-1990 5.0 12. 6 8.8 7.7 1965 9.6 1990 2844.5 3840.2 2037.7 119.5<br />
G -2.6 4.0 0.7 -3.1 1985 3.7 1990 198.1 626.5 0.0 7.9<br />
F -2.4 4.7 1.2 -2.5 1986 5.1 1990 160.2 681.7 0.0 7.5<br />
M -0.1 7.3 3.6 -0.3 1987 7.7 1990 212.4 605.0 0.0 9.3<br />
A 3.1 10.5 6.8 4.4 1980 9.2 1968 232.4 466.5 6.0 11.4<br />
M 7.7 15.3 11.5 7.9 1984 14.7 1986 268.1 504.9 63.6 13.2<br />
G 10.8 18.5 14.6 12.9 1974 17.6 1979 290.0 551.4 81.0 13.9<br />
L 13.3 21.9 17.6 15.0 1980 20.9 1983 203.7 436.5 52.8 10.9<br />
A 13.1 22.1 17.6 14.6 1976 20.0 1974 221.6 507.2 30.0 10.1<br />
S 10.2 18.3 14.3 11.2 1972 17.4 1985 267.4 1142.4 22.5 9.2<br />
12
O 6.3 14.3 10.3 5.3 1974 12.2 1969 259.3 669.2 0.0 8.5<br />
N 1.4 8.7 5.1 2.9 1985 7.4 1978 315.3 725.5 7.0 9.7<br />
D -1.4 5.3 2.0 -0.7 1969 4.3 1971 216.0 522.4 31.3 7.8<br />
Tab. 1.7: Temperatura e piovosità media 1965-‘90 e 1961-‘90 della stazione di Montemaggiore rispettivam.<br />
Stazione: OSEACCO<br />
Quota: 490 m slm<br />
-20°C 31/12/1968 +36°C 20/07/1983 PIOVOSITA' (mm) N. medio<br />
media min max media ext min aa ext max aa media max min gg.piov.<br />
1961-1990 4.5 14.1 9.3 7.5 1965 10.4 1982 2618.5 3479.1 1755.2 115.7<br />
G -5.1 2.6 -1.3 -6.1 1964 3.2 1988 158.8 545.4 0.0 7.3<br />
F -3.5 5.4 1.0 -3.3 1965 3.4 1972 136.2 461.5 0.0 7.0<br />
M 0.1 8.7 4.4 1.2 1987 7.4 1972 171.6 618.5 12.7 9.1<br />
A 4.1 13.3 8.7 6.4 1970 11.6 1981 224.2 676.1 10.0 10.9<br />
M 8.6 18.7 13.7 10.6 1962 17.0 1964 256.4 550.8 64.8 13.1<br />
G 11.4 22.5 17.0 13.2 1969 20.5 1966 233.8 507.8 38.8 13.1<br />
L 13.0 24.6 18.8 17.2 1978 22.7 1983 191.2 420.0 40.0 11.7<br />
A 12.7 24.8 18.8 16.1 1969 24.3 1962 209.7 599.8 31.2 10.5<br />
S 9.5 20.9 15.2 11.3 1965 18.4 1987 243.8 1065.3 32.8 9.0<br />
O 5.4 16.0 10.7 6.5 1964 e 1974 13.4 1966 254.9 969.0 0.0 8.0<br />
N -0.1 9.6 4.3 1.5 1969 e 1988 7.1 1980 356.4 1087.2 5.0 9.0<br />
D -3.5 3.8 0.2 -3.8 1968 3.2 1982 181.6 455.8 18.6 6.9<br />
Tab. 1.8: Temperatura e piovosità media 1961-‘90 della stazione di Oseacco. Da notare come le temperature<br />
calano, mentre le precipitazioni disuniscono passando dai rilievi prospicienti la pianura alle vallate più interne.<br />
1.5.1 - Analisi stagionale<br />
L’inverno non è ugualmente freddo: le Prealpi Cividalesi sono più esposte ai venti<br />
freddi nord-orientali, ciò nonostante le cime non risultano particolarmente fredde:<br />
Vedronza, che per di più si trova ad un’altitudine modesta (325 m) presenta delle<br />
temperature medie minime invernali di quasi più basse di Montemaggiore sito nelle<br />
Prealpi Cividalesi a quasi 1000 m.<br />
In ogni caso l’inverno a fondovalle è più mite a parità di quote rispetto al Val<br />
Raccolana e alla Val Canale, ma è più rigido rispetto alla Carnia: la temperatura<br />
media stagionale si aggira attorno agli 0°C a 500 m.<br />
Nella pedemontana e sui Colli Orientali a 1000 m la temperatura media invernale si<br />
attesta su valori di 1-1.5°C.<br />
L’escursione termica è massima nella pedemontana dove si aggira nei mesi invernali<br />
attorno ai 10°C, mentre diminuisce nelle vallate interne (8°C a Oseacco),<br />
raggiungendo un minimo sulle colline (7°C a Montemaggiore).<br />
Nel gelido Febbraio del 1929 a Vedronza la temperatura scese fino a –24°C, valore<br />
che in Carnia non è stato raggiunto nemmeno a 1300 m.<br />
Le precipitazioni sono abbastanza elevate superando quasi ovunque i 500 mm<br />
distribuiti in una ventina di giorni. La nevosità, invece è modesta, in genere meno<br />
della metà di quella delle Alpi: infatti a Vedronza non si arriva a 30 cm, a Musi si<br />
superano appena i 60 cm e a Montemaggiore si arriva a 125 cm.<br />
13
Se ci si sposta nelle vallate più interne la nevosità aumenta e si ha che in Val Resia<br />
nevica dagli 80 cm ai 150 cm a quote comprese tra i 400 e i 650 m.<br />
La primavera è annunciata da un aumento della piovosità ancor prima che da un<br />
aumento di temperatura. Da Febbraio a Marzo la pioggia passa da 100-150 mm a 160-<br />
210 mm mentre la temperatura cresce di circa 3°C. Poi l’irradiazione solare ha il<br />
sopravvento e la temperatura sale rapidamente.<br />
Le medie stagionali sono comprese tra i 7°C e i 9°C (a 400-900 m).<br />
Nei tre mesi primaverili cadono dai 600 mm agli 800 mm distribuiti in circa 35 giorni.<br />
L’estate è caratterizzata da temperature massime che sfiorano i 26°C nella<br />
pedemontana e si attestano attorno ai 22°C a 1000 m sulle prealpi cividalesi. Le<br />
temperature minime sono fresche e non vanno oltre i 13°C. La media stagionale<br />
risulta compresa tra i 17°C e i 18°C a quote comprese tra i 600 e i 900 m<br />
Il numero di giorni di pioggia è elevato è si aggira attorno ai 37-38 in cui piovono<br />
circa 600-750 mm.<br />
L’autunno è la stagione in cui si registrano precipitazioni davvero notevoli, tali che in<br />
un mese si hanno non di rado valori superiori ai 1000 mm (fino a 1900 mm a Uccea<br />
nel novembre 1951).<br />
Si va dai 650 mm della pedemontana agli 850-900 mm delle Prealpi Cividalesi e della<br />
Val Resia toccando un massimo di 1000-1050 mm nella valle dei Musi.<br />
Le temperature inizialmente calano lentamente registrando temperature ancora miti in<br />
Settembre e all’inizio di Ottobre per poi calare bruscamente a partire dagli inizi di<br />
Novembre: le temperature medie stagionali hanno valori sui 10°C.<br />
1.6 - Tabella riepilogativa<br />
Nella Tabella 1.9 sono riassunti i valori medi stagionali e annuali di temperatura e di<br />
pioggia per le tre zone climatiche prendendo come riferimento un’altitudine compresa<br />
tra i 600 m e gli 800 m. Dato che non sempre sono disponibili stazioni comprese fra<br />
queste due quote, per ricavare il valore di temperatura si è utilizzata<br />
l’approssimazione di Hann (1908), secondo cui la temperatura media annua varia di<br />
circa 0.55°C per ogni 100 m di altezza.<br />
Carnia<br />
Valli del Fella e<br />
Raccolana Prealpi Giulie<br />
Temperature Precipitazioni Temperature Precipitazioni Temperature Precipitazioni<br />
Inverno -1/2°C 200-350mm 0/-3°C 250-400mm -1/+2°C 450-600mm<br />
Primavera +7/+9°C 350-500mm +6/+8°C 350-550mm +7/+8°C 600-750mm<br />
Estate +16/+18°C 400-500mm +15/+18°C 400-600mm +17/+18°C 600-750mm<br />
Autunno +9/+11°C 400-600mm +7/+10°C 450-650mm +9/+11°C 650-1050mm<br />
Anno +8/+10°C 1400-2000mm +7/+9°C 1500-2500mm +8/+10°C 2300-3200mm<br />
Tab. 1.9: Valori medie stagionali e annuali di temperatura e precipitazioni per le tre fasce climatiche.<br />
14
2.0 - <strong>ANALISI</strong> DELLE PRECIPITAZIONI<br />
Come si è potuto vedere nel paragrafo precedente è presente un grosso divario fra le<br />
precipitazioni delle Prealpi Giulie e quelle della parte più settentrionale della<br />
regione (3000 mm/annui vs 1500 mm/annui), ciò nonostante il numero di giorni di<br />
pioggia 3 in un anno è simile: il massimo di giorni piovosi si ha a Uccea con 125.3<br />
gg, il minimo si registra a Tolmezzo con 107.9 gg.<br />
A Forni Avoltri, dove si rileva il minimo di precipitazioni si hanno solo 12 gg in<br />
meno all’anno di piogga rispetto ad Uccea e a Sauris, dove cade meno della metà<br />
delle piogge delle Prealpi Giulie, si registrano ben 120.3 gg.<br />
Se ne deduce che le precipitazioni per ogni singolo episodio risultano decisamente<br />
più abbondanti sulle Prealpi Giulie: 24.7 mm/episodio e 24.3 mm/episodio a Uccea<br />
e Musi rispettivamente; solo 12.4 mm/episodo e 13,1 mm/episodio a Forni e Sauris<br />
rispettivamente.<br />
Anche nel tarvisiano le precipitazioni non risultano particolarmente intense: circa<br />
13 mm/episodio, mentre sulle Alpi Giulie si hanno valori attorno ai 19-22<br />
mm/episodio, quasi come nella pedemontana (18-20 mm/episodio)<br />
2.1 - Andamento delle precipitazioni nel corso del trentennio 1961-‘90 4<br />
Le precipitazioni in tutte le stazioni prese in esame risultano nel corso del trentennio<br />
1961-‘90 in calo, ad eccezione di Pontebba, la quale mostra invece un aumento.<br />
Precipitazione (mm)<br />
3300<br />
3100<br />
2900<br />
2700<br />
2500<br />
2300<br />
2100<br />
1900<br />
1700<br />
1500<br />
1961<br />
1962<br />
1963<br />
1964<br />
1965<br />
1966<br />
1967<br />
1968<br />
VEDRONZA<br />
Precipitazione totale annua<br />
1969<br />
1970<br />
1971<br />
1972<br />
1973<br />
1974<br />
Graf. 2.1: Esempio della tendenza al ribasso delle precipitazioni anche se alla fine degli anni<br />
ottanta sembra esserci un lieve aumento (interpolazione polinomiale).<br />
3 Per giorno di pioggia si intende un giorno in cui è caduto almeno 1 mm di pioggia.<br />
4 Per le stazioni di Musi, Uccea, Oseacco e Saletto, sono disponibili i dati di pioggia anche per le decadi 1951-‘60 e<br />
1991-‘99 e per la stazione di Cave del Predil per gli anni 1991-‘99.<br />
1975<br />
1976<br />
Anno<br />
1977<br />
1978<br />
1979<br />
1980<br />
1981<br />
1982<br />
1983<br />
1984<br />
1985<br />
1986<br />
1987<br />
1988<br />
1989<br />
1990<br />
15
La decade più piovosa risulta per gran parte delle località la prima (‘61-‘70) con<br />
punte di 3300-3500 mm in un anno a Musi e Uccea e 3000 mm anche in Val Resia<br />
(2962 mm a Oseacco) e a Montemaggiore (2983 mm). Valori sopra i 1500-1600<br />
mm si registravano anche sulle Alpi Carniche occidentali. Mentre nell’ultima<br />
decade (‘81-‘90) nessuna località arriva a 3000 mm: Uccea 2931 mm e Musi 2804<br />
mm. Nel Tarvisiano si è passati da valori medi di 1600-1650 mm a 1350-1400 mm<br />
dell’ultima decade e a Forni Avoltri si è addirittura scesi sotto i 1300 mm (1299<br />
mm).<br />
Interpolando i dati del trentennio con una polinomiale di terzo grado per alcune<br />
stazioni si nota una inversione di tendenza negli ultimi anni: come ad esempio per la<br />
pedemontana, le Prealpi Giulie occidentali e le Alpi Giulie, il Tarvisiano e la Carnia<br />
nord-occidentale.<br />
Questa tendenza viene confermata dai dati delle stazioni di Musi, Uccea, Oseacco e<br />
Cave del Predil, ma non da quella di Saletto che invece registra una ulteriore<br />
flessione.<br />
Infatti nelle Prealpi Giulie occidentali si ritorna ad avere precipitazioni oltre i 3000<br />
mm (a Musi 3080 mm e a Uccea 3023 mm).<br />
Oseacco passa da 2349 mm del periodo 1981-‘90 ai 2406 del periodo 1991-‘99 e<br />
Cave del Predil torna quasi a 2000 mm (1996 mm) dopo il minimo di 1931 mm del<br />
decennio 1981-‘90.<br />
Quello che si nota è che mentre diminuisco le precipitazioni in quasi tutte le<br />
stagioni, specie in inverno (dimezzate rispetto al decennio 1951-‘60: 846 mm vs<br />
433 mm a Uccea; 650 mm vs 295 mm a Oseacco), aumentano notevolmente le<br />
piogge in autunno raggiungendo il massimo da 50 anni a questa parte.<br />
A Musi si passa dagli 816 mm del periodo 1981-‘90 ai 1260 del decennio<br />
successivo, a Uccea dagli 867 mm ai 1250 mm e a Oseacco dai 687 mm ai 1050<br />
mm.<br />
Questi aumenti si concentrano soprattutto a ottobre che risulta essere decisamente<br />
più piovoso di novembre.<br />
2.2 - Le precipitazioni nevose<br />
Per quanto riguarda la neve i dati dell’idrografico non sono sufficientemente completi<br />
per poter fare un analisi dettagliata nel trentennio 1961-‘90. Sono a disposizione in<br />
maniera completa, però i dati di nevosità del trentennio 1921-‘50 (Polli S. •).<br />
• Polli S., Il clima della Regione. In: Enciclopedia Monografica del Friuli-Venezia Giulia, 1° Il Paese, Udine<br />
1971, Istituto per l’Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia, pag. 462.<br />
16
In ogni caso si può affermare in base all’andamento delle precipitazioni che la<br />
quantità di neve che cade è sicuramente diminuita nell’ultimo decennio (1981-‘90)<br />
rispetto al primo (1961-‘70) , almeno per quanto riguarda le zone di alta montagna.<br />
La zona più nevosa al di sotto dei 700-800 m è sicuramente Uccea (645 m), la quale,<br />
grazie alla presenza a sud di una barriera montuosa sufficientemente elevata (tra i<br />
1400m e i 1600 m) che impedisce l’ingresso diretto delle correnti miti, gode di un<br />
buon cuscinetto freddo a differenza di Musi che invece risulta completamente<br />
scoperta al flusso meridionale.<br />
Delle stazioni prese in esame la più nevosa al di sotto dei 1000 m è Cave del Predil,<br />
che unisce insieme alle elevate precipitazioni (2050 mm), la quota (906 m) e un<br />
ottimo grado di continentalità. La nevosità media nel trentennio 1921-‘50 era di 292<br />
cm distribuiti in 24 gg.<br />
A Cave del Predil nel periodo 1991-‘99 i mesi esclusi da precipitazioni nevose sono<br />
stati i mesi estivi e settembre.<br />
A Uccea nel decennio 1951-‘60 gli unici mesi in cui non è mai nevicato sono stati<br />
luglio, agosto e settembre. Nel periodo 1991-‘99 non si sono visti fiocchi di neve oltre<br />
che in luglio, agosto e settembre, neanche nei mesi di giugno e ottobre.<br />
La zona meno nevosa è la pedemontana visto sia la quota modesta sia la mancanza di<br />
barriere orografiche a protezione del cuscinetto freddo, così risulta che a Vedronza si<br />
avevano mediamente 28 cm di neve in 5 gg. Spostandosi un po’ più a nord e salendo<br />
di quota si registravano 63 cm in 10 gg a Musi, molto meno nevosa come detto di<br />
Uccea dove si raggiungono circa i 2 m.<br />
A 1000 m nelle Prealpi Giulie cadono mediamente 125 cm in 15 gg, valori che si<br />
registrano a 500-600 m in Val Raccolana e in Val Resia.<br />
In Carnia si va da un minimo di 49 cm di neve a Tolmezzo in 6 gg, a un massimo di<br />
349 cm in 28 gg al Passo della Mauria. A Sauris che si trova quasi alla stessa quota la<br />
neve caduta raggiunge solo i 246 cm in 23 più o meno come a Tarvisio che però si<br />
trova circa 500 m più in basso.<br />
Le elevate precipitazioni che si riscontrano sulle Prealpi Giulie e sulla parte<br />
meridionale delle Alpi Giulie hanno consentito la formazione dei più bassi ghiacciai<br />
delle Alpi, compresi tra i 2100 e 1850 m e i 2300 e i 2100 m e che si trovano<br />
rispettivamente sul Massiccio dello Jôf di Montasio (2753 m) e sul Massiccio del<br />
Monte Canin (2587 m).<br />
Nell’ultimo decennio, durante l’estate il ghiacciaio del Canin si suddivide in numerosi<br />
nevai minori. In superficie è stata notata una coltre di minutissime particelle nere e<br />
untuose al tatto dovute al notevole inquinamento atmosferico (Sgobino F. • ).<br />
2.3 - Estremi pluviometrici<br />
• Sgobino F., Il Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Cooperativa Utopie concrete, Venzone (Ud) 1994;<br />
17
La quantità di precipitazioni che è caduta nella montagna friulana, varia da un<br />
massimo registrato ad Uccea nel 1960 di ben 6103 mm a un minimo di 990 mm<br />
avuti a Forni Avoltri nel 1974.<br />
Gli estremi pluviometrici annui nelle varie stazioni nel trentennio 1961-’90 sono:<br />
Pedemontana:<br />
• a Vedronza si va da una massimo di 3245 mm del 1987 a un minimo di 1636<br />
mm del 1983;<br />
• a Gemona si oscilla tra i 2855 mm del 1965 e i 1339 mm del 1986.<br />
Prealpi Giulie:<br />
• a Musi si va dai 3996 mm registrati nel 1987 e ai 1874 mm del 1983;<br />
• a Uccea si varia dai 4374 mm del 1965 ai 2031 mm del 1983;<br />
• a Montemaggiore si oscilla tra 3840 mm del 1965 e i 2038 mm del 1986;<br />
• a Moggio sono caduti dai 2940 mm del 1987 ai 1353 mm del 1983;<br />
• a Oseacco si va dai 3479 mm del 1965 ai 1755 mm del 1983.<br />
Prealpi Carniche:<br />
• a Tolmezzo si va di 2902 mm del 1979 ai 1402 mm del 1986;<br />
• ad Ampezzo si oscilla tra i 2370 mm del 1966 e i 1229 del 1983;<br />
Alpi Giulie:<br />
• a Saletto sono caduti dai 3097 mm del 1965 ai 1710 mm del 1986;<br />
• a Pontebba si va dai 2840 mm del 1987 ai 1332 mm del 1971;<br />
• a Tarvisio si oscilla tra i 2114 mm del 1965 e i 1111 mm del 1988;<br />
• a Cave del Predi si varia dai 2968 mm del 1968 e i 1569 mm del 1986.<br />
Alpi Carniche:<br />
• a Sauris si va 2179 mm del 1979 ai 1142 mm del 1983;<br />
• a Forni Avoltri si oscilla tra i 2132 mm del 1966 e i 989 mm del 1974.<br />
Da segnalare una curiosità che mentre nel 1960 a Uccea caddero 6103 mm a Musi<br />
che si trova nella stessa vallata e a meno di 10 km in linea d’aria è piovuto solo, si<br />
fa per dire, 4662 mm, cioè una differenza di quasi 1500 mm.<br />
La massima precipitazione mensile si registrò nel Novembre del 1951 a Uccea<br />
caddero ben 1889.7 mm di pioggia, quasi quanta ne cade mediamente in oltre 2 anni<br />
a Bologna o in quasi 4 anni a Ferrara. A Musi in quel mese caddero 1146 mm.<br />
Nel Novembre del 1969 in 5 giorni a Oseacco sono scesi 829.4 mm, a Uccea e a<br />
Musi nello stesso periodo sono scesi 709.6 mm e 629.4 mm rispettivamente.<br />
Nelle Alpi Giulie non si sono registrati valori in 5 giorni superiori a 500 mm (462.2<br />
mm a Saletto) e nelle Alpi Carniche si è arrivato ad un massimo di 498.6 mm nel<br />
novembre del 1966 proprio nel posto solitamente meno piovoso della zona<br />
montuosa, e cioè a Forni Avoltri.<br />
18
Il massimo di precipitazione giornaliera si è registrato a Oseacco dove il 22/08/1969<br />
caddero 414 mm, seguito dal massimo di Uccea dove il 02/11/1963 sono piovuti<br />
339.6 mm e a Musi caddero 320.0 mm.<br />
3.0 - <strong>ANALISI</strong> DELLE TEMPERATURE<br />
Come detto, la misura della temperatura ha bisogno di una particolare cura,<br />
purtroppo i dati a dispostone sono solamente quelli dell’idrografico regionale, ente<br />
interessato più alle precipitazioni che alle temperature.<br />
Inoltre l’osservatore nelle diverse località varia nel corso degli anni, così cambia<br />
anche la posizione delle stazioni; variazione che, per quanto concerne le piogge, è<br />
poco rilevante, mentre per le temperature può risultare fondamentale: una stazione<br />
posta proprio a fondovalle piuttosto che su un versante all’ombra o al sole ha<br />
temperature decisamente diverse nei vari casi.<br />
3.1 - Andamento delle temperature nel corso del trentennio 1961-‘90<br />
La temperatura media annua nel corso del trentennio 1961-‘90 mostra su gran parte<br />
del territorio montano una netta tendenza al rialzo.<br />
In particolare la temperatura ha subito nell’ultimo periodo (1981-‘90) un<br />
incremento rispetto alla decade 1961-‘70 su tutte le zone e in tutte le stagioni<br />
dell’anno (salvo locali eccezioni) 5 , con valori particolarmente pronunciati per quel<br />
che riguarda le due stagioni estreme: gli inverni si sono addolciti (+0.3/+2°C) e le<br />
estati sono diventate decisamente più calde (+0.4/+1.5°C).<br />
Temperatura (°C)<br />
11.0<br />
10.5<br />
10.0<br />
9.5<br />
9.0<br />
8.5<br />
8.0<br />
7.5<br />
1962<br />
1961<br />
1964<br />
1963<br />
1966<br />
1965<br />
1968<br />
1967<br />
PONTEBBA<br />
Temperatura media annuale<br />
1970<br />
1969<br />
1972<br />
1971<br />
1974<br />
1973<br />
1975<br />
Anno<br />
1977<br />
1976<br />
1979<br />
1978<br />
Graf. 2.1: Esempio della tendenza al rialzo delle temperature.<br />
1981<br />
1980<br />
1983<br />
1982<br />
1985<br />
1984<br />
1987<br />
1986<br />
1989<br />
1988<br />
Scendendo nel dettaglio, gli unici mesi che sembrano non aver subito aumenti e<br />
anzi, in diverse località, hanno avuto delle flessioni, più o meno accentuate sono<br />
Giugno e Novembre.<br />
5 Come già detto la temperatura è estremamente variabile anche a movimenti di poche centinaia di metri e visto che le<br />
varie stazioni di osservazione, come già visto ad esempio per Fusine non sono fisse, ma vengono spostate all’interno<br />
della località, ciò può mascherare eventuali trend.<br />
1990<br />
19
Mentre Maggio, Luglio e Agosto hanno mostrato mediamente un incremento di 1-<br />
1,5°C e Gennaio e Dicembre di 1.5-2.5°C.<br />
Febbraio, Marzo, Aprile e Ottobre hanno subito degli aumenti, ma ovunque inferiori<br />
o al più prossimi a 1°C.<br />
3.2 - Estremi termici<br />
Gli anni più caldi del trentennio sono stati il 1961, il 1982, il 1983 e il 1989. Al di<br />
fuori di questo periodo è doveroso segnalare che in molte località, specie per quelle<br />
orientali, il 1992 e il 1994 furono i più caldi in assoluto.<br />
Il mese più freddo è risultato essere il Gennaio ‘64 per le vallate delle Alpi e Prealpi<br />
Giulie, mentre per la Carnia il ‘63 seguito dal ‘79.<br />
Particolarmente rigido sono stati: il Gennaio ‘85, il Dicembre ‘68,‘69,‘81 e ‘90 e il<br />
Febbraio ‘65 e ‘86.<br />
La temperatura media mensile più bassa si è registrata a Fusine (a 800 m circa) nel<br />
Gennaio del 1985 con un valore di –9.2°C (media delle minime di quasi -15°C),<br />
seguita dai –7.8°C del Passo della Mauria (1298 m) e i –7.0°C di Cave del Predil<br />
(906 m).<br />
Il mese più caldo del trentennio è stato senza ombra di dubbio per tutte le località<br />
Luglio 1983; in alcune stazioni Agosto 1992 e Luglio 1994 sono risultati addirittura<br />
più caldi. Con ogni probabilità Agosto 2003 ha registrato le temperature più elevate:<br />
infatti l’unica stazione della quale è stato possibile ottenere il dato mostra che:<br />
• Saletto: 20.9°C nel Luglio 1983 (media delle max di 28.7°C), 22.2°C<br />
nell’Agosto 1992 (media delle max di 30.0°C) e 22.6°C nell’Agosto 2003<br />
(media delle max di 31.4°C);<br />
Nel Luglio 1983 le località più miti sono risultate: Passo della Mauria, che grazie<br />
alla sua quota prossima a 1300 m ha avuto una media di 17.5°C, seguita da Fusine<br />
(854 m) con 18.8°C, Sauris (1212 m) con 19.3°C e Cave del Predil (906 m) con<br />
19.4°C. In Carnia a 900 m si sono avuti valori tra i 20 e i 21.5°C.<br />
Particolarmente miti sono risultati Gennaio e Febbraio del 1988, del 1989 e del<br />
1990. In particolare la media delle massime del Febbraio 1990 ha raggiunto valori<br />
che anche nelle vallate più fredde sono risultati maggiori di quelli tipici per la<br />
Pianura Friulana: Forni di Sopra ha avuto una media di 11.1°C, Tarvisio di 10.1°C,<br />
Fusine di 9.9°C, Cave del Predil di 9.7°C, Saletto di 8.9°C (temperatura abbastanza<br />
bassa rispetto alle altre località, giustificabile dal fatto che si trova a bacìo) e<br />
Passo della Mauria di 8.5°C. Valori questi che si discostano dalle medie del periodo<br />
anche di 5.5°C.<br />
20
Curioso il fatto che nella pedemontana si siano registrati valori non molto più alti e<br />
anzi in alcuni casi addirittura più bassi: infatti Vedronza ha avuto una media delle<br />
max di 10.8°C, “solo” 3.5°C al di sopra del dato medio trentennale.<br />
I picchi di freddo si sono registrati in quasi tutta la regione nel Gennaio del 1985<br />
con valori di –28°C a Fusine, –25°C a Cave del Predil, –24°C a Tarvisio e –22°C al<br />
Passo della Mauria. Nella pedemontana si è scesi fino a –17°C.<br />
Per quanto riguarda invece le temperature estive, spiccano i 36°C e i 37°C registrati<br />
da Fusine e da Tarvisio rispettivamente, seguiti dai 35°C di Cave del Predil che si<br />
sono rilevati alla fine del Luglio 1983. Da segnalare anche i 34°C di Forni Avoltri e<br />
Saletto e i 33°C del Passo della Mauria. A Vedronza, nella pedemontana si sono<br />
toccati i 36°C.<br />
Anche in questo con ogni probabilità l’Agosto 2003 e anche il Luglio 2006 hanno<br />
battuto questi precedenti record: a Saletto infatti si è arrivati a ben 37°C.<br />
4.0 - CONCLUSIONI<br />
Nei paragrafi precedenti si è messo in evidenza come nel clima dell’Alto Friuli si<br />
siano manifeste nel periodo in esame (1961-‘90) due importanti tendenze:<br />
• un aumento della temperatura annuale;<br />
• una diminuzione delle precipitazioni acquee.<br />
Le cause potrebbero essere ricercate in un cambiamento climatico su vasta scala,<br />
cambiamento i cui motivi potrebbero essere legati semplicemente a una normale<br />
oscillazione, dato che l’unica costate del clima è la variabilità oppure all’attività<br />
umana che avrebbe indotto ad un mutamento della circolazione generale<br />
dell’atmosfera.<br />
È doveroso, infine sottolineare come i consumi energetici planetari, attraverso la<br />
combustione di petrolio, carbone e metano, oltre a causare danni ambientali<br />
gravissimi hanno portato ad un aumento considerevole delle concentrazioni di<br />
anidride carbonica che, in epoca pre-industriale, ammontava a 260 parti per milione e<br />
ora a circa 370-380 ppm. Le caratteristiche dell’anidride carbonica sono ben note e<br />
comunque non vorrei addentrarmi in questioni certamente importanti, ma che esulano<br />
dagli scopi di questa trattazione.<br />
Dalla variazione della temperatura dipende in parte quella degli altri elementi<br />
climatici, in primo luogo le precipitazioni che per la loro sensibilità a tali mutamenti e<br />
per la loro facile misurabilità, costituiscono uno dei migliori indici di cambiamento<br />
climatico.<br />
Le particolarità geografiche di una regione possono esaltare, in un elemento<br />
climatico, l’effetto del generale aumento termico, per cui il fenomeno può assumere,<br />
21
per tale elemento valori molto notevoli. Così avviene nel caso della regressione delle<br />
fronti dei ghiacciai alpini, nella forte diminuzione delle precipitazione di certe zone<br />
montane.<br />
In concordanza con la variazione climatica generale cambia come si è visto anche il<br />
clima del territorio in analisi.<br />
La temperatura media del corso del trentennio 1961-‘90 ha subito un aumento di<br />
0.4°C rispetto all’inizio del secolo 6 . L’aumento di temperatura ha di conseguenza<br />
comportato uno spostamento in avanti degli estremi stagionali.<br />
Le precipitazioni del trentennio 1961-‘90 hanno subito un andamento contrastato<br />
nelle varie località rispetto ai decenni precedenti: a Saletto in Val Raccolana sono<br />
aumentate di oltre l’8%, a Paularo invece sono calate di circa il 10%, a Tolmezzo e<br />
nelle Prealpi Giulie sono diminuite del 5%, mentre a Forni Avolti sono aumentate del<br />
4%. Hanno invece mostrato un trend al ribasso nel corso del periodo 1961-’90.<br />
Una probabile spiegazione può essere legata ad un cambiamento, naturale o indotto,<br />
della circolazione generale dell’atmosfera, legata alla North Atlantic Oscillation,<br />
NAO 7 .<br />
La diminuzione delle piogge concentrata soprattutto tra dicembre e marzo è dovuta<br />
alla minor frequenza delle fasi di maltempo e quindi a un minor numero di<br />
perturbazioni che transitano in Regione.<br />
Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che l’Anticiclone delle Azzorre, anziché<br />
stazionare quasi stabilmente nel semestre freddo al largo sull’Atlantico, con il suo<br />
centro appunto sulle Azzorre, e lasciare così campo aperto alle perturbazioni<br />
atlantiche, ha assunto una inconsueta posizione fino a comprendere spesso<br />
l’Inghilterra, la Francia e l’Italia settentrionale.<br />
Così le perturbazioni atlantiche sono costrette a circumnavigare questa salda<br />
struttura anticiclonica, saltando di fatto tutte le regioni dell’Italia settentrionale.<br />
Ciò lo si può dedurre osservando le variazioni dell’indice NAO che mettono in<br />
evidenza come negli ultimi dieci anni di analisi (1990-1999) questo indice sia<br />
risultato positivo nella stagione invernale per ben nove volte (vd. Graf 4.1).<br />
Questa configurazione di NAO Positiva comporta, come visto in precedenza anche<br />
fasi invernali decisamente miti e ciò potrebbe spigare l’incremento registrato nelle<br />
6 I dati relativi all’inizio del secolo per le stazioni di Vedronza (1936-‘55), Montemaggiore (1938-‘55), Tolmezzo (1926<br />
in poi), Passo della Mauria (1923 in poi), Forni Avoltri (1926 in poi) e Tarvisio (1926 in poi) si possono trovare nel<br />
libro di Gentilli J., Il Friuli, I climi, Udine 1964, Camera di Commercio Industria e Agricoltura.<br />
7 L’indice NAO è definito come la differenza tra la pressione in prossimità di Gibilterra e l’Islanda e quindi può<br />
risultare positivo o negativo: un valore positivo del NAO Index sta a indicare un’intensificazione dell’Anticiclone delle<br />
Azzorre e un simultaneo approfondimento del Ciclone d’Islanda (freddo nel Nord-Ovest dell’Atlantico e clima mite in<br />
Europa, con frequenti precipitazioni nell’Europa centro-settentrionale e secco nelle regioni meridionali), mentre valori<br />
negativi descrivono la situazione in cui il dislivello di pressione è debole o addirittura invertito, alta pressione alle alte<br />
latitudini e bassa pressione in prossimità delle Azzorre (una riduzione dei cicloni provenienti dall’Atlantico; numerose<br />
depressioni mediterranee e il Nord Europa è caratterizzato da periodi secchi).<br />
22
temperature medie dell’inverno: infatti come si può vedere dal grafico 4.1 il trend<br />
positivo è iniziato all’incirca con l’inizio degli anni ‘80.<br />
10.00<br />
8.00<br />
6.00<br />
4.00<br />
2.00<br />
0.00<br />
-2.00<br />
-4.00<br />
-6.00<br />
-8.00<br />
-10.00<br />
Andamento indice Nao: Inverno<br />
1999<br />
1998<br />
1997<br />
1996<br />
1995<br />
1994<br />
1993<br />
1992<br />
1991<br />
1990<br />
1989<br />
1988<br />
1987<br />
1986<br />
1985<br />
1984<br />
1983<br />
1982<br />
1981<br />
1980<br />
1979<br />
1978<br />
1977<br />
1976<br />
1975<br />
1974<br />
1973<br />
1972<br />
1971<br />
1970<br />
1969<br />
1968<br />
1967<br />
1966<br />
1965<br />
1964<br />
1963<br />
1962<br />
1961<br />
1960<br />
1959<br />
1958<br />
1957<br />
1956<br />
1955<br />
1954<br />
1953<br />
1952<br />
1951<br />
anno<br />
Graf. 4.1: Andamento del NAO Index nella stagione invernale dal 1951 al 1999 (fonte<br />
www.met.rdg.ac.uk/cag/NAO/).<br />
L’aumento di precipitazioni che si riscontra nei mesi autunnali può trovare<br />
giustificazione nella maggiore frequenza con cui si manifestano le depressioni nel<br />
Mediterraneo occidentale in questo periodo.<br />
Infatti in autunno l’indice NAO risulta quasi sempre negativo ad eccezione del<br />
1992; ciò favorisce l’ingresso nel Mediterraneo di depressioni provenienti<br />
dall’Atlantico, che acquisiscono energia e vapore dal contrasto termico tra l’aria<br />
fredda legata alla perturbazione in arrivo e le calde acquee del Mare Nostrum.<br />
È doveroso notare come, anche se nel ventennio 1951-‘70 l’indice NAO in autunno<br />
non sembra avere “preferenze” (vd. Graf. 4.2), i mesi autunnali risultino comunque<br />
particolarmente piovosi (1200 mm vs 1250 mm del periodo 1991-‘99 a Uccea e<br />
1120 mm vs 1260 mm a Musi), tuttavia in questo periodo il massimo tendeva verso<br />
novembre specie nel decennio 1961-‘70, al contrario del periodo 1991-’99 in cui il<br />
mese più piovoso è risultato ottobre: infatti se si va in dettaglio si può vedere come<br />
settembre e ottobre abbiano, tra il 1991 e il 1999, un indice quasi sempre negativo,<br />
mentre novembre risulta spesso positivo, al contrario nel primo ventennio era<br />
novembre ad avere più spesso gli indici negativi, anche se non in maniera<br />
eccessivamente evidente.<br />
1.30<br />
1.10<br />
0.90<br />
0.70<br />
0.50<br />
0.30<br />
0.10<br />
-0.10<br />
-0.30<br />
-0.50<br />
-0.70<br />
-0.90<br />
-1.10<br />
-1.30<br />
Andamento indice Nao: annuale<br />
anno<br />
23
Graf. 4.2: Andamento del NAO Index nella stagione autunnale dal 1951 al 1999 (fonte<br />
www.met.rdg.ac.uk/cag/NAO/).<br />
Per cercare una correlazione tra NAO e tempo atmosferico sulla Regione sono stati<br />
utilizzati opportuni grafici (grafico di dispersione x,y) dai quali è possibile dedurre<br />
almeno qualitativamente l'eventuale legame che sussiste tra le variabili in analisi.<br />
La correlazione fra le grandezze in esame è utile ricercarla nelle stagioni in cui la<br />
circolazione generale dell'atmosfera e preponderante rispetto agli effetti locali;<br />
ovvero, in estate a farla da padrona è l'instabilità estiva favorita dalla presenza<br />
dell'orografia, dunque si tratta di fenomeni a mesoscala, mentre nei mesi autunnali e<br />
invernali per avere precipitazioni è necessaria la presenza di circolazioni<br />
depressionarie su scala sinottica che interessino la Regione.<br />
Dunque sono stati presi in analisi i mesi da Ottobre a Febbraio e anche quello di<br />
Luglio per verificare se l'ipotesi fatta precedentemente fosse corretta.<br />
Le stazioni utilizzate per cercare la correlazione tra indice NAO e temperatura sono<br />
state quelle di Vedronza, Saletto, Tarvisio e Sauris.<br />
Si può notare dai grafici 4.3 e 4.4 come la regressione lineare indichi per quanto<br />
concerne le precipitazioni una tendenza, come ci si aspetterebbe, ad assumere valori<br />
più elevati quando l'indice NAO è negativo e più bassi quando invece è positivo e<br />
per quanto riguarda le temperature una tendenza a valori più elevati per NAO<br />
positiva e valori più bassi per NAO negativa, ad eccezione che nel mese di Ottobre<br />
per Saletto e Tarvisio dove la tendenza è inversa (vd. Graf. 4.5).<br />
Precipitazione (mm)<br />
Temperatura °C<br />
3.0<br />
2.0<br />
1.0<br />
0.0<br />
-1.0<br />
-2.0<br />
-3.0<br />
-4.0<br />
-5.0<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
R 2 = 0.308<br />
INDICE NAO E PRECIPITAZIONI: Gennaio-Tarvisio<br />
0<br />
-5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0<br />
Indice Nao<br />
Graf.4.3: grafico di dispersione: NAO e precipitazione nel periodo 1961-’90.<br />
R 2 = 0.49<br />
INDICE NAO E TEMPERATURA: Gennaio-Sauris<br />
-6.0<br />
-5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0<br />
Indice Nao<br />
24
Graf.4.4: grafico di dispersione: NAO e temperatura nel periodo 1961-‘90.<br />
Graf.4.5: Anomala tendenza della regressione lineare nel mese di ottobre per la temperatura a Saletto.<br />
E’ presente inoltre una correlazione lineare altamente significativa o almeno<br />
significativa (Taylor J.R. • ) tra la temperatura e l'indice NAO nei mesi di Gennaio e<br />
Febbraio per tutte le stazioni esaminate (vd. Graf. 4.4). Per la temperatura,<br />
significativa risulta anche la correlazione lineare nei mesi di Novembre e Dicembre,<br />
ma solo per le stazioni di Tarvisio e Sauris, mentre risulta davvero poco<br />
significativa per Saletto e Vedronza, dove si arriva nel mese di Novembre a una<br />
probabilità del 60% di avere per due variabili incorrelate un coefficiente di<br />
correlazione maggiore.<br />
Per quanto concerne la relazione tra precipitazioni e NAO è presente una<br />
correlazione lineare altamente significativa per il mese di Gennaio, ad eccezione<br />
che a Uccea dove risulta significativa (vd Graf. 4.3).<br />
Negli altri mesi invece non risulta mai significativa, raggiungendo un minimo di<br />
correlazione proprio nel mese di Luglio (vd Graf. 4.6).<br />
Temperatura (°C)<br />
21.0<br />
20.0<br />
19.0<br />
18.0<br />
17.0<br />
Temperatura °C<br />
13.0<br />
12.0<br />
11.0<br />
10.0<br />
9.0<br />
8.0<br />
7.0<br />
R 2 = 0.02<br />
INDICE NAO E TEMPERATURA: Ottobre-Saletto<br />
6.0<br />
-5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0<br />
Indice Nao<br />
R 2 = 0.004<br />
INDICE NAO E TEMPERATURA: Luglio-Saletto<br />
16.0<br />
-5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0<br />
Indice Nao<br />
Graf. 4.6: Si può notare come la regressione lineare sia sostanzialmente orizzontale, indice di scarsa<br />
correlazione fra le variabili in esame.<br />
• Taylor J.R., Introduzione all’Analisi degli Errori, Bologna 1994, Zanichelli, pp. 292-293.<br />
25
Dunque è sì presente una correlazione tra indice NAO e il tipo di tempo sulla<br />
Regione, ma da solo non è sufficiente. Non basta, quindi, sapere se la differenza tra<br />
la pressione in prossimità della penisola Iberica e l’Islanda è positiva o negativa per<br />
stabilire senza ombra di dubbio le caratteristiche del tempo sul territorio in esame;<br />
bisogna infatti andare a vedere la reale posizione dei due centri di azione principali<br />
che governano il tempo sull’Europa: ovvero l’Anticiclone delle Azzore e la<br />
Depressione semipermanente d’Islanda.<br />
Infatti configurazioni di NAO negativa possono significare sia l’ingresso di<br />
numerose perturbazioni nel bacino del Mediterraneo, sia il blocco di tali<br />
perturbazioni dovute all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso alte<br />
latitudini e quindi l’afflusso di correnti fredde, ma per lo più secche sulla Regione,<br />
ecco perché, probabilmente la correlazione è più forte per quanto riguarda la<br />
temperatura rispetto alle precipitazioni.<br />
5.0 - FONTI UFFICIALI DEI DATI<br />
Tutte le informazioni climatologiche illustrate nel presente lavoro sono state<br />
elaborate sulla base delle osservazioni meteorologiche raccolte e diffuse dai<br />
seguenti enti:<br />
• SIR-FVG – Servizio Idrografico Regionale del Friuli-Venezia Giulia;<br />
• ARPA-FVG settore Osmer – Osservatorio Meteorologico Regionale.<br />
26