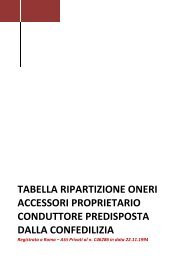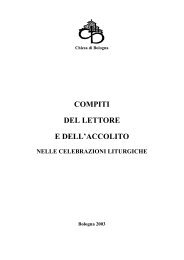28 aprile 2011: Sussidio_Tempo_di_Pasqua - Chiesa di Bologna
28 aprile 2011: Sussidio_Tempo_di_Pasqua - Chiesa di Bologna
28 aprile 2011: Sussidio_Tempo_di_Pasqua - Chiesa di Bologna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Chiesa</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong><br />
La formazione liturgica<br />
SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE<br />
DELLE SOLENNITÀ PASQUALI<br />
Il T e mpo <strong>di</strong> Pas qua<br />
Appen<strong>di</strong>ce con i testi dei canti<br />
<strong>Bologna</strong>, Seminario Arcivescovile<br />
2 <strong>aprile</strong> <strong>2011</strong>
INDICE<br />
In<strong>di</strong>ce p. 1<br />
“Preparazione e celebrazione delle feste pasquali” p. 2<br />
La celebrazione del Mistero <strong>Pasqua</strong>le/2 p. 7<br />
La mistagogia pasquale. Per educare alla vita buona del Vangelo p. 29<br />
Celebrare il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> p. 37<br />
Per <strong>di</strong>latare la celebrazione eucaristica nella famiglia p. 46<br />
Nota liturgica p. 46<br />
<strong>Tempo</strong> … dell’acclamazione p. 51<br />
Maria e il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> p. 52<br />
Antifone domeniche e solennità del <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> p. 55<br />
1
“PREPARAZIONE E CELEBRAZIONE DELLE FESTE PASQUALI”<br />
Dopo il primo intervento, proviamo a riprendere la Lettera circolare Preparazione e celebrazione<br />
delle feste pasquali pubblicata il 16 gennaio 1988 a cura della CONGREGAZIONE PER IL<br />
CULTO DIVINO.<br />
Contenuto della Lettera<br />
La Lettera si può così articolare:<br />
a. Il proemio (nn. 1-5).<br />
b. La rilettura del <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> Quaresima (nn. 6-26) in cui emerge il rapporto tra Quaresima e<br />
itinerario <strong>di</strong> iniziazione cristiana, Quaresima e ascolto della Parola, Quaresima e penitenza-carità<br />
fraterna.<br />
c. Il richiamo del significato della Settimana Santa (nn. 27-37) nella quale la <strong>Chiesa</strong> celebra i<br />
misteri della salvezza portati a compimento da Cristo negli ultimi giorni della sua vita, a cominciare<br />
dal suo ingresso messianico in Gerusalemme.<br />
d. Il Triduo <strong>Pasqua</strong>le (nn. 38-43) con richiami ai vari giorni: la Messa vespertina del Giovedì<br />
santo nella Cena del Signore (nn. 44-57); il Venerdì nella Passione del Signore (nn. 58-72); il<br />
Sabato Santo (nn. 73-76); la Veglia <strong>Pasqua</strong>le nella notte santa (nn. 77-96).<br />
e. La Domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> nella Risurrezione del Signore (nn. 97-99).<br />
f. Il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> (nn. 100-108) formato dai cinquanta giorni che si succedono dalla<br />
Domenica <strong>di</strong> Risurrezione alla Domenica <strong>di</strong> Pentecoste e sono un solo giorno <strong>di</strong> festa, anzi come<br />
un’unica grande Domenica.<br />
Alcune sottolineature<br />
Nelle “Norme generali sull’anno liturgico e sul calendario” leggiamo: «La domenica <strong>di</strong><br />
Risurrezione si <strong>di</strong>lata come una “grande domenica” per cinquanta giorni fino alla Pentecoste» (n.<br />
22). Infatti le letture sia festive sia feriali ci invitano a vivere sempre meglio il Mistero <strong>Pasqua</strong>le <strong>di</strong><br />
Cristo, la grazia che da lì fluisce nei sacramenti e all’interno della <strong>Chiesa</strong>. È quanto viene affermato<br />
nella costituzione conciliare sulla liturgia: «Quest'opera della redenzione umana e della perfetta<br />
glorificazione <strong>di</strong> Dio, che ha il suo prelu<strong>di</strong>o nelle mirabili gesta <strong>di</strong>vine operate nel popolo<br />
dell'Antico Testamento, è stata compiuta da Cristo Signore principalmente per mezzo del mistero<br />
pasquale della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero col quale<br />
«morendo ha <strong>di</strong>strutto la nostra morte e risorgendo ha restaurato la vita». Infatti dal costato <strong>di</strong><br />
Cristo dormiente sulla croce è scaturito il mirabile sacramento <strong>di</strong> tutta la <strong>Chiesa</strong>» (SC n. 5).<br />
Cerchiamo, allora, <strong>di</strong> cogliere alcune opportunità inserite, però, nell’orizzonte della vita delle nostre<br />
comunità.<br />
Uno dei rischi che si può correre è <strong>di</strong> lasciare un po’ cadere l’attenzione dopo l’intenso cammino<br />
della Quaresima e la celebrazione del Triduo <strong>Pasqua</strong>le. Secondo l’antica tra<strong>di</strong>zione testimoniata dai<br />
Padri della <strong>Chiesa</strong>, la Cinquantina <strong>Pasqua</strong>le è il periodo adatto per aiutare a comprendere meglio i<br />
sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia, che inseriscono nel Mistero <strong>Pasqua</strong>le <strong>di</strong><br />
Cristo, e la loro “influenza” nella vita della <strong>Chiesa</strong> e del singolo <strong>di</strong>scepolo del Signore. È il tempo<br />
della mistagogia. È il tempo per approfon<strong>di</strong>re che cosa significhi e come testimoniare l’invito <strong>di</strong><br />
Paolo: «se siete risorti con Cristo, cercate le cose <strong>di</strong> lassù» (Col 1, 1) e «essere pasta nuova, poiché<br />
siete azzimi…Celebriamo dunque la festa con azzimi <strong>di</strong> sincerità e <strong>di</strong> verità» (1 Cor 5, 7-8). In<br />
questo cammino sono <strong>di</strong> grande aiuto le letture del Lezionario sia festivo sia feriale (si veda<br />
l’intervento apposito in queste <strong>di</strong>spense).<br />
Le liturgie della prima Domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> sono la <strong>di</strong>latazione della gioia della grande Veglia<br />
<strong>Pasqua</strong>le che richiama il nostro inserimento in Cristo nel giorno del Battesimo. Diventa opportuno<br />
sostituire l’atto penitenziale all’inizio della Messa con il rito dell’aspersione con l’acqua benedetta<br />
2
durante la Veglia <strong>Pasqua</strong>le e, al pomeriggio, prevedere la celebrazione dei Vespri Battesimali, che<br />
concludono il Triduo <strong>Pasqua</strong>le.<br />
Il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> per tanti combacia con la celebrazione della Cresima, della prima piena<br />
partecipazione all’Eucaristia, del Matrimonio e, conseguentemente con l’anniversario della<br />
celebrazione <strong>di</strong> tali sacramenti. Oggi, per vari motivi e mutate situazioni, questi sacramenti sono<br />
celebrati nell’arco dell’intero anno liturgico, però, è importante che si tenga vivo il loro<br />
collegamento con il Mistero <strong>Pasqua</strong>le <strong>di</strong> Cristo celebrato dalla <strong>Chiesa</strong>.<br />
Negli Atti degli apostoli si <strong>di</strong>ce che la comunità <strong>di</strong> Gerusalemme era perseverante e concorde<br />
nella preghiera insieme con Maria, la madre <strong>di</strong> Gesù (cfr. 1, 12-14). Il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> comprende<br />
gran parte o l’intero mese <strong>di</strong> maggio, mese de<strong>di</strong>cato alla devozione della Beata Vergine Maria.<br />
Simile coincidenza, unita alla tra<strong>di</strong>zione tipicamente bolognese dei c. d. “viaggi della Madonna”<br />
presenti in Città e in tante comunità parrocchiali, <strong>di</strong>venta occasione per esprimere la <strong>di</strong>latazione del<br />
gau<strong>di</strong>o della Vergine <strong>di</strong> Nazaret per la vittoria del Figlio sulla morte.<br />
Si suggerisce <strong>di</strong> rivalutare il suggerimento che fu dato dalla Congregazione per il culto <strong>di</strong>vino con la<br />
Lettera circolare del 3 <strong>aprile</strong> 1987 Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano<br />
al n. 21, ove si <strong>di</strong>ce che al termine della celebrazione eucaristico si inserisse l’invocazione finale<br />
alla Beata Vergine Maria con l’antifona Regina caeli oppure un altro canto che celebri insieme la<br />
risurrezione <strong>di</strong> Cristo e la gioia della Madre del Risorto.<br />
Una delle forme più tra<strong>di</strong>zionali della devozione mariana è la recita del Rosario. Questo “Salterio<br />
della Vergine” esige una recita tranquilla e me<strong>di</strong>tativa, perché incentrato sulla contemplazione degli<br />
eventi salvifici della vita <strong>di</strong> Cristo, cui fu strettamente associata la Vergine Madre.<br />
La solennità <strong>di</strong> Pentecoste conclude il grande gau<strong>di</strong>o pasquale.<br />
Nelle comunità c’era la tra<strong>di</strong>zionale “Novena”, che può essere rivalutata cercando <strong>di</strong> fare tesoro<br />
delle opportunità che offrono i testi delle letture e delle orazioni delle Messe e della Liturgia delle<br />
ore nei giorni feriali.<br />
Sarebbe molto opportuno, poi, che a livello zonale o parrocchiale si instaurasse la celebrazione della<br />
Veglia seguendo le in<strong>di</strong>cazioni del Messale Romano (cfr. pp. 239-240.979-980). Nella celebrazione<br />
eucaristica si potrebbe inserire la memoria dell’anniversario della Cofermazione seguendo la<br />
proposta riportata più avanti.<br />
Dopo i Secon<strong>di</strong> Vespri termina il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, si spegne il cero pasquale, che viene portato<br />
presso il battistero e verrà normalmente acceso in occasione della celebrazione del Battesimo e delle<br />
esequie, per richiamare la prima e ultima <strong>Pasqua</strong> del cristiano. Si potrà sottolineare simile gesto con<br />
un apposito rito riportato più avanti.<br />
MEMORIA DELLA CONFERMAZIONE<br />
Dopo l’omelia, il presidente introduce con queste o altre parole simili:<br />
Fratelli e sorelle, nella notte santa <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> abbiamo rinnovato le<br />
promesse battesimali. In questo giorno <strong>di</strong> Pentecoste, che ci fa riscoprire<br />
la presenza e l’azione dello Spirito operante nella <strong>Chiesa</strong>, ricor<strong>di</strong>amo il<br />
sacramento della Confermazione, invocando la rinnovata spirituale<br />
unzione del Paraclito, affinché si accresca in noi l’impegno della<br />
comunione e della missione.<br />
Tutti pregano per qualche momento in silenzio. Quin<strong>di</strong> il presidente pronuncia la<br />
seguente supplica intercalata dall’invocazione allo Spirito Santo.<br />
3
Presidente: Spirito increato, forza primor<strong>di</strong>ale dell’universo,<br />
potenza santificatrice della <strong>Chiesa</strong>,<br />
ravviva in noi i doni del Battesimo e della Confermazione.<br />
Assemblea: Vieni Spirito Santo.<br />
Presidente: Spirito <strong>di</strong> vita, soffio d’amore<br />
energia scaturita dalla Croce,<br />
rinvigorisci nel cuore dei tuoi fedeli<br />
l’impegno a vivere come stirpe eletta, sacerdozio regale,<br />
nazione santa, popolo che Dio si è acquistato.<br />
Assemblea: Vieni Spirito Santo.<br />
Presidente: Spirito del Padre e del Figlio,<br />
<strong>di</strong>sceso sulla Vergine,<br />
donato agli Apostoli,<br />
anima e feconda la <strong>Chiesa</strong><br />
con il conforto dei tuoi sette santi doni.<br />
Assemblea: Vieni Spirito Santo.<br />
Presidente: Nello stesso Spirito, ora invocato,<br />
professiamo la fede cattolica.<br />
Tutti <strong>di</strong>cono il Credo utilizzando il “Simbolo apostolico”.<br />
RITO DELLO SPEGNIMENTO DEL CERO PASQUALE<br />
Al termine della celebrazione, prima del congedo, il presidente <strong>di</strong>ce:<br />
Fratelli e sorelle, nella notte che ha dato vita al<br />
“lietissimo spazio” del <strong>Tempo</strong> <strong>Pasqua</strong>le,<br />
il giorno <strong>di</strong> cinquanta giorni,<br />
all’accensione del cero abbiamo acclamato a Cristo nostra luce.<br />
E la luce del cero pasquale ci ha accompagnati in questi giorni<br />
e ha contribuito a ricordarci la grande realtà del mistero pasquale.<br />
Oggi, nel giorno <strong>di</strong> Pentecoste,<br />
al chiudersi del <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>,<br />
il cero pasquale viene spento.<br />
Questo segno ci viene tolto, anche perché,<br />
allenati alla scuola del Maestro Risorto<br />
e infuocati dal dono dello Spirito Santo,<br />
ormai dobbiamo essere noi luce <strong>di</strong> Cristo che si irra<strong>di</strong>a<br />
e, come colonna luminosa,<br />
passa nel mondo, in mezzo ai fratelli,<br />
4
per guidarli nell’esodo verso la Terra promessa.<br />
Vedremo ancora, nel corso dell’anno liturgico,<br />
risplendere la luce del cero pasquale<br />
soprattutto in due importanti momenti del cammino della <strong>Chiesa</strong>:<br />
per la prima <strong>Pasqua</strong> che vivranno i suoi figli nel Battesimo,<br />
e per l’ultima <strong>Pasqua</strong> quando, con la morte, faranno ingresso nella vera vita.<br />
Si canta come ritornello un’acclamazione a Cristo luce.<br />
Lettore: O raggio benedetto, prima fonte <strong>di</strong> luce,<br />
o ardentemente desiderato al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> tutto;<br />
potente, inscrutabile e ineffabile; gioia del bene,<br />
visione <strong>di</strong> speranza sod<strong>di</strong>sfatta, lodato e celebrato,<br />
Cristo creatore, Re della gloria, certezza <strong>di</strong> vita,<br />
colma i vuoti della nostra voce con la tua Parola onnipotente<br />
e offrila come supplica gra<strong>di</strong>ta al Padre tuo altissimo. Rit.<br />
Lettore: Splendore della gloria del Padre,<br />
che <strong>di</strong>ffon<strong>di</strong> il chiarore della vera luce,<br />
raggio della luce, fonte <strong>di</strong> ogni bagliore.<br />
Tu, giorno che illumini il giorno,<br />
tu vero sole, penetri e infon<strong>di</strong> nei nostri sensi<br />
la fiamma del tuo Spirito. Rit.<br />
Lettore: Sei la lampada della casa paterna che illumina <strong>di</strong> luce soffusa,<br />
Tu sei il sole <strong>di</strong> giustizia, il giorno che mai volge al tramonto,<br />
la luminosa stella del mattino. Rit.<br />
Lettore: Tu del mondo sei il vero datore <strong>di</strong> luce,<br />
più luminoso del pieno sole, tutto luce e giorno,<br />
illumini i profon<strong>di</strong> sentimenti del nostro cuore. Rit.<br />
Lettore: O luce dei miei occhi, dolce Signore, <strong>di</strong>fesa dei miei giorni,<br />
o viva fiamma della mia lucerna, o Dio, mia luce,<br />
rischiara il mio cammino, Tu sola speranza nella lunga notte Rit.<br />
Mentre si canta il ritornello, il <strong>di</strong>acono o il presidente spegne il cero; quin<strong>di</strong> il<br />
presidente <strong>di</strong>ce la seguente orazione:<br />
Preghiamo.<br />
Degnati, o Cristo, dolcissimo Salvatore,<br />
<strong>di</strong> accendere le nostre lampade;<br />
costantemente nel tuo tempio rifulgano,<br />
alimentate da te, che sei la luce eterna.<br />
Siano rischiarati gli angoli oscuri del nostro spirito e<br />
5
Tutti: Amen.<br />
siano fugate lontano da noi le tenebre del mondo.<br />
Fa’ che ve<strong>di</strong>amo, contempliamo, desideriamo te solo,<br />
te solo amiamo, sempre in attesa fervente <strong>di</strong> te,<br />
che vivi e regni con il Padre,<br />
nell’unità dello Spirito Santo<br />
per tutti i secoli dei secoli.<br />
Presidente: La fede in Cristo Risorto illumini sempre i nostri cuori<br />
e rischiariamo con questa speranza le contrade del mondo.<br />
Andate in pace, alleluia, alleluia.<br />
Tutti: Ren<strong>di</strong>amo grazie a Dio, alleluia, alleluia.<br />
L’assemblea si scioglie mentre esegue un canto alla Beata Vergine Maria.<br />
6
La celebrazione del Mistero <strong>Pasqua</strong>le/2<br />
L’unità del Mistero <strong>Pasqua</strong>le<br />
Nella precedente trattazione de<strong>di</strong>cata alla Quaresima e al Triduo Sacro, abbiamo sottolineato il<br />
carattere unitario del “mistero pasquale”, al quale la <strong>Chiesa</strong> si prepara, con la celebrazione del<br />
sacramento quaresimale e che poi celebra, con pienezza <strong>di</strong> segni, nel tempo pasquale.<br />
In questo senso, il tempo pasquale non è da intendere solo come commemorazione della<br />
risurrezione del Signore, ma come celebrazione riattualizzante (memoriale) <strong>di</strong> tutto il mistero,<br />
secondo l’espressione paolina, ripresa più volte dalla liturgia, in particolare nel canto <strong>di</strong> comunione<br />
della veglia e del giorno <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: “Cristo, nostra <strong>Pasqua</strong>, è stato immolato: celebriamo dunque la<br />
festa con purezza e verità, alleluia” (1 Cor 5,7-8).<br />
La risurrezione è inseparabile dalla crocifissione, e viceversa: “Gesù, il crocifisso è risorto, come<br />
aveva detto, alleluia” (seconda ant. <strong>di</strong> Comunione pasquale, Mt <strong>28</strong>,5.6).<br />
La passione e morte del Signore restano parte integrante dell’annuncio e della celebrazione della<br />
<strong>Chiesa</strong>, in quanto inseparabili dalla risurrezione: il concetto stesso <strong>di</strong> “risurrezione” è inseparabile<br />
dalla morte: “Cristo è risorto dai morti, con la sua morte ha <strong>di</strong>strutto la morte, ai morti ha dato la<br />
vita” (tropario pasquale bizantino).<br />
Progre<strong>di</strong>re nel mistero della vita<br />
I vangeli e la fede della <strong>Chiesa</strong> non descrivono la risurrezione <strong>di</strong> Gesù come un “ritorno alla vita”:<br />
non si tratta del ristabilimento, seppur pro<strong>di</strong>gioso, della situazione precedente alla morte. Questo<br />
semmai è il caso <strong>di</strong> Lazzaro, che per opera <strong>di</strong> Cristo “tornò” alla vita, alla vita mortale.<br />
Cristo invece è transitato attraverso la morte ed è avanzato nella pienezza della vita (fisica e<br />
corporale, ma anche spirituale). Il sepolcro vuoto testimonia la storicità e la tangibilità del fatto, ma<br />
la modalità delle apparizioni, per le quali il Signore è riconosciuto presente solo attraverso la fede,<br />
mostra che egli è entrato in una <strong>di</strong>mensione che per noi, pellegrini sulla terra, è raggiungibile solo<br />
nella grazia della fede.<br />
In effetti, piuttosto che <strong>di</strong> “apparizioni” <strong>di</strong> Gesù risorto ai <strong>di</strong>scepoli, dovremmo parlare con Gv<br />
21,1ss <strong>di</strong> “manifestazioni” del risorto. Non è che il Signore appare e scompare: egli è sempre con i<br />
suoi e in alcuni momenti manifesta questa sua presenza.<br />
La “fede” resta la chiave centrale <strong>di</strong> questo nuovo rapporto tra Cristo e i suoi <strong>di</strong>scepoli. Solo per<br />
iniziare una riflessione potremmo infatti chiederci: perché Gesù dopo la sua risurrezione non si è<br />
manifestato a Caifa, o a Pilato, o alla folla che aveva urlato “Crucifige!”?. Dalla risposta a questo<br />
interrogativo potremo comprendere perché il Signore vuole essere conosciuto attraverso la fede e<br />
non attraverso l’evidenza…<br />
Dal Catechismo della <strong>Chiesa</strong> Cattolica<br />
646 La risurrezione <strong>di</strong> Cristo non fu un ritorno alla vita terrena, come lo fu per le risurrezioni che egli aveva<br />
compiute prima della pasqua: quelle della figlia <strong>di</strong> Giairo, del giovane <strong>di</strong> Naim, <strong>di</strong> Lazzaro. Questi fatti erano<br />
avvenimenti miracolosi, ma le persone miracolate ritrovavano, per il potere <strong>di</strong> Gesù, una vita terrena<br />
«or<strong>di</strong>naria». Ad un certo momento esse sarebbero morte <strong>di</strong> nuovo. La risurrezione <strong>di</strong> Cristo è essenzialmente<br />
<strong>di</strong>versa. Nel suo corpo risuscitato egli passa dallo stato <strong>di</strong> morte ad un'altra vita al <strong>di</strong> là del tempo e dello<br />
spazio. Il corpo <strong>di</strong> Gesù è, nella risurrezione, colmato della potenza dello Spirito Santo; partecipa alla vita<br />
<strong>di</strong>vina nello stato della sua gloria, sì che san Paolo può <strong>di</strong>re <strong>di</strong> Cristo che egli è l'uomo celeste (Cf 1 Cor 15,35-<br />
50).<br />
7
La “sacramentalità” della liturgia<br />
Come abbiamo visto, nella messa vespertina del Giovedì Santo, la <strong>Chiesa</strong> ricorda come nell’ultima<br />
Cena il Signore Gesù le consegnò il rito nuovo della <strong>Pasqua</strong>: esso, superando la barriera fisicamente<br />
invalicabile del tempo e dello spazio, pone il credente in comunione reale con il sacrificio pasquale<br />
e con il suo effetto <strong>di</strong> grazia. La <strong>Chiesa</strong> esprime questa consapevolezza, ripetendo spesso e<br />
particolarmente nei giorni santi, l’espressione “Oggi”.<br />
Dal Catechismo della <strong>Chiesa</strong> Cattolica<br />
1165 Quando la <strong>Chiesa</strong> celebra il mistero <strong>di</strong> Cristo, una parola scan<strong>di</strong>sce la sua preghiera: «Oggi! », come eco<br />
della preghiera che le ha insegnato il suo Signore (Cf Mt 6,11) e dell'invito dello Spirito Santo.(Cf Eb 3,7–<br />
4,11; Sal 95,8). Questo «oggi» del Dio vivente in cui l'uomo è chiamato ad entrare è l'«Ora» della pasqua <strong>di</strong><br />
Gesù, che attraversa tutta la storia e ne è il car<strong>di</strong>ne:<br />
«La vita si è posata su tutti gli esseri e tutti sono investiti da una grande luce; l'Oriente degli<br />
orienti ha invaso l'universo, e colui che era prima della stella del mattino e prima degli astri,<br />
immortale e immenso, il grande Cristo, brilla su tutti gli esseri più del sole. Perciò, per noi che<br />
cre<strong>di</strong>amo in lui, sorge un giorno <strong>di</strong> luce, lungo, eterno, che non si spegnerà più: la <strong>Pasqua</strong><br />
mistica» (Pseudo-Ippolito Romano, In sanctum Pascha, 1, 1-2: Stu<strong>di</strong>a patristica me<strong>di</strong>olanensia<br />
15, 230-232).<br />
1168 A partire dal Triduo pasquale, come dalla sua fonte <strong>di</strong> luce, il tempo nuovo della risurrezione permea<br />
tutto l'anno liturgico del suo splendore. Progressivamente, da un versante e dall'altro <strong>di</strong> questa fonte, l'anno è<br />
trasfigurato dalla liturgia. Esso costituisce realmente l'anno <strong>di</strong> grazia del Signore (Cf Lc 4,19). L'Economia<br />
della salvezza è all'opera nello svolgersi del tempo, ma dopo il suo compimento nella pasqua <strong>di</strong> Gesù e<br />
nell'effusione dello Spirito Santo, la conclusione della storia è anticipata, « pregustata », e il regno <strong>di</strong> Dio entra<br />
nel nostro tempo.<br />
Oltre a quanto abbiamo annotato nella trattazione del Giovedì Santo, possiamo richiamare<br />
l’attenzione su un altro aspetto molto suggestivo: nel CANONE ROMANO, che è la Preghiera<br />
Eucaristica (anafora) più antica tra quelle presenti nel Messale Romano in uso oggi, il sacerdote<br />
prendendo in mano il calice, esprime la consapevolezza <strong>di</strong> una identificazione totale tra la <strong>Chiesa</strong><br />
che concretamente celebra, e l’atto oblativo <strong>di</strong> Cristo, nel segno dell’identico calice:<br />
“Dopo la cena, allo stesso modo,<br />
prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, …”.<br />
Si potrebbe <strong>di</strong>re, in sintesi, che “oggetto” della celebrazione del tempo pasquale non è un singolo<br />
aspetto ma tutto il mistero <strong>di</strong> Cristo, <strong>di</strong> incarnazione, passione, morte, sepoltura e risurrezione, la cui<br />
efficacia <strong>di</strong> salvezza è <strong>di</strong>sponibile “qui e ora”, per la <strong>Chiesa</strong> che lo celebra nel sacramento.<br />
1169 Per questo la <strong>Pasqua</strong> non è semplicemente una festa tra le altre: è la «festa delle feste», la «solennità delle<br />
solennità», come l'Eucaristia è il sacramento dei sacramenti (il grande sacramento). Sant'Atanasio la chiama «la grande<br />
domenica» (Sant'Atanasio <strong>di</strong> Alessandria, Epistula festivalis, 1 (anno 329), 10: PG 26, 1366), come la Settimana santa<br />
in Oriente è chiamata «la grande Settimana». Il mistero della risurrezione, nel quale Cristo ha annientato la morte,<br />
permea della sua potente energia il nostro vecchio tempo, fino a quando tutto gli sia sottomesso.<br />
1171 L'anno liturgico è il <strong>di</strong>spiegarsi dei <strong>di</strong>versi aspetti dell'unico mistero pasquale. Questo è vero soprattutto per il<br />
ciclo delle feste relative al mistero dell'incarnazione (Annunciazione, Natale, Epifania) le quali fanno memoria degli<br />
inizi della nostra salvezza e ci comunicano le primizie del mistero <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
Il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: l’ottava e la cinquantina<br />
Fin dalle origini paleocristiane, fu ben chiaro che la solennità pasquale non poteva considerarsi una<br />
semplice ricorrenza annuale del calendario: per questo le fu attribuito uno spazio temporale più<br />
vasto e ben identificato, tanto in oriente quanto in occidente: i cinquanta giorni successivi, con una<br />
accentuazione speciale nei primi otto, de<strong>di</strong>cati da una parte alla contemplazione delle testimonianze<br />
evangeliche relative alla risurrezione (come ancor oggi nella liturgia dell’ottava) e d’altra parte alla<br />
8
introduzione dei fedeli appena battezzati nella comunità e nella vita cristiana, con la catechesi sui<br />
sacramenti.<br />
I cinquanta giorni: la “grande domenica”<br />
Una delle più antiche attestazioni storiche della Pentecoste è contenuta nel De oratione <strong>di</strong><br />
Tertulliano (150-230ca); l’autore si riferisce alla pratica delle prostrazioni (metanie), frequenti nel<br />
culto cristiano primitivo:<br />
Noi, in conformità alla tra<strong>di</strong>zione ricevuta, esclusivamente nel giorno della risurrezione del<br />
Signore dobbiamo guardarci non solo dal prostrarci in ginocchio, ma da qualsiasi<br />
comportamento e da qualsiasi gesto <strong>di</strong> culto che esprima angoscia e dolore; riman<strong>di</strong>amo<br />
perfino i nostri affari per non lasciare al <strong>di</strong>avolo nessuna occasione <strong>di</strong> operare. Lo stesso<br />
facciamo anche durante la Pentecoste; lo trascorriamo, a <strong>di</strong>versità degli altri perio<strong>di</strong><br />
dell’anno, con uguale solennità e viviamo nella gioia 1 .<br />
Tertulliano si riferisce qui alla Pentecoste non come ad una festa a sé stante, ma come al periodo <strong>di</strong><br />
50 giorni nei quali si <strong>di</strong>lata la celebrazione della <strong>Pasqua</strong>. Fin dall’epoca apostolica, la preghiera<br />
restando in pie<strong>di</strong>, senza prostrazioni, era riservata esclusivamente alla domenica: la Pentecoste era<br />
dunque vissuta fin dall’origine come una “grande domenica”.<br />
La Cinquantina pasquale doveva essere un tempo <strong>di</strong> riposo e <strong>di</strong> gioia, con la celebrazione frequente,<br />
se non ad<strong>di</strong>rittura quoti<strong>di</strong>ana dell’Eucaristia 2 . Da Sant’Agostino appren<strong>di</strong>amo che durante la<br />
Pentecoste erano sospese le cause giu<strong>di</strong>ziarie (probabilmente nel solo tribunale episcopale) e i fedeli<br />
dovevano piuttosto esercitarsi nella carità e nel perdono reciproco. Si trovano anche in<strong>di</strong>cazioni<br />
antiche sulla norma <strong>di</strong> astenersi dai lavori servili, ma questo <strong>di</strong> fatto non accadeva (e non poteva<br />
ovviamente accadere), se non nei primi giorni <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>. Il riposo festivo venne progressivamente<br />
riducendosi all’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, poi al lunedì e al martedì dell’ottava, oggi al solo lunedì<br />
(Pasquetta).<br />
La Pentecoste e il Giubileo<br />
La norma apostolica della gioia pentecostale ha delle profonde attinenze con quella ebraica del<br />
Giubileo (Lv 25,10-13 3 ), che prevedeva l’astensione da ogni lavoro per un anno intero e il recupero<br />
<strong>di</strong> quanto si era perduto: una norma che non ha avuto praticamente mai una vera e propria<br />
realizzazione e che costituiva per Israele più un ideale, un segno <strong>di</strong> speranza, che una realtà storica.<br />
Altrettanto si dovrebbe <strong>di</strong>re per il Popolo della Nuova Alleanza: il tempo della Pentecoste dovrebbe<br />
essere il tempo della libertà dalle costrizioni materiali, per pregustare la gioia della <strong>Pasqua</strong> eterna; il<br />
tempo nel quale la legge suprema è l’amore fraterno e la comunione, tempo nel quale toccare con<br />
mano e godere della vita nuova in Cristo e nella <strong>Chiesa</strong>.<br />
Già Origene, nel terzo secolo, scriveva che il numero cinquanta ricorda il giubileo ed è come un<br />
sacramento del perdono e dell’indulgenza (In Num. hom., 5,2). Isidoro <strong>di</strong> Siviglia, alla fine del<br />
secolo successivo, aggiungeva che "il giubileo si interpreta come l’anno del perdono... Anche noi<br />
celebriamo questo numero con la festa <strong>di</strong> Pentecoste, cinquanta giorni dopo la risurrezione del<br />
1 Le prostrazioni sono ancora molto presenti nella pratica spirituale orientale e, in quaresima, costituiscono un vero e<br />
proprio esercizio <strong>di</strong> mortificazione, perché vengono ripetute molte volte, anche durante la celebrazione liturgica: i fedeli<br />
compiono il segno della croce, poi – piegando entrambi le ginocchia – arrivano a sfiorare il pavimento con la fronte, per<br />
poi tornare in posizione eretta. Questa pratica nell’antichità era <strong>di</strong>ffusa in tutto il mondo cristiano, ma in occidente<br />
venne pian piano scomparendo, sostituita dal semplice pregare in ginocchio, fatto oggi più raro in oriente.<br />
2 Dobbiamo considerare che nell’antichità la celebrazione eucaristica era vissuta come un grande momento <strong>di</strong> gioia<br />
comunitaria, anche perché associata all’agape fraterna. Questo è il motivo per cui le sinassi (riunioni liturgiche) della<br />
quaresima, comportavano raramente l’offerta eucaristica, nei giorni infrasettimanali.<br />
3 “Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi<br />
un giubileo; ognuno <strong>di</strong> voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno sarà per voi un<br />
giubileo; non farete né semina, né mietitura <strong>di</strong> quanto i campi produrranno da sé. Né farete la vendemmia delle vigne<br />
non potate. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro; potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno<br />
del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo”.<br />
9
Signore, con cui la colpa è rimessa e la pena è cancellata, così che liberi da ogni legame possiamo<br />
ricevere la grazia dello Spirito Santo che viene a noi" (Etym., lib. V, 37,3-4).<br />
Non è un caso che la MESSA CRISMALE, vero prelu<strong>di</strong>o della <strong>Pasqua</strong>, riproponga i testi <strong>di</strong> Is 61 e Lc<br />
4, che presentano il Messia-Cristo come colui che promulga l’anno <strong>di</strong> grazia del Signore:<br />
Is 61,1-3.6.8b-9; Lc 4,16-21<br />
“Lo Spirito del Signore è sopra <strong>di</strong> me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a<br />
portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a<br />
rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno <strong>di</strong> grazia del Signore”.<br />
La Liturgia stessa <strong>di</strong> Pentecoste vede nella celebrazione dei 50 giorni pasquali il compimento<br />
dell’antica legge del Giubileo, come testimonia in particolare l’inno delle Lo<strong>di</strong> mattutine 4 , <strong>di</strong> un<br />
autore anonimo del sesto secolo.<br />
1. Beáta nobis gáu<strong>di</strong>a / anni redúxit órbita,<br />
cum Spíritus Paráclitus / effúlsit in <strong>di</strong>scípulos.<br />
2. Ignis vibránte lúmine / linguæ figúram détulit,<br />
verbis ut essent próflui / et caritáte férvi<strong>di</strong>.<br />
3. Linguis loquúntur ómnium; / turbæ pavent gentílium,<br />
musto madére députant, / quos Spíritus repléverat.<br />
4. Patráta sunt hæc m!stice / Paschæ perácto témpore,<br />
sacro <strong>di</strong>érum número, / quo lege fit remíssio.<br />
5. Te nunc, Deus piíssime, / vultu precámur cérnuo:<br />
illápsa nobis cælitus / largíre dona Spíritus.<br />
6. Dudum sacráta péctora / tua replésti grátia;<br />
<strong>di</strong>mítte nunc peccámina / et da quiéta témpora.<br />
7. Per te sciámus da Patrem / noscámus atque Fílium,<br />
te utriúsque Spíritum / credámus omni témpore. Amen.<br />
1. Il ciclo dell’anno ci ha riportato le gioie beate <strong>di</strong><br />
quando lo Spirito Paraclito risplendette nei <strong>di</strong>scepoli.<br />
2. Con una luce sfolgorante <strong>di</strong> fuoco, <strong>di</strong>scese in forma <strong>di</strong><br />
lingua, affinché fossero fluenti nel parlare e fervi<strong>di</strong><br />
nell’amare.<br />
3. Parlano nelle lingue <strong>di</strong> tutti; restano sbigottite le folle<br />
dei gentili, reputano ubriachi <strong>di</strong> mosto coloro che lo<br />
Spirito ha riempito.<br />
4. Si compirono queste cose misticamente passato dalla<br />
<strong>Pasqua</strong> il sacro numero <strong>di</strong> giorni, in cui nella legge si<br />
compie la remissione.<br />
5. Ora, o Dio piissimo, ti preghiamo, col capo chino:<br />
conce<strong>di</strong>ci i doni dello Spirito <strong>di</strong>scesi dal cielo.<br />
6. Da tempo hai riempito <strong>di</strong> grazia i cuori che hai<br />
consacrato; ora perdona i peccati e dà un tempo<br />
tranquillo.<br />
7. Conce<strong>di</strong> che per te conosciamo il Padre e<br />
riconosciamo anche il Figlio e cre<strong>di</strong>amo in ogni tempo in<br />
te, Spirito <strong>di</strong> entrambi. Amen.<br />
La lettura “giubilare” della Pentecoste cristiana, offre alcune prospettive spirituali molto<br />
significative. Possiamo tentare una lettura in parallelo tra queste due realtà:<br />
IL GIUBILEO EBRAICO (cfr. Lv 25) LA PENTECOSTE CRISTIANA<br />
Il periodo <strong>di</strong> 50 anni: sette settimane <strong>di</strong> anni, più uno.<br />
Ogni sette anni, vi era l’anno sabbatico, vissuto come un<br />
grande sabato. Ogni sette anni sabbatici, si aggiungeva<br />
l’anno del giubileo.<br />
<strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> riposo dal lavoro della terra.<br />
<strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> riposo per la terra stessa, che non doveva essere<br />
lavorata, ma lasciata produrre spontaneamente i suoi<br />
frutti.<br />
10<br />
Sette settimane, più una domenica: sette, numero<br />
simbolico del tempo, moltiplicato per se stesso (cioè<br />
considerato nella sua pienezza), più uno, il numero<br />
dell’unità <strong>di</strong> Dio, della sua infinita perfezione, il numero<br />
dell’eternità.<br />
La <strong>Pasqua</strong> ci introduce nel riposo <strong>di</strong> Dio; riposo che<br />
afferma la libertà dell’uomo rispetto alla schiavitù delle<br />
cose materiali.<br />
La <strong>Pasqua</strong> ricostituisce l’armonia, il giusto rapporto con<br />
le cose materiali e con i beni del cosmo.<br />
4 Traduzione liturgica in italiano:<br />
Giorno d'immensa gioia nella città <strong>di</strong> Dio: la fiamma dello Spirito risplende nel cenacolo.<br />
Si rinnova il pro<strong>di</strong>gio degli antichi profeti: una mistica ebbrezza tocca le lingue e i cuori.<br />
O stagione beata della <strong>Chiesa</strong> nascente, che accoglie nel suo grembo le primizie dei popoli!<br />
E' questo il giubileo dell'anno cinquantesimo, che riscatta gli schiavi e proclama il perdono.<br />
Manda su noi, Signore, il dono del tuo Spirito, conce<strong>di</strong> al mondo inquieto la giustizia e la pace.<br />
O luce <strong>di</strong> sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen.
Si ritorna in possesso dei propri beni perduti.<br />
È ban<strong>di</strong>ta ogni forma <strong>di</strong> oppressione sul prossimo.<br />
Il Giubileo ristabilisce il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> Dio sul creato, <strong>di</strong> cui<br />
l’uomo è solo ospite, non proprietario.<br />
Il Giubileo restituisce la libertà perduta.<br />
Il Giubileo afferma che Israele è proprietà <strong>di</strong>vina e che<br />
ogni membro del popolo è a servizio <strong>di</strong> Dio.<br />
11<br />
La <strong>Pasqua</strong> ricostituisce la nostra <strong>di</strong>gnità ferita e ci rende il<br />
dono perduto della misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong>vina e la <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong> figli<br />
<strong>di</strong> Dio.<br />
Nella mistero della sua <strong>Pasqua</strong>, riceviamo in dono lo<br />
Spirito Santo, l’amore stesso <strong>di</strong> Dio, che produce rapporti<br />
nuovi, <strong>di</strong> fraternità, <strong>di</strong> amore e <strong>di</strong> servizio reciproco, e<br />
rende ogni uomo, nostro “prossimo”. La <strong>Pasqua</strong> dona la<br />
gioia della carità fraterna.<br />
Nella <strong>Pasqua</strong> noi proclamiamo che “Gesù Cristo è il<br />
Signore”, che sconfigge ogni dominio che opprime<br />
l’uomo: il male, il peccato, la morte.<br />
L’uomo è liberato dalla necessità <strong>di</strong> possedere e ritrova in<br />
Cristo la sua autentica libertà.<br />
Dalla <strong>Pasqua</strong> nasce la <strong>Chiesa</strong> <strong>di</strong> Dio, che Cristo “si è<br />
acquistata con il suo sangue” (At 20,<strong>28</strong>).<br />
Si potrebbe tentare un altro suggestivo percorso, che qui abbozziamo solamente: quello <strong>di</strong> rileggere,<br />
alla luce della tra<strong>di</strong>zione ebraica del “giubileo” i cosiddetti sommari degli Atti degli Apostoli, che<br />
contengono una decrizione ideale della comunità dei credenti. Gli Atti mostrano come la grazia<br />
della fede in Cristo, crocifisso risorto, definisce un rapporto nuovo con se stessi, con i fratelli, con le<br />
cose materiali. La gioia dell’amore fraterno è la nota dominante della vita <strong>di</strong> questo nuovo popolo,<br />
riscattato dal Sangue <strong>di</strong> Cristo.<br />
Atti degli Apostoli 2,42-48; 4,32-35<br />
42 Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del<br />
pane e nelle preghiere. 43 Un senso <strong>di</strong> timore era in tutti e pro<strong>di</strong>gi e segni avvenivano per opera degli<br />
apostoli. 44 Tutti coloro che erano <strong>di</strong>ventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in<br />
comune; 45 chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno <strong>di</strong><br />
ciascuno. 46 Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo<br />
i pasti con letizia e semplicità <strong>di</strong> cuore, 47 lodando Dio e godendo la simpatia <strong>di</strong> tutto il<br />
popolo. 48 Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.<br />
32 La moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> coloro che eran venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno<br />
<strong>di</strong>ceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. 33 Con grande forza<br />
gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano <strong>di</strong><br />
grande simpatia. 34 Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li<br />
vendevano, portavano l'importo <strong>di</strong> ciò che era stato venduto 35 e lo deponevano ai pie<strong>di</strong> degli apostoli;<br />
e poi veniva <strong>di</strong>stribuito a ciascuno secondo il bisogno.<br />
Quaresima e Pentecoste: “sacramento” del presente e del futuro<br />
“Ecco, questi giorni santi che celebriamo dopo la resurrezione del Signore rappresentano la vita<br />
futura, quella che vivremo dopo la resurrezione. Come i giorni della quaresima, celebrati prima<br />
della <strong>Pasqua</strong>, hanno simboleggiato la vita stentata fra le tribolazioni della con<strong>di</strong>zione mortale, così<br />
questi giorni <strong>di</strong> letizia simboleggiano la vita futura quando regneremo insieme col Signore. La vita<br />
raffigurata dalla quaresima, prima <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, è quella che viviamo adesso; la vita raffigurata dai<br />
cinquanta giorni che seguono la resurrezione del Signore non è quella che viviamo adesso ma quella<br />
che speriamo e, nella speranza, amiamo. Mentre la si ama, si loda Dio che ce l'ha promessa, e tali<br />
lo<strong>di</strong> costituiscono l'Alleluia”. (dal <strong>di</strong>scorso 243 <strong>di</strong> sant’Agostino).<br />
“Ma voi sapete che l'importante per noi è fare il bene durante il periodo dei quaranta, in modo che<br />
nel periodo dei cinquanta possiamo lodare il Signore. Per questo celebriamo nella fatica, nel <strong>di</strong>giuno<br />
e nell'astinenza i quaranta giorni che precedono la veglia: essi simboleggiano il tempo presente. I<br />
giorni che decorrono dopo la resurrezione del Signore simboleggiano invece la gioia eterna. Non<br />
sono la gioia eterna ma la simboleggiano: si tratta <strong>di</strong> una rappresentazione misteriosa, fratelli, non<br />
ancora della realtà. Difatti, quando noi celebriamo la <strong>Pasqua</strong> non è che venga crocifisso il Signore,<br />
ma come simbolicamente celebriamo con ricordo annuale i fatti del passato così anche anticipiamo
quelli dell'avvenire. Sta comunque il fatto che in questo tempo attenuiamo i <strong>di</strong>giuni: a significare<br />
che il numero <strong>di</strong> questi giorni ci rappresenta la pace che ha da venire. Badate, fratelli, che non vi<br />
succeda che, volendo celebrare questi giorni in maniera carnale, con indebito permissivismo e<br />
manica larga vi abbandoniate a ubriachezze smodate e così non meritiate <strong>di</strong> celebrare in eterno con<br />
gli angeli ciò che i giorni stessi simboleggiano. Poni che io debba rimproverare un ubriaco. Egli mi<br />
<strong>di</strong>rà: Tu stesso ci hai insegnato che questi giorni raffigurano la gioia eterna; tu ci hai lasciato<br />
intravvedere che questo tempo è il preannuncio del go<strong>di</strong>mento che proveremo in cielo insieme con<br />
gli angeli. Non dovevo quin<strong>di</strong> passarmeli bene? Oh! bene sì, non male. Il periodo attuale ti<br />
rappresenta infatti la gioia eterna se sarai stato tempio <strong>di</strong> Dio. Se viceversa riempi questo tempio <strong>di</strong><br />
Dio con la sporcizia dell'ubriachezza, dovranno risuonarti all'orecchio le parole dell'Apostolo: Chi<br />
violerà il tempio <strong>di</strong> Dio, Dio lo annienterà. Sia pertanto scolpito nel cuore della vostra Santità<br />
questo: è meglio un uomo che capisce poco ma vive bene anziché uno che capisce molto ma vive<br />
male”. (dal <strong>di</strong>scorso 252 <strong>di</strong> sant’Agostino).<br />
Gli otto e i cinquanta giorni.<br />
L’antica tra<strong>di</strong>zione cristiana, testimoniata in particolare da sant’Agostino, poneva in grande rilievo<br />
il significato teologico dei numeri 8 (7 + 1), e 50 (7x7 + 1) come annuncio del giorno eterno <strong>di</strong> Dio.<br />
Dal <strong>di</strong>scorso 260/c sull’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: “Notate qui che, come nell'ottava dei sacramenti il giorno ottavo<br />
giunge dopo i sette, così accade nel sacramento della Pentecoste, che arriva dopo sette settimane che<br />
chiu<strong>di</strong>amo nel quarantanovesimo giorno. Anche lì si aggiunge un ottavo giorno per arrivare al numero<br />
completo <strong>di</strong> cinquanta: una unità nel numero minore e parimenti una unità nel numero maggiore. Ma, per<br />
quanto concerne l'eternità, <strong>di</strong> cui l'ottavo giorno è simbolo, non può né crescere né <strong>di</strong>minuire: è un oggi<br />
perpetuo, poiché non c'è tempo nuovo che subentri a quello che se ne va. Quell'oggi non inizia con la fine del<br />
giorno <strong>di</strong> ieri né termina quando inizierà il domani, ma è un oggi che rimane per sempre. Se ci sono stati<br />
tempi passati, essi son tutti passati senza che quel giorno passasse; e se verranno tempi futuri, verranno tutti<br />
senza che quel giorno inizi”.<br />
Dal <strong>di</strong>scorso 259 sull’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: “È come quando adesso, passati sette giorni, si entra nell'ottavo che<br />
equivale al primo. Allo stesso modo, quando saranno passate e terminate le sette epoche in cui si snoda il<br />
tempo presente, destinato a passare, torneremo allo stato <strong>di</strong> immortalità e beatitu<strong>di</strong>ne da cui decadde l'uomo.<br />
Per questo nel giorno ottavo si dà compimento ai sacramenti conferiti agli infanti. E, riguardo al numero<br />
sette, se lo si moltiplica per sette si ha quarantanove: al quale numero se si aggiunge una unità si ottiene<br />
come un ritorno al punto <strong>di</strong> partenza e si ha cinquanta, numero che nel mistero noi celebriamo nei giorni da<br />
<strong>Pasqua</strong> a Pentecoste. Lo stesso risultato vien fuori se, pur con computo <strong>di</strong>verso, il numero quaranta viene<br />
<strong>di</strong>viso come sopra proponevamo, aggiungendo poi il numero <strong>di</strong>eci come simbolo della ricompensa. In questa<br />
maniera con ambedue i sistemi <strong>di</strong> computare si raggiunge sempre lo stesso numero cinquanta. Che se questo<br />
numero si moltiplica per tre - simbolo della Trinità - si ottiene centocinquanta. Se a questo numero si<br />
ad<strong>di</strong>ziona <strong>di</strong> nuovo il tre - a comprovare l'avvenuta moltiplicazione per tre e l'allusione alla Trinità - si<br />
giunge a comprendere come in quei centocinquantatré pesci sia stata prefigurata la <strong>Chiesa</strong>”.<br />
Il tempo dell’Alleluia<br />
Caratteristica peculiare della liturgia pasquale, nei riti occidentali, è il canto frequente e ripetuto<br />
dell’ALLELUIA.<br />
HALLELUYA è la traslitterazione della parola ebraica !"#$%&'() che significa lo<strong>di</strong>amo Dio: hallelu + Ya,<br />
dove Ya è l’abbreviazione del Nome <strong>di</strong>vino.<br />
Questa parola-acclamazione si trova frequentemente nel libro del salterio, in apertura o chiusura del<br />
salmo. Il Salmo 136 (eterna è la sua misericor<strong>di</strong>a), si apre con questa acclamazione e nel suo<br />
sviluppo viene considerato come una esegesi spirituale dell’Alleluia, per questo viene spesso<br />
chiamato “il grande Hallel”. Esso veniva cantato dagli ebrei nella festa <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>. Lo cantò anche<br />
Gesù con gli apostoli, dopo l’ultima cena (Mt 26,30).<br />
12
Ma soprattutto l’Alleluia si trova nel libro dell’Apocalisse: è l’acclamazione della folla immensa<br />
che canta l’inaugurazione del regno <strong>di</strong> Dio e l’imminenza delle nozze dell’Agnello, in<br />
contrapposizione al lamento terreno per la <strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> Babilonia.<br />
Dopo questo, u<strong>di</strong>i come una voce potente <strong>di</strong> folla immensa nel cielo che <strong>di</strong>ceva: "Alleluia! Salvezza,<br />
gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giu<strong>di</strong>zi. Egli ha condannato la<br />
grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, ven<strong>di</strong>cando su <strong>di</strong> lei il sangue dei<br />
suoi servi!". E per la seconda volta <strong>di</strong>ssero: "Alleluia! Il suo fumo sale nei secoli dei secoli!".<br />
Allora i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio, seduto sul<br />
trono, <strong>di</strong>cendo: "Amen, alleluia". Dal trono venne una voce che <strong>di</strong>ceva: "Lodate il nostro Dio, voi<br />
tutti, suoi servi, voi che lo temete, piccoli e gran<strong>di</strong>!". U<strong>di</strong>i poi come una voce <strong>di</strong> una folla immensa,<br />
simile a fragore <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> acque e a rombo <strong>di</strong> tuoni possenti, che gridavano: "Alleluia! Ha preso<br />
possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, ren<strong>di</strong>amo<br />
a lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: le fu data una veste <strong>di</strong><br />
lino puro e splendente". La veste <strong>di</strong> lino sono le opere giuste dei santi (Ap 19,1-8).<br />
L’Alleluia entrò molto presto nel culto cristiano, tanto in oriente, quanto in occidente. sant’Agostino<br />
è testimone dell’uso <strong>di</strong> cantarlo nei 50 giorni <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, che venivano chiamati anche “tempo<br />
dell’Alleluia”. Per il suo carattere pasquale, veniva si iniziò a cantarlo anche nei riti funebri: così<br />
ancora oggi nel rito bizantino e nel rito mozarabico.<br />
Nel rito bizantino, l’alleluia ritorna oltre che come acclamazione al Vangelo, anche nel<br />
“Cherubikon”, un inno molto solenne che introduce la presentazione dei doni all’altare e nel quale<br />
si esprime la consapevolezza della partecipazione alla Liturgia celeste:<br />
“Noi che misticamente raffiguriamo i Cherubini e alla Trinità vivificante cantiamo l'inno trisagion,<br />
deponiamo ogni mondana preoccupazione per accogliere il Re dell'universo, invisibilmente scortato<br />
dalle schiere angeliche. Alleluia. Alleluia. Alleluia”.<br />
Nel rito romano, San Damaso lo prescrisse da <strong>Pasqua</strong> a Pentecoste, mentre San Gregorio Magno lo<br />
estese l’alleluia a tutto l’anno, ma questa norma non venne seguita dappertutto. Sarà papa<br />
Alessandro II nel 1061 a co<strong>di</strong>ficare l’omissione dell’Alleluia a partire dalla settuagesima, fino alla<br />
notte pasquale. Ancora oggi, le chiese latine omettono totalmente l’alleluia durante la quaresima.<br />
Il modo <strong>di</strong> cantare l’Alleluia e la sequenza<br />
In epoca patristica, questo canto prevedeva la ripetizione per tre volte dell’alleluia, con numerose<br />
modulazioni sulle vocali: dopo il terzo alleluia era presente lo “jubilus”, un vocalizzo prolungato<br />
sull’ultima sillaba (ya) che contiene il Nome <strong>di</strong>vino.<br />
Notker Balbulus (840-912) nel suo Liber hymnorum (raccolta <strong>di</strong> sequenze) racconta che i suoi<br />
monaci <strong>di</strong> san Gallo, per meglio ricordare le lunghissime melo<strong>di</strong>e senza testo proprie degli alleluia<br />
gregoriani, avevano preso l'abitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> inserire un testo (prosa) alla melo<strong>di</strong>a, trasformandola in<br />
canto sillabico. Questi canti vennero in seguito inseriti nella liturgia della Messa, trovando la loro<br />
naturale collocazione dopo il canto dell'alleluia, prolungandone lo jubilus 5 .<br />
Il significato spirituale dell’Alleluia<br />
Dimensione pasquale, suggerita dal Salterio, e <strong>di</strong>mensione escatolica, suggerita dall’Apocalisse: il<br />
canto dell’Alleluia costituisce una mirabile sintesi della fede professata, celebrata e vissuta.<br />
Dal <strong>di</strong>scorso 256 “sull’Alleluia nei giorni <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>” <strong>di</strong> ant’Agostino.<br />
“Cantiamo Alleluia anche adesso, sebbene in mezzo a pericoli e a prove che ci provengono e dagli<br />
altri e da noi stessi. … Oh felice Alleluia, quello <strong>di</strong> lassù! Alleluia pronunciato in piena tranquillità,<br />
5 Il numero delle sequenze crebbe rapidamente e costituirono la base <strong>di</strong> numerosi canti sacri popolari in lingua volgare.<br />
Tra le molte sequenze esistenti, nel Messale <strong>di</strong> San Pio V del 1570 ne rimasero solo 4 (<strong>Pasqua</strong>, Pentecoste, Corpus<br />
Domini, e Messe dei defunti). Il Messale del 1970 prevede come obbligatorie solo le sequenze <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> (Victime<br />
paschali) e Pentecoste (Veni Sancte Spiritus), mentre sono facoltative quelle del Corpus Domini (Lauda Sion) e<br />
dell’Addolorata (Stabat Mater). È stato abolito il Dies Irae della Messa dei defunti.<br />
13
senza alcun avversario! Lassù non ci saranno nemici, non si temerà la per<strong>di</strong>ta degli amici. Qui e lassù<br />
si cantano le lo<strong>di</strong> <strong>di</strong> Dio, ma qui da gente angustiata, lassù da gente libera da ogni turbamento; qui da<br />
gente che avanza verso la morte, lassù da gente viva per l'eternità; qui nella speranza, lassù nel reale<br />
possesso; qui in via, lassù in patria. Cantiamolo dunque adesso, fratelli miei, non per esprimere il<br />
gau<strong>di</strong>o del riposo ma per procurarci un sollievo nella fatica. Come sogliono cantare i viandanti, canta<br />
ma cammina; cantando consolati della fatica, ma non amare la pigrizia. Canta e cammina! Cosa vuol<br />
<strong>di</strong>re: cammina? Avanza, avanza nel bene, poiché, al <strong>di</strong>re dell'Apostolo ci sono certuni che<br />
progre<strong>di</strong>scono in peggio. Se tu progre<strong>di</strong>sci, cammini; ma devi progre<strong>di</strong>re nel bene, nella retta fede,<br />
nella buona condotta. Canta e cammina! Non uscire <strong>di</strong> strada, non volgerti in<strong>di</strong>etro, non fermarti!<br />
Rivolti al Signore”.<br />
Dal <strong>di</strong>scorso 246 <strong>di</strong> sant’Agostino<br />
“Cosa significa infatti Alleluia? È un vocabolo ebraico Alleluia, e significa "Lodate Dio". Alleluia<br />
vuol <strong>di</strong>re: lodate, Ia vuol <strong>di</strong>re: Dio. Ogni volta che echeggia tra noi l'Alleluia, cioè: lodate Dio, ci<br />
sproniamo a lodare Dio. Con la concor<strong>di</strong>a del cuore, che supera quella delle corde <strong>di</strong> una cetra,<br />
innalziamo lo<strong>di</strong> a Dio, cantiamo Alleluia. Terminato il canto, essendo deboli ci allontaniamo per<br />
rifocillare il corpo. Perché lo ristoriamo se non perché ci sentiamo venir meno? Ma c'è <strong>di</strong> peggio. È<br />
tale e tanta la fragilità della carne, tanti i fasti<strong>di</strong> che ci causa la vita presente, che tutte le cose, anche<br />
le più importanti, ci vengono a noia. Adesso che questi giorni stanno volgendo al termine, come<br />
abbiamo desiderato che tornassero da qui a un anno! e con quanta avi<strong>di</strong>tà siamo tornati a loro durante<br />
questo intervallo! Eppure, se ci si <strong>di</strong>cesse: Acclamate <strong>di</strong>cendo Alleluia senza interruzione,<br />
addurremmo delle scuse. Perché tali scuse? Perché per la stanchezza non potremmo perseverare,<br />
perché anche fare il bene ci darebbe fasti<strong>di</strong>o e stancherebbe. Lassù, al contrario, non si viene mai<br />
meno, non ci si stanca mai. State dunque in pie<strong>di</strong> e lodate 6 , voi che abitate nella casa del Signore,<br />
negli atri della casa del nostro Dio. Perché cercare quali saranno le tue occupazioni lassù? Dice:<br />
Beati coloro che abitano nella tua casa, Signore! Ti loderanno nei secoli dei secoli”.<br />
Dal <strong>di</strong>scorso 252 <strong>di</strong> sant’Agostino<br />
“Non è infatti senza motivo, miei fratelli, che la <strong>Chiesa</strong> conserva la consuetu<strong>di</strong>ne, tramandataci dagli<br />
antichi, <strong>di</strong> far ripetere in questi cinquanta giorni l'Alleluia. Che se questo Alleluia significa "lode a<br />
Dio", viene con ciò in<strong>di</strong>cata a noi, ora nell'affanno, la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> quando saremo nella pace.<br />
Quando infatti sarà terminato il nostro affanno <strong>di</strong> adesso e noi avremo raggiunto quella pace, la<br />
nostra unica occupazione sarà la lode <strong>di</strong> Dio: lassù non faremo altro se non <strong>di</strong>re: Alleluia. Che vuol<br />
<strong>di</strong>re: Alleluia? Lodate Dio. Ebbene, chi, se non gli angeli, potrà lodare Dio senza esaurirsi? Gli<br />
angeli non hanno né fame, né sete, non sono soggetti né a malattia né a morte. Quanto a noi, invece,<br />
è vero che abbiamo detto: Alleluia, che l'abbiamo cantato anche stamani in questa basilica; e anche<br />
poco fa, dopo che ci eravamo radunati, abbiamo detto: Alleluia. Ci ha raggiunto una specie <strong>di</strong> olezzo<br />
della lode <strong>di</strong>vina e della quiete celeste; ma in proporzione maggiore è ancora la mortalità a<br />
schiacciarci. Ci stanchiamo a parlare e vogliamo dare ristoro alle nostre membra; e anche se<br />
ripetiamo in maniera prolungata l'Alleluia, la stessa lode <strong>di</strong> Dio ci viene resa pesante dalla materialità<br />
del nostro corpo. La pienezza dell'Alleluia con esclusione <strong>di</strong> ogni limite l'avremo alla fine del tempo<br />
presente, quando saranno cessati i travagli. Cosa <strong>di</strong>re quin<strong>di</strong>, o fratelli? Cantiamo adesso<br />
l'Alleluia come meglio possiamo, per meritare <strong>di</strong> poterlo cantare ininterrottamente. Lassù l'Alleluia<br />
sarà nostro cibo e nostra bevanda; sarà l'Alleluia l'impegno della quiete, tutta la gioia sarà<br />
l'Alleluia, cioè la lode <strong>di</strong> Dio. Chi infatti è in grado <strong>di</strong> lodare qualcosa senza stancarsi se non chi ne<br />
gode senza alcuna noia? Orbene, <strong>di</strong> quanta forza non sarà dotata allora la nostra mente, <strong>di</strong> quanta<br />
stabilità non sarà dotato il nostro corpo, <strong>di</strong>venuto immortale, se né la mente verrà meno nel<br />
contemplare Dio dov'è immersa, né le membra si afflosceranno nell'impegno, che sarà ininterrotto, <strong>di</strong><br />
lodare Dio?”.<br />
“Ci si stanca a cantare Alleluia” (Dal <strong>di</strong>scorso 229/B)<br />
“Quando tutti i santi saranno radunati insieme, quando s'incontreranno tanti che non si conoscevano,<br />
si ritroveranno tanti che si conoscevano, e staranno talmente al sicuro che mai si perderà un amico,<br />
mai si avrà a temere un nemico? Ecco, noi <strong>di</strong>ciamo: Alleluia; è bello, è lieto, è pieno <strong>di</strong> gioia, <strong>di</strong><br />
giocon<strong>di</strong>tà, <strong>di</strong> soavità. Eppure, se lo <strong>di</strong>cessimo sempre, ci stancheremmo. Siccome però ritorna in un<br />
6 Allusione alla pratica <strong>di</strong> pregare in posizione eretta durante i giorni pasquali.<br />
14
preciso tempo dell'anno, con quanta gioia arriva, con quanta nostalgia se ne va! Forse anche lassù<br />
uguale sarà la gioia e uguale la stanchezza? No, non sarà così. Qualcuno forse <strong>di</strong>rà: Ma come è<br />
possibile che sia sempre così e non ci si stanchi mai? Se io ti saprò in<strong>di</strong>care qualcosa in questa vita <strong>di</strong><br />
cui non ci si può stancare, dovrai credere che lassù tutto sarà così. Ci si stanca del cibo, ci si stanca<br />
del bere, ci si stanca degli spettacoli, ci si stanca <strong>di</strong> questo e <strong>di</strong> quell'altro; ma della salute non ci si<br />
stanca mai. Come dunque quaggiù, in questo morire della carne, in questa fragilità, in questo fasti<strong>di</strong>o<br />
per il peso del corpo mai ci può essere stanchezza della salute, così lassù mai ci sarà stanchezza della<br />
carità, dell'immortalità, dell'eternità”.<br />
15
La liturgia del <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong><br />
Tra visione unitaria del mistero e cronologia<br />
Come abbiamo già più volte sottolineato il mistero pasquale ha un carattere profondamente unitario:<br />
ogni singola parte richiama e contiene l’altra. Questo vale in particolare per i misteri della<br />
risurrezione. Per comprendere meglio, possiamo utilizzare come riferimento la narrazione <strong>di</strong> due<br />
evangelisti, che riportamo in maniera molto schematica:<br />
- San Luca, che è molto interessato al senso teologico della storia come luogo della rivelazione,<br />
negli Atti degli Apostoli <strong>di</strong>spone il racconto dei misteri all’interno <strong>di</strong> una precisa cronologia: la<br />
risurrezione al mattino <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, l’Ascensione al quarantesimo giorno, l’effusione dello Spirito<br />
nel giorno cinquantesimo (Pentecoste) 7 .<br />
- San Giovanni, che offre una lettura più mistica e teologica degli eventi, sottolinea il senso<br />
unitario <strong>di</strong> tutti i singoli aspetti: già nella passione <strong>di</strong> Cristo, Giovanni in<strong>di</strong>vidua la sua<br />
esaltazione, il dono dello Spirito e la nascita della <strong>Chiesa</strong>. Nei racconti della risurrezione<br />
possiamo leggere insieme anche la glorificazione celeste del Signore e il dono dello Spirito<br />
Santo. Non per niente, il Vangelo <strong>di</strong> Pentecoste (Gv 20), ricorda come Gesù alitò lo Spirito sui<br />
<strong>di</strong>scepoli la sera stessa <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, e in quella stessa sera li inviò nel mondo.<br />
Queste due <strong>di</strong>mensioni dunque, sono in<strong>di</strong>spensabili per comprendere il senso e il modo della<br />
celebrazione liturgica della <strong>Pasqua</strong>: da una parte l’aspetto cronologico/narrativo, dall’altra parte<br />
quello teologico/ontologico, che enfatizza maggiormente l’unità del mistero e il significato del<br />
passaggio <strong>di</strong> Cristo (e della <strong>Chiesa</strong>) nelle <strong>di</strong>mensioni dell’essere, dalla vita mortale alla gloria <strong>di</strong><br />
Dio.<br />
Così, mentre la Liturgia vive le tappe della domenica <strong>di</strong> Risurrezione, dell’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, della<br />
Ascensione e della Pentecoste, non dobbiamo mai considerare queste celebrazioni come ricorrenze<br />
a se stanti, ma come espressioni <strong>di</strong>verse dell’unico mistero: la Pentecoste, ad es., non è la festa dello<br />
Spirito Santo, ma è la <strong>Pasqua</strong> <strong>di</strong> Cristo, che fiorisce nella <strong>Chiesa</strong>, alla quale il risorto comunica il<br />
suo Spirito.<br />
Le prime testimonianze storiche attestano che oggetto della celebrazione pasquale dei cinquanta<br />
giorni era tutto il complesso della esaltazione <strong>di</strong> Cristo nel dono dello Spirito Santo: fu in un<br />
secondo tempo, ma già verso la fine del IV secolo, che avviene una specificazione dei singoli<br />
aspetti e una amplificazione cronologica del mistero della salvezza. Ancora la pellegrina Egeria <strong>di</strong><br />
Gerusalemme e san Girolamo, testimoniano che a Gerusalemme il contenuto della festa del<br />
cinquantesimo giorno (Pentecoste) erano tanto l’ascensione al cielo <strong>di</strong> Gesù che l’invio dello Spirito<br />
Santo: la profonda connessione dell’uno e dell’altro mistero sono sottolineati anche dal racconto<br />
storicizzante degli Atti.<br />
Lo sviluppo storico: Ascensione e Pentecoste<br />
La solennità dell’Ascensione, nel 40.mo giorno dalla risurrezione, venne istituita già verso la fine<br />
del IV secolo, quando si sentì il bisogno <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre in una cronologia la contemplazione e la<br />
celebrazione del poliedrico mistero pasquale. Affermatasi inizialmente con fatica (poiché non<br />
cadeva <strong>di</strong> domenica), questa festa venne a costituire quasi lo spartiacque del tempo <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> e a<br />
spezzare l’originaria cinquantina. Il Messale <strong>di</strong> San Pio V, co<strong>di</strong>ficò l’uso <strong>di</strong> spegnere il cero<br />
pasquale dopo la lettura del Vangelo, segnando, quasi la fine del <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>. Ancora oggi, nel<br />
rito bizantino, terminata la <strong>di</strong>vina Liturgia dell’Ascensione, la comunità si sofferma in preghiera<br />
sostando in ginocchio, cioè nella posizione che in<strong>di</strong>ca tipicamente la conclusione della gioia<br />
pasquale.<br />
7<br />
Si può notare ancora che anche Luca, nel Vangelo, pare collocare l’ascensione, cronologicamente nella sera stessa <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>, dopo la manifestazione agli apostoli (Lc 24,50).<br />
16
Con la riforma liturgica è stato felicimente soppresso tanto il “<strong>Tempo</strong> dell’Ascensione”, quanto la<br />
pur antica “ottava <strong>di</strong> Pentecoste” che seguiva la solennità del 50mo giorno; la domenica che<br />
intercorre tra Ascensione e Pentecoste (che oggi purtroppo non si celebra in Italia, a causa del<br />
trasferimento della festa) ha preso il titolo <strong>di</strong> Settima domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
Si è così ricomposta l’unità e la peculiarità della cinquantina pasquale, anche se – da un punto <strong>di</strong><br />
vista pastorale – resta ancora molto da fare: tra le devozioni del mese <strong>di</strong> maggio, le sagre paesane e<br />
le gite <strong>di</strong> primavera, i fedeli ancora non arrivano a percepire la peculiarità <strong>di</strong> questo tempo.<br />
Elementi celebrativi<br />
ALLELUIA: Abbiamo già accennato al canto dell’ALLELUIA, come elemento caratterizzante della<br />
Liturgia dei 50 giorni pasquali. Oltre alla sua ricomparsa come Canto al Vangelo, lo troviamo<br />
sempre nelle antifone <strong>di</strong> Ingresso e <strong>di</strong> Comunione (per coerenza, il canto che eventualmente le<br />
sostituisce, lo deve sempre contenere). Nella liturgia della Parola, inoltre, è sempre possibile<br />
sostituire con il triplice alleluia il ritornello del salmo responsoriale. In questo caso, nella messa<br />
feriale, si puà omettere il canto al Vangelo. Il duplice alleluia è anche presente nel congedo della<br />
Messa e della Liturgia delle ore, nell’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> e nella solennità <strong>di</strong> Pentecoste. Nella<br />
Liturgia delle Ore, l’alleluia è presente praticamente in ogni antifona, fino a <strong>di</strong>ventare esso stesso<br />
l’antifona della salmo<strong>di</strong>a delle ore minori (ora me<strong>di</strong>a e compieta).<br />
Nella notte <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, il canto viene reintrodotto con molta solennità: spetta infatti <strong>di</strong>rettamente al<br />
celebrante il compito <strong>di</strong> intonarlo 3 volte, alzando ogni volta il tono. Nella Liturgia episcopale, il<br />
<strong>di</strong>acono (cui spetterà il compito <strong>di</strong> proclamare l’annuncio angelico con la lettura del vangelo),<br />
annuncia sommessamente l’Alleluia al Vescovo, il quale poi lo intona solennemente.<br />
Dal Cerimoniale dei Vescovi<br />
352. Terminata l’epistola, secondo l’opportunità e secondo la consuetu<strong>di</strong>ne del luogo, uno dei <strong>di</strong>aconi<br />
o il lettore si avvicina al vescovo e gli <strong>di</strong>ce: Reveren<strong>di</strong>ssimo Padre, vi annunzio una grande gioia, che<br />
è “alleluia”. Dopo questo annunzio oppure, se esso non ha luogo, imme<strong>di</strong>atamente dopo, l’epistola,<br />
tutti si alzano. Il vescovo, in pie<strong>di</strong> senza mitra, intona solennemente l’Alleluia, aiutato, se è necessario,<br />
da uno dei <strong>di</strong>aconi o dei concelebranti. Lo canta tre volte elevando gradualmente il tono della voce: il<br />
popolo dopo ogni volta lo ripete nel medesimo tono. Quin<strong>di</strong> il salmista o il lettore proclama il salmo, a<br />
cui il popolo risponde con l’Alleluia.<br />
LETTURE BIBLICHE: Poichè la <strong>Pasqua</strong> segna il compimento della rivelazione, durante questo tempo<br />
liturgico le letture bibliche, sia nella Messa che nella Liturgia delle Ore, sono tratte dal NUOVO<br />
TESTAMENTO. In particolare sono ampio oggetto <strong>di</strong> lettura gli Atti degli Apostoli e l’Apocalisse <strong>di</strong><br />
Giovanni. Nell’ufficio delle letture, si trovano anche le lettere <strong>di</strong> Giovanni. Occorre tenere presente<br />
questo principio nella scelta <strong>di</strong> brani da leggere in occasione <strong>di</strong> momenti <strong>di</strong> preghiera, o nelle feste<br />
dei santi, quando bisogna prendere le letture dai Comuni.<br />
IL CERO PASQUALE: Dal Cerimoniale dei Vescovi: “Il cero pasquale si accende in tutte le<br />
celebrazioni liturgiche più solenni <strong>di</strong> questo tempo, sia alla messa, sia alle lo<strong>di</strong> e ai vespri. Dopo il<br />
giorno <strong>di</strong> Pentecoste, il cero pasquale è conservato con il debito onore nel battistero. Alla fiamma<br />
del cero si accendono, nella celebrazione del battesimo, le candele dei neo-battezzati.<br />
Durante tutto il tempo pasquale, per conferire il battesimo si adopera l’acqua benedetta nella notte<br />
pasquale” (n. 372).<br />
LA MEMORIA DEI SANTI: Dopo l’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, riprende la possibilità <strong>di</strong> celebrare le memorie e<br />
le feste dei Santi. Queste però assumono una coloritura particolare: nelle antifone e nei canti della<br />
Messa si aggiunge sempre l’Alleluia. Le memorie degli Apostoli e dei Martiri assumono una<br />
coloritura particolare, con testi propri per il tempo pasquale. Anche il Comune della Beata Vergine<br />
Maria ha testi propri per il tempo pasquale, prima e dopo l’Ascensione.<br />
17
LE CELEBRAZIONI ESEQUIALI: La celebrazione della Messa e dei riti esequiali prevede testi propri,<br />
che mettono maggiormente in evidenza la speranza pasquale. Sono previste letture proprie.<br />
DAL DIRETTORIO SU PIETÀ POPOLARE E LITURGIA<br />
Nel <strong>Tempo</strong> <strong>Pasqua</strong>le<br />
La bene<strong>di</strong>zione annuale delle famiglie nelle loro case<br />
152. Durante il tempo pasquale - o in altri perio<strong>di</strong> dell’anno – si svolge l’annuale bene<strong>di</strong>zione delle famiglie, visitate<br />
nelle loro case. Raccomandata alla cura pastorale dei parroci e dei loro collaboratori, questa consuetu<strong>di</strong>ne molto sentita<br />
dai fedeli è una preziosa occasione per far risonare nelle famiglie cristiane il ricordo della costante presenza bene<strong>di</strong>cente<br />
<strong>di</strong> Dio, l’invito a vivere in conformità al Vangelo, l’esortazione a genitori e figli <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>re e promuovere il mistero<br />
del loro essere “chiesa domestica” 8 .<br />
La «Via lucis»<br />
153. In tempi recenti, in varie regioni, si è venuto <strong>di</strong>ffondendo un pio esercizio denominato Via lucis. In esso, a guisa <strong>di</strong><br />
quanto avviene nella Via Crucis, i fedeli, percorrendo un cammino, considerano le varie apparizioni in cui Gesù – dalla<br />
Risurrezione all’Ascensione, in prospettiva della Parusia – manifestò la sua gloria ai <strong>di</strong>scepoli in attesa dello Spirito<br />
promesso (cf. Gv 14, 26; 16, 13-15; Lc 24, 49), ne confortò la fede, portò a compimento gli insegnamenti sul Regno,<br />
definì ulteriormente la struttura sacramentale e gerarchica della <strong>Chiesa</strong>.<br />
Attraverso il pio esercizio della Via lucis, i fedeli ricordano l’evento centrale della fede – la Risurrezione <strong>di</strong> Cristo – e la<br />
loro con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scepoli che nel Battesimo, sacramento pasquale, sono passati dalle tenebre del peccato alla luce<br />
della grazia (cf. Col 1, 13; Ef 5, 8).<br />
Per secoli la Via Crucis ha me<strong>di</strong>ato la partecipazione dei fedeli al primo momento dell’evento pasquale – la Passione –<br />
e ha contribuito a fissarne i contenuti nella coscienza del popolo. Analogamente, nel nostro tempo, la Via lucis, a<br />
con<strong>di</strong>zione che si svolga con fedeltà al testo evangelico, può me<strong>di</strong>are efficacemente la comprensione vitale dei fedeli<br />
del secondo momento della <strong>Pasqua</strong> del Signore, la Risurrezione.<br />
La Via lucis può <strong>di</strong>venire altresì un’ottima pedagogia della fede, perché, come si <strong>di</strong>ce, «per crucem ad lucem». Infatti<br />
con la metafora del cammino, la Via lucis conduce dalla constatazione della realtà del dolore, che nel <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> Dio<br />
non costituisce l’approdo della vita, alla speranza del raggiungimento della vera meta dell’uomo: la liberazione, la gioia,<br />
la pace, che sono valori essenzialmente pasquali.<br />
La Via lucis, infine, in una società che spesso reca l’impronta della “cultura della morte”, con le sue espressioni <strong>di</strong><br />
angoscia e <strong>di</strong> annientamento, è uno stimolo per instaurare una “cultura della vita”, una cultura cioè aperta alle attese<br />
della speranza e alle certezze della fede.<br />
Il «Regina cæli»<br />
196. Nel tempo pasquale, per <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> papa Benedetto XIV (20 <strong>aprile</strong> 1742), al posto dell’Angelus Domini si<br />
recita la celebre antifona Regina cæli. Essa, risalente probabilmente al secolo X-XI 9 , congiunge felicemente il mistero<br />
dell’incarnazione del Verbo (Cristo, che hai portato nel grembo) con l’evento pasquale (è risorto, come aveva<br />
promesso), mentre l’”invito alla gioia” (Rallegrati), che la comunità ecclesiale rivolge alla Madre per la risurrezione del<br />
Figlio, si ricollega e <strong>di</strong>pende dall’”invito alla gioia” («Rallegrati, piena <strong>di</strong> grazia»: Lc 1, <strong>28</strong>), che Gabriele rivolse<br />
all’umile Serva del Signore, chiamata ad essere la madre del Messia salvatore.<br />
A guisa <strong>di</strong> quanto è stato suggerito per l’Angelus, sarà conveniente talvolta solennizzare il Regina cæli oltre che con il<br />
canto dell’antifona, con la proclamazione del vangelo della Risurrezione.<br />
Il mese <strong>di</strong> maggio<br />
Diventa sempre più urgente una attenta riflessione pastorale sulla sovrapposizione del <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong> con la pratica devozionale del “mese mariano”. Al riguardo è molto illuminante un<br />
passaggio del Direttorio su pietà popolare e Liturgia:<br />
I «mesi mariani»<br />
190. Relativamente alla pratica <strong>di</strong> un “mese mariano”, <strong>di</strong>ffusa in varie Chiese sia dell’Oriente sia dell’Occidente 10 , si<br />
possono richiamare alcuni orientamenti essenziali 11 .<br />
8 (Cf. RITUALE ROMANUM, De Bene<strong>di</strong>ctionibus, Ordo bene<strong>di</strong>ctionis annuae familiarum in propris domibus, 68-89)<br />
!"L’antifona è attestata nell’Antifonario (secolo XII) dell’Abbazia <strong>di</strong> san Lupo <strong>di</strong> Benevento. Cf. R. J. HESBERT<br />
(ed.), Corpus Antiphonalium Officii, vol. II, Herder, Roma 1965, pp. xx-xxiv; vol. III, Herder, Roma 1968, p. 440."<br />
10 Nel rito bizantino il mese <strong>di</strong> agosto, la cui liturgia è centrata sulla solennità della Dormizione <strong>di</strong> Maria (15 <strong>di</strong> agosto),<br />
costituisce, fin dal secolo XIII, un vero “mese mariano”; nel rito copto il “mese mariano” coincide sostanzialmente con<br />
il mese <strong>di</strong> kiahk (<strong>di</strong>cembre-gennaio) ed è strutturato liturgicamente intorno al Natale. In Occidente le prime<br />
testimonianze del mese <strong>di</strong> maggio de<strong>di</strong>cato alla Vergine, si hanno verso la fine del secolo XVI. Nel secolo XVIII il<br />
mese mariano, nel senso moderno dell’espressione, è già ben attestato; ma si tratta <strong>di</strong> un’epoca in cui i pastori<br />
18
In Occidente i mesi de<strong>di</strong>cati alla Vergine, sorti in un’epoca in cui si faceva scarso riferimento alla Liturgia come a<br />
forma normativa del culto cristiano, si sono sviluppati parallelamente al culto liturgico. Ciò ha posto e pone tuttora<br />
alcuni problemi <strong>di</strong> indole liturgico-pastorale che meritano un'accurata valutazione.<br />
191. Limitatamente alla consuetu<strong>di</strong>ne occidentale <strong>di</strong> celebrare un “mese mariano” in maggio (in novembre, in alcuni<br />
paesi dell’emisfero australe), sarà opportuno tenere conto delle esigenze della Liturgia, delle attese dei fedeli, della loro<br />
maturazione nella fede, e stu<strong>di</strong>are la problematica posta dai “mesi mariani” nell’ambito della “pastorale d’insieme”<br />
della <strong>Chiesa</strong> locale, evitando situazioni <strong>di</strong> contrasto pastorale che <strong>di</strong>sorientano i fedeli, come accadrebbe, ad esempio, se<br />
si spingesse per abolire il “mese <strong>di</strong> maggio”.<br />
In molti casi la soluzione più opportuna sarà quella <strong>di</strong> armonizzare i contenuti del “mese mariano” con il concomitante<br />
tempo dell’Anno liturgico. Così, ad esempio, durante il mese <strong>di</strong> maggio, che in gran parte coincide con i cinquanta<br />
giorni della <strong>Pasqua</strong>, i pii esercizi dovranno mettere in luce la partecipazione della Vergine al mistero pasquale (cf. Gv,<br />
19, 25-27) e all’evento pentecostale (cf. At 1, 14), che inaugura il cammino della <strong>Chiesa</strong>: un cammino che essa,<br />
<strong>di</strong>venuta partecipe della novità del Risorto, percorre sotto la guida dello Spirito. E poiché i “cinquanta giorni” sono il<br />
tempo proprio per la celebrazione e la mistagogia dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, i pii esercizi del mese <strong>di</strong><br />
maggio potranno utilmente dar rilievo alla funzione che la Vergine, glorificata in cielo, svolge sulla terra, “qui e ora”,<br />
nella celebrazione dei sacramenti del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia 12 .<br />
In ogni caso dovrà essere <strong>di</strong>ligentemente seguita la <strong>di</strong>rettiva della Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla necessità<br />
che «l’animo dei fedeli sia in<strong>di</strong>rizzato prima <strong>di</strong> tutto verso le feste del Signore, nelle quali, durante il corso dell’anno, si<br />
celebrano i misteri della salvezza» 13 , ai quali, certo, è stata associata la beata Vergine Maria.<br />
Un’opportuna catechesi convincerà i fedeli che la domenica, memoria ebdomadaria della <strong>Pasqua</strong>, è «il giorno <strong>di</strong> festa<br />
primor<strong>di</strong>ale». Infine, tenendo presente che nella Liturgia Romana le quattro settimane <strong>di</strong> Avvento costituiscono un<br />
tempo mariano armonicamente inserito nell’Anno liturgico, si dovranno aiutare i fedeli a valorizzare convenientemente<br />
i numerosi riferimenti alla Madre del Signore offerti da questo intero periodo.<br />
L’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong><br />
Con la celebrazione della domenica <strong>di</strong> Risurrezione e dell’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, la <strong>Chiesa</strong> esprime in<br />
particolare questa consapevolezza che la <strong>Pasqua</strong> non è una ricorrenza tra le altre, ma un mistero che<br />
si <strong>di</strong>lata nel tempo e si apre all’eternità.<br />
La domenica <strong>di</strong> Risurrezione e la domenica dell’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> sono il prototipo del Giorno del<br />
Signore, memoria, presenza e profezia della risurrezione <strong>di</strong> Cristo e della <strong>Chiesa</strong> 14 .<br />
Anticamente questo periodo veniva chiamato “settimana dei sacramenti”, perché durante questi<br />
giorni veniva spiegato ai neofiti il significato dei sacramenti che avevano ricevuto nella notte <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>. Questa infatti era la prassi antica: prima si riceveva la grazia del sacramento, poi, con il<br />
sostegno della luce <strong>di</strong>vina, la <strong>Chiesa</strong> ne svelava il significato.<br />
La liturgia mostra ancora oggi questa attenzione verso i neofiti, che vengono commemorati nella<br />
preghiera eucaristica. La <strong>di</strong>mensione battesimale è molto presente anche nelle orazioni <strong>di</strong> questi<br />
giorni. Il rito ambrosiano prevede ancora, per ognuno <strong>di</strong> questi giorni, anche una “messa per i<br />
battezzati”, testimonianza dell’antica prassi <strong>di</strong> celebrare l’eucaristia ogni giorni con i rinati a vita<br />
nuova.<br />
Nell’antichità l’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> concludeva anche l’itinerario delle stazioni romane che aveva<br />
caratterizzato tutta la Quaresima, con quoti<strong>di</strong>ane processioni da una <strong>Chiesa</strong> ad un'altra. L’ultima<br />
stazione, nel sabato, poi nella domenica dell’ottava, avveniva nella <strong>Chiesa</strong> <strong>di</strong> San Pancrazio, sul<br />
Gianicolo: il giovane che subì il martirio sotto Diocleziano, è venerato come protettore e custode<br />
incentrano la loro azione apostolica – tranne che per la Penitenza ed il sacrificio eucaristico – non tanto sulla liturgia<br />
quanto sui pii esercizi, e verso <strong>di</strong> essi convogliano <strong>di</strong> preferenza i fedeli.<br />
11<br />
Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lettera circolare Orientamenti e proposte per la celebrazione<br />
dell’Anno mariano, 64-65.<br />
#$"%&'"()*+,&"-,.-*(/-0,-"1+"2('-("&"-"1(*'(3&,4-".&))5-,-/-(/-0,&"*'-14-(,(6"*78"!"!#$"$9:9#8"<br />
#9";
dei giuramenti e delle promesse. Sulla sua tomba, i neofiti rinnovavano la loro professione <strong>di</strong> fede e<br />
deponevano le albe battesimali.<br />
Il 5 maggio del 2000, con un decreto della Congregazione per il Culto <strong>di</strong>vino, il servo <strong>di</strong> Dio<br />
Giovanni Paolo II <strong>di</strong>spose che alla seconda domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> venisse aggiunto il titolo “DELLA<br />
DIVINA MISERICORDIA”, senza alcun mutamento nei testi liturgici 15 .<br />
La Liturgia della Parola dei giorni dell’ottava è caratterizzata dall’inizio della lettura degli Atti degli<br />
Apostoli, che proseguirà fino a Pentecoste; mentre le pagine evangeliche riportano tutte le memorie<br />
delle manifestazioni del Signore risorto. La celebrazione è sempre festiva: è previsto il Gloria e la<br />
sequenza <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>. Nella Liturgia delle Ore, si ripetono sempre a Lo<strong>di</strong> e a Vespro i salmi del<br />
giorno <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
DAL DIRETTORIO SU PIETÀ POPOLARE E LITURGIA<br />
La devozione alla <strong>di</strong>vina misericor<strong>di</strong>a<br />
154. Connessa con l’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, in tempi recenti e a seguito dei messaggi della religiosa Faustina Kowalska,<br />
canonizzata il 30 <strong>aprile</strong> 2000, si è progressivamente <strong>di</strong>ffusa una particolare devozione alla misericor<strong>di</strong>a <strong>di</strong>vina elargita<br />
da Cristo morto e risorto, fonte dello Spirito che perdona il peccato e restituisce la gioia <strong>di</strong> essere salvati. Poiché la<br />
Liturgia della “Domenica II <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> o della <strong>di</strong>vina misericor<strong>di</strong>a” – come viene ora chiamata 16 – costituisce l’alveo<br />
naturale in cui esprimere l’accoglienza della misericor<strong>di</strong>a del Redentore dell’uomo, si educhino i fedeli a comprendere<br />
tale devozione alla luce delle celebrazioni liturgiche <strong>di</strong> questi giorni <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>. Infatti, «il Cristo pasquale è<br />
l’incarnazione definitiva della misericor<strong>di</strong>a, il suo segno vivente: storico-salvifico e insieme escatologico. Nel<br />
medesimo spirito, la Liturgia del tempo pasquale pone sulle nostre labbra le parole del salmo: “Canterò in eterno le<br />
misericor<strong>di</strong>e del Signore” (Sal 89 [88], 2)». 17<br />
Anno A Anno B Anno C<br />
<strong>Pasqua</strong> <strong>di</strong> Risurrezione:<br />
At 10, 34a. 37-43 Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.<br />
Sal 117 Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.<br />
Col 3, 1-4 Cercate le cose <strong>di</strong> lassù, dove è Cristo.<br />
oppure 1Cor 5, 6b-8 Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova.<br />
SEQUENZA: Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio <strong>di</strong> lode. L'agnello ha redento il suo gregge, l'Innocente ha<br />
riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e Vita si sono affrontate in un pro<strong>di</strong>gioso duello. Il Signore della vita era<br />
morto; ma ora, vivo, trionfa. «Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». «La tomba del Cristo vivente, la gloria del<br />
Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in<br />
Galilea». Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.<br />
Gv 20, 1-9 Egli doveva risuscitare dai morti.<br />
oppure alla sera Lc 24,13-35 Resta con noi perché si fa sera.<br />
oppure Mt <strong>28</strong>,1-10 E' risorto e vi Mc 16,1-7 Gesù Nazareno, Lc 24,1-12 Perché cercate<br />
precede in Galilea. il crocifisso, è risorto. tra i morti colui che è vivo?<br />
15<br />
DECRETO DELLA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO:<br />
Pietà e tenerezza è il Signore (Sal 111, 4), il quale per il grande amore con il quale ci ha amati (Ef 2,4), ci ha donato<br />
con in<strong>di</strong>cibile bontà il suo unico Figlio, nostro Redentore, affinché attraverso la sua morte e risurrezione aprisse al<br />
genere umano le porte della vita eterna, e affinché, accogliendo la sua misericor<strong>di</strong>a dentro il suo tempio, i figli<br />
dell’adozione esaltassero la sua gloria fino ai confini della terra. Ai nostri giorni i fedeli <strong>di</strong> molte regioni della terra,<br />
nel culto <strong>di</strong>vino e soprattutto nella celebrazione del mistero pasquale, nel quale l’amore <strong>di</strong> Dio verso tutti gli uomini<br />
risplende in massima misura, desiderano esaltare quella misericor<strong>di</strong>a. Accogliendo tali desideri, il Sommo Pontefice<br />
Giovanni Paolo II ha benignamente <strong>di</strong>sposto che nel Messale Romano d’ora innanzi al titolo della II Domenica <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong> sia aggiunta la <strong>di</strong>zione « o della Divina Misericor<strong>di</strong>a », prescrivendo anche che, per quanto concerne la<br />
celebrazione liturgica della stessa Domenica, siano da adoperare sempre i testi che per quel giorno si trovano nello<br />
stesso Messale e nella Liturgia delle Ore <strong>di</strong> Rito Romano.<br />
16<br />
Cf. Notificazione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti (5.5.2000):<br />
cf. L’Osservatore Romano 24 maggio 2000, p. 4.<br />
17<br />
GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Dives in misericor<strong>di</strong>a, 8.<br />
20
Lunedì dell’Ottava:<br />
At 2, 14. 22-32 Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.<br />
Sal 15 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.<br />
Mt <strong>28</strong>, 8-15 Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno<br />
Martedì dell’Ottava:<br />
At 2, 36-41 Convertitevi e ciascuno <strong>di</strong> voi si faccia battezzare nel nome <strong>di</strong> Gesù Cristo.<br />
Sal 32 Dell’amore del Signore è piena la terra.<br />
Gv 20, 11-18 Ho visto il Signore e mi ha detto queste cose<br />
Mercoledì dell’Ottava:<br />
At 3, 1-10 Quello che ho te lo do: nel nome <strong>di</strong> Gesù, àlzati e cammina!<br />
Sal 104 Gioisca il cuore <strong>di</strong> chi cerca il Signore.<br />
Lc 24, 13-35 Riconobbero Gesù nello spezzare il pane<br />
Giovedì dell’Ottava:<br />
At 3, 11-26 Avete ucciso l'amore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti<br />
Sal 8 O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!<br />
Lc 24, 35-48 Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno<br />
Venerdì dell’Ottava:<br />
At 4, 1-12 In nessun altro c’è salvezza<br />
Sal 117 La pietra scartata dai costruttori è <strong>di</strong>venuta la pietra d’angolo<br />
Gv 21 1-14 Gesù si avvicinò, prese il pane e lo <strong>di</strong>ede loro, e così pure il pesce<br />
Sabato dell’Ottava:<br />
At 4, 13-21 Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato<br />
Sal 117 Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto<br />
Mc 16, 9-15 Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo<br />
Seconda Domenica <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>:<br />
L’OTTAVO GIORNO<br />
At 2,42-47 [Quelli che<br />
erano stati battezzati]<br />
erano perseveranti<br />
nell’insegna-mento degli<br />
apostoli e nella comunione,<br />
nello spezzare il pane e<br />
nelle preghiere.<br />
Sal 117 Rendete grazie al<br />
Signore perché è buono: il<br />
suo amore è per sempre.<br />
1 Pt 1, 3-9 Ci ha rigenerati<br />
per una speranza viva,<br />
me<strong>di</strong>ante la risurrezione <strong>di</strong><br />
Gesù Cristo dai morti.<br />
21<br />
At 4, 32-35 Un cuore solo<br />
e un'anima sola.<br />
Sal 117 Rendete grazie al<br />
Signore perché è buono: il<br />
suo amore è per sempre.<br />
1 Gv 5, 1-6 Chiunque è<br />
stato generato da Dio vince<br />
il mondo.<br />
SEQUENZA (Facoltativa) - Gv 20, 19-31 Otto giorni dopo venne Gesù.<br />
Le Domeniche <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong><br />
At 5, 12-16 Venivano<br />
aggiunti credenti al<br />
Signore, una moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
uomini e <strong>di</strong> donne.<br />
Sal 117 Rendete grazie al<br />
Signore perché è buono: il<br />
suo amore è per sempre.<br />
Ap 1, 9-11.12-13.17.19<br />
Ero morto, ma ora vivo per<br />
sempre.<br />
Per le domeniche <strong>di</strong> questo periodo, in occasione della riforma liturgica, si è in<strong>di</strong>viduata una felice<br />
intitolazione: seconda, terza, … domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>. Nel Messale precedente queste domeniche<br />
venivano celebrate come prima domenica dopo <strong>Pasqua</strong>, ecc.<br />
La nuova denominazione, peraltro ine<strong>di</strong>ta nella storia della Liturgia, ha il pregio <strong>di</strong> ricordare che<br />
non esiste un “dopo <strong>Pasqua</strong>”, ma che la <strong>Pasqua</strong> è la <strong>di</strong>mensione costitutiva della <strong>Chiesa</strong> e che ogni<br />
domenica è <strong>Pasqua</strong> settimanale. Nei tre cicli annuali, le domeniche ripresentano i gran<strong>di</strong> temi della<br />
vita cristiana: l’incontro con il risorto, la rivelazione del mistero trinitario, il mistero della <strong>Chiesa</strong>, il<br />
dono dello Spirito Paraclito.
Terza Domenica <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>:<br />
LE APPARIZIONI<br />
DEL RISORTO<br />
Quarta Domenica <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>:<br />
IL PASTORE E IL GREGGE<br />
Quinta Domenica <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>:<br />
RIVELAZIONE TRINITARIA<br />
Sesta Domenica <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>:<br />
LA PROMESSA DEL<br />
PARACLITO<br />
Settima domenica <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>:<br />
LA PREGHIERA<br />
SACERDOTALE DI CRISTO<br />
In Italia non si celebra.<br />
Anno A Anno B Anno C<br />
At 2, 14a. 22-33 Non era<br />
possibile che la morte lo<br />
tenesse in suo potere.<br />
Sal 15 Mostraci, Signore, il<br />
sentiero della vita.<br />
1 Pt 1, 17-21 Foste liberati<br />
con il sangue prezioso <strong>di</strong><br />
Cristo, agnello senza <strong>di</strong>fetti e<br />
senza macchia.<br />
Lc 24, 13-35 Lo riconobbero<br />
nello spezzare il pane.<br />
At 2, 14a.36-41 Dio lo ha<br />
costituito Signore e Cristo.<br />
Sal 22 Il Signore è il mio<br />
pastore: non manco <strong>di</strong> nulla.<br />
1 Pt 2, 20b-25 Siete tornati al<br />
pastore delle vostre anime.<br />
Gv 10, 1-10 Io sono la porta<br />
delle pecore.<br />
At 6, 1-7 Scelsero sette<br />
uomini pieni <strong>di</strong> Spirito Santo.<br />
Sal 32 Il tuo amore, Signore,<br />
sia su <strong>di</strong> noi: in te speriamo.<br />
1 Pt 2, 4-9 Voi stirpe eletta,<br />
sacerdozio regale.<br />
Gv 14, 1-12 Io sono la via , la<br />
verità e la vita.<br />
At 15, 1-2. 22-29 È parso<br />
bene, allo Spirito Santo e a<br />
noi, <strong>di</strong> non imporvi altro<br />
obbligo al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> queste<br />
cose necessarie.<br />
Sal 66 Ti lo<strong>di</strong>no i popoli, o<br />
Dio, ti lo<strong>di</strong>no i popoli tutti.<br />
Ap 21, 10-14. 22-23 L'Angelo<br />
mi mostrò la città santa che<br />
scende dal cielo.<br />
Gv 14, 23-29 Lo Spirito Santo<br />
vi ricorderà tutto ciò che io vi<br />
ho detto.<br />
At 1,12-14 Erano<br />
perseveranti e concor<strong>di</strong> nella<br />
preghiera.<br />
Sal 26 Contemplerò la bontà<br />
del Signore nella terra dei<br />
viventi.<br />
1 Pt 4,13-16 Beati voi, se<br />
venite insultati per il nome <strong>di</strong><br />
Cristo.<br />
Gv 17,1-11a Padre, glorifica<br />
il Figlio tuo.<br />
22<br />
At 3,13-15.17-19 Avete ucciso<br />
l’autore della vita, ma Dio<br />
l’ha risuscitato dai morti.<br />
Sal 4 Risplenda su <strong>di</strong> noi,<br />
Signore, la luce del tuo volto.<br />
1Gv 2,1-5 Gesù Cristo è<br />
vittima <strong>di</strong> espiazione per i<br />
nostri peccati e per quelli <strong>di</strong><br />
tutto il mondo.<br />
Lc 24,35-48 Così sta scritto:<br />
il Cristo patirà e risorgerà dai<br />
morti il terzo giorno.<br />
At 4, 8-12 In nessun altro c’è<br />
salvezza.<br />
Sal 117 La pietra scartata dai<br />
costruttori è <strong>di</strong>venuta la pietra<br />
d’angolo.<br />
1 Gv 3,1-2 Vedremo Dio così<br />
come egli è.<br />
Gv 10, 11-18 Il buon pastore<br />
dà la vita per le pecore.<br />
At 9, 26-31 Bàrnaba raccontò<br />
agli apostoli come durante il<br />
viaggio Paolo aveva visto il<br />
Signore.<br />
Sal 21 A te la mia lode,<br />
Signore, nella grande<br />
assemblea.<br />
1 Gv 3, 18-24 Questo è il suo<br />
comandamento: che cre<strong>di</strong>amo<br />
e ci amiamo.<br />
Gv 15, 1-8 Chi rimane in me<br />
ed io in lui fa molto frutto.<br />
At 10, 25-27. 34-35. 44-48<br />
Anche sui pagani si è effuso il<br />
dono dello Spirito Santo.<br />
Sal 97 Il Signore ha rivelato<br />
ai popoli la sua giustizia<br />
1 Gv 4, 7-10 Dio è amore.<br />
Gv 15, 9-17 Nessuno ha un<br />
amore più grande <strong>di</strong> questo:<br />
dare la sua vita per i propri<br />
amici.<br />
At 1,15-17.20ac-26 Bisogna<br />
che uno <strong>di</strong>venga, insieme a<br />
noi, testimone della sua<br />
risurrezione.<br />
Sal 102 Benedetto il Signore<br />
nell'alto dei cieli.<br />
1 Gv 4, 11-16 Chi sta<br />
nell'amore <strong>di</strong>mora in Dio e<br />
Dio <strong>di</strong>mora in lui.<br />
Gv 17,11b-19 Siano una cosa<br />
sola, come noi.<br />
La solennità dell’Ascensione<br />
At 5, 27b-32. 40b-41 Di<br />
questi fatti siamo testimoni noi<br />
lo Spirito Santo.<br />
Sal 29 Ti esalterò, Signore,<br />
perché mi hai risollevato.<br />
Ap 5, 11-14 L’Agnello, che è<br />
stato immolato, è degno <strong>di</strong><br />
ricevere potenza e ricchezza.<br />
Gv 21, 1-19 Viene Gesù,<br />
prende il pane e lo dà loro,<br />
così pure il pesce.<br />
At 13, 14. 43-52 Ecco, noi<br />
ci rivolgiamo ai pagani.<br />
Sal 99 Noi siamo suo popolo,<br />
gregge che egli guida.<br />
Ap 7, 9. 14-17 L'Agnello sarà<br />
il loro pastore e li guiderà alle<br />
fonti delle acque della vita<br />
Gv 10, 27-30 Alle mie pecore<br />
io do la vita eterna.<br />
At 14, 21b-27 Riferirono alla<br />
comunità tutto quello che Dio<br />
aveva fatto per mezzo loro.<br />
Sal 144 Bene<strong>di</strong>rò il tuo nome<br />
per sempre, Signore<br />
Ap 21, 1-5 Dio asciugherà<br />
ogni lacrima dai loro occhi<br />
Gv 13, 31-33a. 34-35 Vi do un<br />
comandamento nuovo: che vi<br />
amiate gli uni agli altri<br />
At 15, 1-2. 22-29 È parso<br />
bene, allo Spirito Santo e a<br />
noi, <strong>di</strong> non imporvi altro<br />
obbligo al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> queste<br />
cose necessarie<br />
Sal 66 Ti lo<strong>di</strong>no i popoli, o<br />
Dio, ti lo<strong>di</strong>no i popoli tutti.<br />
Ap 21, 10-14. 22-23 L'Angelo<br />
mi mostrò la città santa che<br />
scende dal cielo.<br />
Gv 14, 23-29 Lo Spirito Santo<br />
vi ricorderà tutto ciò che io vi<br />
ho detto.<br />
At 7,55-60 Io contemplo il<br />
Figlio dell'uomo che sta alla<br />
desta <strong>di</strong> Dio.<br />
Sal 96 Donaci occhi, Signore,<br />
per vedere la tua gloria.<br />
Ap 22, 12-14.16-17.20 Vieni,<br />
Signore Gesù!<br />
Gv 17,20-26 Che tutti siano<br />
una cosa sola.<br />
Il “Legionario” dell’Ascensione offre ogni anno il brano degli Atti degli Apostoli come prima<br />
lettura: alla richiesta <strong>di</strong> una instaurazione “politica” del suo regno, Gesù contrappone la promessa<br />
dello Spirito Santo, e poi è elevato in alto sotto gli occhi dei <strong>di</strong>scepoli. Caratteristico è il salmo 46
che nel Salterio canta la conquista <strong>di</strong> Gerusalemme e l’ingresso dell’arca dell’alleanza nella città<br />
santa: “Ascende il Signore tra conti <strong>di</strong> gioia”.<br />
Nei cicli A e B, l’epistola è tratta dalla lettera agli Efesini: la prima contempla la gloria <strong>di</strong> Cristo<br />
intronizzato nel cielo; la seconda è una esortazione a raggiungere la pienezza <strong>di</strong> Cristo. Nel ciclo C<br />
troviamo un prezioso brano dalla lettera agli Ebrei, il testo <strong>di</strong> fondamentale importanza per<br />
comprendere il mistero pasquale <strong>di</strong> Cristo come perfetta offerta sacerdotale.<br />
Il primo prefazio canta la signoria universale <strong>di</strong> Cristo, il secondo la narrazione storica del mistero.<br />
Ascensione del Signore:<br />
At 1,1-11 Fu elevato in alto sotto i loro occhi.<br />
Sal 46 Ascende il Signore tra canti <strong>di</strong> gioia.<br />
Ef 1, 17-23 Lo fece sedere<br />
alla sua destra nei cieli.<br />
Mt <strong>28</strong>, 16-20 Mi è stato<br />
ogni potere in cielo e in<br />
terra.<br />
Ef 4, 1-13 Raggiungere la<br />
misura della pienezza <strong>di</strong><br />
Cristo.<br />
Mc 16, 15-20 Il Signore fu<br />
elevato in cielo e sedette<br />
alla destra <strong>di</strong> Dio.<br />
23<br />
Eb 9,24-<strong>28</strong>; 10,19-23<br />
Cristo è entrato nel cielo<br />
stesso.<br />
Lc 24,46-53 Mentre li<br />
bene<strong>di</strong>ceva veniva portato<br />
verso il cielo.<br />
PREFAZIO DELL’ASCENSIONE I: Il Signore Gesù, re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al<br />
cielo tra il coro festoso degli angeli. Me<strong>di</strong>atore tra Dio e gli uomini, giu<strong>di</strong>ce del mondo e Signore dell’universo, non si<br />
è separato dalla nostra con<strong>di</strong>zione umana, ma ci ha preceduti nella <strong>di</strong>mora eterna, per darci la serena fiducia che dove è<br />
lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria.<br />
PREFAZIO DELL’ASCENSIONE II: Dopo la risurrezione egli si mostrò visibilmente a tutti i <strong>di</strong>scepoli, e sotto il loro<br />
sguardo salì al cielo, perché noi fossimo partecipi della sua vita <strong>di</strong>vina.<br />
PREFAZIO DOPO L’ASCENSIONE: Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, me<strong>di</strong>atore e<br />
garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e vescovo delle nostre anime, ci chiama alla preghiera unanime,<br />
sull’esempio <strong>di</strong> Maria e degli Apostoli, nell’attesa <strong>di</strong> una rinnovata Pentecoste.<br />
DAL DIRETTORIO SU PIETÀ POPOLARE E LITURGIA<br />
La novena <strong>di</strong> Pentecoste 155. La Scrittura attesta che nei nove giorni intercorrenti tra l’Ascensione e la Pentecoste, gli<br />
apostoli «erano assidui e concor<strong>di</strong> nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la Madre <strong>di</strong> Gesù, e con i<br />
fratelli <strong>di</strong> lui» (At 1, 14), in attesa <strong>di</strong> essere «rivestiti <strong>di</strong> potenza dall’alto» (Lc 24, 49). Dalla riflessione orante su questo<br />
evento salvifico è sorto il pio esercizio della novena <strong>di</strong> Pentecoste, molto <strong>di</strong>ffuso nel popolo cristiano.<br />
In realtà nel Messale e nella Liturgia delle Ore, soprattutto nei Vespri, tale “novena” è già presente: testi biblici ed<br />
eucologici richiamano, in vario modo, l’attesa del Paraclito. Pertanto, quando è possibile, la novena della Pentecoste sia<br />
fatta consistere nella celebrazione solennizzata dei Vespri. Ove invece questa soluzione non sia attuabile, si faccia in<br />
modo che la novena <strong>di</strong> Pentecoste rispecchi i temi liturgici dei giorni che vanno dall’Ascensione alla Vigilia <strong>di</strong><br />
Pentecoste.<br />
In alcuni luoghi viene celebrata in questi giorni la settimana <strong>di</strong> preghiera per l'unità dei cristiani 18 .<br />
La Domenica <strong>di</strong> Pentecoste<br />
Dal Catechismo della <strong>Chiesa</strong> Cattolica<br />
La Pentecoste 731 Il giorno <strong>di</strong> Pentecoste (al termine delle sette settimane pasquali), la <strong>Pasqua</strong> <strong>di</strong> Cristo si compie<br />
nell'effusione dello Spirito Santo, che è manifestato, donato e comunicato come Persona <strong>di</strong>vina: dalla sua pienezza<br />
Cristo Signore effonde a profusione lo Spirito 19 .<br />
732 In questo giorno è pienamente rivelata la Santissima Trinità. Da questo giorno, il Regno annunziato da Cristo è<br />
aperto a coloro che credono in lui: nell'umiltà della carne e nella fede, essi partecipano già alla comunione della<br />
Santissima Trinità. Con la sua venuta, che non ha fine, lo Spirito Santo introduce il mondo negli « ultimi tempi », il<br />
tempo della <strong>Chiesa</strong>, il Regno già ere<strong>di</strong>tato, ma non ancora compiuto:<br />
«Abbiamo visto la vera Luce, abbiamo ricevuto lo Spirito celeste, abbiamo trovato la vera fede:<br />
adoriamo la Trinità in<strong>di</strong>visibile, perché ci ha salvati» 20 .<br />
18 Cf. Pontificio Consiglio per l’unità dei cristiani, Directoire pour l’application des Principes et des Normes sur<br />
l’Oecuménisme (25.3.1993), 110: AAS 85 (1993) 1084.<br />
19 Cf At 2,33-36<br />
20 Ufficio delle Ore bizantino. Vespri <strong>di</strong> Pentecoste, Stico 4.
Nel calendario ebraico è chiamata “festa delle settimane” (Shavuot, in greco pentecoste): nella<br />
Scrittura è chiamata anche “festa della mietitura” o “delle primizie”. Accanto ai primi frutti della<br />
terra, Shavuot celebra anche la <strong>di</strong>vina consegna della legge a Mosè sul Monte Sinai. Gli Ebrei usano<br />
decorare le case e le sinagoge con erbe e rami ver<strong>di</strong> a ricordo della verdeggiante montagna sulla<br />
quale fu consegnata la Legge.<br />
Come abbiamo già ricordato, in origine con la parola “Pentecoste” si identificava nel culto cristiano<br />
il periodo intero dei cinquanta giorni, celebrati come la “grande domenica”. Nel sec. IV i vari<br />
significati dell’unico mistero vennero <strong>di</strong>stribuiti cronologicamente, secondo il racconto <strong>di</strong> Atti.<br />
La Pentecoste <strong>di</strong>venne subito una festa battesimale, soprattutto per quei catecumeni che non<br />
avevano superato gli scrutini <strong>di</strong> quaresima. Si teneva una veglia notturna più corta rispetto a quella<br />
pasquale (perché vi era un minor numero <strong>di</strong> battezzan<strong>di</strong>), con una strutura simile (lucernario,<br />
liturgia della parola, sacramenti). Verso l’VIII-IX secolo si cominciò ad anticipare questa veglia al<br />
sabato pomeriggio e poi al mattino (come accadde anche per la veglia pasquale).<br />
La sequenza VENI SANCTE SPIRITUS è stata attribuito a vari autori (tra cui il re Roberto il Pio <strong>di</strong><br />
Francia, papa Innocenzo III, e Stefano Langton arcivescovo <strong>di</strong> Canterbury): essa è chiamata anche<br />
“Sequenza aurea” ed è considerata uno dei capolavori della poesia sacra cristiana.<br />
Nel IX secolo venne composto l’inno VENI CREATOR attribuito a Rabano Mauro, arcivescovo <strong>di</strong><br />
Magonza. Una particolare enfasi è attribuita all’Ora Terza (con un inno proprio), in quanto celebra<br />
l’ora della <strong>di</strong>scesa dello Spirito Santo sugli apostoli.<br />
Ancora nel XIX secolo esisteva in Italia l'uso <strong>di</strong> far piovere dall'alto sui fedeli, al Gloria della messa<br />
<strong>di</strong> Pentecoste, dei petali <strong>di</strong> rose rosse, per evocare la <strong>di</strong>scesa dello Spirito Santo. Per questo la<br />
festività prese il nome anche <strong>di</strong> "<strong>Pasqua</strong> rosata", che conserva tuttora in alcune zone del centro e del<br />
sud dell'Italia, o <strong>di</strong> Pascha rosatum. Le Chiese slave bizantine vengono adornate con rami frondosi<br />
e fiori.<br />
Il Messale attuale prevede una Messa per il sabato mattina, in cui è rilevante l’orazione sulle offerte<br />
in cui lo Spirito Santo viene chiamato “la remissione <strong>di</strong> tutti i peccati”. Colletta: “Dio onnipotente<br />
ed eterno che ci dai la gioia <strong>di</strong> portare a compimento i giorni della <strong>Pasqua</strong>, fa’ che tutta la nostra<br />
vita sia una testimonianza del Signore risorto”.<br />
È prevista una Messa Vespertina per la vigilia, che prevede una ricca scelta <strong>di</strong> letture dall’Antico<br />
Testamento; il Messale italiano offre la possibilità <strong>di</strong> celebrare la Liturgia della Parola con<br />
ampiezza, sul modello della Veglia <strong>Pasqua</strong>le, con salmi e orazioni: la storia <strong>di</strong> Babele, l’alleanza sul<br />
Sinai, la visione delle ossa inari<strong>di</strong>te, la promessa dello Spirito su ogni uomo.<br />
La colletta della Messa vigiliare, celebra il compiersi della cinquantina pasquale: “Dio onnipotente<br />
ed eterno, che hai racchiuso la celebrazione della <strong>Pasqua</strong> nel tempo sacro dei cinquanta giorni,<br />
rinnova il pro<strong>di</strong>gio della Pentecoste…”.<br />
Il prefazio è una nuova composizione <strong>di</strong> frammenti del Sacramentario Gelasiano. Mentre la prima<br />
lettura è sempre il racconto <strong>di</strong> Atti (2,1-11), vi è una <strong>di</strong>versificazione per le altre letture nei cicli B e<br />
C.<br />
Il Cerimoniale dei Vescovi prescrive la celebrazione solenne della Messa e della Liturgia delle Ore<br />
da parte del vescovo (cfr. n. 376).<br />
Di grande importanza la celebrazione del Vespro, con il quale si conclude il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: esso<br />
dovrebbe essere celebrato in ogni comunità con grande solennità.<br />
DAL DIRETTORIO SU PIETÀ POPOLARE E LITURGIA<br />
La domenica <strong>di</strong> Pentecoste 156. Il tempo pasquale si conclude, al 50° giorno, con la domenica <strong>di</strong> Pentecoste,<br />
commemorativa dell’effusione dello Spirito Santo sugli apostoli (cf. At 2, 1-4), dei primor<strong>di</strong> della <strong>Chiesa</strong> e dell’inizio<br />
della sua missione ad ogni lingua, popolo e nazione. Significativa importanza ha assunto, specie nella chiesa cattedrale<br />
ma anche nelle parrocchie, la celebrazione protratta della Messa della Vigilia, che riveste il carattere <strong>di</strong> intensa e<br />
24
perseverante orazione dell’intera comunità cristiana, sull’esempio degli apostoli riuniti in preghiera unanime con la<br />
Madre del Signore 21 .<br />
Esortando alla preghiera e al coinvolgimento nella missione, il mistero della Pentecoste rischiara la pietà popolare:<br />
anch’essa «è una <strong>di</strong>mostrazione continua della presenza dello Spirito Santo nella <strong>Chiesa</strong>. Egli accende nei cuori la fede,<br />
la speranza e l’amore, virtù eccelse che danno valore alla pietà cristiana. Lo stesso Spirito nobilita le numerose e<br />
svariate forme <strong>di</strong> trasmettere il messaggio cristiano secondo la cultura e le consuetu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> ogni luogo in tutti i tempi» 22 .<br />
Con formule note, che provengono dalla celebrazione della Pentecoste (Veni, creator Spiritus, Veni, Sancte Spiritus) 23 o<br />
con brevi suppliche (Emitte Spiritum tuum et creabuntur…), i fedeli sono soliti invocare lo Spirito soprattutto all’inizio<br />
<strong>di</strong> un’attività o <strong>di</strong> un lavoro, come in particolari situazioni <strong>di</strong> smarrimento. Anche il Rosario, nel terzo mistero glorioso,<br />
invita a me<strong>di</strong>tare l’effusione dello Spirito Santo. I fedeli poi sanno <strong>di</strong> aver ricevuto, particolarmente nella<br />
Confermazione, lo Spirito <strong>di</strong> sapienza e <strong>di</strong> consiglio che li guida nella loro esistenza, lo Spirito <strong>di</strong> fortezza e <strong>di</strong> luce che<br />
li aiuta a prendere le decisioni importanti e a sostenere le prove della vita. Sanno che il loro corpo, dal giorno del<br />
Battesimo, è tempio dello Spirito Santo, e dunque va rispettato e onorato, anche nella morte, e che nell’ultimo giorno la<br />
potenza dello Spirito lo farà risorgere.<br />
Mentre apre alla comunione con Dio nella preghiera, lo Spirito Santo spinge verso il prossimo con sentimenti <strong>di</strong><br />
incontro, riconciliazione, testimonianza, desiderio <strong>di</strong> giustizia e <strong>di</strong> pace, rinnovamento della mentalità, vero progresso<br />
sociale, slancio missionario 24 . In questo spirito, la solennità <strong>di</strong> Pentecoste è celebrata in alcune comunità come «giornata<br />
della sofferenza per le missioni» 25 .<br />
Veglia <strong>di</strong> Pentecoste:<br />
Gn 11,1-9 La si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua <strong>di</strong> tutta la terra.<br />
Sal 32 Su tutti i popoli regna il Signore.<br />
ORAZIONE: Scenda su <strong>di</strong> noi, o Padre, i tuo Santo Spirito, perché tutti gli uomini cerchino sempre l'unità nell'armonia e,<br />
abbattuti gli orgogli <strong>di</strong> razza e <strong>di</strong> cultura, la terra <strong>di</strong>venti una sola famiglia, e ogni lingua proclami che Gesù è il<br />
Signore. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli.<br />
Es 19,3-8a,16-20b Il Signore scese sul monte monte Sinai davanti a tutto il popolo.<br />
Sal 102 La grazia del Signore è su quanti lo temono.<br />
ORAZIONE: O Dio dell'alleanza antica e nuova, che ti sei rivelato nel fuoco della santa montagna e nella Pentecoste del<br />
tuo Spirito, fa' un rogo solo dei nostri orgogli, e <strong>di</strong>struggi gli o<strong>di</strong> e le armi <strong>di</strong> morte; accen<strong>di</strong> in noi la fiamma della tua<br />
carità, perché il nuovo Israele radunato da tutti i popoli accolga con gioia la legge eterna del tuo amore. Per Cristo<br />
nostro Signore.<br />
Ez 37,1-14 Ossa inari<strong>di</strong>te, infonderò in voi il mio spirito e rivìvrete.<br />
Sal 50 Rinnovami, Signore, con la tua grazia.<br />
ORAZIONE: O Dio, creatore e Padre, infon<strong>di</strong> in noi il tuo alito <strong>di</strong> vita: lo Spirito che si librava sugli abissi delle origini<br />
torni a spirare nelle nostre menti e nei nostri cuori, come spirerà alla fine dei tempi per ridestare i nostri corpi alla<br />
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.<br />
Gl 3,1-5 Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo.<br />
Sal 103 Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.<br />
ORAZIONE: Ascolta, o Dio, la tua <strong>Chiesa</strong> unita in concorde preghiera in questa santa veglia a compimento della <strong>Pasqua</strong><br />
perenne; scenda sempre su <strong>di</strong> essa il tuo Spirito, perché illumini la mente dei fedeli e tutti i rinati nel Battesimo siano<br />
nel mondo testimoni e profeti. Per Cristo nostro Signore.<br />
Rm 8,22-27 Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.<br />
Gv 7,37-39 Sgorgheranno fiumi <strong>di</strong> acqua viva.<br />
Pentecoste:<br />
At 2, 1-11 Tutti furono colmati <strong>di</strong> Spirito Santo e cominciarono a parlare.<br />
Sal 103 Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.<br />
21<br />
Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lettera circolare sulla preparazione e celebrazione delle feste<br />
pasquali, 107; le modalità, i testi biblici e le orazioni per la veglia <strong>di</strong> Pentecoste – già presenti in alcune e<strong>di</strong>zioni del<br />
Messale Romano nelle varie lingue - sono in<strong>di</strong>cati in Notitiae 24 (1988) 156-159.<br />
22<br />
Giovanni Paolo II, Omelia pronunziata durante la Celebrazione della Parola a La Serena (Chile), 2, in Insegnamenti <strong>di</strong><br />
Giovanni Paolo II, X/1 (1987), cit., p. 1078<br />
23<br />
Cf. EI, Aliae concessiones 26, pp. 70-71.<br />
24<br />
Cf. Gal 5,16.22; CONCILIO VATICANO II, Ad gentes, 4; Gau<strong>di</strong>um et spes, 26.<br />
25<br />
Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Redemptoris missio, 78: in AAS 83 (1991) 325.<br />
25
1 Cor 12, 3b-7. 12-13 Noi<br />
tutti siamo stati battezzati<br />
me<strong>di</strong>ante un solo Spirito in<br />
un solo corpo<br />
Sequenza<br />
Gv 20, 19-23 Come il<br />
Padre ha mandato me<br />
anch’io mando voi.<br />
26<br />
Gal 5, 16-25 Il frutto dello<br />
Spirito.<br />
Gv 15, 26-27; 16, 12-15 Lo<br />
Spirito <strong>di</strong> verità vi guiderà<br />
a tutta la verità<br />
Rm 8, 8-17 Quelli che<br />
sono guidati dallo Spirito<br />
<strong>di</strong> Dio, questi sono figli <strong>di</strong><br />
Dio.<br />
Gv 14, 15-16. 23-26 Lo<br />
Spirito Santo vi insegnerà<br />
ogni cosa.<br />
SEQUENZA: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, datore<br />
dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica, riposo,<br />
nella calura, riparo, nel pianto, conforto. O luce beatissima, inva<strong>di</strong> nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua<br />
forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sór<strong>di</strong>do, bagna ciò che è árido, sana ciò che sánguina. Piega<br />
ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi<br />
doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.<br />
PREFAZIO: Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli <strong>di</strong> adozione in Cristo tuo<br />
Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della <strong>Chiesa</strong> nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei<br />
secoli, e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell’unica fede.
APPROFONDIMENTO TEOLOGICO<br />
Atemporalità del mistero e gloria eterna <strong>di</strong> Cristo<br />
Tratto da “Discese agli inferi, salì al cielo…”: lezioni <strong>di</strong> teologia del Card. Giacomo<br />
Biffi ai docenti universitari.<br />
Le professioni <strong>di</strong> fede in uso nella <strong>Chiesa</strong> sembrano concepire gli eventi successivi alla morte <strong>di</strong> Gesù come<br />
una teoria <strong>di</strong> fatti <strong>di</strong>stinti che si sono succeduti secondo un or<strong>di</strong>ne cronologico ben definito: la <strong>di</strong>scesa agli<br />
inferi, la risurrezione, l’ascensione, la intronizzazione alla destra del Padre, la venuta <strong>di</strong> Cristo giu<strong>di</strong>ce. È un<br />
concatenarsi <strong>di</strong> avvenimenti che prolunga senza soluzione <strong>di</strong> continuità la serie degli episo<strong>di</strong> della vita<br />
terrestre: la concezione, la nascita, la passione, la morte.<br />
Si è visto però come questa «storicizzazione» della gloria del Risorto, che pure in una certa misura è innegabilmente<br />
presente, sia nel Nuovo Testamento più superficiale che profonda tanto da presentarsi con forme<br />
e significati <strong>di</strong>versi. Soprattutto è più strumentale che intesa in modo <strong>di</strong>retto: essa viene introdotta non<br />
tanto con la pretesa <strong>di</strong> far proseguire la «storia» al <strong>di</strong> là della morte <strong>di</strong> Gesù, quanto per lo scopo <strong>di</strong> cogliere il<br />
più compiutamente possibile le componenti dell’evento pro<strong>di</strong>gioso che ha concluso la storia esaurendola.<br />
Con il passaggio dalla con<strong>di</strong>zione terrestre alla «gloria» tutto è consumato, niente può essere aggiunto. La<br />
risurrezione e già la fine: non c’è storia al <strong>di</strong> là della storia.<br />
Tuttavia la «storicizzazione» non è arbitraria e illegittima; anzi, essa è stata necessaria. Era il solo modo<br />
consentito a spiriti eminentemente concreti <strong>di</strong> cogliere la ricchezza della con<strong>di</strong>zione del Risorto. Nessuno <strong>di</strong><br />
questi fatti – la <strong>di</strong>scesa agli inferi, l’ascensione, la intronizzazione, la «parusia» – può essere negato senza<br />
che si travisi il senso dello stato <strong>di</strong> gloria. Essi sono tutti reali. Ciò che non è reale, è la loro sussistenza<br />
separata, la loro <strong>di</strong>sgregazione, dovuta solo alla nostra intelligenza <strong>di</strong>scorsiva che, se non analizza,<br />
immiserisce le sue sintesi e in definitiva travisa e tra<strong>di</strong>sce con la semplificazione la complessità dei suoi oggetti.<br />
Anzi c’è da <strong>di</strong>re che anche la cronologia, sotto qualche profilo, è reale: l’esperienza del sepolcro vuoto, le<br />
successive apparizioni del Risorto, le sue ascensioni, la pentecoste; la «parusia» in quanto manifestazioni<br />
dell’unico evento che è la «gloria» <strong>di</strong> Cristo, sono <strong>di</strong>sposte secondo una successione che trapunta la tela della<br />
storia umana e perciò è essa stessa storica senza dubbio. Non va però <strong>di</strong>menticato che sono manifestazioni<br />
temporalmente <strong>di</strong>stinte e or<strong>di</strong>nate <strong>di</strong> una realtà unica e sovratemporale.<br />
Il un torto della nostra riflessione teologica il non aver tenuto abbastanza conto della natura puramente strumentale<br />
e manifestativa <strong>di</strong> tale cronologia.<br />
C’è l’attenuante – ma è un’attenuante? – dello scarso impegno posto finora dalla teologia occidentale nella<br />
me<strong>di</strong>tazione <strong>di</strong> ciò che segue l’immolazione del Calvario, considerata praticamente come l’unico fatto<br />
redentivo. La gloria <strong>di</strong> Cristo raramente era oggetto <strong>di</strong> indagini molto approfon<strong>di</strong>te, sicché gli eventi della<br />
sua vita gloriosa venivano accettati e ripetuti senza molti controlli sulle fonti e senza troppe ricerche circa la<br />
loro intelligibilità.<br />
Di qui l’utilità <strong>di</strong> un riesame complessivo e totale della con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Gesù che «sta alla destra del Padre»<br />
(cfr. G. Biffi, Alla destra del Padre, Milano, 1970, pp. 16-18).<br />
Che un uomo – appartenente alla nostra famiglia, costituito nella nostra stessa natura – stia «alla destra del<br />
Padre», cioè sia entrato a partecipare nel modo più intenso pensabile alla <strong>di</strong>vina intimità, e quin<strong>di</strong> alla <strong>di</strong>vina<br />
potenza sull’universo, questo è l’evento che sta al centro <strong>di</strong> tutta la visione cristiana delle cose, questo è<br />
l’elemento primario e caratterizzante della nostra fede.<br />
Sicché, se ci si <strong>di</strong>mentica <strong>di</strong> questa centralità, o deliberatamente la si relega in secondo piano, o la si lascia<br />
tra le idee risapute e psicologicamente inoperanti, l’intera prospettiva offertaci dalla Rivelazione <strong>di</strong>vina si<br />
altera o almeno risulta sfocata.<br />
Oggi sta prevalendo una presentazione «debole» del cristianesimo, che ferma l’attenzione soprattutto su ciò<br />
che è «imitabile» <strong>di</strong> quanto Cristo ha compiuto: l’amore per il prossimo, l’aiuto ai poveri e agli sventurati, la<br />
donazione <strong>di</strong> se stesso agli altri. È un’attenzione giusta, doverosa, irrinunciabile, purché non si sovrapponga<br />
a quella primaria dello stato <strong>di</strong> gloria e <strong>di</strong> potenza raggiunta da Gesù <strong>di</strong> Nazaret; stato che è la fonte<br />
ontologica della «umanità nuova», e quin<strong>di</strong> anche della «carità» che è l’anima <strong>di</strong> tutta la vita ecclesiale.<br />
Anche la contemplazione del Figlio <strong>di</strong> Dio crocifisso, e quin<strong>di</strong> umiliato e sofferente – tipica della pietà occidentale<br />
– è preziosa per noi, che stiamo vivendo nelle nostre vicissitu<strong>di</strong>ni personali e comunitarie<br />
l’esperienza della sconfitta e del dolore come via obbligata alla redenzione. Ma non può farci <strong>di</strong>menticare<br />
27
che il Vangelo è essenzialmente una «buona notizia», cioè l’annuncio <strong>di</strong> una vittoria e <strong>di</strong> un trionfo sovrumano<br />
raggiunto: la vittoria <strong>di</strong> Cristo, che è anche vincita dell’uomo sulle forze del male; il trionfo definitivo<br />
del Capo come premessa al trionfo del «Christus totus».<br />
Appunto perché sta sempre più o meno rivivendo il mistero della salita al Calvario e sta verificando quoti<strong>di</strong>anamente<br />
la sua fiacchezza <strong>di</strong> fronte ai poteri mondani, la <strong>Chiesa</strong> deve tener sempre desta la convinzione<br />
della forza del suo Salvatore. È il pensiero <strong>di</strong> san Paolo che dal Signore raccoglie la parola consolante: «La<br />
mia potenza si manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,9); e perciò non esita ad affermare: «Mi<br />
vanterò quin<strong>di</strong> ben volentieri delle mie debolezze, perché <strong>di</strong>mori in me la potenza <strong>di</strong> Cristo. Perciò mi<br />
compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per<br />
Cristo: quando sono debole, è allora che sono forte» (2 Cor 12,9.10).<br />
A chi appassionatamente con<strong>di</strong>vide l’esperienza ecclesiale, troppe volte Gesù appare sconfitto e quasi<br />
estromesso dalla storia esteriore del mondo; ma proprio per questo noi abbiamo bisogno <strong>di</strong> sapere e <strong>di</strong> ricordare<br />
che già adesso il vincitore è lui, ed è lui che dalla destra del «Benedetto» muove e guida la storia<br />
vera dell’universo e dei singoli secondo il suo <strong>di</strong>segno e la sua volontà, che sono perfettamente conformi al<br />
<strong>di</strong>segno e alla volontà del Padre.<br />
Abbiamo già notato che quello <strong>di</strong> tener viva e salda la certezza della «potenza» <strong>di</strong> Cristo – come potenza già<br />
in atto, e non solo come speranza escatologica – è un problema pastorale che san Paolo sente acutamente<br />
soprattutto nelle lettere della prigionia; (…) dunque anche noi dobbiamo renderci ragione della centralità <strong>di</strong><br />
questo elemento della fede cristiana e riscoprire esistenzialmente la primarietà del Cristo «pantocrator», la<br />
cui figura dominava <strong>di</strong> solito dall’abside delle antiche basiliche.<br />
<strong>28</strong>
Premessa<br />
LA MISTAGOGIA PASQUALE<br />
Per educare alla vita buona del Vangelo<br />
“Cristiani non si nasce, si <strong>di</strong>venta”. Con questa espressione lapidaria Tertulliano<br />
(Apologeticum, 18), verso il 200, si faceva interprete <strong>di</strong> una consapevolezza che animò l’azione<br />
missionaria e pastorale della <strong>Chiesa</strong> fin dai primi tempi e che continuerà lungo i secoli. Si <strong>di</strong>venta<br />
cristiani attraverso una progressiva introduzione alla vita nuova rivelata e offerta in Gesù Cristo. A<br />
questo processo si dà il nome <strong>di</strong> iniziazione cristiana, fondata su due presupposti: lo sviluppo <strong>di</strong> una<br />
fede personale accompagnata da un fattivo cambiamento <strong>di</strong> vita e l’apporto fondamentale<br />
dell’azione educativa e santificatrice della <strong>Chiesa</strong> che trova la sua espressione culminante nella<br />
celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione.<br />
“Ogni volta, scrive Henri De Lubac, che la <strong>Chiesa</strong> indaga sulla sua fede, sul suo pensiero e<br />
sulla sua teologia, essa ritorna ai Padri”(“La costituzione Lumen Gentium e i Padri della <strong>Chiesa</strong>”, in<br />
La teologia dopo il Vaticano II, Queriniana, Brescia 1967, 2<strong>28</strong>). Nello stesso tempo l’attuale<br />
contesto sociale, culturale, religioso e anche quello ecclesiale ha pochi contatti con quello dei primi<br />
secoli. Quale lezione, dunque, il modello <strong>di</strong> catechesi del catecumenato antico può offrire alle<br />
comunità e agli operatori del nostro tempo?<br />
Fare riferimento al passato non significa cadere nella tentazione <strong>di</strong> archeologismo. Un<br />
richiamo che, già alla fine del XIX secolo, risuonava nelle sagge parole <strong>di</strong> Luis Duchesne: “Nella<br />
<strong>Chiesa</strong> nessuna preoccupazione per l’avvenire può <strong>di</strong>sinteressarsi della tra<strong>di</strong>zione. Ma non sono<br />
così antiquato da credere che l’avvenire del cristianesimo consista nella restaurazione <strong>di</strong> questo o<br />
quell’altro antico stato <strong>di</strong> cose, qualunque siano i nomi che lo raccomandano”(Autonomies<br />
ecclésiastique. Église separées, Paris 1896, VII). Richiamarsi all’esperienza dei Padri impegna a<br />
in<strong>di</strong>viduare le scelte ispiratrici del processo iniziatico e della catechesi catecumenale per, poi,<br />
attuarle con <strong>di</strong>scernimento e creatività, adattandole al nostro tempo.<br />
La scelta della pastorale mistagogica costituisce oggi una svolta necessaria per passare da<br />
una pastorale che prepara ai sacramenti a una pastorale <strong>di</strong> progressivo inserimento nel mistero.<br />
"Voglio rivolgere un'ultima parola ai nuovi illuminati; e chiamo così non solo quanti<br />
hanno meritato <strong>di</strong> recente il dono spirituale, ma pure coloro che l'hanno ricevuto già da un anno<br />
o da molto più tempo. Anch'essi se vogliono, possono gioire continuamente <strong>di</strong> tale appellativo. In<br />
realtà questa nuova giovinezza non conosce vecchiaia, non soggiace a malattia, non cede allo<br />
scoraggiamento, non appassisce con il tempo, non si arrende a nulla, non è vinta da nulla,<br />
tranne solo che dal peccato. E' il peccato infatti la sua gravosa vecchiezza ...” (S. Giovanni<br />
Crisostomo, Catechesi X, 21).<br />
Terminata la Veglia <strong>Pasqua</strong>le e dopo la prima Eucaristia non tutto è finito. Con la<br />
celebrazione dei sacramenti i catecumeni hanno varcato l'ultima porta dell'iniziazione e, secondo<br />
una espressione <strong>di</strong> san Giovanni Crisostomo, «sono ora liberi e citta<strong>di</strong>ni della <strong>Chiesa</strong>, santi, giusti,<br />
ere<strong>di</strong>, membra <strong>di</strong> Cristo e tempio dello Spirito» (Catechesi III, 5). I neofiti devono ora vivere nella<br />
novità <strong>di</strong> vita ricevuta con i sacramenti.<br />
Dal “Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti”. Il tempo della mistagogia<br />
37. Dopo quest'ultimo grado [la celebrazione dei sacramenti], la comunità insieme con i neofiti<br />
prosegue il suo cammino nella me<strong>di</strong>tazione del Vangelo, nella partecipazione all'Eucaristia e<br />
nell'esercizio della carità, cogliendo sempre meglio la profon<strong>di</strong>tà del mistero pasquale e<br />
traducendolo sempre più nella pratica della vita. Questo è l'ultimo tempo dell'iniziazione cioè il<br />
tempo della "mistagogia" dei neofiti.<br />
29
38. In realtà una più piena e più fruttuosa intelligenza dei "misteri" si acquisisce con la novità<br />
della catechesi e specialmente con l'esperienza dei sacramenti ricevuti. I neofiti infatti sono stati<br />
rinnovati interiormente, più intimamente hanno gustato la buona parola <strong>di</strong> Dio, sono entrati in<br />
comunione con lo Spirito Santo e hanno scoperto quanto è buono il Signore. Da questa esperienza,<br />
propria del cristiano e consolidata dalla pratica della vita, essi attingono un nuovo senso della fede,<br />
della <strong>Chiesa</strong> e del mondo.<br />
39. La nuova e frequente partecipazione ai sacramenti, se da un lato chiarisce l'intelligenza delle<br />
Sacre Scritture, dall'altro accresce la conoscenza degli uomini e l'esperienza della vita<br />
comunitaria, così che per i neofiti <strong>di</strong>vengono più facili e più utili insieme i rapporti con gli altri<br />
fedeli. Perciò il tempo della mistagogia ha una importanza gran<strong>di</strong>ssima e consente ai neofiti,<br />
aiutati dai padrini, <strong>di</strong> stabilire più stretti rapporti con i fedeli e <strong>di</strong> offrire loro una rinnovata<br />
visione della realtà e un impulso <strong>di</strong> vita nuova.<br />
40. Poiché la caratteristica e l'efficacia <strong>di</strong> questo tempo <strong>di</strong>pendono da questa personale e nuova<br />
esperienza della vita sacramentale e comunitaria, il momento più significativo della "mistagogia" è<br />
costituito dalle cosiddette "Messe per i neofiti" o Messe delle domeniche <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, perché in<br />
esse, oltre alla comunità riunita e alla partecipazione ai misteri, i neofiti trovano, specialmente<br />
nell'anno "A" del Lezionario, letture particolarmente adatte per loro. A queste Messe si deve<br />
perciò invitare tutta la comunità locale insieme con i neofiti e con i loro padrini. Quanto ai testi<br />
<strong>di</strong> tali Messe, si possono usare anche quando l'iniziazione si celebra fuori del tempo consueto.<br />
La mistagogia è quel tempo, limitato nella durata – da <strong>Pasqua</strong> a Pentecoste –, ma che ritorna<br />
ogni anno, nel quale la comunità cristiana accoglie al suo interno coloro che, celebrando i<br />
sacramenti dell’iniziazione cristiana, sono <strong>di</strong>ventati figli <strong>di</strong> Dio.<br />
Dall'attenta lettura delle mistagogie si evince la necessità <strong>di</strong> vedere i riti per capirli:<br />
“Desideravo anche per il passato, o figli genuini e desideratissimi della <strong>Chiesa</strong>, parlarvi <strong>di</strong><br />
questi spirituali e celesti misteri. Siccome però sapevo che si crede <strong>di</strong> più a quello che si vede che a<br />
quello che si sente, aspettai questo momento. Prendendovi ora che l'esperienza vi ha reso<br />
maggiormente atti a comprendere quello che sarà detto, vi potrò guidare (mistagogizzare) verso il<br />
prato assai splen<strong>di</strong>do e profumato <strong>di</strong> questo para<strong>di</strong>so. Ormai siete <strong>di</strong>venuti capaci dei più <strong>di</strong>vini<br />
misteri, perché fatti degni anche del battesimo vivificatore...” (Cirillo <strong>di</strong> Gerusalemme, Catechesi I,<br />
1).<br />
Tutto, dunque, deve essere analizzato, spiegato e approfon<strong>di</strong>to da parte del vescovo, e tutto<br />
come riappreso da parte dei battezzati, ma con una percezione più profonda, in quanto<br />
ontologicamente <strong>di</strong>versi dai catecumeni. All'ammonizione che ormai si deve procedere sempre in<br />
avanti: “Bada a te stesso - <strong>di</strong>ce al neofita - perché non ti avvenga che, mentre metti mano<br />
all'aratro, ti volga poi in<strong>di</strong>etro e ritorni alle amare consuetu<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> questa vita. Fuggi invece sul<br />
monte incontro a Cristo…“ (I,8).<br />
Dalla Nota pastorale “L’iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti”<br />
del Consiglio permanente della Cei (30 marzo 1997)<br />
80. - Rigenerati a vita nuova i neofiti devono essere aiutati premurosamente e amichevolmente dalla<br />
comunità dei fedeli, dai loro padrini e dai pastori ad approfon<strong>di</strong>re i misteri celebrati, a<br />
consolidare la pratica della vita cristiana e a favorire un pieno e sereno inserimento nella<br />
comunità (RICA, 235).<br />
81. - Per assicurare la formazione dei neofiti è opportuno prevedere alcuni incontri catechistici,<br />
destinati a spiegare ulteriormente i sacramenti ricevuti e a introdurre opportunamente nella<br />
comprensione degli altri sacramenti, soprattutto quello della Riconciliazione, ad approfon<strong>di</strong>re il<br />
mistero della <strong>Chiesa</strong> e il significato della vita nuova del battezzato e della sua sequela <strong>di</strong> Cristo.<br />
30
Anche le celebrazioni delle Messe per i neofiti nelle domeniche <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> favoriscono una più<br />
fruttuosa intelligenza dei misteri celebrati e la partecipazione sempre più attiva all’Eucaristia,<br />
culmine e fonte della vita ecclesiale.<br />
82. - Con particolare cura si dovrà promuovere l’esperienza comunitaria dei neobattezzati ed il<br />
loro inserimento nella vita parrocchiale. Si tratta, per i neofiti, <strong>di</strong> intensificare i rapporti personali<br />
con i <strong>di</strong>versi membri della comunità, prendere atto della vita parrocchiale e delle sue attività<br />
pastorali, conoscere forme e iniziative <strong>di</strong> formazione permanente dei fedeli adulti, alle quali aderire<br />
per continuare il cammino <strong>di</strong> fede. In questo inserimento comunitario dei neofiti hanno grande<br />
responsabilità i padrini, i catechisti e i presbìteri.<br />
83. - Alla fine del tempo <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> termina la mistagogia, ultima fase dell’iniziazione. Per la<br />
Pentecoste occorrerà prevedere, anche con solennità esterna, una celebrazione conclusiva. I<br />
neofiti, abbandonati i posti a loro riservati, si mescolano al popolo dei fedeli, come ricorda<br />
efficacemente sant’Agostino: Oggi i nostri nuovi nati si riuniscono agli altri fedeli e volano,<br />
per così <strong>di</strong>re, fuori del nido.<br />
La crescita <strong>di</strong> questi nuovi battezzati, però, non é affatto conclusa. Continua con la ricerca<br />
personale, l’esperienza comunitaria, la partecipazione alla vita liturgica e, in particolare, a itinerari<br />
<strong>di</strong> formazione permanente previsti per i fedeli adulti. Merita poi attenzione l’iniziativa, suggerita<br />
dal Rito, della celebrazione dell’anniversario del Battesimo: dopo un anno i neobattezzati si<br />
ritrovano insieme per ringraziare Dio, comunicarsi esperienze spirituali e acquistare nuove energie<br />
per il loro cammino <strong>di</strong> credenti (cf. Rica, 239).<br />
Due riflessioni potrebbero esserci utili a partire da ciò che è richiesto ai neofiti.<br />
La prima: ci siamo tanto abituati a un cristianesimo offerto tramite la cultura con<strong>di</strong>visa da<br />
prescindere quasi dal cammino <strong>di</strong> conversione o almeno da un briciolo <strong>di</strong> fede manifesta per<br />
concedere ai richiedenti le cose più sacre che abbiamo, cioè i sacramenti, cosa che non è certo nella<br />
natura né nella dottrina del cristianesimo stesso.<br />
La seconda: il fatto che i neofiti abbiano nella <strong>Chiesa</strong> uno statuto preciso, prerogative solo ora<br />
aperte, una collocazione visibile e specifica nell’Assemblea, ad<strong>di</strong>rittura per un breve periodo un<br />
abbigliamento caratteristico, ci ricorda che nella <strong>Chiesa</strong> non vige il regime dell’omogeneizzazione<br />
in<strong>di</strong>fferenziata, ma della <strong>di</strong>versità organizzata, e, si potrebbe aggiungere, anche gerarchicamente.<br />
Quin<strong>di</strong> è normale che non tutti possano o debbano fare tutto nelle nostre liturgie o nelle <strong>di</strong>verse<br />
incombenze comunitarie: i catecumeni possono entrare e fermarsi sino alla liturgia della Parola, i<br />
fedeli giungono sino alla con<strong>di</strong>visione della mensa del Signore, i neofiti hanno dei posti particolari<br />
in assemblea che abbandoneranno terminata la mistagogia; certi requisiti sono richiesti per svolgere<br />
compiti pubblici come il lettore, il padrino e simili, per altri compiti sono richieste altre attitu<strong>di</strong>ni o<br />
prerequisiti e così via. Ma tutti egualmente fanno parte del popolo <strong>di</strong> Dio in cammino verso il<br />
Regno con la stessa <strong>di</strong>gnità, benché con statuti <strong>di</strong>fferenti.<br />
Se la prassi corretta dell’iniziazione cristiana fosse più visibile, questo potrebbe aiutare a<br />
comprendere che si può far parte della <strong>Chiesa</strong> in <strong>di</strong>versi mo<strong>di</strong>: come simpatizzanti, come<br />
catecumeni, come eletti, come neofiti e anche come ministri, come ministri or<strong>di</strong>nati e, perché no,<br />
come penitenti, tanto per riprendere una prassi tanto antica quanto saggia. E che oggi potrebbe<br />
risultare <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria attualità, pensando ad esempio ai “ritorni” alla <strong>Chiesa</strong>, dopo decenni <strong>di</strong><br />
assenza, dei giovani nuben<strong>di</strong>: un inserimento pieno ed imme<strong>di</strong>ato – che corrisponderebbe in pratica<br />
alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>cale irrilevanza dell’esperienza personale passata <strong>di</strong> chi abbiamo davanti -<br />
sarebbe l’unica freccia <strong>di</strong>sponibile per il nostro arco? Ancor più interessante sarebbe una riflessione<br />
simile applicata alle nuove situazioni matrimoniali “irregolari” che si sono venute a creare.<br />
31
LE OTTO DOMENICHE DI PASQUA (Anno A)<br />
Ogni domenica celebra l’unico mistero pasquale-pentecostale, ma questo periodo ne esalta il<br />
significato ponendolo in primo piano. La celebrazione eucaristica rende presente il Signore Risorto<br />
e settimanalmente dobbiamo chiederci come cambia la nostra vita a partire dall’annuncio che «Egli<br />
non è qui (nella tomba). È risorto come aveva detto» (Mt <strong>28</strong>,6) e ci dona il suo Spirito, per cui<br />
siamo vivificati nel corpo <strong>di</strong> una umanità nuova, nella quale più «nessuno vive per se stesso o<br />
muore per se stesso» (Rm 14,7).<br />
Dalla lettura degli Atti degli apostoli si coglie l’invito a dare un volto nuovo anche alla<br />
comunità parrocchiale: il tempo pasquale è come una prolungata revisione <strong>di</strong> vita circa<br />
l’impegno <strong>di</strong> evangelizzazione, <strong>di</strong> liturgia e <strong>di</strong> vita comunitaria. Non si fa festa solo<br />
interrompendo il lavoro, ma anche impostando il lavoro in un modo nuovo, con spirito <strong>di</strong> servizio,<br />
con stile fraterno, con una più attenta premura per gli altri, confrontandosi con la Parola <strong>di</strong> Dio e<br />
con il modello delle prime comunità cristiane.<br />
1^ domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: L’annuncio del Risorto e la vita nuova (Gv 20,1-9)<br />
! Celebrazione dei sacramenti della iniziazione cristiana con l’invito alla comunità a<br />
rinnovare gli impegni del Battesimo e preghiera per i neofiti. Questi vengono aiutati a vivere<br />
la vita nuova in Cristo. I già battezzati dovrebbero chiedersi: se non fossi cristiano, deciderei<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ventarlo ? Come cambierebbe la mia vita per l’incontro con il Signore risorto ?<br />
2^ domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: La fede in Gesù risorto, gioia e amore nella <strong>Chiesa</strong> (Gv 20,19-31)<br />
! La domenica è il giorno ottavo nel quale la comunità cristiana si riunisce per annunciare la<br />
<strong>Pasqua</strong> del Signore nell’attesa della sua venuta. Il vangelo <strong>di</strong> Giovanni riporta il racconto della<br />
apparizione del Signore nel giorno stesso della risurrezione e otto giorni dopo. Egli è presente a<br />
ogni riunione dei suoi fedeli nelle assemblee domenicali: non si può mancare a questo<br />
appuntamento con il Risorto. Nella consapevolezza <strong>di</strong> questa presenza si e<strong>di</strong>fica la comunità<br />
ecclesiale per la quale la primitiva chiesa <strong>di</strong> Gerusalemme è modello esemplare.<br />
! Il Risorto dà ai <strong>di</strong>scepoli, con il dono dello Spirito, la capacità <strong>di</strong> rimettere i peccati (v. 23): i<br />
neofiti vengono progressivamente iniziati al sacramento della penitenza. Tutta la comunità,<br />
celebrando la domenica della <strong>di</strong>vina misericor<strong>di</strong>a, si chiede come accoglie il dono dello Spirito,<br />
Signore che dà la vita, anche attraverso il sacramento della misericor<strong>di</strong>a. L’esperienza<br />
rinnovatrice della <strong>Pasqua</strong> si manifesta nella vita spirituale come consolante certezza <strong>di</strong> essere stati<br />
liberati dal maligno e <strong>di</strong> essere continuamente assistiti dal Paraclito.<br />
! L’immagine <strong>di</strong> Gesù, secondo le rivelazioni a Santa Faustina Kowalska, comunica il tono<br />
del tempo pasquale: il Cristo mostra i segni della passione che lo hanno fatto entrare nell’oscurità<br />
della morte, ma ora sono come una sorgente <strong>di</strong> luce e colore. Come recita il III Prefazio pasquale:<br />
«Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato: sacrificato sulla croce più non<br />
muore, e con i segni della passione vive immortale».<br />
Se nella quaresima si è sperimentata la vita cristiana come sequela <strong>di</strong> Gesù nell’accettazione<br />
della croce, ora si deve poterla sentire come espansione del cuore, penetrato dallo Spirito, in opere<br />
<strong>di</strong> carità. Il servizio, <strong>di</strong> per sé faticoso, viene reso facile dall’interiore mozione dello Spirito del<br />
Signore. In un clima <strong>di</strong> entusiasmo si compie ciò che normalmente si fa con sforzo.<br />
3^ domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: Gesù: compimento delle Scritture, riconosciuto nello spezzare il pane (Lc<br />
24,13-35).<br />
! Nella liturgia si metterà in rilievo il momento della fractio panis. I neofiti vengono aiutati a<br />
comprendere la messa, soprattutto nella parte propriamente eucaristica e la comunità<br />
cristiana rinnova l’impegno a preparare adeguatamente la celebrazione domenicale. (Durante<br />
la settimana si troverà l’occasione per presentare il gruppo liturgico ai neofiti)<br />
32
4^ domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: Il buon Pastore presente nella <strong>Chiesa</strong> (Gv 10,1-10).<br />
! La presenza del Risorto continua attraverso il ministero dei pastori; ma questa domenica offre<br />
l’occasione per presentare la comunità cristiana come il gregge le cui pecore sono conosciute e<br />
chiamate per nome e ciascuna risponde alla voce del pastore e lo segue. Ognuno ha un nome,<br />
una responsabilità, un servizio nella <strong>Chiesa</strong>. Ciascuno è invitato a superare l’anonimato per<br />
rendere operante la grazia sacramentale del battesimo.<br />
(Si troverà l’occasione per fare incontrare i neofiti con i ministri della comunità cristiana:<br />
sacerdote, <strong>di</strong>acono, accolito, lettore, catechisti, <strong>di</strong>rettore coro …)<br />
5^ domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: La <strong>Chiesa</strong> fra la partenza e il ritorno <strong>di</strong> Cristo (Gv 14,1-12)<br />
! «Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me»: siamo <strong>di</strong> fronte alla coerenza della fede<br />
rappresentata più che da parole da gesti <strong>di</strong> accoglienza per cui nella casa del Padre c’è posto per<br />
tutti. Il libro degli Atti presenta oggi la scelta da parte della comunità <strong>di</strong> sette uomini per un servizio<br />
<strong>di</strong> carità. Tutti sono interpellati a prendere atto delle emergenze del momento e a rispondervi<br />
con la propria <strong>di</strong>sponibilità personale.<br />
! Si potrebbe suggerire anche un impegno specifico <strong>di</strong> carità, motivato dalla fede (cfr l’insistenza<br />
del vangelo sull’aver fede/credere) da portare nella messa della domenica successiva (quando la<br />
continuazione del vangelo insisterà sull’amore).<br />
I neofiti verranno adeguatamente informati sulle iniziative <strong>di</strong> carità della comunità<br />
parrocchiale (presentazione del Gruppo caritas).<br />
6^ domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: La promessa dello Spirito Santo (Gv 14,15-21)<br />
! Le letture <strong>di</strong> oggi (il ministero <strong>di</strong> Filippo e l’invito <strong>di</strong> Paolo a dare ragione della speranza che<br />
abbiamo) suggeriscono <strong>di</strong> verificare la missione <strong>di</strong> evangelizzare. La comunità cristiana – in<br />
particolare gli adulti – vengono sollecitati ad avere occasioni <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento della fede<br />
per riuscire a orientare la propria umanità nella vera libertà dello Spirito (interiorizzare il<br />
comandamento dell’amore) e per testimoniare la fede. Così la <strong>Chiesa</strong> rende presente il Signore<br />
Risorto.<br />
Verranno presentati ai neofiti i catechisti e gli educatori con i vari momenti <strong>di</strong> formazione alla<br />
fede.<br />
7^ Ascensione: Esaltazione <strong>di</strong> Gesù vivente nella gloria <strong>di</strong> Dio Padre in comunione con lo Spirito<br />
Santo (Mt <strong>28</strong>,16-20).<br />
! L’esperienza pasquale fa vivere l’impegno nel mondo avendo chiara la speranza <strong>di</strong> un destino<br />
escatologico.<br />
! I neofiti sono invitati a trovare un nuovo equilibrio nella organizzazione della propria vita,<br />
tenendo conto della prospettiva del regno, tutta la comunità cristiana deve essere in questa<br />
ricerca <strong>di</strong> un modo nuovo <strong>di</strong> vivere la quoti<strong>di</strong>anità come «feria».<br />
«Certo, siamo avvertiti che niente giova all’uomo se guadagna il mondo intero ma perde se stesso.<br />
Tuttavia l’attesa <strong>di</strong> una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitu<strong>di</strong>ne<br />
nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell’umanità nuova che già riesce ad<br />
offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba<br />
accuratamente <strong>di</strong>stinguere il progresso terreno dallo sviluppo del Regno <strong>di</strong> Dio, tuttavia, nella<br />
misura in cui può contribuire a meglio or<strong>di</strong>nare l’umana società, tale progresso è <strong>di</strong> grande<br />
importanza per il Regno <strong>di</strong> Dio» (GS 39; cfr. anche GS 43 e 57).<br />
8^ Pentecoste: Manifestazione dello Spirito Santo nella <strong>Chiesa</strong> (Gv 20,19-23)<br />
! Memoria della confermazione come conferma dell’adesione al Signore Risorto attraverso la<br />
preghiera per domandare l’effusione dello Spirito.<br />
! La <strong>Chiesa</strong> è ricca dei doni dello Spirito che siamo chiamati a riconoscere e ad accogliere. Quali<br />
carismi sono presenti nel territorio parrocchiale? Istituti <strong>di</strong> vita consacrata, movimenti ecclesiali,<br />
gruppi <strong>di</strong> preghiera … I neofiti vengano messi a conoscenza <strong>di</strong> questa vitalità e la comunità a<br />
trovare le via della comunione per l’unica missione e l’utilità comune (1 Cor 12).<br />
33
«Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, il Cristo resta nel passato, il vangelo una lettera<br />
morta, la <strong>Chiesa</strong> una semplice organizzazione, l’autorità un potere, la missione una propaganda, il<br />
culto un arcaismo, e l’agire morale un agire da schiavi. Ma nello Spirito Santo il cosmo è<br />
nobilitato per la generazione del Regno, il Cristo risorto si fa presente, il vangelo si fa potenza e<br />
vita, la <strong>Chiesa</strong> realizza la comunione trinitaria, l’autorità si trasforma in servizio, la liturgia è<br />
memoriale e anticipazione, l’agire umano viene deificato» (Atenagora).<br />
DEPOSIZIONE DELLA VESTE BIANCA NELLA DOMENICA “IN ALBIS”<br />
Anticamente a Roma, alla sera del sabato in albis, quando i neofiti tornavano a visitare il<br />
battistero, il papa pronunciava sui nuovi battezzati una preghiera mentre toglievano la veste bianca<br />
battesimale. Questo significava l’ingresso nella or<strong>di</strong>narietà della vita cristiana.<br />
Dove ci sono neofiti battezzati nella veglia pasquale si può compiere il gesto della<br />
riconsegna della veste battesimale. Il presidente alla porta della chiesa ACCOGLIE I<br />
CATECUMENI CHE INDOSSANO LA VESTE BIANCA e li accompagna ai posti preparati per<br />
loro, inizia la celebrazione con il rito dell’aspersione e lo conclude con la seguente preghiera:<br />
Visita, Signore, questo tuo popolo con i tuoi <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> salvezza;<br />
ve<strong>di</strong> come è tutto illuminato dalla gioia pasquale<br />
e conserva nei nostri neofiti ciò che tu stesso hai operato in loro.<br />
Fa’ che mentre si spogliano delle vesti bianche,<br />
il loro cambiamento sia soltanto esteriore:<br />
L’invisibile candore <strong>di</strong> Cristo sia inseparabile dalla loro vita: fa’ che non lo perdano mai.<br />
La tua grazia aiuti tutti ad ottenere, per mezzo delle buone opere,<br />
quella vita immortale alla quale impegna il mistero della <strong>Pasqua</strong>.<br />
Per Cristo nostro Signore. Amen<br />
I neofiti depongono le vesti bianche e vengono accompagnati in mezzo all’assemblea. È<br />
bene comunque che per tutte le domeniche <strong>di</strong> pasqua i neofiti abbiano un loro posto.<br />
BATTESIMO-CONFERMAZIONE NELLA LUCE DELLA PASQUA-PENTECOSTE<br />
Si può <strong>di</strong>re che il Battesimo si rapporta alla <strong>Pasqua</strong> e la Confermazione alla Pentecoste, però<br />
considerate come aspetti <strong>di</strong> un unico evento: la risurrezione dai morti del Signore che dona il suo<br />
Spirito alla <strong>Chiesa</strong>. Questa realtà così ricca e complessa ha avuto bisogno <strong>di</strong> esprimersi in momenti<br />
<strong>di</strong>fferenti, così essa viene comunicata al cristiano nella <strong>Chiesa</strong> con segni <strong>di</strong>fferenziati e in<br />
celebrazioni articolate.<br />
Non si attende la Pentecoste per richiamare la <strong>di</strong>mensione «crismale» della esistenza<br />
cristiana: essa è già ricordata a <strong>Pasqua</strong>, quando i fedeli ringraziano Dio per la salvezza ricevuta in<br />
Gesù Cristo, rinnovano i loro impegni, e quin<strong>di</strong> prendono atto della testimonianza che essi devono<br />
rendere al Signore. Anzi, tutta la «cinquantina pasquale» contribuisce a risvegliare nei cristiani la<br />
loro coscienza <strong>di</strong> essere presi nel <strong>di</strong>namismo pentecostale <strong>di</strong> crescita e <strong>di</strong> cooperazione per e<strong>di</strong>ficare<br />
la <strong>Chiesa</strong> come servizio al mondo.<br />
Entrambi i sacramenti Battesimo-Confermazione hanno nel <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> il loro «luogo»<br />
opportuno per essere richiamati e approfon<strong>di</strong>ti nei doni che conferiscono, dopo essersi <strong>di</strong>sposti nella<br />
preparazione quaresimale ad assecondarne le esigenza <strong>di</strong> conversione e <strong>di</strong> lotta.<br />
L’EUCARISTIA E LA COMUNIONE DELLO SPIRITO SANTO<br />
La seconda «preghiera eucaristica» recita, rivolgendosi al Padre: «…santifica questi<br />
doni con l’effusione del tuo Spirito perché <strong>di</strong>venti cono per noi il corpo e il sangue <strong>di</strong> Gesù Cristo<br />
nostro Signore». Questa preghiera detta «epicletica» (dal greco epiclesis = invocazione) è<br />
34
accompagnata dall’imposizione delle mani: tipico gesto esprimente l’azione dello Spirito Santo.<br />
Questo intervento dello Spirito Santo non è limitato al momento pre-consacratorio; esso è invocato<br />
anche dopo la consacrazione perché nella comunità <strong>di</strong> coloro che si comunicheranno continui la sia<br />
azione trasformante: «Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue <strong>di</strong> Cristo lo<br />
Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo» (seconda «preghiera eucaristica»). Questo corpo nel<br />
quale essere riuniti è quello ecclesiale <strong>di</strong> Cristo. Lo Spirito Santo quin<strong>di</strong> anche attraverso<br />
l’eucaristia continua l’attività che si manifesta in tutta la storia della salvezza, perché la <strong>Chiesa</strong> si<br />
e<strong>di</strong>fichi nella storia e per il mondo come corpo <strong>di</strong> Cristo.<br />
NOTA SULLA “MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE”<br />
L’Eucaristia è il sacramento culmine dell’iniziazione cristiana; perciò la “Messa <strong>di</strong> prima<br />
Comunione” deve necessariamente far riferimento all’iniziazione e, in particolare al Battesimo;<br />
anche la celebrazione della Confermazione ha inizio con la memoria del Battesimo. Un<br />
orientamento dato dalle CEI relativamente all’iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi <strong>di</strong>ce<br />
giustamente che "In considerazione del legame con il mistero pasquale i sacramenti dell’iniziazione<br />
cristiana si celebrano <strong>di</strong> norma nella Veglia <strong>Pasqua</strong>le, o in altra domenica durante il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>” (n. 46; cfr. anche 55). Anche l’Istruzione del 25 marzo 2004 Redemptionis sacramentum su<br />
"Alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia", <strong>di</strong>ce: "Salvo casi<br />
eccezionali, è poco appropriato amministrarla il Giovedì Santo "in Cena Domini". Si scelga<br />
piuttosto un altro giorno, come le domeniche II-VI <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> o la solennità del Santissimo Corpo e<br />
Sangue <strong>di</strong> Cristo o le domeniche "per annum", in quanto la domenica è giustamente considerata il<br />
giorno dell’Eucaristia” (n. 87).<br />
MEMORIA DELLA CONFERMAZIONE NEL GIORNO DI PENTECOSTE<br />
… Viene adombrata la carne dalla imposizione delle mani perché l’anima rifulga illuminata dallo<br />
Spirito … (Tertulliano, De resurrectione mortuorum, VIII,3)<br />
Il rito ripropone all’assemblea dei fedeli l’imposizione delle mani, memoriale della loro<br />
Confermazione nel giorno della Cresima, secondo sacramento della’iniziazione cristiana,<br />
Pentecoste personale in comunione con tutta la <strong>Chiesa</strong>.<br />
Dopo l’omelia il <strong>di</strong>acono o un ministro accende dal cero pasquale le candele <strong>di</strong>stribuite in<br />
precedenza ai fedeli. Tenendo in mano la candela accesa il presidente invita a rinnovare la<br />
professione <strong>di</strong> fede nella formula battesimale (cfr. Messale, Veglia <strong>Pasqua</strong>le o Rituale del<br />
Battesimo).<br />
Quin<strong>di</strong> il presidente <strong>di</strong>ce la seguente preghiera imponendo le mani sull’assemblea:<br />
Dio onnipotente,<br />
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,<br />
che ci hai rigenerato dall’acqua e dallo Spirito Santo liberandoci dal peccato,<br />
rinnova su <strong>di</strong> noi in questo giorno santo<br />
l’effusione del Tuo Santo Spirito Paraclito:<br />
spirito <strong>di</strong> sapienza e <strong>di</strong> intelletto,<br />
spirito <strong>di</strong> consiglio e <strong>di</strong> fortezza,<br />
spirito <strong>di</strong> scienza e <strong>di</strong> pietà,<br />
e riempici dello Spirito del tuo santo timore.<br />
Per Cristo nostro Signore.<br />
Amen.<br />
Si spengono i ceri e il rito prosegue con la preghiera universale.<br />
35
Presidente:<br />
Fratelli carissimi,<br />
invochiamo Dio, Padre onnipotente:<br />
sia unanime la nostra preghiera,<br />
in quell’unità <strong>di</strong> fede, speranza e carità,<br />
che lo Spirito Santo genera nei nostri cuori.<br />
Diacono o ministro:<br />
Padre santo, tu mandasti nella Pentecoste il tuo Spirito dando inizio e vita alla tua <strong>Chiesa</strong>.<br />
Da quel giorno continui a radunare sulla terra una moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> fedeli<br />
che tu hai scelto ed unito al tuo Figlio, Gesù Cristo, Signore e fratello nostro;<br />
fa’ che questo tuo popolo, nel suo vangelo, cresca nell’unità della fede e dell’amore<br />
in unione con il papa, i vescovi, i presbiteri e i <strong>di</strong>aconi, fino alla sua venuta, noi ti preghiamo:<br />
Ascoltaci, o Signore !<br />
Cristo Gesù, tutti gli uomini hanno un solo Creatore e Padre<br />
fa’ che tutti si riconoscano fratelli senza <strong>di</strong>scriminazione <strong>di</strong> razze, <strong>di</strong> lingua, <strong>di</strong> religione,<br />
fa’ che cerchino con lealtà e purezza <strong>di</strong> cuore il regno del Padre<br />
che è pace e gioia sotto la guida del tuo Spirito Paraclito, noi ti preghiamo:<br />
Ascoltaci, o Signore !<br />
Spirito Paraclito, l’immensità del cielo è piena della tua sapienza,<br />
l’or<strong>di</strong>ne del creato è pieno della tua scienza, quanto la terra contiene ci rivela la tua bontà;<br />
dona a coloro che ci governano il dono della saggezza,<br />
ai responsabili della società civile il tuo consiglio,<br />
a noi pellegrini sulla terra la tua fortezza, ai poveri, ai malati, agli oppressi il tuo conforto,<br />
a tutte le vittime dell’o<strong>di</strong>o umano la tua pietà,<br />
a quanti abusano dei tuoi doni il tuo perdono, noi ti preghiamo:<br />
Ascoltaci, o Signore !<br />
Presidente:<br />
O Dio, che nell’amore della creazione ci hai voluti a tua immagine e somiglianza;<br />
per riscattarci dalla <strong>di</strong>sobbe<strong>di</strong>enza antica hai mandato e sacrificato il tuo Figlio,<br />
e ai suoi apostoli hai dato lo Spirito Santo<br />
affinché per mezzo <strong>di</strong> essi e dei loro successori fosse trasmesso a tutti i membri della tua <strong>Chiesa</strong>,<br />
esau<strong>di</strong>sci la nostra preghiera: continua oggi, nella comunità dei credenti,<br />
i pro<strong>di</strong>gi che il tuo amore ha operato agli inizi della pre<strong>di</strong>cazione del vangelo<br />
ed esten<strong>di</strong> il tuo Spirito Paraclito sulla intera umanità,<br />
frutto della tua creazione, affinché tutti ricevano grazia, misericor<strong>di</strong>a e pace.<br />
Per Cristo nostro Signore. Amen<br />
36
C ELEBRARE IL T EMPO DI P ASQUA<br />
“I 50 giorni dalla domenica <strong>di</strong> Resurrezione alla domenica <strong>di</strong><br />
Pentecoste sono celebrati nella letizia e nell'esultanza come<br />
un solo giorno <strong>di</strong> festa, anzi come una GRANDE domenica”<br />
(“Norme generali sull'anno liturgico e sul calendario”, n.° 22).<br />
Fin dai primi secoli la <strong>Chiesa</strong> ha sentito il bisogno <strong>di</strong><br />
organizzare un tempo liturgico che aiutasse i cristiani<br />
ad approfon<strong>di</strong>re l'evento centrale della loro fede,<br />
ovvero il Mistero della <strong>Pasqua</strong>. È noto che già a partire<br />
dal III secolo, la festa annuale della <strong>Pasqua</strong> <strong>di</strong>venne una<br />
“cinquantina gioiosa” (Tertulliano parla <strong>di</strong> “laetissimum spatium”), una grande domenica che<br />
durava 7 settimane, durante le quali si commemoravano<br />
insieme la Resurrezione del Crocifisso, la sua <strong>di</strong>partita e il<br />
dono dello Spirito Santo. Ancora oggi i 50 giorni che<br />
uniscono la domenica <strong>di</strong> Resurrezione a quella <strong>di</strong> Pentecoste,<br />
che noi chiamiamo <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, costituiscono un itinerario spirituale <strong>di</strong> necessario<br />
approfon<strong>di</strong>mento del Mistero <strong>Pasqua</strong>le vero e proprio archetipo della vita della <strong>Chiesa</strong> e<br />
dell'esistenza cristiana.<br />
Durante i 50 giorni infatti «la comunità, insieme con i nuovi battezzati, prosegue il suo cammino<br />
nella me<strong>di</strong>tazione del Vangelo, nella partecipazione all'Eucaristia e nell'esercizio della carità,<br />
cogliendo sempre meglio la profon<strong>di</strong>tà del Mistero pasquale e traducendolo sempre più nella pratica<br />
della vita» (Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, n.° 37).<br />
Tutta la vita <strong>di</strong> Gesù è stata l’annunzio dell’ “oggi” <strong>di</strong> Dio, Gli Atti, testo tipicamente<br />
pasquale, raccontano che quell’ “oggi” non si è arrestato con la Resurrezione, con l’Ascensione, ma,<br />
a partire dalla manifestazione ed effusione dello Spirito continua, nell’ “oggi” della <strong>Chiesa</strong> La<br />
<strong>Chiesa</strong> è frutto della <strong>Pasqua</strong> e, attraverso <strong>di</strong> essa, noi incontriamo il Cristo risorto. La “cinquantina”<br />
<strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> è un unico tempo. Non è un tempo per arrivare alla Pentecoste, non è un tempo <strong>di</strong><br />
transizione per arrivare ad una nuova festa, ma è un tempo tutto festivo, perché ciò che la <strong>Pasqua</strong><br />
dona è ormai attuale. La lettura cronologicamente anticipata degli Atti, già prima <strong>di</strong> Pentecoste, ci<br />
riporta a questo mistero: la vita liturgica della <strong>Chiesa</strong>, espressamente nella sua <strong>di</strong>mensione<br />
sacramentale, è vita e presenza del Cristo risorto e dello Spirito. La <strong>di</strong>mensione ecclesiologica si<br />
rivela così realtà sacramentale. Il Cristo risorto, Colui che spezza il pane già con i <strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong><br />
Emmaus, è lo stesso Cristo che ha radunato la prima comunità nella “fractio panis” ed è Colui che<br />
“oggi” raduna la <strong>Chiesa</strong>, <strong>di</strong>spersa nel mondo intorno, all’unica Eucaristia.<br />
Come afferma Nocent:«possiamo vedere nelle otto domeniche <strong>di</strong> Pentecoste – 49 giorni+uno – “la<br />
volontà <strong>di</strong> esprimere l’ultimo giorno”, l’ottavo giorno, oramai iniziato in terra, dall’unica <strong>Pasqua</strong><br />
che si protende nel tempo».<br />
La Liturgia della Parola non si <strong>di</strong>spiega, nel <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, in una successione cronologica <strong>di</strong><br />
eventi, ma nella riproposizione dei <strong>di</strong>fferenti aspetti delle meraviglie e dell’opera della<br />
Resurrezione.<br />
Il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> inizia con la domenica <strong>di</strong> Risurrezione e si protrae per cinquanta giorni<br />
fino alla solennità <strong>di</strong> Pentecoste, per questo motivo è anche detto Cinquantina pasquale.<br />
Nella tra<strong>di</strong>zione patristica e liturgica i cinquanta giorni che seguivano la celebrazione della <strong>Pasqua</strong><br />
annuale venivano considerati come una grande domenica, un solo “grande giorno”. Per la <strong>Chiesa</strong><br />
antica i cinquanta giorni del tempo <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> erano vissuti come «una perenne e ininterrotta<br />
festività» nella quale si celebrava nella gioia la risurrezione del Signore. In tali giorni era vietato<br />
ogni atteggiamento e ogni gesto che ne potesse oscurare il carattere festivo e gioioso (<strong>di</strong>giuno,<br />
genuflessioni…) e ciò per esprimere la gioia della <strong>Chiesa</strong> per la vittoria del Signore sulla morte e<br />
per la nuova vita che la partecipazione alla <strong>Pasqua</strong> <strong>di</strong> Cristo aveva fatto germogliare nei credenti.<br />
37<br />
“Il Signore è davvero<br />
risorto. Alleluia. A<br />
lui gloria e potenza<br />
nei secoli eterni”.<br />
(Ant. ingresso Dom. <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong>)
Quando i padri affermano che si tratta <strong>di</strong> “una grande domenica”, intendono questo tempo pasquale<br />
come un unico “ottavo giorno”, nome che veniva dato alla domenica, cioè un giorno che va fuori<br />
dai ritmi normali del tempo, fondato sulla settimana, <strong>di</strong>venendo in tal modo profezia, anticipazione,<br />
“caparra” della vita eterna. È per questo motivo che le domeniche del <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> sono<br />
considerate domeniche <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> e, dopo la domenica <strong>di</strong> risurrezione, si chiamano domeniche II,<br />
III, IV, V, VI e VII <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>. Questo sacro tempo dei cinquanta giorni si conclude con la domenica<br />
<strong>di</strong> Pentecoste.<br />
A partire dai testi biblici ed eucologici si comprende subito come la <strong>Chiesa</strong> in questo <strong>Tempo</strong><br />
sia condotta a “fare propria” la <strong>Pasqua</strong> che ha celebrato “in unità” nel Triduo santo. Tutta la liturgia,<br />
nelle domeniche <strong>di</strong> questo tempo liturgico, guida all’incontro con il Cristo risorto presente nella<br />
comunità dei credenti e mostra i frutti della <strong>Pasqua</strong> nella vita della <strong>Chiesa</strong>, nelle varie angolature<br />
nelle quali è possibile comprendere il mistero pasquale.<br />
Cristo Gesù, il Signore, è <strong>di</strong>venuto il Vivente ed è presente ed operante nella <strong>Chiesa</strong>: domenica per<br />
domenica la celebrazione liturgica introduce a tale realtà. Il Risorto, viene incontro alla comunità<br />
radunata nel suo nome, si lascia incontrare e toccare da ogni generazione <strong>di</strong> credenti, anche da chi,<br />
come Tommaso, la sera del giorno <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> era assente. Nella sua <strong>Pasqua</strong> è <strong>di</strong>venuto per la <strong>Chiesa</strong><br />
Colui nel quale le Scritture trovano pieno compimento, la loro chiave interpretativa e il loro senso<br />
ultimo. Nello spezzare il pane, con e per mezzo dei gesti memoriali dell’Ultima Cena, gli occhi dei<br />
<strong>di</strong>scepoli si aprono e «ritorna la memoria del cuore che ardeva nel loro petto mentre il Risorto,<br />
pellegrino sconosciuto che camminava accanto a loro sulla strada, spiegava le Scritture». Egli è il<br />
buon pastore che i <strong>di</strong>scepoli hanno seguito nel suo cammino verso la <strong>Pasqua</strong>, hanno ascoltato le sue<br />
parole e visto i suoi gesti; ora pertanto ne riconoscono la voce e lo seguono. Egli è il pastore che<br />
continua a nutrire le pecore con la sua stessa vita alla duplice mensa del banchetto eucaristico,<br />
anticipazione e prelu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> quel banchetto preparato dal Padre, fin dalla fondazione del mondo, per<br />
tutta l’umanità. Quin<strong>di</strong> Gesù Risorto è <strong>di</strong>venuto per la sua <strong>Chiesa</strong> la guida, Colui che la conduce<br />
attraverso i sentieri della storia verso i pascoli della vita eterna. Gesù il Signore è “la via”, una “via<br />
nuova e vivente” inaugurata per noi (cfr. Eb 10,20), quella via che ogni <strong>di</strong>scepolo/ credente è<br />
chiamato a percorrere per giungere alla piena conformazione con il suo Maestro e Signore. Cristo<br />
Gesù è la verità e la vita, Colui che rivela il volto del Padre perché insegna e consegna ai suoi<br />
<strong>di</strong>scepoli il comandamento dell’amore, quell’amore da Lui vissuto nella totalità del dono. Non si<br />
tratta, infatti, semplicemente della consegna <strong>di</strong> una norma, ma della consegna <strong>di</strong> un modello <strong>di</strong> vita,<br />
<strong>di</strong> progetto esistenziale.<br />
Nella <strong>Pasqua</strong> <strong>di</strong> Gesù è stato dato alla <strong>Chiesa</strong> il dono per eccellenza, quel dono che rende possibile e<br />
attuale ognuno dei doni che abbiamo appena elencato: il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito è il<br />
Consolatore, colui che guida i <strong>di</strong>scepoli alla “verità tutta intera” e che “ricorderà” tutto ciò che Gesù<br />
ha detto; è il “dono” dei tempi messianici, “segno” del compimento delle promesse <strong>di</strong> Dio. Che la<br />
Pentecoste sia il compimento e il coronamento del tempo pasquale lo <strong>di</strong>mostra anche il fatto che il<br />
termine “Pentecoste” sia stato usato sia per in<strong>di</strong>care l’ultimo giorno <strong>di</strong> questo tempo, sia l’intero<br />
periodo dei cinquanta giorni.<br />
La celebrazione liturgica del <strong>Tempo</strong> pasquale, mentre annuncia e celebra la presenza viva del<br />
Risorto nella comunità dei credenti, le rivela i molteplici volti della <strong>Pasqua</strong>, delineando anche i<br />
«tratti irrinunciabili del volto della <strong>Chiesa</strong>, le realtà che stanno alla base della sua vita e che le sono<br />
state donate appunto dalla vittoria pasquale del suo Signore».<br />
Il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> è, per eccellenza, il tempo della mistagogia, cioè il tempo della “intelligenza dei<br />
misteri” che si sono celebrati nella notte <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: luogo proprio della celebrazione dei sacramenti<br />
dell’iniziazione cristiana, in quanto i sacramenti sono partecipazione alla vittoria pasquale <strong>di</strong> Cristo,<br />
eventi sorgivi del processo <strong>di</strong>namico <strong>di</strong> conformazione a Lui.<br />
Fin dall’antichità è esistita nella <strong>Chiesa</strong> una speciale metodologia catechistica che, proprio a<br />
partire da una comprensione piena dei riti e delle preghiere, tende a far partecipare attivamente i<br />
fedeli alla celebrazione liturgica. Questa catechesi prese il nome <strong>di</strong> catechesi mistagogica.<br />
38
Il termine mistagogia affonda le ra<strong>di</strong>ci nella parola greca mystérion che a sua volta deriva<br />
dal verbo myéô che significa: insegnare una dottrina, iniziare ai misteri; infatti «erano chiamati<br />
mystai coloro che venivano introdotti (= ago) nella comprensione piena dei santi misteri della fede<br />
al termine del catecumenato e dopo aver ricevuto i tre sacramenti dell’Iniziazione cristiana:<br />
Battesimo, Confermazione, Eucaristia». La tra<strong>di</strong>zione ci riporta antiche e splen<strong>di</strong>de catechesi<br />
mistagogiche <strong>di</strong> alcuni dei Padri della <strong>Chiesa</strong> facendone emergere la finalità. Cirillo <strong>di</strong><br />
Gerusalemme, ad esempio, nel rivolgersi ai neofiti li chiama «figli genuini e desideratissimi della<br />
<strong>Chiesa</strong>»; spiega il tempo e lo stile della catechesi mistagogica in questo modo: «Siccome sapevo<br />
che si crede <strong>di</strong> più a quello che si vede che a quello che si ode, ho aspettato questo<br />
momento...Ormai siete <strong>di</strong>venuti capaci dei più <strong>di</strong>vini misteri, perché fatti degni anche del battesimo<br />
vivificatore. Dal momento che ormai bisogna imban<strong>di</strong>re a voi il banchetto degli insegnamenti più<br />
perfetti, incominciamo dunque a insegnarveli <strong>di</strong>ligentemente, affinché compren<strong>di</strong>ate quello che<br />
avete veduto compiersi su <strong>di</strong> voi nella notte del battesimo».<br />
Teodoro <strong>di</strong> Mopsuestia nelle sue Omelie catechetiche: «Ogni sacramento è l'in<strong>di</strong>cazione, attraverso<br />
segni e simboli, <strong>di</strong> realtà invisibili e ineffabili. Una rivelazione e una spiegazione su tali realtà sono<br />
certamente necessarie, se qualcuno vuole conoscere la forza <strong>di</strong> questi misteri. Se ciò che accade<br />
effettivamente fosse soltanto quello che si vede fare, la spiegazione sarebbe superflua, perché<br />
basterebbe la vista a mostrarci le cose che si verificano. Ma nel sacramento si trovano i segni <strong>di</strong> ciò<br />
che avverrà (nel futuro) o <strong>di</strong> ciò che è già avvenuto (nel passato), e perciò è necessario un <strong>di</strong>scorso<br />
che spieghi il senso dei segni e dei misteri». In tal modo le catechesi mistagogiche sono <strong>di</strong>stinte,<br />
come tempo e come metodologia, sia dalla catechesi catecumenale che dall'omelia.<br />
Nella <strong>Chiesa</strong> antica alla mistagogia era de<strong>di</strong>cata tutta la settimana che segue la <strong>Pasqua</strong>; il<br />
Vescovo rivolgendosi ai «neofiti» (= nuove piante) offriva «il banchetto degli insegnamenti più<br />
perfetti»; che si concludeva con la domenica in albis, così detta per la deposizione delle vesti<br />
bianche. La mistagogia aveva dunque la funzione <strong>di</strong> condurre, attraverso i segni, oltre la soglia del<br />
mistero cristiano dove è possibile incontrare il Signore risorto che misticamente, e realmente, si fa<br />
presente alla sua <strong>Chiesa</strong>.<br />
La mistagogia, sia come termine che come metodo del processo dell’ Iniziazione cristiana è<br />
ritornata a pieno titolo, come frutto della riflessione conciliare del Vaticano II. Il nuovo Rito<br />
dell’iniziazione cristiana degli adulti (= RICA, 1972), consapevole dell'importanza che hanno i<br />
santi segni per entrare più profondamente nel mistero cristiano, ha recuperato questa antica<br />
tra<strong>di</strong>zione: «Dopo quest'ultimo grado (il conferimento dei 3 sacramenti <strong>di</strong> Iniziazione: Battesimo,<br />
Confermazione, Eucaristia), la comunità insieme con i neofiti prosegue il suo cammino nella<br />
me<strong>di</strong>tazione del Vangelo, nella partecipazione all'Eucaristia e nell'esercizio della carità, cogliendo<br />
sempre meglio la profon<strong>di</strong>tà del mistero pasquale e traducendolo sempre più nella pratica della vita.<br />
Questo è l'ultimo tempo dell'Iniziazione cioè il tempo della "mistagogia" dei neofiti» (RICA 37). E<br />
continua ancora: «In realtà una più piena e più fruttuosa intelligenza dei misteri si acquisisce con la<br />
novità della catechesi e specialmente con l'esperienza dei sacramenti ricevuti. I neofiti infatti sono<br />
stati rinnovati interiormente, più intimamente hanno gustato la buona parola <strong>di</strong> Dio, sono entrati in<br />
comunione con lo Spirito Santo e hanno scoperto quanto è buono il Signore. Da questa esperienza,<br />
propria del cristiano e consolidata dalla pratica della vita, essi traggono un nuovo senso della fede,<br />
della <strong>Chiesa</strong> e del mondo» (RICA 38). Le catechesi dunque, come all'inizio della <strong>Chiesa</strong>, devono<br />
tornare ad essere un cammino che introduca alla vita liturgica (catechesi mistagogica).<br />
Le «Premesse» all'e<strong>di</strong>zione italiana del RICA (1978) così affermano: «questo itinerario,<br />
graduale e progressivo <strong>di</strong> iniziazione e <strong>di</strong> evangelizzazione... è presentato con valore <strong>di</strong> forma tipica<br />
per la formazione cristiana»; ed invitavano a «costituire una catechesi <strong>di</strong> tipo mistagogico dei<br />
sacramenti già ricevuti, in vista <strong>di</strong> una esperienza più piena della loro <strong>di</strong>vina efficacia».<br />
Dall'esperienza dei Padri e dalla tra<strong>di</strong>zione liturgica, «emerge dunque che “mistagogia” è:<br />
* una conoscenza-esperienza sempre più profonda, piena, fruttuosa del mistero pasquale e la<br />
sua traduzione nella pratica della vita;<br />
* un attingere un nuovo senso della fede, della <strong>Chiesa</strong>, del mondo;<br />
39
* ciò è possibile per la confluenza <strong>di</strong> almeno due vie: la novità <strong>di</strong> una catechesi che permette<br />
<strong>di</strong> chiarire l'intelligenza delle Scritture me<strong>di</strong>ante la me<strong>di</strong>tazione della buona parola <strong>di</strong> Dio e<br />
me<strong>di</strong>ante una più profonda comprensione dei riti e delle preghiere; la comunione con lo Spirito<br />
Santo prodotta dai sacramenti ricevuti accresce l'esperienza della vita sacramentale e comunitaria,<br />
permettendo <strong>di</strong> fare esperienza del Signore e del suo amore, motivo <strong>di</strong> crescita e <strong>di</strong> continua<br />
conversione».<br />
Risulta così evidente che lo specifico della mistagogia non si riduce alla semplice spiegazione dei<br />
riti sacramentali dopo la loro celebrazione. Ancora due immagini patristiche che ci aiutano a<br />
coglierne la comprensione ed il valore:<br />
«Presso gli uomini esiste la norma <strong>di</strong> avvolgere in fasce i bambini alla loro nascita perché il corpo<br />
ancora tenero, che si è appena costituito, non riceva alcun danno, ma senza movimento, resti della<br />
sua costituzione; e li si mette a dormire e li si fa riposare prima in fasce e, dopo, li si conduce al<br />
naturale nutrimento appropriato a conveniente a loro. Allo stesso modo anche noi, è come se<br />
avessimo strettamente avvolti in fasce d’insegnamento coloro che sono appena nati col battesimo,<br />
perché si affermi in essi il ricordo della grazia che è stata data; e terminato il <strong>di</strong>scorso, li abbiamo<br />
fatti riposare, perché era sufficiente la misura <strong>di</strong> ciò che era stato detto…» (Teodoro <strong>di</strong> Mopsuestia,<br />
Omelie catechetiche XV,1)<br />
Ed il vescovo Agostino: «Questa giornata è detta “Ottava dei nuovi nati”; a questi si toglie oggi dal<br />
capo il velo in segno della libertà da loro acquistata… Due sono le nascite dell'uomo: il nascere e il<br />
rinascere; la prima ci fa nascere alla fatica e alla miseria, l'altra ci fa rinascere alla pace e alla<br />
felicità eterna. Hanno oggi la loro festa i bambini: questi infanti, questi piccoli, lattanti ancora<br />
attaccati al seno della mamma, i quali, in quanto infanti, non conoscono, come vedete, quale grande<br />
grazia viene loro data oggi; ma anche tutti costoro - vecchi, uomini maturi, giovani - sono nuovi<br />
nati… Quelli che voi vedete neonati, sono nati vecchi perché l'Adamo da cui tutti nasciamo, è stato<br />
detto il nostro uomo vecchio, mentre il Cristo da cui rinasciamo, è l'uomo nuovo. Costoro dunque<br />
sono sia neonati sia rinati a una vita nuova e con il loro nascere portano in sé, se così si può <strong>di</strong>re,<br />
una vecchiezza giovane. Oggi i nostri nuovi nati si riuniscono agli altri fedeli e volano per così <strong>di</strong>re<br />
fuori dal nido. Ci dobbiamo rivolgere a loro mentre li generiamo alla vita nuova; dobbiamo fare<br />
come le madri dei ron<strong>di</strong>notti e dei passerotti che volano strepitando intorno ai loro piccoli, quando<br />
questi cominciano a volare fuori dal nido, e con i loro gri<strong>di</strong> li avvertono amorosamente dei pericoli»<br />
(Discorso 376A).<br />
Dopo la celebrazione dei sacramenti nella Veglia <strong>Pasqua</strong>le, occorreva, e occorre anche oggi,<br />
un tempo <strong>di</strong> “intelligenza” <strong>di</strong> ciò che si è vissuto; intelligenza non <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne razionale, ma<br />
intelligenza che scaturisce dalla fede donata dagli stessi sacramenti. Il sacramento celebrato nella<br />
Veglia <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, come ha avuto bisogno del tempo della Quaresima quale preparazione nella<br />
conversione, così ha bisogno <strong>di</strong> un altro tempo, quello della mistagogia per essere fatto proprio,<br />
potremmo <strong>di</strong>re assimilato. Sarebbe importante «recuperare l’importanza del “celebrare nel tempo”<br />
anche per ciò che riguarda i sacramenti; anche i sacramenti non sono “atti puntuali”, ma hanno<br />
bisogno <strong>di</strong> tempi e spazi “appropriati”. E il tempo nel quale i sacramenti possono “respirare” è<br />
proprio il <strong>Tempo</strong> pasquale nel quale si celebra la forza della risurrezione <strong>di</strong> Cristo nella vita della<br />
<strong>Chiesa</strong>».<br />
PER LA CELEBRAZIONE<br />
Domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
Il <strong>Tempo</strong> pasquale inizia con la Domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, chiamata, con espressione ebraica<br />
”solennità delle solennità”. Dopo la grande celebrazione della Veglia pasquale, che ha segnato il<br />
punto culminante del Triduo pasquale e <strong>di</strong> tutto l'anno liturgico, questa Messa della Domenica <strong>di</strong><br />
<strong>Pasqua</strong> è un solenne ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> grazie per il soffio <strong>di</strong> vita nuova portato dal Risorto nella <strong>Chiesa</strong><br />
e nei singoli cristiani; è una RINNOVATA PROFESSIONE DI FEDE in Colui che è il vivente, riapparso<br />
glorioso in mezzo i suoi. La <strong>Chiesa</strong> che proclama sempre le meraviglie <strong>di</strong> Dio, lo fa soprattutto in<br />
questo giorno, nella pienezza della gioia pasquale (prefazio). Il formulario della Messa del giorno<br />
40
pone l’accento sul fatto storico della risurrezione, senza <strong>di</strong>menticare le sue implicanze teologico –<br />
salvifiche, le sue ripercussioni sulla vita teologale e morale dei cristiani, la proiezione escatologica<br />
della <strong>Pasqua</strong>. La Lettera circolare Paschalis sollemnitatis al n.97 così si esprime:<br />
«Si celebri la Messa del giorno <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> con grande solennità. È opportuno oggi compiere<br />
l’aspersione dell’acqua, benedetta nella veglia, come atto penitenziale. Durante l’aspersione si canti<br />
l’antifona «Ecco l’acqua», o un altro canto <strong>di</strong> carattere battesimale».<br />
La fedeltà a questi richiami possono aiutare a dare l’impronta caratteristica a questo giorno, che<br />
spesso rischia, dopo la grande Veglia, <strong>di</strong> trasformarsi nelle comunità parrocchiali in una messa<br />
scarna dal punto <strong>di</strong> vista del clima celebrativo. Durante tutto il tempo pasquale in ogni celebrazione<br />
liturgica il cero pasquale rimane acceso, al termine <strong>di</strong> tale tempo il suo posto è accanto al cero<br />
pasquale e viene acceso solamente durante la celebrazione dei Battesimi e per le esequie. La Lettera<br />
circolare, inoltre, richiama alla valorizzazione della celebrazione dei Vespri detti battesimali, da<br />
concludere con la processione al fonte battesimale. E’ un forte richiamo al frutto della <strong>Pasqua</strong> che<br />
nel Battesimo ha fatto della comunità credente un popolo sacerdotale che innalza a Dio Padre nello<br />
Spirito per mezzo del suo Signore il sacrificio del ringraziamento e della lode, espressione del<br />
nuovo culto.<br />
Ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> o settimana “in Albis”.<br />
I primi otto giorni del tempo pasquale costituiscono l’ottava <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> e si celebrano come<br />
solennità del Signore (cf Norme generali per l’or<strong>di</strong>namento dell’anno liturgico e del calendario,<br />
22-26). La Liturgia della Parola in tutti i giorni dell’ottava pasquale presenta una struttura<br />
tipicamente festiva, con lettura, epistola e vangelo. Le pericopi sono tutte focalizzate sul mistero<br />
della Resurrezione, La liturgia <strong>di</strong> questa ottava è, però, caratterizzata non solo dal mistero pasquale,<br />
ma anche dall’attenzione per i neobattezzati, i quali nelle celebrazioni eucaristiche quoti<strong>di</strong>ane<br />
venivano introdotti più profondamente nei misteri dei sacramenti dell’iniziazione da essi ricevuti<br />
(catechesi mistagogiche). Questa settimana si chiamava un tempo, a motivo delle vesti bianche dei<br />
neobattezzati, anche settimana in albis, e la domenica seguente domenica in albis.<br />
È una opportunità pastorale e catechetica per itinerari <strong>di</strong> Iniziazione cristiana. L’ottava si<br />
conclude con la Domenica “in albis depositis”, in quanto venivano deposte le vesti bianche; è<br />
incentrata sul Vangelo della manifestazione del Risorto “otto giorni dopo”.<br />
Dalla Lettera circolare è richiesto «che si faccia sempre, nell’ottava <strong>di</strong> pasqua, la preghiera <strong>di</strong><br />
intercessione per i neo-battezzati, inserita nella preghiera eucaristica» (n. 102).<br />
II Domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
La seconda domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> è il giorno ottavo della resurrezione e ottava del battesimo. I<br />
cristiani sono uomini che hanno fatto esperienza della liberazione pasquale, il dono dello spirito<br />
<strong>di</strong>venta principio <strong>di</strong> una nuova creazione, l'inizio <strong>di</strong> una nuova l'umanità. L'incredulità <strong>di</strong> Tommaso<br />
e il suo successivo vedere, spiegano i padri della <strong>Chiesa</strong>, è servito alla comunità credente che, pur<br />
non avendo visto il Signore, hanno parte del dono del suo Spirito e della sua pace. Da qui nasce una<br />
gioia in<strong>di</strong>cibile e gloriosa. Ogni anno a <strong>Pasqua</strong>, «non solo si ricorda il grande evento che è al centro<br />
della storia della salvezza, ma lo si rivive questo fatto, nella sua efficacia attualità sacramentale, e lo<br />
si proietta nella certezza <strong>di</strong> un futuro, quando vita e gioia saranno l'espressione concreta della<br />
<strong>Pasqua</strong> eterna. Un passato, dunque un presente ed un futuro in cui si esprime la mirabile ricchezza<br />
misterica della <strong>Pasqua</strong> cristiana». È il senso dell'incessante ripresa della <strong>Pasqua</strong> nella vita della<br />
<strong>Chiesa</strong>. Celebrare è rivivere, RIUNITI, il mistero della <strong>Pasqua</strong>, in un'affermazione <strong>di</strong> fede e in<br />
un'espressione concreta d'amore. La <strong>Pasqua</strong> riunisce: per questo è avvenuto Gesù, per questo è<br />
morto e del risorto, per riunire i figli <strong>di</strong>spersi. I cristiani si <strong>di</strong>stinguono subito come coloro che si<br />
riuniscono in un giorno determinato, per incontrarsi, come per un appuntamento, con Cristo<br />
Signore. Una presenza la sua, invisibile ormai, ma non per questo meno reale ed efficace.<br />
41
III Domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
La celebrazione eucaristica <strong>di</strong> questa domenica viene illuminata dalla descrizione del<br />
racconto <strong>di</strong> Luca 24, 13-35. L’evangelista lo descrive con i termini propri della Celebrazione<br />
eucaristica del suo tempo. Il termine «spezzare il pane» per in<strong>di</strong>care l'Eucaristia, è troppo frequente<br />
nel libro degli Atti, per non pensare qui ad essa. Un episo<strong>di</strong>o, questo, che la liturgia della messa è<br />
rivivere in pieno nei suoi due momenti: i due momenti in cui si articola l'unico atto <strong>di</strong> culto che è la<br />
Messa. Noi incontriamo Gesù nell'assemblea liturgica, lo ascoltiamo quando vengono proclamate le<br />
Scritture perché è Lui stesso che ci spiega la parola, ma lo riconosciamo quando viene spezzato il<br />
pane. Prima L'ASCOLTO della parola e poi L'INCONTRO con Cristo nella frazione del pane, cioè al<br />
momento della comunione; ma «perché ci sia questo incontro è necessario che avvenga per primo<br />
l'ascolto. L'ascolto si riaggancia un passato <strong>di</strong> fede, l'incontro e <strong>di</strong> attualizza quel passato in una<br />
presenza <strong>di</strong> amore». L'episo<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Emmaus è il fatto che si riprende sacramentalmente in ogni<br />
Messa domenicale In questa terza domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, inoltre, la liturgia ritorna con rinnovata<br />
letizia su alcuni temi fondamentali della celebrazione pasquale: la <strong>di</strong>mensione cosmica della<br />
risurrezione <strong>di</strong> Cristo; il compimento, nella resurrezione <strong>di</strong> Cristo, <strong>di</strong> tutti i segni con cui Dio aveva<br />
preparato a poco a poco, lungo i secoli della storia della salvezza; la nostra resurrezione finale con<br />
Cristo.<br />
IV Domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
La liturgia <strong>di</strong> questa domenica è dominata dalla figura significativa del Buon Pastore,<br />
un'implicita affermazione <strong>di</strong> Cristo Dio e uomo. Dio, nell'Antico Testamento, si era rivelato al suo<br />
popolo Israele con questa immagine del buon pastore che si prende cura del suo gregge. Gesù<br />
riprende questa immagine biblica per la sua persona facendone un'affermazione in<strong>di</strong>retta della sua<br />
<strong>di</strong>vinità: Egli, infatti è una sola cosa con il Padre. Un'immagine che viene completata con quella del<br />
buon pastore che dà la vita per il suo gregge: affermazione della sua azione redentrice. È naturale<br />
che la figura del buon pastore venga rievocata dalla liturgia proprio nel tempo pasquale: periodo<br />
liturgico in cui la <strong>Chiesa</strong> si stringe intorno a Cristo Signore, che morendo sulla croce e risorgendo<br />
ha ridonato agli uomini la vita. Ecco perché tale immagine, fin dall'inizio, fu così cara ai primi<br />
cristiani considerandola un compen<strong>di</strong>o della loro fede in Cristo Signore. L'antifona <strong>di</strong> comunione lo<br />
esprime con eloquenza: «è risorto il Buon pastore, che ha offerto la vita per le pecorelle, e per il suo<br />
gregge è andato incontro alla morte, alleluia». Ciò che salva il gregge è la mutua conoscenza tra il<br />
pastore le pecore: esse LO ASCOLTANO perché LO CONOSCONO. La vita della comunità cristiana<br />
<strong>di</strong>pende allora da questo “rapporto profondo” che i <strong>di</strong>scepoli hanno con il Maestro. Nella<br />
conoscenza <strong>di</strong> Lui, che per Giovanni significa intima comunione <strong>di</strong> spirito con Lui, i cristiani<br />
possono trovare quella serenità e sicurezza che dovrebbero poi trasfondere nel mondo. Nel<br />
momento della COMUNIONE EUCARISTICA Gesù si rivela in pieno il Buon Pastore: non solo la sua<br />
parola penetra i cuori, li illumina e li riscalda, ma in lui stesso il risorto, colui che ha donato la vita,<br />
che si dona a chi crede e si accosta a riceverlo sotto il segno dell'eucaristia.<br />
In questa domenica la <strong>Chiesa</strong> prega in modo particolare per le vocazioni <strong>di</strong> “speciale<br />
consacrazione". La comunità cristiana deve avvertire la responsabilità <strong>di</strong> maturare nella vita<br />
cristiana e far sì che al suo interno possano, alcuni dei suoi membri, accogliere la chiamata ad una<br />
consegna ra<strong>di</strong>cale a Dio, in Cristo, per l’annuncio e la testimonianza del Vangelo. Una vita tutta e<br />
totalmente donata, come quella del Buon pastore, al Padre per i fratelli.<br />
V Domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
La quinta domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> fa emergere come la celebrazione dell'eucaristia,<br />
specialmente quella domenicale, e l'espressione è la manifestazione più bella della vita della <strong>Chiesa</strong>.<br />
Nella celebrazione eucaristica abbiamo il culmine dell'azione con cui Dio in Cristo santifica il<br />
mondo e l‘azione della <strong>Chiesa</strong> che, per mezzo <strong>di</strong> Cristo, nello Spirito rende culto al Padre. Inoltre<br />
«la celebrazione eucaristica contribuisce a che i cristiani esprimano nella loro vita e manifestino agli<br />
altri il mistero <strong>di</strong> Cristo e la genuina natura della <strong>Chiesa</strong>». E’ dalla <strong>Pasqua</strong> <strong>di</strong> Cristo che è nata la<br />
<strong>Chiesa</strong>. Dalla <strong>Pasqua</strong> <strong>di</strong> Cristo, morto e risorto, la <strong>Chiesa</strong> attinge incessantemente la sua vita; una<br />
42
vita pasquale che trova il suo compimento nella liberazione dalla schiavitù del peccato e<br />
nell'alleanza nuova ed eterna con Dio Padre. In questa domenica la <strong>Chiesa</strong> viene presentata nel suo<br />
essere e la sua vita, riconoscendo in Cristo la «sua pietra angolare, eletta e preziosa» su cui si regge<br />
tutto il suo e<strong>di</strong>ficio; Colui che la guida e la sostiene. Cristo Gesù è il suo Maestro e Signore, Colui<br />
che è la via la verità e la vita. Non si può andare al Padre se non per mezzo <strong>di</strong> questa via, non si può<br />
accogliere la salvezza se non attraverso questa verità; non si può entrare nella vita eterna se non si<br />
partecipa a questa vita. Cristo Gesù ha voluto la sua <strong>Chiesa</strong> come un e<strong>di</strong>ficio compatto e nello<br />
stesso tempo come un organismo vitale, in cui ognuno ha la sua funzione in modo gerarchico e<br />
or<strong>di</strong>nato. La <strong>Chiesa</strong> ed insieme <strong>di</strong> tutti i fedeli: «pietre vive, innalzate in e<strong>di</strong>ficio spirituale, in un<br />
sacerdozio santo, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, un sacerdozio santo, popolo che<br />
Dio si è acquistato». La <strong>Chiesa</strong> così intesa manifesta nella celebrazione eucaristica pienamente se<br />
stessa. Cristo, figlio del Padre e primogenito tra i fratelli, presiede invisibilmente la celebrazione e<br />
conduce la <strong>Chiesa</strong> al Padre; il celebrante e i ministri consacrati che presiedono la celebrazione,<br />
rappresentano visibilmente Cristo, proclamano, loro e non altri, la sua parola, <strong>di</strong>spensano<br />
l'Eucaristia, pregano a nome <strong>di</strong> tutto il popolo; il popolo santo <strong>di</strong> Dio offre il sacrificio <strong>di</strong> Cristo e <strong>di</strong><br />
se stesso insieme con i ministri or<strong>di</strong>nati e comunica così con Dio e con i fratelli. Nell'Eucaristia,<br />
dunque, questa unità si riafferma e si rinsalda. La celebrazione <strong>di</strong> questa domenica richiede una<br />
maggiore cura, perché tale unità e ministerialità emerga in tutto il suo valore e nella sua bellezza.<br />
VI Domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
Nella sesta domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> che precedere la solennità dell'Ascensione, comunità<br />
credente è orientata verso il compimento del mistero pasquale: il trionfo supremo <strong>di</strong> Cristo e la<br />
venuta dello Spirito santo. Cristo è morto ed è risorto proprio per questo: ritornare nella gloria del<br />
Padre suo e Padre nostro, per preparare un posto alla nostra umanità glorificata nella sua ed inviare<br />
un altro consolatore lo Spirito paraclito che rimanga con la sua <strong>Chiesa</strong> per sempre.<br />
La liturgia <strong>di</strong> questa domenica ricorda ai fedeli che la propria grandezza sta nel fatto <strong>di</strong><br />
essere stati santificati da Cristo Signore e che ora sono chiamati a glorificarLo in loro. La <strong>di</strong>scesa<br />
dello Spirito, riprendendo l'opera <strong>di</strong> Cristo la porta a compimento nella verità che libera e salva.<br />
Lo Spirito è dono del Padre, un dono che però si recepisce solo nella fede e nell'amore. Un<br />
amore che consiste nell'osservare la parola <strong>di</strong> Gesù, ossia i suoi comandamenti. Questo amore<br />
effettivo sarà la manifestazione stessa dello Spirito, sia per coloro cui è dato sia per gli altri. Cristo<br />
allora continua ad essere presente nella sua <strong>Chiesa</strong>, anche dopo la sua glorificazione, nel dono dello<br />
Spirito che si manifesta per mezzo della fede e dell'amore che i suoi figli esercitano. Questa carica<br />
interiore darà ai cristiani la forza <strong>di</strong> rispondere a chiunque doman<strong>di</strong> ragione della speranza che è in<br />
loro. La certezza che Cristo è vivo, ed è presente nella sua <strong>Chiesa</strong> e nell'anima dei cristiani, li rende<br />
sereni anche in mezzo alle persecuzioni e alle tribolazioni.<br />
La DIMENSIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA è già presente: si sottolinea la me<strong>di</strong>azione degli<br />
Apostoli, che hanno il compito <strong>di</strong> confermare, attraverso l'imposizione delle mani, non solo il<br />
battesimo ricevuto nel nome del Signore Gesù, ma anche la pre<strong>di</strong>cazione dei missionari. È una<br />
chiara allusione al secondo sacramento che inizia, cioè forma, rafforza e conferma, dopo il<br />
battesimo il cristiano e gli comunica il dono dello Spirito perché <strong>di</strong>a della sua vita testimonianza<br />
fattiva della sua fede in Cristo. Il tempo pasquale è quello in cui la nostra fede nella resurrezione<br />
viene confermata, e nello stesso tempo si fa convinzione profonda, da manifestare nel modo <strong>di</strong><br />
pensare, <strong>di</strong> parlare e <strong>di</strong> vivere. La celebrazione dell'eucaristia, mentre è il memoriale della morte<br />
redentrice del Cristo, rafforza in questa fede e impegna a testimoniarla nella vita.<br />
Ascensione<br />
In questa solennità la liturgia celebra in Cristo asceso al cielo il compimento dell'avventura<br />
del Figlio <strong>di</strong> Dio, che uscito dal Padre per venire nel mondo, lascia <strong>di</strong> nuovo il mondo per ritornare<br />
al Padre. La <strong>Chiesa</strong> celebra non tanto il fatto dell'Ascensione <strong>di</strong> Gesù, quanto il mistero, cioè il<br />
valore <strong>di</strong> questa Ascensione. Essa risulta l'ultimo atto <strong>di</strong> quella «esaltazione pasquale» che, iniziata<br />
con la resurrezione, anzi come <strong>di</strong>ce l'evangelista Giovanni con l’intronizzazione <strong>di</strong> Cristo sulla<br />
43
croce, ha innalzato alla gloria del Padre la sua umanità, dopo la vittoria sul peccato e sulla morte. In<br />
questo trionfo Cristo non è solo, con lui, Capo, anche le membra, ascendono alla gloria del Padre<br />
resi partecipi della sua stessa vita. La glorificazione <strong>di</strong> Cristo, infatti, non è un avvenimento che<br />
riguarda solo la persona <strong>di</strong> Gesù, ma riguarda tutti gli uomini. Tutti sono chiamati a comprendere a<br />
«quale speranza sono stati chiamati, a quale tesoro <strong>di</strong> gloria sono stati condotti, quando Dio<br />
risuscitò Cristo dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli». L'umanità intera, in Cristo, ha<br />
raggiunto la sfera celeste. Egli, nella sua glorificazione, è <strong>di</strong>ventato non solo Signore e giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
tutta la creazione, ma è <strong>di</strong>ventato Capo del corpo che è la <strong>Chiesa</strong>. Ne deriva che dove si trova il<br />
Capo, là è destinato a giungere anche il corpo. L'Ascensione è una festa <strong>di</strong> speranza che scaturisce<br />
dalla certezza nella fede del Signore risorto.<br />
I cristiani, afferma san Paolo, sono coloro che «ATTENDONO LA BEATA SPERANZA», una speranza<br />
che da una parte acuisce il desiderio del cielo dall'altra non <strong>di</strong>sancora dagli impegni <strong>di</strong> questo<br />
mondo. È questo uno dei paradossi cristiani: la continua tensione fra l'impegno nel mondo in cui<br />
vivono e il desiderio del mondo in cui sperano. Nella celebrazione dei <strong>di</strong>vini misteri tale tensione<br />
raggiunge il suo equilibrio e nella docilità all'azione dello spirito viene trasformata in rinnovata<br />
energia <strong>di</strong> vita. I cristiani «pellegrini sulla terra, possono pregustare nella fede e nei sacramenti la<br />
gloria <strong>di</strong> quella patria eterna, dove Cristo ha innalzato l'uomo accanto a sè» nella gloria Gli stessi<br />
<strong>di</strong>scepoli, tornate dal monte a Gerusalemme, in obbe<strong>di</strong>enza la parola del Maestro si riuniscono in<br />
preghiera in attesa <strong>di</strong> ricevere la forza dello Spirito. Le solennità pasquali non si chiudono con<br />
l'Ascensione ma occorre attendere <strong>di</strong> essere rivestiti <strong>di</strong> potenza dall'alto: è ciò che fa tutta la <strong>Chiesa</strong><br />
in questi giorni che è l separano dalla Pentecoste.<br />
Pentecoste.<br />
Con la solennità della Pentecoste giunge a compimento il tempo colmo <strong>di</strong> gioia dei 50 giorni<br />
in cui la <strong>Chiesa</strong> celebra «la risurrezione del Signore, la gloria del suo Sposo, l'ineffabile potenza del<br />
suo amore che si irra<strong>di</strong>a con soave forza e dolce consolazione me<strong>di</strong>ante il dono dello Spirito santo».<br />
Questo dono, nel quale «Dio viene sempre a salvare l'uomo e l'uomo è abilitato a compiere le opere<br />
del suo Signore», costituisce il compimento delle promesse <strong>di</strong>vine contenute nella Scrittura e segna<br />
giustamente il compimento della celebrazione liturgica del <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>. Il Mistero celebrato in<br />
questo giorno può essere ricondotto a questi temi particolari, espressi anche nel prefazio <strong>di</strong><br />
Pentecoste:<br />
" giungere a compimento il mistero pasquale;<br />
" si commemora il dono dello spirito santo effuso sugli apostoli;<br />
" inizia la missione della <strong>Chiesa</strong> presso tutte le lingue, i popoli e le nazioni.<br />
Nel cinquantesimo giorno, pienezza della <strong>Pasqua</strong>, vi sono due gran<strong>di</strong>ose liturgie da tenere<br />
presente: quella della vigilia e del giorno. La sera del sabato, secondo le in<strong>di</strong>cazioni del Messale<br />
romano, si può prolungare la celebrazione vigilare ad imitazione de Cenacolo <strong>di</strong> Gerusalemme. Le<br />
letture previste per la Messa Vespertina della Vigilia ci introducono nella ricchezza del mistero<br />
salvifico della Pentecoste: lo spirito <strong>di</strong> Dio e del Signore opera come energia <strong>di</strong> unità, fonte <strong>di</strong><br />
fraternità nella giustizia e nell'amore. Andando ogni giorno a Gesù con la propria fede, la <strong>Chiesa</strong> si<br />
<strong>di</strong>sseta incessantemente all'acqua viva dello Spirito, nel quale trova la sorgente della propria vita e<br />
della propria missione e già sperimenta <strong>di</strong> partecipare, pellegrina sulla terra, alla liturgia del cielo.<br />
La gioia dei tempi messianici ha inizio con la fede pasquale in Gesù, fede alla cui luce la croce non<br />
è né scandalo né stoltezza ma potenza <strong>di</strong> Dio per la salvezza <strong>di</strong> quanti accolgono il suo amore. Non<br />
a caso nella liturgia <strong>di</strong> questa solennità il Vangelo riporta al giorno stesso <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, quando il<br />
Signore risorto venne in mezzo ai suoi riuniti portando la sua pace ed alitando il suo Spirito su <strong>di</strong><br />
essi, perché con la remissione dei peccati, data in suo nome, essi portassero nel mondo la sua pace.<br />
Ogni missione scaturisce dalla <strong>Pasqua</strong> del Signore che si fa presente in mezzo ai suoi per renderli<br />
partecipi della sua salvezza e dunque della sua missione. La missione <strong>di</strong> Gesù è il fondamento e il<br />
modello della missione <strong>di</strong> <strong>di</strong>scepoli. In quanto comunità della nuova alleanza i <strong>di</strong>scepoli sono<br />
abilitati dallo Spirito a portare il Vangelo fino agli estremi confini della terra, accogliendo nella<br />
44
<strong>Chiesa</strong> i credenti perché «abbiano la conoscenza della salvezza nella remissione dei peccati» e<br />
<strong>di</strong>ventino, a loro volta, <strong>di</strong>scepoli inviati dal Risorto nella potenza dello Spirito.<br />
Gli elementi con cui Luca descrive la Pentecoste cristiana sono un chiaro riferimento alla<br />
teofania del Sinai in occasione dell'antica alleanza (Es 19, 16 – 19). È l'intervento potente del<br />
Signore che si fa presente al popolo che si è scelto e al quale sta per consegnare la legge nuova: lo<br />
Spirito in un cuore rinnovato. Gesù, risorto e asceso al cielo, ha ricevuto dal Padre lo Spirito per<br />
poterla sua volta riversare sui suoi <strong>di</strong>scepoli. Pentecoste compimento della <strong>Pasqua</strong>. I <strong>di</strong>scepoli sono<br />
ancora riuniti nella preghiera e nell’attesta, con Maria, la madre <strong>di</strong> Gesù e con alcune donne fedeli:<br />
lo Spirito scende e riempie la casa che tutti li accoglieva. Al Giordano lo Spirito è sceso su Cristo,<br />
uomo-Dio, a Pentecoste <strong>di</strong>scende sul Cristo mistico della <strong>Chiesa</strong> nascente, raccolto in preghiera,<br />
“iniziandolo” a rendere testimonianza delle gran<strong>di</strong> opere compiute da Dio. Lo Spirito santo è Colui<br />
che scrive la rivelazione <strong>di</strong> Dio nel cuore dell'uomo in quanto trasforma i credenti, trasfigurandoli<br />
«nell'icona gloriosa del Signore» e costituendoli perciò comunità della nuova alleanza. I popoli<br />
elencati in modo solenne ed emblematico rappresentano la primizia della <strong>Chiesa</strong> chiamata ad essere<br />
testimone <strong>di</strong> Gesù «fino agli estremi confini della terra». È finito il tempo in cui l'umanità è chiusa<br />
nell'angustia della propria incomunicabilità, è finito il tempo della confusione delle lingue: lo<br />
Spirito è «fonte <strong>di</strong> unità nella confessione delle gran<strong>di</strong> opere <strong>di</strong> Dio e <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> tutti i popoli<br />
nell'identità e mutua comunicazione delle loro culture».<br />
Da un autore africano del secolo VI: «Celebrate questo giorno come membra dell'unico<br />
corpo <strong>di</strong> Cristo. Infatti NON LO CELEBRERETE INUTILMENTE SE VOI SARETE QUELLO CHE CELEBRATE.<br />
Se cioè sarete incorporati a quella <strong>Chiesa</strong>, che il Signore colma dello Spirito santo, estende con la<br />
sua forza in tutto il mondo, riconosce come sua venendo da essa riconosciuto».<br />
Per la celebrazione <strong>di</strong> questa solennità si potrà creare un contesto <strong>di</strong> fuoco, ad esempio con delle<br />
fiaccole, nell'aula liturgica. Dopo l'omelia, per la professione <strong>di</strong> fede si potrà andare al fonte<br />
battesimale cantando e rinnovare le promesse del Battesimo. La partecipazione eucaristica sia per<br />
tutti i fedeli «con i segni del pane e del vino che proprio il fuoco dello Spirito»<br />
Come sintesi conclusiva possiamo <strong>di</strong>re che il tempo pasquale sottolinea, almeno, 4 aspetti<br />
importanti:<br />
! È tempo <strong>di</strong> Cristo: è Lui la nostra <strong>Pasqua</strong>, ed è Lui il Vero Agnello in cui si compiono le<br />
antiche prefigurazioni.<br />
! È tempo dello Spirito (Gv 20,19-23): Cristo è risorto per opera dello Spirito Santo ed è Egli<br />
stesso sorgente dello Spirito. Attraverso questo dono possiamo partecipare realmente alla vita nuova<br />
del Risorto nella <strong>Chiesa</strong>. “Dove c'è lo Spirito <strong>di</strong> Dio, là c'è la <strong>Chiesa</strong>” (S. Ireneo).<br />
! È tempo della <strong>Chiesa</strong>: tutto il Mistero della <strong>Chiesa</strong> trae origine e forza dal Mistero salvifico<br />
<strong>Pasqua</strong>le e progre<strong>di</strong>sce sotto l'azione dello Spirito <strong>di</strong> Pentecoste.<br />
! È tempo escatologico: la <strong>Pasqua</strong> che celebriamo è anticipazione della vita nuova e attesa del<br />
suo compimento nella <strong>Pasqua</strong> celeste.<br />
Il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> è dunque: partecipazione piena alla vita nuova del Signore Risorto; richiamo<br />
forte ad una autentica testimonianza <strong>di</strong> vita; conferma della speranza <strong>di</strong> vittoria sulla Morte;<br />
accoglienza gioiosa della sollecitazione dello Santo; invito a vivere nella libertà dei figli <strong>di</strong> Dio;<br />
richiamo a portare agli altri la gioia della Resurrezione.<br />
Con questi atteggiamenti an<strong>di</strong>amo incontro al compimento del tempo pasquale: il giorno <strong>di</strong><br />
Pentecoste, giorno della manifestazione della <strong>Chiesa</strong> ed inizio della sua missione nell’annuncio,<br />
nella testimonianza, nel servizio; segno sacramentale <strong>di</strong> Cristo, unico Salvatore del mondo.<br />
45
P ER DILATARE LA C ELEBRAZIONE E UCARISTICA NELLA<br />
F AMIGLIA<br />
Sarebbe opportuno facendo riferimento a quanto in<strong>di</strong>cato alle pp. 130-137 <strong>di</strong> La famiglia in<br />
preghiera (Ed. Conferenza Episcopale Italiana, Roma 1994) pre<strong>di</strong>sporre sussi<strong>di</strong> appropriati da<br />
<strong>di</strong>stribuire alle famiglie per aiutarle a vivere nelle proprie case come “chiesa domestica” il cammino<br />
del <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> Quaresima e il Triduo <strong>Pasqua</strong>le.<br />
N OTA L ITURGICA<br />
ASSEMBLEA LITURGICA E BATTISTERO<br />
Il tempo <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong> è il tempo liturgico che, in modo del tutto speciale fa risaltare, il legame<br />
tra il battistero o fonte battesimale, «icona spaziale» del sacramento del Battesimo e l’assemblea<br />
riunita a celebrare i Divini Misteri.<br />
La Sacrosanctum Concilium (=SC) al n. 26 così scrive: «Le azioni liturgiche non sono azioni<br />
private, ma celebrazioni della <strong>Chiesa</strong>; che è sacramento <strong>di</strong> unità, cioè popolo santo radunato e<br />
or<strong>di</strong>nato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni appartengono all’intero Corpo della <strong>Chiesa</strong>, lo<br />
manifestano e lo implicano; i singoli membri poi vi sono interessati in <strong>di</strong>verso modo, secondo la<br />
<strong>di</strong>versità degli stati, degli uffici dell’attuale partecipazione».<br />
La novità più ra<strong>di</strong>cale e importante della Riforma a livello <strong>di</strong> principi è stata la riscoperta<br />
dell’assemblea-chiesa come elemento base della stessa liturgia.<br />
È con la SC che l’assemblea liturgica ritorna ad assumere una piena soggettualità, persa durante i<br />
secoli a causa della forte clericalizzazione dell’agire liturgico, impoverito nei suoi segni e nel suo<br />
linguaggio celebrativo. Il termine «partecipazione», parola chiave e ricorrente della riforma<br />
liturgica (SC n. 52) ha riportato l’assemblea liturgica alla sua vera soggettualità e <strong>di</strong> conseguenza al<br />
suo ruolo nel’ambito della celebrazione liturgica. A partire dai molti interventi magisteriali, che si<br />
succederanno al periodo post riforma, la comunità dei fedeli, radunata e presieduta dal suo pastore a<br />
celebrare la sacra liturgia, e considerata come la massima epifania della <strong>Chiesa</strong>, è stata oggetto <strong>di</strong><br />
molte riflessioni. La partecipazione alla liturgia è <strong>di</strong>ritto e dovere <strong>di</strong> tutti i fedeli in forza del<br />
Battesimo che li ha resi popolo sacerdotale, ed è la prima ed in<strong>di</strong>spensabile fonte da cui i cristiani<br />
possono attingere l’autentico spirito cristiano.<br />
Così afferma Gelineau: «L’assemblea dei cristiani è un’esigenza in se stessa, antecedentemente a<br />
qualsiasi azione liturgica particolare, parola o rito. Essa è già <strong>di</strong> per se stessa azione e situazione<br />
liturgica; è già in se stessa mistero e sacramento, grazie alla presenza operante del Signore».<br />
La SC al n. 106 evidenzia la motivazione storico – teologica del riunirsi della <strong>Chiesa</strong> <strong>di</strong> domenica,<br />
ricorda infatti che: «Secondo la tra<strong>di</strong>zione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della<br />
risurrezione <strong>di</strong> Cristo, la <strong>Chiesa</strong> celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama<br />
giustamente «giorno del Signore » o « domenica ». Se anzitutto si stabilisce il giorno<br />
dell’assemblea, non è meno presente la consapevolezza della prima comunità cristiana <strong>di</strong> concepirsi<br />
come assemblea. Ciò significa che l’esperienza del radunarsi insieme tra i credenti in Cristo è<br />
determinante per l’autocoscienza della comunità cristiana quale ekklesìa Da tale motivazione<br />
scaturisce <strong>di</strong> conseguenza l’esigenza – impegno del ritrovarsi come assemblea liturgica: «In questo<br />
giorno infatti i fedeli devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola <strong>di</strong> Dio e partecipare alla<br />
eucaristia e così far memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù e<br />
46
ender grazie a Dio, che li « ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della risurrezione <strong>di</strong> Gesù<br />
Cristo dai morti» (1 Pt 1,3)». Già al n. 6 era stato affermato che a partire dal giorno <strong>di</strong> Pentecoste:<br />
«che segnò la manifestazione della <strong>Chiesa</strong> al mondo, quelli che accolsero la parola <strong>di</strong> Pietro furono<br />
battezzati » ed erano « assidui all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna nella<br />
frazione del pane e alla preghiera... lodando insieme Dio e godendo la simpatia <strong>di</strong> tutto il popolo »<br />
(At 2,41-42,47). Da allora la <strong>Chiesa</strong> mai tralasciò <strong>di</strong> riunirsi in assemblea per celebrare il mistero<br />
pasquale: leggendo « in tutte le Scritture ciò che lo riguardava» (Lc 24,27), celebrando l'eucaristia,<br />
nella quale « vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte » e rendendo grazie «a Dio<br />
per il suo dono ineffabile» (2 Cor 9,15) nel Cristo Gesù, «a lode della sua gloria» (Ef 1,12), per<br />
virtù dello Spirito Santo (SC 6). Questa assemblea liturgica i cristiani continueranno a celebrarla<br />
come segno della presenza <strong>di</strong> Cristo e del suo mistero attraverso il tempo e lo spazio. Già a partire<br />
dal II secolo la celebrazione eucaristica si presenta con uno schema simile a quello attuale.<br />
Il termine <strong>Chiesa</strong> vuol <strong>di</strong>re assemblea; la <strong>Chiesa</strong> vive e si realizza innanzitutto, dunque, quando «si<br />
raccoglie in assemblea convocata dal e riunita nel suo Spirito».<br />
Come ci ricorda la Nota pastorale della CEI del 1984 «Il Giorno del Signore»: “Il «<strong>di</strong>es dominicus»<br />
è anche il «<strong>di</strong>es Ecclesiae», il giorno della <strong>Chiesa</strong>”.<br />
La comunità dei fedeli che si raduna, nella fede e nella carità, «è il primo sacramento della presenza<br />
del Signore in mezzo ai suoi: nel segno umile, ma vero, del convenire in unum, nel ritrovarsi dei<br />
molti nell'unità <strong>di</strong> «un cuore solo e un'anima sola», si manifesta l'unità <strong>di</strong> quel corpo misterioso <strong>di</strong><br />
Cristo che è la <strong>Chiesa</strong>». L’ assemblea liturgica «deve saper esprimere in se stessa la verità del suo<br />
«segno»: nell'accoglienza che sa fare unità fra tutti i presenti; nell'intensità della preghiera che sa<br />
aprire alla comunione con tutti i fratelli nella fede, anche lontani; nella generosità della carità che sa<br />
farsi carico delle necessità <strong>di</strong> tutti i poveri e dei bisognosi, il cui grido la raggiunge da ogni parte<br />
della terra; nella varietà dei ministeri, infine, che sa esprimere tutta la ricchezza dei doni che lo<br />
Spirito effonde nella sua <strong>Chiesa</strong> e i <strong>di</strong>versi compiti che la comunità affida ai suoi membri».<br />
L'assemblea «si realizza e si manifesta, nella sua forma più piena e più perfetta, quando è radunata<br />
attorno al suo Vescovo, o a coloro che, a lui associati con l'Or<strong>di</strong>ne sacro nello stesso sacerdozio<br />
ministeriale, legittimamente lo rappresentano nelle singole porzioni del suo gregge, le parrocchie»<br />
(n.9). L’assemblea liturgica, in quanto tale, è chiamata non solo a manifestare la chiesa ma ad essere<br />
anche «luogo rivelativo ed educativo» per la stragrande maggioranza del popolo cristiano. Essa non<br />
è elemento secondario della celebrazione è piuttosto «il contesto che permette una corretta, chiara e<br />
fruttuosa comprensione del rito».<br />
Parlando del luogo dove si riunisce la <strong>Chiesa</strong>, la Nota pastorale della CEI per la Costruzione <strong>di</strong><br />
nuove chiese del 1993, offre una ricca definizione <strong>di</strong> assemblea liturgica: «La realtà della chiesa<br />
nella sua profon<strong>di</strong>tà misterico-sacramentale si esprime nell'immagine storico-salvifica del «popolo<br />
<strong>di</strong> Dio» e si manifesta in modo speciale nell'assemblea liturgica, soggetto della celebrazione<br />
cristiana. Infatti Gesù Cristo, Verbo incarnato, sacramento del Padre, partecipa per mezzo dello<br />
Spirito la sua me<strong>di</strong>azione salvifica al popolo profetico, sacerdotale e regale, la cui ragion d'essere è<br />
l'annuncio, la lode, il servizio». L’assemblea, che si raduna a celebrare, gode dello statuto <strong>di</strong> popolo<br />
profetico, sacerdotale e regale, gli stessi “tria munera” che appartengono a Cristo Capo e Signore<br />
della <strong>Chiesa</strong> e che ha comunicato al suo Corpo mistico me<strong>di</strong>ante il sacramento del Battesimo.<br />
Lo stesso spazio liturgico <strong>di</strong>venta connotativo della realtà della <strong>Chiesa</strong> nel suo essere e nel suo<br />
continuo crescere nella <strong>di</strong>namica della vita cristiana; infatti in ogni liturgia, soprattutto nella<br />
celebrazione eucaristica il farsi dell’assemblea ha il suo punto <strong>di</strong> partenza nell’iniziativa libera e<br />
gratuita del Signore, il quale convoca i credenti attorno a sé. Pertanto: «Il luogo nel quale si riunisce<br />
la comunità cristiana per ascoltare la parola <strong>di</strong> Dio, per innalzare a lui preghiere <strong>di</strong> intercessione e <strong>di</strong><br />
lode e soprattutto per celebrare i santi misteri, è immagine speciale della chiesa, tempio <strong>di</strong> Dio,<br />
e<strong>di</strong>ficato con pietre vive. […] Il progetto ecclesiologico-liturgico scaturito dal concilio Vaticano II<br />
esprime due convinzioni che: la chiesa è mistero <strong>di</strong> comunione e popolo <strong>di</strong> Dio pellegrinante verso<br />
la Gerusalemme celeste; la liturgia è azione salvifica <strong>di</strong> Gesù Cristo, celebrata nello Spirito,<br />
47
dall'assemblea ecclesiale, ministerialmente strutturata, attraverso l'efficacia <strong>di</strong> segni sensibili» (n.1 –<br />
2)<br />
Nel 1996, la CEI, affrontando l’adeguamento delle chiese in fedeltà ai criteri della riforma liturgica,<br />
constata come sia «l'assemblea celebrante a generare e plasmare l'architettura della chiesa».<br />
Nel radunarsi la «<strong>Chiesa</strong>, in qualche modo, proietta, imprime se stessa nell'e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> culto e vi<br />
ritrova tracce significative della propria fede, della propria identità, della propria storia e<br />
anticipazioni del proprio futuro». Ciò scaturisce dal fatto che «L'assemblea che celebra,<br />
manifestando nella sua conformazione e nei suoi gesti il volto della <strong>Chiesa</strong>, è una realtà<br />
eminentemente viva, <strong>di</strong>namica, "storica", in continua, anche se lenta, trasformazione». Facendone<br />
risentire <strong>di</strong> tali trasformazioni alla stessa liturgia«profondamente sensibile rispetto alle vicende e<br />
alle trasformazioni ecclesiali e sociali», in quanto pur componendosi <strong>di</strong> alcuni elementi essenziali<br />
ed immutabili, è anch'essa una realtà viva, vissuta da uomini e donne concrete, quin<strong>di</strong><br />
contestualizzata nei <strong>di</strong>versi contesti culturali sia storici che geografici.<br />
L’assemblea liturgica, nell’atto del celebrare, è «attuazione e rivelazione del mistero della <strong>Chiesa</strong><br />
[…] e proprio perché mistero non è frutto dell’azione <strong>di</strong> coloro che sono radunati ma dello Spirito<br />
che opera nel radunarsi, nel celebrare, nel ricordare».<br />
L’assemblea trova la sua origine sorgiva nei sacramenti dell’Iniziazione cristiana: «Per mezzo dei<br />
sacramenti dell’Iniziazione cristiana, gli uomini, uniti con Cristo nella sua morte, sepoltura e<br />
risurrezione, vengono liberati dal potere delle tenebre, ricevono lo Spirito <strong>di</strong> adozione a figli e<br />
celebrano, con tutto il popolo <strong>di</strong> Dio, il memoriale della morte e risurrezione del Signore» (Rito<br />
Iniziazione cristiana adulti, Premesse, n.1). Non esiste, dunque, assemblea liturgica senza la<br />
celebrazione <strong>di</strong> questi sacramenti ed è grazie alla loro celebrazione che la <strong>Chiesa</strong> attua se stessa<br />
<strong>di</strong>ventando segno della presenza e dell’azione salvifica <strong>di</strong> Dio. Secondo uno stu<strong>di</strong>o che<br />
approfon<strong>di</strong>sce il legame tra assemblea liturgica e Iniziazione cristiana viene evidenziato come dal<br />
RICA emerge che l’«Iniziazione si compie nell’assemblea e l’assemblea, a sua volta, prende forma<br />
nella e dalla Iniziazione».<br />
La <strong>di</strong>mensione sacramentale della <strong>Pasqua</strong> del Signore si attua nei fedeli me<strong>di</strong>ante la celebrazione<br />
rituale cioè celebrativo – liturgica, <strong>di</strong>venendo per la vita cristiana «con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> verità, forma e<br />
senso. La forma con cui la comunità celebra è «quella recettiva <strong>di</strong> chi si lascia costituire nella fede e<br />
nella sua forma ecclesiale dalla presenza del Signore». Lo spazio liturgico connota tale accoglienza<br />
nella misura in cui «si interseca con la forma della fede ecclesiale».<br />
I «molteplici linguaggi ai quali la liturgia ricorre - parola, silenzio, gesto, movimento, musica, canto<br />
- trovano nello spazio liturgico il luogo della loro globale espressione. Da parte sua lo spazio<br />
contribuisce con il suo specifico linguaggio a potenziare e a unificare la sinfonia del linguaggi <strong>di</strong> cui<br />
la liturgia è ricca. Così, anche lo spazio, come il tempo, viene coinvolto dalla celebrazione del<br />
mistero salvifico <strong>di</strong> Cristo e, <strong>di</strong> conseguenza, assume caratteri nuovi e originali, una forma<br />
specifica, tanto che se ne può parlare come <strong>di</strong> una "icona"» (Nota pastorale, Adeguamento…, n. 13).<br />
Una lunga tra<strong>di</strong>zione che sta alle nostre spalle ha in qualche modo umiliato lo spazio<br />
dell'iniziazione cristiana e lo ha ridotto sovente ad un angolo oscuro e abbandonato con un fonte<br />
battesimale che ha serie <strong>di</strong>fficoltà ad esprimere le luminose origini pasquali della vita cristiana.<br />
Gli spazi liturgici, come del resto ogni altro spazio, non sono affatto innocui; si sono pertanto<br />
strutturati come espressione visibile <strong>di</strong> ciò che la <strong>Chiesa</strong> intendeva annunciare attraverso i riti.<br />
In altre parole, è praticamente il rito che con le sue esigenze ha dato forma allo spazio.<br />
All'inizio, come si legge negli Atti degli Apostoli (8,26-40), ogni luogo dove vi fosse dell'acqua era<br />
adatto al battesimo. Nei primi secoli infatti tanti battesimi avevano luogo sulle rive <strong>di</strong> un fiume, <strong>di</strong><br />
un lago o del mare (cf Tertulliano, De baptismo IV).<br />
La progressiva strutturazione <strong>di</strong> un rito sempre più ricco <strong>di</strong> azioni simboliche, unitamente ad altre<br />
esigenze molto pratiche, portarono la celebrazione <strong>di</strong> questo sacramento in un primo tempo<br />
semplicemente in un luogo riparato e poi, soprattutto dopo la pace costantiniana, dalle case private<br />
in un luogo costruito appositamente vicino alla chiesa, dove il rito si concludeva con l'Eucaristia.<br />
48
Nascono così i primi battisteri, che per essere funzionali al rito assumono inevitabilmente una<br />
struttura fortemente simbolica. I battisteri pertanto sorsero come e<strong>di</strong>fici ben <strong>di</strong>stinti dallo spazio<br />
dove coloro che già erano battezzati si radunavano per la celebrazione dell'Eucaristia.<br />
Il battesimo infatti è la "porta" che immette nella <strong>Chiesa</strong>, che aggrega al popolo <strong>di</strong> Dio e che<br />
pertanto permette la partecipazione al banchetto eucaristico, segno della piena comunione in Cristo<br />
e nella <strong>Chiesa</strong>.<br />
Il luogo del battesimo consisteva generalmente in una vasca dove il battezzando da una parte<br />
scendeva per venire immerso e dall'altra usciva per meglio esprimere il passaggio ad una situazione<br />
del tutto nuova, per esprimere la morte dell'uomo vecchio e la nascita dell'uomo nuovo con Cristo<br />
risorto. Subito all'uscita della vasca il neo-battezzato veniva accolto dai fratelli, rivestito della tunica<br />
bianca e riceveva dal Vescovo la Confermazione.<br />
Infine tutti i neo-battezzati entravano processionalmente in chiesa accolti come fratelli da tutta<br />
quanta la comunità cristiana che dava loro l'abbraccio <strong>di</strong> pace per la prima volta.<br />
Fin dall'inizio, come attesta anche lo stesso Cipriano (258), vescovo <strong>di</strong> Cartagine, soprattutto per gli<br />
ammalati e le persone deboli (cf Epist. 76,12), non è mai mancato anche il battesimo per infusione,<br />
cioè versando semplicemente l'acqua sul capo, senza la completa immersione del corpo.<br />
L'infusione ha preso il sopravvento quando, verso la fine del primo millennio, in una società<br />
interamente cristianizzata, vennero a mancare quasi del tutto i battesimi degli adulti. Per ovvi motivi<br />
si preferiva battezzare i bambini per infusione e <strong>di</strong> conseguenza in vasche sempre più piccole.<br />
Ciò nonostante i battisteri, per la forza dell'antica tra<strong>di</strong>zione, continuarono ad essere costruiti presso<br />
le cattedrali delle gran<strong>di</strong> città fino al XIII secolo. Tuttavia, venendo a mancare in una società<br />
cristiana una chiara <strong>di</strong>stinzione fra battezzati e non, come pure l'articolato itinerario <strong>di</strong> conversione,<br />
anche «il fonte battesimale finì con l'entrare in chiesa, <strong>di</strong>ventando parte integrante dello spazio<br />
riservato al fedeli». Sovente confuso fra le tante cappelle laterali, il fonte battesimale per quasi un<br />
millennio esprime una <strong>Chiesa</strong> che praticamente s'identifica con la società civile.<br />
Il profondo rinnovamento conciliare della <strong>Chiesa</strong> non poteva non influire sulla prassi<br />
dell'Iniziazione cristiana, e <strong>di</strong> conseguenza anche sullo spazio cultuale riservato alla celebrazione<br />
del Battesimo. Anche oggi «questo spazio è chiamato, come del resto tutta quanta la struttura<br />
architettonica della chiesa, a rivelare l'identità e la sua missione nel mondo o<strong>di</strong>erno».<br />
Si è riscoperta la <strong>di</strong>mensione comunitaria della fede e del battesimo; <strong>di</strong>mensione che per lungo<br />
tempo è stata oscurata. Per questo le norme (con soluzioni forse un po’ troppo affrettate e<br />
sbilanciate sulla visibilità del rito) prevedono o uno spazio battesimale che prima <strong>di</strong> tutto permetta<br />
una celebrazione comunitaria.<br />
«Il Fonte battesimale può essere collocato in una cappella, situata in chiesa o fuori <strong>di</strong> essa, o anche<br />
in altra parte della chiesa, visibile ai fedeli; in ogni caso deve essere <strong>di</strong>sposto in modo da consentire<br />
la partecipazione comunitaria». (RICA, Premesse, 25).<br />
La Nota pastorale della CEI sulla progettazione <strong>di</strong> nuove chiese, al n.11 così afferma: «Si tenga<br />
presente che il rito del Battesimo si articola in luoghi <strong>di</strong>stinti, con i relativi «percorsi» che devono<br />
essere tutti agevolmente praticabili. In ogni caso, non è possibile accettare l'identificazione dello<br />
spazio e del fonte battesimale con l'area presbiteriale o con parte <strong>di</strong> essa, né con un sito riservato ai<br />
posti dei fedeli». Proprio a questo scopo si. sta instaurando sempre più la prassi innovativa <strong>di</strong> porre<br />
il fonte battesimale in uno spazio ben <strong>di</strong>stinto, ma sull'itinerario ideale che conduce verso l'altare,<br />
affinché «risulti manifesto il nesso del Battesimo con la parola <strong>di</strong> Dio e con l'eucaristia che è<br />
culmine dell'Iniziazione cristiana».<br />
Accanto al fonte battesimale è prevista una <strong>di</strong>gnitosa collocazione del cero pasquale: il Battesimo è<br />
inserimento nel Mistero <strong>Pasqua</strong>le, e richiama l’assemblea ad un permanente itinerario <strong>di</strong><br />
conversione secondo l’adagio <strong>di</strong> Leone Magno: «Cristiano <strong>di</strong>venta quel che sei».<br />
È interessante ricordare che i più antichi battisteri erano circolari, come lo erano in genere i<br />
mausolei, per evidenziare la partecipazione alla morte <strong>di</strong> Cristo.<br />
Stesso significato per alcuni battisteri esagonali: Cristo è morto nel sesto giorno della settimana.<br />
49
Assai più numerosi i battisteri ottagonali in memoria della risurrezione avvenuta nell'ottavo giorno,<br />
cioè nel primo giorno della nuova creazione, dopo il settimo dell'antica alleanza.<br />
Ritornando poi all'antica tra<strong>di</strong>zione, le attuali norme prevedono la possibilità <strong>di</strong> fonti battesimali<br />
con l'acqua corrente affinché l'acqua viva manifesti ancor meglio la pienezza <strong>di</strong> vita nuova in Cristo<br />
(RICA; Premesse, 21 e 25)<br />
È tutta questa ricchezza simbolica che la comunità dei battezzati è chiamata a riacquistare e ad<br />
esprimere attraverso lo spazio riservato alla celebrazione dell'Iniziazione cristiana. Come realtà che<br />
non sta alle spalle, evento già avvenuto e chiuso in se stesso, ma come processo <strong>di</strong> crescita che<br />
continuamente spinge verso il futuro, in quel «già e non ancora» a cui la liturgia continuamente<br />
richiama.<br />
Il <strong>Tempo</strong> <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, dunque, tempo particolarmente adatto per la catechesi mistagogica. Esso può<br />
offrire la possibilità <strong>di</strong> realizzare itinerari, che a partire dalle stesse celebrazioni esprimano l’unità<br />
dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana ed il loro intrinseco legame con la <strong>di</strong>namica celebrativa<br />
facendo crescere l’assemblea liturgica, per e nella celebrazione, verso la pienezza della sua identità<br />
e missione.<br />
50
IL TEMPO … DELL’ACCLAMAZIONE<br />
Questo è il tempo della gioia! Al n°100 del documento Paschalis sollemnitatis, leggiamo: “La<br />
celebrazione della <strong>Pasqua</strong> continua nel tempo pasquale. I cinquanta giorni che si succedono dalla<br />
domenica <strong>di</strong> risurrezione alla domenica <strong>di</strong> Pentecoste, si celebrano nella gioia come un solo giorno<br />
<strong>di</strong> festa, anzi come «la grande domenica». Questa affermazione ci consente <strong>di</strong> andare alla ra<strong>di</strong>ce<br />
dell’espressione naturale della gioia: l’acclamazione, acclamare significa prima <strong>di</strong> tutto approvare<br />
clamorosamente, assentire con entusiasmo, applau<strong>di</strong>re.<br />
Il termine acclamazione, in liturgia, caratterizza « tutto un insieme <strong>di</strong> formule liturgiche che<br />
non sono né antifone, né responsori, né orazioni, né esorcismi, e che nella loro brevità<br />
esprimono un augurio o un’affermazione <strong>di</strong> fede, un’invocazione o una supplica» 26<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista della struttura testuale le acclamazioni sono descritte come «un breve<br />
periodo che costituisce un’unità semantica che può essere formata da una sola parola o da più<br />
frasi, pronunciate sia in continuazione, sia alternativamente». 27<br />
Si possono <strong>di</strong>stinguere vari tipi <strong>di</strong> acclamazioni liturgiche <strong>28</strong> :<br />
1. acclamazione grido (ad esempio “Parola <strong>di</strong> Dio”, “Luce <strong>di</strong> Cristo”, “Credo”, …)<br />
2. acclamazione inno (ad esempio “Santo”, formule dossologiche, …)<br />
3. acclamazione jubilus (ad esempio “Alleluia”, “Osanna”, “Kyrie” fiorito, …)<br />
4. acclamazione <strong>di</strong> saluto e <strong>di</strong>alogo (ad esempio “Il signore sia con voi”, …)<br />
5. acclamazione responsoriale (risposte brevi <strong>di</strong> salmi e responsori)<br />
Tutte queste formule hanno in comune una cosa: sono segni e strumenti della partecipazione<br />
vocale dell’assemblea.<br />
«Le acclamazioni e le risposte dei fedeli al saluto del sacerdote e alle orazioni, costituiscono<br />
quel grado <strong>di</strong> partecipazione attiva che i fedeli riuniti devono porre in atto in ogni forma <strong>di</strong><br />
Messa, per esprimere e ravvivare l’azione <strong>di</strong> tutta la comunità.» 29<br />
Ad esempio l’Amen è l’assenso, la ratifica alla preghiera presidenziale, l’ Alleluia è l’espressione<br />
tipica della lode <strong>di</strong>vina; i saluti e i <strong>di</strong>aloghi sono l’espressione viva, in azione, dell’unione fra il<br />
sacerdote e il popolo; e così via.<br />
Le acclamazioni hanno dunque nella celebrazione una funzione <strong>di</strong> primaria importanza; anzi, come<br />
già riportato sopra riguardo alla partecipazione attiva del popolo (actuosa partecipatio)<br />
sono senz’altro i gesti e i momenti più importanti.<br />
I riti in cui queste formule operano sono <strong>di</strong>versi e neppure la brevità della formula basta a<br />
caratterizzare le «acclamazioni» come rito. Il Santo, ad esempio, è un rito <strong>di</strong> acclamazione, eppure<br />
non è una formula semplice e breve.<br />
Per sapere identificare le acclamazioni è sufficiente leggere - o meglio stu<strong>di</strong>are – il libro<br />
dell’Apocalisse, il libro dell’acclamazione per eccellenza come nessun altro libro ispirato. Qui si<br />
trovano, nel loro contesto più vero e per così <strong>di</strong>re nella loro sorgente, tutte le espressioni, anzi<br />
le formule stesse dell’acclamazione cristiana.<br />
«A Colui che è, era e sarà » 30 «nei secoli dei secoli ». 31<br />
«Senza fine, giorno e notte <strong>di</strong>cono: Santo! Santo! Santo!» 32<br />
$? "F. Cabrol in DAL Dictionnaire d’ Archeologie chretienne et de Liturgie), I 253-254."<br />
$@ "J. Gelineau in Le traduzioni dei libri liturgici, Città del Vaticano 1966, p. 266."<br />
$> "
Gridano «a gran voce », 33 come una «gran voce <strong>di</strong> molta folla » 34 , come la voce «<strong>di</strong> molte acque<br />
e <strong>di</strong> forti tuoni » 35 .<br />
E con Amen 36 , anche l’altra acclamazione <strong>di</strong>vina, dalla complessa traduzione, della lode pura:<br />
Alleluia 37 .<br />
Come realizzare le acclamazioni? Se vogliamo una celebrazione piena e rispettosa dell’indole <strong>di</strong><br />
ogni acclamazione, non basta recitare quei testi o cantarli col materiale musicale <strong>di</strong>sponibile al<br />
momento: «Un Signore, pietà cantato su una melo<strong>di</strong>a non è un’acclamazione litanica, ma una<br />
“lode” generica; un Alleluia recitato non è un’esclamazione <strong>di</strong> lode, ma una giaculatoria; un<br />
Gloria a te, Signore biascicato sottovoce non è più niente» 38 .<br />
Alcune proposte dal RN<br />
N° Titolo Come realizzarlo<br />
9 ALLELUIA<br />
10 ALLELUIA (O FILII ET FILIAE)<br />
12 ALLELUIA! CANTATE AL SIGNORE Possibilità polifonica<br />
14 ALLELUIA! SIGNORE, TU HAI PAROLE DI Possibilità polifonica<br />
VITA ETERNA<br />
31 Amen ! (Cerino) Possibilità polifonica<br />
32 Amen ! (Rossi) Possibilità polifonica<br />
MARIA E IL TEMPO DI PASQUA<br />
La prima celebrazione che offre degli spunti <strong>di</strong> analisi e riflessione, in merito al tema, è la VII<br />
domenica dopo <strong>Pasqua</strong>, ciclo A. La prima lettura è tratta da At 1,12-14. Il testo <strong>di</strong>ce che i <strong>di</strong>scepoli,<br />
dopo l’Ascensione del Signore tornarono a Gerusalemme, nel luogo dove abitavano e con loro c’era<br />
anche Maria, la madre <strong>di</strong> Gesù. Il credente che partecipa alla Celebrazione Eucaristica, quin<strong>di</strong>,<br />
mentre si avvia a compimento il tempo <strong>Pasqua</strong>le, constata che Maria ha voluto seguire Gesù negli<br />
ultimi istanti della sua vita e poi, non nutrendo dubbi sulla risurrezione <strong>di</strong> Lui, è rimasta con i<br />
<strong>di</strong>scepoli fino al momento della <strong>di</strong>scesa del Consolatore. Sempre nella VII domenica dopo <strong>Pasqua</strong>,<br />
la seconda colletta, riportata nell’e<strong>di</strong>zione italiana del Messale Romano, riprende il tema della<br />
presenza <strong>di</strong> Maria nel cenacolo. L’eucologia, interpretando il testo <strong>di</strong> At 1,12-14, presenta la <strong>Chiesa</strong><br />
raccolta come i <strong>di</strong>scepoli con Maria nel cenacolo. Il Messia risorto è asceso al cielo: subito i<br />
<strong>di</strong>scepoli tornano alla loro casa e vivono insieme, nella preghiera, per attuare il comandamento<br />
9$ "Ap 4,8"<br />
99 "5,12; 7,10; ecc."<br />
9H "Ap 19,1"<br />
9I "Ap 14,2; 19,6"<br />
9? "Ap 1,6-7; 5,14; 7,12; 19,4; 22,17"<br />
9@ "Ap 19,l ss"<br />
9> "G. Stefani, in Il canto dell’Assemblea, n. 9"<br />
52
icevuto: voi mi sarete testimoni (Lc 24,48; At 1,8). Il prefazio per i giorni dopo l’Ascensione,<br />
presente solo nell’e<strong>di</strong>zione italiana e non nell’e<strong>di</strong>tio typica del Messale, ha per tema l’attesa della<br />
venuta dello Spirito. Nel testo ancora una volta si accenna agli apostoli ed a Maria come modelli <strong>di</strong><br />
preghiera unanime. Il testo eucologico, infatti, presenta il Messia come intercessore presso il Padre:<br />
egli otterrà per la <strong>Chiesa</strong> il dono dello Spirito Santo. I fedeli, intanto, mentre attendono il Paraclito,<br />
come avvenne nel cenacolo, rimangono in preghiera e Maria è con loro. Il prefazio insiste sulla<br />
comunione della preghiera, attraverso l’aggettivo unanime, riprendendo il testo <strong>di</strong> At 1,14, in<br />
cui si <strong>di</strong>ce che i <strong>di</strong>scepoli erano assidui e concor<strong>di</strong> nella preghiera. L’aggettivo unanime, però,<br />
sottolinea anche l’atteggiamento che la comunità cristiana deve assumere, se vuol essere simile alla<br />
comunità apostolica, su cui <strong>di</strong>scese lo Spirito Santo. Nel Comune della B. Vergine Maria del<br />
Messale Romano Italiano il formulario n. 6 è stato pensato per le celebrazioni nel tempo <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>.<br />
La prima delle due collette insiste sul tema della gioia che viene restituita al mondo dopo il peccato<br />
per mezzo della risurrezione. Maria è chiamata ad intercedere perché tutti i credenti possano<br />
partecipare <strong>di</strong> quella gioia <strong>di</strong>vina, entrando nella vita senza fine. La seconda colletta, da recitarsi nel<br />
tempo dopo l’Ascensione, riprende le tematiche già esaminate nella VII domenica <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>. Il<br />
Padre, che donò lo Spirito Santo ai suoi <strong>di</strong>scepoli riuniti nel cenacolo con Maria, conceda anche a<br />
noi, per intercessione della Madre celeste <strong>di</strong> consacrarci al servizio del Regno, annunziando con le<br />
parole e con l’esempio le gran<strong>di</strong> opere dell’amore <strong>di</strong>vino. Il testo sintetizza ciò che è detto in At<br />
1,12-14 e negli ultimi versetti <strong>di</strong> ciascun vangelo sinottico, in cui Gesù raccomanda <strong>di</strong> andare ad<br />
annunciare la buona novella, perdonare i peccati e battezzare tutte le genti (cfr. Mt <strong>28</strong>,18-20; Lc<br />
24,46-48; Mc 16,15-18).<br />
Nel documento “ORIENTAMENTI E PROPOSTE PER LA CELEBRAZIONE DELL'ANNO<br />
MARIANO” leggiamo alcuni suggerimenti per celebrare, nel modo più consono, la tra<strong>di</strong>zione<br />
popolare del mese mariano.<br />
Al n.3 si legge: “ Nel corso dell'Anno liturgico la beata Vergine, per la sua singolare<br />
partecipazione al mistero <strong>di</strong> Cristo, è costantemente celebrata sotto una mirabile varietà <strong>di</strong><br />
aspetti: …<br />
— nel tempo <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>, in cui la gioia ecclesiale per la risurrezio ne <strong>di</strong> Cristo e per il dono<br />
dello Spirito è come prolungamento del gau<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Maria <strong>di</strong> Nazaret, la Madre del Risorto:<br />
essa infatti, secondo il sentire della <strong>Chiesa</strong>, fu riempita <strong>di</strong> « ineffabile letizia » per la<br />
vittoria del Figlio sulla morte e, secondo gli Atti degli Apostoli, fu al centro della<br />
<strong>Chiesa</strong> nascente, in attesa del Paraclito (cf. At 1, 14); …”<br />
Una precisazione doverosa, che ci permette <strong>di</strong> inserire nel modo più adeguato anche il canto nelle<br />
<strong>di</strong>verse celebrazioni, infatti come leggiamo al n. 16 dello stesso documento “Forse più che in altre<br />
celebrazioni, nelle messe della beata Vergine Maria, la scelta dei canti deve essere curata e<br />
aderente alle norme dell'istruzione Musicam Sacram<br />
In particolare i canti liturgici dovranno essere:<br />
— confacenti all'oggetto specifico della celebrazione;<br />
— adatti al particolare momento della messa in cui vengono eseguiti;<br />
— vali<strong>di</strong> dal punto <strong>di</strong> vista musicale e tali da favorire la partecipazione dei fedeli,<br />
soprattutto nelle parti loro spettanti.<br />
Nessun dubbio, negli interventi in musica e canto, continueremo a riferirci alle Antifone<br />
d’Ingresso e Comunione, anche nelle celebrazioni della B. Vergine Maria, con la pertinenza rituale<br />
dovuta e tali dai favorire la partecipazione dell’assemblea.<br />
Ancora un suggerimento dal documento sopra citato al n. 21 si esegua “nel tempo <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong><br />
l'antifona Regina caeli o un altro canto che celebri insieme la risurrezione <strong>di</strong> Cristo e la gioia<br />
della Madre del Risorto.<br />
53
MESSE DELLA BV<br />
MARIA<br />
SANTA MARIA<br />
NELLA<br />
RISURREZIONE<br />
DEL SIGNORE<br />
MARIA VERGINE<br />
FONTE DI LUCE E<br />
DI VITA<br />
MARIA VERGINE<br />
DEL CENACOLO<br />
MARIA VERGINE<br />
REGINA DEGLI<br />
APOSTOLI<br />
ANTIFONA D'INGRESSO ANTIFONA ALLA<br />
COMUNIONE<br />
Rallegrati, Madre della luce: Rallegrati, Vergine Madre:<br />
Gesù, sole <strong>di</strong> giustizia,<br />
Cristo è risorto. Alleluia<br />
vincendo le tenebre del sepolcro<br />
illumina tutto l'universo. Alleluia<br />
Salve, Madre della luce:<br />
vergine hai generato il Cristo<br />
e sei <strong>di</strong>venuta l'immagine della<br />
<strong>Chiesa</strong> madre,<br />
che nell'onda pura del Battesimo<br />
rigenera i popoli credenti.<br />
Alleluia.<br />
I <strong>di</strong>scepoli erano assidui e<br />
concor<strong>di</strong> nella preghiera<br />
con Maria, madre <strong>di</strong> Gesù.<br />
Alleluia.<br />
I <strong>di</strong>scepoli erano assidui e<br />
concor<strong>di</strong> nella preghiera<br />
con Maria, madre <strong>di</strong> Gesù.<br />
Alleluia.<br />
54<br />
Te beata, o Vergine Maria,<br />
che adombrata dallo Spirito Santo<br />
hai portato nel grembo verginale<br />
il Figlio dell'eterno Padre<br />
e sei <strong>di</strong>venuta la <strong>di</strong>mora<br />
dei sacramenti celesti. Alleluia.<br />
I <strong>di</strong>scepoli erano assidui<br />
Nell’ascoltare l'insegnamento degli<br />
Apostoli<br />
e nell'unione fraterna,<br />
nella frazione del pane e nelle<br />
preghiere.<br />
Alleluia.<br />
Beata la Vergine Maria,<br />
che ha portato in grembo<br />
il Figlio dell'eterno Padre.<br />
Alleluia.
ANTIFONE DELLE DOMENICHE E SOLENNITÀ DEL TEMPO DI PASQUA<br />
Dom Ant Ingresso Ant Comunione<br />
2° Come bambini appena nati,<br />
bramate il puro latte spirituale,<br />
che vi faccia crescere verso la salvezza.<br />
Alleluia. (1Pt 2,2)<br />
Oppure:<br />
Entrate nella gioia e nella gloria,<br />
e rendete grazie a Dio, che vi ha chiamato<br />
al regno dei cieli. Alleluia. (4 Esd 2,36-37<br />
(Volg.))<br />
3° Acclamate al Signore da tutta la terra,<br />
cantate un inno al suo nome,<br />
rendetegli gloria, elevate la lode. Alleluia.<br />
(Sal 66,1-2)<br />
4° Della bontà del Signore è piena la terra;<br />
la sua parola ha creato i cieli. Alleluia. (Sal<br />
33,5-6)<br />
5° Cantate al Signore un canto nuovo,<br />
perché ha compiuto pro<strong>di</strong>gi;<br />
a tutti i popoli ha rivelato la salvezza.<br />
Alleluia. (Sal 98,1-2)<br />
6° Con voce <strong>di</strong> giubilo date il grande<br />
annunzio,<br />
fatelo giungere ai confini del mondo:<br />
il Signore ha liberato il suo popolo.<br />
Alleluia. (cf. Is 48,20)<br />
Ascensione “Se mi amate, osservate i miei<br />
comandamenti”,<br />
<strong>di</strong>ce il Signore.<br />
“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un<br />
altro Consolatore,<br />
che rimanga con voi in eterno”. Alleluia.<br />
(Gv 14,15-16)<br />
Pentecoste Lo Spirito del Signore ha riempito<br />
l’universo,<br />
egli che tutto unisce,<br />
conosce ogni linguaggio. Alleluia. (Sap<br />
1,7)<br />
Oppure:<br />
L’amore <strong>di</strong> Dio è stato effuso nei nostri<br />
cuori<br />
per mezzo dello Spirito,<br />
che ha stabilito in noi la sua <strong>di</strong>mora.<br />
Alleluia. (Rm 5,5; 8,11)<br />
55<br />
“Accosta la tua mano,<br />
tocca le cicatrici dei chio<strong>di</strong><br />
e non essere incredulo, ma credente”. Alleluia.<br />
(cf. Gv 20,27)<br />
I <strong>di</strong>scepoli riconobbero Gesù, il Signore,<br />
nello spezzare il pane. Alleluia. (cf. Lc 24,35)<br />
È risorto il buon Pastore,<br />
che ha dato la vita per le sue pecorelle,<br />
e per il suo gregge è andato incontro alla morte.<br />
Alleluia.<br />
Oppure:<br />
“Io sono il buon pastore e offro la vita per le<br />
pecore”,<br />
<strong>di</strong>ce il Signore. Alleluia. (Gv 10,14.15)<br />
“Io sono la via, la verità e la vita”,<br />
<strong>di</strong>ce il Signore. Alleluia. (Gv 14,6)<br />
“Se mi amate, osservate i miei comandamenti”,<br />
<strong>di</strong>ce il Signore.<br />
“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro<br />
Consolatore, che rimanga con voi in eterno”.<br />
Alleluia. (Gv 14,15-16)<br />
“Ecco, io sono con voi tutti i giorni<br />
sino alla fine del mondo”. Alleluia. (Mt <strong>28</strong>,20)<br />
Tutti furono ripieni <strong>di</strong> Spirito Santo<br />
e proclamavano le gran<strong>di</strong> opere <strong>di</strong> Dio. Alleluia.<br />
(At 2,4.11)<br />
Oppure:<br />
“Come il Padre ha mandato me,<br />
anch’io mando voi.<br />
Ricevete lo Spirito Santo”. Alleluia. (Gv<br />
20,21.22)
<strong>Chiesa</strong> <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong><br />
La formazione liturgica<br />
SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE<br />
DELLE SOLENNITÀ PASQUALI<br />
Il T e mpo <strong>di</strong> Pas qua<br />
Appen<strong>di</strong>ce con i testi dei canti<br />
<strong>Bologna</strong>, Seminario Arcivescovile<br />
2 <strong>aprile</strong> <strong>2011</strong>
& b b b c ˙<br />
CHRISTUS RESURREXIT 170<br />
(q = 104)<br />
A1 Coro misto<br />
(O)<br />
n˙<br />
& bb b œ œ œ œ œ œ<br />
œ œ œ ˙ ˙<br />
Chri-stus re-sur-re - xit.<br />
C<br />
B<br />
œ<br />
œ œ œ œ œ<br />
Chri-stus re-sur-re - xit,<br />
A2<br />
˙<br />
(O)<br />
n˙<br />
œ œ œ ˙ ˙<br />
& bbb œ œ œ œ œ<br />
œ œ .<br />
œ œ nœ ˙<br />
Al - le - lu - ia,<br />
A1<br />
1. Acclamazione pasquale<br />
& bb b J œ<br />
œ œ nœ œ<br />
J<br />
O tu che dor - mi,<br />
& bb b œ<br />
A2 œ œ nœ œ<br />
Cri- sto sa - rà la<br />
& bb 2. Salmo 117 (118)<br />
b Œ œ œ œ œ nœ nœ<br />
& bb b<br />
& bb b<br />
al - le - lu - ia!<br />
œ œ œ œ œ œ<br />
sor - gi dai mor - ti,<br />
œ œ œ œ<br />
tu - a lu - ce.<br />
C<br />
<br />
B<br />
<br />
<br />
<br />
œ œ œ œ Aœ œ<br />
1. Dal-la stret-ta ho gri - da- to al Si - gno-re:<br />
B<br />
C<br />
œ œ œ<br />
j<br />
œ œ<br />
j<br />
œ<br />
m’ha e - sau-<strong>di</strong> - to, m’ha<br />
Ó Œ œ œ<br />
2. Mi - a<br />
œ œ<br />
J<br />
œ œ ˙<br />
sciol - to.<br />
œ nœ œ<br />
J<br />
nœ œ<br />
for-za e mi - o in - no
& bb b œ œ œ Aœ œ<br />
& bbb œ.<br />
& bb b<br />
è il Si - gno - re:<br />
J œ<br />
nœ œ<br />
J<br />
œ<br />
J<br />
fu la mi - a sal - vez - za.<br />
œ œ œ œ ˙<br />
3. Io non mo - ri - rò,<br />
& bbb Œ œ n œ<br />
nœ<br />
.<br />
œ<br />
J<br />
nar - re - rò le<br />
& bb b Ó Œ œ œ<br />
4. Ti rin -<br />
& bbb œ œ œAœ œ<br />
hai e - sau - <strong>di</strong> - to.<br />
& bbb œ œ j<br />
J œ<br />
B<br />
œ œA˙ œ œ ˙<br />
ma vi-vrò,<br />
œ œ Aœ œ œ<br />
su - e o - pe- re.<br />
œ œ œ n œ<br />
Ó Œ œ œ<br />
nœ<br />
.<br />
e - gli<br />
C<br />
B<br />
C<br />
œ<br />
J<br />
gra - zio per - ché mi<br />
B<br />
Aœ œ<br />
mi - a sal - vez - za.<br />
& b b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ<br />
& b b b<br />
Œ œ<br />
nœ œ<br />
J<br />
œ<br />
J<br />
Sei sta- to<br />
C<br />
la<br />
œ œ œ œ œ<br />
5. Que-sto è il gior-no che il Si - gno - re ha fat - to:<br />
B<br />
œ œ œ œ nœ nœ œ<br />
ral - le - gria - mo - ci, e - sul -
& bb b œ œ œ ˙<br />
tia - - - mo.<br />
Christus resurrexit,<br />
Christus resurrexit.<br />
Alleluia, alleluia.<br />
O tu che dormi, sorgi dai morti.<br />
Cristo sarà la tua luce.<br />
1. Dalla stretta ho gridato al Signore:<br />
m’ha esau<strong>di</strong>to, m’ha sciolto.<br />
2. Mia forza e mio inno è il Signore:<br />
egli fu la mia salvezza.<br />
3. Io non morirò, ma vivrò,<br />
narrerò le sue opere.<br />
4. Ti ringrazio perché mi hai esau<strong>di</strong>to.<br />
Sei stato la mia salvezza.<br />
C<br />
5. Questo è il giorno che il Signore ha fatto:<br />
rallegriamoci, esultiamo.
RN 170 T: Salmo 117 M: J. Berthier<br />
TESTO Ancora un’ acclamazione: ci invita a risorgere con Cristo, proclamando il bellissimo<br />
testo del Salmo Alleluiatico 117, Questo splen<strong>di</strong>do inno biblico è collocato<br />
all’interno della piccola raccolta <strong>di</strong> Salmi, dal 112 al 117, detta lo "Hallel pasquale",<br />
cioè la lode salmica usata dal culto ebraico per la <strong>Pasqua</strong>. Il Salmo 117 rincuora i<br />
cristiani a riconoscere nell’evento pasquale <strong>di</strong> Gesù "il giorno fatto dal Signore", in<br />
cui "la pietra scartata dai costruttori è <strong>di</strong>venuta testata d’angolo". Col Salmo essi<br />
possono quin<strong>di</strong> cantare pieni <strong>di</strong> gratitu<strong>di</strong>ne: "Mia forza e mio canto è il Signore, egli<br />
è stato la mia salvezza" (v. 14); "Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed<br />
esultiamo in esso" (v. 24).<br />
MUSICA Lo stile, originale e riconoscibile, è sempre quello: frasi brevi e incisive, facili, ma<br />
pur sempre nobili, che intercalano o, spesso, accompagnano, come refrain <strong>di</strong><br />
sottofondo, l’intervento del solista. In questo caso il <strong>di</strong>segno melo<strong>di</strong>co interpreta, in<br />
modo inequivocabile, l’annuncio della mattina <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>: Cristo è risorto!<br />
Anche per questo brano il suggerimento è quello <strong>di</strong> poterlo eseguire intercalando le<br />
acclamazioni con strumenti a fiato, a corde che ne arricchiscono l’armonia.<br />
QUANDO<br />
Le possibilità sono <strong>di</strong>verse, trattandosi <strong>di</strong> una acclamazione, può servire per aprire<br />
una celebrazione, così come per incamminarsi a ricevere l’eucaristia oppure per<br />
riecheggiare l’alleluia del saluto finale: Ren<strong>di</strong>amo grazie a Dio alleluia, alleluia!
& # # c ˙<br />
CRISTO È RISORTO, 172<br />
ALLELUIA (Haendel)<br />
œ.<br />
j<br />
œ<br />
RIT. Cri - sto˘è ri -<br />
& # # w<br />
ia!<br />
Solenne e gioioso (q = 96)<br />
& # # œ œ œ.<br />
& # #<br />
al - le - lu -<br />
˙ ˙<br />
ver - so,<br />
˙<br />
˙<br />
sor - to,<br />
œ œ œ œ œ œ<br />
Vin - ta è˘or-mai<br />
FINE<br />
la<br />
j<br />
œ<br />
w<br />
ia!<br />
œ œ œ œ<br />
al - le - lu -<br />
& # # œ œ œ œ œ œ<br />
un in - no <strong>di</strong><br />
& # # œ œ œ # œ.<br />
œ œ œ œ œ œ<br />
al - le - lu -<br />
Rit. Cristo è risorto, alleluia!<br />
Vinta è ormai la morte, alleluia!<br />
1. Canti l’universo, alleluia,<br />
un inno <strong>di</strong> gioia al nostro Redentor.<br />
2. Con la sua morte, alleluia,<br />
ha ridato all’uomo la vera libertà.<br />
˙ ˙<br />
mor - te,<br />
œ œ œ œ œ œ<br />
1. Can - ti l’u - ni -<br />
j<br />
œ<br />
al no - stro Re - den -<br />
w<br />
ia,<br />
˙ # ˙<br />
gio - ia<br />
3. Segno <strong>di</strong> speranza, alleluia,<br />
luce <strong>di</strong> salvezza per questa umanità.<br />
w<br />
tor.
RN 172 T: M. Piatti M: G.F. Haendel<br />
TESTO 1 Haendel compose questo coro per descrivere l’accoglienza, in Gerusalemme, <strong>di</strong><br />
Giuda Maccabeo, nell’Oratorio omonimo. I fanciulli, le giovani, e il popolo degli<br />
Israeliti, si succedono, in una sequenza trionfale, a salutare il vittorioso; ed il tutto<br />
culmina in una marcia. In seguito, qualcuno vi applicò il testo latino salmico Cantate<br />
Domino, <strong>di</strong>venne così un brano <strong>di</strong> “musica sacra” a <strong>di</strong>ffusione europea, tradotto in<br />
lingue <strong>di</strong>verse.<br />
QUANDO<br />
Il testo in esame è indovinato, quanto al contenuto globale (messaggio <strong>di</strong> vittoria<br />
pasquale) e all’articolazione fondamentale tripartita : affermazione –<br />
acclamazione/commento esortazione/ripresa<br />
La robusta melo<strong>di</strong>a si presenta tripartita: A,B,C, sono sezioni che fungono da<br />
apertura, intermezzo e ripresa: ciascuna delle sezioni si compone <strong>di</strong> due semifrasi.<br />
La prima e la terza giocano sull’alternanza tonica dominante; la seconda tocca la<br />
relativa minore e poi modula sulla dominante, per rilanciare la ripresa. A loro volta le<br />
semifrasi sono costruite con incisi che ritmicamente fanno rima tra loro: un modo <strong>di</strong><br />
procedere questo che, ottiene un effetto <strong>di</strong> stabilità e rassicurazione.<br />
Come realizzarlo: con un attacco sicuro ed una conduzione “solenne e gioiosa”. E’<br />
auspicabile una esecuzione articolata : pochi/tutti con possibili riprese strumentali,<br />
così come il testo originario dell’Oratorio parlava <strong>di</strong> trombe flauti e cembali.<br />
In ogni momento rituale acclamatorio, del T. P. ed in particolare alla processione col<br />
Vangelo.<br />
1 Cfr F. Rainol<strong>di</strong> in MeA 1982/42, p.16, Marietti - AL
CRISTO, SPLENDORE DEL PADRE 175<br />
& 4 3<br />
B<br />
& œ<br />
In uno - Energico (m . = 54-60)<br />
A<br />
Do<br />
œ<br />
œ œ<br />
Sol<br />
œ œ œ<br />
1. Cri - sto, splen - do - re del<br />
œ œ<br />
al - le - lu -<br />
& œC œ œ<br />
D<br />
& œ<br />
Cri - sto, fra -<br />
œ œ<br />
sia glo - ria˘a<br />
.<br />
˙<br />
ia,<br />
œ œ œ<br />
tel - lo del -<br />
˙.<br />
te,<br />
La–<br />
˙.<br />
Pa -<br />
œ œ œ<br />
al - le - lu -<br />
œ œ œ<br />
l’uo -<br />
œ œ œ<br />
sia glo - ria˘a<br />
1. Cristo, splendore del Padre,<br />
alleluia, alleluia,<br />
Cristo, fratello dell’uomo,<br />
sia gloria a te, sia gloria a te.<br />
2. Cristo, risorto da morte,<br />
alleluia, alleluia,<br />
in te rimane la vita:<br />
cre<strong>di</strong>amo in te, cre<strong>di</strong>amo in te.<br />
3. Luce e salvezza del mondo,<br />
alleluia, alleluia,<br />
forza, rifugio, conforto:<br />
speriamo in te, speriamo in te.<br />
4. Manda lo Spirito Santo,<br />
alleluia, alleluia,<br />
guida nel nostro cammino<br />
incontro a te, incontro a te.<br />
Sol<br />
˙.<br />
dre,<br />
.<br />
˙<br />
ia,<br />
.<br />
˙<br />
mo,<br />
.<br />
˙<br />
te!
RN 175 T: F. Rainol<strong>di</strong> M: J. Berthier<br />
TESTO 2<br />
Il testo verbale invita, con poche ma incisive invocazioni, ad acclamare a Cristo nel suo<br />
mistero: Verbo incarnato, salvatore,datore dello Spirito. A dare vigore ed essenzialità contribuisce<br />
il testo musicale, quasi solo un'ossatura costruita prevalentemente sulle note<br />
dell'accordo <strong>di</strong> DO e la sua dominante (SOL). II ritmo, molto semplice, è strutturato<br />
su due soli valori. Da notare che i suoni lunghi (in questo caso esattamente il triplo<br />
dei brevi) si trovano prevalentemente sulle finali <strong>di</strong> ogni verso, quasi a dare respiro<br />
alla frase.<br />
MUSICA E’ un inno, e quin<strong>di</strong> può essere eseguito da tutta l'assemblea all'unisono,<br />
possibilmente senza slabbrature ma cercando <strong>di</strong> mantenere agilmente la precisione ritmica<br />
(da <strong>di</strong>rigere in uno ». La forma del testo, invocazione/ acclamazione, permette<br />
anche l'alternarsi <strong>di</strong> un solista io un piccolo gruppo) con l'assemblea. E’ un inno, ma è<br />
anche un canone a quattro. La struttura melo<strong>di</strong>co - armonica permette infatti la sovrapposizione<br />
delle parti ( in questo caso quattro) con entrate successive, e il gesto<br />
acclamativo si <strong>di</strong>lata fonicamente ed emotivamente: cantare « in canone » è anche un<br />
gioco e il gioco fa festa. le possibilità esecutive sono <strong>di</strong>verse; per esempio, invece <strong>di</strong><br />
partire subito con il canone, si potrebbe far eseguire la 1° strofa da voci femminili<br />
all'unisono, la 2° strofa da voci maschili, sempre all'unisono, e la 3° e 4° strofa « in<br />
canone. Le possibilità sono <strong>di</strong>verse, e perché non introdurre <strong>di</strong>verse parti strumentali da<br />
rafforzare o sostituire le risposte-acclamazioni?<br />
QUANDO<br />
Essendo un inno, il suo posto all’'interno <strong>di</strong> una celebrazione può essere l'apertura, la<br />
chiusura o un altro momento in cui sia opportuno tale gesto.<br />
Quanto ai tempi liturgici, le strofe richiamano le tappe fondamentali del mistero <strong>di</strong><br />
Cristo: incarnazione, resurrezione, dono dello Spirito, così che il canto risulla adatto per<br />
tutte le feste in cui si celebri tale mistero globalmente o in qualche suo aspetto.<br />
2 Cfr J. Tafuri in MeA 1980/31, p. 10
& # # # 4 2 (q = 70) 4<br />
.<br />
& # # # œ œ œ œ<br />
& # # #<br />
& # # #<br />
& # # #<br />
& # # # j<br />
œ œ<br />
&<br />
ie - ri og - gi˘e<br />
<br />
CRISTO VIVENTE 176<br />
œ<br />
œ œ<br />
S1.<br />
Tu sei il<br />
j<br />
œ<br />
Di - o vi -<br />
œ<br />
RIT. Cri - sto vi -<br />
œ œ<br />
sem - pre,<br />
œ œ œ œ<br />
bria - mo˘il tuo mi -<br />
œ œ<br />
mo - re,<br />
& # # # œ œ<br />
& # # #<br />
no - me,<br />
‰<br />
j<br />
œ œ œ<br />
a te la<br />
& # # # œ œ œ<br />
glo - ria, Si -<br />
œ œ œ<br />
ac - cla -<br />
œ œ<br />
ven - te<br />
œ œ<br />
œ œ œ œ<br />
j<br />
œ œ<br />
u - ni - ca sal -<br />
œ œ œ<br />
œ œ<br />
ven - te<br />
œ œ œ<br />
ce - le -<br />
j<br />
œ<br />
ste - ro d’a -<br />
œ œ œ<br />
mia - mo˘al tuo<br />
œ œ<br />
vez - za:<br />
œ œ œ<br />
lo - de˘e la<br />
gno - re Ge -<br />
˙<br />
sù.<br />
œ œ œ<br />
Fi - glio del<br />
‰ j<br />
œ œ œ<br />
che of- fre˘al
& # # #<br />
& # # # ‰<br />
œ œ œ<br />
mon - do la<br />
œ œ œ<br />
J<br />
da o - gni<br />
& # # # œ œ œ œ<br />
& # # #<br />
& # # #<br />
te il no- stro<br />
œ œ<br />
zio - ne!<br />
œ œ œ<br />
œ œ œ<br />
sua re - den -<br />
œ œ<br />
ma - le.<br />
œ œ<br />
can - to<br />
˙ <br />
Ver - bo splen - den - te del<br />
& # # # ‰ j<br />
œ œ œ œ œ<br />
œ<br />
la lu - ce ve - ra che<br />
& # # #<br />
œ œ<br />
nio - ne<br />
& # # # œ ‰ j<br />
œ<br />
& # # #<br />
TA<br />
œ œ œ œ<br />
<strong>di</strong> be - ne - <strong>di</strong> -<br />
j<br />
œ œ<br />
‰<br />
j<br />
œ<br />
J œ œ œ<br />
tra uo-mo˘e<br />
œ œ œ œ<br />
te il no- stro<br />
œ œ<br />
zio - ne!<br />
œ œ<br />
zio - ne<br />
œ ‰ j<br />
œ<br />
T A<br />
œ œ œ œ<br />
<strong>di</strong> be - ne - <strong>di</strong> -<br />
œ<br />
œ œ<br />
STu<br />
sei il<br />
œ œ<br />
Pa - dre,<br />
œ œ œ<br />
fa co - mu -<br />
œ œ<br />
uo - mo.<br />
œ œ<br />
can - to<br />
˙<br />
.
Rit. Cristo vivente ieri oggi e sempre,<br />
celebriamo il tuo mistero d’amore,<br />
acclamiamo al tuo nome, unica salvezza:<br />
a te la lode e la gloria, Signore Gesù.<br />
1. Tu sei il figlio del Dio vivente<br />
che offre al mondo la sua redenzione<br />
da ogni male.<br />
A te il nostro canto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione!<br />
Tu sei il Verbo splendente del Padre,<br />
la luce vera che fa comunione<br />
tra uomo e uomo.<br />
A te il nostro canto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione!<br />
2. Tu sei l’Agnello che Dio ha immolato<br />
per dare ai figli riconciliazione,<br />
perdono e pace.<br />
A te il nostro canto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione!<br />
Tu sei la Vita offerta in pienezza,<br />
l’unica Via <strong>di</strong> liberazione<br />
del nostro mondo.<br />
A te il nostro canto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione!<br />
3. Tu sei il Santo che doni lo Spirito<br />
per rinnovare la tua creazione<br />
e i nostri cuori.<br />
A te il nostro canto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione!<br />
Tu sei il Pane donato dal cielo,<br />
cibo <strong>di</strong> vita e consolazione,<br />
forza d’amore.<br />
A te il nostro canto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione!<br />
4. Tu sei Colui che sei e che eri,<br />
Colui che viene per ogni nazione<br />
a fare grazia.<br />
A te il nostro canto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione!<br />
Tu sei il Cristo vivente in eterno,<br />
sei la primizia <strong>di</strong> risurrezione,<br />
nostra speranza.<br />
A te il nostro canto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione!
RN 176 3 T: A.M. Galliano M: A. Parisi<br />
TESTO Il tema del XXIII CEN <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> “Gesù Cristo, unico salvatore del mondo,<br />
ieri,oggi e sempre” è ripreso nel testo <strong>di</strong> questo brano, che appartiene alla raccolta<br />
nata per le celebrazioni eucaristiche <strong>di</strong> tale evento. Le parole del ritornello invitano<br />
a proclamare la fede che ogni cristiano racchiude nel suo intimo e guida i suoi passi<br />
verso l’altare dove si celebra il mistero della salvezza, acclamando a Cristo unica<br />
salvezza. Le quattro strofe ripercorrono la storia della salvezza operata in Cristo e si<br />
<strong>di</strong>panano nelle affermazioni: Tu sei il figlio del Dio vivente - Tu sei il Verbo – Tu<br />
sei l’Agnello – Tu sei la Vita, etc, che si alternano all’ acclamazione: A te il nostro<br />
canto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>zione! Un linguaggio semplice ed essenziale per l’assemblea riunita,<br />
in occasioni particolari.<br />
MUSICA Una melo<strong>di</strong>a semplice e allo stesso tempo solenne e coinvolgente.<br />
QUANDO<br />
Il ritornello può essere cantato a quattro voci. Le strofe, <strong>di</strong>vise in due parti, vanno<br />
eseguite, alternando un coretto maschile e uno femminile, con la risposta<br />
dell’assemblea.<br />
La proposta dell’autore prevede, oltre l’organo, l’utilizzo dei fiati ed in particolare<br />
degli ottoni che ben sottolineano il carattere acclamatorio del ritornello.<br />
E’ un canto d’ingresso che adatto a caratterizzare la solennità della celebrazione.<br />
Sarebbe opportuno eseguire tutte le strofe ma nel caso si facesse una scelta, mai<br />
tralasciare l’ultima che nella seconda parte annuncia “Tu sei il Cristo vivente in<br />
eterno, sei la primizia <strong>di</strong> risurrezione, nostra speranza” che richiama il tempo<br />
liturgico che stiamo considerando.<br />
3 Il brano è inserito nella raccolta preparata per il XXIII CEN <strong>di</strong> <strong>Bologna</strong> “CRISTO IERI OGGI SEMPRE” EP 1996
& # # 2 2 Œ<br />
IL MATTINO DI PASQUA 179<br />
Allegro moderato (q = 160)<br />
Re<br />
La/Do#<br />
œ œ œ œ œ<br />
Rit. Il Signore è risorto: cantate con noi!<br />
Egli ha vinto la morte, alleluia.<br />
1. a) Il mattino <strong>di</strong> <strong>Pasqua</strong>,<br />
nel ricordo <strong>di</strong> lui,<br />
siamo andate al sepolcro:<br />
non era più là!<br />
b) Senza nulla sperare,<br />
con il cuore sospeso,<br />
siamo andati al sepolcro:<br />
non era più là!<br />
œ œ œ œ œ œ<br />
RIT. Il Signo- re˘è ri - sor - to: canta- te con<br />
Si–<br />
(Al- le - lu<br />
Mi<br />
-<br />
La<br />
ia, al - le - lu -<br />
FINE<br />
Mi7/4 3 La4 3<br />
& # # . 8 6<br />
œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w<br />
noi!<br />
ia,<br />
& # # 8 6 . Œ<br />
1. S1 a)<br />
E- gli˘ha<br />
al - le -<br />
(o = q = 52-60)<br />
Fa#–<br />
Re<br />
œ<br />
vin- to la<br />
lu -<br />
Si–/Re<br />
œ œ œ œ<br />
Il mat - ti - no <strong>di</strong><br />
Si–7<br />
Re<br />
morte,˘al- le - lu - ia!<br />
ia,al - le - lu - ia!)<br />
La<br />
Re<br />
œ. œ œ œ œ œ œ<br />
Pa-squa,<br />
nel ri-cor-do<br />
<strong>di</strong><br />
& # # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ ˙.<br />
.<br />
Sol<br />
lu - i, sia-mo˘an-da-te˘al<br />
se- pol-cro:non<br />
e - ra più là!<br />
Mi<br />
La7
2. a) Sulla strada <strong>di</strong> casa<br />
parlavamo <strong>di</strong> lui<br />
e l’abbiamo incontrato:<br />
ha parlato con noi!<br />
b) Sulle rive del lago<br />
pensavamo a quei giorni<br />
e l’abbiamo incontrato:<br />
ha mangiato con noi!<br />
3. a) Oggi ancora, fratelli,<br />
ricordando quei giorni,<br />
ascoltiamo la voce<br />
del Signore tra noi!<br />
b) E, spezzando il suo Pane<br />
con la gioia nel cuore,<br />
noi cantiamo alla vita<br />
nell’attesa <strong>di</strong> lui!
RN 179 T e M: P. Sequeri<br />
TESTO 4<br />
MUSICA<br />
QUANDO<br />
Siamo <strong>di</strong> fronte a un testo chiaramente pasquale con un accento decisamente<br />
acclamativo nel ritornello.<br />
Le strofe, scritte in prima persona, pongono chi canta <strong>di</strong>rettamente all’interno del<br />
mistero pasquale, visto nello svolgersi degli eventi imme<strong>di</strong>atamente successivi alla<br />
risurrezione: le donne che vanno al sepolcro e scoprono la tomba vuota (Mt <strong>28</strong>,1-8;<br />
Mc 16,1-8; Lc 24,1-10), i due <strong>di</strong>scepoli che, <strong>di</strong>sillusi, si allontanano da Gerusalemme<br />
(Lc 24,13-35; Mc 16,12-13), l’apparizione del Risorto ai <strong>di</strong>scepoli sul lago <strong>di</strong><br />
Tiberiade (Gv 21,1-19).<br />
La terza strofa mette in risalto l’attualizzarsi nell’Eucarestia degli eventi pasquali<br />
evocati nelle strofe precedenti, in particolare nella Parola e nell’Eucarestia.<br />
La composizione è strutturata in forma <strong>di</strong> canzone nell’alternanza tra ritornello e<br />
strofe. Questa alternanza è sottolineata pure dalla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> tempo: ritornello in<br />
tempo semplice, strofe in tempo composto. Tale struttura, naturalmente, chiede <strong>di</strong><br />
affidare ad un solista il canto delle strofe, vista la <strong>di</strong>fficoltà del cambio ritmico.<br />
Anche gli strumenti che accompagnano devono essere attenti ad una assoluta<br />
precisione ritmica per non assecondare inutili, ma possibili rallentamenti.<br />
Questo canto appare particolarmente adatto per la processione d’ingresso perché<br />
collega l’evento pasquale all’intera celebrazione eucaristica. In quest’ottica non<br />
sembra opportuno tralasciare la seconda e la terza strofa perché sviluppano con<br />
consequenzialità questa logica. Questa composizione, <strong>di</strong> carattere festoso è adatta ad<br />
un’assemblea giovanile.<br />
4 Cfr Don Graziano Ghisolfi in ULN Schede <strong>di</strong> canti per la Quaresima - <strong>Pasqua</strong> 2010
(q = 92-100)<br />
Fa<br />
& b 4 2 ‰ j<br />
œ<br />
Fa<br />
& b ˙<br />
ti,<br />
Re–<br />
Re -<br />
,<br />
REGINA DEI CIELI 184<br />
œ œ œ<br />
gi -<br />
Si@<br />
œ.<br />
al -<br />
& b œ œ œ œ<br />
& b<br />
na dei<br />
œ<br />
J<br />
le -<br />
Cri - sto, che˘hai por -<br />
Si@<br />
œ.<br />
al -<br />
Re–7<br />
j<br />
œ<br />
le -<br />
& b œ œ œ œ<br />
œ œ<br />
Sol–<br />
lu -<br />
Fa<br />
œ œ<br />
J<br />
cie-li,<br />
œ œ<br />
lu -<br />
La–<br />
œ œ<br />
J<br />
Si@<br />
œ œ œ<br />
ta - to nel<br />
Do<br />
˙<br />
ia,<br />
œ<br />
J<br />
7<br />
La–<br />
Fa<br />
œ<br />
J<br />
ral -<br />
Sol–7<br />
6<br />
˙<br />
˙<br />
ia:<br />
Si@9<br />
˙<br />
œ œ<br />
8<br />
Si@<br />
grem -<br />
sor - to co-me˘a - ve- va pro - mes - so,<br />
Re– Do<br />
& b œ œ<br />
lu -<br />
Sol7/4<br />
& b ˙<br />
no -<br />
Re–<br />
3<br />
& b œ œ œ<br />
lu -<br />
ia,<br />
Fa /Sol /La Si@<br />
Do<br />
˙<br />
i,<br />
˙<br />
ia.<br />
Si@<br />
œ.<br />
7<br />
al -<br />
˙<br />
j<br />
œ<br />
Fa<br />
œ. j<br />
œ<br />
le -<br />
al -<br />
5<br />
œ œ œ<br />
œ œ<br />
le -<br />
Do<br />
˙<br />
˙<br />
bo,<br />
Do<br />
Fa4<br />
gra -<br />
3<br />
Fa<br />
œ. j<br />
œ<br />
è<br />
Sol–4<br />
Re–<br />
œ.<br />
al -<br />
œ œ œ<br />
ri -<br />
3 j<br />
œ<br />
le -<br />
Pre - ga˘il Si - gno-re<br />
per<br />
le -<br />
Si@6<br />
œ œ<br />
lu -<br />
Si@<br />
œ œ œ<br />
lu -<br />
Fa<br />
˙<br />
ia!<br />
Do<br />
ia,<br />
La–<br />
œ. j<br />
œ<br />
al -<br />
U<br />
œ<br />
le -
Regina dei cieli, rallégrati, alleluia:<br />
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,<br />
è risorto come aveva promesso, alleluia.<br />
Prega il Signore per noi,<br />
alleluia, alleluia, alleluia!
RN 184 T: Liturgia M: M. Piatti<br />
TESTO 5<br />
II testo <strong>di</strong> questa antifona racchiude i misteri fondamentali della vita della Madonna: il verbo<br />
« rallegrati » richiama il saluto dell'angelo, che le ha annunciato il concepimento, nel suo<br />
ventre, del figlio <strong>di</strong> Dio. L'attesa dell’umanità si concretizza nel modo più umano possibile;<br />
nell'attesa <strong>di</strong> una madre, nel suo « portare » il proprio figlio nel grembo per nove mesi. Maria<br />
è madre del Salvatore, <strong>di</strong> colui che, attraverso la sua morte e la resurrezione, regna e regnerà<br />
sopra tutte le nazioni. E? quin<strong>di</strong> Madre e Regina: regina nel regno dei cieli, regina della<br />
<strong>di</strong>mora <strong>di</strong> Dio, della patria alla quale aspiriamo. E’ nostra Signora, madre <strong>di</strong> tutti gli uomini,<br />
che raccoglie le nostre preghiere ed intercede per noi presso Dio.<br />
MUSICA La musica sembra uno sviluppo del « rallegrati »: interpreta la gioiosità intima che prelude a<br />
qualcosa <strong>di</strong> grande, e sì espande verso la fine nella certezza e nella fiducia <strong>di</strong> una presenza.<br />
QUANDO<br />
II canto può essere eseguito all'unisono da tutta l'assemblea, se affiatata e non troppo<br />
numerosa. Si presta anche bene a un <strong>di</strong>alogo fra solista (o coretto) che esegue l'antifona, e<br />
tutti che rispondono con l'alleluia.<br />
È in<strong>di</strong>cato naturalmente per tutte le celebrazioni <strong>di</strong> feste mariane ed in particolare per<br />
l'Assunzione.<br />
Nella liturgia eucaristica si può inserire come antifona d'ingresso.<br />
5 Cfr P.Silva in MeA 1980/31 p.16
VERGINE MADONNA 226<br />
& # 6<br />
# 4<br />
2 . œ œ œ œ<br />
& # # œ œ œ œ<br />
cie - lo,<br />
& # # œ œ œ œ<br />
rel - la e<br />
& # # œ œ œ<br />
tia - mo<br />
œ œ œ<br />
1. Ver - gi - ne, Ma - don - na del<br />
œ Œ<br />
œ œ œ œ<br />
no - stra so -<br />
œ œ œ<br />
Ma - dre,<br />
œ œ œ œ<br />
u - na can-zo -<br />
& # #<br />
œ œ œ œ œ œ œ<br />
per lo-da - re le<br />
& # # œ œ œ<br />
& # # œ<br />
RIT.<br />
per pre-gar -<br />
œ œ<br />
San-ta Ma -<br />
& # # ‰ j<br />
œ œ œ<br />
se nel - la<br />
& # # œ œ œ œ<br />
og-gi la tua<br />
& # # œ œ œ œ<br />
œ œ œ œ<br />
ti <strong>di</strong><br />
œ œ œ<br />
ri - a, il<br />
œ œ œ<br />
te - ne - bra<br />
œ œ œ<br />
Na - za - reth, rac -<br />
œ œ œ<br />
ne<br />
œ œ œ œ<br />
tu-e vir-tù,<br />
œ œ œ œ<br />
vol-ger-ti˘a noi.<br />
œ œ<br />
œ œ<br />
vi-so no-stro<br />
œ œ<br />
lu - ce s’ac - cen - de.<br />
œ œ œ œ<br />
con- ta - ci <strong>di</strong><br />
œ ‰ œ œ<br />
J<br />
ti can -<br />
œ Œ<br />
œ Œ<br />
œ Œ<br />
œ œ<br />
splen- de<br />
œ œ œ œ<br />
del no - stro<br />
‰ j<br />
œ œ œ<br />
Ma-ria <strong>di</strong><br />
œ œ<br />
Cri - sto;
& # # œ œ œ<br />
Ma - dre <strong>di</strong><br />
& # # œ œ<br />
ro - la,<br />
per continuare<br />
œ œ<br />
1. Vergine, Madonna del cielo,<br />
nostra sorella e Madre,<br />
ti cantiamo una canzone per lodare le tue virtù,<br />
per pregarti <strong>di</strong> volgerti a noi.<br />
Rit. Santa Maria, il viso nostro splende<br />
se nella tenebra del nostro oggi<br />
la tua luce s’accende.<br />
Maria <strong>di</strong> Nazareth, raccontaci <strong>di</strong> Cristo;<br />
Madre <strong>di</strong> Dio, che custo<strong>di</strong>vi la Parola,<br />
ridona al mondo la tua voce.<br />
2. Vergine del «sì» fiducioso,<br />
mostraci la gioia dell’offerta<br />
sull’altare della vita.<br />
Tu sei dono per l’umanità,<br />
sei modello per tutti noi.<br />
3. Vergine e giovane donna,<br />
scelta nel <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> Dio<br />
per ridare storia all’uomo;<br />
resa Madre non da uomini,<br />
ma dal dono dello Spirito.<br />
3<br />
œ œ œ<br />
Di - o, che cu- sto -<br />
‰ j<br />
œ œ œ<br />
ri - do- na˘al<br />
& # # j .<br />
˙ œ œ œ œ ˙<br />
ce.<br />
œ œ œ œ<br />
mon-do la tua<br />
per finire<br />
–ce.<br />
œ œ œ œ<br />
<strong>di</strong> - vi la Pa -<br />
U<br />
œ<br />
˙<br />
vo -<br />
Œ
4. Vergine dell’umile ascolto,<br />
docile alla mano <strong>di</strong> Dio<br />
sei vissuta nella preghiera;<br />
resa forte nella libertà<br />
dalla forte tua fedeltà.<br />
5. Vergine e sposa perfetta,<br />
sempre in comunione con lo Spirito,<br />
guarda a noi, ren<strong>di</strong>ci uniti;<br />
dona amore a tutti gli uomini,<br />
dona gioia ai nuovi apostoli.
RN 226 T: e M: GM Rossi<br />
TESTO 6 Questa canzone è de<strong>di</strong>cata alla “Regina degl Apostoli”: E’ una contemplazione della<br />
Vergine, Madonna del cielo, ma anche nostra sorella e madre: Sia i vocaboli che il periodare<br />
sono semplici, concreti, contemporanei. La fede cristiana, riguardo a Maria viene espressa<br />
dalle strofe in modo affermativo, mentre nel ritornello si tramuta in un’espressione <strong>di</strong><br />
supplica comunitaria (“ridona al mondo la tua voce!”).<br />
MUSICA Musicalmente, lo schema è quello classico della canzone (str. e rit.), come un breve prelu<strong>di</strong>o<br />
iniziale. Il canto è impiantato in SI min., ma con caratteristiche spesso più modali che tonali. La<br />
melo<strong>di</strong>a è semplice: va rilevato che il ritornello è del tutto alla portata <strong>di</strong> un'assemblea "me<strong>di</strong>a",<br />
non spingendosi oltre il DO # in alto. Il ritmo è lineare; occorre solo fare attenzione (per il<br />
solista) alla battuta 3, in cui si trova quasi un appoggiatura (FA # MI-FA # ), da eseguire con<br />
eleganza; per l'assemblea, occhio alla battuta 36 del ritornello, che include una terzina (SI-LA-<br />
FA #) e che non va precipitata. Tutti apprezzeranno l'armonia (accor<strong>di</strong>), fresca e moderna, che<br />
sostiene la linea melo<strong>di</strong>ca, Nell'esecuzione , bisogna rispettare il <strong>di</strong>namismo voluto dall'autore:<br />
ritornello cantato da tutti, in contrasto con la strofa - che va assolutamente riservata a uno, o<br />
anche due solisti -. Il "tutti" è il momento dell'adesione unanime alla figura della Vergine,<br />
"messaggera <strong>di</strong> Dio". Come accompagnamento, oltre all'organo, si può aggiungere una chitarra:<br />
arpeggi nella strofa, accor<strong>di</strong> sgranati nel ritornello. Attenti a non strascicare l'andatura; in<br />
particolare il solista cerchi <strong>di</strong> fraseggiare in modo fluido, come se dovesse "parlare".<br />
QUANDO<br />
È un canto <strong>di</strong> inizio, nei mesi, tempi o feste de<strong>di</strong>cati a Maria, e dovrebbe andar bene anche<br />
per un'assemblea "eterogenea".<br />
6 Cfr C. Pran<strong>di</strong>ni in MeA 1987/64 p.23 Marietti AL
RD T: F. Buttazzo M: D. Scarpa<br />
TESTO 7<br />
MUSICA<br />
QUANDO<br />
Decisamente apprezzabile poiché ricco <strong>di</strong> echi <strong>di</strong> parole bibliche. Il ritornello fa evidentemente<br />
riferimento all'episo<strong>di</strong>o della Pentecoste narrato in Atti 2,1-11: «Mentre... si trovavano tutti<br />
insieme... venne d'improvviso dal ciclo un rombo, come <strong>di</strong> vento... apparvero loro lingue come <strong>di</strong><br />
fuoco... ed essi cominciarono a parlare come lo Spirito davava loro potere <strong>di</strong> esprimersi». Il vento e il<br />
fuoco sono protagonisti anche nelle prime due strofe: la prima riprende il racconto della<br />
Pentecoste, che vede i <strong>di</strong>scepoli timorosi trasformarsi in coraggiosi testimoni del Risorto («Avrete<br />
forza dallo Spirito che scenderà su <strong>di</strong> voi e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della<br />
terra»: At 1,8); la seconda è <strong>di</strong> comprensione meno imme<strong>di</strong>ata, così come meno palese è il<br />
riferimento alla Scrittura (ad esempio: «le certezze che ingannano la vita» sono forse le "false<br />
certezze" che propone il mondo?). Nelle strofe terza e quarta gli agganci biblici tornano invece a essere<br />
evidenti: lo Spirito è invocato come fonte <strong>di</strong> coraggio e forza (cfr. At 1,8 e 2,1-11), <strong>di</strong> amore, <strong>di</strong><br />
pace e <strong>di</strong> unità (cfr. Gai 5,22).<br />
Il canto non presenta particolari <strong>di</strong>fficoltà né ritmiche né melo<strong>di</strong>che. Pur nella sua semplicità,<br />
può offrire però <strong>di</strong>verse modalità esecutive in base al contesto celebrativo e ai mezzi a <strong>di</strong>sposizione.<br />
La maniera più semplice può prevedere 1''unisono nella strofa (prendendo te parti <strong>di</strong> soprani e tenori) e<br />
“giocare" sull'ingresso dei vari attori; il ritornello, invece, può essere eseguito da tutti, mentre due solisti<br />
potranno alternarsi nella strofa e unirsi nell’invocazione che rilancia il ritornello. (Quando il canto è<br />
eseguito nella celebrazione della Confermazione, data la tessitura piuttosto comoda, potrebbero<br />
essere gli stessi cresiman<strong>di</strong> - convenientemente preparati! a proporre le strofe). Una seconda e più<br />
sonora maniera potrebbe essere l'esecuzione polifonica con l'armonizzazione proposta a quattro voci,<br />
che non presenta gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà (si ponga attenzione però al pianissimo del vocalizzo e al<br />
suggerimento <strong>di</strong> cantare le strofe a mezza voce: data la tessitura piuttosto grave e l'unisono in cui, in alcuni<br />
punti, le voci si incontrano, si rischierebbe altrimenti <strong>di</strong> appesantire l'intero canto).<br />
Certamente durante la celebrazione della Confermazione <strong>di</strong> ragazzi e adulti, ma anche all'interno<br />
<strong>di</strong> veglie <strong>di</strong> preghiera per la festa <strong>di</strong> Pentecoste o per invocare lo Spirito all'inizio <strong>di</strong> riunioni<br />
spirituali; non <strong>di</strong>mentichiamo infatti che lo Spirito Santo è presente e agisce in ogni celebrazione<br />
sacramentale: non è dunque un peccato invocarlo... per ricordarcelo!<br />
7 Cfr.G.Scattolin MeA 2008/139 p. <strong>28</strong> EDB
!<br />
!!!!!"#$%&!'()!&*!<br />
!!!!!+,-./!0&!<br />
PASQUA
& # (q = 88-96)<br />
Re<br />
#<br />
œ œ<br />
Al - le - lu -<br />
& # # w<br />
ALLELUIA 9<br />
œ œ œ œ œ<br />
S (Versetto)<br />
Re Fa#–<br />
w w<br />
ia, al- le -<br />
Si–<br />
œ œ œ œ œ<br />
lu -<br />
Sol<br />
Mi–7<br />
La<br />
œ ˙<br />
ia, al- le - lu - ia!<br />
Sol/Si Sol La<br />
œ w w œ œ w<br />
Alleluia, alleluia, alleluia!
& b b 4 3 œ<br />
& bb W<br />
ALLELUIA (O filii et filiae) 10<br />
(m . = 50-56)<br />
Sol–<br />
˙ œ<br />
Do–/Sol<br />
œ œ œ<br />
Sol–<br />
œ œ œ<br />
Fa6<br />
˙ œ<br />
Do–<br />
œ ˙<br />
Al - le - lu - ia, al - le - lu - ia, al - le-lu<br />
- ia!<br />
S (Versetto)<br />
/Si@ Fa6<br />
œ œ œ w<br />
Alleluia, alleluia, alleluia!<br />
Fa<br />
Sol–<br />
˙<br />
Re– 7/Do Sol–/Si@<br />
W œ œ œ w
ALLELUIA! CANTATE AL SIGNORE 12<br />
& # 8 6 œ<br />
& #<br />
(q . = 60-66)<br />
Do<br />
& # 8 9<br />
Al -<br />
j<br />
œ œ<br />
j<br />
œ<br />
Sol /Fa# Mi– (Re) Sol<br />
œ œ œ œ.<br />
lu -<br />
& # j<br />
œ<br />
Do6/Mi<br />
œ<br />
S1. Can -<br />
Sol<br />
Re<br />
ia!<br />
al -<br />
Mi–<br />
le -<br />
œ<br />
Al -<br />
œ. œ œ œ.<br />
lu -<br />
j<br />
œ œ<br />
Re<br />
ia,<br />
Rit. Alleluia, alleluia!<br />
Alleluia, alleluia!<br />
j<br />
œ<br />
Sol /Fa# Mi– (Re)<br />
Do6/Mi (Re)<br />
1. Cantate al Signore con gioia:<br />
gran<strong>di</strong> pro<strong>di</strong>gi ha compiuto.<br />
Cantatelo in tutta la terra!<br />
2. Agli occhi <strong>di</strong> tutte le genti<br />
mostra la sua grandezza,<br />
rivela la sua giustizia!<br />
œ<br />
al -<br />
Sol<br />
Sol<br />
j<br />
œ œ. œ œ<br />
le -<br />
œ. œ œ œ.<br />
le - lu -<br />
Do (La–) Re Sol<br />
j<br />
œ œ. œ œ œ œ œ<br />
(Re) Sol<br />
le -<br />
Re/Mi<br />
lu - - -<br />
œ. œ œ œ œ œ<br />
ta - te˘al Si - gno - re con<br />
& # œ. œ œ œ œ œ<br />
gran - <strong>di</strong> pro - <strong>di</strong> -<br />
La–<br />
Do/Sol<br />
gi˘ha com -<br />
& # œ. œ œ œ œ œ<br />
ta -<br />
La<br />
te-lo˘in tut -<br />
ta la<br />
Re<br />
ia,<br />
8<br />
9<br />
8<br />
6 U FINE j<br />
œ.<br />
œ ‰<br />
Mi–<br />
Sol7+<br />
ia!<br />
œ . œ .<br />
gio -<br />
œ. œ<br />
piu -<br />
Re2<br />
La–7/Mi<br />
Sol<br />
to.<br />
ia:<br />
œ . œ.<br />
ter -<br />
3<br />
ra!<br />
œ<br />
J<br />
Can -<br />
D.C.
& #<br />
& #<br />
& #<br />
Sol<br />
Fa6<br />
œ œ œ nœ œ œ<br />
4. Tu - a, o Pa - dre˘è la<br />
Do<br />
La–<br />
œ œ œ œ œ œ<br />
Tut - ta la ter - ra ti˘ac - cla -<br />
Sol<br />
œ. œ œ œ œ œ<br />
Spi- ri-to<br />
3. Fedele è il Signore per sempre,<br />
buono e misericor<strong>di</strong>oso:<br />
lodate il suo nome in eterno!<br />
Do–9<br />
Fa7<br />
è ri -<br />
Si@<br />
bœ œ œ<br />
J<br />
4. Tua, o Padre è la gloria!<br />
Tutta la terra ti acclama!<br />
Del tuo Spirito è ricolmo<br />
l’universo!<br />
5. Forte è la tua Parola,<br />
penetra come una spada:<br />
ci trasformerà e vivremo<br />
nella luce!<br />
6. Tu sei il Cristo Signore,<br />
nato fra noi da Maria:<br />
fai rinascere alla vita<br />
con Dio!<br />
Sol<br />
7. Oggi il Signore è risorto,<br />
ora il Cristo è vivente:<br />
chi soffrì con lui ora canta<br />
alleluia!<br />
8. Venga lo Spirito Santo,<br />
fuoco che accende la terra:<br />
nella libertà si rinnovi<br />
il nostro cuore!<br />
j<br />
œ œ<br />
glo- ria!<br />
7<br />
Œ ‰<br />
j<br />
œ a œ ‰ Re<br />
œ œ<br />
Mi@6<br />
ma! Del tuo<br />
5/Sol j<br />
œ œ<br />
J<br />
Re4<br />
col-mo<br />
l’u - ni - ver-so!<br />
3 7<br />
œ œ.<br />
D.C.
ALLELUIA! SIGNORE, 14<br />
TU HAI PAROLE DI VITA ETERNA<br />
(q = 96-100)<br />
& b 4 3 œ œ œ œ œ œ<br />
Al - le -<br />
Si@ Do<br />
& b ˙ œ<br />
lu - - -<br />
Re–<br />
lu -<br />
œ œ œ ˙<br />
Fa<br />
& b œ œ œ œ<br />
& b W<br />
œ œ œ œ<br />
/Fa<br />
œ œ œ œ<br />
Fa<br />
(Do)<br />
ia, al - le -<br />
œ œ œ œ<br />
lu -<br />
Alleluia, alleluia, alleluia!<br />
Signore, tu hai parole <strong>di</strong> vita eterna. Alleluia!<br />
Fa<br />
œ œ œ œ<br />
ia, al- le -<br />
˙ œ œ œ œ œ œ<br />
ia!<br />
lu - ia, al - le -<br />
(Versetto)<br />
Re–<br />
S (Signore, tu hai parole <strong>di</strong> vita<br />
Re–<br />
/Fa<br />
œ œ œ œ<br />
(Do)<br />
Al - le - lu - ia, al - le -<br />
Si@ La–<br />
Re–<br />
˙ œ<br />
˙<br />
œ œ œ U FINE<br />
˙<br />
lu - - -<br />
œ W<br />
W œ W<br />
& b œ œ œ œ œ<br />
Al - le - lu - - - -<br />
ia!<br />
$ - terna.)<br />
La<br />
˙<br />
ia!
Fa Mi@<br />
& b b C ˙ ˙<br />
˙ ˙<br />
A -<br />
AMEN! (Cerino) 31<br />
Si@/Re<br />
w<br />
w<br />
men,<br />
Amen, amen!<br />
Mi@ 6<br />
˙ ˙<br />
˙<br />
˙<br />
a -<br />
Si@<br />
w<br />
w<br />
men!
CANONE (m = 72-80)<br />
A<br />
& b 2 4<br />
Do<br />
˙<br />
A -<br />
AMEN! (Rossi) 32<br />
˙ œ œ ˙ U<br />
Fa<br />
Sol–7 Do7(<br />
)<br />
Re–7<br />
men,<br />
& b œ œ ˙ U ( )<br />
œ œ ˙<br />
a - men!<br />
a -<br />
C<br />
˙<br />
˙<br />
men!<br />
B<br />
˙<br />
˙<br />
A - men,<br />
˙ œ œ ˙ U ( )<br />
˙ œ œ ˙<br />
A - men, a - men!<br />
Amen, amen! Amen, amen! Amen, amen!
Pro manuscripto<br />
a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano e del Centro Servizi Generali dell’Arci<strong>di</strong>ocesi<br />
Via Altabella, 6 - 40126 <strong>Bologna</strong> - tel. 051.64.80.777 - fax 051.235.207<br />
posta elettronica: csg2@bologna.chiesacattolica.it<br />
56



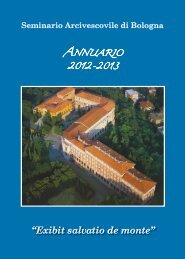

![Convivenze (o coppie di fatto o unioni libere) [.pdf] - Chiesa di Bologna](https://img.yumpu.com/16125635/1/184x260/convivenze-o-coppie-di-fatto-o-unioni-libere-pdf-chiesa-di-bologna.jpg?quality=85)


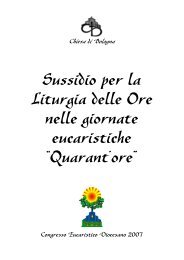
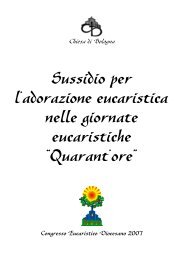

![Percorso fidanzati a 16 incontri [.pdf] - Chiesa di Bologna](https://img.yumpu.com/15272004/1/190x135/percorso-fidanzati-a-16-incontri-pdf-chiesa-di-bologna.jpg?quality=85)