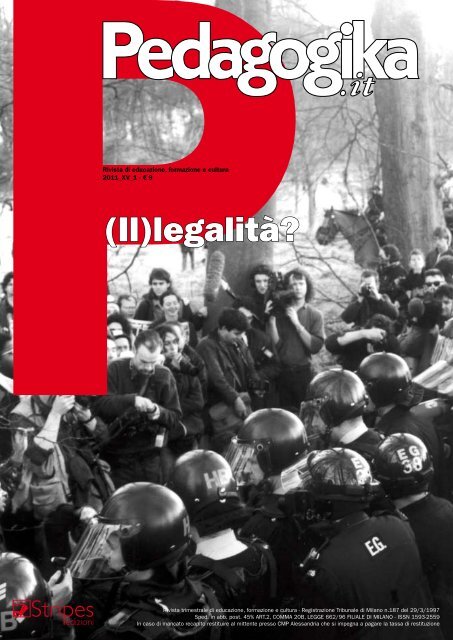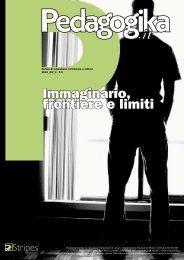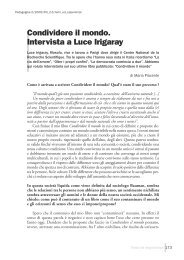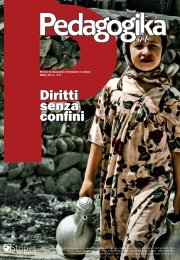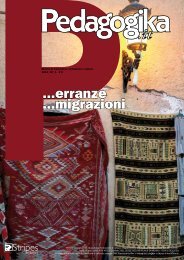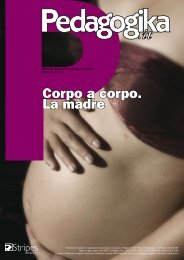(Il)legalità? - Pedagogika
(Il)legalità? - Pedagogika
(Il)legalità? - Pedagogika
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Rivista di educazione, formazione e cultura<br />
2011_XV_1 - € 9<br />
(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?<br />
Rivista trimestrale di educazione, formazione e cultura - Registrazione Tribunale di Milano n.187 del 29/3/1997<br />
Sped. in abb. post. 45% ART.2, COMMA 20B, LEGGE 662/96 FILIALE DI MILANO - ISSN 1593-2559<br />
In caso di mancato recapito restituire al mittente presso CMP Alessandria che si impegna a pagare la tassa di restituzione
Rivista di educazione, formazione e cultura<br />
anno XV, n° 1<br />
Gennaio, Febbraio, Marzo 2011
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/<br />
2<br />
Rivista di educazione, formazione e cultura<br />
esperienze - sperimentazioni - informazione - provocazioni<br />
Anno XV, n° 1 – Gennaio/Febbraio/Marzo 2010<br />
Direttrice responsabile<br />
Maria Piacente<br />
maria.piacente@pedagogia.it<br />
Redazione<br />
Fabio Degani, Marco Taddei, Mario Conti,<br />
Dafne Guida Conti, Nicoletta Re Cecconi, Carlo<br />
Ventrella, Mariarosaria Monaco, Liliana Leotta,<br />
Cristiana La Capria, Laura Conti, Coordinamento<br />
pedagogico Coop. Stripes.<br />
Comitato scientifico<br />
Silvia Vegetti Finzi, Fulvio Scaparro, Duccio Demetrio,<br />
Don Gino Rigoldi, Eugenio Rossi, Alfio Lucchini, Pino<br />
Centomani, Ambrogio Cozzi, Salvatore Guida, Pietro<br />
Modini, Antonio Erbetta, Angela Nava Mambretti,<br />
Anna Rezzara, Lea Melandri, Angelo Villa<br />
Hanno collaborato<br />
Roberta Sala, Cesare Moreno, Andrea Zummo,<br />
Giovanni Impastato, Franco Vassia, Salvatore Licata,<br />
Fabio Lucchini, Vincenzo D’Ambrosio, Alessandra<br />
Callegari, Cristina Busi, Giulia Depero, Isabella<br />
Grottola, Marisa Vecchi, Piero Abbondati e Roberta<br />
Ranalli, Grazia Cecchini, Fabio Dovigo, Alberto Dionigi,<br />
Dario Costantino, Antonella Cagnolati, Giulia Rossetti<br />
Edito da<br />
Stripes Coop. Sociale Onlus<br />
www.stripes.it<br />
Direzione e Redazione<br />
Via Papa Giovanni XXIII n.2 - 20017 Rho (MI) -<br />
Tel. 02/9316667 - Fax 02/93507057<br />
e-mail: pedagogika@pedagogia.it<br />
Sito web: www.pedagogia.it<br />
FaceBook: <strong>Pedagogika</strong> Rivista<br />
Responsabile testata on-line<br />
Igor Guida - igor.guida@pedagogia.it<br />
Progetto grafico/Art direction<br />
Raul Jannone - raul.jannone@studioatre.it<br />
Promozione e diffusione<br />
Fabio Degani, Federica Rivolta<br />
Pubblicità<br />
Clara Bonfante, Daniela Colombo<br />
Registrazione Tribunale di Milano n.187 del<br />
29/3/1997 - Sped. in abb. post. 45%<br />
ART. 2, COMMA 20B LEGGE 662/96 FILIALE DI<br />
MILANO - issn 1593-2559<br />
Stampa:<br />
Impressionigrafiche S.c.s.<br />
Acquiterme (Al) - Tel. 0144-313350<br />
Distribuzione in libreria:<br />
Joo Distribuzione - Via F. Argelati, 35 - Milano<br />
Fotografie: stock.xchng<br />
é possibile proporre propri contributi inviandoli<br />
all’indirizzo e-mail articoli@pedagogia.it<br />
I testi pervenuti sono soggetti all’insindacabile giudizio<br />
della Direzione e del Comitato di redazione e<br />
in ogni caso non saranno restituiti agli autori<br />
Questo periodico è iscritto all’Unione<br />
Stampa Periodica Italiana
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/<br />
s o m m a r i o<br />
5 Editoriale<br />
Maria Piacente<br />
../dossier/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?<br />
8 Introduzione<br />
10 Legalità, legittimità, cultura<br />
Roberta Sala<br />
18 Tra <strong>legalità</strong> ed <strong>Il</strong><strong>legalità</strong>.<br />
Intervista a Cesare Moreno<br />
Salvatore Guida<br />
27 <strong>Il</strong><strong>legalità</strong> e <strong>legalità</strong>: confine<br />
labile, scommessa cruciale<br />
Andrea Zummo<br />
33 Resistere a Mafiopoli<br />
Giovanni Impastato e Franco<br />
Vassia<br />
44 La Rabbia di Esistere<br />
Salvatore Licata<br />
55 Terrorismo, il confine tra<br />
motivazione e vulnerabilità<br />
Fabio Lucchini<br />
../temi ed esperienze<br />
60 Una nuova educazione per<br />
superare la mente patriarcale<br />
Vincenzo D’Ambrosio<br />
70 SAT Educazione, un modello<br />
culturale per gli insegnanti.<br />
Intervista a Grazia Cecchini<br />
Alessandra Callegari<br />
74 Uno spazio per la mediazione<br />
delle controversie<br />
Fabio Dovigo (Traduz. A fronte)<br />
87 La funzione psicopedagogica<br />
e terapeutica del clown<br />
Alberto Dionigi<br />
95 Sport “senza frontiere”: note<br />
pedagogiche e pratiche educative<br />
Dario Costantino<br />
../cultura<br />
104 A due voci<br />
Angelo Villa, Ambrogio Cozzi<br />
108 Scelti per voi<br />
Libri Ambrogio Cozzi (a cura di)<br />
Musica Angelo Villa (a cura di)<br />
Cinema Cristiana La Capria (a cura di)<br />
116 Arrivati in redazione<br />
../In_breve<br />
119 In ricordo di Antonio Erbetta<br />
../In_vista<br />
120 Rovereto Musei per le scuole<br />
3
ABBONARSI è IMPORTANTE<br />
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/<br />
Piano editoriale 2011<br />
(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?<br />
<strong>Il</strong> viaggio. Realtà e metafora<br />
Fratelli d'Italia?<br />
Educare alla creatività<br />
Rivista di educazione, formazione e cultura<br />
Numero di c/c postale 36094233<br />
intestato a Stripes Coop. Sociale ONLUS<br />
via Papa Giovanni XXIII, 2 - 20017 Rho (Mi)<br />
L’abbonamento annuale per 4 numeri è:<br />
€ 30 privati<br />
€ 60 Enti e Associazioni<br />
€ 90 Sostenitori<br />
Insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento inviare il coupon presente all’interno della rivista,<br />
una volta compilatolo, al n° di fax 02-93507057 o per posta ordinaria al seguente indirizzo:<br />
Redazione <strong>Pedagogika</strong>.it, via Papa Giovanni XXIII, 2 - 20017 Rho (Mi)<br />
<strong>Pedagogika</strong>.it è disponibile presso tutte le librerie Feltrinelli d’Italia e in altre librerie il cui elenco<br />
è consultabile sul sito www.pedagogia.it<br />
Per ordini e abbonamenti on line: www.pedagogia.it<br />
4<br />
Per informazioni: Redazione <strong>Pedagogika</strong>.it Tel. 02/93.16.667 - Fax 02/93.50.70.57 - www.pedagogia.it - pedagogika@pedagogia.it
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/editoriale<br />
La forza di Antigone<br />
L'essere umano, l'uomo e la donna fin dalla loro nascita devono fare i conti<br />
con le norme e le leggi che consentono alla vita stessa la sua sopravvivenza. In nuce<br />
ciascuno e ciascuna di noi è abitato da norme e leggi umane e divine – in un altro<br />
tempo il divino è stato parte inscindibilmente integrante della vita umana- che<br />
dovrebbero permetterci di riconoscere in coscienza il bene dal male, la giustizia<br />
dall'ingiustizia regolando così il nostro comportamento etico e sociale. E nello<br />
scrivere la parola “divino” vorrei, per non perdermi, stare ancorata al pensiero di<br />
Maria Zambrano che è stata grande filosofa, ma anche grande politica impegnata a<br />
fianco delle forze repubblicane per la liberazione della Spagna e per questo esiliata<br />
per quarant'anni.<br />
<strong>Il</strong> rispetto delle norme e delle leggi dovrebbe per così dire scaturire dal nostro<br />
essere più profondo, dalla giustizia, dalla verità, dalla bellezza, sentimenti così<br />
radicati e forti da respingere la tentazione sempre presente di fare, praticare, far<br />
praticare solo il proprio tornaconto personale. Un tornaconto personale che nulla<br />
ha a che vedere con il riconoscimento di se stessi in quanto soggetti bisognosi di<br />
rispecchiarsi nell'altro, di dare un senso alla propria vita sia nella dimensione pubblica<br />
sia in quella privata.<br />
Al centro del nostro divenire assume estrema importanza l'humus e la cultura<br />
che ci circonda e ci forgia: uomini e donne in relazione gli uni con gli altri facenti<br />
parte della società, uniti da interessi generali e progetti comuni con la necessità<br />
intrinseca alla nostra stessa specie di essere visti e riconosciuti .<br />
In quanto facenti parte della polis diventa naturale per ognuno di noi partecipare<br />
e seguire quello che accade nel nostro Paese, legittimando o delegittimando<br />
quanto avviene dentro e fuori dalle Istituzioni. Ma siamo capaci di orientarci, di<br />
dare ascolto al nostro senso critico ? Siamo in grado di capire, di leggere e interlegere<br />
le norme e le leggi, le regole del vivere civile?<br />
Etologi, biologi e antropologi – pensiamo a come in questo particolare periodo<br />
della nostra vita pubblica la questione antropologica sia divenuta cruciale - sono<br />
ormai convinti che la società nella quale viviamo è sempre più influenzata dalla<br />
società che l'uomo riesce a creare: se è fondata su una cultura della pace emergerà<br />
l'attitudine alla solidarietà e alla pace; se è fondata sulla guerra e sull'odio emergerà<br />
l'attitudine alla guerra e alla violenza organizzata; se è fondata sul disimpegno<br />
politico, sull'avidità, sul consumismo e sul proprio tornaconto personale, non ne<br />
potrà scaturire nulla di buono. Si tratta quindi di una questione culturale e non<br />
naturale.<br />
5
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/editoriale<br />
6<br />
Tutto ciò emerge, vistosamente, anche dai contributi pubblicati all'interno di<br />
questo dossier: nello spasmodico desiderio di fare parte di qualcosa, di lasciare un<br />
segno in questo mondo, possiamo vedere come chi non “conta” proprio niente,<br />
perché nessuno si è mai curato, preoccupato, di lui/lei, pur di esistere riemerge,<br />
come un fiume carsico e trova luogo all'interno di organizzazioni illegali, distruttive,<br />
mafiose. Risucchiato dagli inferi del consumismo e del godimento, sordo ad<br />
ogni richiamo , senza alcuna forma di pensiero critico si dispone ad infittire le orde<br />
dell'il<strong>legalità</strong> e della supponenza. Oppure cede ad un esasperato qualunquismo,<br />
non meno letale della supponenza che porta a dire a chi è più fragile, e meno<br />
costruito, che non si può fare niente, tanto... E' così che chi ci governa, alla povera<br />
gente che si trova di fronte alle catastrofi annunciate e alle ingiustizie patite, fa<br />
dire: “...è cosa 'e niente!”. No! Non è cosa da niente! Non dobbiamo mai lasciare<br />
perdere i nostri diritti, né ciò che ci è dovuto. Nessuno deve elemosinare ciò che<br />
gli è dovuto, nessuno. Così il pensiero critico ci può portare ad assumere, ad intraprendere,<br />
strade che possono sembrare illegali; tanti sono gli esempi e le storie che,<br />
a partire dall'antica Grecia, passando per la storia contemporanea ed alle vicende<br />
a noi più vicine – pensiamo a quanti nel nostro Paese, nell'epoca della dittatura si<br />
sono appellati alla pietas per soccorrere i perseguitati - ci fanno sperare nella giustizia<br />
e nel futuro, rendendo ancora attuale: ”La tua legge, Signore, scritta nel cuore<br />
degli uomini” di S. Agostino<br />
Oggi nel nostro Paese il qualunquismo e l'il<strong>legalità</strong> paiono esser diventate le<br />
leggi di chi, pur di mantenere il potere, il potere di perpetrare l'irrisione degli altri<br />
e perseguire il proprio narcisismo, diventa capace di minacciare con il “Muoia<br />
Sansone, con tutti i filistei”!<br />
Ma molti e molte di noi, moltissimi conoscono questi giochi di potere ed alla<br />
resistenza sono forgiati per eredità e per sapere. Tante belle politiche abbiamo visto<br />
in questi giorni in giro per le strade. E auspichiamo che, grazie alla sensibilità, alla<br />
cultura, all'esperienza ed alla bellezza, il qualunquismo, la volgarità, il male e gli<br />
scempi non passeranno, non diventeranno la norma.<br />
Come diceva Peppino Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si<br />
fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza<br />
di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni<br />
speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le<br />
piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima; ed<br />
ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre.<br />
È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e<br />
donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi<br />
la curiosità e lo stupore”.<br />
Maria Piacente
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/<br />
8<br />
(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?<br />
Un recente documento, presentato da Telmo Pievani e Alberto Martinelli, mette<br />
in discussione, proponendone un aggiornamento, la Carta di Siviglia del 1989,<br />
allorché un team di scienziati e studiosi si era cimentato a dimostrare come la<br />
guerra non sia un bisogno, una necessità insita nella natura umana. <strong>Il</strong> documento<br />
va oltre tale ottimistica e buonistica visione sostenendo che: “.... E' ora di smettere<br />
di cercare una spiegazione biologica o genetica alla guerra e anche di pensare che<br />
l'uomo sia naturalmente buono... la guerra e la pace stanno, entrambe, nelle possibilità<br />
dell'uomo..”. Queste considerazioni saranno sottoposte agli studiosi che interverranno<br />
alla conferenza mondiale sulla pace e saranno oggetto di una proposta<br />
nelle scuole italiane a partire dal concetto che “le stesse specie che hanno inventato<br />
la guerra sono capaci di inventare la pace”.<br />
Riteniamo che lo stesso approccio, che vede le antinomie guerra /pace, amore/<br />
odio come invenzioni culturali e sociali possa essere esteso agevolmente anche ai<br />
concetti di <strong>legalità</strong> e il<strong>legalità</strong>: si tratta di atteggiamenti culturali, legati alle evenienze<br />
storiche ed alla distribuzione geografica, non rispondono a niente di predeterminato<br />
e possono essere, per ciò stesso, soggetti ad azioni correttive, ad azioni ed intenzionalità<br />
politiche, a valutazioni etiche, a interpretazioni e scelte pedagogiche.<br />
Nell'affrontare questi temi ci siamo chiesti da dove traggono forza e credibilità<br />
le leggi; come nasce e si rafforza il conecetto di <strong>legalità</strong>; quali sono le condizioni<br />
ceh favoriscono il consolidamento di diffusi comportamenti di il<strong>legalità</strong>, devianza,<br />
criminalità più o meno pubblica, l'indebolimento dell'autorevolezza della figura<br />
del padre. Ci siamo chiesti se esistono codici, strutturati o meno, concepiti per<br />
trasmettere atteggiamenti di indifferenza o di impermeabilità ai concetti di legge,<br />
legittimità e <strong>legalità</strong>; e se è possibile perseguire coerenti strategie culturali e pedagogiche<br />
per contrastare quella sorta di relativismo estico che molti percepiscono<br />
come il terreno di coltura di un più ampio processo di degrado ed imbarbarimento<br />
della vita sociale che soprattutto negli ultimi anni sta investendo la dimensione<br />
pubblica.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/<br />
(<strong>Il</strong>)legality?<br />
A recent document, proposed by Telmo Pievani and Alberto Martinelli, debates,<br />
offering a revision, the Seville Statement on violence of 1989, when a team<br />
of scientists and scholars ventured on demonstrating that war is not an innate<br />
need, an innate necessity in human nature. The document goes beyond this optimistic<br />
vision maintaining that: “…It’s time to stop looking for a biological or genetic<br />
explanation of war and thinking that man is naturally good…war and peace<br />
are both in the abilities of man…”.<br />
These reflections are going to be submitted to scholars who will attend the<br />
world conference on peace and they are going to be the object of a proposal in Italian<br />
schools whose basic concept is that “the same species that have invented war<br />
are able to invent peace.”<br />
We believe the same approach, which regard war/peace, love/hate antinomies as<br />
cultural and social inventions, could be easily extended to concept of legality and<br />
illegality too: they are cultural attitudes bound to historical events and geographical<br />
distribution, they do not respond to nothing predetermined and, therefore,<br />
they could be subjected to corrective actions, political actions and intentions, ethical<br />
valuations, pedagogical interpretations and choices.<br />
Dealing with these topics we wonder where laws draw their force; how concept<br />
of legality originates and grows stronger; what are the conditions that promote<br />
the consolidation of widespread behaviors of illegality, deviance and more or less<br />
organized crime; what place takes the weakening of father figure authoritativeness<br />
in rarefying of public ethics. And, moreover, whether there are structured or unstructured<br />
codes conceived to transfer behaviors of indifference or impermeability<br />
to the concepts of law, lawfulness, and legality; whether it is possible to pursue<br />
consistent cultural and pedagogical strategies to contrast that sort of ethic relativism,<br />
perceived by many as the fertile source of a wider process of social life decay<br />
and barbarization that, especially in the last years, is assailing public dimension.<br />
Dossier 9
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/<br />
10<br />
Legalità, legittimità, cultura<br />
‘Giusto’, preciso ancora, non significa necessariamente condiviso: non è detto<br />
che una legge sia giusta solo perché essa è esito di una procedura legislativa corretta;<br />
ammettere che una legge possa essere ingiusta nonostante la giustezza<br />
procedurale con cui è stata posta significa considerare la ‘giustizia’ delle leggi<br />
come qualcosa di superiore e indipendente dalla loro validità.<br />
Roberta Sala*<br />
La domanda che qui mi pongo è se le nozioni di <strong>legalità</strong> e di il<strong>legalità</strong> siano<br />
contestualmente determinate o se, piuttosto, non indichino standard universali. Si<br />
tratta di una domanda rilevante: bisogna capire se, parlando di <strong>legalità</strong> e di il<strong>legalità</strong>,<br />
disponiamo di riferimenti indipendenti per regolamentare il vivere associato, ovvero<br />
se tali riferimenti siano contingenti, validi cioè solo relativamente al contesto del loro<br />
utilizzo. Una cosa è infatti dire che una prassi è giusta o sbagliata, disponendo di<br />
un’idea non controversa di giusto e sbagliato, altra cosa è invece dire che una prassi<br />
è giusta o sbagliata in quel determinato momento, per quel determinato gruppo<br />
di persone o in certe condizioni. Sosterrò, in questo mio intervento, l’esistenza di<br />
standard universali anche se mutevoli e molteplici possono essere le forme della loro<br />
applicazione. Questa affermazione risulterà chiara al termine della mia riflessione.<br />
Intendo procedere come segue: a) comincio con il chiarire il significato di <strong>legalità</strong><br />
mettendo in luce la differenza di <strong>legalità</strong> e legittimità; mi avvarrò dell’esempio<br />
socratico per spiegare meglio questa differenza; procedo con il dire perché il rinvio<br />
alla legittimità delle leggi agisca da istanza critica nei confronti dell’attualità, cioè<br />
nei confronti delle consuetudini che, nel tempo presente, sembrano invalse e non<br />
controverse, e nei confronti di quei meccanismi di comportamento che, per il fatto<br />
di essere tacitamente osservati dai più e nella maggior parte delle situazioni, rivendicano<br />
per ciò stesso autorità; dirò perché il rinvio alla legittimità assuma il significato<br />
di un gesto filosofico, cioè di un atteggiamento critico che non esita a sottoporre<br />
al vaglio della ragione automatismi e convenzioni; invocare la legittimità delle leggi<br />
non significa andare contro il sistema giuridico ma, proprio al contrario, significa<br />
sospendere l’obbedienza nei confronti di quelle singole leggi che, alla luce degli<br />
standard di legittimità cui si riferisce il sistema giuridico nel suo insieme, si rivelino<br />
ingiuste; b) procedo con un riferimento alle culture: mi interessa in questo discorso<br />
capire se sia una ragione di giustizia quella che spinge i portatori di una tradizione<br />
culturale a contestare le leggi di uno stato liberale e democratico o se, diversamente,<br />
si tratti di un’istanza non ricevibile dall’ordinamento in quanto illegittima. Si<br />
potrà decidere di accogliere un’istanza culturale, accomodandola all’interno di un<br />
sistema legislativo, ovvero di respingerla, motivate entrambe le alternative da una<br />
medesima ragione di giustizia.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />
Mi concentro ora sulla differenza tra <strong>legalità</strong> e legittimità. Propongo di partire<br />
dalla imperitura lezione socratica così come Platone la narra nell’Apologia di Socrate.<br />
Comincio con il ricordare come la condanna a morte di Socrate fu decisa a<br />
seguito di un processo che lo vide imputato di empietà e di corruzione dei giovani.<br />
Ciò che di fatto Socrate fece, tale da attirargli il biasimo dei suoi concittadini,<br />
fu invitare i suoi interlocutori – chiunque essi fossero - all’esercizio della critica,<br />
all’assunzione di un atteggiamento di distacco dal sapere convenzionale, da quel<br />
plesso di tradizioni e abitudini fino ad allora incontroverso, onde sottoporlo al<br />
vaglio della razionalità. La vera guida di Socrate è appunto la ragione, il logos: non<br />
c’è alcuna condotta né alcuna legge che non possa essere sottoposta al giudizio della<br />
ragione anzi, potremmo dire, della filosofia. Non c’è nulla nell’esperienza umana<br />
cui la filosofia non si possa liberamente applicare 1 . Per via di queste e altre simili<br />
affermazioni Socrate viene accusato di empietà: è per i suoi concittadini empio, in<br />
quanto ha mostrato di non voler accettare passivamente l’ordine costituito, che è<br />
ordine naturale e divino insieme poiché naturali e divine insieme sono le leggi su<br />
cui si regge. L’accusa di empietà si affianca ad un’altra accusa, quella di corruzione<br />
dei giovani. Infatti, la libertà di filosofare, cioè di ricercare senza subire interferenze<br />
facendo uso soltanto della propria intelligenza e del proprio senso critico, è oggetto<br />
dell’insegnamento socratico; sono soprattutto i giovani ad avvicinarsi a Socrate e<br />
ad ascoltare le sue parole, essendo i più disposti ad apprendere, a farsi interpellare<br />
sul senso dell’esistenza, del vivere insieme, sul senso della politica e delle leggi. A<br />
loro Socrate si rivolge in particolare, insegnando a seguire il ragionamento fino<br />
in fondo, fino alle sue conseguenze più estreme, fino a respingere, se necessario,<br />
il sapere da sempre considerato verità senza che nessuno lo abbia mai indagato<br />
veramente. Ciò che ai giovani Socrate mostra è, in sintesi, l’esercizio della libertà<br />
del giudizio, l’autonomia del ragionamento ‘senza sponde’. Non è strano allora<br />
che i concittadini di Socrate, e in specie i più potenti, provassero preoccupazione:<br />
proprio i giovani, educati all’obbedienza, potevano ribellarsi, rifiutando ogni deferenza<br />
nei confronti di regole e convenzioni. Socrate è allora giudicato e condannato<br />
per empietà e corruzione; in realtà la sua colpa è mostrarsi del tutto indipendente,<br />
non deferente né sottomesso a potere e gerarchie.<br />
Mi sono soffermata sul caso di Socrate perché esso presenta spunti interessanti<br />
per comprendere in che senso la sua sfida sia una battaglia per la giustizia. Socrate<br />
invita i suoi ascoltatori a ripensare il senso del fare politica: bisogna – è questo in<br />
sostanza l’insegnamento di Socrate – accantonare gli interessi particolari e ridisegnare<br />
i confini stessi dell’agire politico, rinvigorire le regole costituzionali, gli<br />
standard immutabili della giustizia. La città cui Socrate si rivolge è una Atene resa<br />
fragile dalla guerra del Peloponneso, una Atene indebolita e corrotta. Ciò che So-<br />
1 “Ancor meno mi crederete se dico che il più grande bene dato all’uomo è proprio questa possibilità<br />
di ragionare quotidianamente sulla virtù e sui vari temi su cui mi avete sentito discutere o esaminare<br />
me stesso e altri, e che una vita senza ricerca non vale la pena di essere vissuta dall’uomo”<br />
(Apologia [38b], a cura di M. Sassi, Rizzoli, Milano, 2005, p. 165).<br />
Dossier 11
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />
12<br />
crate intende fare è risvegliare la coscienza degli ateniesi perché si riprendano dalla<br />
decadenza dei costumi e tornino a celebrare l’eccellenza di una città, la loro, degna<br />
dei suoi eroi. Anzi, ancor più radicalmente, Socrate intende rivedere il significato<br />
stesso dell’eccellenza, ne propone una revisione. Quel che in concreto Socrate fa<br />
è giudicare le leggi onde capire se siano o meno leggi giuste; intende verificare la<br />
coerenza delle leggi con gli ideali morali ad esse superiori, con quelli che oggi noi<br />
chiameremmo i valori costituzionali. <strong>Il</strong> messaggio socratico è chiaro: non è il fatto<br />
di esser legge che rende una legge giusta. Esiste, infatti, uno standard di <strong>legalità</strong> ed<br />
esiste uno standard di legittimità. C’è la legge, e c’è la giustizia, e non è detto che<br />
coincidano. Dunque, Socrate invita a porsi a distanza dalle leggi positive e valutarne<br />
la giustizia oltre la giustezza formale del loro essere state legittimamente poste.<br />
Per far ciò occorre assumere la ‘posizione del filosofo’, occupando idealmente quella<br />
postazione critica che sta alla ‘giusta’ distanza da ciò che accade.<br />
A proposito di obbedienza o di disobbedienza alle leggi, Socrate mostra di essere<br />
un esempio di disobbediente civile: di fronte ad ordini iniqui ricevuti dai suoi<br />
superiori (per esempio, l’ordine di prelevare e uccidere un uomo giusto – Leone<br />
di Salamina - solo perché inviso al potere) Socrate disobbedisce e “torna a casa” 2 .<br />
Ancora, a fronte dell’alternativa alla pena di morte offertagli dai suoi accusatori,<br />
smettere di filosofare e andarsene in esilio, Socrate rifiuta: smettere di filosofare<br />
significherebbe tacere e mettere a tacere il suo diritto di critica, la sua inesauribile<br />
istanza di giustizia; per Socrate significherebbe ignorare la sua missione divina e<br />
tradire la giustizia.<br />
In conclusione, potremmo dire che il dono che Socrate fa alla sua città consiste<br />
nella sua filosofia, messa a disposizione della vita pubblica. <strong>Il</strong> dono del filosofo alla<br />
città è insegnare a ciascun cittadino a essere soggetto autonomo, a diventare valutatore<br />
indipendente capace di distinguere tra la <strong>legalità</strong> di un comando e la sua legittimità,<br />
ovvero la sua giustizia. Non i cittadini ma solo gli schiavi ricevono passivamente<br />
ordini ed ingiunzioni senza porsi la domanda se siano o meno legittimi.<br />
Ora, a partire dalla vicenda socratica e dall’ideale di cittadinanza che Socrate<br />
ha incarnato, capiamo in che senso la filosofia conferisca alla politica una dimensione<br />
utopica: significa che lo sguardo disincantato del filosofo – ovvero, in questa<br />
ricostruzione, di ogni cittadino che voglia dirsi libero – si può sempre rivolgere al<br />
potere e alle sue costrizioni, all’autorità e alle sue leggi. Si potrebbe persino riconoscere<br />
a questa istanza critica una dimensione anarchica: anarchia non significa qui<br />
negazione del potere o dell’ordine costituito; significa riservarsi il diritto di giudi-<br />
2 “I Trenta mi convocarono con altri quattro nella Rotonda, ingiungendoci di condurre qui da<br />
Salamina, per mandarlo a morte, Leone di Salamina. Di ordini simili a quelli là ne davano un bel<br />
po’ a parecchia gente, con l’intenzione di coinvolgerne il più possibile nella responsabilità dei loro<br />
crimini. Tuttavia anche allora, non a parole ma con i fatti, ho dimostrato che della morte non mi<br />
importa […] sopra ogni altra cosa, invece, m’importa di non compiere azioni ingiuste o empie.<br />
[…] Usciti dalla Rotonda, mentre gli altri quattro se ne andavano a Salamina a prendere Leone, io<br />
me ne sono tornato a casa” (Platone, Apologia di Socrate [32d], a cura di M. Sassi, Rizzoli, Milano,<br />
2005, p. 149.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />
care i vincoli che il potere impone sulle libertà dei singoli; significa, ancora, sfidare<br />
il potere, obbligandolo a rendere conto delle sue azioni e ad assumersi in toto le<br />
sue responsabilità. <strong>Il</strong> significato utopico della filosofia in politica consiste proprio<br />
nell’opporsi a qualsiasi forma di pigrizia del pensiero, a quella che Berlin chiamerebbe<br />
immaturità 3 , che è all’origine di ogni degrado del sistema democratico.<br />
Discorrendo della legittimità come istanza critica della <strong>legalità</strong>, ho inteso difendere<br />
una prospettiva di giustizia per la quale il ‘giusto’ è inteso come un criterio al<br />
di sopra di qualsiasi ordine dato; il ‘giusto’ funge da norma stabile di valutazione<br />
che non è posta né dai cittadini né tanto meno da colui o coloro che li amministra<br />
e governa. ‘Giusto’, preciso ancora, non significa necessariamente condiviso: non<br />
è detto che una legge sia giusta solo perché essa è esito di una procedura legislativa<br />
corretta; ammettere che una legge possa essere ingiusta nonostante la giustezza<br />
procedurale con cui è stata posta significa considerare la ‘giustizia’ delle leggi come<br />
qualcosa di superiore e indipendente dalla loro validità. Se ammettiamo dunque<br />
un doppio criterio per valutare se una legge è giusta, dovremmo ammettere la<br />
possibilità che essa sia formalmente giusta – cioè posta legittimamente, secondo<br />
correttezza procedurale – e, al contempo, intrinsecamente ingiusta – perché in<br />
contrasto con valori superiori quali quelli custoditi dalle carte costituzionali. In<br />
fondo Socrate fa proprio questo: si domanda se le leggi di Atene, che la città condivide,<br />
siano giuste; quindi dichiara che alcune di queste non lo sono: non è giusta<br />
per esempio la decisione, peraltro presa in modo proceduralmente corretto, di<br />
mandarlo a morte, quale esito di pubblico processo. <strong>Il</strong> problema, a questo punto, è<br />
pratico: si tratta di decidere che fare di fronte a leggi ingiuste. L’alternativa è secca e<br />
consiste o nel seguire le leggi o nel disobbedire ad esse, accettando le conseguenze.<br />
Socrate opta per la seconda alternativa: disobbedisce e subisce la pena, e per questo<br />
lo consideriamo un esempio paradigmatico di disobbediente civile. In altri specifici<br />
casi sono le leggi stesse a riconoscere spazi di esenzione dall’obbedire definiti a precise<br />
condizioni: il disobbedire alle leggi non deve comportare, per esempio, alcuna<br />
violazione dei diritti fondamentali degli altri, né può contenere alcuna minaccia<br />
di destabilizzazione. In questi casi si parla di obiezione di coscienza; non me ne<br />
posso però occupare in questa sede, poiché richiederebbe maggior spazio di quello<br />
concesso a questo contributo.<br />
La questione cui ora vorrei fare cenno è quella relativa alle richieste di esenzione<br />
che portatori di codici culturali avanzano nei confronti della legge dello Stato. In<br />
primo luogo è necessario che io spieghi il nesso tra quanto fin qui detto e quanto<br />
mi appresto a introdurre. L’idea, comune ai due ragionamenti, a quello precedente<br />
e a quello che sto per fare, è che, a fronte di leggi stabilite, ogni individuo ha il diritto<br />
di esprimere un giudizio su di esse, a partire da criteri in qualche modo esterni<br />
alle leggi, a partire cioè da ideali che le leggi medesime dovrebbero rispettare.<br />
Nel caso di Atene, il cittadino Socrate si interroga sulla legittimità di alcune<br />
prescrizioni (potremmo dire sulla loro giustizia, considerata la giustizia il sommo<br />
3 I. Berlin, “Due concetti di libertà”, in Libertà, Feltrinelli, Milano, 2005, pp. 195 ss.<br />
Dossier 13
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />
14<br />
criterio cui le singole leggi devono ispirarsi per essere, appunto, leggi giuste) e,<br />
trovandosi in profondo disaccordo con queste, si appella alla sua coscienza e disobbedisce.<br />
Certamente, nell’appello alla coscienza potrebbe annidarsi il pericolo<br />
di una deriva soggettivistica: chiunque, infatti, potrebbe addurre qualsivoglia impulso<br />
interiore come giustificazione della disobbedienza; se però tutti si appellassero<br />
discrezionalmente alla propria coscienza per disobbedire alle leggi, potremmo<br />
facilmente immaginare quali conseguenze di destabilizzazione e di generalizzato<br />
disordine tale appello porterebbe con sé. In Socrate tali conseguenze sono scongiurate<br />
nel momento in cui egli dichiara di essersi riferito, a giustificazione della sua<br />
condotta, a un comando divino, alla sollecitazione che gli è venuta dal dio che lo<br />
invita a filosofare; al dio e non ai concittadini Socrate dice di dovere obbedienza<br />
per cui – scrive - “finché avrò vita e forze non cesserò di fare filosofia” 4 . Socrate fa<br />
appello, in sostanza, alla ragione, anzi alla verità che detta la giustizia: “è nel dire<br />
cose giuste che io confido” 5 .<br />
Nei casi di individui ‘portatori’ di codici culturali, la questione non è se disobbedire<br />
o meno alle leggi in ragione della coscienza o della verità, ma chiedere di<br />
poter disobbedire a motivo della propria appartenenza culturale. L’idea che costoro<br />
esprimono è che alcune leggi risultano oppressive nei loro confronti, laddove se<br />
applicate finirebbero per sminuire o cancellare le loro peculiarità. Alcune leggi<br />
sembrano non tenere in debito conto le identità culturali di alcuni cittadini –<br />
membri di comunità culturali minoritarie – per il fatto di non garantire a loro<br />
il diritto all’eguaglianza e alla non discriminazione. Un esempio per capire che<br />
intendo quando parlo di una legge che, per quanto ispirata a ideali di giustizia e<br />
non discriminazione, può portare a esiti discriminatori, è quello fornito dal cosiddetto<br />
“affare del velo”, scoppiato in Francia agli inizi degli anni Novanta. Ad<br />
alcune studentesse di fede islamica venne proibito di indossare lo hijab in classe,<br />
in quanto il principio di laicità dello spazio pubblico, e la scuola è senz’altro tale,<br />
esige che nessuno studente abbia il permesso di esibire segni visibili della propria<br />
appartenenza religiosa. Ora, senza addentrarci nella questione, è intuibile come a<br />
prima vista tale prescrizione mostri di ispirarsi al principio di non discriminazione:<br />
la neutralizzazione religiosa dello spazio pubblico dovrebbe impedire che le istituzioni<br />
siano parziali e incarnino una cultura (o una religione) a discapito delle altre.<br />
La prescrizione in oggetto risulta, tuttavia, iniqua: le ragazze islamiche, per le quali<br />
l’identità religiosa – in quanto minoritaria - è un valore da esibire pubblicamente e<br />
non da nascondere dentro ai contesti non pubblici delle rispettive comunità, non<br />
si sentono trattate da eguali. La richiesta delle ragazze islamiche di indossare il velo<br />
a scuola è dunque un’istanza di riconoscimento: loro intento è essere pubblicamente<br />
riconosciute per quel che sono, senza che ciò che le contraddistingue debba<br />
essere cancellato dagli spazi pubblici, poiché a tali spazi anch’esse hanno diritto di<br />
accesso come tutti gli altri e non a certe restrittive condizioni. La loro istanza di<br />
4 Platone, Apologia [29d], cit., p. 141.<br />
5 Platone, Apologia [17c], cit., p. 103.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />
riconoscimento è dunque avanzata agli occhi del pubblico proprio per denunciare<br />
i limiti di una società liberale che pensa di affrontare la discriminazione mediante<br />
la neutralizzazione delle differenze, laddove tale neutralizzazione mostra nei fatti<br />
di perpetuarla 6 . Se dunque le differenze identitarie sembrano assumere, come nel<br />
caso del velo, la veste di legittime istanze di riconoscimento – riposando la loro<br />
legittimità sul principio di eguale considerazione e rispetto - si pone tuttavia la<br />
domanda relativa ai limiti del riconoscimento: esistono istanze di riconoscimento<br />
che non possono essere accolte da una società liberale? Quali sono, in sostanza, i<br />
limiti del riconoscimento? La domanda mira a stabilire se le richieste di esenzione<br />
dal rispetto della legge (nel caso delle ragazze islamiche la richiesta di esenzione è<br />
quella di poter disobbedire alla legge che vieta di indossare segni di appartenenza<br />
religiosa) debbano a loro volta essere sottoposte a un test di giustizia. Una bozza di<br />
risposta è la seguente: garantire riconoscimento alle caratteristiche identitarie dei<br />
singoli, appartenenti a gruppi o comunità, in base al principio dell’eguaglianza,<br />
non implica per ciò stesso accettazione indifferente di tutte le possibili istanze di<br />
riconoscimento. Nel nostro caso, ci si chiede se quel che le ragazze vogliono sia,<br />
prima di tutto, qualcosa che loro vogliono autonomamente, per rivendicare la propria<br />
identità e il diritto alla loro differenza; o se, al contrario, sia la loro comunità<br />
di appartenenza a imporre loro di indossare il velo come espressione della subordinazione<br />
delle donne secondo un codice culturale cui tali comunità si assoggettano<br />
per prime. Porsi questa domanda significa ritenere che le istanze di riconoscimento<br />
non sono tutte uguali: alcune sono accoglibili nel contesto della società liberale,<br />
poiché rimandano a suoi standard fondamentali quali l’eguaglianza e la non discriminazione;<br />
altre non loro sono, poiché esprimono istanze illegittime, quali la<br />
subordinazione di alcuni individui, perlopiù donne, ai dettami di una comunità<br />
che li opprime. La legittimità delle istanze di riconoscimento dipende dall’impatto<br />
che esse hanno sugli inviolabili diritti individuali. È alle ragioni della giustizia, agli<br />
standard superiori cui le leggi di uno stato devono rinviare, che occorre dunque<br />
tornare per fissare i limiti del riconoscimento: sono accolte quelle istanze che non<br />
si pongano in contrasto con i diritti individuali e, in particolare, con il diritto di<br />
ciascuno ad essere trattato con eguale considerazione e rispetto. È, in sostanza, il<br />
rispetto del singolo e delle sue scelte che va salvaguardato come criterio di massima<br />
per l’accettazione delle culture, ovvero per il loro pubblico riconoscimento. Limite<br />
del riconoscimento è dunque l’interesse del singolo, la sua volontà di aderire o<br />
meno alla cultura, la sua autonomia.<br />
Sono partita dalla vicenda socratica per mettere a tema la distinzione tra <strong>legalità</strong><br />
e legittimità, tra prescrizioni di legge e ragioni di coscienza, tra consenso e giustizia.<br />
Ho assimilato Socrate al disobbediente civile, colui che esime se stesso dall’obbedienza<br />
alle leggi legittimamente poste - nel senso che soddisfano lo standard di<br />
<strong>legalità</strong> - ma considerate intrinsecamente illegittime per riferimento a uno standard<br />
6 Sulla questione del velo, si veda A. E. Galeotti, Toleration and recognition, Cambridge University<br />
Press, Cambridge 2003, pp. 115-36.<br />
Dossier 15
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/(<strong>Il</strong>)<strong>legalità</strong>?/Legalità_legittimità_cultura<br />
16<br />
superiore di giustizia. Sono passata a un esempio di tutt’altra natura, desunto dal<br />
dibattito intorno alle richieste di riconoscimento delle minoranze culturali: mi<br />
sono soffermata sulla richiesta di esenzione dall’obbedienza alla legge francese che<br />
vieta di portare segni di appartenenza religiosa; tale richiesta di esenzione è motivata<br />
dal medesimo ideale di eguaglianza e non discriminazione che la legge intendeva<br />
perseguire. In entrambi i casi la disobbedienza viene spiegata per ragioni superiori<br />
o precedenti le singole leggi: sia da parte di Socrate sia da quella delle ragazze islamiche<br />
viene invocata la ragione superiore della giustizia. Socrate la invoca per dire<br />
che tutte le leggi vi si devono adeguare; le ragazze islamiche la invocano rivendicando<br />
il diritto ad essere trattate con equità. È alla luce dell’ideale di giustizia che<br />
le leggi, anche quelle che formalmente vi si ispirano, chiedono di essere riviste,<br />
integrate o reinterpretate. Dei modi di tale revisione non posso qui evidentemente<br />
occuparmi; rinvio tale approfondimento a discussione futura.<br />
*Ricercatrice di Filosofia politica presso l'Università Vita-Salute San Raffaele
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/<br />
Temi ed esperienze<br />
L’intenzione della sezione Temi ed Esperienze è quella di offrire al lettore<br />
uno spazio di condivisione su riflessioni, percorsi, progetti, testimonianze,<br />
narrazioni, presentando una serie di contributi che, pur non<br />
negando l’esigenza dell’approccio e della definizione teorica, cerchino<br />
di ricollegarsi all’idea della pratica, di quell’ambito del conoscere, legato<br />
alle forme dell’azione, della sperimentazione e della verifica in<br />
continuo divenire ed in costante trasmissione.<br />
Temi ed esperienze<br />
59
<strong>Pedagogika</strong>.it/2010/XIV_3/temi_ed_esperienze/l'idea_di_lavoro<br />
86
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/<br />
La funzione psicopedagogica<br />
e terapeutica del clown<br />
Da diversi anni la popolazione scientifica sta rivolgendo sempre di più il proprio<br />
interesse verso l’umorismo. Una figura particolare che sta inserendosi in un<br />
numero sempre maggiore di contesti è data dal personaggio del Clown sia come<br />
figura di supporto psicologico che come strumento pedagogico.<br />
Alberto Dionigi*<br />
Thomas Sydenham, autorevole medico del XVII secolo, era solito affermare<br />
che “l'arrivo di un buon clown esercita, sulla salute di una città, un'influenza benefica<br />
superiore a quella di venti asini carichi di medicinali” 1 .<br />
Questa frase ben illustra come il valore della comicità clownesca abbia sostenitori<br />
antichi e che le proprietà benefiche del ridere e dell’arte comica non siano<br />
affatto una scoperta recente.<br />
Per riuscire a comprendere il ruolo del clown, sia come strumento di formazione<br />
psicopedagogica che come strumento terapeutico, è bene soffermarsi sulla<br />
natura stessa della comicità. Nella letteratura comune, si riscontra una varietà<br />
decisamente ampia di parole connesse con il comico e l’umorismo che vengono<br />
spesso usate come sinonimi: ridicolo, satirico, buffo, ironico, comico, scherzoso,<br />
divertente, assurdo, risibile o spiritoso, solo per citarne alcune 2 . Se si va ad analizzare<br />
la radice etimologica della parola “comico” si nota che essa risale ai “komos”<br />
dell’antica Grecia: i komos erano i canti che accompagnavano i riti dionisiaci, legati<br />
all’ebbrezza prodotta dal vino, connotati di una natura contemporaneamente<br />
trasgressiva ed “estatica” 3 . Nel corso dei secoli tale accezione viene introdotta nella<br />
commedia, dove il riferimento ai culti dionisiaci è data dall’allusione all’esistenza<br />
di un mondo altro e alla possibilità di sovvertire l’ordine e la razionalità del mondo<br />
civile, esorcizzandone le paure e festeggiando il piacere e le gioie della vita.<br />
Bisogna ricordare che la figura del clown, e di conseguenza le origini dell’arte<br />
clownesca, sono legate, in moltissime culture, a pratiche magico-religiose in cui<br />
il clown è una figura capace di mantenere un legame, attraverso rituali e pratiche<br />
peculiari, con il mondo dell’aldilà; la risata, avrebbe in questo senso una funzione<br />
catartica volta a sdrammatizzare ed esorcizzare la paura della morte.<br />
Ruoli e funzioni primordiali del clown attuale sono rintracciabili anche nei<br />
“pagliacci divini” del Nord America, protagonisti di rituali con i morti e gli antenati<br />
per i quali è stato anche coniato il termine di “clownismo primitivo” 4 . Con<br />
tale termine ci si riferisce a queste primordiali forme di clown che si inserivano<br />
1 A. Dionigi, La Comicoterapia, in Psicologia Contemporanea, 2009, 214, pp. 58-62.<br />
2 A. Dionigi, P. Gremigni, Psicologia dell’umorismo, Carocci, Roma, 2010.<br />
3 A. Farneti, La maschera più piccola del mondo. Aspetti psicologici della clownerie, Alberto Perdisa,<br />
Bologna, 2004<br />
4 W. Willeford, <strong>Il</strong> Fool e il suo scettro, <strong>Il</strong> Tridente Saggi, 1998.<br />
Temi ed esperienze 87
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />
88<br />
nei contesti mistici, magici e religiosi dei popoli primitivi. E’ poi attraverso l’allontanamento<br />
dalla sfera del divino ed un maggiore approfondimento verso una<br />
relazione più soggettiva, individuale e giocosa con la magia che si ha il passaggio<br />
dal clownismo rituale al clownismo comico 5 .<br />
Durante la sua evoluzione nei secoli, la figura del clown incontra e si confronta<br />
sempre più con un mondo sociale ed espressivo aperto a funzioni culturali e<br />
psicologiche sia di polemica sociale che di feroce ironia e sarcasmo. Attraverso la<br />
figura del clown diviene possibile guardare il mondo da un punto di vista altro, far<br />
emergere la disapprovazione, il risentimento e la critica popolare attraverso l’amplificazione<br />
grottesca ed esagerata.<br />
Un elemento che accomuna la storia del clown presso tutte le culture è rappresentato<br />
dal suo personaggio, apparentemente sciocco, ma in realtà depositario<br />
di una sapienza “altra”, incaricato di mettere a nudo le contraddizioni dell’umano<br />
agire, delle leggi, delle consuetudini, della parola dei potenti 6 . E’ di queste debolezze<br />
che il popolo ride.<br />
Appare evidente come questo ruolo venga mantenuto dalla figura del clown odierno:<br />
tutto o quasi è permesso se si indossa un naso rosso, ed una volta dinanzi, si resta in<br />
attesa che egli faccia o dica qualcosa di divertente in grado di scatenare una risata.<br />
Ma perché il clown fa ridere? Quali sono i meccanismi che vengono attivati nel<br />
momento in cui uno stimolo provoca divertimento? Nei laboratori espressivi e nei<br />
corsi di formazione sull’arte clownesca si cerca di capire e sperimentare quali siano<br />
i meccanismi utilizzati dal clown per strappare una risata: al contrario di quanto<br />
universalmente pensato le smorfie, i capitomboli e le torte in faccia provocano uno<br />
scarso apprezzamento umoristico. E’ nel momento del fallimento, in cui il clown è<br />
afflitto, imbarazzato, affranto che scatta la risata: non è il personaggio che fa ridere,<br />
ma è l’uomo, nel momento in cui viene “messo a nudo”.<br />
E’ dal concetto di fallimento che bisogna partire per far sì che la figura del clown<br />
diventi uno “strumento” pedagogico, in modo da poter lavorare sull’inadeguatezza<br />
di ogni uomo nei confronti della realtà. “<strong>Il</strong> clown non esiste al di fuori dell’attore che<br />
lo recita: siamo tutti dei clown, crediamo tutti di essere belli, intelligenti e forti, mentre<br />
ognuno di noi ha le sue debolezze, i lati ridicoli che, rivelandosi, provocano il riso” 7 .<br />
<strong>Il</strong> clown indossa sempre una maschera, il naso rosso, definito come la maschera<br />
più piccola del mondo e gliene affida un potere enorme. Attraverso il naso rosso è<br />
possibile scoprire i lati unici e nascosti della propria personalità, intraprendendo<br />
un viaggio alla riscoperta delle proprie debolezze, delle proprie fragilità, del proprio<br />
clown personale.<br />
Indossare la maschera più piccola del mondo porta a lavorare su aspetti di sé<br />
tenuti convenzionalmente nascosti, facendo emergere i lati ridicoli che esistono già<br />
in ognuno di noi e accettandoli attraverso una drammatizzazione teatrale. <strong>Il</strong> naso<br />
5 Idem, p.94.<br />
6 S. Fioravanti, L. Spina, La terapia del ridere. Guarire con il buonumore, Red Edizioni, Como,<br />
1999.<br />
7 J. Lecoq , <strong>Il</strong> corpo poetico, Ubulibri, Milano, 2000, pag. 167.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />
rosso diventa quindi un potentissimo strumento pedagogico. Ogni volta che viene<br />
indossato, non vi è più necessita di recitare un personaggio in quanto non vi è più<br />
differenza fra attore e clown; è in questa unione simbiotica che l’attore/clown si<br />
accetta interamente con i propri difetti, le proprie insicurezze e li vive nel gioco<br />
scenico che la maschera da clown gli permette. L’attore vive il proprio fallimento e<br />
instaura un nuovo rapporto con se stesso, non ha più necessita di salvaguardare la<br />
propria faccia 8 diventa libero di ridere di se stesso per poter far ridere gli altri. Non<br />
si tratta di “fare il clown”, ma di “essere clown”.<br />
Anche i difetti fisici vengono messi in risalto attraverso il proprio abbigliamento<br />
che viene realizzato utilizzando abiti della vita quotidiana: il costume del clown,<br />
colorato e di dimensioni assurde, costringe così lo stesso clown a movimenti goffi e<br />
di difficile attuazione che diventano un modo per mettere in risalto possibili particolarità<br />
di deambulazione e facendola diventare una caratteristica unica e peculiare<br />
di quel personaggio specifico.<br />
A queste peculiarità personali, si aggiungono molto spesso competenze artistiche e<br />
tecniche, volte all’acquisizione di strumenti e metodi utili a far scaturire una risata.<br />
Ciò che rende pedagogicamente utile la figura del clown è il fatto che indossando<br />
il naso rosso, non si tratta di indossare una maschera, bensì utilizzare uno<br />
strumento che porta la persona alla scoperta di una dimensione di creatività e di<br />
ascolto sia di sé che degli altri che permette di vivere sia la scena che la quotidianità<br />
con un atteggiamento psicologico particolare e funzionale. <strong>Il</strong> clown è essenzialmente<br />
uno stato d’animo. Indossando il naso rosso ci si spoglia completamente<br />
delle proprie difese e sicurezze, si vive una condizione di emancipazione totale, in<br />
cui tutto è concesso e legittimato dalla maschera che si indossa: l’attore si libera<br />
degli schemi mentali e sociali soliti e ha libero accesso anche a gesti proibiti nella<br />
vita quotidiana. E’ in questa maniera che può emerge veramente l’unicità della<br />
persona e la sua forza personale; il clown diventa così il portatore di una filosofia di<br />
vita alternativa, una filosofia in cui non esistono convenzioni sociali e ciò conduce<br />
inevitabilmente a vedere il mondo in maniera diversa, da un’altra prospettiva.<br />
La funzione terapeutica del clown<br />
Vestire i panni del clown è divenuta ormai un’esperienza utilizzata nei più vari<br />
contesti, non solo in quello teatrale. Tale universalizzazione è data dal fatto che indossando<br />
i panni del clown ci si avventura verso un percorso di riscoperta di sé, una<br />
sorta di percorso psicoterapeutico autocelebrato volto a conoscere, individuare, far<br />
emergere ed accettare le proprie fragilità represse per paura del giudizio degli altri e<br />
della società. Indossando la maschera più piccola del mondo ci si spoglia dei ruoli<br />
abitualmente interpretati, ci si libera delle difese solitamente utilizzate allo scopo<br />
di affrontare la vita quotidiana da un’altra prospettiva, solitamente sottaciuta e<br />
nascosta: attraverso la figura del clown non si evitano le situazioni pericolose o pre-<br />
8 E. Goffman, Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behaviour, Anchor Books, Gardena City<br />
(NY), 1967.<br />
Temi ed esperienze<br />
89
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />
90<br />
occupanti, ma ci si fionda dentro, anche giocandoci per trovare una soluzione che<br />
tenga conto di un ribaltamento del punto di vista, non dando nulla per scontato e<br />
cercando di ristrutturare la scena anche vedendo il mondo “al contrario”.<br />
Indossando il naso rosso, anche in senso metaforico, è possibile acquisire temporaneamente<br />
una nuova immagine di sé, spesso contraria e paradossale a quella<br />
abituale, permettendo anche di osservarsi meglio: trovare un’identità nuova permette<br />
di aprirsi a nuove possibilità di relazione e alla scoperta di prospettive nuove,<br />
allargando il proprio orizzonte.<br />
Da quanto detto emerge che il clown non è solo un personaggio comico, il cui<br />
unico scopo è quello di fare ridere, ma appare la sua utilità e capacità relazionali,<br />
in quanto capace di abbattere barriere e permettendo di sovvertire il punto di vista.<br />
Appunto per tali caratteristiche, la figura del clown è stata presa in considerazione<br />
come possibile strumento di intervento nei percorsi di emancipazione dal disagio<br />
personale e collettivo. Vestire i panni del clown può quindi essere sia un’esperienza<br />
vissuta in prima persona allo scopo di affrontare le proprie debolezze, sovvertire i<br />
propri schemi relazionali e confrontarsi con i propri limiti sia un’esperienza indiretta,<br />
in cui beneficiare dell’intervento di uno o più clown, adeguatamente formati,<br />
con la finalità di promuovere il benessere psichico, fisico e sociale all’interno di<br />
contesti di disagio o di strutture di formazione e ricovero.<br />
Negli ultimi anni sono caduti diversi tabù, come quello che relegava il ridere ad<br />
argomento poco serio, enfatizzandone invece le peculiarità positive e permettendo<br />
così anche alla figura del clown di entrare in strutture fino a pochi decenni fa impensabili:<br />
è esperienza quotidiana trovare clown nelle scuole, negli ospedali, nelle<br />
case di riposo, nei carceri minorili e così via. A comprovare la funzione terapeutica<br />
della figura del clown vi è la nascita di un numero sempre maggiore di associazioni<br />
ONLUS il cui scopo è quello di promuovere l’utilizzo della clown terapia, cioè<br />
l’attuazione di tecniche clownesche, derivate dal circo e dal teatro di strada, in contesti<br />
di disagio, al fine di migliorare l’umore delle persone 9 e promuovere missioni<br />
umanitarie all’estero in cui i “clown dottori” portano oltre agli aiuti materiali anche<br />
la propria arte clownesca realizzando spettacoli di clownerie e gag comiche.<br />
<strong>Il</strong> clown è diventato così un vero e proprio messaggero di pace e il naso rosso è diventato<br />
simbolo di amicizia, di gioia, di speranza. È la possibilità di stupirsi e poter sorridere<br />
e ridere anche in quelle situazioni pregne di sofferenza in cui è possibile trovare un modello<br />
comunicativo comune che oltrepassa qualsiasi differenza e che lascia spazio ad una<br />
vicinanza umana in cui non esistono confini, barriere o diversità. <strong>Il</strong> clown diventa così un<br />
personaggio universale in grado di sovvertire anche la situazione più traumatica.<br />
È infatti un dato ormai assodato che ridere e l’utilizzo dell’umorismo abbiano<br />
proprietà rilassanti, che fungano da strategia di gestione dello stress e che sia coinvolta<br />
nella regolazione di secrezioni di ormoni e di endorfine implicati nel meccanismo<br />
fisiologico della regolamentazione del piacere 10 .<br />
9 A. Dionigi, La Comicoterapia, cit.<br />
10 A. Dionigi A., P. Gremigni P., Psicologia dell’umorismo, cit.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />
L’umorismo può essere utilizzato anche per valutare le risposte emotive delle<br />
persone in relazione a determinate situazioni. Durante periodi di forte stress o<br />
pericolo, quando mostrare le proprie paure può essere vissuto come elemento di<br />
inferiorità, il ricorso allo humour può consentire di valutare il grado di emozioni<br />
negative sperimentate dal soggetto 11 .<br />
L’umorismo quindi favorisce il benessere personale attraverso meccanismi cognitivi,<br />
moderando l’effetto nocivo di stimoli stressanti. Numerose ricerche hanno<br />
dimostrato che eventi di vita particolarmente faticosi e impegnativi possono avere<br />
una ricaduta negativa su vari aspetti della salute personale, quali l’inibizione della<br />
funzione immunitaria e l’aumento del rischio di malattie attraverso la secrezione<br />
di ormoni stress-correlati come catecolamine e cortisolo 12 . L’umorismo può essere<br />
un’efficace strategia per fronteggiare lo stress, riducendone gli effetti nocivi per la<br />
salute: una visione umoristica della vita e la capacità di vedere il lato comico delle<br />
cose possono aiutare gli individui a fronteggiare al meglio gli eventi negativi, permettendo<br />
loro di distanziarsi emotivamente dalla situazione stressante aumentando<br />
le proprie capacità di controllo e padronanza dell’ambiente 13 .<br />
La funzione terapeutica del clown è rappresenta dalla capacità di sovvertire gli<br />
schemi standard e abituali. Mantenere schemi rigidi durante i momenti di stress<br />
e malattia può infatti peggiorare il proprio stato emotivo: schemi mentali negativi<br />
possono essere collegati a un maggiore stress psicofisico, una maggiore resistenza<br />
e difficoltà a trovare una soluzione efficace ai problemi ed è alla base dei disturbi<br />
depressivi 14 . Le persone che tendono a vedere in maniera negativa e senza speranza<br />
le situazioni stressanti in cui si trovano tendono ad avere una bassa autostima ed<br />
essere meno pronti ad affrontare situazioni di stress 15 .<br />
Riuscire a sovvertire gli schemi abituali, significa essere capaci di flessibilità<br />
mentale, riuscendo a trovare un maggior numero di soluzioni ai problemi che si<br />
presentano e riuscendo ad affrontare lo stress in maniera più positiva. Ciò porta a<br />
ridimensionare gli eventi negativi che vengono vissuti in maniera meno stressante e<br />
minacciosa in quanto la persona si sente capace di poter aver avere un ruolo attivo<br />
sulla modificazione degli eventi o di poter fare comunque qualcosa, essa ha quindi<br />
un maggior senso di autoefficacia.<br />
Attraverso la clown terapia è quindi possibile aiutare le persone non solo a rivedere<br />
in maniera alternativa la situazione problematica ma anche ad affrontare in<br />
modo più ottimistico la vita, portando ad un maggior grado di autoefficacia percepita<br />
attraverso l’esercizio sistematico e consapevole dell’autoironia che diventa così<br />
11 T. R. Kane, J. Suls, J.T. Tedeschi, Humor as a Tool of Social Interaction, in A. J. Chapman, H. C.<br />
Foot (eds.), It’s a Funny Thing, Humour, Pergamon Press, Oxford, 1977, p. 13.<br />
12 R.A. Martin, Humor, Laughter, and Physical Health: Methodological Issues and Research Findings,<br />
in Psychological Bulletin, 2001, 4, pp. 504-19.<br />
13 R. A. Martin, The Psychology of Humor, Academic Press, New York, 2007.<br />
14 A. T. Beck, La depressione, Bollati Boringhieri, Torino, 1978.<br />
15 M. E. P. Seligman, Learned optimism. How to change your mind and your life, Simon & Schuster<br />
Inc, NY, 1996.<br />
Temi ed esperienze<br />
91
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />
92<br />
uno strumento potentissimo per prendere consapevolezza e distaccarsi in maniera<br />
funzionale dal problema vissuto: vedendolo con occhi altri e dall’esterno è maggiormente<br />
probabile che esso venga non solo ridimensionato ma che la persona<br />
stessa si senta più capace di operare un cambiamento.<br />
La clown terapia si propone quindi di attuare, per mezzo dell’umorismo, della<br />
risata e del gioco, una vera e propria ristrutturazione interna portando un’innovazione<br />
in una situazione routinaria che altrimenti sarebbe rigida, spostando<br />
l’attenzione su elementi altrimenti esclusi e portando così ad un cambio di prospettiva.<br />
Attraverso un esercizio continuo e ripetuto è così possibile portare questa<br />
ristrutturazione ad una metodologia continua per diventare un nuovo e funzionale<br />
modalità di affrontare la vita.<br />
L’umorismo che si utilizza nelle tecniche di clown terapia poiché coinvolge<br />
incongruità e diverse possibili interpretazioni, fornisce alle persone una strategia<br />
alternativa che le rende capaci di cambiare prospettiva rispetto a una situazione<br />
stressante, reinterpretandola in un nuovo modo, cambiando punto di vista e rendendola<br />
meno minacciosa. Come conseguenza di questa reinterpretazione umoristica,<br />
l’evento è percepito come meno stressante e maggiormente affrontabile 16 .<br />
Sovvertire gli schemi risulta quindi fondamentale per il clown per suscitare la<br />
risata; chi fa il clown sa bene che un clown che fa “fiasco” è molto più divertente<br />
agli occhi del pubblico di uno che vince e che per far ridere in maniera ancora più<br />
forte è importante cercare sempre di perdere nel modo più rovinoso possibile.<br />
Mettendo in evidenza la propria difficoltà, la propria imperfezione e incapacità<br />
di riuscire, il clown mostra la propria impotenza: ed è questo, che a distanza<br />
di millenni, rappresenta ancora l’effetto catartico. La clown terapia diventa una<br />
terapia della vergogna che ha effetti sia sul clown che sullo spettatore. Attraverso<br />
rispecchiamenti e proiezioni anche il paziente/spettatore può ridere della propria<br />
goffaggine, pur restando difeso in una posizione di distanza e superiorità. 17<br />
Un altro aspetto che ha reso tanto popolare la figura del clown in ospedale è<br />
data dalla sua natura intrinsecamente tragicomica e malinconica. Egli è sempre in<br />
bilico fra la tristezza e la gioia, fra il pianto e il riso, perché la sua è un’ironia bonaria<br />
e perdente, un po’malata di malinconia. <strong>Il</strong> mestiere del clown è quello di far ridere<br />
ma anche, probabilmente, quello di piangere con chi piange, di essere piccolo e<br />
solo con chi è piccolo e solo 18 .<br />
Da quanto fin qui detto, si può quindi parlare di “clownterapia” cioè dell’attuazione<br />
di un insieme di tecniche derivate dal circo e dal teatro di strada, in contesti<br />
di disagio quali ad esempio gli ospedali, le case di riposo, le case famiglia, gli orfanotrofi,<br />
i centri diurni, ecc.<br />
Data la vastità e l’importanza della funzione della clownterapia, si è avvertita<br />
negli ultimi anni l’esigenza di fare chiarezza sul ruolo, sulle competenze, sulle<br />
16 A. Dionigi, P. Gremigni, Psicologia dell’umorismo, cit.<br />
17 A. Farneti, La maschera più piccola del mondo. Aspetti psicologici della clownerie, cit.<br />
18 Idem.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/temi_ed_esperienze/la_funzione_psicopedagogica_del_clown<br />
modalità di intervento, sulle metodologie formative dei “nasi rossi” definiti clown<br />
dottori come agenti di servizio per la persona.<br />
Con il termine clown dottori si intendono:<br />
- i volontari formati allo scopo di adattare le proprie capacità individuali specifiche<br />
e le loro varie professionalità al servizio svolto in ospedali, comunità, ecc.;<br />
- i non professionisti dello spettacolo formati professionalmente come professionisti<br />
clown dottori;<br />
- i professionisti dello spettacolo, non volontari, provenienti dai più diversi ambiti<br />
teatrali, appositamente formati allo scopo di adattare le proprie capacità artistiche<br />
e umane al lavoro in ospedali, comunità, ecc.<br />
<strong>Il</strong> clown dottore è quindi colui che (a prescindere dal proprio titolo di studio)<br />
opera nei contesti di disagio utilizzando le arti del clown e integrandole con conoscenze<br />
psico-socio-sanitarie al fine di agire sulle emozioni, per modificarle.<br />
<strong>Il</strong> clown dottore va visto, quindi, come una figura di sostegno e di aiuto concreto ai<br />
percorsi terapeutici dei pazienti ospedalizzati operando in stretto contatto con l’équipe<br />
ospedaliera e indossando un camice da dottore variamente colorato allo scopo di ironizzare<br />
sulla figura medica e sovvertirne l’immagine rendendolo più umano.<br />
L’intervento dei clown dottori, inoltre, non è mai imposto in quanto non forzano<br />
mai il bambino e i genitori ad accettare la loro visita: se si rendono conto che<br />
il dolore del piccolo paziente è cosi forte da non potergli permettere di vivere il<br />
gioco in serenità si adeguano e limitano il loro intervento (ad es. facendo un timido<br />
saluto dalle vetrate, facendo volare bolle di sapone o semplicemente sorridendogli<br />
con dolcezza).<br />
L’intervento dei clown dottori si basa sull’improvvisazione potendo contare su<br />
un bagaglio di tecniche e conoscenze che spazia dal repertorio clown, alla giocoliera,<br />
alla magia, all’espressività teatrale. Risulta fondamentale mantenere sempre<br />
spontaneità e sincerità in modo da fare emergere l’originale comicità che ognuno<br />
racchiude in sé; i clown dottori operano lasciandosi guidare dall’ispirazione del<br />
momento. <strong>Il</strong> clown dottore coglie gli spunti della situazione e si lascia andare al<br />
suo estro clownesco, stando sempre attento ad osservare le reazioni, sia per lavorare<br />
su ciò che effettivamente è importante per il bambino, sia per valutare eventuali<br />
errori.<br />
Quando i bambini partecipano attivamente ai giochi dei clown dottori, come<br />
per esempio nella risoluzione di semplici conflitti o nel portare a termine buffe magie,<br />
ricavano dall’esperienza la sensazione di essere artefici di qualcosa di speciale,<br />
di “magico”. <strong>Il</strong> bambino sente che la sua collaborazione e tutto il suo essere sono<br />
importanti per il clown, anzi essenziali. E questo rinforza il senso di fiducia e di<br />
stima in se stesso e verso gli altri; rinnova la sua disponibilità alla collaborazione<br />
verso gli altri; stimola il suo processo di sviluppo.<br />
*Psicologo, clown dottore, membro dell’International Society for Humor Studies<br />
e del Gruppo P.A.T. - Dipartimento di Psicologia di Bologna,<br />
svolge la sua attività di ricerca sull’umorismo<br />
Temi ed esperienze<br />
93
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/<br />
Angelo Villa<br />
104<br />
A due Voci<br />
“Con tutto quel che oggi si sente dire in<br />
giro; con tutto quel che si vede alla televisione!”<br />
Chi non ha sentito ripetere recisamente<br />
frasi del genere, ogni qual volta si<br />
pone concretamente la possibilità d’esercizio<br />
di un’autonomia minima per un bambino?<br />
Fosse anche il tornare a casa da solo da<br />
scuola o il recarsi da un amico a giocare…<br />
L’ossessione della sicurezza (del bambino?<br />
Dei genitori?) contagia tutto e tutti. Cosa<br />
diavolo è mai successo?<br />
Sono le condizioni di<br />
vita dei bambini, in un<br />
mondo popolato quasi<br />
esclusivamente da tristi<br />
vecchi egocentrici, che<br />
sono divenute maggiormente<br />
a rischio?<br />
Oppure siamo noi che<br />
abbiamo fatto della paranoia<br />
il pane quotidiano<br />
con cui ci nutriamo<br />
avidamente da mattina<br />
a sera?<br />
Simili preoccupazioni<br />
ruotano attorno a un<br />
terrore che le domina<br />
in maniera assoluta,<br />
quello che riguarda il<br />
fantasma di un cattivo<br />
incontro tra un adulto<br />
perverso e il povero, ingenuo<br />
bambino.<br />
L’orco, il “malato”, da<br />
una parte, e l’innocente,<br />
la vittima, dall’altra.<br />
<strong>Il</strong> male assoluto, insomma,<br />
contro il bene;<br />
la sporcizia contro la<br />
Melanie Benjamin<br />
Sono stata Alice<br />
Fazi Editore, Roma 2010<br />
pp. 383, € 19,00<br />
<strong>Il</strong> libro è la biografia romanzata di Alice Pleasence<br />
Liddell, una delle eroine più famose<br />
della letteratura, che ispirò Alice nel paese<br />
delle meraviglie di Lewis Carroll, il libro<br />
che l'ha consegnata all'immaginario della<br />
sua epoca e degli anni a seguire.<br />
Alice, io narrante del romanzo, racconta per<br />
la prima volta la sua storia affascinante, segnata<br />
dal morboso rapporto (dietro il quale si<br />
staglia l'ambigua ombra della pedofilia) con<br />
il reverendo Charles<br />
Dodgson, alias Lewis<br />
Carroll, professore di<br />
matematica al Christ<br />
Church di Oxford il<br />
cui Decano era Henry<br />
George Liddell, padre<br />
di Alice.<br />
<strong>Il</strong> pomeriggio del 4<br />
luglio 1862, Charles<br />
Dodgson e il suo<br />
amico Robinson<br />
Duckworth portarono<br />
Alice, che all'epoca<br />
aveva 10 anni, e le sue<br />
sorelle Ina ed Edith a<br />
fare una gita in barca<br />
sul fiume Isis, durante<br />
la quale Dodgson iniziò<br />
a raccontare la storia<br />
di una bambina che<br />
seguì un coniglio nella<br />
sua tana. Alice Liddell,<br />
affascinata, gli chiese<br />
quindi di mettere la<br />
storia per iscritto.<br />
Gli ci vollero due<br />
anni ma alla fine, nel<br />
novembre 1864, con-<br />
Ambrogio Cozzi
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/a_due_voci<br />
purezza. Poche situazioni, come quelle<br />
proprie alla pedofilia o dintorni, sollecitano<br />
e mobilitano giudizi così netti, assoluti<br />
e condivisi.<br />
Eppure, appena un secolo fa, tale Sigmund<br />
Freud aveva fatto una scoperta che poi, alla<br />
prova della realtà, non era così originale.<br />
Con la sua abituale modestia, il maestro<br />
di Vienna andava dicendo che quel che lui<br />
asseriva era a perfetta conoscenza della più<br />
sprovveduta bambinaia. Inutile aggiungere<br />
che l’ipocrisia perbenista eresse subito<br />
un muro contro le sue spregiudicate tesi.<br />
Come poteva sostenere che i bambini avessero<br />
una loro sessualità? Cosa gli saltava in<br />
mente? A nulla valevano i supporti clinici<br />
che Freud esponeva in difesa delle sue tesi.<br />
La tesi che il bambino possedesse una sua<br />
economia di soddisfazione sessuale toglieva<br />
il sonno agli educatori d’ogni risma e categoria.<br />
L’idea, insomma, che il bambino non incarnasse<br />
quella sorta di figura angelica, in<br />
cui l’adulto si compiaceva di vederlo, era<br />
inaccettabile. Così, tempo fa. E oggi, invece?<br />
Qualcosa è cambiato?<br />
Le intuizioni rivoluzionarie e, in un certo<br />
senso, adultizzanti di Freud permangono<br />
tuttavia agli occhi di molti individui, specialisti<br />
compresi, come astruse, fuorvianti,<br />
addirittura nefaste. Con buona pace<br />
di Freud, il bambino è stato ricondotto a<br />
quell’icona rassicurante che sembra fatta<br />
apposta per custodire gelosamente e silenziosamente<br />
quel godimento che gli adulti<br />
(castamente?) gli rovesciano addosso.<br />
Uno dei più noti e ambigui rapporti che la<br />
storia della letteratura ricorda tra un adulto<br />
e un minore, una bambina in questo caso,<br />
fu quello tra il reverendo Charles Lutwidge<br />
Dodgson, in arte Lewis Carroll (l’autore<br />
del celeberrimo Alice nel paese delle meraviglie),<br />
e la piccola Alice Pleasance Liddell.<br />
segnò ad Alice un manoscritto rilegato in<br />
pelle intitolato Le avventure di Alice sotto<br />
terra, contenente illustrazioni curate da lui<br />
stesso e una fotografia di Alice a sette anni<br />
sul retro. Da quel momento fu allontanato<br />
dalla famiglia Liddell.<br />
Riteniamo che, per introdurre questo testo,<br />
la cosa migliore sia dare la parola all’autrice,<br />
ci si perdonerà la lunga citazione, ma crediamo<br />
che vi si possano rintracciare le ragioni<br />
e le fantasie che hanno orientato e ispirato<br />
la sua scrittura.<br />
“Alcuni anni fa, mentre vagavo per le sale<br />
dell’Art Institute of Chicago, mi imbattei in<br />
una mostra molto interessante: Dreaming in<br />
Pictures: The Photografy of Lewis Carroll.<br />
Conoscevo Lewis Carroll solo come autore del<br />
classico Alice nel Pese delle Meraviglie. Suppongo<br />
di essermelo sempre immaginato come<br />
una benevola figura paterna.<br />
Immaginate quindi la mia sorpresa, quando<br />
scoprii che le fotografie di Lewis Carroll (o del<br />
Reverendo Charles Lutwidge Dodgson, il suo<br />
vero nome) erano esclusivamente immagini di<br />
ragazzine. Ragazzine in pose alquanto provocanti.<br />
Anche se apparteneva all’ingenua epoca vittoriana,<br />
quella raccolta di fotografie mi sembrò<br />
inquietante. Tra quelle immagini affascinanti,<br />
una foto spiccava in particolare. Era la<br />
fotografia di una bambina vestita in modo<br />
succint, che metteva in mostra abbastanza<br />
pelle da far sentire a disagio anche me. Ma<br />
furono gli occhi a colpirmi; scuri, scintillanti,<br />
saggi, esperti, quasi insolenti. Gli occhi di una<br />
donna.<br />
La didascalia diceva che era Alice Liddell, sette<br />
anni, figlia privilegiata del Decano Liddell del<br />
Christ Church College di Oxford, dove Dodgson<br />
insegnava matematica; era la bambina che<br />
aveva ispirato il libro che aveva scritto il Reverendo<br />
con lo pseudonimo di Lewis Carroll. Un<br />
classico: Alice nel Paese delle Meraviglie.<br />
Cultura<br />
105
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/a_due_voci<br />
106<br />
Dodgson/Carroll era il terzogenito e primo<br />
maschio degli undici figli di un curato del<br />
Nord dell’Inghilterra. Legatissimo alla madre,<br />
si divertiva a giocare con le sette sorelle<br />
per le quali creò un giornalino di famiglia.<br />
Brillante logico e matematico, si fece diacono<br />
per assecondare l’insistenza paterna.<br />
Pare fosse un uomo timido, ma vanitoso.<br />
Amava le sue eccentricità, senza darsi<br />
troppa pena per gli altri. Capelli lunghi,<br />
stile effeminato, molto attento alla dieta:<br />
un salutista della prima ora. Era sordo da<br />
un orecchio, soffriva di balbuzie, incespicava<br />
sino al punto che quando parlava gli<br />
tremava tutto il labbro superiore. Per un<br />
diacono ciò non costituiva un handicap da<br />
poco, visto che lo costringeva a non predicare.<br />
Sintomaticamente, però, il disturbo<br />
spariva, quasi una magia, all’improvviso,<br />
quando parlava con le bambine. La sua<br />
gioia più grande, del resto, era quella di<br />
intrattenersi con loro. Le femmine, esclusivamente.<br />
Pare, infatti, che Charles nutrisse<br />
un vero e proprio orrore nei riguardi dei<br />
maschietti, che cercò di evitare per tutta la<br />
vita. Era attratto dai corpi delle bambine<br />
che ritraeva nude o discinte, in pose spesso<br />
equivoche, ma, ovviamente, con il permesso<br />
della mamma. Ebbe a scrivere: “Se<br />
avessi la più bella bambina del mondo da<br />
disegnare o fotografare e trovassi una sia<br />
pur modesta riluttanza (per quanto lieve e<br />
facile da superare) ad essere ritratta nuda,<br />
riterrei un solenne dovere nei confronti di<br />
Dio di lasciar cadere definitivamente la richiesta”.<br />
Simonetta Agnello Hornby ha scritto un<br />
racconto sulle ambigue passioni del nostro<br />
reverendo, dal titolo equivocamente perfetto,<br />
Camera oscura, che riporta alla fine<br />
alcune delle sue belle e celebri foto. E’ stato<br />
forse l’autore di Dietro lo specchio un Humbert<br />
Humbert, il protagonista della “Lolita”<br />
Mi domandai cosa le fosse accaduto, da grande.<br />
Mi domandai anche cosa fosse accaduto tra<br />
i due guardando quella fotografia tanto sorprendente.<br />
Pensai che poteva essere una storia<br />
interessante.<br />
Nel 1862, Charles Dodgson raccontò ad Alice,<br />
allora decenne, e alle sue due sorelle, la storia<br />
di una bambina che era caduta nella tana di<br />
un coniglio. Cosa molto insolita – perché lui<br />
aveva raccontato molte storie alle tre bambine<br />
– Alice gli chiese di scrivere proprio quella.<br />
Dodgson raccontava queste storie alle bambine<br />
perché provava una grande, bizzarra affinità<br />
nei loro confronti; lui viveva in un edificio<br />
accanto al Decanato, la dimora del Decano<br />
del Christ Church di Oxford e della sua famiglia.<br />
Nel 1863, dopo anni di cordiale frequentazione<br />
con questa famiglia, accadde qualcosa che<br />
provocò una rottura definitiva dei loro rapporti;<br />
allora Alice aveva undici anni e Dodgson<br />
trentuno. Qualche tempo dopo, la madre di lei<br />
aveva distrutto, bruciandola in un caminetto,<br />
tutta la corrispondenza intercorsa tra Alice e<br />
il Reverendo. Dopo la sua morte, i parenti di<br />
lui avevano eliminato, forse strappandole, le<br />
pagine del suo diario relative a quel periodo.<br />
Alice e la sua famiglia non parlarono più<br />
in pubblico dei rapporti intercorsi tra loro e<br />
Dodgson, se non più tardi, quando lei fu costretta<br />
a vendere il manoscritto originale di<br />
Alice nel Paese delle meraviglie per salvare la<br />
sua amata casa. Fu solamente allora che sembrò<br />
che lei fosse capace di accettare il ruolo che<br />
aveva avuto nella creazione di quel capolavoro<br />
senza età.<br />
Questa era la storia che dovevo scrivere: le<br />
avventure di Alice dopo che aveva lasciato il<br />
Paese delle Meraviglie. Mi sembrava che tutto<br />
ruotasse attorno a ciò che era accaduto tra<br />
l’uomo e la bambina prima di quella misteriosa<br />
rottura, in quello splendido pomeriggio<br />
d’estate.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/a_due_voci<br />
del grandissimo Nabokov, vittoriano? Chi<br />
può dirlo? Fu un esteta? Un artista? Un pedofilo?<br />
Si chiede la scrittrice siciliana. D’accordo.<br />
Sì, ma i bambini, anzi, le bambine,<br />
anzi, Alice. Cosa si può dire di lei?<br />
Ora, io non so cosa abbia spinto Melanie<br />
Benjamin a identificarsi in maniera così<br />
esplicita nella piccola Liddell nel suo primo<br />
romanzo, quale inconscia intuizione le sia<br />
passata per la mente. Analiticamente sarebbe<br />
interessante saperlo. Anche il suo titolo,<br />
d’altronde, parla chiaro, sembra un indizio:<br />
Sono stata Alice. Ma lasciamo perdere,<br />
non è questo il punto. Sta di fatto che, per<br />
una volta, è per il tramite di questa finzione<br />
che un’eco del complesso rapporto che una<br />
bambina può intrattenere con la sessualità<br />
trova una sua voce. Può darsi che talune<br />
espressioni risultino eccessive, adulterazioni<br />
“adulteggianti” forse esagerate, troppo<br />
romanzate, come: “Volevo essere speciale,<br />
volevo essere bellissima, volevo essere amata”.<br />
Oppure, forse, insisto sul forse, non lo<br />
sono. <strong>Il</strong> libro della Benjamin si legge piacevolmente,<br />
è ben costruito e appassionante.<br />
Non ci risparmia nemmeno l’incontro tra<br />
Alice e … Peter Pan. Se ne consiglia vivamente<br />
la lettura ai nuovi e indefessi moralisti,<br />
psicologi e magistrati in testa, impegnati<br />
nella difesa a oltranza del bambino, quasi<br />
fosse una sorta di piccolo panda in versione<br />
umana da proteggere dal mondo. O, più<br />
realisticamente, dai loro fantasmi.<br />
Non sono una storica, non sono una studiosa<br />
di Lewis Carroll; di quelli ce ne sono molti,<br />
e questa non è la sua storia. Non ho alterato<br />
i fatti noti della vita di Alice, con l’eccezione<br />
dell’ultima fotografia fatta da Dodgson quando<br />
lei era una giovane donna; questa, in realtà,<br />
fu scattata quando Alice aveva diciotto<br />
anni, quindi prima del periodo in cui il Principe<br />
Leopold visse a Oxford.<br />
Ma che dire di quella rottura? Cosa avvenne<br />
realmente in quel pomeriggio d’estate da portare<br />
a una frattura così definitiva tra Dodgson<br />
e Alice? Come romanziera, quello era il mio<br />
regalo più grande. Perché nessuno – né Dodgson,<br />
né Alice, né sua madre, né le sue sorelle<br />
– ne ha mai parlato pubblicamente, se non<br />
per un interessante accenno in una lettera ad<br />
Alice da parte di sua sorella Ina, poco prima<br />
della loro morte. Ci furono delle chiacchiere,<br />
naturalmente, perché Oxford era famosa<br />
per i suoi pettegolezzi. Ma quello, uno degli<br />
eventi principali della vita di Alice – forse il<br />
più importante – rimane tuttora avvolto delle<br />
congetture.<br />
Tuttavia, il fatto più importante che si conosce,<br />
è stato sviluppato in un’opera di fantasia:<br />
un piccolo volume, ancora oggi un classico<br />
della letteratura, Alice nel Paese delle Meraviglie.<br />
Questo è ciò che rimane; questo è ciò<br />
che, credo, la stessa Alice avrebbe voluto che<br />
rimanesse.<br />
Spero che la sua storia vi sia piaciuta”<br />
Cultura<br />
107
libri<br />
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/<br />
a cura di Ambrogio Cozzi<br />
108<br />
Scelti per voi<br />
libri, cinema, musica<br />
Giovanna Spagnuolo<br />
(a cura di)<br />
Intercultura<br />
e formazione.<br />
I lineamenti teorici<br />
e le esperienze<br />
Franco Angeli, Milano<br />
2010<br />
pp. 144, p. € 17,00<br />
<strong>Il</strong> volume si colloca su<br />
un percorso già felicemente avviato dalla<br />
Curatrice con la pubblicazione de <strong>Il</strong> magico<br />
mosaico dell’intercultura. Teorie, mondi,<br />
esperienze (Franco Angeli, 2007) in cui la<br />
criticità del binomio intercultura/formazione<br />
veniva sottolineata non solo in tutta<br />
la sua dirompente problematicità, bensì<br />
nell’ottica propositiva di far emergere la<br />
sfida che la globalizzazione pone a ciascuno<br />
di noi, in termini di adesione attiva e<br />
partecipe alla nuova società, che si profila<br />
sempre più chiaramente all’orizzonte in<br />
questo Terzo Millennio.<br />
L’approccio intenzionalmente perseguito<br />
dalla curatrice è interdisciplinare,<br />
con lo scopo di permettere un confronto<br />
approfondito sulla complessità<br />
del tema trattato, ovvero la necessità di<br />
preconizzare una forma di “cittadinanza<br />
europea”, che non pare ancora ben<br />
teorizzata e compiuta, così come l’idea<br />
di una “identità ed appartenenza” europea,<br />
che possa essere fondata su alcuni<br />
elementi comuni.<br />
I quattordici saggi che compongono il<br />
volume sono razionalmente suddivisi in<br />
tre parti distinte che si completano sinergicamente.<br />
Nella prima sezione, “Gli<br />
scenari”, si ragiona approfonditamente<br />
su parole-chiave di grande respiro teorico<br />
come i diritti umani, il dialogo e l’inclusione<br />
sociale, con l’esplicita finalità<br />
di far emergere un contesto eticamente<br />
alto al quale ogni modello comportamentale<br />
debba essere rapportato. Ne “I<br />
lineamenti teorici” gli autori mettono<br />
in esplicito rilievo la questione educativa<br />
come sfida per il futuro e come base<br />
per la costruzione di un’identità comune<br />
costruita sulla tolleranza, sul rispetto,<br />
nonché sul reciproco riconoscimento.<br />
Nella sezione dedicata a “Le esperienze”,<br />
si descrivono le buone prassi tratte<br />
da contesti assai differenziati: si tratta di<br />
esempi che denotano come si possa fare<br />
intercultura dando corpo e sostanza ai<br />
principi e agli ideali che siamo forse abituati<br />
a pensare come meramente teorici<br />
e, talvolta, privi di una specifica adattabilità<br />
ad ambiti nuovi o inusuali.<br />
Forti e giustamente sottolineate sono<br />
le criticità nello sforzo di costruire una<br />
nuova cittadinanza: se, infatti, la Comunità<br />
Europea pare procedere senza<br />
intoppi di sorta, nel suo sviluppo sul<br />
piano istituzionale ed economico, non<br />
altrettanto chiara sembra la volontà di<br />
edificare una “casa comune” sotto il<br />
profilo civico e culturale. In aggiunta,<br />
da molti saggi pare evidenziarsi una sorta<br />
di cahier de doléances che riguarda<br />
la scuola: se da una parte si sottolinea<br />
come la scuola sia l’unico luogo che può<br />
avere tutte le potenzialità richieste ad<br />
un ente di socializzazione, è altrettanto<br />
vero come sia carente la formazione e<br />
l’aggiornamento dei docenti sulle tematiche<br />
dell’intercultura. Altrettanto chiara<br />
è la necessità di transitare da un multiculturalismo<br />
ingannevole e a rischio<br />
di emarginazione culturale per coloro
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/scelti_per_voi<br />
che restano ai margini, ad un sincero<br />
atteggiamento interculturale, basato su<br />
un pensiero critico, aperto, alieno dai<br />
pregiudizi e dalle facili mistificazioni.<br />
Dunque un volume ricco di suggestioni,<br />
di aperture conoscitive, stimolante per<br />
la fiducia che la positività degli esempi<br />
proposti garantiscono a chi si avventura<br />
nel complesso “viaggio culturale”, come<br />
ben afferma la curatrice (pp. 9-10), un<br />
iter che deve diventare cammino condiviso<br />
per coloro che, a tutti i livelli, hanno<br />
il delicato compito di fare formazione<br />
con le generazioni che edificheranno<br />
la società del futuro.<br />
Antonella Cagnolati<br />
Francesco Berto,<br />
Paola Scalari<br />
Padri che amano<br />
troppo. Adolescenti<br />
vittime di attrazioni<br />
fatali<br />
La meridiana,<br />
Molfetta, 2009<br />
pp. 128, p. € 14,00<br />
Padri che amano<br />
troppo: ma cosa vorrà<br />
dire realmente “amare troppo”? <strong>Il</strong><br />
titolo si propone con un ossimoro che<br />
incuriosisce, ma al contempo inquieta.<br />
Amare è un termine dal sapore tutto al<br />
positivo, che difficilmente può essere<br />
concepito come un qualcosa di erroneo,<br />
di eccessivo, di nocivo. Troppo è un avverbio<br />
che suona come un rimprovero,<br />
che ci mette in guardia e ci ricorda il<br />
naturale equilibrio delle cose.<br />
E’ proprio da questo sottile tranello iniziale<br />
che il libro di Francesco Berto e<br />
Paola Scalari ci conduce dentro le storie<br />
di padri dei nostri giorni, così diversi,<br />
ma così uguali a quelli di qualche anno<br />
fa, alle prese con i loro figli adolescenti e<br />
con le loro paure, le loro contrazioni, le<br />
loro insicurezze e i loro eccessi.<br />
<strong>Il</strong> libro ci introduce subito alla consapevolezza<br />
che mai come in questi anni,<br />
di rivoluzione sociale, il ruolo del padre<br />
ha dovuto cambiare volto e reinventarsi:<br />
non sta più, severo osservatore, sullo<br />
sfondo della scena della vita dei figli che<br />
crescono; non è più l’unica fonte di sostentamento<br />
per la famiglia; non incute<br />
più quella sacra riverenza che mantiene<br />
le distanze; non è più l’uomo tutto d’un<br />
pezzo, saldo e difficilmente perturbabile.<br />
<strong>Il</strong> mutamento triangolare che caratterizza<br />
i nostri giorni ci porta quindi faccia<br />
a faccia con questi nuovi uomini, che<br />
si trovano in diretta e violenta relazione<br />
con i loro figli senza avere, per varie<br />
vicissitudini di vita, la protezione e<br />
la complicità della donna, di colei che<br />
materialmente ha dato alla luce il bambino<br />
e che storicamente deve fondersi<br />
e distaccarsi da lui per permettergli di<br />
crescere come individuo affettivamente<br />
autonomo.<br />
E da questa nuova figura di padre che<br />
quasi si reinventa madre, nascono le<br />
storie di questo libro che ci mettono in<br />
prima linea spettatori di realtà tanto inquietanti<br />
quanto quotidiane di padri e<br />
figli vittime della loro esistenza.<br />
In un continuum, che va dalla “soffice”<br />
storia di Rocco alla straziante vicenda<br />
di Veronica, ci sfilano davanti le vite di<br />
ragazzi e ragazze, alle prese con la loro<br />
fatica di crescere, con tutte le loro paure<br />
e inadeguatezze dove l’incontro o lo<br />
scontro con il padre rende questo già<br />
difficile processo ancora più esasperato.<br />
Ed è così che in una solida cornice spaziale,<br />
che si concretizza in Venezia e i<br />
suoi dintorni, tanti nomi di ragazze e<br />
Cultura<br />
109
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/scelti_per_voi<br />
110<br />
tanti nomi di ragazzi si rincorrono tra<br />
le pagine drammaticamente appassionanti<br />
di questo libro, e i loro padri e<br />
le loro storie tutte diversamente così<br />
invischianti ne disegnano quello che ci<br />
appare come un ineluttabile destino.<br />
… Ed è proprio nell’ultima storia,<br />
quando anche noi ci troviamo in volo<br />
a mezz’aria con la protagonista, che nelle<br />
sue parole troviamo un’imbarazzante<br />
via di uscita che sembra vanificare quella<br />
sensazione soffocante, quella sensazione<br />
di troppo… Veronica non dice molto…<br />
dice semplicemente “papà”.<br />
Giulia Rossetti<br />
Eugenio Rossi<br />
Paure e bisogni di<br />
sicurezza degli anziani<br />
Bruno Mondadori,<br />
Milano 2009<br />
pp. 192, p. € 15,00<br />
<strong>Il</strong> disagio evolutivo<br />
non è una prerogativa<br />
di una stagione<br />
della vita, in particolare di quella<br />
iniziale, dove esploratori senza mappa<br />
si provano quotidianamente. Tutto<br />
il tempo dell’esistenza umana, sulla<br />
scena dell’azione sociale, richiede forti<br />
capacità di adattamento e suscita<br />
continui mutamenti nei sentimenti<br />
e nell’emotività degli attori in gioco.<br />
L’evidenza scientifica prova che proprio<br />
la classe di età più anziana subisce<br />
in maniera più forte ed accentuata, a<br />
causa della maggiore vulnerabilità, le<br />
insidie e le insicurezze presenti nella<br />
vita quotidiana.<br />
Questo saggio rappresenta il felice<br />
esito di un’indagine sulla percezione<br />
della criminalità e sui bisogni di tutela<br />
individuale e collettiva degli anziani,<br />
dei Comuni dei territori a sud di<br />
Milano. L’indagine qualitativa e motivazionale<br />
ha interrogato un campione<br />
di 255 anziani sulla qualità della vita<br />
e sugli aspetti di criticità. L’indagine è<br />
importante perché rappresenta la testimonianza<br />
autentica di uno spaccato di<br />
stili di vita e di preoccupazioni reali,<br />
che, in parte e in similitudine, è stato<br />
sondato nelle due ricerche sulla vittimizzazione<br />
in Italia dall’ISTAT e da<br />
Carrer su un campione di anziani della<br />
città di Genova. Siamo all’inizio di un<br />
nuovo modo di incontrare e interpretare<br />
la realtà in cui viviamo; è uno dei<br />
primi tasselli di indagini di self-report<br />
(resoconto di sé) sull’opinione pubblica.<br />
Nessuno di noi è “nato imparato” e<br />
può arrogarsi di rappresentare i bisogni<br />
dei nostri simili. Questo lavoro afferma<br />
l’importanza di seguire una nuova<br />
strada, un nuovo metodo ecologico,<br />
per ascoltare i bisogni della gente e per<br />
fare un bagno di umiltà prima di proporre<br />
politiche sociali.<br />
<strong>Il</strong> volume parte dal presupposto che<br />
la condizione anziana misuri e produca<br />
sentimenti di paura nell’interazione<br />
sociale della vita quotidiana. Per questo<br />
sono state sondate la consistenza e la natura<br />
delle reti di amicizia, di sostegno e<br />
di protezione che circondano gli anziani<br />
e l’incidenza delle fonti di informazione<br />
televisive e della carta stampata che<br />
concorrono a formare le opinioni sulla<br />
realtà circostante. Assieme alle informazioni<br />
relative alla condizione di salute,<br />
alla scolarità ed ai mestieri patrimonio<br />
degli anziani intervistati, queste risultanze<br />
sulle reti di socializzazione sono<br />
state incrociate con una batteria di que-
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/scelti_per_voi<br />
siti sui reati realmente subiti, o a cui si<br />
è stati testimoni, o che si temono di più<br />
nella propria esistenza.<br />
Collocare il problema della sicurezza<br />
dentro i fattori relazionali e culturali<br />
dell’esistenza quotidiana degli anziani,<br />
permette all’indagine di suggerire concrete<br />
ipotesi di sviluppo della comunità,<br />
di buone prassi che possono essere prese<br />
a modello dai decisori politici nei territori<br />
considerati.<br />
Molti quesiti sondavano la qualità della<br />
vita nei Comuni considerati ed i luoghi<br />
ed i tempi quotidiani della paura.<br />
La ricerca empirica voleva approfondire<br />
le rappresentazioni sociali dell’insicurezza<br />
e la paura di vittimizzazione,<br />
comprendendone i riflessi sui comportamenti<br />
agiti nella vita quotidiana e<br />
sulle reali necessità di protezione. Questo<br />
è il vero valore aggiunto dell’indagine<br />
che affronta il punto di vista degli<br />
anziani, l’influenza della paura e i<br />
cambiamenti messi in atto nelle loro<br />
abitudini quotidiane e suggerisce, a<br />
tutti noi, un arco di bisogni concreti e<br />
di misure di protezione da realizzare a<br />
loro tutela.<br />
Anche nella parte del saggio che affronta<br />
la vittimizzazione subita, l’autore si<br />
concentra sulle conseguenze fisiopsichiche<br />
subite e sviluppate nel tempo dagli<br />
anziani e sulle ragioni che hanno motivato<br />
la denuncia o il non ricorso alla<br />
denuncia.<br />
<strong>Il</strong> libro è un punto di vista, è un racconto,<br />
è un approfondimento sull’influenza<br />
che le reti sociali hanno nel mitigare il<br />
sentimento della paura nelle interpretazioni<br />
della vita quotidiana ed è, anche,<br />
una riuscita testimonianza dei risvolti<br />
psicologici che governano la paura.<br />
Maria Piacente<br />
Codrignani Giancarla<br />
Ottanta, gli anni di<br />
una politica<br />
Editore Servitium,<br />
Fontanella di Sotto<br />
il Monte (BG), €<br />
16,00, pp. 224<br />
Due volte 80 Codrignani<br />
una signora<br />
della politica<br />
Non fosse “una delle figure più rappresentative<br />
della cultura italiana della nonviolenza”<br />
(così su Wikipedia), Giancarla<br />
Codrignani sarebbe una combattente;<br />
ma per rispetto alle sue convinzioni anche<br />
Stefano Rodotà la definisce “uno spirito<br />
indomito”. Quanto a lei, raggiunta la soglia<br />
dei suoi primi ottant'anni, tra le sue<br />
molte identità (docente, filologa, giornalista,<br />
cattolica, laica, teologa, femminista,<br />
pacifista) ha scelto quella oggi più difficile<br />
da indossare: politica. E ci gioca con autoironia<br />
nel titolo del libro che ora offre<br />
come un rendiconto alla sua città; Ottanta,<br />
gli anni di una politica (Servitium<br />
Editore) contiene, ovviamente, anche un<br />
altro gioco di parole: Ottanta è il decennio<br />
che la vide impegnata nella politica<br />
istituzionale, tre legislature in Parlamento<br />
come indipendente di sinistra. SE LA politica<br />
a Bologna non fosse quel paesaggio<br />
maciullato che è, avrebbe in Giancarla<br />
una coscienza critica: ruolo che lei s'è ritagliato<br />
comunque nel circolo di amici che<br />
riunisce da anni sotto il nome eloquente<br />
di Capire. Questo libro è un repertorio<br />
di temi che la politica va trascurando,<br />
sotto forma di antologia di articoli scritti<br />
in oltre cinquant'anni e cuciti con brevi<br />
note in un "diario in pubblico" sullo stile<br />
del suo amato Vittorini: più richiami al<br />
presente che rimpianti per il passato. Un<br />
Cultura<br />
111
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/scelti_per_voi<br />
112<br />
dizionario di argomenti che oggi sembrano<br />
avere un suono antico: cos'è la guerra?<br />
E la laicità? E l'etica? Su, chi risponde?<br />
Giancarla risponde, e le sue risposte scontentano<br />
perché non sono mai omologate.<br />
Come credente prima di tutto: cioè come<br />
laica, “perché i credenti dovrebbero essere<br />
i più laici di tutti”. Ribelle alle etichette.<br />
Cattolica di quelle che “quando il Vaticano<br />
si pronuncia, s'arrabbia più dell'ateo”.<br />
Scrivendo sul caso Englaro, confessa<br />
un amaro ricordo privato: “Nessuno mi<br />
disse che si poteva forzare la durata della<br />
macchina che aveva preso il posto del<br />
mio babbo; l'avrei certamente preteso”.<br />
Terzomondista, dice no ai Radicali quando<br />
le chiedono una firma contro la fame<br />
nel mondo, perché “anche il grano può<br />
essere usato come un'arma”. Eletta nelle<br />
liste Pci, si batte per la libertà di Sacharov.<br />
Pacifista, si aggiorna sui sistemi d'arma<br />
delle new war perché “per combattere la<br />
guerra devi conoscerla”. E ogni tanto traduce<br />
dal greco antico, cosa? Saffo, donna<br />
fra donne, il cui “amore in sé limpido viene<br />
insudiciato dall'ipocrisia della malizia”.<br />
Difficile fare i conti con Giancarla se non<br />
si accettano anche le sue utopie (nel 2008<br />
propose una “moratoria internazionale<br />
delle guerre”). Perché il libro? Per dare un<br />
piccolo rendiconto, dice lei. Ma, forse,<br />
anche perché Giancarla la pensa come la<br />
sua rimpianta amica Aura Maria Arriola,<br />
antropologa "guerrigliera" guatemalteca,<br />
che un giorno le confessò: “Se fossi stata<br />
uomo, alla mia morte qualcuno scriverebbe<br />
di me; ma sono una donna ed è meglio<br />
che provveda da sola”.<br />
Michele Smargiassi<br />
(Recensione su La Repubblica, 2 dicembre<br />
2010. Si ringrazia l'editore per l'autorizzazione<br />
alla pubblicazione).<br />
Artisti Vari<br />
No One Knows<br />
About Persian<br />
Cats: The Soundtrack<br />
Milan Records,<br />
2010, € 9,65<br />
Mohsen Namjoo<br />
Oy<br />
Stradivarius - Fabrica,<br />
2009,€ 11,93<br />
Non nutro grandi<br />
passioni per la politica,<br />
non ci riesco, è più forte di me. Mi<br />
verrebbe da dire che, quando il delirio<br />
era la norma, ivi compreso il mio ben<br />
s’intende, ho già dato. E’ una scappatoia,<br />
una risposta stupida e cialtrona,<br />
ma mi viene così, anche a sforzarmi,<br />
proprio non ci riesco. Che ci devo fare?<br />
In questa sorta di “desolation row” che,<br />
nella mia mente e nel mio cuore, tiene<br />
il posto che dovrebbe spettare alla politica,<br />
un’attenzione del tutto differente<br />
è invece riservata a quel che accade in<br />
Iran. Mi colpisce e mi addolora sinceramente<br />
la storia di quel travagliato e<br />
nobile Paese.<br />
Passato dallo Scià a Khomeni, ai mullah<br />
al delirante Al. Da una dittatura a<br />
un’altra senza che, dall’esterno, nessuno<br />
osasse alzare un dito, protestare. I contestatori<br />
professionisti, i bruciatori di<br />
bandiere, gli imbrattatori di muri, gli<br />
inventori degli slogan più trucidi, mai<br />
che abbiano proferito o proferiscano<br />
verbo quando a Teheran si massacra e<br />
s’imprigionano giovani, studenti, intellettuali<br />
o donne che osano ribellarsi. Un<br />
silenzio assordante, una latitanza imbarazzante,<br />
se si pensa alla sinistra.<br />
musica a cura di Angelo Villa
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/scelti_per_voi<br />
Quale ne è la ragione? Immagino, e se mi<br />
sbaglio mi si corregga, che non si voglia<br />
infastidire i pii musulmani, le obbedienti<br />
masse arabe. Forse, inoltre, qualcuno pensa<br />
che sostenere i sogni di libertà iraniani<br />
sia fare il gioco del capitalismo occidentale.<br />
E’ una scemenza che mi è capitato<br />
di sentire da uno che si picca di essere un<br />
alternativo. Mica uno qualsiasi!<br />
E allora? Allora, rock! Tocca ancora una<br />
volta alla musica, alla canzone dare voce<br />
alle aspirazioni, ai desideri di chi vuole<br />
esprimersi, vivere. In una parola, provare<br />
a prendersi in mano la responsabilità e<br />
il senso della propria esistenza. La cosiddetta<br />
rivoluzione di velluto di Praga,<br />
quella che portò al potere Havel, prende<br />
il suo nome da un mitico gruppo rock,<br />
i Velvet (per l’appunto) Underground.<br />
Insomma, Nico, Lou Reed e soci… E<br />
in Iran? Vi consiglio due cd che vale la<br />
pena di ascoltare. <strong>Il</strong> primo, molto bello,<br />
è la colonna sonora di un film altrettanto<br />
bello e struggente: Gatti persiani del<br />
regista Bahman Ghobadi, perseguitato<br />
dalla censura del suo Paese. Se non lo<br />
avete ancora visto, procuratevelo perché<br />
ne vale la pena. Purtroppo, il film risente<br />
del prezzo che ha dovuto pagare alla repressione<br />
del moralismo dei mullah e dei<br />
loro compagni, ma è toccante, veramente.<br />
Mostra che cosa significa cercare di<br />
fare musica pop in una dittatura che non<br />
la tollera, che la vive come una minaccia<br />
ai saldi principi morali che l’ipocrisia religiosa<br />
detta. Su un numero di qualche<br />
mese fa della rivista Indice (mannaggia,<br />
io non lo trovo più, chissà dov’è, ma voi,<br />
voi che siete abili, potete cercarlo su internet…)<br />
si trova un’ottima recensione,<br />
molto accurata ed esaustiva, del film e<br />
delle vicissitudini che ha patito il regista.<br />
<strong>Il</strong> cd è di grande qualità e varietà, rac-<br />
coglie il contributo di diversi artisti. Si<br />
parte con un brano di rap iraniano, poi<br />
si prosegue con un pezzo pop cantato in<br />
inglese e via di seguito. E’ tutta gente che<br />
sa suonare con la tecnica e con l’anima.<br />
Sarò un romantico, ma la mia preferenza<br />
va alla traccia numero sette, in cui Mirza<br />
canta “Emshab”. <strong>Il</strong> pezzo vale da solo<br />
l’intero cd. Un pezzo che strappa il cuore,<br />
non ho aggettivi a cui ricorrere.<br />
Spegnete la luce, create il silenzio intorno<br />
a voi, alzate il volume e lasciate che<br />
la sua musica vi entri dentro, regalandovi<br />
una sensazione d’intensità rara, unica.<br />
E’ il miracolo che una canzone può<br />
produrre. Voi dite: non comprendiamo<br />
le parole. Lo so, rispondo, ma non importa.<br />
Ve lo assicuro.<br />
<strong>Il</strong> secondo cd, invece, è quello di Mohsen<br />
Namjoo, detto il Dylan persiano,<br />
e si chiama “Oy”. Trascinante il brano<br />
d’apertura che sfuma riprendendo addirittura<br />
“Bang bang” di Sonny & Cher.<br />
C’è poi anche una bella versione di “Cielito<br />
lindo”. Insomma, la musica gira, passa<br />
le frontiere, circola nelle fessure che apre<br />
nei muri. Non ama le cupe barbe dei pruriginosi<br />
mullah, le sentenze fascistoidi di<br />
deliranti imam, … Dimenticavo, un’eccezione.<br />
Avevo già scritto queste note,<br />
quando mi è capitato di vedere, una domenica<br />
sera alla televisione, le immagini<br />
di giovani iraniani picchiati, brutalizzati.<br />
In sottofondo passava una canzone partigiana:<br />
“Bella ciao”. La rete era la Sette, il<br />
programma “Niente di personale”, mi ha<br />
commosso, emozionato. Ascoltate i “gatti<br />
persiani” o Namjoo. Sarà il rock e non la<br />
bellezza, come supponeva il grande russo,<br />
a salvare il mondo? Chissà? Rock on …<br />
Un riff seppellirà i mullah fascistoni e i<br />
loro feroci e stupidi servitori!<br />
Angelo Villa<br />
Cultura<br />
113
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/scelti_per_voi<br />
cinema<br />
a cura di Cristiana La Capria<br />
114<br />
Una vita tranquilla<br />
di Claudio Cupellini<br />
Germania, Francia,<br />
Italia 2010<br />
Produzione Acaba<br />
Produzioni,<br />
Babe Film, EOS<br />
Entertainment,<br />
Hofmann & Voges<br />
Entertainment GmbH<br />
Chi è 'o bbuono e chi è 'o malamente?<br />
Bisogna approvare la bellezza di questo<br />
film, che suggerisco a tutti gli adulti che<br />
vogliono vedere meglio.<br />
Dai fotogrammi passano attraverso gli<br />
occhi innumerevoli e pressanti questioni<br />
che tutte le si vorrebbe sviscerare ma<br />
che, per motivi logistici, qui riduciamo<br />
a due: il limite tra legale e illegale, il potere<br />
educativo nella distanza.<br />
La prima sequenza apre su una radiografia<br />
ravvicinata delle vene di un tronco<br />
d’albero; man mano che la ripresa si allontana<br />
l’albero appare sempre più alto,<br />
circondato da altri alberi a formare una<br />
immensa foresta tedesca. Una costruzione<br />
in pietra spunta da una radura, si<br />
legge “da Rosario”, tipica insegna di ristorante.<br />
Ancora più dentro, nei locali<br />
della cucina, vediamo armeggiare con le<br />
pentole lui, Rosario, cioè lo chef, intorno<br />
a cui ruotano una serie di assistenti,<br />
oltre alla moglie e al giovane figlio. Fin<br />
qui ci conducono le inquadrature, una<br />
musica d’acciaio e poche parole. Ma chi<br />
è quest’uomo? Che dà nutrimento agli<br />
umani con la sua cucina e però devitalizza<br />
gli alberi con chiodi iniettati nel tronco?<br />
Che urla aggressivo contro i dipendenti e<br />
accarezza la guancia del figlio?<br />
Le anomalie del comportamento restano<br />
confezionate dai nastrini tipici di<br />
una “vita tranquilla”: un lavoro onesto,<br />
una bella casa, una brava famiglia. Ma<br />
una delle solite mattine, mentre Rosario<br />
sta per colmare i piatti di prelibatezze<br />
alla tavola dei suoi ospiti, qualcuno<br />
fuori dalla finestra calamita il suo<br />
sguardo che, come un fuori campo, un<br />
fuori pasto si insinua velenoso nella sua<br />
tranquillità: è il figlio maggiore, Diego.<br />
Questo figlio, rimasto a Napoli insieme<br />
al resto della sua vita passata, gli riporta,<br />
fino in Germania, il ricordo dei suoi<br />
trascorsi di uomo “malamente” che si è<br />
sporcato di crimini e delitti.<br />
Più impacchettiamo rigidamente con<br />
carta colorata l’uovo di Pasqua della nostra<br />
vita rinnegata, più quella carta tende<br />
a stropicciarsi e a mostrare le brutture<br />
nascoste. Lui, Rosario, è un pentito<br />
che se l’e svignata dal posto in cui viveva,<br />
ha messo chilometri di distanza e di<br />
tempo tra il proprio sé cattivo e il proprio<br />
sé ripulito. Nulla può ostacolare il<br />
suo percorso riabilitativo verso una vita<br />
calma, composta, senza sbalzi emotivi,<br />
rispettabile, tranquilla appunto. Nulla<br />
e nessuno. Neppure il figlio. Che, rigorosamente,<br />
ha imitato l’attitudine criminale<br />
del papà cattivo; è diventato un<br />
malvivente, uno della camorra, uno che<br />
ammazza la gente.<br />
Ha ripetuto la disposizione del padre,<br />
anche se questo padre non lo vedeva da<br />
anni, anche se questo padre aveva annullato<br />
ogni indizio di malvivenza dai<br />
suoi documenti personali. O proprio<br />
per questo. Per questa lontananza e per<br />
allentarne gli effetti dolorosi, il figlio<br />
emula il padre. Non si sottrae alle pressioni<br />
di quel sistema diabolico che lo<br />
seduce, si fa prendere all’amo e diventa<br />
criminale. <strong>Il</strong> potere educativo del padre<br />
a distanza è tanto. Quando sorprende
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/scelti_per_voi<br />
da lontano il figlio nel bel mezzo di un<br />
gesto omicida, gli basta gridare “Diego”<br />
per pietrificare la mano del giovane con<br />
la pistola. <strong>Il</strong> figlio, in quel momento,<br />
non uccide. Ma il padre, dopo, si. Colpisce<br />
a morte il delinquente amico del<br />
figlio, quello che minaccia la sua vita<br />
tranquilla, lo fa senza un centimetro di<br />
rimorso. Impone al figlio di non uccidere<br />
ma lui uccide, eccome, per preservare<br />
la sua vita da ex-assassino. Tra i due<br />
criminali, tra il padre pentito e il figlio<br />
militante, chi è il buono e chi è il malamente?<br />
Sullo sfondo metallico di un paesaggio<br />
severo, fasci di sguardi densi emanano<br />
bagliori di passioni contraddittorie che<br />
ci risucchiano gli occhi dentro al loro<br />
pericoloso perimetro. E quando ne<br />
veniamo fuori non siamo più uguali a<br />
prima.<br />
Cristiana La Capria<br />
Cultura 115
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/<br />
ARRIVATI_IN_REDAZIONE<br />
116<br />
Adinolfi Isabella, Galzigna Mario (a cura di),<br />
Derive. Figure della soggettività.<br />
Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2010, pp. 339, € 20,00<br />
Rispetto ai saperi codificati e alle discipline accademiche consolidate, il percorso<br />
a più voci che qui presentiamo - l’erranza, il libero vagabondaggio lungo i<br />
più svariati profili della presenza - assume i caratteri di un movimento creativo<br />
e proteiforme. L’ambigua e poliedrica complessità semantica del termine “deriva”,<br />
perennemente in bilico tra il normale e il patologico, viene qui messa<br />
in gioco per mettere a fuoco la vasta gamma di significati e di sfumature che<br />
caratterizzano alcuni stati d’animo ed alcune esperienze soggettive: la malinconia,<br />
il furore, la disperazione, l’angoscia, la noia, la tristezza, la solitudine,<br />
l’ossessione...<br />
Cruz Manuel<br />
I brutti scherzi del passato.<br />
Identità, responsabilità, storia<br />
Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 164, € 18,50<br />
Tema centrale del libro è la memoria: l'autore esprime forti riserve contro<br />
l'eccesso di memoria che affligge il nostro tempo, contro quella che definisce<br />
un’industria della nostalgia. <strong>Il</strong> rapporto con il passato è materia molto delicata:<br />
il ricordo non è mai innocente. <strong>Il</strong> risultato è che il presente viene svuotato<br />
di contenuto, l'idea di futuro è scomparsa dal nostro campo visivo, ci si rivolge<br />
sempre più al passato come se non rimanesse altro progetto possibile che<br />
conservare il meglio di ciò che è stato. Di fronte a questi guasti e ai pericoli<br />
della malinconia e del rimpianto, Manuel Cruz rivendica come necessarie<br />
l'autonomia e la funzione critica della memoria…<br />
Edoardo Boncinelli, Michele Di Francesco<br />
Che fine ha fatto l'io?<br />
Editrice San Raffaele, Milano 2010,<br />
pp 208, € 19,50<br />
Chi è il colpevole? Forse una pigrizia mentale che ci spinge a non discutere<br />
i paradigmi del quotidiano. Forse una cultura ingessata su concetti divenuti<br />
dogmi. L’io oggi è scontato al punto che nel nostro immaginario non c’è<br />
scampo al farvi ricorso. Ma siamo sicuri che “io” voglia dire la stessa cosa<br />
anche solo da un giorno all’altro? Come ricostruiamo ciò che ci permette<br />
di avere un’identità, di essere riconoscibili ai nostri stessi occhi, di spiegare i<br />
nostri comportamenti, di assumerci responsabilità e, in sostanza, di dire “io”?<br />
Un filosofo della mente e un biologo si incontrano e si scontrano su un nodo<br />
concettuale ineludibile, nella speranza di gettarvi un po’ di luce sull’enigma.<br />
Crepet Paolo (a cura di)<br />
Perché siamo infelici<br />
Einaudi, Torino 2010, pp. 184 , € 15,50<br />
Le abbiamo dato nel corso dei secoli i nomi più diversi: malinconia, depressione,<br />
angoscia, pena, tristezza... Abbiamo tentato di esorcizzarla, di conviverci,<br />
di narcotizzarla, di addomesticarla o di farne una malattia da curare.<br />
Alcuni sono riusciti a farne la compagna di una vita, altri sono usciti sconfitti<br />
nel tentativo di negarla, altri ancora sono in cerca di consolazione. L'infelicità<br />
abita da sempre nel cuore dell'essere umano. Mai però come in questi<br />
anni la farmacologia è stata cosi invadente nel tentativo di appropriarsene per<br />
neutralizzarla. Ma siamo certi che l'infelicità sia una malattia?
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/arrivati_in_redazione<br />
Legrenzi Paolo<br />
Non occorre essere stupidi per fare sciocchezze<br />
il Mulino, Bologna 2010, pp. 148, € 10,00<br />
"Stupido è chi lo stupido fa", diceva Forrest Gump. Per Carlo M. Cipolla invece<br />
gli stupidi esistono davvero: sono una categoria di persone dalle caratteristiche<br />
inconfondibili e incorreggibili. Purtroppo, sostiene Paolo Legrenzi, la<br />
stupidità non è assenza di intelligenza e può colpire chiunque, anche le persone<br />
dotate di un quoziente di intelligenza superiore. Quali sono allora le trappole<br />
cognitive e le circostanze sociali che ci inducono a commettere una sciocchezza<br />
di cui poi ci pentiremo? E quanto conta il giudizio degli altri? Legrenzi racconta<br />
cosa hanno da dirci le scienze cognitive alla luce di alcuni casi storici ed episodi<br />
di cronaca…<br />
Bruno Moroncini<br />
Sull'amore.<br />
Jacques Lacan e il Simposio di Platone<br />
Cronopio, Napoli 2005, pp.170, € 15,00<br />
Dopo quella freudiana, l'interpretazione del Simposio di Platone offerto<br />
da Jacques Lacan al fine di tematizzare da un punto di vista psicoanalitico<br />
il desiderio erotico, è senza ombra di dubbio la più profonda e articolata.<br />
Questo libro ripercorre il commento lucido e appassionato che nel seminario<br />
sull'amore da transfert del 1960-61 Lacan dedica all'opera platonica per<br />
porre in evidenza da un lato l'originalità della lettura lacaniana del Simposio<br />
e dall'altro l'apporto tutt'altro che marginale che essa offre agli studi di di<br />
filosofia antica per un'interpretazione del dialogo platonico.<br />
Llonto Pablo<br />
I mondiali della vergogna. I campionati<br />
di Argentina '78 e la dittatura<br />
Edizioni Alegre, Roma 2010, pp. 223, € 15,00<br />
Durante i campionati del mondo del 1978 successe di tutto. Eppure Argentina<br />
78 sarà il momento di maggior popolarità della dittatura Videla. Dalle simpatie<br />
comuniste dell'allenatore Menotti, alla finale con l'Olanda, il libro ripercorre i<br />
principali eventi sportivi che riempirono d'orgoglio il paese insieme ai tentativi<br />
di boicottaggio del Mondiale e alle azioni di guerriglia dei montoneros. Un libro<br />
che affronta le responsabilità collettive della società argentina nell'occultamento<br />
della realtà, e che dimostra come l'innocenza sportiva e i suoi festeggiamenti si<br />
convertono spesso in appoggio ai governi, anche ai più sanguinari.<br />
Naranjo Claudio<br />
La civiltà, un male curabile<br />
Franco Angeli, Milano 2007, pp. 144, € 16,50<br />
<strong>Il</strong> malessere di quella che definiamo "civiltà" ha radici nella civiltà stessa, che<br />
si identifica con l'organizzazione patriarcale della società e della. La "civiltà"<br />
si presenta come una reazione patologica degli esseri umani a una condizione<br />
traumatica di un lontano passato e attualmente non risulta essere più funzionale.<br />
Naranjo propone che solamente l'educazione possa avere il potere<br />
di capovolgere il corso della storia e operare una reale trasformazione. Sulla<br />
base di questa convinzione, propone un modello educativo alternativo che<br />
promuova lo sviluppo psico-spirituale dell'individuo e che lo renda capace di<br />
cooperare ad una necessaria evoluzione sociale.<br />
Cultura<br />
117
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/arrivati_in_redazione<br />
118<br />
Umberto Merli Zuccardi, Fabio Tognassi<br />
<strong>Il</strong> bambino iperattivo. Dalla teoria alle pratiche della cura<br />
Franco Angeli, Milano 2010, pp. 192, € 23,00<br />
L'applicazione della psicoanalisi al sintomo dell'iperattività nasce dal desiderio<br />
di confrontarsi con il disagio infantile contemporaneo che altera l'ingresso del<br />
bambino nel legame sociale. Contro il sintomo si tenta di opporre strategie di<br />
controllo del comportamento e del pensiero e una farmacoterapia prolungata<br />
nei casi più gravi. La prospettiva teorica e clinica degli autori di questo libro<br />
propone invece una lettura dell'iperattività che ha qualcosa che riguarda il suo<br />
legame con l'altro. Se la mente è un organo sociale, anche la sua cura può<br />
passare dal sociale…<br />
Luisella Mambrini<br />
Lacan e il femminismo contemporaneo<br />
Quodlibet, Macerata 2010, pp. 152, € 18,00<br />
Jacques Lacan ha operato una rivoluzione nella teoria e nella clinica rispetto<br />
al tema della femminilità. Per Lacan la donna non è la madre, ma le si apre<br />
un orizzonte che va al di là dell'Edipo. Oggi, che Lacan non è più coperto<br />
da interdizione, ma assurge a interlocutore negli scritti di molte femministe,<br />
si può davvero dire che la sovversione del suo approccio sia stata colta? E<br />
che cosa viene espresso nei confronti di Lacan dalle due posizioni "tipo" nei<br />
confronti della femminilità e cioè dall'approccio essenzialista, che guarda alla<br />
femminilità come essenza irriducibile, e da quello costruzionista, che guarda<br />
al genere come costruzione simbolica?<br />
José Bleger<br />
Simbiosi e ambiguità.<br />
Studio psicoanalitico<br />
Armando Editore, Roma 2010, pp. 382, € 30,00<br />
Un'opera ricca di esemplificazioni cliniche di personalità narcisistiche o<br />
borderline e incentrata sullo studio della parte psicotica della personalità, che<br />
evidenzia i fenomeni della dissociazione (clivaggio). Dall'osservazione dello<br />
psicoanalista alle prese con la parte psicotica della personalità nel transfert e<br />
nel controtransfert, Bleger estrapola alcune indicazioni che ampliano la teoria<br />
delle personalità ambigue.<br />
Erbetta Antonio (a cura di)<br />
Decostruire formando.<br />
Concetti pratiche orizzonti<br />
Ibis Edizioni, Como-Pavia 2010, pp. 142, € 15,00<br />
<strong>Il</strong> volume si articola su tre livelli di analisi. In primo luogo sui presupposti<br />
teorici della critica radicale come metodo di formazione pedagogica. In<br />
secondo luogo sulla definizione di una specifica e originale metodologia che<br />
consente di sperimentarlo nelle diverse situazioni operative. In ultimo sulla<br />
descrizione/interpretazione dei tre campi di applicazione in cui si mettono in<br />
gioco le diverse professionalità pedagogiche. Concepito come modello d'intervento<br />
educativo, il testo si presenta in forma di strumento/guida per coloro<br />
che intendono agire secondo una prospettiva che lega in maniera radicale<br />
il tema della formazione all'analisi dei processi culturali e sociali.
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/in_breve<br />
In ricordo di Antonio Erbetta<br />
Antonio Erbetta (La Spezia, 1949) è stato professore ordinario di Storia dell’educazione<br />
europea nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Torino, tenendo anche<br />
l’insegnamento di Storia della Filosofia. Per un decennio Vicedirettore del «Centro Internazionale<br />
di Studi Italiani» dell’Università di Genova, per il quale ha tenuto i corsi di Storia delle Idee,<br />
è stato altresì condirettore di «Encyclopaideia», la rivista di fenomenologia pedagogia e formazione<br />
fondata e diretta da Piero Bertolini. Ha coordinato alcune collane per diverse case editrici.<br />
Era fondatore e direttore di «Paideutika. Quaderni di formazione e cultura». Studioso attento,<br />
in particolare, al significato formativo dell’esperienza morale, sia nelle sue risonanze esistenziali,<br />
sia nei suoi risvolti etico-politici, si è sempre occupato di filosofia dell’educazione e di storia<br />
delle idee educative. Centrali i suoi studi su Banfi, Gentile, Nietzsche, Simmel. Collaboratore<br />
di molte Riviste nazionali e internazionali di filosofia e di scienze dell’educazione, ha pubblicato<br />
oltre venti volumi. Tra i più recenti: <strong>Il</strong> tempo della giovinezza (La Nuova Italia, 2001); <strong>Il</strong> corpo<br />
spesso (Utet Libreria, 2001); Senso della politica e fatica di pensare (Clueb, 2003); In forma<br />
di tragedia (Utet Libreria, 2004); L’educazione come esperienza vissuta (Tirrenia Stampatori,<br />
2005); Pedagogia e nichilismo (Tirrenia Stampatori, 2007); L’umanesimo critico di Antonio<br />
Banfi (ed., Anicia, 2008); Decostruire formando. Concetti pratiche orizzonti (Ibis, 2010).<br />
Su <strong>Pedagogika</strong>.it, della quale è stato, ancor prima che membro del comitato scientifico,<br />
amico, ha pubblicato diversi articoli.<br />
Ci piace ricordare il suo splendido e lucido “Elogio del conflitto formativo” (<strong>Pedagogika</strong>.it,<br />
Anno VIII, numero 5, pagg. 26-37), seguito dai contributi, sullo stesso tema, di<br />
Silvano Calvetto ed Elena Madrussan.<br />
Di seguito riportiamo, quale segno della nostra affettuosa stima, un breve quanto attuale stralcio<br />
di un suo intervento ad un Convegno, “Alla ricerca del tempo vissuto”, svoltosi a Landriano<br />
(PV) nel 2004: “.... Sentiamo che il silenzio ha un prezzo e che mettere in discussione le premesse<br />
apparentemente indiscutibili del nostro modo di vivere e, aggiungerei, di educare, può essere considerato<br />
il più urgente dei servizi che dobbiamo svolgere per noi stessi e per gli altri, contrastando<br />
l'individualismo che si è insinuato nelle persone, nelle relazioni sociali, negli stili di vita e di pensiero<br />
e di cui non ci siamo accorti in questi anni. A questo individualismo assunto come paradigma<br />
della modernità ci siamo un po' tutti subalternamente piegati; la crisi dei luoghi di riproduzione<br />
sociale, delle identità collettive, della politica come passione civile, hanno fatto poi il resto. Un antidoto<br />
può essere, è, il narrare ed il narrarsi poiché la memoria è un diritto per le giovani generazioni<br />
ed un dovere per noi adulti se vogliamo che ragionare d'infanzia sia, ancora una volta scommettere<br />
sul futuro, giacché interrogarsi sull'infanzia è, da parte di noi adulti un rispondere ad un'ansia<br />
conoscitiva che il futuro appunto vuole prefigurare con l'ottimismo della ragione; perché essere<br />
qui insieme vuol dire resistere alla lusinga di accettare l'esistente per quello che è: immodificabile<br />
perché difficile da interpretare e da leggere nei suoi segni contraddittori e complessi”.<br />
Un ricordo, infine, tutto personale: a margine e conclusione di un convegno, qualche<br />
anno fa a Torino, sul conflitto formativo e nel contesto di un pranzo a cui, tra gli altri, partecipavano<br />
Elena Madrussan, Roberto Farné, Angela Nava Mambretti, ci siamo accaniti,<br />
stimolati da Antonio, per oltre tre ore a ragionare sulla figura di Giovanni Gentile e sul suo<br />
ruolo e peso nella storia dell'educazione italiana. Indimenticabile la passione e la competenza<br />
di Antonio e per me uno stimolo ad andare a rileggere, depurandolo dalla passione<br />
politica, i testi di un autore che, forse un po' troppo semplicisticamente, avevo archiviato<br />
tra i cattivi maestri del fascismo.<br />
Salvatore Guida<br />
in_breve<br />
In breve 119
in_vista<br />
<strong>Pedagogika</strong>.it/2011/XV_1/cultura/in_vista<br />
120<br />
Rovereto Musei per le scuole<br />
Mart Rovereto e Casa d'Arte Futurista<br />
Depero, Museo Civico, Museo<br />
Storico Italiano della Guerra e Fondazione<br />
Opera Campana dei Caduti<br />
Le esperienze, i temi e le attività dei<br />
Musei di Rovereto si abbinano per<br />
costruire percorsi alla scoperta delle<br />
mille sfaccettature della nostra realtà,<br />
tra arte, storia, natura e scienza.<br />
E' possibile concordare una o più<br />
giornate didattiche con esperienze<br />
suddivise tra il Museo Civico e gli<br />
altri musei cittadini, studiando interazioni<br />
tra scienza, storia e arte.<br />
I musei inoltre in collaborazione con<br />
l'Azienda per il Turismo di Rovereto<br />
e Vallagarina propongono viaggi<br />
d'istruzione per le scuole ed educational<br />
tour per insegnanti.<br />
<strong>Il</strong> Museo Civico di Rovereto ha<br />
attuato una strategia di "musealizzazione<br />
diffusa" che l'ha portato a<br />
muoversi con efficacia sul territorio,<br />
varcando i confini istituzionali delle<br />
sale museali.<br />
Un museo insolito, vivo e in movimento,<br />
che vuole accompagnare alla<br />
scoperta di un territorio straordinariamente ricco tutti coloro che intendono<br />
fare del proprio tempo libero occasione di conoscenza intelligente.<br />
Museo Civico di Rovereto | Borgo Santa Caterina, 41 - 38068 Rovereto (TN)<br />
Italy | Tel. +39 0464 452800 - Fax +39 0464 439487 - E-mail museo@museocivico.rovereto.tn.it
Di prossima uscita<br />
a cura di Barbara Mapelli, Lucia Portis, Susanna Ronconi<br />
Molti modi di essere uniche<br />
Percorsi di scrittura di sé<br />
per re-inventare l’età matura<br />
Collana POLIS<br />
Le donne che sono state giovani negli anni ’60 e ’70<br />
hanno dato vita a una radicale rivoluzione di genere.<br />
Rotture, conitti, cambiamenti e alternative che<br />
hanno aperto e frantumato quel bozzolo in cui le vite<br />
delle donne sino ad allora erano state chiuse.<br />
Oggi, dopo quella rivoluzione, queste donne si<br />
trovano a dover re-inventare la propria seconda età<br />
adulta, ad andare verso la vecchiaia in assenza di<br />
modelli. Come stanno vivendo questo transito d’età?<br />
E come stanno costruendo il loro futuro? Questo<br />
libro racconta la ricerca di nuove risposte a questa<br />
domanda da parte di 125 donne che hanno<br />
interrogato se stesse scrivendo di sé e ascoltando le<br />
scritture delle altre in 11 laboratori autobiograci.<br />
a cura di Eugenio Rossi<br />
Ragazzi che educano ragazzi<br />
Un intervento di peer education<br />
per la riparazione del disagio evolutivo<br />
Collana <strong>Pedagogika</strong><br />
Questo saggio impatta con un paradigma classico e apparentemente<br />
inconfutabile dei processi educativi: la trasmissione del sapere e delle<br />
competenze relazionali avviene nello scambio tra generazioni di simboli<br />
sociali ed i loro contenuti. Pur condividendo la logica ed intrinseca<br />
correttezza di questo evidente assunto, il libro prova ad aggirare il<br />
paradigma inconfutabile, raccontando di ragazzi che educano altri<br />
ragazzi e dell’efcacia dell’inuenza sulle opinioni collettive che alcuni<br />
giovani esercitano perché gli altri amici di pari età si dano di loro.<br />
mail: pedagogika@pedagogia.it