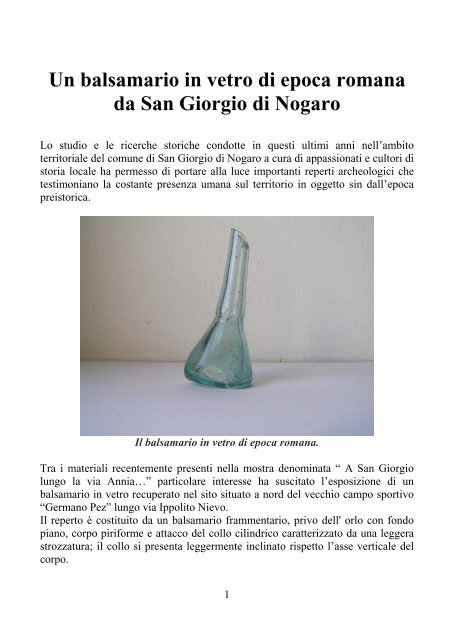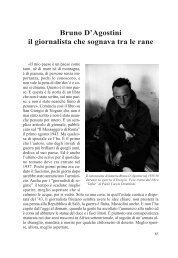Un balsamario in vetro di epoca romana da San ... - Ad Undecimum
Un balsamario in vetro di epoca romana da San ... - Ad Undecimum
Un balsamario in vetro di epoca romana da San ... - Ad Undecimum
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Un</strong> <strong>balsamario</strong> <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> <strong>di</strong> <strong>epoca</strong> <strong>romana</strong><br />
<strong>da</strong> <strong>San</strong> Giorgio <strong>di</strong> Nogaro<br />
Lo stu<strong>di</strong>o e le ricerche storiche condotte <strong>in</strong> questi ultimi anni nell’ambito<br />
territoriale del comune <strong>di</strong> <strong>San</strong> Giorgio <strong>di</strong> Nogaro a cura <strong>di</strong> appassionati e cultori <strong>di</strong><br />
storia locale ha permesso <strong>di</strong> portare alla luce importanti reperti archeologici che<br />
testimoniano la costante presenza umana sul territorio <strong>in</strong> oggetto s<strong>in</strong> <strong>da</strong>ll’<strong>epoca</strong><br />
preistorica.<br />
Il <strong>balsamario</strong> <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> <strong>di</strong> <strong>epoca</strong> <strong>romana</strong>.<br />
Tra i materiali recentemente presenti nella mostra denom<strong>in</strong>ata “ A <strong>San</strong> Giorgio<br />
lungo la via Annia…” particolare <strong>in</strong>teresse ha suscitato l’esposizione <strong>di</strong> un<br />
<strong>balsamario</strong> <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> recuperato nel sito situato a nord del vecchio campo sportivo<br />
“Germano Pez” lungo via Ippolito Nievo.<br />
Il reperto è costituito <strong>da</strong> un <strong>balsamario</strong> frammentario, privo dell' orlo con fondo<br />
piano, corpo piriforme e attacco del collo cil<strong>in</strong>drico caratterizzato <strong>da</strong> una leggera<br />
strozzatura; il collo si presenta leggermente <strong>in</strong>cl<strong>in</strong>ato rispetto l’asse verticale del<br />
corpo.<br />
1
I balsamari, contenitori per unguenti e profumi, erano assai <strong>di</strong>ffusi nel mondo<br />
romano; venivano realizzati <strong>in</strong> terracotta, <strong>in</strong> metallo prezioso e <strong>in</strong> <strong>vetro</strong>.<br />
I più antichi esemplari erano prodotti utilizzando come materia prima l’argilla,<br />
vennero poi sostituiti <strong>in</strong> età augustea <strong>da</strong>l <strong>vetro</strong> che, grazie all’affermarsi <strong>di</strong> nuove<br />
tecniche <strong>di</strong> produzione, garantiva la fabbricazione <strong>di</strong> contenitori trasparenti, <strong>da</strong>i<br />
vivaci colori che consentivano <strong>da</strong> un lato una migliore conservazione del<br />
contenuto e <strong>da</strong>ll’altro <strong>in</strong>dubitabili economie nel processo produttivo oltre alla<br />
possibilità <strong>di</strong> sperimentare forme nuove.<br />
Questi contenitori venivano prodotti su larga scala, a livello quasi <strong>in</strong>dustriale, <strong>in</strong><br />
seguito all'<strong>in</strong>troduzione <strong>in</strong> Italia <strong>in</strong>torno agli anni 50-40 a. C. della tecnica della<br />
soffiatura1, <strong>in</strong>ventata probabilmente nelle città sviluppatesi lungo la costa siropalest<strong>in</strong>ese,<br />
che an<strong>da</strong>va a sostituire il più articolato proce<strong>di</strong>mento della fusione <strong>in</strong><br />
stampi con cui si producevano prima manufatti <strong>in</strong> pasta <strong>di</strong> <strong>vetro</strong>.<br />
Con questa nuova tecnica gli artigiani del <strong>vetro</strong> potevano <strong>in</strong>ventare nuove forme a<br />
secon<strong>da</strong> delle varie richieste della committenza ed altresì decorare i manufatti con<br />
colorazioni vivaci, creando, molto spesso, accostamenti cromatici orig<strong>in</strong>ali, grazie<br />
all'aggiunta <strong>di</strong> sostanze particolari all'impasto vitreo.<br />
I recipienti <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> risultavano più consoni <strong>in</strong> grado <strong>di</strong> garantire una buona<br />
conservazione dei prodotti, <strong>in</strong> modo particolare dei balsami e dei profumi, che<br />
venivano ottenuti, come ci traman<strong>da</strong>no le fonti antiche, <strong>da</strong> essenze naturali<br />
facilmente ossi<strong>da</strong>bili con il passare del tempo, che <strong>in</strong> questo modo venivano<br />
protette <strong>da</strong>lla impermeabilità del <strong>vetro</strong>.<br />
1 L'<strong>in</strong>troduzione della tecnica della soffiatura, libera o comb<strong>in</strong>ata con l'uso <strong>di</strong> stampi, cambiò<br />
ra<strong>di</strong>calmente la lavorazione del <strong>vetro</strong> e permise una vasta <strong>di</strong>ffusione degli oggetti <strong>in</strong> tale materiale<br />
per la riduzione dei tempi tecnici <strong>di</strong> lavorazione e la possibilità <strong>di</strong> creare una grande varietà <strong>di</strong><br />
forme <strong>in</strong> tempi brevi. L'<strong>in</strong>venzione della canna <strong>da</strong> soffio avvenne <strong>in</strong> ambiente me<strong>di</strong>o orientale: la<br />
più antica testimonianza proviene <strong>da</strong> Gerusalemme <strong>in</strong> un contesto <strong>da</strong>tato alla prima metà del I<br />
secolo a.C. La prima commercializzazione del <strong>vetro</strong> soffiato co<strong>in</strong>cide con la conquista dell'Egitto<br />
(31 a.C.) e l'<strong>in</strong>staurazione del pr<strong>in</strong>cipato <strong>di</strong> Augusto alla f<strong>in</strong>e del I secolo (27 a.C.-14 d.C.): fattori<br />
politici ed economici congiunti all'<strong>in</strong>tensificarsi del commercio marittimo nel Me<strong>di</strong>terraneo e<br />
l'aff<strong>in</strong>amento delle conoscenze tecniche, favorirono la capillare <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> manufatti soffiati nel<br />
mondo romanizzato, f<strong>in</strong>o alla loro predom<strong>in</strong>anza sui mercati nel corso del I secolo d.C.<br />
La conquista, <strong>da</strong> parte dei romani, delle città greche permise un afflusso <strong>di</strong> ricchezze e <strong>di</strong> artigiani<br />
specializzati <strong>da</strong>l Me<strong>di</strong>terraneo orientale: maestranze ed offic<strong>in</strong>e vetrarie si stabilirono a Roma, <strong>in</strong><br />
Campania (Cuma, Pozzuoli) e lungo la costa alto-adriatica (Aquileia), aree che <strong>da</strong> lunga <strong>da</strong>ta<br />
avevano <strong>in</strong>trattenuto rapporti commerciali con la Grecia e il Me<strong>di</strong>terraneo orientale. Cfr. M. C.<br />
CALVI, I vetri romani del Museo <strong>di</strong> Aquileia, Aquileia, 1968.<br />
Il materiale è attualmente conservato presso il deposito <strong>di</strong> materiale archeologico del comune <strong>di</strong><br />
<strong>San</strong> Giorgio <strong>di</strong> Nogaro ed è stato recentemente sche<strong>da</strong>to per il Centro <strong>di</strong> Catalogazione <strong>di</strong> Villa<br />
Man<strong>in</strong> <strong>di</strong> Passariano a cura della dott.ssa Paola Maggi. Il reperto porta il n. 30876 d’<strong>in</strong>ventario.<br />
2
Questa tipologia <strong>di</strong> piccoli contenitori rappresenta un oggetto molto <strong>di</strong>ffuso <strong>in</strong><br />
<strong>epoca</strong> <strong>romana</strong>2, sia <strong>in</strong> contesti sepolcrali che <strong>in</strong> contesti abitativi, <strong>da</strong>l momento<br />
che veniva utilizzato come contenitore per essenze dest<strong>in</strong>ate al rito funebre oppure<br />
come recipiente per aromi, profumi e polveri cosmetiche usati nella vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana3.<br />
La forma piriforme del corpo ed il colore verde-azzurro del <strong>vetro</strong> riconducono<br />
l'esemplare ad una fase posteriore alla metà del I sec. d. C., quando si sviluppò su<br />
larga scala (e a scapito <strong>di</strong> produzioni più raff<strong>in</strong>ate e preziose) la produzione <strong>di</strong><br />
tipologie più comuni e tipizzate, create <strong>da</strong>gli artigiani <strong>in</strong> comune <strong>vetro</strong> <strong>in</strong>colore o<br />
verde-azzurro e rispondenti ad esigenze più utilitaristiche che formali e stilistiche.<br />
L’<strong>in</strong><strong>di</strong>viduazione della tipologia si basa soprattutto sulle caratteristiche del collo e<br />
sulla forma del corpo del contenitore; <strong>in</strong> ragione <strong>di</strong> quanto sopra, il <strong>balsamario</strong><br />
portato alla luce a <strong>San</strong> Giorgio <strong>di</strong> Nogaro potrebbe essere associato al tipo Is<strong>in</strong>gs<br />
82b, <strong>da</strong>tabile tra la metà del I e la f<strong>in</strong>e del II d.C.4.<br />
La casualità del r<strong>in</strong>venimento, ma soprattutto la mancanza <strong>di</strong> riferimenti precisi<br />
circa le circostanze del ritrovamento, non consentono allo stato attuale <strong>di</strong><br />
formulare un’ipotesi precisa circa il reale impiego <strong>di</strong> questo reperto, anche se, la<br />
vic<strong>in</strong>anza del luogo <strong>di</strong> r<strong>in</strong>venimento con l’antico tracciato della via Annia<br />
lascerebbe supporre che tale oggetto possa essere associato ad un corredo<br />
funerario.<br />
Marco Zanon<br />
2 Da prodotto riservato all'élite sociale, il <strong>vetro</strong> entra nella vita quoti<strong>di</strong>ana <strong>di</strong> tutti i ceti accanto al<br />
vasellame ceramico e metallico <strong>di</strong> cui spesso imita le forme. Nella fase <strong>in</strong>iziale della produzione<br />
frequente è l'uso del <strong>vetro</strong> soffiato colorato ottenuto con l'ad<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong> metallici (foto 1);<br />
<strong>da</strong>lla metà circa del I secolo d.C. prevale l'uso del <strong>vetro</strong> naturale <strong>di</strong> colorazione azzurra (foto 2)<br />
mentre verso la f<strong>in</strong>e del I secolo si torna a pre<strong>di</strong>ligere il <strong>vetro</strong> <strong>in</strong>colore, sottile e trasparente<br />
3 G. DE TOMMASO, Ampullae Vitreae. Contenitori <strong>in</strong> <strong>vetro</strong> <strong>di</strong> unguenti e sostanze aromatiche<br />
dell'Italia <strong>romana</strong> (I sec. a.C. - III sec. d.C.), Roma, 1990<br />
4 Cfr. <strong>in</strong> tal senso C. ISINGS, Roman Glass from <strong>da</strong>ted f<strong>in</strong>ds, Gron<strong>in</strong>gen – Djakarta, 1957.<br />
3