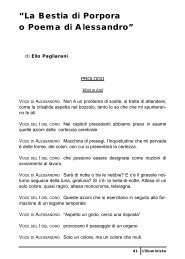Lezioni sull'Inferno dantesco a confronto: Pirandello e Bacchelli
Lezioni sull'Inferno dantesco a confronto: Pirandello e Bacchelli
Lezioni sull'Inferno dantesco a confronto: Pirandello e Bacchelli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Francesca Fagnani<br />
un disprezzo che arrivato al punto, dopo il primo sfogo innanzi al papa simoniaco,<br />
qui lo avrebbe mosso a far di quell’accusa, col riso, la più allegra vendetta?».<br />
Di «riso amaro», dunque, si tratterebbe a cui il poeta sarebbe stato indotto dall’urgenza<br />
dei ricordi personali, riemersi con forza tale da determinare la stesura<br />
dell’episodio. Dante, come è noto, fu confinato fuori dalla patria proprio con<br />
l’accusa di baratteria, reato di chi trae illeciti guadagni o profitti dalle cariche<br />
pubbliche di cui è stato investito. In realtà, è assai complicato stabilire quanto<br />
pesò sull’animo del poeta l’onta di un’accusa senza dubbio infamante, di cui tuttavia,<br />
si servivano, ormai abitualmente e vicendevolmente, le fazioni vittoriose<br />
come comodo strumento per allontanare i nemici della parte avversa. Ancora più<br />
difficile è stabilire in che misura la memoria personale agì nell’elaborazione dell’avventura<br />
che si svolge nella quinta bolgia. Tuttavia, la chiave di lettura, per<br />
così dire, biografica, fornita da <strong>Pirandello</strong> non va affatto trascurata, tanto più che<br />
essa si presenta circonstanziata e ricca di prove atte a confermarne la validità. In<br />
primo luogo, è interessante notare come la premessa a quella che egli definisce<br />
felicemente «allegra vendetta» sia da lui posta già nella terza bolgia, dove vengono<br />
puniti i simoniaci:<br />
Con una trovata tra le più felici, perché naturalissima, ma naturalissima come può essere una<br />
vipera piena di veleno, Niccolò scambia Dante per Bonifazio VIII, perché questi, ladro della chiesa,<br />
volle veramente in terra cambiar le carte; far comparire Dante ladro del comune, facendolo<br />
accusare dai Neri come reo di baratteria. Ed è qui una suprema irrisione dell’accusa. – Tu m’hai<br />
preso per te, tu hai creduto ch’io fossi come te, viene a dire Dante con questa sua finzione.<br />
Dopo un rapido excursus degli episodi che si svolgono nelle bolge precedenti la<br />
quinta, funzionale a mettere in evidenza come neppure in questi casi si possa parlare<br />
di «comico», <strong>Pirandello</strong> entra nel vivo del XXI canto, passando in rassegna tutti quei<br />
passi che conforterebbero la tesi della partecipazione memoriale-biografica dell’autore.<br />
Un primo indizio in tal senso andrebbe colto già nei versi che aprono il canto:<br />
Così di ponte in ponte, altro parlando<br />
che la mia comedìa cantar non cura<br />
<strong>Pirandello</strong> interrogandosi su quale potesse essere il discorso intercorso tra il<br />
discepolo e e il suo maestro, arriva a questa conclusione: «Sarà fren dell’arte<br />
anche qui? Non credo. Il poeta non direbbe che di quest’altro che parlava con<br />
Virgilio non cura cantare. Il discorso, alla fine del canto precedente, era sulla luna<br />
piena benigna a Dante smarrito negli orrori della selva, alcuna volta. Quando?<br />
Forse nella più triste delle sue vicende: nella fuga per l’esilio dopo l’infame accusa.<br />
Ecco che forse possiamo intendere di quale argomento parlavano oltre questo<br />
ponte della quinta bolgia». In realtà questa interpretazione, per quanto attraente,<br />
non sembra esente da dubbi, dal momento che si basa su dati aprioristici e non<br />
verificabili in alcun modo. L’intenzionale vaghezza dell’autore sembra, invece,<br />
220