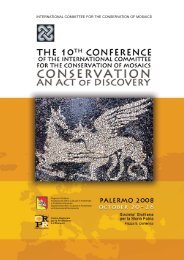R - Centro Restauro
R - Centro Restauro
R - Centro Restauro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DOSSIER<br />
22<br />
SPECIE LAPIDEE<br />
I MARMI DELLA VILLA DEL CASALE<br />
Lorenzo Lazzarini<br />
Università IUAV - Venezia<br />
I marmi della Villa del Casale di<br />
Piazza Armerina sono stati in passato<br />
oggetto di attenzione e indagine da<br />
parte di vari studiosi, a iniziare dagli<br />
scavatori (Carandini et al. 1982 ), che<br />
redassero un primo elenco, peraltro<br />
molto incompleto e con errori, delle<br />
specie lapidee presenti, e continuando<br />
con lo studio di Pensabene, anch’esso<br />
non esaustivo e con qualche imprecisione,<br />
per finire poi con i due lavori<br />
dello scrivente (Lazzarini 2003 e<br />
2007) che riguardarono solamente i<br />
marmi e le pietre ancora in posto, e si<br />
basarono solo su una identificazione<br />
autoptica delle varie specie lapidee.<br />
Una recentissima indagine, sempre di<br />
chi scrive, estesa alle diverse decine di<br />
cassette di frammenti marmorei raccolti<br />
nel corso dello scavo sia della<br />
Basilica che del resto della villa, e<br />
opportunamente integrata da indagini<br />
archeometriche di laboratorio eseguite<br />
su campioni prelevati principalmente<br />
dalla Basilica stessa, rende ora possibile<br />
la stesura di un elenco delle qualità<br />
di marmi presenti nell’edificio, che si<br />
ritiene pressoché definitivo almeno per<br />
quanto sinora messo in luce e studiato,<br />
e una prima serie di considerazioni sull’impiego<br />
dei materiali lapidei di<br />
importazione nella villa.<br />
L’elenco di quest’ultimi viene sintetizzato<br />
in tabelle suddivise per area geografica<br />
di provenienza (vedi pag. 24), e<br />
fornisce una valutazione semiquantitativa<br />
dei materiali e un’indicazione<br />
delle tipologie d’uso. Per valutare la<br />
quantità, ci si è basati sul numero di<br />
casse riempite per ciascuna specie, in<br />
particolare:<br />
da uno, sino a qualche decina di frammenti,<br />
presenza in tracce<br />
da una a tre casse, presente<br />
da tre sino a cinque casse, abbondante<br />
oltre cinque casse, molto abbondante.<br />
Circa la tipologia d’uso, si sono facilmente<br />
identificati gli elementi architettonici<br />
(principalmente cornici e loro<br />
frammenti, colonne e loro frammenti,<br />
capitelli e loro frammenti), nonché gli<br />
altri manufatti e loro frammenti (ad es.<br />
vasche), mentre si è assunto lo spessore<br />
delle lastre per distinguere i rivestimenti<br />
pavimentali (spessore > di 1 cm)<br />
da quelli parietali (spessore ≤ di 1 cm).<br />
L’identificazione dei marmi colorati,<br />
come si è detto sopra è stata largamente<br />
basata su un riconoscimento autoptico<br />
e per confronto con specifici atlanti<br />
fotografici (Mielsch 1985; Borghini<br />
1989; Dolci, Nista 1992; Pensabene,<br />
Bruno 1998) ma anche su studi minero-petrografici<br />
al microscopio polarizzatore<br />
di sezioni sottili di campioni<br />
delle specie lapidee di incerta provenienza,<br />
e di quelle sconosciute.<br />
L’identificazione dei marmi bianchi e<br />
bigi è invece da considerarsi ampiamente<br />
ipotetica perché basata sulle<br />
loro caratteristiche macroscopiche<br />
(dimensioni della grana, colore, brillanza,<br />
etc.), salvo che per un numero<br />
significativo di campioni, prelevati per<br />
litotipo e in modo rappresentativo, che<br />
sono stati identificati con una buona<br />
probabilità di esattezza del risultato<br />
mediante dettagliato esame petrografico<br />
in sezione sottile combinato ad analisi<br />
degli isotopi stabili del carbonio e<br />
dell’ossigeno, e tenendo conto della<br />
relativa banca dati più aggiornata tra<br />
quelle attualmente esistenti (Gorgoni<br />
et al. 2002).<br />
Sui dettagli di tali identificazioni di<br />
laboratorio, si rimanda allo specifico,<br />
recente rapporto scientifico redatto per<br />
la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di<br />
Enna (Lazzarini 2009).<br />
Per informazioni storico-archeologiche<br />
e archeometriche sulle varie specie<br />
lapidee identificate, si consiglia la consultazione<br />
delle pubblicazioni di Gnoli<br />
(1988); Borghini (1989), con relativa<br />
recensione di L.Lazzarini (1990); De<br />
Nuccio, Ungaro (2002); Lazzarini<br />
(2004 e 2007).<br />
Come si desume dalle tabelle, sono i<br />
marmi di origine ellenica che prevalgono<br />
su tutti gli altri. In particolare, si<br />
può senz’altro affermare che siano le<br />
due specie lapidee estratte dall’isola di<br />
Sciro (ora, Skyros), e cioè la breccia di<br />
settebasi e il marmo sciretico bianco, a<br />
predominare. Della prima sono le<br />
grandi colonne del peristilio prospiciente<br />
il mosaico della grande caccia, e<br />
molti riquadri e cornici dell’opus sectile<br />
della basilica; del secondo erano con<br />
ogni probabilità molti dei rivestimenti<br />
parietali e pavimentali, sia della basilica<br />
che di altri spazi della villa. Va<br />
anche notata la considerevole abbondanza<br />
del verde antico, il cui uso e diffusione<br />
è, come noto, da datare a dopo<br />
l’età adrianea, ma la cui massiccia presenza<br />
in contesti romani non è molto<br />
comune.<br />
Dei marmi microasiatici, l’africano<br />
appare il più usato, e solo per rivestimenti,<br />
mentre i graniti sono presenti<br />
specie in colonne. Di questi, il più<br />
abbondante è il misio, presente con