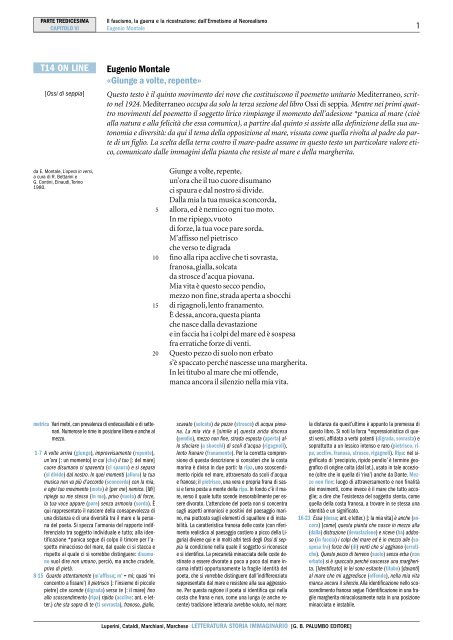Eugenio Montale «Giunge a volte, repente» T14 ON LINE
Eugenio Montale «Giunge a volte, repente» T14 ON LINE
Eugenio Montale «Giunge a volte, repente» T14 ON LINE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PARTE TREDICESIMA Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo<br />
CAPITOLO VI <strong>Eugenio</strong> <strong>Montale</strong><br />
<strong>T14</strong> <strong>ON</strong> <strong>LINE</strong><br />
[Ossi di seppia]<br />
da E. <strong>Montale</strong>, L’opera in versi,<br />
a cura di R. Bettarini e<br />
G. Contini, Einaudi, Torino<br />
1980.<br />
<strong>Eugenio</strong> <strong>Montale</strong><br />
<strong>«Giunge</strong> a <strong>volte</strong>, <strong>repente»</strong><br />
metrica Vari metri, con prevalenza di endecasillabi e di settenari.<br />
Numerose le rime in posizione libera e anche al<br />
mezzo.<br />
1-7 A <strong>volte</strong> arriva (giunge), improvvisamente (repente),<br />
un’ora [: un momento] in cui (che) il tuo [: del mare]<br />
cuore disumano ci spaventa (ci spaura) e si separa<br />
(si divide) dal nostro. In quei momenti (allora) la tua<br />
musica non va più d’accordo (sconcorda) con la mia,<br />
e ogni tuo movimento (moto) è [per me] nemico. [Mi]<br />
ripiego su me stesso (in me), privo (vuoto) di forze,<br />
la tua voce appare (pare) senza armonia (sorda). È<br />
qui rappresentato il nascere della consapevolezza di<br />
una distanza e di una diversità tra il mare e la persona<br />
del poeta. Si spezza l’armonia del rapporto indifferenziato<br />
tra soggetto individuale e tutto; alla identificazione<br />
*panica segue di colpo il timore per l’aspetto<br />
minaccioso del mare, dal quale ci si stacca e<br />
rispetto al quale ci si vorrebbe distinguere: disumano<br />
vuol dire non umano, perciò, ma anche crudele,<br />
privo di pietà.<br />
8-15 Guardo attentamente (m’affisso; m’ = mi; quasi ‘mi<br />
concentro a fissare’) il pietrisco [: l’insieme di piccole<br />
pietre] che scende (digrada) verso te [: il mare] fino<br />
allo scoscendimento (ripa) ripido (acclive: ant. e letter.)<br />
che sta sopra di te (ti sovrasta), franoso, giallo,<br />
Questo testo è il quinto movimento dei nove che costituiscono il poemetto unitario Mediterraneo, scritto<br />
nel 1924. Mediterraneo occupa da solo la terza sezione del libro Ossi di seppia. Mentre nei primi quattro<br />
movimenti del poemetto il soggetto lirico rimpiange il momento dell’adesione *panica al mare (cioè<br />
alla natura e alla felicità che essa comunica), a partire dal quinto si assiste alla definizione della sua autonomia<br />
e diversità: da qui il tema della opposizione al mare, vissuta come quella rivolta al padre da parte<br />
di un figlio. La scelta della terra contro il mare-padre assume in questo testo un particolare valore etico,<br />
comunicato dalle immagini della pianta che resiste al mare e della margherita.<br />
Giunge a <strong>volte</strong>, repente,<br />
un’ora che il tuo cuore disumano<br />
ci spaura e dal nostro si divide.<br />
Dalla mia la tua musica sconcorda,<br />
5 allora, ed è nemico ogni tuo moto.<br />
In me ripiego, vuoto<br />
di forze, la tua voce pare sorda.<br />
M’affisso nel pietrisco<br />
che verso te digrada<br />
10 fino alla ripa acclive che ti sovrasta,<br />
franosa, gialla, solcata<br />
da strosce d’acqua piovana.<br />
Mia vita è questo secco pendio,<br />
mezzo non fine, strada aperta a sbocchi<br />
15 di rigagnoli, lento franamento.<br />
È dessa, ancora, questa pianta<br />
che nasce dalla devastazione<br />
e in faccia ha i colpi del mare ed è sospesa<br />
fra erratiche forze di venti.<br />
20 Questo pezzo di suolo non erbato<br />
s’è spaccato perché nascesse una margherita.<br />
In lei tìtubo al mare che mi offende,<br />
manca ancora il silenzio nella mia vita.<br />
scavato (solcata) da pozze (strosce) di acqua piovana.<br />
La mia vita è [simile a] questa arida discesa<br />
(pendìo), mezzo non fine, strada esposta (aperta) allo<br />
sfociare (a sbocchi) di scoli d’acqua (rigagnoli),<br />
lento franare (franamento). Per la corretta comprensione<br />
di questa descrizione si consideri che la costa<br />
marina è divisa in due parti: la ripa, uno scoscendimento<br />
ripido nel mare, attraversato da scoli d’acqua<br />
e franoso; il pietrisco, una vera e propria frana di sassi<br />
e terra posta a monte della ripa. In fondo c’è il mare,<br />
verso il quale tutto scende inesorabilmente per essere<br />
divorato. L’attenzione del poeta non si concentra<br />
sugli aspetti armoniosi e positivi del paesaggio marino,<br />
ma piuttosto sugli elementi di squallore e di instabilità.<br />
La caratteristica franosa delle coste (con riferimento<br />
realistico al paesaggio costiero a picco della Liguria)<br />
diviene qui e in molti altri testi degli Ossi di seppia<br />
la condizione nella quale il soggetto si riconosce<br />
e si identifica. La precarietà minacciata delle coste destinate<br />
a essere divorate a poco a poco dal mare incarna<br />
infatti opportunamente la fragile identità del<br />
poeta, che si vorrebbe distinguere dall’indifferenziato<br />
rappresentato dal mare e resistere alla sua aggressione.<br />
Per questa ragione il poeta si identifica qui nella<br />
costa che frana e non, come una lunga (e anche recente)<br />
tradizione letteraria avrebbe voluto, nel mare:<br />
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese LETTERATURA STORIA IMMAGINARIO [G. B. PALUMBO EDITORE]<br />
1<br />
la distanza da quest’ultimo è appunto la premessa di<br />
questo libro. Si noti la forza *espressionistica di questi<br />
versi, affidata a verbi potenti (digrada, sovrasta) e<br />
soprattutto a un lessico intenso e raro (pietrisco, ripa,<br />
acclive, franosa, strosce, rigagnoli). Ripa: nel significato<br />
di ‘precipizio, ripido pendio’ è termine geografico<br />
di origine colta (dal lat.), usato in tale accezione<br />
(oltre che in quella di ‘riva’) anche da Dante. Mezzo<br />
non fine: luogo di attraversamento e non finalità<br />
dei movimenti, come invece è il mare che tutto accoglie;<br />
a dire che l’esistenza del soggetto stenta, come<br />
quella della costa franosa, a trovare in se stessa una<br />
identità e un significato.<br />
16-23 Essa (dessa; ant. e letter.) [: la mia vita] è anche (ancora)<br />
[come] questa pianta che nasce in mezzo alla<br />
(dalla) distruzione (devastazione) e riceve (ha) addosso<br />
(in faccia) i colpi del mare ed è in mezzo alle (sospesa<br />
fra) forze dei (di) venti che si aggirano (erratiche).<br />
Questo pezzo di terreno (suolo) senza erba (non<br />
erbato) si è spaccato perché nascesse una margherita.<br />
[Identificato] in lei sono esitante (tìtubo) [davanti]<br />
al mare che mi aggredisce (offende), nella mia vita<br />
manca ancora il silenzio. Alla identificazione nello scoscendimento<br />
franoso segue l’identificazione in una fragile<br />
margherita miracolosamente nata in una posizione<br />
minacciata e instabile.
PARTE TREDICESIMA Il fascismo, la guerra e la ricostruzione: dall’Ermetismo al Neorealismo<br />
CAPITOLO VI <strong>Eugenio</strong> <strong>Montale</strong><br />
<strong>T14</strong> <strong>ON</strong> <strong>LINE</strong><br />
<strong>Eugenio</strong> <strong>Montale</strong> ~ <strong>«Giunge</strong> a <strong>volte</strong>, <strong>repente»</strong><br />
Guardo la terra che scintilla,<br />
25 l’aria è tanto serena che s’oscura.<br />
E questa che in me cresce<br />
è forse la rancura<br />
che ogni figliuolo, mare, ha per il padre.<br />
24-28 Guardo la terra che brilla (scintilla), l’aria è a tal punto (tanto) serena che diventa scura (s’oscura; s’ = si). E questa [reazione] che in me si sviluppa<br />
(cresce) è forse il rancore (la rancura), [o] mare, che ogni figlio (figliuolo) ha per il padre. L’attenzione è ancora concentrata sul paesaggio,<br />
del quale viene offerta una rappresentazione espressionistica, esasperata soprattutto nella percezione della luce; la terra brilla sotto i raggi violenti<br />
del sole e l’aria sembra divenire scura a causa della trasparenza serena che concentra l’azzurro del cielo. A questo rapporto sofferto e tragico con la<br />
realtà si accompagna la coscienza (appena attenuata da un forse) del conflitto aperto con il mare, simile a quello di un figlio con il padre, determinato<br />
dal desiderio di definire una propria identità ben caratterizzata e originale. Rancura: è termine ant. (e dantesco) che propriamente significa ‘angoscia,<br />
dolore’; usato però qui da <strong>Montale</strong> (e, prima, da d’Annunzio) nel significato di ‘rancore’.<br />
guida alla lettura<br />
Il tema<br />
Il tema del poemetto Mediterraneo è quello del rapporto fra il poeta e il<br />
mare, simbolo di felicità panica ma anche sentito come equivalente della<br />
intera realtà, rispetto a cui il poeta deve definire la propria identità.<br />
Ma tale processo è difficile e ambivalente, in quanto il mare non mostra<br />
un carattere unico: da una parte, infatti, rappresenta un modello di armonia<br />
e di perfezione (degno perciò di essere imitato), ma dall’altra si configura<br />
come minaccia distruttiva, nemica di tutto ciò che si definisce in sua<br />
opposizione e dunque anche della terra. Quest’ultima è concepita come<br />
simbolo alternativo al mare, come luogo del sacrificio, della sofferenza,<br />
della difficile conquista dell’identità individuale. Si tratta di un’alternativa<br />
psicologica: è la maturità che segue all’infanzia, con il suo bisogno di<br />
Il motivo esistenziale e quello etico<br />
<strong>Montale</strong> sottolinea qui il limite della vita umana. Essa è priva di<br />
identità e di significato sicuro, è smottamento continuo, logoramento<br />
di ogni certezza, è priva di scopi certi, «mezzo non fine» (v.<br />
14). Tuttavia la consapevolezza di tale condizione non induce il<br />
poeta a un atteggiamento rassegnato o scettico: l’immagine della<br />
esercizi<br />
Analizzare e interpretare<br />
1<br />
Suddividi il testo indicando le parti narrative e quelle riflessive.<br />
2 Definisci l’opposizione poeta-mare e l’analogia poeta-terra,<br />
poeta-pianta.<br />
3 Caratterizza, attraverso le scelte lessicali, gli aspetti fisici del<br />
paesaggio terrestre. Quali suoni privilegia <strong>Montale</strong> e a qua-<br />
identità e di differenziazione dal mare-padre (cfr. v. 28). Si tratta anche<br />
di un’alternativa ideologica e filosofica: mentre il mare rappresenta la fiducia<br />
nel significato della realtà e quindi della propria esistenza all’interno<br />
di essa, la terra rinvia al senso di una scissione e di una solitudine priva<br />
di significato. Si tratta infine di un’alternativa di poetica fra l’«inno» e<br />
l’«elegia» (cfr. la Guida alla lettura di CD292), fra la celebrazione dionisiaca<br />
dell’essere e l’avvertimento doloroso della scissione da esso, fra il<br />
simbolismo panico di d’Annunzio – secondo il quale è nella fusione armoniosa<br />
con la natura (e con il mare che la rappresenta) che il poeta si<br />
realizza – e il bisogno invece di una poesia che sia espressione di un<br />
rapporto sociale e comunicazione di un messaggio etico.<br />
pianta (un’agave, probabilmente) che resiste all’attrazione del mare<br />
(al suo appello dionisiaco e panico) e quella del suolo che si<br />
spacca per far nascere una margherita (vv. 16-21) comunicano<br />
un messaggio etico, la coscienza della necessità del sacrificio per<br />
gli altri.<br />
le realtà esistenziale essi rimandano?<br />
Cogli gli elementi che identificano il mare con il padre e rifletti<br />
sul significato che assumono nel contesto la «rancura»<br />
e la separazione del figlio.<br />
Confronta questo testo con Corno inglese (T13 on line) e<br />
metti in rilievo il diverso rapporto tra il poeta e la natura.<br />
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese LETTERATURA STORIA IMMAGINARIO [G. B. PALUMBO EDITORE]<br />
4<br />
5<br />
2