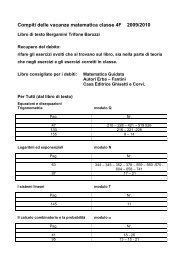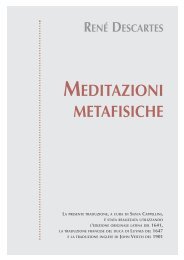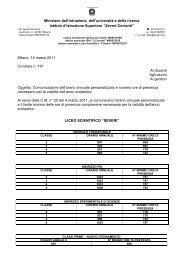La gioventù nella poesia trobadorica
La gioventù nella poesia trobadorica
La gioventù nella poesia trobadorica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Donatella Allegro Ai margini del potere. <strong>La</strong> gioventù <strong>nella</strong> <strong>poesia</strong> <strong>trobadorica</strong><br />
rappresenterebbero, invece, il vero e proprio rito di passaggio <strong>nella</strong> sua forma di ‘rito di<br />
aggregazione’. <strong>La</strong> prova richiesta può essere di vario tipo, ed è attorno ad essa che si struttura il<br />
romanzo cortese[29]; mentre <strong>nella</strong> letteratura <strong>trobadorica</strong>, <strong>nella</strong> maggior parte dei casi, abbiamo solo<br />
la ripresa metaforica di questi passaggi, e la prova in sé è meno rilevante. In questo caso, diventa<br />
centrale quella che dovrebbe essere una fase transitoria, cioè il periodo di margine. Quando sono<br />
molto prolungati, i periodi di margine possono acquistare una certa autonomia, fino a diventare a loro<br />
volta sistemi sociali, caratterizzati, al loro interno, da altre soglie e altri passaggi [30]; esattamente<br />
quanto avviene alla bassa cavalleria, che elabora, dalla sua posizione, il codice cortese.<br />
Come si è visto, c’è un rapporto molto stretto tra la tensione ascensionale dell’amante cortese sul<br />
piano morale e gli sforzi di elevazione sociale della piccola nobiltà. <strong>La</strong> metafora di un amore<br />
inaccessibile esprimerebbe il desiderio di superamento di una barriera sociale mediante valori nuovi –<br />
quelli della cortesia – che sono indipendenti dalla nobiltà di nascita [31]. Tuttavia, questa omologia<br />
tra l’amante ‘senza speranza’ della <strong>poesia</strong> cortese e una classe sociale ‘emarginata’ non deve<br />
suggerire un «rapporto genetico» [32]: è evidente – lo spiega lo stesso Köhler – che, se l’ideologia di<br />
joven è il risultato unitario di una tensione sociale permanente, pur essendo nata principalmente dalle<br />
istanze di un singolo gruppo, essa diventa ben presto linguaggio comune: il che spiega anche la lunga<br />
durata di alcuni dei temi cortesi. <strong>La</strong> <strong>poesia</strong> cortese passa, così, da una relativa aproblematicità iniziale,<br />
in cui i momenti dell’«ideale lodato» e della «realtà criticata» sono compresenti (i primi vers di<br />
Guglielmo IX), alla definizione di due nuovi generi, la canzone e il sirventese, nei quali ciascuno dei<br />
due momenti, resosi autonomo, si pone ad un livello stilistico diverso. In questo senso, il formarsi di<br />
una linea cosiddetta ‘alto-cortese’ e di una cosiddetta ‘piccolo-cortese’, non necessariamente<br />
ricollegabili alla situazione personale dei loro fautori, sono una conseguenza dell’evoluzione dello<br />
stesso sistema della fin’amor. Abbiamo quindi, da un lato, le canzoni di Jaufre Rudel e, dall’altro, i<br />
sirventesi di Marcabru; ma anche la canzone, che domina il sistema dei generi <strong>nella</strong> letteratura<br />
<strong>trobadorica</strong>, lungi dall’essere estranea alle istanze fin qui descritte, sarebbe una «forma di<br />
compromesso che celebra […] l’armonizzazione degli interessi della piccola nobiltà in ascesa e<br />
dell’antica aristocrazia» [33].<br />
6. Il ruolo della donna<br />
Una volta stabilite e codificate le doti ideali, esse vengono ri-attribuite alla dama. joven, virtù delle<br />
virtù, originariamente maschile, sulla fine della parabola <strong>trobadorica</strong> può essere riferita anche alla<br />
donna. Il primo esempio a noi noto di questo travaso, precedente anche al caso già esaminato in<br />
Bertran de Born, è in Rigaut de Berbezilh. Nella lirica Atressi con Persavaus(«Come Perceval»), il<br />
trovatore tesse una lode della donna amata (chiamandola Miels-de-dompna, «ottima-fra-le-donne»),<br />
rifacendosi ad un topos tradizionale: la donna è anziana per esperienza e saggezza, ma giovane nel<br />
possesso delle qualità cortesi (jois, v. 56; bel domneiar, v. 59; jovenz, v. 62; gent acuilir, v. 66). Il<br />
topos del puer senilis, che fonde caratteri di maturità e doti giovanili, è antichissimo [34], e Rigaut lo<br />
riprende intendendo ‘vecchio’ e ‘giovane’ alla maniera cortese; vale a dire non – o, almeno, non solo –<br />
in accezione anagrafica. Se quel che rende tale il giovane non è la sua età, anche vielh non significa<br />
letteralmente «vecchio»: «le mot est relativement rare et signifie ‘méchant’ chez les moralistes et<br />
‘discourtois’ chez les poètes» [35]. Si tratta, ancora una volta, di qualità al tempo stesso morali e<br />
sociali, anche se nell’accezione di joven si può avvertire un riavvicinamento alla nozione tradizionale di<br />
giovinezza (E joves d’ans). Almeno in un altro luogo Rigaut attribuisce joven alla sua dama (Lo nous<br />
mes d’abril comensa, «Inizia il nuovo mese di aprile»), questa volta non come precisa qualità, bensì<br />
in senso astratto, come somma qualità cortese di cui la dama è signora. Lo stesso troviamo in Guillem<br />
de Berguedà, contemporaneo di Rigaut o di poco successivo: «Ahi, signora, che la gioventù mantiene<br />
e la discrezione guida…» (XXVIII, vv. 22 sg.) [36].<br />
È interessante notare come, nonostante il tentativo di individuare differenze fondanti tra la <strong>poesia</strong><br />
http://www.griseldaonline.it/percorsi/5allegro2_print.htm (5 di 10) [12/10/2008 15.01.16]