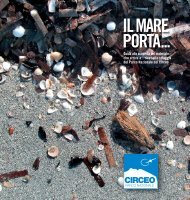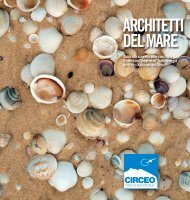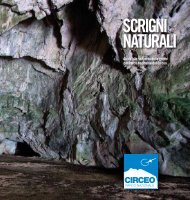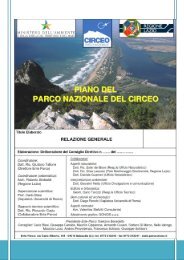Piano del Parco 4 pag 58-104.pdf - Parco Nazionale Del Circeo
Piano del Parco 4 pag 58-104.pdf - Parco Nazionale Del Circeo
Piano del Parco 4 pag 58-104.pdf - Parco Nazionale Del Circeo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Ente <strong>Parco</strong> <strong>Nazionale</strong> <strong>del</strong> <strong>Circeo</strong> – Schema di <strong>Piano</strong> <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> – Dicembre 2010<br />
che si espanse presso tutto il promontorio. Sempre ad età tardo - repubblicana rimandano le strutture che<br />
gravitavano attorno all’area portuale: i muri in opera reticolata ed i muri di fondazione.<br />
Gli impianti termali<br />
Tra gli impianti termali presenti sul territorio, soprattutto costruiti a servizio di ville e residenze patrizie ricordiamo i<br />
resti di un impianto <strong>del</strong>la fine I a.C. - inizio I d.C. venuti alla luce in prossimità di Torre Paola, sulla Pedemontana, nel<br />
corso dei lavori di sistemazione stradale effettuati dal Consorzio di Bonifica di Piscinara nel 1939. Il complesso,<br />
costituito da tre ambienti comunicanti, realizzati in opera incerta e coperti con volta a botte, presenta caratteristiche<br />
proprie <strong>del</strong>le terme ma anche elementi tipici dei colombari (nicchie lungo le pareti).<br />
Tuttavia l’ipotesi di una trasformazione <strong>del</strong> complesso termale in colombario contrasta con l’analisi <strong>del</strong>le strutture.<br />
Alcuni elementi superstiti sono stati di grande utilità agli studiosi nel precisare la cronologia <strong>del</strong>la struttura. La tecnica<br />
edilizia, il tipo di mosaico adoperato nei pavimenti e la decorazione in stucco collocano l’impianto tra l’ epoca tardo -<br />
repubblicana ed augustea.<br />
L’impianto rappresenta un’altra testimonianza nell’area compresa tra Torre Paola e la Cala dei Pescatori di intervento<br />
anteriore alle realizzazioni neroniane.<br />
3. IL PERIODO FINO ALLA GRANDE BONIFICA PONTINA<br />
La decadenza <strong>del</strong>l’Impero Romano si evidenziò anche nel progressivo abbandono <strong>del</strong>la Pianura Pontina, soprattutto<br />
per effetto <strong>del</strong> crescente dissesto <strong>del</strong>la via Appia nel tratto più paludoso <strong>del</strong>la piana, il che implicò la rivalutazione<br />
<strong>del</strong>la via pedemontana. Questo determinò l’oblìo <strong>del</strong>la pianura, nella quale si diffusero forme di utilizzo agricolo<br />
sempre meno estese ed il recupero spontaneo <strong>del</strong>la vegetazione su gran parte <strong>del</strong>le superfici.<br />
Nel XVI secolo furono intraprese, ad opera dei papi Leone X e Sisto V, nuovi interventi di bonifica e, nella seconda<br />
metà <strong>del</strong> XVIII secolo, ad opera però di Pio VI, viene avviato il più significativo dei lavori di prosciugamento <strong>del</strong>la<br />
palude, anche attraverso la realizzazione di un grande canale di drenaggio adiacente alla via Appia, il canale “Linea<br />
Pio”. Grazie a tale intervento la via Appia venne ripristinata come grande strada di collegamento con il Meridione.<br />
Il sistema utilizzato in questo intervento fu quello <strong>del</strong>la realizzazione di una serie di canali disposti perpendicolarmente<br />
alla “Linea Pio”, distanziati tra loro un miglio e associati ad una serie di strade minori (che presero il nome di<br />
“migliare”). Le canalizzazioni <strong>del</strong>le migliare interessavano le aree più pianeggianti e più soggette all’impaludamento,<br />
cioè quelle comprese tra l’Appia e i rilievi che <strong>del</strong>imitano la pianura (fig. 6). Questo impianto funzionale (cioè le<br />
migliare associate ad un canale principale di gronda) rimase come schema di riferimento per tutte le iniziative<br />
successive, progettuali ed operative, e costituì la base <strong>del</strong>l’intervento di bonifica degli anni ‘20/’30 <strong>del</strong> secolo scorso.<br />
In quel periodo, le attività praticate nella pianura erano sostanzialmente quella <strong>del</strong>la produzione <strong>del</strong> carbone, <strong>del</strong>la<br />
pesca nei laghi e stagni, <strong>del</strong>la caccia, <strong>del</strong> pascolo e, in parte, <strong>del</strong>l’agricoltura. Gli insediamenti erano costituiti da piccoli<br />
nuclei di capanne circolari (costruite sulle aree più asciutte e rilevate, dette lestre); l’ambiente era ancora inospitale e<br />
pericoloso per la presenza <strong>del</strong>la malaria, costituiva però una risorsa per i proprietari e le comunità che abitavano sulle<br />
colline circostanti, che ne utilizzavano ampi appezzamenti come università agrarie.<br />
90