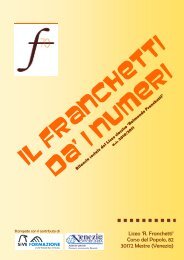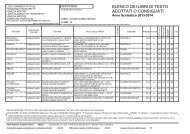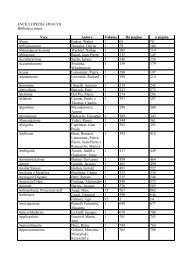Filosofia e retorica
Filosofia e retorica
Filosofia e retorica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Filosofia</strong> e <strong>retorica</strong> 16<br />
Poiché solo poche delle premesse dei sillogismi retorici sono necessarie<br />
(infatti la maggior parte delle questioni su cui si fanno giudizi ed esami,<br />
possono anche essere diversamente; infatti si deliberano ed esaminano<br />
argomenti di azione, e le azioni sono tutte di questo tipo e non ve n’è<br />
nessuna, per così dire, necessaria); e poiché le proposizioni che si verificano<br />
solo per lo più e che sono solo possibili si concludono necessariamente da<br />
proposizioni di questo tipo, e quelle necessarie da proposizioni necessarie<br />
(questo è evidente dai nostri Analitici, è chiaro che le premesse degli entimemi<br />
saranno alcune necessarie, ma la maggior parte soltanto frequenti, e gli<br />
entimemi si traggono dai verosimili e dai segni, cosicché è necessario che<br />
questi due tipi di premesse si identifichino con quei due tipi.<br />
Il verosimile è ciò che avviene per lo più, non però assolutamente, come<br />
alcuni definiscono, ma ciò che, nell’ambito di quel che può essere diversamente,<br />
è, rispetto alla cosa rispetto a cui è verosimile, come l’universale<br />
rispetto al particolare. Dei segni l’uno si comporta come un particolare in<br />
rapporto all’universale, l’altro come un universale in rapporto al particolare.<br />
Di essi quello necessario è la prova, quello non necessario non ha un nome<br />
corrispondente a questa differenza. Intendo per necessarie le proposizioni<br />
da cui derivano sillogismi. Perciò anche dei segni quello che è tale è la<br />
prova: quando infatti si ritiene che non è possibile confutare la proposizione<br />
enunciata, allora si pensa di apportare una prova, che si ritiene dimostrata<br />
e compiuta; nella lingua antica infatti τέκμαρ [prova] e πέρας [compimento]<br />
significano la stessa cosa.<br />
Dei segni l’un tipo si trova nel rapporto del particolare all’universale:<br />
ad esempio: se uno dice che del fatto che i sapienti siano giusti è segno il<br />
fatto che Socrate è sapiente e giusto. Questo è un segno, ma è confutabile,<br />
anche se la proposizione detta sia vera: esso infatti è asillogistico. Un altro<br />
segno invece è del tipo di quando uno dice esser segno ch’egli sia malato il<br />
fatto di aver la febbre, oppure esser segno che ella abbia partorito il fatto<br />
che ha latte: questo è necessario. E questo è il solo dei segni che sia una<br />
prova: esso solo, infatti, se è vero, è inconfutabile. Un altro tipo si trova<br />
invece nel rapporto dell’universale al particolare; ad esempio se uno dice<br />
che un indizio che egli abbia la febbre è che respira rapidamente. Anche<br />
questo è confutabile, anche se è vero: infatti è possibile che abbia difficoltà<br />
di respiro anche chi non ha la febbre.<br />
Si è qui detto dunque che cos’è il verosimile e che cosa sono il segno e la<br />
prova e in che cosa differiscono. . .<br />
S’è detto che l’esempio è un’induzione e intorno a quali soggetti è<br />
induzione. Esso non è nel rapporto della parte al tutto né in quello del<br />
tutto alla parte, ma in quello della parte all parte, del simile al simile,<br />
quando i due termini appartengono a uno stesso genere, ma uno sia più