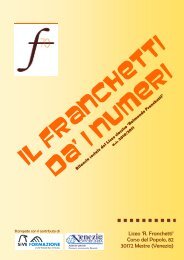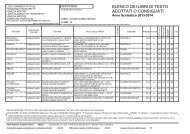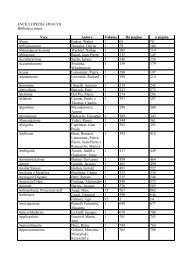Filosofia e retorica
Filosofia e retorica
Filosofia e retorica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Filosofia</strong> e <strong>retorica</strong> 2<br />
dato; perciò affermiamo che essa non costituisce una tecnica intorno a un<br />
genere proprio e determinato» 1 . L’entimema è un sillogismo nel quale una<br />
premessa viene omessa, in ragione della sua ovvietà. La <strong>retorica</strong> appartiene<br />
dunque all’ambito del probabile, della conoscenza diffusa e non scientifica, e<br />
si differenzia dalla dialettica per il fatto che quest’ultima fa uso esclusivo di<br />
argomenti di tipo razionale. Di conseguenza, l’entimema può sostenere una<br />
tesi e anche convincere, ma non dimostrare. Infatti «La <strong>retorica</strong> è analoga<br />
alla dialettica: entrambe riguardano oggetti che, in certo modo, è proprio<br />
di tutti gli uomini conoscere e non di una scienza specifica. Perciò tutti<br />
partecipano in certo modo a entrambe; tutti infatti sino a un certo punto si<br />
preoccupano di indagare su qualche tesi e di sostenerla, di difendersi e di<br />
accusare» 2 .<br />
La <strong>retorica</strong> perciò ha anche una destinazione concreta, di matrice politica<br />
che Aristotele individua al di sopra degli altri usi possibili: «La sua<br />
funzione riguarda argomenti intorno ai quali deliberiamo e intorno ai quali<br />
non abbiamo arti, e di fronte a uditori che non sono in grado di trarre<br />
un’inferenza da molti elementi, né di ragionare alla lontana» 3 . Dunque, essa<br />
ha per oggetto precipuo argomenti che attengono all’attività deliberativa.<br />
La dialettica riguarda il sapere opinativo, nel caso che esso si applichi in<br />
particolar modo alla politica. Aristotele mostra così di trovarsi a cavallo tra<br />
la pratica dei Sofisti e la rifondazione della <strong>retorica</strong> proposta da Platone<br />
nel Fedro, dopo la drastica liquidazione del Gorgia. Viene ripreso lo sforzo<br />
platonico di abbandonare una <strong>retorica</strong> fatta di parole ingannatrici e vuote,<br />
ma allo stesso tempo se ne accentua la natura debole.<br />
In ogni caso, pur riconoscendo il ruolo dell’emozione e il ricorso alle tecniche<br />
psicagogiche, Aristotele lamenta che la <strong>retorica</strong> ha negletto l’elemento<br />
argomentativo, svuotandosi per conseguenza di contenuto. L’emozione è<br />
elemento immancabile e anzi necessario, ma dev’essere prodotta dal flusso<br />
degli argomenti (cioè, ancora una volta, dai contenuti) e non da espedienti<br />
esterni, di matrice esclusivamente verbale. Peraltro, Aristotele imputa questo<br />
decadimento al fatto che l’oratoria sia stata applicata all’attività forense,<br />
che giudica secondaria, piuttosto che alla sua fisiologica destinazione, e cioè<br />
la deliberazione politica.<br />
Aristotele opera una cesura fra dimostrazione scientifica e argomentazione<br />
<strong>retorica</strong>. La prima non solo possiede un indiscutibile rigore formale, ma<br />
finisce per essere cogente nei confronti dell’ascoltatore, le cui caratteristiche<br />
sono inessenziali al buon fine della dimostrazione stessa. Invece, la seconda<br />
Ruolo<br />
deliberativo<br />
della <strong>retorica</strong><br />
Il ruolo dell’emozione<br />
Dimostrazione<br />
e<br />
argomentazione<br />
1 Aristotele, Retorica, 1355 b 25–34.<br />
2 Aristotele, Retorica, 1345a, 1–5.<br />
3 Aristotele, Retorica, 1357a 1–3.