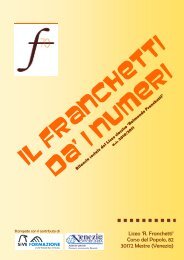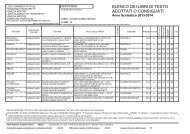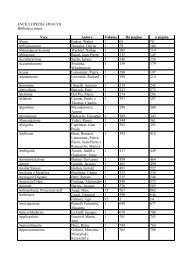Filosofia e retorica
Filosofia e retorica
Filosofia e retorica
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Filosofia</strong> e <strong>retorica</strong> 20<br />
L’estensione cosí conferita alla dialettica, che comprende sia lo studio<br />
delle inferenze valide che l’arte di trovare e di giudicare gli argomenti, sottrae<br />
alla <strong>retorica</strong> aristotelica le sue due componenti essenziali, l’invenzione e la<br />
disposizione, per non lasciarle che l’elocuzione, lo studio delle forme del<br />
linguaggio ornato. È in questo spirito, in seguito a questa riduzione filosoficamente<br />
giustificata, che l’amico di Pietro Ramo, Omer Talon, pubblica a<br />
Colonia, nel 1572, la prima <strong>retorica</strong> sistematicamente limitata allo studio<br />
delle figure: la figura essendo, secondo la definizione di Talon, «un’espressione<br />
per la quale l’andamento del discorso differisce dalla retta e semplice<br />
abitudine» 10 . In tal modo si instaurò dunque la <strong>retorica</strong> classica, quella<br />
<strong>retorica</strong> delle figure che ha progressivamente condotto dalla degenerazione<br />
alla morte della <strong>retorica</strong> stessa.<br />
È universalmente noto che la logica moderna, quale si è sviluppata a<br />
partire dal xix secolo, sotto l’influenza di Kant e dei logici matematici, ha<br />
identificato la logica non con la dialettica, ma con la logica formale, vale a<br />
dire con i ragionamenti analitici di Aristotele, trascurando completamente<br />
i ragionamenti dialettici, considerati estranei alla logica. Così facendo, mi<br />
sembra che essa abbia commesso un errore simmetrico rispetto a quello di<br />
Ramo. Se infatti è innegabile che la logica formale costituisce una disciplina<br />
distinta, che si presta, come la matematica, a operazioni e al calcolo, è<br />
altrettanto innegabile che noi ragioniamo, anche quando non calcoliamo, nel<br />
caso di una deliberazione intima o di una discussione pubblica, presentando<br />
argomenti a favore o contro una tesi, criticando, o confutando una critica.<br />
In tutti questi casi, non si effettua una dimostrazione, come in matematica,<br />
ma si svolge un’argomentazione. È dunque normale, se si concepisce la<br />
logica come lo studio del ragionamento in tutte le sue forme, completare la<br />
teoria della dimostrazione, sviluppata dalla logica formale, con una teoria<br />
dell’argomentazione, che studi i ragionamenti dialettici di Aristotele.<br />
Questi ultimi sono costituiti da argomentazioni miranti all’accettazione<br />
o al rifiuto di una tesi in discussione: il loro studio, come pure quello delle<br />
condizioni della loro presentazione, costituisce l’oggetto della nuova <strong>retorica</strong><br />
che si pone come seguito, e ampliamento, di quella di Aristotele.<br />
In effetti, Aristotele aveva contrapposto la <strong>retorica</strong> alla dialettica, quale<br />
l’aveva esaminata nei Topici, pur vedendo in essa il corrispettivo (ἀντίστροφος)<br />
della dialettica 11 : quest’ultima si interessa degli argomenti utilizzati in<br />
una controversia, ovvero una discussione con un solo interlocutore, mentre<br />
la <strong>retorica</strong> concerne le tecniche dell’oratore, che si rivolge a una folla riunita<br />
sulla pubblica piazza, sprovvista di qualsiasi sapere specializzato e incapace<br />
10 Cfr., a questo proposito, TA, pp. 177–78.<br />
11 Aristotele, Retorica 1354 a 1.