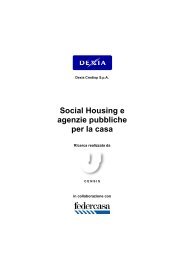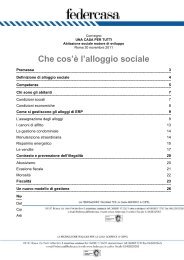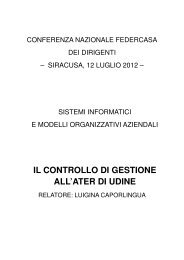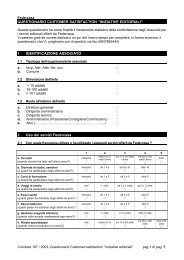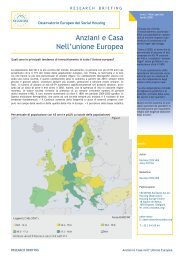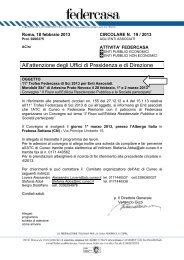EDILIZIA SOCIALE E INNOVAZIONE - Federcasa
EDILIZIA SOCIALE E INNOVAZIONE - Federcasa
EDILIZIA SOCIALE E INNOVAZIONE - Federcasa
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>EDILIZIA</strong> <strong>SOCIALE</strong> E <strong>INNOVAZIONE</strong><br />
Il binomio fra<br />
sperimentazione<br />
tipologicocostruttiva<br />
e case<br />
popolari ancora<br />
oggi sembra<br />
inscindibile.<br />
Nonostante<br />
le difficoltà<br />
nelle quali si<br />
dibatte il settore.<br />
Che cerca<br />
nuove strade<br />
di Fulvio Bertamini<br />
La storia<br />
continua<br />
tipologica, tecnico-costruttiva,<br />
persino urbanistica, è passata<br />
e passa tuttora da qui, in Italia.<br />
Dalle tanto bistrattate case popolari.<br />
Lo racconta la storia, lo conferma<br />
L’innovazione,<br />
il presente. Ancora oggi, infatti, nonostante<br />
le difficoltà che connotano il comparto dell’alloggio<br />
sociale, non mancano nelle realizzazioni<br />
degli ex Iacp sperimentazioni in materia di risparmio<br />
energetico, difesa antisismica, utilizzo di fonti<br />
energetiche alternative, ma anche residenze dedicate<br />
alle utenze svantaggiate, studenti e anziani su<br />
tutti. La ragione è semplice: il committente pubbli-<br />
co – molto più del privato – non persegue il business<br />
economico a tutti i costi. Al contrario, ha nel<br />
proprio dna la necessità di fornire un servizio ai<br />
clienti. E questo nonostante i mille vincoli che lo<br />
soffocano. Un ottimo motivo per rilanciare il settore,<br />
che da anni patisce l’assenza di politiche pubbliche<br />
mirate, a dispetto del fondamentale ruolo sociale<br />
che è chiamato a svolgere e che è ormai è stato<br />
riconosciuto anche a livello europeo.<br />
CASE PER TUTTI<br />
Nel 1903 la legge Luzzatti crea gli Istituti per le case<br />
popolari. Gli obiettivi, sottolinea Anna Maria<br />
SETTEMBRE 2006 ■ N. 279
Pozzo, direttore tecnico di <strong>Federcasa</strong> (che associa i<br />
114 enti che costruiscono e gestiscono in Italia le<br />
abitazioni sociali), erano “controbattere la speculazione<br />
privata, ma anche fornire modi utili di investimento<br />
dei capitali e provvedere al bisogno di abitazione<br />
di proletari, artigiani, piccoli coloni, proprietari<br />
rurali e impiegati, costruendo quartieri con<br />
pigioni adeguate al reddito di lavoro e aiutando a<br />
comporre il dissidio fra iniziativa individuale e accentramento<br />
municipale. Tutto questo senza nulla<br />
chiedere allo Stato, anzi fornendogli un nuovo cespite<br />
di ricchezza tassabile”. Sorgono ben presto<br />
complessi edilizi modello, come il quartiere Mac<br />
Mahon di Milano (1908-09) o come l’ex sede dell’Istituto<br />
autonomo delle case popolari della provincia<br />
di Milano (oggi sede Aler) di viale Romagna 26,<br />
sempre nel capoluogo lombardo. Fioriscono anche<br />
progetti d’autore, come l’asilo di Quadrio Pirani nel<br />
quartiere di San Saba, a Roma. Persino “il lessico<br />
architettonico e urbanistico del Razionalismo –<br />
prosegue Pozzo – trova in Italia alcune sue prime,<br />
significative realizzazioni in interventi di edilizia<br />
sociale a cavallo degli anni Trenta”.<br />
Ma è soprattutto dopo la guerra che viene varata<br />
una politica di ampio respiro, nei tempi e nei finanziamenti,<br />
diretta a realizzare nuove case popolari.<br />
L’impulso viene da due provvedimenti legislativi<br />
del 1949, il piano Fanfani (legge n. 43), pensato<br />
per “incrementare l’occupazione operaia mediante<br />
la costruzione di case per lavoratori”, che<br />
difatti contribuiscono alla dote finanziaria della 43<br />
versando lo 0,60 per cento dei propri salari, e la<br />
legge Tupini (n. 408), rivolta alla generalità dei cittadini,<br />
indipendentemente dal lavoro svolto, purché<br />
bisognosi di una casa e in possesso di determinati<br />
requisiti. Il piano lanciato dal ministro del Lavoro<br />
Amintore Fanfani, che apre la stagione dell’Ina<br />
casa, si pone il problema, fra l’altro, di definire<br />
le caratteristiche tecniche e tipologiche degli alloggi,<br />
nel quadro di una politica tesa a perseguire<br />
“una tipizzazione razionale, estetica ed economica<br />
delle costruzioni e correlativamente dei loro elementi”:<br />
così la norma. Allo scopo vengono redatti<br />
manuali di “raccomandazioni e suggerimenti”, dedicati<br />
alla progettazione degli alloggi e la loro aggregazione<br />
secondo quattro tipi edilizi (casa multipiano<br />
continua e isolata, casa a schiera a uno e a<br />
due piani); alla configurazione dei quartieri di edilizia<br />
popolare “in una prospettiva di urbanistica<br />
estensiva – sottolinea Pozzo – ed è completato dalla<br />
presentazione di progetti elaborati d’ufficio”;<br />
agli aspetti economici, finanziari e procedurali del<br />
piano per la realizzazione degli interventi (reperimento<br />
delle aree, costi di costruzione, compensi<br />
professionali, capitolati e appalti eccetera).<br />
“I nuovi quartieri – prosegue Pozzo – sorgono in periferia<br />
e sfruttano le opportunità delle nuove tecnologie<br />
costruttive per proporre architetture intensive<br />
e anonime”. Il tiro viene rettificato con legge n.<br />
167 del 1962, che introduce un’importante novità<br />
urbanistica: i piani di zona, che entrano a far parte<br />
della dotazione comunale di strumenti particolareggiati.<br />
La legge ponte, come viene ribattezzata la<br />
167, consente ai Comuni di costruire un patri- <br />
A lato,un’immagine del quartiere<br />
Laurentino di Roma.In basso,<br />
l’edificio per 12 alloggi<br />
di Lodivecchio,firmato da Fiano<br />
Guidarini Salvadeo architetti<br />
associati e realizzato nel 1996.<br />
Nell’altra pagina,lo storico<br />
complesso di viale Romagna 26<br />
a Milano,oggi sede dell’Aler.<br />
COSTRUIRE avvenimenti<br />
19
<strong>EDILIZIA</strong> <strong>SOCIALE</strong> E <strong>INNOVAZIONE</strong><br />
COSTRUIRE avvenimenti<br />
20<br />
A destra,la torre della Martesana,<br />
a Milano.In basso,l’edificio<br />
realizzato nel 1986 a Pordenone,<br />
uno dei primi esempi di solare<br />
passivo con un sistema di serre.<br />
monio di aree da urbanizzare e cedere ai soggetti<br />
attuatori, ma le assoggetta anche tutte all’esproprio<br />
“indipendentemente dalla loro destinazione –<br />
afferma Pozzo – in modo da creare l’indifferenza<br />
dei proprietari nei confronti della previsione dei<br />
piani”. Per la prima volta si parla di possibile integrazione<br />
dell’edilizia realizzata dagli Iacp con quella<br />
privata, per costruire un mix sociale più equilibrato<br />
nei quartieri. Altre innovazioni con la successiva<br />
legge 60 del 1963, che sostituisce la gestione<br />
Ina casa con la Gescal e promuove un piano decennale<br />
di costruzione di alloggi: di rilievo, in particolare,<br />
la previsione di finanziamenti per la realizzazione<br />
di attrezzature e servizi e il finanziamento di<br />
ricerche operative sull’edilizia residenziale e di progetti<br />
sperimentali.<br />
“Nasce un nuovo concetto del rapporto fra casa e<br />
servizi – sottolinea Pozzo - e si sviluppano quartieri<br />
integrati, quali il complesso residenziale del Gallaratese<br />
(1967-74), firmato fra gli altri da Carlo Aymonino<br />
e Aldo Rossi”. I tempi sono maturi per un’evoluzione<br />
ulteriore del concetto di quartiere come<br />
unità autosufficiente: un’utopia, certo, che viene però<br />
implementata dal varo della legge n. 865 del<br />
1975. Sono gli anni che vedono fiorire soprattutto il<br />
Corviale e il Laurentino a Roma, il Rozzol Melara a<br />
Trieste e il Cige di Genova-Rivarolo, quartieri periferici<br />
fortemente connotati; ma sorgono anche interventi<br />
più a scala degli abitanti, come il San Miniato<br />
di Siena realizzato da Giancarlo De Carlo.<br />
Nella fase di riorganizzazione che segue alla 865<br />
sono lanciati due piani straordinari che costituiscono<br />
un prologo alla riforma del 1978: anche in questo<br />
caso non mancano novità rilevanti, quali la destinazione<br />
di fondi per il risanamento di complessi<br />
pubblici nei centri storici e il varo di nuove norme<br />
tecniche, cogenti per tutta l’edilizia e prevalenti<br />
sulle disposizioni dei regolamenti comunali. I programmi<br />
straordinari, fra l’altro, incentivano la prefabbricazione,<br />
come evidenzia la realizzazione degli<br />
edifici a torre di Grosseto (1980).<br />
DAL GRANDE AL PICCOLO<br />
L’ultima riforma di un certo peso in materia è la<br />
legge 5 agosto 1978, n. 457, che fra l’altro incentiva<br />
il recupero dell’esistente. La norma avvia un<br />
percorso che porterà, nel giro di qualche anno, all’abbandono<br />
dell’intervento a grande scala urbana<br />
e al ripiegamento verso piccole opere di maggiore<br />
qualità complessiva, come i progetti di architettura<br />
lanciati dalla serie di concorsi “Opera prima”<br />
promossi dall’Aniacap (oggi <strong>Federcasa</strong>): fra tutti,<br />
l’edificio per 12 alloggi a Lodivecchio firmato da<br />
Fiano Guidarini Salvadeo architetti associati e<br />
realizzato nel 1996. La 457 apre la strada anche<br />
alle sperimentazioni odierne in materia energetica<br />
e tipologica e alla riqualificazione urbana diffusa,<br />
poi ulteriormente spinta dalla legge Botta-Ferrarini<br />
(n. 179/92). Fra i primi esempi in questa direzione<br />
la comunità per minori e handicappati inserita<br />
in un fabbricato pubblico del quartiere M2 di<br />
Torino, la trasformazione di un appartamento del<br />
Gratosoglio a Milano per portatori di handicap o,<br />
sempre nel Milanese, il complesso residenziale di<br />
Bussero con abolizione delle barriere architettoniche,<br />
tutte iniziative che anticipano la relativa legge<br />
13/89 di sei-sette anni.
<strong>EDILIZIA</strong> <strong>SOCIALE</strong> E <strong>INNOVAZIONE</strong><br />
COSTRUIRE avvenimenti<br />
22<br />
In campo energetico, le prime applicazioni di<br />
pannelli solari avvengono nel piccolo complesso<br />
realizzato a Carate Brianza, nel 1978 e soprattutto,<br />
su scala ben maggiore, in quello costruito nel<br />
1981 alla Martesana (Mi). Sempre a Milano, nel<br />
quartiere Moncucco, si sperimenta su quattro edifici<br />
a torre il sistema a pareti ventilate (1975). Le<br />
iniziative si susseguono con tale ritmo da far individuare<br />
una vera e propria linea di tendenza, ben<br />
evidenziata nelle mostre dell’Aniacap al Saie di<br />
Bologna del 1983 e alla successiva Expo energia<br />
di Torino. In rassegna, fra l’altro, la ristrutturazione<br />
del 24° quartiere Iacp nel capoluogo piemontese,<br />
che utilizza il sistema caldo-robot per<br />
garantire un’offerta diversificata di calore nel<br />
tempo e nello spazio abitativo; l’edificio pubblico<br />
di Vignole Borbera (Al), in cui il fabbisogno energetico<br />
è soddisfatto da un sistema che combina<br />
pompa di calore e pannelli solari; il quartiere di<br />
Busalla (Ge), la cui planimetria è stata progettata<br />
in funzione dell’ottimizzazione degli apporti solari,<br />
così come l’edificio Iacp di Caorle (Ve), che adotta<br />
anche vetrocamera, serramenti a taglio termico,<br />
tetto rovescio e coibentazione a cappotto in<br />
chiave di contenimento delle dispersioni termiche;<br />
il quartiere di Borgo San Sergio, a Trieste, che impiega<br />
fra l’altro pareti ventilate e impianti solari.<br />
A Pordenone, nel 1986, ecco uno dei primi esempi<br />
di solare passivo con un sistema di serre. Ma, come<br />
alla Martesana, l’esperimento fallisce e non<br />
viene ripetuto, perché non compreso – e peggio<br />
utilizzato – dagli inquilini.<br />
ECLISSI E RILANCIO<br />
Anna Maria Pozzo non usa mezzi termini: “La 457<br />
ha avuto il grande merito di avviare un’interessante<br />
fase di sperimentazione edilizia sul tema del risparmio<br />
energetico: una novità che è stata accolta<br />
con entusiasmo da molti Iacp, ma che si è risolta in<br />
un sostanziale fallimento. Le ragioni sono da ricercare<br />
nell’inadeguatezza del sistema imprenditoriale,<br />
caratterizzato da imprese non mature per installare<br />
questi impianti ed effettuare la manutenzione,<br />
in componenti non sufficientemente collaudati<br />
e, appunto, nella scarsa disposizione degli<br />
utenti per l’uso di dispositivi di nuova concezione.<br />
Questo il motivo che ha spinto a interrompere per<br />
circa vent’anni esperimenti di questo tipo. Oggi però<br />
alcune condizioni sono mutate e abbiamo ricominciato<br />
a sperimentare, in un’ottica più ampia di<br />
sostenibilità ambientale e sociale”.<br />
Anche questa volta è un’iniziativa di <strong>Federcasa</strong>, il<br />
premio “Palmarès 2003”, a fotografare il fiorire di<br />
nuovi interventi di edilizia pubblica nei settori della<br />
biocompatibilità, del risparmio energetico e delle<br />
nuove tecnologie. Fra le realizzazioni premiate, dieci<br />
alloggi nel borgo di Coniolo, presso Orzinuovi<br />
(Bs), costruiti a basso costo e limitato impatto ambientale,<br />
con solai in legno isolati con pannelli di sughero<br />
e muri portanti in laterizio, collettore solare<br />
integrato da una piccola caldaia da 35 kW e abbinato<br />
a un impianto centralizzato a pannelli radianti<br />
a pavimento, che consente risparmi energetici intorno<br />
al 15 per cento; il recupero di due edifici nella<br />
borgata Tufello, a Roma, realizzato con il duplice<br />
obiettivo di agevolare la permanenza degli inquilini<br />
anziani nelle proprie abitazioni mediante l’eliminazione<br />
delle barriere architettoniche negli spazi comuni<br />
e di adottare i principi della bioarchitettura,<br />
pur rimanendo nei limiti dei costi previsti per un<br />
ordinario intervento di recupero di edilizia pubblica;<br />
un edificio passivo nella periferia di Jesi (An) nel<br />
quale, per consentire l’orientamento verso sud degli<br />
affacci principali, il corpo di fabbrica è stato disaggregato<br />
in coppie di alloggi a doppio corpo, con a meridione<br />
la zona stanziale e a nord quella tecnica, collegate<br />
dai vani scala che svolgono la funzione di cer-<br />
SETTEMBRE 2006 ■ N. 279
niera e sistemi bioclimatici attivi e passivi; l’edificio<br />
antisismico di Città di Castello (vedi Costruire<br />
n. 250), dotato di isolatori costituiti da cuscinetti di<br />
appoggio multistrato di gomma e acciaio ancorati<br />
con elementi di acciaio alle strutture.<br />
La sperimentazione continua. A Bolzano, in zona<br />
Semirurali, è stato realizzato un complesso residenziale<br />
biocompatibile che, fra l’altro, utilizza<br />
materiali a basso consumo energetico e facilmente<br />
riciclabili, pratica l’ecogestione dei diversi flussi di<br />
risorse, siano essi energetici (mediante l’impiego<br />
di tecniche di risparmio e l’utilizzo di fonti rinnovabili)<br />
o idrici (recupero dell’acqua piovana), adotta<br />
misure per garantire la qualità dell’aria e della<br />
luce (ventilazione e illuminazione naturali), prevenendo<br />
l’inquinamento elettromagnetico interno<br />
(impianti elettrici schermati). A Torino l’attivissimo<br />
Atc sta gestendo sia l’intervento di via Arquata,<br />
quartiere che sarà dotato di un impianto di cogenerazione<br />
del calore, distribuito attraverso una<br />
rete di teleriscaldamento, e dell’installazione di <br />
Sopra,un’immagine<br />
complessiva e un dettaglio<br />
di facciata dell’insediamento<br />
residenziale biocompatibile<br />
realizzato a Bolzano,<br />
in zona Semirurali.<br />
Nell’altra pagina,foto<br />
e prospetto dell’edificio<br />
passivo realizzato<br />
nella periferia di Jesi<br />
dallo Iacp di Ancona.<br />
SETTEMBRE 2006 ■ N. 279
<strong>EDILIZIA</strong> <strong>SOCIALE</strong> E <strong>INNOVAZIONE</strong><br />
COSTRUIRE avvenimenti<br />
24<br />
A fianco,una vista delle murature<br />
e delle prese dell’aria preriscaldata<br />
nelle serre di un edificio<br />
residenziale a Vinovo (To),<br />
realizzato dall’Atc.<br />
Sotto,un rendering illustra<br />
il fronte sud del complesso<br />
sperimentale.<br />
pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici esposti<br />
a sudovest e sulla facciata della stessa sede dell’Atc,<br />
sia l’interessante esperimento del villaggio<br />
olimpico di Vinovo. Qui due edifici uguali, uno realizzato<br />
con tecnologie tradizionali e l’altro con tecniche<br />
bioclimatiche (materiali ecocompatibili, tetto<br />
verde, solai in legno-cemento, serre, pannelli solari<br />
e fv), consentiranno nel giro di qualche anno il confronto<br />
fra i risultati e i risparmi conseguiti.<br />
IL FUTURO<br />
“Da queste esperienze – afferma Anna Maria Pozzo<br />
– si possono trarre alcune indicazioni sulla possibilità<br />
di introdurre normative che favoriscano l’uso di<br />
materiali e tecnologie biocompatibili. Il settore dell’edilizia<br />
residenziale pubblica ha vincoli di costo<br />
che occorre rimuovere e rendere più flessibili; oc-<br />
corrono risorse finanziarie e incentivi mirati; sono<br />
necessari interventi di sensibilizzazione dell’utenza<br />
e anche di assistenza maggiori che per il settore<br />
privato. A queste condizioni il nostro comparto può<br />
essere ancora un campo di sperimentazione interessante,<br />
che oltretutto consente una maggiore<br />
qualità del monitoraggio rispetto al privato”.<br />
In assenza di politiche mirate, gli ex Iacp provano<br />
(da tempo) a fare da soli, o quasi. Il futuro più immediato<br />
può passare attraverso una triangolazione<br />
in cui il nuovo partner, che si affianca alla coppia<br />
tradizionale formata da ente gestore e inquilino-utilizzatore,<br />
si chiama Esco (Energy service company),<br />
società indipendenti che operano nel campo dei servizi<br />
energetici utilizzando lo strumento del finanziamento<br />
tramite terzi (ftt). Sfruttando il know-how<br />
delle Esco, per esempio, gli enti possono programmare<br />
interventi per ridurre i consumi di energia dei<br />
propri edifici: toccherà alle compagnie di servizi reperire<br />
sia i fornitori che le risorse, assumendosi i costi<br />
dell’opera. Il recupero dell’investimento potrà avvenire<br />
incassando i risparmi previsti in un arco di<br />
tempo: gli ammortamenti sono proposti, di solito, in<br />
cinque o in 15 anni. “Il sistema è previsto dalle normative<br />
europee – precisa Pozzo – ed è una strada<br />
che stiamo tentando di praticare per moltiplicare le<br />
sperimentazioni in materia di bioarchitettura, risparmio<br />
energetico e nuove tecnologie, oggi legate<br />
più alla possibilità che alla volontà degli enti di investire”.<br />
In altre parole, per continuare ad<br />
avere un futuro all’altezza del passato. C