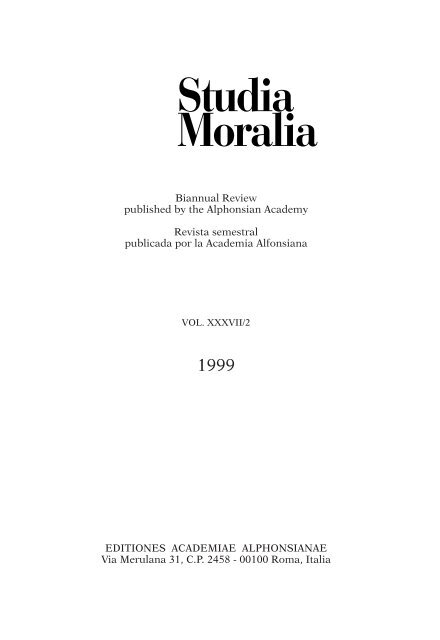Vol. XXXVII / 2 - Studia Moralia
Vol. XXXVII / 2 - Studia Moralia
Vol. XXXVII / 2 - Studia Moralia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Studia</strong><br />
<strong>Moralia</strong><br />
Biannual Review<br />
published by the Alphonsian Academy<br />
Revista semestral<br />
publicada por la Academia Alfonsiana<br />
VOL. <strong>XXXVII</strong>/2<br />
1999<br />
EDITIONES ACADEMIAE ALPHONSIANAE<br />
Via Merulana 31, C.P. 2458 - 00100 Roma, Italia
<strong>Studia</strong> <strong>Moralia</strong> – <strong>Vol</strong>. <strong>XXXVII</strong> / 2<br />
CONTENTS / ÍNDICE<br />
Articles / Artículos<br />
L. PADOVESE, La dimensione sociale del pensiero patristico:<br />
considerazioni generali .........................................<br />
T. KENNEDY, St. Alphonsus’ Selva. Should it be Understood<br />
as Rhetoric? .......................................................<br />
S. VIOTTI, Il problema morale della legge civile ................<br />
J. RÖMELT, Theologische Ethik und In-Vitro-Fertilisation<br />
M. P. FAGGIONI, Stato vegetativo persistente (seconda parte)..................................................................................<br />
R. TREMBLAY, Variations thérésiennes sur le thème de<br />
“l’enfant prodigue”.......................................................<br />
B. V. JOHNSTONE, Can Tradition Be a Source of Moral<br />
Truth? A Reply to Karl-Wilhelm Merks......................<br />
Events/Eventos<br />
D. GROS, Accademia Alfonsiana: Cronaca relativa all’anno<br />
accademico 1998-1999 ................................................<br />
Reviews / Recensiones<br />
Short Notices / Noticias<br />
Books Received / Libros recibidos<br />
Index of <strong>Vol</strong>ume <strong>XXXVII</strong> / Índice del <strong>Vol</strong>umen <strong>XXXVII</strong><br />
273<br />
295<br />
321<br />
357<br />
371<br />
413<br />
431<br />
453<br />
479<br />
525<br />
531<br />
535
273<br />
StMor 37 (1999) 273-293<br />
LUIGI PADOVESE OFM. CAP.<br />
LA DIMENSIONE SOCIALE<br />
DEL PENSIERO PATRISTICO:<br />
CONSIDERAZIONI GENERALI<br />
Prima di presentare alcuni aspetti della dottrina sociale dei<br />
Padri della Chiesa occorre ricordare che le fonti a nostra disposizione<br />
- per quanto ci appaiano consistenti - sono scarse, ci sono<br />
pervenute spesso casualmente 1 e sono disparate poiché composte<br />
da autori diversi, con finalità diverse, in tempi e luoghi diversi.<br />
Con altre parole: non si può capire un periodo o un ambiente<br />
sulla base di una o di poche opere rimasteci. Per quanti<br />
documenti si abbiano a disposizione, non va dimenticato che essi<br />
sono sempre un frammento; occorre altresì ricordare che ogni<br />
ricostruzione del mondo antico fatta con soli testi letterari è<br />
parziale e talora può essere sviante. Non si dimentichi inoltre<br />
che i testi di cui disponiamo provengono in genere da persone<br />
dei ceti colti e, nel caso presente, da autori ecclesiastici e capi di<br />
comunità che vivono all’interno di un particolare ambiente socio-religioso<br />
con responsabilità dirette nei suoi confronti. La lettura<br />
che essi offrono non ricostruisce pertanto la realtà sociale<br />
così com’è, ma soltanto il modo con cui essi se la sono rappresentata.<br />
Oltretutto negli scritti dei Padri c’è una progettualità trasformatrice<br />
ovvero il desiderio di costringere gli ascoltatori o i<br />
lettori ad entrare nella loro prospettiva, accogliendo la ricostruzione<br />
che essi offrono della realtà. A ciò si aggiunga la considerazione<br />
che la trattazione patristica dei temi sociali è perlopiù<br />
espressa attraverso la predicazione e - più esattamente - attra-<br />
1<br />
Si pensi a certi testi teologici antichi che scompaiono perché il tema<br />
da loro trattato (ad es. la lotta contro il marcionismo o il donatismo) non è<br />
più attuale o a certe omelie di Agostino che un autore del V/VI secolo come<br />
Cesario di Arles riduce, semplifica, ritocca adattandole a dei fedeli imbarbariti<br />
ed ignoranti.
274 LUIGI PADOVESE<br />
verso l’esegesi della Bibbia fatta nella predicazione. Questo significa<br />
che la S. Scrittura avrà un ruolo centrale nello sviluppo<br />
di temi sociali. Se poi si considera che l’interpretazione della<br />
Scrittura è storicamente sempre condizionata da circostanze diverse,<br />
si capirà come - variando queste - possa variare anche l’interpretazione<br />
‘sociale’ di certi brani. Talvolta, a determinare certe<br />
letture della Bibbia sono state delle provocazioni esterne al testo<br />
stesso. Insomma, va tenuto ben presente che “la Bibbia nella<br />
storia è stata comandante in quanto comandata, ha agito come<br />
stimolo su gruppi, su società intere, ma in quanto è stata - se<br />
si può dire così - agita da” 2 . Una indagine qual è la presente non<br />
potrà ignorare questi condizionamenti. Va tenuto ben chiaro, insomma,<br />
che i documenti che possediamo per ricostruire la dottrina<br />
sociale dei primi secoli cristiani muovono da una concezione<br />
cristiana della vita che è condizionata dalle circostanze<br />
storiche, dall’area geografica, dalla cultura antropologica, teologica<br />
ed etica del tempo 3 . Tali documenti portano, inoltre, l’impronta<br />
del carattere e delle esperienze di vita di chi scrive. La<br />
cultura, infatti, non è mai impersonale. Sarebbe dunque inesatto<br />
operare una specie di riduzionismo cognitivistico che si limita a<br />
ricercare le idee sociali dei Padri prescindendo asetticamente<br />
dalle proprietà psicologiche di ciascuno. Va ricordato che i nostri<br />
autori non hanno soltanto cervello ma anche cuore. Essi desiderano<br />
e sentono oltreché pensare, e i loro desideri e sentimenti<br />
impregnano i loro pensieri e influenzano le loro intenzioni.<br />
Rilevo, ad esempio, quanto sia significativo che i testi scritti<br />
che possediamo provengano esclusivamente da autori ‘maschi’ e<br />
quindi con un carattere androcentrico e una visione della realtà<br />
sociale improntata dalla cultura patriarcale caratteristica dei<br />
primi secoli cristiani e del mondo mediterraneo. In conclusione,<br />
2<br />
F. BOLGIANI, Senso e limiti di una storia dell’esegesi per il periodo dal II<br />
sec. a.C. al II sec. d.C., in ASE 2 (1985), 21.<br />
3<br />
Il riconoscimento dei condizionamenti culturali, non deve tuttavia indurre<br />
a credere che l’individuo sia un semplice portatore di cultura, uno di<br />
una serie passiva di identiche unità. L’odierna etnologia ha preso coscienza<br />
di come un individuo, in determinate circostanze, lasci questo ruolo passivo<br />
divenendo fattore di mutamenti culturali. Cf T. TENTORI, Antropologia culturale,<br />
Studium ed., Roma 1992, 125.
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 275<br />
per capire la storia bisogna incominciare a capire chi l’ha scritta,<br />
mettendosi il più possibile ‘nei suoi panni’, o acquistando<br />
“una visione dal di dentro”, non limitata - come dicevamo - a ricostruire<br />
soltanto teorie o una storia astratta delle idee come se<br />
il cristianesimo sia consistito soltanto in dottrine e non piuttosto<br />
in esperienze e pratiche religiose che si sono espresse anche<br />
nella vita sociale. Si tratta di tenere congiunti anima e corpo, il<br />
pensato ed il vissuto.<br />
E’ altresì importante non accostarsi allo studio del passato<br />
con criteri finalistici o utilitaristici. Ad esempio, le affermazioni<br />
del primitivo cristianesimo sulla proprietà non si possono applicare<br />
che limitatamente alla nostra società industriale dove il capitale<br />
è accumulato nelle mani di pochi e dove esistono corporazioni<br />
pubbliche (sindacati, mutue, assicurazioni...) ignote nella<br />
Chiesa antica la cui etica non può, quindi, offrire un sistema<br />
generale di norme vincolanti 4 . Il passato va preso in sé e per sé<br />
stesso e questo si può fare nonostante che ciascuno di noi - al<br />
pari degli antichi scrittori ecclesiastici - sia storicamente condizionato<br />
da interessi o da prospettive del presente. Eppure è necessario<br />
confrontarsi con altre esperienze perché “impariamo<br />
qualcosa su di noi stessi mettendoci nei panni degli altri” 5 . Del<br />
resto che cosa fa maggiormente crescere del fatto di non vivere<br />
isolati e di trarre insegnamento dalle esperienze altrui, sia passate<br />
che presenti? E dunque, il confronto storico risulta necessario<br />
e fa crescere purché non sia strumentalizzato a fini immediati.<br />
Proprio lo studio del pensiero sociale dei Padri della Chiesa<br />
mostra, invece, come la storicità dello storico abbia condizionato<br />
- a volte in modo determinante e addirittura sviante - la ricerca,<br />
isolando dal contesto antichi testi, e utilizzandoli come<br />
pretesti per avvalorare una particolare posizione ideologica.<br />
Non è questa la sede per ripercorrere le posizioni della storiografia<br />
marxista; quelle successive offerte dalla teologia liberale,<br />
da quella dialettica o kerygmatica, dalla cosiddetta ‘scuola’ di<br />
4<br />
Cf. M. HENGEL, Eigentum und Reichtum in der frühen Kirche - Aspekte<br />
einer frühchristlichen Sozialgeschichte, Calwer Verlag, Stuttgart, 1973, 87-88.<br />
5<br />
V. TURNER, Dal rito al teatro, trad. dall’inglese, Il Mulino, Bologna 1986,<br />
165.
276 LUIGI PADOVESE<br />
Chicago e gli orientamenti attuali 6 . Mi limito soltanto a ricordare<br />
che oggi generalmente si evita di leggere i testi cristiani antichi<br />
attraverso un’univoca interpretazione teologica, così come è<br />
rimossa anche l’idea di considerare il cristianesimo un mero fenomeno<br />
sociale. La sua nascita non si può spiegare in chiave di<br />
moto o di rivoluzione sociale, ma si deve intendere come un fatto<br />
di natura religiosa. Questa realtà religiosa, tuttavia, possiede<br />
un sicuro e fortissimo impatto sul ‘sociale’, anche se indiretto<br />
poiché il vangelo non dà indicazioni concrete o ricette per una<br />
prassi sociale, ma queste vengono dedotte dai suoi principi etici<br />
e, in primo luogo, dal grande principio “ama il prossimo tuo come<br />
te stesso”. Questo pare essere l’elemento caratterizzante della<br />
novità cristiana. Evidentemente questo amore non è legato a<br />
un tipo particolare di traduzione storica. All’inizio del cristianesimo,<br />
in un certo contesto sociale, s’è tradotto in beneficenza e<br />
condivisione dei beni, oggi le forme possono variare, eppure il<br />
movente dell’amore resta perennemente attuale.<br />
Tale movente è riconducibile allo speciale annuncio di Gesù<br />
il quale si rivolge a gente perlopiù economicamente vessata, in<br />
una società in preda a forti tensioni e in cerca di risposte 7 e dove<br />
la decomposizione politica e sociale ha distrutto gli antichi<br />
ideali terreni 8 . E’ fuori discussione che il suo annuncio procede<br />
dal centro focale dell’escatologia. Il Regno di Dio che egli annuncia<br />
è il cuore della sua predicazione. Tuttavia, questo Regno,<br />
ovvero questo regime teocratico che ha il Padre al centro non è<br />
interpretato come avviene nell’ambiente circostante come un regno<br />
che si impone con il diritto e con la forza, ma è un Regno a<br />
sfondo quietista, non violento, che porta una salvezza non confinata<br />
alla sola anima, ma attenta alla totalità della persona, uomo<br />
e donna e, proprio per questo, contro le strutture oppressive<br />
6<br />
Per una sintesi ragionata delle diverse posizioni rimando a G. BARBA-<br />
GLIO, Rassegna di studi di storia sociale e di ricerche di sociologia sulle origini<br />
cristiane I/II, in Rivista Biblica Italiana XXXVI (1988), 377-410.495-520.<br />
7<br />
Al proposito, uno spaccato della situazione socio-politica del tempo di<br />
Gesù è contenuta nell’interessante lavoro di R. A. HORSLEY-J.S. HANSON, Banditi,<br />
profeti e messia, trad. dall’inglese, Paideia 1995.<br />
8<br />
Cf E. TROELTSCH, Le dottrine sociali delle Chiese e dei gruppi cristiani,<br />
trad. dal tedesco, La Nuova Italia ed., Firenze 1941, 33.
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 277<br />
di ordine sociale e religioso del momento. In effetti, con l’annuncio<br />
del Regno Gesù sovverte le strutture di oppressione prospettando<br />
un futuro e rapporti umani diversi muovendo dal presupposto<br />
che davanti a Dio non vi sono differenze. Non è senza<br />
ragione che il messaggio di Gesù abbia avuto un impatto particolare<br />
sulle donne. Il suo annuncio propone un discepolato di<br />
uguali, dove chi comanda dev’essere come chi serve e dove non<br />
ci sono più padri e più maestri, ma tutti sono uguali. In altre parole<br />
Gesù, attraverso un annuncio di tipo religioso, “implicitamente<br />
sovverte le strutture economiche o androcentrico-patriarcali,<br />
anche se, probabilmente, le persone coinvolte in questo<br />
processo non avranno pensato in termini di strutture sociali” 9 .<br />
Va ricordato che l’annuncio di Gesù e dei suoi primi discepoli<br />
fu l’ambiente giudaico dell’area rurale siro-palestinese. E’<br />
noto come la tradizione delle parole di Gesù è legata al mondo<br />
agricolo. Basti pensare alle parabole. Eppure, pochi anni dopo<br />
la sua morte, il movimento da lui iniziato varcò i confini della<br />
Galilea, Giudea e Samaria per opera di alcuni missionari giudeo/cristiani<br />
grecoparlanti (At 11,20).<br />
Che cosa ha comportato questo passaggio ambientale? Previamente<br />
va richiamata la sproporzione economica tra le ‘zone depresse’<br />
della Palestina e il prosperoso mondo urbano mediterraneo.<br />
Occorre inoltre ricordare che la missione di questi primi<br />
cristiani (si pensi a Paolo, Barnaba) si concentrò in città dove<br />
non esistevano quelle contraddizioni strutturali tipiche del critico<br />
assetto socio/politico palestinese. Per questo non meraviglia<br />
che l’annuncio teocratico radicale del primo movimento cristiano<br />
sia venuto via via scomparendo 10 . E’ da collegare a questo<br />
mutamento il fatto che Paolo non annunzi il Regno di Dio che<br />
invece caratterizzava la predicazione di Gesù e dei carismatici<br />
itineranti palestinesi. Neppure meraviglia che le comunità ellenistiche<br />
recepissero molto cautamente le tradizioni palestinesi<br />
che provenivano da un mondo completamente diverso.<br />
9 SCHÜSSLER FIORENZA E., In memoria di lei - Una ricostruzione femminista<br />
delle origini cristiane, trad. dall’inglese, Claudiana ed., Torino 1990, 169.<br />
10<br />
Cf G. THEISSEN, Sociologia del cristianesimo primitivo, trad. dal tedesco,<br />
Marietti, Genova 1987, 187.
278 LUIGI PADOVESE<br />
La conseguenza di ciò si riflette nelle lettere del cristianesimo<br />
primitivo che assai di rado richiamano delle parole di Gesù.<br />
Al radicalismo etico afamiliare che non si poteva realizzare, subentra<br />
un ‘patriarcalismo d’amore’ di stampo familiare che non<br />
scardina dall’ambiente in cui si vive, che accetta, relativizzandole,<br />
le differenze sociali esistenti e che assume senza riserve la<br />
struttura politica (Rom 13,1ss), eppure attenua tutte le differenze<br />
di classe obbligando all’amore vicendevole. Ormai essere<br />
schiavo o libero importa relativamente, dal momento che la<br />
chiamata alla fede prescinde da tutto ciò e svuota le diversificazioni<br />
o stratificazioni vigenti nella società. Per questo Paolo può<br />
affermare: “ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando<br />
fu chiamato” (1Co 7,20). Concretamente ciò significa che le<br />
differenze nella chiesa non contano nulla (cf 1Co 7,19) e non determinano<br />
la situazione dei singoli all’interno di essa. Si tratta<br />
piuttosto di rimanere nello status di schiavo, ma senza la mentalità<br />
dello schiavo, o di rimanere nella condizione giuridica di<br />
libero, ma di non vivere più con la mentalità dell’uomo libero.<br />
Ciò è possibile, secondo Paolo, se avendo presente che “il tempo<br />
ormai si è fatto breve” (1Co 7,29) si vive nelle diverse situazioni<br />
come se non si vivesse realmente in esse: “quelli che hanno moglie<br />
- scrive - vivano come se non l’avessero (...), quelli che comprano<br />
come se non comprassero, quelli che usano del mondo,<br />
come se non ne usassero appieno, poiché passa la scena di questo<br />
mondo”(1Co 7, 29-31). Con questo rinnovamento della mente<br />
(cf Rom 12,2) la struttura sociale non cambia; le differenze<br />
possono continuare ad esistere, eppure l’appartenenza alla nuova<br />
famiglia cristiana le relativizza (cf Gal 3,28) in nome di quell’uguaglianza<br />
che non scaturisce dall’aver la stessa natura o una<br />
comune appartenenza sociale, ma una santità prodotta dal battesimo,<br />
ovvero il fatto che Dio in Cristo ci rende partecipi della<br />
sua immagine (Rom 8,29). Proprio questo patriarcalismo “con il<br />
suo moderato conservatorismo sociale, ha dato al cristianesimo<br />
un’impronta durevole” 11 . Non lo ha comunque privato del suo riferimento<br />
alla persona di Gesù e al suo comportamento che resta<br />
centrale e neppure della tensione escatologica, ovvero del<br />
11<br />
G. THEISSEN, Sociologia... 239.
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 279<br />
convincimento dell’imminenza del Regno che caratterizza l’annuncio<br />
di Cristo. Osserviamo anzi che là dove questi aspetti prevalgono<br />
sull’impegno di inculturazione si afferma un cristianesimo<br />
avente una scarsa sensibilità sociale. In aree geograficamente<br />
isolate dal mondo mediterraneo come quelle della Siria/Mesopotamia<br />
evangelizzate da missionari giudeo/cristiani di<br />
lingua aramaica si assisterà così allo sviluppo di comunità cristiane<br />
della apotaxìa ovvero della rinuncia radicale ad ogni forma<br />
di possesso, realizzata a partire dal concetto di sequela e sostenuta<br />
da una forte tensione escatologica 12 . Tra i testi rappresentativi<br />
di questo modo di pensare dove il criterio della sequela<br />
è imperativo per tutti i cristiani e dove la vita ascetica costituisce<br />
l’unica forma di vita cristiana 13 va ricordato il Vangelo di<br />
Tommaso (140 ca.) 14 e gli Atti di Tommaso (metà del III sec.) 15 . In<br />
essi il problema etico circa la proprietà, il possesso delle ricchezze<br />
e il loro utilizzo è del tutto secondario rispetto al tema<br />
kerygmatico della discepolanza e della sequela di Gesù povero<br />
ed itinerante. In questi scritti che ci mettono a contatto con il<br />
cristianesimo siriaco non v’è posto per una dottrina sociale della<br />
Chiesa perché il rapporto con il mondo e i suoi beni, se non è<br />
conflittuale, è perlomeno di disinteresse verso questa realtà<br />
transitoria che non è percepita come ‘nostra’ e nella quale le ricchezze<br />
appaiono quantomeno distraenti e pericolose. Ci trovia-<br />
12<br />
Circa queste osservazioni rimando a M. MEES, Pilgerschaft und Heimatslosigkeit.<br />
Das frühe Christentum Ostsyriens, in Augustinianum 19 (1979),<br />
53-73, in cui l’autore sostiene che la normatività della sequela per tutti i cristiani<br />
delle Chiese della Siria occidentale è riconducibile ad asceti missionari<br />
giudeo cristiani di lingua aramaica che diffusero un cristianesimo di poveri<br />
itineranti.<br />
13<br />
Questa posizione, documentabile sino al IV secolo, rappresenta il pensiero<br />
della maggioranza dei cristiani nell’area siriana ad est di Edessa (Nisibi,<br />
Hatra). cf A. FELDTKELLER, Identitätssuche des syrischen Urchristentums -<br />
Mission, Inkulturation und Pluralität im ältesten Heidenchristentums, Vandenhoeck<br />
& Ruprecht, Göttingen 1993, 80-81.<br />
14<br />
Per la presentazione di questo scritto cf L. MORALDI, (a cura di), Apocrifi<br />
del Nuovo Testamento - Vangeli, Piemme, Casale M., 1994, 547-551.<br />
15<br />
Per informazioni di carattere introduttivo cf L. MORALDI (a cura di)<br />
Apocrifi del Nuovo Testamento - Atti e leggende, Piemme, Casale M. 1994,<br />
303-319.
280 LUIGI PADOVESE<br />
mo dinanzi a una “prospettiva potenzialmente disgregatrice nei<br />
confronti di ogni ordinamento sociale e per questo si troverà necessariamente<br />
in difficoltà man mano che il decorso storico darà<br />
ragione a un cristianesimo non più straniero e itinerante, ma insediato<br />
nel mondo. Sopravviverà allora ai margini dei circuiti<br />
sociali, là dove forme di persecuzione o il vivo sentimento escatologico<br />
terranno desto il senso di estraneità dal mondo” 16 . Se da<br />
questa area della Siria ci si sposta verso il mondo mediterraneo<br />
si constaterà un mutato atteggiamento in rapporto ai temi sociali.<br />
A determinarlo concorre - come già accennato - la situazione<br />
socio-ambientale diversa, il processo di inculturazione in<br />
un mondo greco/romano cittadino, la composizione della Chiesa<br />
(incremento numerico, presenza di strati sociali diversi con<br />
relativa crescita dei cristiani ricchi e colti), la trasformazione o<br />
il passaggio in secondo piano di talune credenze cristiane (es. la<br />
concezione apocalittica), i mutamenti politici, la situazione personale<br />
di chi scrive, ecc. Si può dunque ritenere che a fissare la<br />
diversità di atteggiamenti in rapporto ai temi sociali concorrono<br />
sempre circostanze storiche, ambientali e personali che non vanno<br />
mai dimenticate. Una conferma di una mutata sensibilità sociale<br />
rispetto alle Chiese della apotaxia ci è offerta dal Pastore d’Erma<br />
17 e dal Quis dives salvetur di Clemente Alessandrino 18 , scritti<br />
rispettivamente a Roma e ad Alessandria. Nel Pastore gli inviti al<br />
radicalismo evangelico risultano temperati e prevale quel ‘patriarcalismo<br />
d’amore’ che attenua le differenze sociali nel riconoscimento<br />
della complementarietà - all’interno dello stesso<br />
gruppo cristiano - di ricchi e poveri: i primi aiutano material-<br />
16<br />
G. VISONA’, Povertà, sequela, carità. Orientamenti del cristianesimo dei<br />
primi due secoli, in AaVv, Per foramen acus. Il cristianesimo antico di fronte<br />
alla pericope evangelica del giovane ricco, Milano 1986, 36.<br />
17<br />
Lo scritto redatto in modo definitivo da Erma, un ex schiavo fratello<br />
di Pio, vescovo di Roma, si compone di diverse sezioni redatte in tempi diversi<br />
(presumibilmente dal 90 al 140). Per una sua presentazione generale e<br />
per il testo critico, cf R. JOLY, Hermas - Le pasteur, Introduction, texte critique,<br />
traduction et notes par R. Joly: SCh 53.<br />
18<br />
Una presentazione del Quis dives salvetur che costituisce un commento<br />
(o forse un’omelia?) alla pericope di Mc 10, 17-31 sull’incontro tra Gesù<br />
e il giovane ricco, è offerta da C. NARDI, in CLEMENTE D’ALESSANDRIA, Quale<br />
ricco si salva? Il cristiano e l’economia, Roma 1991.
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 281<br />
mente i secondi e questi sostengono i primi con le loro preghiere.<br />
Erma non esige dai ricchi l’abbandono del mondo e, tantomeno,<br />
considera malvagia la ricchezza, ma la considera un dono<br />
funzionale di Dio in quanto serve a beneficare gli altri, facendo<br />
loro parte dei beni da Lui creati. Nell’essere ricchi è implicito<br />
perciò l’impegno al servizio dei poveri. La pericolosità<br />
della ricchezza - pur riconosciuta - non importa, pertanto, che la<br />
si abbandoni, ma che la si usi rettamente e la povertà non è più<br />
intesa come una ‘virtù’, ma come un ‘male’ da riparare con la beneficenza.<br />
Dal canto suo Clemente (+ prima del 215), facendo<br />
un’esegesi di Mc 10, 17-31 adattata ad un uditorio di ricchi, ritiene<br />
che l’invito di Gesù a lasciare tutto non impone la rinuncia<br />
alle ricchezze, ma la solidarietà verso i poveri. I beni materiali<br />
che provengono da Dio, di per sé non sono né buoni né cattivi.<br />
E’ il loro utilizzo che ne specifica la bontà o la malizia. Anche<br />
per Clemente il senso ultimo della ricchezza si giustifica nel suo<br />
utilizzo sociale, ovvero nell’essere posta al servizio dei bisognosi.<br />
Il diritto alla proprietà privata è limitato dai bisogni dei fratelli<br />
di fede e, probabilmente, di tutti gli uomini.<br />
Se si confronta la posizione degli scritti dell’area siriana<br />
(Vangelo e Atti di Tommaso) con quanto Erma o Clemente scrivono,<br />
si potrebbe pensare che l’atteggiamento di costoro costituisca<br />
un compromesso e quasi un venir meno all’ideale di radicalità<br />
proposto da Cristo. In realtà, l’atteggiamento verso i beni<br />
terreni presentato particolarmente nel Quis dives salvetur? muove<br />
da una diversa spiritualità: è la spiritualità che “risulterà sempre<br />
più quella della Grande Chiesa, anche perché più idonea a<br />
seguire l’evoluzione dell’annuncio cristiano (...). E’ la Chiesa dell’agape,<br />
dell’amore verso il prossimo, della condivisione fraterna,<br />
dell’elemosina meritoria, la Chiesa che predica l’amore per i poveri.<br />
Qui nasce la dottrina sociale della Chiesa” 19 . Tale dottrina<br />
troverà le sue formulazioni più significative nel IV/V secolo per<br />
opera dei grandi Padri orientali ed occidentali. Tutto il discorso<br />
economico svolto da costoro riflette la realtà di un cristianesimo<br />
divenuto ormai fenomeno di massa che ingloba in sé tutti gli<br />
19<br />
G. VISONA’, Povertà, sequela, carità 60.
282 LUIGI PADOVESE<br />
strati dell’antica società. Tenuto presente questo stato di cose,<br />
s’impongono alcune precisazioni:<br />
a. Va tenuto anzitutto ricordato che i testi concernenti temi<br />
sociali provengono perlopiù da personaggi di famiglia benestante<br />
che hanno avuto una buona formazione culturale pagano/cristiana<br />
(Ilario di Poitiers, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo,<br />
Gregorio di Nissa, Giovanni Crisostomo, Ambrogio, Agostino,<br />
Teodoreto di Cirro). L’approccio alla cultura pagana attraverso<br />
l’apprendimento della retorica e della filosofia, spiega il frequente<br />
ricorso negli scritti di questi Padri a concezioni divulgate<br />
anzitutto dallo stoicismo e aventi chiari risvolti sociali 20 . Si<br />
pensi all’idea dell’uguaglianza tra gli uomini; allo stato primordiale<br />
di pura natura dove tutto era in comune; al dovere dell’elemosina<br />
in forza della stessa natura; alla concezione che la nobiltà<br />
e la schiavitù dipendono dalla fortuna e dal capriccio; al<br />
convincimento che la vera ricchezza è l’assenza di bisogni, ecc. 21<br />
Non va poi dimenticato che i Padri sopra ricordati, a motivo dell’estrazione<br />
sociale generalmente elevata, hanno una parresìa o<br />
libertas dicendi nel denunciare situazioni di ingiustizia sociale<br />
che ad altri, provenienti da ceti inferiori, sarebbe probabilmente<br />
mancata 22 .<br />
20<br />
Tenendo presente questo, occorrerà rivedere la concezione che considera<br />
i grandi Padri del IV secolo debitori soltanto formalmente della strumentazione<br />
retorica e concettuale della cultura pagana. In realtà essi respirarono,<br />
anche in rapporto a temi sociali, la sensibilità del loro ambiente. Basti<br />
qui richiamare al fatto che il famoso retore pagano Libanio, maestro di<br />
Giovanni Crisostomo e fors’anche di Basilio e di Gregorio di Nazianzo, teneva<br />
e assegnava ai suoi alunni conferenze di retorica concernenti aspetti sociali<br />
(avidità, ricchezze, povertà). Non meraviglia dunque che costoro, divenuti<br />
vescovi, continuassero a svolgere gli stessi temi su una base di esperienza<br />
personale. Cf R.M. GRANT, Cristianesimo primitivo e società 131-133.<br />
21<br />
Per le dottrine stoiche circa temi sociali rimando alla silloge concernente<br />
l’etica, a cura di M. I. PARENTE, Gli stoici - Opere e testimonianze II,<br />
UTET, Torino 1989, 1053-1279.<br />
22<br />
Basti menzionare al riguardo Ambrogio che reputa la libertas dicendi<br />
come una caratteristica del sacerdote. Nel De officiis II 39 ai suoi chierici<br />
scrive: “Il vostro ministero brilla in tutto il suo splendore se con l’aiuto della<br />
Chiesa viene rintuzzata la violenza di un potente al quale o una vedova o degli<br />
orfani non sono in grado di resistere, se mostrate che ai vostri occhi vale
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 283<br />
b. Ha un suo peso nelle considerazioni di carattere sociale<br />
dei nostri autori il fatto che tutti, direttamente o indirettamente,<br />
siano venuti a contatto con l’esperienza monastica percepita come<br />
un modo di vivere la fede cristiana in modo più radicale ed<br />
integrale. In essa, poi, l’elemento più in rilievo è la comunione,<br />
la condivisione. S’inquadra in questa cornice l’affermazione di<br />
Giovanni Crisostomo per il quale “ora si vive nei monasteri come<br />
un tempo a Gerusalemme” 23 . E, tuttavia, il monachesimo,<br />
con la sua spiritualità di condivisione totale, di rinuncia al mondo,<br />
di sacrifici volontari, di comportamenti al limite della misura<br />
e della razionalità, incarna un’ideale di vita difficilmente praticabile<br />
all’interno delle grandi comunità cristiane. Non meraviglia<br />
pertanto che, a motivo del suo carattere provocatorio, produca<br />
anche reazioni negative da parte pagana, ma anche da parte<br />
di alcuni cristiani 24 . In esso, comunque, l’apertura escatologica<br />
rimane più vivace che non tra i cristiani comuni. Ora, questo<br />
sentire escatologico mantiene viva l’idea della radicalità della<br />
sequela in disprezzo al ‘saeculum’. Insomma, l’ideale della apotaxìa<br />
o della fuga mundi che era stato caratteristico delle Chiese<br />
della Siria, ora persiste soltanto all’interno dei monasteri e determina<br />
l’atteggiamento dialettico di quei vescovi-monaci come<br />
Basilio, Crisostomo, Teodoreto che si trovano a capo delle Chiese<br />
dell’agape. Come si conciliano in essi le due tendenze ideologicamente<br />
contrapposte di cui sono rappresentanti? Come monaci,<br />
infatti, hanno scelto la strada della rinuncia radicale ai beni<br />
del mondo; come vescovi devono indicare una strada di salvezza<br />
attraverso l’uso moderato dei beni del mondo. La risposta<br />
a questo apparente conflitto è trovata da costoro nell’affermare<br />
due misure o gradi di essere cristiano, dove la fedeltà all’intransigenza<br />
della sequela non esclude un’altra possibile via di salvezza<br />
(non di perfezione!) attraverso l’esercizio della carità e attraverso<br />
l’uso parsimonioso dei beni terreni. Il rapporto tra le due<br />
più il comandamento del Signore che il favore del ricco. Voi stessi ricordate<br />
quante volte abbiamo lottato contro gli attacchi imperiali in difesa dei depositi<br />
delle vedove, anzi di tutti”.<br />
23<br />
In Act apost. hom 11 1,3.<br />
24<br />
Cf M. SIMONETTI, Cristianesimo antico e cultura greca, Borla 1983,<br />
78-80.
284 LUIGI PADOVESE<br />
strade è lo stesso rapporto che esiste tra il buono e il meglio, tra<br />
il rimedio e la salute, tra il seguire Cristo e il seguirlo expeditior<br />
(più decisamente) 25 , tra l’essere giusto e l’essere perfetto 26 . In<br />
questo contesto si inquadra la precisazione che fa un ignoto autore<br />
del IV secolo: “La legge - dichiara - consiste nel fatto che tu<br />
non prenda l’altrui, ma che non dia neppure del tuo. La grazia,<br />
invece, nel non togliere l’altrui e nel dare il tuo” 27 . In questo tentativo<br />
di fedeltà all’intransigenza della sequela e di adattamento<br />
alla situazione di una Chiesa in cui non tutti si sentono chiamati<br />
alla perfezione, i vescovi si trovano all’interno di una dialettica<br />
immanente all’essenza stessa di un cristianesimo divenuto<br />
‘religione’ di massa. Essi devono salvaguardare “da un lato l’universalità<br />
del messaggio, dall’altro il radicalismo necessariamente<br />
selettivo delle sue esigenze; da un lato la comunione con la<br />
grande chiesa, dall’altro la solidarietà, esente da ogni compromesso,<br />
all’interno del piccolo gruppo; da un lato l’accettazione<br />
realistica della pesantezza del corpo ecclesiale terreno, pur nella<br />
volontà di rinnovarlo per quanto è possibile a partire dalla<br />
propria interiore riforma, dall’altro la tensione verso la riforma<br />
istituzionale e integrale o addirittura l’utopia” 28 .<br />
c. Un altro elemento da non sottovalutare per arrivare a<br />
un’adeguata comprensione della dottrina sociale dei Padri del<br />
IV/V secolo va ricercato nel progressivo disfacimento dello stato<br />
e nel peggioramento della situazione economica, prodotta da diversi<br />
fattori, ma riconducibile alla crisi della ‘dominazione universale<br />
dell’impero’, ovvero al fatto che l’impero non era in grado<br />
di far fronte e sostenere l’apparato politico, amministrativo e<br />
militare che lo garantiva 29 . Il discorso sulla situazione sociale va-<br />
25<br />
Così ZENO DI VERONA, Tractatus II 11, 5. Su questa concezione rimando<br />
per intero al mio studio L’originalità cristiana - Il pensiero etico-sociale di<br />
alcuni vescovi norditaliani del IV secolo, Laurentianum, Roma 1983.<br />
26<br />
Così in MASSIMO DA TORINO, a proposito del giovane ricco del Vangelo<br />
il quale mostra come nelle ricchezze si possa essere giusti e santi, ma non<br />
perfetti. Cf Sermo 48 42-44.<br />
27<br />
Opus imperfectum in Matthaeum - Om. XII 41.<br />
28<br />
Così P.C. BORI, Chiesa primitiva... 197.<br />
29<br />
Cf R. RÉMONDON, La crisi dell’impero romano. Da Marco Aurelio ad<br />
Anastasio (orig. franc. 1964), Mursia, Milano 1975, 264.
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 285<br />
ria da Oriente ad Occidente e a seconda degli anni 30 . Tuttavia si<br />
possono individuare alcuni ‘fattori’ costanti di crisi 31 . Anzitutto<br />
la svalutazione con conseguente fluttuazione tra il denaro e l’oro;<br />
le invasioni barbariche e le guerre interne che avevano distrutto<br />
grandi quantità di ricchezze; il peso economico dell’esercito<br />
che doveva essere mantenuto mediante un’eccessiva tassazione<br />
sulle attività allora più diffuse, ma con conseguente abbandono<br />
del lavoro. Se poi si considera che l’imposta fondiaria<br />
gravava sui contadini e piccoli imprenditori indipendenti, non<br />
sulla plebe urbana, ci si spiega la decadenza del ceto borghese<br />
medio e, da parte dei contadini, l’abbandono delle terre coltivate,<br />
l’aumento del latifondo che ingoiava le piccole proprietà e altri<br />
fenomeni collaterali come l’usura, l’incetta consistente nell’accumulo<br />
di beni (grano, olio) tolti dapprima al mercato per essere<br />
poi rivenduti a prezzi maggiorati. La cosa risulta tanto più<br />
grave se si considera che l’impero aveva un’economia prevalentemente<br />
agricola e ricavava più del 90% delle sue entrate dalle<br />
imposte che gravavano sulla terra e sui contadini 32 . La tendenza<br />
ad abbandonare il proprio lavoro spinse il governo a vincolare i<br />
contadini alla terra (colonato). Una legge del 371 emessa da Valentiniano<br />
si esprimeva al riguardo così: “Riteniamo che i coloni<br />
non abbiano la libertà di abbandonare i campi ai quali li legano<br />
la loro condizione e la loro nascita. Se se ne allontanano e<br />
passano presso un altro signore, che siano ricondotti, incatenati<br />
e puniti” 33 . Evidentemente questo rapporto di schiavitù rispetto<br />
alla terra d’origine toglieva materiale umano all’esercito che<br />
pertanto doveva reclutare tra i barbari. Oltretutto, per rendere<br />
appetibile il servizio militare occorreva concedere agli arruolati<br />
dei privilegi che, alla lunga, venivano sempre a gravare su con-<br />
30<br />
Sulla differente situazione tra Oriente ed Occidente in rapporto all’evoluzione<br />
economica nel IV sec. cf R. RÉMONDON, La crisi..., 244-259.<br />
31<br />
Al riguardo cf A. MOMIGLIANO, Il cristianesimo e la decadenza dell’impero<br />
romano, in A. MOMIGLIANO (a cura di), Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo<br />
nel secolo IV, (orig. ingl. 1963), Einaudi, Torino 1975, 10-11.<br />
32<br />
Cf A.H.M. JONES, Lo sfondo sociale della lotta tra paganesimo e cristianesimo<br />
in A. MOMIGLIANO (a cura di), Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo<br />
nel secolo IV (orig. ingl. 1963), Einaudi, Torino 1975, 28.<br />
33<br />
Cod Just., 11, 53.
286 LUIGI PADOVESE<br />
tadini ed artigiani 34 . Il sistema del colonato aveva prodotto come<br />
reazione un sistema di patronato consistente nell’affidarsi alla<br />
protezione di un potente al quale si affidava forza lavorativa e libertà<br />
in cambio di protezione. Ora questo sistema di protezione<br />
dei contadini metteva in questione la funzione di riscossione<br />
delle imposte da parte dei magistrati cittadini i quali si vedevano<br />
costretti a risarcire con i propri beni quelle tasse che non avevano<br />
riscosso. Si comprende così come il patronato comportasse<br />
anche la fuga dalle attività di pubblica gestione da parte dei<br />
ricchi cittadini 35 . Non si dimentichi, inoltre, che una delle cause<br />
dell’impoverimento, almeno in Occidente, va ricercata anche<br />
nell’evoluzione delle strutture agrarie: si diffonde l’utilizzo del<br />
mulino ad acqua e, alla fine del IV secolo, la falciatrice che riduce<br />
i tempi di lavoro e la manodopera 36 . A determinare il declino<br />
dello stato ha concorso anche la Chiesa. Come nota un’eminente<br />
studioso “la gente fuggiva dallo Stato dandosi alla Chiesa<br />
e indeboliva lo Stato, offrendo le proprie forze migliori alla<br />
Chiesa (...). Gli uomini migliori lavoravano per la Chiesa, non<br />
per lo Stato” 37 .<br />
In una situazione economicamente così instabile e con un<br />
‘vuoto sociale’, non meraviglia che i vescovi venissero visti come<br />
i garanti della giustizia, come i veri ‘leaders’ a cui fare riferimento.<br />
E da parte sua “il vescovo cristiano e il suo clero ambivano<br />
ad avere una parte sempre più importante nell’esercizio<br />
dell’autorità cittadina” 38 . In realtà, nelle città del IV secolo il vescovo<br />
si profila come “l’amante dei poveri” - in questo tempo<br />
sempre più numerosi - ai quali le amministrazioni municipali<br />
non dedicavano attenzione 39 . Il fatto che Costantino avesse atttribuito<br />
ai capi delle Chiese il giudizio arbitrale in cause di conflitto<br />
in cui erano coinvolti cristiani (audientia episcopalis), permette<br />
di capire come il vescovo dovesse prendersi a cuore situa-<br />
34<br />
Cf R. RÉMONDON, La crisi dell’impero... 141-142.<br />
35<br />
Cf R. RÉMONDON, La crisi dell’impero... 144-145.<br />
36<br />
Cf R. RÉMONDON, La crisi..., 246.<br />
37<br />
A. MOMIGLIANO, Il cristianesimo e la decadenza... 14.<br />
38<br />
P. BROWN, Potere e cristianesimo nella tarda antichità (orig. ingl. 1992),<br />
Laterza, Bari 1995, 111.<br />
39<br />
Cf P. BROWN, Potere e cristianesimo... 133-134.
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 287<br />
zioni molto concrete e come diventasse anche protettore delle<br />
classi inferiori 40 . Sarà soprattutto questo rapporto con i poveri<br />
che accrescerà il potere del vescovo, rendendolo un importante<br />
patrono urbano. E dunque il ‘vuoto di potere’ o il senso di sfiducia<br />
nel potere tradizionale che caratterizza in parte il IV secolo,<br />
crea l’esigenza di una nuova leadership: la figura, appunto, del<br />
vescovo dotato oltretutto di un particolare potere ‘spirituale’ 41 .<br />
E’ all’interno di queste considerazioni sull’estrazione socio/culturale<br />
dei vescovi, sulla loro vicinanza all’ideale monastico,<br />
sulla situazione di crisi politica/sociale del IV secolo come<br />
pure sulla funzione di supplenza dei vescovi rispetto alle autorità<br />
locali che si colloca il loro messaggio sociale.<br />
Va anzitutto ricordato che fra i Padri greci quelli che risultano<br />
più attenti ai problemi sociali sono anzitutto Basilio, vescovo<br />
di Cesarea, Gregorio di Nazianzo, Gregorio di Nissa e, in<br />
modo del tutto particolare, Giovanni Crisostomo. Tra i latini<br />
emerge in questo ambito soprattutto Ambrogio di Milano ed<br />
Agostino. Occorre qui aggiungere che lo svolgimento di tematiche<br />
sociali si colloca perlopiù all’interno dell’attività di predicatori<br />
che essi svolgono. Il loro insegnamento etico è dunque legato<br />
al momento liturgico ed è quasi sempre vincolato a passi biblici<br />
che vengono commentati con un’attenzione attualizzante 42 .<br />
L’uditorio al quale si rivolgono è perciò un uditorio cittadino e<br />
quasi esclusivamente cristiano. Sarebbe certo sbagliato pensare<br />
40<br />
Cf P. BROWN, Potere e cristianesimo... 144-145.<br />
41<br />
Rimando, a questo riguardo, all’interessante lavoro di P. BROWN, limitato<br />
però alla sola zona geografica della Siria e interessato ad esaminare figura<br />
e ruoli sociali di eremiti locali. Mi pare, tuttavia, che alcune sue riflessioni<br />
si possano applicare anche ad alcune figure di vescovi e spieghino fenomeni<br />
analoghi a quelli registrati nella Siria del IV/V secolo. Cf L’ascesa e il<br />
ruolo dell’uomo santo nella tarda antichità, in D. VERA (a cura di), La società<br />
del Basso Impero. Guida storica e critica, Laterza, Bari 1983, 75-114.<br />
42<br />
Si veda ad esempio come l’episodio evangelico di Mc 10,17-31 sul giovane<br />
ricco o la parabola sul ricco stolto (Lc 12,16-21) siano state occasione<br />
di una pluralità di riflessioni non sempre coincidenti (al proposito cf il lavoro<br />
di M.G. MARA, Ricchezza e povertà nel cristianesimo primitivo, Città Nuova,<br />
Roma 1980). Lo stesso si dica per altri versetti biblici, come ad es., Prov<br />
22,2. A questo proposito cf J.L. FEIERTAG, Quelques commentaires patristiques<br />
de Proverbe 22,2. Pour une nouvelle approche du problème richesses et pauvreté<br />
dans l’Église des premiers siècles, in VigCh 42 (1988), 156-178.
288 LUIGI PADOVESE<br />
che questi autori abbiano un programma di rivendicazioni sociali<br />
o di rinnovamento delle strutture economiche del loro tempo;<br />
essi mirano piuttosto a denunciare e/o a risolvere situazioni<br />
concrete di ingiustizia 43 ; mirano ad incrementare una più giusta<br />
distribuzione dei beni in nome della fede che annunciano. Le loro<br />
idee sono dunque di natura religiosa e non economica 44 . In<br />
questa prospettiva si collocano le riflessioni sulla proprietà privata<br />
dove motivazioni bibliche e cristiane si intrecciano a considerazioni<br />
umanistiche. Tipico il caso di Gregorio di Nazianzo<br />
per il quale la proprietà privata con i conseguenti fenomeni di<br />
ricchezza e di povertà è conseguenza del peccato, mentre prima<br />
di esso tutto era in comune 45 : dottrina, questa, comune nell’antichità<br />
e legata al convincimento di un’”età d’oro” dove proprietà<br />
privata e schiavitù erano assenti e dove gli uomini erano guidati<br />
dalla natura senza leggi esterne 46 . Verosimilmente anche Ambrogio<br />
condivide la stessa opinione presente in Gregorio quando<br />
afferma: “Dio comandò che tutto fosse prodotto in modo che il<br />
cibo fosse comune a tutti e la terra fosse, in un certo senso, proprietà<br />
di tutti. La natura, dunque, ha creato il diritto comune,<br />
l’usurpazione il diritto privato (natura igitur ius commune generavit,<br />
usurpatio ius fecit privatum”) 47 . Dal canto suo Giovanni<br />
43<br />
Al proposito è sufficiente ricordare come un piccolo trattato ambrosiano<br />
quale il De Nabuthe, seppure svolga un tema biblico, è ispirato da situazioni<br />
di ingiustizia sociale che hanno l’appoggio del potere regale. Come,<br />
al proposito osserva M.G. MARA “i suoi interventi (di Ambrogio), e di riflesso<br />
le sue opere, vanno sempre misurate con gli avvenimenti di quel momento,<br />
di quella situazione o che a quella situazione fanno capo”, in AMBROGIO,<br />
La storia di Naboth a cura di M.G. Mara, L.U. Japadre ed., L’Aquila 1975, 22.<br />
44<br />
Cf R.M. GRANT, Cristianesimo primitivo e società 137-139.<br />
45 GREGORIO DI NAZIANZO, Sull’amore dei poveri - Oratio XIV 26: “Da<br />
quando l’invidia e la discordia entrarono nel mondo, insieme con la tirannia<br />
fallace del serpente che ci incanta con l’esca del piacere e mette i più forti<br />
contro i più deboli, da quel tempo il genere umano, prima unito, si è diviso<br />
in tanti popoli dai nomi diversi; l’avarizia ha infranto la generosità naturale,<br />
facendosi forza persino della legge, che difende il potente. Ma tu guarda invece<br />
l’iniziale uguaglianza, non le successive divisioni. Aiuta con tutte le forze<br />
la natura, onora la libertà primitiva, rispetta te stesso...”.<br />
46<br />
Tale dottrina, patrimonio comune dell’antichità, troverà poi l’avallo<br />
da parte dei teologi francescani. Cf M. HENGEL, Eigentum... 11-16.<br />
47<br />
De officiis ministrorum I 28, 132. Su questo testo e la problematica
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 289<br />
Crisostomo lascia intendere che all’origine dell’appropriazione<br />
delle ricchezze, per sé buone, c’è sempre - direttamente o indirettamente,-<br />
una qualche forma di ingiustizia 48 . Se si prescinde<br />
da queste affermazioni, i Padri del IV/V secolo non contestano di<br />
fatto la proprietà privata né obbligano ad una condivisione comunitaria<br />
dei beni 49 ; non è questa la finalità dei loro interventi;<br />
essi vogliono piuttosto arrivare ad affermare la destinazione universale<br />
dei beni, l’uguaglianza nativa di ciascun uomo: “La terra<br />
- scrive Ambrogio - è stata messa in comune a tutti, ricchi e poveri:<br />
perché, voi ricchi,vi arrogate il diritto di proprietà del suolo?<br />
La natura non sa che cosa siano i ricchi, lei che genera tutti<br />
ugualmente poveri” 50 . E’ rimarcato pertanto l’uso sociale della<br />
ricchezza e il ricco viene presentato come l’amministratore<br />
(oikonomos) (non il possessore) dei beni con una missione sociale<br />
da compiere: “non siamo cattivi amministratori dei beni<br />
che ci sono stati elargiti - esorta Gregorio di Nazianzo - per non<br />
udire le parole di Pietro: ‘Vergognatevi, voi che possedete i beni<br />
altrui, imitate l’equità di Dio e nessuno sarà povero’” 51 ; da parte<br />
di alcuni autori è altresì rilevato il ruolo complementare di ricchi<br />
e poveri, làddove anche il povero serve al ricco offrendogli<br />
sorta attorno ad esso, cf M.G. MARA, Ricchezza e povertà... nota 121, 70-71.<br />
Da parte sua anche Agostino vede nella disuguaglianza delle condizioni sociali<br />
ed economiche della società una conseguenza del peccato originale. “Il<br />
peccato è la prima causa della schiavitù, per cui l’uomo è sottomesso all’uomo<br />
in una situazione di dipendenza (...): però nella natura in cui Dio originariamente<br />
ha creato l’uomo, nessuno è schiavo dell’uomo, né del peccato”,<br />
La città di Dio XIX 15.<br />
48<br />
Al proposito Giovanni Crisostomo affronta il tema nell’Om 12 in 1Tm<br />
4: “Dimmi: da dove provengono le tue ricchezze? Da chi le hai ricevute? Da<br />
dove provenivano quelle di chi te le ha trasmesse? ‘Da mio nonno - rispondi<br />
- attraverso mio padre’. Potresti dunque, risalendo di generazione in generazione,<br />
dimostrare che sono state procurate in modo giusto? No, non potresti,<br />
e, necessariamente, alla loro origine ci fu qualche ingiustizia”. Sul tema<br />
cf S. ZINCONE, Ricchezza e povertà nelle omelie di Giovanni Crisostomo, L.U.<br />
Japadre ed., L’Aquila 1973, 42-49.<br />
49<br />
Cf R.M. GRANT, Cristianesimo primitivo e società 132-133.<br />
50<br />
De Nabuthe I 2.<br />
51 GREGORIO DI NAZIANZO, Sull’amore dei poveri - oratio XIV 24. Su questo<br />
tema si possono moltiplicare le attestazioni dei Padri. Cf sull’argomento<br />
S. ZINCONE, Ricchezza e povertà... 119-146.
290 LUIGI PADOVESE<br />
l’occasione di fare opere meritorie 52 ; si richiama la distinzione<br />
tra ciò che è necessario e ciò che è superfluo e si rileva che il superfluo<br />
appartiene ai poveri: “il tuo superfluo - scrive Agostino -<br />
è il necessario per un altro” 53 , o, riportando il pensiero di Basilio:<br />
“se ciascuno prendesse soltanto ciò che gli serve per le proprie<br />
necessità e lasciasse il superfluo all’indigente, nessuno sarebbe<br />
ricco, nessuno sarebbe povero, nessuno sarebbe nella miseria”<br />
54 . Lo svolgimento della problematica sociale è accompagnato<br />
da riflessioni circa i pericoli insiti nel possedere: la bramosia<br />
del di più che rende il possessore un ‘posseduto’ 55 , l’iniqua<br />
sopraffazione esercitata sui diritti e sui beni altrui e, fondamentalmente,<br />
quella progressiva miopia - rilevata soprattutto dai Padri<br />
latini 56 - che impedisce al cristiano di vedere e di tendere al<br />
futuro escatologico. La gravità di questa colpa consiste nello<br />
snaturare il messaggio cristiano privandolo della sua ‘apertura’<br />
al futuro e facendo ripiombare gli uomini all’interno del paganesimo<br />
dove si vive “nihil de futuro opinantes” 57 o - come direbbe<br />
il vescovo latino Cromazio d’Aquileia - al modo dei gentili<br />
“qui quasi pecora in hunc mundum viventes et de victu praesentis<br />
vitae tantummodo cogitantes, nihil putant esse post mortem”<br />
58 . Quando ciò si verifica per i battezzati, la pratica cristiana<br />
si restringe al solo momento cultuale, ma non è più vita e non<br />
incide sulla vita. Nascono così le contraddizioni più assurde di<br />
52<br />
Sul tema cf J.L. FEIERTAG, Quelques commentaires... 173.<br />
53 AGOSTINO, Sermo XXXIX 6.<br />
54 BASILIO DI CESAREA, Omelia VI 7.<br />
55<br />
Basta al riguardo richiamare un eloquente testo di AMBROGIO: “è la cosa<br />
posseduta che deve appartenere a chi la possiede, non già viceversa, che<br />
il possessore appartenga alla cosa posseduta. Perciò chi non usa il suo patrimonio<br />
come cosa che sia in suo potere; chi non sa donare al povero ed<br />
elargire con larghezza, è servo dei propri averi; non può dirsi padrone delle<br />
sue sostanze, perché le custodisce come cose altrui, alla pari di un servo: non<br />
le usa come proprie con la libertà di un padrone. Con una simile disposizione<br />
d’animo bisogna dire che quell’uomo appartiene alle sue ricchezze, non le<br />
ricchezze all’uomo”, De Nabuthe XV 63.<br />
56<br />
Come fa osservare J.L. FEIERTAG le riflessioni dei Padri latini si incrociano<br />
con riflessioni sulla salvezza eterna più che non presso i Padri orientali.<br />
Quelques commentaires... 173.<br />
57 ZENONE DI VERONA, Tractatus II 1, 16.<br />
58 CROMAZIO D’AQUILEIA, Tractatus XXXII 172-176.
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 291<br />
cui i Padri citati sono diretti testimoni. Nasce, insomma, un cristianesimo<br />
“di cornice” che solo parzialmente soppianta il paganesimo.<br />
<strong>Vol</strong>endo globalmente richiamare il pensiero sociale dei Padri<br />
del IV/V - pur con le diverse accentuazioni e sfumature che<br />
ciascuno presenta - è possibile richiamare alcuni aspetti fondamentali<br />
e ricorrenti in tutti:<br />
1. L’annuncio di questi predicatori - seppure riconosca la superiorità<br />
dell’ideale di povertà e castità in vista del Regno - non<br />
mira ad allontanare i cristiani dal mondo, estraniandoli dalla costruzione<br />
d’una società più giusta. Eppure il loro ideale non è<br />
questo. L’invito che essi di continuo muovono ai fedeli non è<br />
quello di “fuggire nel deserto”, sottraendosi alle loro responsabilità<br />
verso questo mondo 59 , ma di non confondersi con esso, magari<br />
ritenendo che le leggi della società e il concetto di “giustizia”<br />
vigente in essa debba valere allo stesso modo anche per i cristiani.<br />
Zenone di Verona sintetizza questa posizione comune richiamandosi<br />
a quanto un ipotetico cristiano potrebbe dire: “E’<br />
giusto che io conservi i miei beni e non cerchi quelli altrui. Ma<br />
questo - commenta il vescovo - sono soliti dirlo anche i pagani.<br />
In realtà vedremo quanto ciò sia ingiusto dinanzi a Dio” 60 . A base<br />
di questa concezione è possibile scorgere l’idea biblica della<br />
novitas christiana (“nuova creatura in Cristo” 2Co 5,17) secondo<br />
la quale - per il cristiano - etica, modelli comportamentali ed<br />
ideali non sono identici a quelli vigenti nella società. Come osserva<br />
Ilario di Poitiers “è necessario che i rigenerati (nel battesimo)<br />
abbiano un nuovo modo di pensare” 61 . Avendo presente<br />
questo convincimento di fondo si capisce come i grandi Padri<br />
59<br />
Basti qui richiamare il dovere della ‘responsabilità’ che Giovanni Crisostomo<br />
inculca ai cristiani di Antiochia verso tutti gli abitanti della città (cf<br />
Omelia I al popolo antiocheno. Sulle statue, 122), o alle espressioni di un vescovo<br />
come MASSIMO DI TORINO sulla responsabilità che i padroni cristiani<br />
hanno verso i loro schiavi pagani o, più generalmente, verso i pagani. Cf Sermone<br />
92 1; Sermone 106 2.<br />
60<br />
Trattato II 1. Sul carattere talora ingiusto della giustizia umana che discrimina<br />
in materia matrimoniale tra uomo e donna o che, in ambito sociale,<br />
maschera sotto apparente legittimità disoneste speculazioni, cf L. PADO-<br />
VESE, L’originalità cristiana - Il pensiero etico sociale... 80-81; 83-84<br />
61<br />
De Trinitate liber I 18.
292 LUIGI PADOVESE<br />
del IV/V secolo non considereranno l’impegno sociale del cristiano<br />
nel mondo racchiuso nello spazio di questo mondo. Si<br />
tratta di un impegno sociale, ma con una fondazione religiosa.<br />
2. Conformemente a questo sentire, i predicatori cristiani<br />
del periodo considerato lasciano intendere che un superamento<br />
delle ingiustizie di cui soffre la loro società scaturisce dalla modificazione<br />
interiore dell’uomo e non da un semplice mutamento<br />
delle strutture al quale neppure pensano. Nessuno dei vescovi,<br />
ad esempio, lotta per abolire la schiavitù, quantunque riconoscano<br />
che essa proviene dalla sopraffazione e dal peccato originale,<br />
eppure la svuotano di contenuto insistendo sulla fraternità<br />
universale, sulla comune figliolanza divina e sulla conseguente<br />
corresponsabilità.<br />
3. Questi vescovi, infine, tengono fede a quella tensione<br />
escatologica che costituisce una delle peculiarità cristiane. In<br />
forza di essa, dei predicatori come Giovanni Crisostomo, Ambrogio,<br />
Agostino riconoscono che il cristiano è al centro di un bipolarismo<br />
tra un “già” e un “non ancora”. Tenuto ben presente<br />
ciò, l’impegno del cristiano nel mondo consisterà nel vivere l’oggi<br />
senza dimenticarsi del domani.<br />
Concludendo è possibile affermare che l’insegnamento sociale<br />
dei grandi Padri del IV/V secolo, posti a capo delle Chiese<br />
dell’agápe, più che in vista di pianificazioni su come risolvere i<br />
problemi sociali, può esserci utile a livello di stimoli e di suggestioni.<br />
E’ un insegnamento che ha di mira soprattutto i singoli<br />
ed è inserito in un impegno di coerenza con la vocazione cristiana.<br />
Questi aspetti ci rendono anche ragione del perché, all’interno<br />
di tutta l’enorme produzione patristica in parte perduta,<br />
le omelie ‘sociali’ dei Padri ci siano state conservate. Esse<br />
hanno trovato il consenso della tradizione cristiana; sono valse<br />
a formarla e hanno certo concorso - assieme alla riflessione teologica<br />
sulla dignità dell’uomo e sul suo destino 62 - a creare quel-<br />
62<br />
Mi limito a rilevare l’influenza che la riflessione trinitaria e cristologica<br />
della Chiesa antica ha avuto nello sviluppo della conceziona sull’uomo:<br />
sui suoi diritti, sulla acquisita consapevolezza della sua dignità, sulla libertà<br />
di coscienza, libertà religiosa, sulla questione delle classi sociali. Cf al proposito<br />
A. GRILLMEIER, Moderne Hermeneutik und altchristliche Christologie -<br />
Zur Diskussion um die chalkedonische Christologie heute, in Mit ihm und in
LA DIMENSIONE SOCIALE DEL PENSIERO PATRISTICO 293<br />
la sensibilità odierna, tributaria di un passato da non dimenticare.<br />
Collegio S. Lorenzo da Brindisi<br />
G.R.A. Km. 68,800<br />
C.P. 9091<br />
00163 Roma<br />
Italy.<br />
LUIGI PADOVESE, OFM. CAP.<br />
—————<br />
The reality of the Church as a community of people is subject to a<br />
variety of factors such as historical circumstances, particular epochs<br />
and various localities. This explains the diversity of attitudes with<br />
regard to social issues which one finds within the Church. This article<br />
points out some factors to explain this by examining the 4th and 5th<br />
centuries: the socio-cultural origin of the leaders of the Church, their<br />
closeness to the monastic ideal, the political and social crisis of the 4th<br />
century and the role of the bishops as a sort of substitute in the resulting<br />
power vacuum. It is within this context that the social message of<br />
the great Fathers of the 4th and 5th centuries is placed, communicated<br />
in the main through homilies and focused on recalling the practical<br />
consequences of being a Christian in that particular historical<br />
moment.<br />
La realidad de la Iglesia en cuanto comunidad de personas, está<br />
sujeta a una serie de factores, como las coyunturas históricas, los tiempos<br />
especiales y los diversos lugares. Ello explica la diversidad de actitudes<br />
frente a los problemas sociales que uno encuentra en la Iglesia.<br />
Para explicarla, este artículo señala algunos factores, examinando los<br />
siglos IV y V: el origen sociocultural de los líderes de la Iglesia, su<br />
aproximación al ideal monástico, la crisis política y social del siglo IV<br />
ihm. Christologische Forschungen und Perspektiven, Herder Verlag, Freiburg<br />
in Br 1975, 552-553; vedi pure G. WILLMANN, La concezione personalistica di<br />
Dio come presupposto della storia della libertà in Occidente, in Concilium 3<br />
(1977), 154.
294 LUIGI PADOVESE<br />
y el papel sustitutivo de los obispos con el resultado de un ‘vacío de<br />
poder’. En este contexto se ubica el mensaje social de los grandes<br />
Padres de los siglos IV y V, difundido sobre todo por medio de homilías<br />
y orientado a recordar las consecuencias prácticas del ser cristiano en<br />
ese especial momento histórico.<br />
—————<br />
The author is an invited Professor of Patrology at the Alphonsian<br />
Academy<br />
El autor es profesor invitado de Patrología en la Academia<br />
Alfonsiana<br />
—————
295<br />
StMor 37 (1999) 295-320<br />
TERENCE KENNEDY C.Ss.R.<br />
ST. ALPHONSUS’ SELVA.<br />
SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC?<br />
I. The Contemporary Retrieval of Rhetoric.<br />
Philosophy in the twentieth century has undergone many<br />
changes of mood. One that has gone rather unnoticed is the<br />
revival of rhetoric in the academy and in practice. In 1958<br />
Chaim Perelman and Lucie Olbrechs-Tyteca published Traité de<br />
l’argumentation. La nouvelle rhétorique. 1 It sparked a revolution<br />
in philosophy by proving that everyday communication could<br />
not really be grasped by the abstract logic of science but by<br />
rhetoric. This they conceived as the deep logic hidden in all<br />
discourse, a universal structure evoking the possibility of global<br />
communication with a universal audience. Perelman held that<br />
we became immune to rhetoric’s power when positivism<br />
branded everyday language pre-scientific and so not fully<br />
rational and reliable. In ethics this stance became known as<br />
emotivism. Perelman devoted great effort to overcoming the<br />
age-old prejudice against rhetoric as dishonest, suave, hidden<br />
manipulation of people’s emotions, without their consent and<br />
often for malign purposes. These accusations have been<br />
repeated ever since Plato objected that the Sophists were no true<br />
philosophers and false educators. 2 On the contrary Perelman<br />
proved that newspapers, radio, television, advertising and the<br />
pulpit all have a coherent, but non-formal logic, typical of life’s<br />
affairs and found in every culture such that without it human<br />
1<br />
Presses Universitaires de France, Paris 1958.<br />
2<br />
For a good account of this tension see SAMUEL IJSSELING, Rhetoric and<br />
Philosophy in Conflict. An Historical Survey, Martinus Nijhoff, The Hague<br />
1976.
296 TERENCE KENNEDY<br />
community could not exist. Rhetoric is essentially the capacity<br />
to reason with people by means of speech, a discourse in a<br />
public assembly that calls a people together as one community,<br />
or as we say, the people united by a common purpose. So speech<br />
in this strong sense, or rhetoric properly so called, creates a<br />
community, a people. This is no mere classroom transmission of<br />
information. It unites people’s purposes by persuading them<br />
about the common good, something that touches individual<br />
interests while remaining the good every citizen enjoys.<br />
Perelman’s analysis of our rhetorical ways of reasoning has<br />
influenced our understanding of contemporary society, its<br />
structures and theories of communication, literature and social<br />
science. It has found application in Biblical studies, Church<br />
history and theology as a model for academic endeavour. 3 What<br />
first appeared unthinkable has happened. Physicists and experts<br />
in pure science have taken over his ideas and often scientific<br />
theories are today viewed as metaphors to be analysed<br />
rhetorically.<br />
A great conquest in this retrieval has been the discovery of<br />
the true character of Giambattista Vico’s (1668-1744)<br />
philosophy. When it was realised that Vico did not fit smoothly<br />
into the mold of scepticism, nor of scientific rationalism, nor of<br />
the aesthetics of romantic idealism as Benedetto Croce wanted,<br />
recent research sought another key to his thought. The answer<br />
lay in rhetoric. In 1708 inaugurating the University of Naples’<br />
academic year, exactly 250 before Perelman published his book,<br />
Vico pronounced his famous discourse on education. He<br />
attacked Descartes’ fashionable new abstract science as<br />
incapable of keeping society together because it failed to<br />
stimulate youths’ imagination with the ideal of a society joined<br />
in a common aim and a common tradition. The timeless logic of<br />
mathematics is no match for myth and the power of the classic<br />
Greek and Roman authors’ narratives to create a viable<br />
historical identity for a people. “If you were to import the<br />
geometric method into practical life, you would do no more than<br />
3<br />
For example, DAVID S.CUNNINGHAM, Faithful Persuasion. In Aid of a<br />
Rhetoric of Christian Theology, Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 1991.
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 297<br />
exhaust yourself in becoming a rational lunatic,” 4 says Vico. The<br />
language of imagination cements social relationships; and the<br />
key that unlocks language’s social meaning is rhetoric. Vico<br />
exploited it to penetrate the mythic worlds of Homer and the<br />
Twelve Tables of Roman Law, to discover their true identity and<br />
to explain how the heroic societies of Greece and Rome arose in<br />
time. He extended rhetoric’s range to his own period in Naples,<br />
thus allowing him to unify, some would say straddle, the current<br />
speculative theories of natural right and their historical<br />
evolution. He believed that God effected his providence for the<br />
civic commonwealth rhetorically, as evidenced by the language<br />
employed in religion, jurisprudence and education in various<br />
civilisations. An acute examination of this language revealed<br />
how they developed in history as human creations. Vico too<br />
perceived in rhetoric the organising principle for a university’s<br />
course of studies. He argued that just as a person must have all<br />
the virtues in order to have any one of them, so a scholar must<br />
be familiar with all the sciences in order to be competent in his<br />
profession. This is because rhetoric has no specific content but<br />
can be applied to each and every discipline. Vico was acutely<br />
aware of how rhetoric unifies knowledge as a social reality. 5 He<br />
is thus often honoured as the founder of the modern philosophy<br />
of history and the father of the social sciences.<br />
Vico’s passion for rhetoric makes him a useful model in<br />
recuperating the thought of another great Neapolitan, Alfonso<br />
Maria de Liguori (1696-1787). 6 The one professor, the other<br />
student at L’ Università Federico II di Napoli, both lawyers, they<br />
shared the same culture, were educated to be advocates at the<br />
Neapolitan bar, but their destinies took radically different<br />
directions. Vico aspired to use his rhetoric to save the civic<br />
4<br />
See quotation in ROBERT C. MINER, “Verbum-factum and Practical<br />
Wisdom in the Early Writings of Giambattista Vico,” Journal of the History<br />
of Ideas, 59(1998)1, 53, note 2.<br />
5<br />
See ANDEA BATTISTINI, La sapienza retorica di Giambattista Vico, Guerini<br />
e associati, Milano 1995, especially chapter III at 64.<br />
6<br />
For the relation between Vico and St. Alphonsus see ANDREA BATTISTINI,<br />
“Convergenze e divergenze culturali tra Vico e de Liguori,” in Alfonso M. De<br />
Liguori. La civiltà letteraria del settecento, P. Giannantonio (ed), Leo S.<br />
Olschki Editore, Firenze 1999, 269-295.
298 TERENCE KENNEDY<br />
commonwealth from decline and disintegration. When<br />
Alphonsus the barrister laid off his silks for a priestly habit he<br />
put on the rhetoric of Christ. He now exploited rhetoric to help<br />
him design and execute his apostolic project of forming a<br />
missionary institute dedicated to the salvation of the people.<br />
This institute was to be, we could say, the profession, almost<br />
parallel to lawyers in civil society, who would activate the<br />
practice of the love of Jesus Christ so as to create a truly<br />
Christian community bound to persevere in that love. 7<br />
The differences do not end here. In a short document, “La<br />
pratica della scienza nuova” 8 that Vico did not succeed in<br />
printing with the 1744 edition of the Scienza nuova, he laments<br />
that all his efforts up to then had been speculative and proceeds<br />
to indicate in sketchy outline the virtues needed for its pratica.<br />
Where Vico failed to put his project into pratica, St. Alphonsus<br />
succeeded magnificently. He saw his life not as speculation but<br />
as practice, The Practice of the Love of Christ as he expressed it<br />
in the title of his most famous book. He was not a man of action<br />
but of pratica. He knew how to discipline, direct, project and<br />
magnify his action out to the whole community by using<br />
rhetoric. His pratica of the Christian virtues was shaped by<br />
rhetoric.<br />
Retrieving St. Alphonsus’ rhetoric raises some peculiar<br />
problems not encountered in Vico because his knowledge of its<br />
principles is hidden by the skillful way he puts them into<br />
practice. It is a case of the art that conceals art. Nobody doubts<br />
that St. Alphonsus used rhetoric. His Glories of Mary addressed<br />
the whole Catholic world through emotion, imagination, story,<br />
myth, and the witness of the saints down the centuries. When<br />
translating these stories into English and German the<br />
7<br />
The finality of a mission is precisely to implant this love of Jesus Christ<br />
so as to leave “le anime legate con Gesù Cristo.” Selva di materie predicabili,<br />
Marietti, Torino 1905, Appendice, Punto I, n. 5: page 289. This was<br />
translated into English in two books: Dignity or Duties of the Priest, or Selva,<br />
Redemptorist Fathers, Brooklyn 1927; Preaching of God’s Word, Benzinger<br />
Brothers, New York 1890. Both were translated by Eugene Grimm, C.Ss.R.<br />
These three books will be referred to as Selva, Dignity and Preaching.<br />
8<br />
GIAMBATTISTA VICO, La scienza nuova, Introduzione e note di Paolo<br />
Rossi, Rizzoli, Milano 1998, 716-719.
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 299<br />
Redemptorists appointed to the task deliberately exorcised the<br />
most vivid tales out of their texts. They were terrified by the<br />
criticisms being published by John Henry Newman in England<br />
and Johannes Ignaz von Döllinger in Germany. 9 These<br />
denigrated St. Alphonsus’ spiritual writings as historically<br />
unreliable, a sort of fairy tales apt to scandalise the faithful. But<br />
the faithful were never really put off by this story-telling. It<br />
delighted them immensely thereby fulfilling one of the three<br />
aims of good rhetoric. These experts, who had lost contact with<br />
the popular, pre-enlightened imagination failed to recognise the<br />
rhetorical techniques Alphonsus was using. Perhaps their<br />
cultural arrogance sprang from a preoccupation for Northern<br />
European culture where Protestant interests prevailed. It would<br />
appear that St. Alphonsus’ reputation as an intellectual and<br />
spiritual guide never quite recovered in those countries from<br />
these attacks on his rhetoric, his imaginativeness and<br />
practicality.<br />
Both Newman and Döllinger belong to the period when<br />
rhetoric, quite wrongly, had been reduced either to literary<br />
criticism or to elocution as speech delivery, a time when the<br />
logic of ordinary speech and story-telling had been drowned in<br />
a flood of rationalism. To what tradition then did St. Alphonsus’<br />
popular preaching and writing style belong? His exempla are<br />
drawn from medieval modes of narrative and hagiography as<br />
Giuseppe Orlandi has shown. 10 Orlandi also notes that St.<br />
Alphonsus shared the rationalists’ critical spirit. This purified<br />
his thinking, making his reasoned preaching of the Gospel to the<br />
most abandoned convincing even to the most clear minded<br />
audience. He integrated the old and the new, the inductive and<br />
the deductive in rhetorical reasoning. He therefore belongs to<br />
the great tradition of rhetoric exercised by public figures such as<br />
statesmen,judges and jurists, churchmen and missionaries as a<br />
public ministry or office. He shared Vico’s concern for “il<br />
9<br />
See OTTO WEISS, “Alphonse de Liguori et la théologie allemande du<br />
XIX e siècle,” in Alphonse de Liguori, Pasteur et Docteur, J. Delumeau (ed),<br />
Beauchesne, Paris 1987, 183-229.<br />
10<br />
“L’uso degli in s. Alfonso Maria de Liguori,” in<br />
Spicilegium Historicum C.SS.R., XXXIX(1991)1, 3-39.
300 TERENCE KENNEDY<br />
popolo,” the classic term of reference for the audience which he<br />
repeats in his short tract on rhetoric.<br />
II. Some Presuppositions of Rhetoric.<br />
Alphonsus and Vico inhabited a world furnished by rhetoric.<br />
Aristotle, Cicero, Quintilian and St. Augustine are all in the DNA<br />
chains constitutive of their mental frameworks. St. Alphonsus<br />
was trained to be rigorous about the aims and means of rhetoric.<br />
Some of its important principles and presuppositions are the<br />
following. Classical thought treated rhetoric both as a technique<br />
and a branch of ethics. Aristotle’s Ethics, Rhetoric and Politics<br />
are inseparably connected as the sources of his moral theory.<br />
This essay works from an Alasdair MacIntyre’s premise for the<br />
recovery of virtue, namely that the transmission of a moral<br />
tradition is done rhetorically. 11 Eugene Garver’s Aristotle’s<br />
Rhetoric. An Art of Character 12 construes rhetoric as an art of<br />
ethical rationality, the character of the speaker being the first<br />
cause of persuasion. Alphonsus saw eloquence as a force of<br />
character emanating from the preacher to inculcate virtue in the<br />
assembled people.<br />
The second major principle is that the persuasion needed to<br />
inculcate virtue works through three factors, i). coherent,<br />
logical, argumentation, ii). the emotional state of the audience<br />
which the speaker aims to alter, and iii). the morally upright<br />
character of the speaker. These are the criteria for the apostolic<br />
group of priests Alphonsus formed with the mission of<br />
preaching salvation.<br />
Thirdly, these fit into the tradition of Christian eloquence<br />
formulated in St. Augustine’s De doctrina christiana that aims<br />
11<br />
This is a subtheme in his theory of virtue. It is obvious in his account<br />
of dialectic as the logic of most rhetorical reasoning. It underlies the<br />
historical processes whereby traditions are transmitted. See Chapter XVIII,<br />
“The Rationality of Traditions” in Whose Justice? Which Rationality?,<br />
University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 1988.<br />
12<br />
University of Chicago Press, Chicago 1994.
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 301<br />
not at imparting information but at applying faith to life, 13 for<br />
knowledge does not guarantee practice. And so St. Alphonsus<br />
translated St. Augustine’s usus as pratica. 14 Since justifying faith<br />
is to be preached to the whole world, each person is capable<br />
under grace of responding to the Gospel. Faith comes through<br />
hearing and St. Augustine asserts that Scripture itself, the<br />
message of salvation, is intrinsically rhetorical and so<br />
communicable to all humanity. This is the foundation for<br />
popular preaching, spiritual exercises, missions to the people.<br />
St. Alphonsus saw faith working through rhetoric to raise up a<br />
people holy to the Lord.<br />
Fourthly, rhetoric is the way of activating the symbolic<br />
forms that constitute a culture, being the art of using language<br />
rightly. Both Aristotle and St. Augustine devote an immense<br />
space in their treatises to its consideration. Aristotle lists a<br />
complete organon of the sciences and gives a comprehensive list<br />
of the virtues to be exercised in public discourse with the aim of<br />
making the polis a community of virtue. St. Augustine is no less<br />
exhaustive in showing how all the sciences lead to knowledge of<br />
Christ through the Scriptures. For this reason Henri Marrou<br />
thought of the De docrtina christiana as the platform for a<br />
Christian culture. 15 Vico and St. Alphonsus were both aware of<br />
rhetoric’s force as a social glue.<br />
While the rhetorical character of St. Alphonsus’ writing is<br />
readily evident, these principles are rarely recognised in them.<br />
How were they lost? Just as Alasdair MacIntyre had to excavate<br />
behind the ruin worked by emotivism in modern ethics to<br />
reestablish the tradition of virtue so it will be necessary for us to<br />
see what could be blocking a more faithful vision of St.<br />
Alphonsus’ rhetoric.<br />
This essay cannot examine all his spiritual writings but will<br />
take up the one work where he explicitly invokes rhetoric as a<br />
13<br />
See A. VERWILGHEN, S.D.B., “Rhétorique et prédication chez<br />
Augustine,” Nouvelle Revue Théologique, 120(1998)2, 233-248.<br />
14<br />
I would like to thank Father DALMAZIANO MONGILLO, O.P. of the<br />
Angelicum who pointed this out to me.<br />
15<br />
See S. AGOSTINO D’IPPONA, La dottrina cristiana, introduzione,<br />
traduzione e note di Luigi Alici, EP, Milano 1989, 29.
302 TERENCE KENNEDY<br />
necessary means in priestly ministry, giving instructions for and<br />
examples of its use. The Selva di materie predicabili was<br />
thoroughly revolutionary when published in 1760. Today it is<br />
usually passed off as out of date because of his insistence on<br />
rhetoric and its perceived theology of priesthood. I shall discuss<br />
that only in as far as it is relevant to understanding his rhetoric<br />
of sanctity. The accepted, rather unreflected, conviction that the<br />
Selva replaced baroque histrionics with simple preaching in the<br />
style of the Apostles, all’apostolica, is utterly justified. 16 St.<br />
Alphonsus found the ideal of preaching for the people that he<br />
longed for suitably formulated in Canon Muratori’s manual of<br />
popular ecclesiastic eloquence. Muratori and St. Alphonsus<br />
became the heroes of the renewal of preaching. 17 Muratori<br />
theorised how a familiar style that could reach every class, even<br />
the unlettered, was always necessary in the pulpit. Some literati<br />
clergy were scandalised by Alphonsus’ novel notions and the<br />
innovation of using ordinary speech without lengthy Latin<br />
quotations or the adornments of wit and ingenuity, and worst of<br />
all without the operatic intonations dictated by the baroque style<br />
of delivery. Alphonsus responded to these attacks on his Selva<br />
with two apologies. 18 Citing Muratori’s authority in his defense,<br />
he proved that simple preaching as on missions was the<br />
normative pratica handed on by Christ, the Apostolic Church<br />
and the Fathers and the great Doctors. His priestly experience<br />
convinced him of its efficacy. “With the aid of popular eloquence<br />
the eternal truths are expounded nakedly, subjects easily<br />
understood are explained in a simple and familiar style, so that<br />
each person present may understand the entire instruction. In<br />
sermons, we address not only the learned, but also the<br />
16<br />
See VINCENZO RICCI, “Per una lettura degli interventi di s. Alfonso sulla<br />
predicazione apostolica,” Spicilegium Historicum C.SS.R., XX(1972), 54-70.<br />
17<br />
See AA. VV., La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento,<br />
Edizioni Dehoniane, Roma 1996.<br />
18<br />
See Opere Ascetiche, III, Marietti, Torino 1867, “Istruzioni ed<br />
avvertimenti ai predicatori. Lettera I. ad un religioso amico. Ove si tratta del<br />
modo di predicare all’apostolica con semplicità, evitando lo stile alto e<br />
fiorito (298-326). Lettera II. Ad un vescovo novello. Ove si tratta del grand’<br />
utile spirituale, che recano a’ popoli le sante missioni (326-337).”
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 303<br />
uninstructed, and these ordinarily form the greater part of the<br />
audience.” 19 His reasoning, stories and illustrations were those<br />
of the poor folk of Naples and the countryside as Hamish<br />
Swanston has shown. 20 These rationalist objections to his<br />
popular rhetoric were magnified as his influence spread in the<br />
nineteenth century. Let us now look a little more into the fate of<br />
the Selva.<br />
III. Literary Criticism and the Selva.<br />
St. Alphonsus published the Selva as one volume in three<br />
parts. In the English and in many other editions these have been<br />
separated, wrongly I contend, into retreat and mission matter.<br />
Parts I and II are the sermons and instructions preached in the<br />
spiritual exercises to clergy. Part III gives the practice of<br />
conducting missions. It tends to be viewed as but an appendix to<br />
the Spiritual Exercises, affording St. Alphonsus a splendid<br />
chance to publish matter collected over years on parish<br />
missions. Since it appeared to interrupt the rhythm of the<br />
whole, publishers have been prone to edit it separately or with<br />
other works on preaching. In spite of their different styles and<br />
tone and the various pragmatic uses to which they can be put,<br />
there is one evangelising intention running through the entire<br />
work, an intention that informs all the apostolates of a<br />
Redemptorist house. The tract on rhetoric is not just a catalogue<br />
of high-class, sophisticated pulpit technique but a revelation of<br />
how he would put his apostolic purpose into action.<br />
In the preface of the Introduzione Generale to the Opere<br />
Ascetiche Don Giuseppe De Luca states forcefully that the<br />
19<br />
Dignity, 269. Selva, 116 (Pt. II, Istruz. IV, n. 5). “Colla popolare poi si<br />
espongono schiettamente le verità eterne, e si dicono dottrine facili con istile<br />
familire e semplice, talmente che ciascuno degli uditori comprenda tutto ciò<br />
che si predica. Nelle prediche non si parla solo a’ dotti, ma anche a’rozzi, i<br />
quali ordinariemente compongono la maggior parte dell’uditorio.”<br />
20<br />
HAMISH SWANSTON, Celebrating Eternity Now, Redemptorist<br />
Publications, Chawton, Hampshire 1995, “He said nothing to them without<br />
parables,” 171-205.
304 TERENCE KENNEDY<br />
obstacles encountered in preparing such a critical edition were<br />
so immense that mistakes were almost inevitable. 21 G.<br />
Cacciatore notes what a many faceted composition the Selva is,<br />
bristling with all sorts of enigmas for the unwary researcher,<br />
In the Selva the citations feature jurists, moralists, inspiring<br />
ascetical authorities, and preachers, all mixed together - proof of<br />
St. Alphonsus’ various experiences as an author, preacher, writer<br />
of moral theology and confessor. (my translation) 22<br />
Cacciatore then explains his approach. By extrapolating from<br />
the rules of rhetoric in Part III he could interpret the saint’s<br />
whole literary production. Distinguishing fontes communes<br />
from fontes particulares enabled him to perform an operation of<br />
archeological retrieval that unearthed the fontes from which St.<br />
Alphonsus proceeded. 23 Cacciatore established that his direct<br />
sources were authors between 1650 and 1760 who summarised<br />
the Scriptures, the Fathers, pious stories and preaching with<br />
their vivid exempla, all according to seventeenth and eighteenth<br />
century canons of literary criticism. 24 It is a curious fact that<br />
Cacciatore transforms St. Alphonsus’s loci into fontes,<br />
evidencing the fact that he has a profoundly different conception<br />
of rhetoric. For Cacciatore it has become the critical discipline<br />
of literary composition that digs out sources embedded in<br />
historical material. For St. Alphonsus loci are not invoked to<br />
project our minds back into the past, but to create presence,<br />
which Chaim Perelman opines is the principal dynamic in<br />
rhetoric. St. Alphonsus wanted to describe preaching as an event<br />
that makes Christ, the Blessed Virgin and the saints actual today<br />
21<br />
Opere Ascetiche. Intoduzione Generale, by O. GREGORIO, G. CACCIATORE<br />
and D. CAPONE, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1960, especially xv.<br />
Hereafter Introduzione Generale.<br />
22<br />
Ibid. 224. “Nella Selva figurano promiscuamente giuristi, moralisti,<br />
esortatori ascetici, oratori, espressione della complessa esperienza<br />
dell’autore, predicatore, scrittore di morale, confessore.”<br />
23<br />
Ibid. “Le fonti e i modi di documentazione”, 119-290, especially<br />
sections beginning at 182 and 186.<br />
24<br />
Cacciatore has a chapter on literary style in St. Alphonsus but no<br />
parallel treatment of rhetoric or sacred oratory.
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 305<br />
in His Church. “By preaching the faith has been propagated, and<br />
by the same means God wishes it to be preserved: Faith comes<br />
by hearing: and hearing by the word of Christ.” 25 The gift of faith<br />
enables us to respond to Christ’s voice lovingly inviting us into<br />
the communion of saints. Although the following declaration<br />
by Perelman is not formally theological it is still rings true of<br />
St. Alphonsus: “The arguing always includes procedures by<br />
which ideas and values can be given special presence (in the<br />
French sense of being made present) in the minds of those<br />
addressed.” 26<br />
Did Cacciatore’s theory of literary criticism prevent him<br />
from properly appreciating St. Alphonsus’ rhetorical presence<br />
and contact with real life situations? Domenico Capone in his<br />
apologetic answer to Döllinger’s assault on St. Alphonsus’<br />
veracity adverted to these crucial questions about correct<br />
criteria and their provenance. 27 Although Capone’s insights into<br />
his master’s pastoral purposes are profound, beautiful and<br />
fruitful, he still seems rather fixed on proving that St. Alphonsus<br />
did not breach Döllinger’s iron laws of critical thought.<br />
Historical criticism based on the methods of the exact sciences<br />
such as physics is clearly unacceptable. But the informal logic of<br />
rhetoric open to audience reaction and flexible life conditions<br />
brings us closer to preaching as an irrepeatable event, a fact to<br />
which St. Alphonsus himself alluded. We can gauge the<br />
effectiveness of a sermon only from the witness of those who<br />
actually hear and are affected by it, e.g., St. Augustine’s<br />
testimony to how grace worked in him through St. Ambrose’s<br />
utterances. 28 The Selva is surely St. Alphonsus’ witnessing to his<br />
first-hand experience on the missions to how the Spirit liberated<br />
so many souls enslaved by sinful habits. Freedom is of course<br />
the invisible element differentiating testimony from science. St.<br />
25<br />
Dignity, 265. Original Selva, 114 (Pt. II. Istruz. IV. n. 2). “Per la<br />
predicazione si è propagata la fede, e per la medesima vuol il Signore che si<br />
conservi: Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi.”<br />
26<br />
CHAIM PERELMAN, The Realm of Rhetoric, University of Notre Dame<br />
Press, Notre Dame, IN, 1982, x.<br />
27<br />
See Introduzione Generale, part three especially from 297.<br />
28<br />
See Opere Ascetiche, III, 302.
306 TERENCE KENNEDY<br />
Alphonsus was utterly persuaded that true freedom before God<br />
was effected through the divine efficacy of preaching. For<br />
preaching is a concrete reality that realises God’s universal will<br />
to save humanity, something not achievable by abstract critical<br />
thought. Simple preaching reaches rich and poor, educated and<br />
uneducated, those who can read and write and those who<br />
cannot. It draws together every class and social grade, the whole<br />
people, as a community united in accepting God’s word. That is<br />
why St. Alphonsus railed against hidden motives in the preacher.<br />
Lack of simplicity or self-seeking after acclaim and glory always<br />
excluded somebody or some class from God’s grace<br />
communicated in his word. The only valid motive is God’s glory<br />
that realises his universal salvific will embodied in his word. The<br />
question thus becomes: how did St. Alphonsus witness to the<br />
efficacy of God’s action in preaching? G. Orlandi, as mentioned<br />
above, found a path through these difficulties by investigating<br />
the exempla as samples of sacred story-telling. 29 Historians have<br />
classified them as a species of rhetoric, thereby defusing<br />
Döllinger’s rationalist objections. Such stories provided concrete<br />
motivation for conversion. To us they may sound fantastic but<br />
for the believing people of St. Alphonsus’ time they were<br />
concrete examples, models of salvation. They allowed people to<br />
enter the stream of salvation history in a spontaneous, non selfreflexive<br />
way, there to respond to Christ present in their history.<br />
IV. The Structure of the Selva.<br />
St. Alphonsus’ rhetoric structures both his message and its<br />
live communication. He was dealing with priests but not in a<br />
theoretic manner. Quite often the contemporary reader is put off<br />
by his definition of priesthood in terms of dignity, indeed a<br />
dignity greater than any other in this world. He seems to over<br />
emphasise priestsly status and superiority over the laity. But his<br />
stance had the same electrifying effect for the priests he<br />
29<br />
G. ORLANDI, “L’uso degli in S. Alfonso Maria de Liguori,”<br />
Spicilegium Historicum C.SS.R., XXXIX(1991)1, 3-39.
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 307<br />
addressed that the proclamation of human rights has today for<br />
the downtrodden and deprived. It is an irrefutable premise, a<br />
definition so obvious that it hardly needs proof, that restores<br />
self-esteem and self-worth. Its one foundation is that God has<br />
chosen them to be priests from eternity and hence their priestly<br />
identity can never be taken from them. Just as all human rights<br />
derive from personal dignity, so all ministerial roles and duties<br />
in the Church flow from divine vocation. Why St. Alphonsus<br />
should be almost strident will becomes obvious when we<br />
consider the state of the clergy at the time. He structured his<br />
argument almost like a system of human rights: all the lesser<br />
arguments confirm and reinforce his starting point, priestly<br />
dignity in whose light all his other theses become meaningful.<br />
This definition is functional and not merely notional.<br />
St. Alphonsus uses dignity in this meaning to put his own<br />
original imprint on the Spiritual Exercises. His proposition<br />
moves the human heart through its connection with the eternal<br />
truths; priests’ path of salvation is their priesthood. By<br />
personally choosing them God wants them to be holy. Their<br />
salvation depends on their being saints who sanctify others. His<br />
idea of salvation and the sanctity flowing out of it is spelt out in<br />
Parts I and II. He divides his retreat talks rhetorically into<br />
sermons to do with the ends of the priesthood (motivation) and<br />
instructions on the means to achieve these (teaching). The<br />
sermons lasted about three quarters of an hour and were<br />
grouped in the following way. Positive topics included; the<br />
dignity, the end or goal, and the sanctity of the priesthood.<br />
Negative themes centred on the harm sin does to priestly dignity,<br />
the evil of tepidity, and the punishment that sins of<br />
incontinence, sacrilegious Masses, and scandal deserve. He<br />
called them to live priestly charity to the full by attending with<br />
zeal to the salvation of the souls in their flock. The last sermon<br />
on vocation to the priesthood was to be preached to seminarians<br />
before ordination, reminding them that their eternal salvation<br />
depended on their honest entry into the priesthood for the right<br />
motives. A priest without a vocation was a thief in the Lord’s<br />
sheepfold. This sermon was not to be preached to priests<br />
because it could easily precipitate some of them into despair.<br />
The dynamic of his preaching has a double motivation<br />
toward conversion; negatively, it exposes sin and its evil
308 TERENCE KENNEDY<br />
consequences; positively, he attracts them by the power of God’s<br />
love away from despair to trust in God’s infinite mercy. He<br />
situates the truth of their vocation within the universe of God’s<br />
providence so as to draw them to God and distance them from<br />
sin as they begin to use the compass that indicates true North,<br />
where true happiness is found, the standard by which to<br />
measure the worth of all things before God. This fulfills the first<br />
aim of rhetoric, to move people to change their goals by<br />
redefining their identity through conversion.<br />
The instructions in Part II are as their name implies, a “how<br />
to do it” course in the skills necessary in pastoral ministry. They<br />
lasted about fifteen minutes each and apply the motives already<br />
inculcated to the details of a priest’s virtuous daily living. They<br />
summarise his spirituality and piety under the titles of<br />
celebrating the Mass, good example, chastity, preaching and<br />
hearing confessions, mental prayer, humility, meekness, internal<br />
and external mortification, the love of God, and devotion to Our<br />
Blessed Lady. Here St. Alphonsus fulfills the second aim of<br />
rhetoric, that is, to teach his hearers by instructing them in a<br />
new style of life.<br />
Part III proposed that priestly life become mission. It<br />
transcends the end of individual conversion and sanctity<br />
programmed in the retreat, inviting the retreatant to a social<br />
commitment to work for the salvation of the world. Called “The<br />
Exercises of the Missions,” (degli esercizi di missione) it is often<br />
characterised as a mission manual. In it St. Alphonsus teaches<br />
priests to become evangelisers like himself by sharing his<br />
rhetorical skills in the communication of the kerygma with them.<br />
Like Christ he calls them to become disciples, taking them on as<br />
apprentices and showing them by example how exhortatory<br />
invitations (sentimenti) and instructions in childrens’ and adults’<br />
catechesis work. Job descriptions on a mission, e.g. of a<br />
superior, preacher, catechist and master of ceremonies, etc., are<br />
clearly laid out. He sets down rules for the frequency and<br />
planning of missions; they are to be held even in small villages<br />
so as to reach the whole population. There must be sufficient<br />
missionaries and time for all to go to confession. Chapter Seven,<br />
“The Sermon” (della predica) is the centre piece in the whole<br />
volume, explaining the techique of preaching. It sketches all a<br />
priest needs to know to compose and deliver a sermon. The
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 309<br />
sermon was the means that encapsulated the Gospel message<br />
for his contemporaries. St. Alphonsus constructed a sermon on<br />
the classic principles of rhetoric, not as stylistics or literary<br />
criticism but as oral communication. 30 His rhetoric focuses on<br />
live performance, a purpose it achieves through the four phases<br />
of invention, disposition, elocution and memory. He states what<br />
right proclamation consists in, i.e., all that will cause the hearers<br />
to actively receive the message with faith and respond with a<br />
total conversion of life. The Selva proposes sermon schemas and<br />
rhetorical principles: his Sunday Sermons and popular writings<br />
are completed discourses informed by the very same rhetoric.<br />
In summary, the dignity of the priest is the motive for his<br />
conversion, for a new style of priestly existence, and for<br />
becoming a disciple, a professional missionary preacher like<br />
Alphonsus himself. In this sense the Selva is a comprehensive<br />
educational programme. Its aims are surety in priestly vocation,<br />
knowledge of its basic duties, and identity with the tradition of<br />
missionary proclamation. Education is an ancient aim of<br />
rhetoric as we know from Quintilian, St. Augustine and many<br />
others. St. Alphonsus is a Doctor of the Church because of the<br />
magisterial way he proposed ideas that could be put into<br />
practice and so be imitated. To read the Selva is still to<br />
experience a Kairos, a moment of conversion.<br />
V. The Rationale of the Selva.<br />
To fully account for St. Alphonsus’ rhetorical techniques<br />
would fill a textbook. That would be a major work impossible in<br />
this essay. Some important indications can be given. St.<br />
Alphonsus denounces the moral shortcomings and even the vice<br />
of the clergy of his time without mincing his terms. He did know<br />
saintly priests but they were a minority. He contends in his<br />
retreat that when people fail to live Christian lives this is caused<br />
30<br />
See H. SWANSTON, Celebrating Eternity Now, Redemptorist<br />
Publications, Chawton, Hampshire 1995, 176 for his dependence on Vico<br />
and Quintilian.
310 TERENCE KENNEDY<br />
by bad example and weak morals among priests. People are not<br />
holy because priests have not satisfied their spiritual hunger for<br />
preaching, catechesis, and the sacraments. Vices such as<br />
superstition reflect those of priests. A priest is set apart for God’s<br />
business, to raise up a holy people, worshiping Him in spirit and<br />
truth.<br />
... our eternal salvation depends principally on embracing the<br />
state to which God has called us. The reason is evident: for it is<br />
God that destines according to the order of his Providence, his<br />
state of life for each individual, and according to the state to<br />
which he calls him, prepares for him abundant graces and<br />
suitable helps..this is the order of predestination. 31<br />
Without a vocation to sainthood a priest cannot realise God’s<br />
providence for his Church. 32 Meditating the eternal truths a<br />
priest comes face to face with his destiny before God and so<br />
discerns his true vocation. His standard is the saint who quivers<br />
with fear at the thought of sacred ordination,<br />
But how, I ask, does it happen that the saints, who live only<br />
for God, resist their ordination through a sense of their<br />
unworthiness, and that some run blindly to the priesthood, and<br />
rest not until they obtain it by lawful or unlawful means? 33<br />
31<br />
Dignity, 201-202. Selva, 86 (Pt. I. Cap. X. n. 13). “...la nostra salute<br />
eterna principalmente depende dal prendere quello stato a cui ci chiama<br />
Iddio...E la ragione è chiara, perchè Dio è quello che, secondo l’ordine della<br />
sua provvidenza, destina a ciascuno lo stato di vita. e, secondo lo stato a cui<br />
lo chiama, prepara poi le grazie e gli aiuti convenienti:...e questo è l’ordine<br />
della predestinazione... “<br />
32<br />
See L. PETROSINO, “Fedeltà alla vocazione sacerdotale secondo S.<br />
Alfonso,” Rivista di ascetica e mistica, 48(1979)3, 218-244. I shall not go into<br />
St. Alphonsus’ theology of priesthood nor its part in disputes earlier this<br />
century. Each image of the dozens he proposes has its own rhetoric which<br />
needs to be grasped before one can come to a unified theology thereof.<br />
33<br />
Dignity, 40-41. Selva, 14 (Pt. I. Cap. II. n. 3). “Ma come va, mi<br />
domando, che i santi, quei che vivono solemente a Dio, ripugnano di<br />
ordinarsi perchè se ne stimano indegni, e poi tanti corrono alla cieca a farsi<br />
sacerdoti e non si quietano, se non vi giungono per impegni e per vie diritte<br />
o storte?”
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 311<br />
The clerical vices described above run parallel to and are<br />
balanced by the virtues of the true priest of Jesus Christ. A<br />
priest’s task is to cooperate with Christ in the world’s salvation<br />
and so continue his work. St. Alphonsus refers to them as<br />
workers (operai) or priest workers (sacerdoti operai). 34 They<br />
honour the Father by distributing the benefits Christ gave into<br />
their keeping to forgive sin and consecrate the body of Christ. 35<br />
They guard Christ’s body in His real presence in the Eucharist<br />
and in His mystical body, the Church. Here are some terms<br />
employed to define their offices:<br />
The dignity of the priest is estimated from the exalted nature<br />
of his offices. Priests are chosen by God to manage on earth all<br />
his concerns and interests. St. Ambrose has called the priestly<br />
office a divine profession. A priest is a minister destined by God<br />
to be a public ambassador of the whole Church, to honor him,<br />
and to obtain his graces for all the faithful...The dignity of the<br />
priest is also estimated from the power that he has over the real<br />
and the mystical body of Christ...Priests are the dispensers of the<br />
divine graces and the companions of God...the glory and the<br />
immovable columns of the Church: they are the doors of the<br />
eternal city...they are the vigilant guardians to whom the Lord<br />
has confided the keys of the kingdom of heaven. 36<br />
Like all the great pastors down the ages St. Alphonsus could<br />
cry when confronted with the decline in the priesthood in his<br />
34<br />
See Selva, 73 (Pt. I. Cap. IX. n. 21).<br />
35<br />
Selva, 14 (Pt. I. Cap. II. n. 5). “Gesù Cristo ha formato i sacerdoti come<br />
suoi cooperatori a procurare l’onore dell’eterno suo Padre e la salute delle<br />
anime.”<br />
36<br />
Dignity, 24-28. Selva, 7-9 (Pt. I. Cap. I. n. 2-7). “Si misura la dignità del<br />
sacerdote dai grandi uffizi ch’essi hanno. I sacerdoti sono gli eletti da Dio a<br />
trattare in terra tutti i suoi negozi ed interessi divini...è chiamato l’uffizio<br />
sacerdotale professione divina...Il sacerdote è il ministro destinato da Dio<br />
come pubblico ambasciatore di tutta la chiesa per onorarlo e per impetrarne<br />
la grazia a tutti i fedeli... Si misura anche la dignità del sacerdote dalla<br />
potestà che tiene sovra il corpo reale e sovra il corpo mistico di Gesù Cristo<br />
... I sacerdoti sono i dispensatori delle divine grazie ed i compagni di<br />
Dio...Sono l’onore e le colonne, sono le porte e i portinai del cielo.”
312 TERENCE KENNEDY<br />
day. 37 And so he drew up his retreat as a polar opposition<br />
between dignity-depravity, sanctity-sin, virtue-vice, good<br />
example-scandal, chastity-incontinence, ambition-meekness<br />
and zeal-tepidity. By now it should be clear how his rhetoric of<br />
contrast was a leaver for conversion. It is a powerful tool,<br />
creating tension inside the hearer, opening up a space where<br />
God can act. He based this rhetoric on Scripture, on the<br />
fundamental distinction of ends: between the highest ends (fini<br />
altissimi) which come from God and false ends (fini storti)<br />
derived from this world’s self-seeking. In his words,<br />
Neither nobility of birth, nor the will of parents are marks of<br />
a vocation to the priesthood; nor is talent or fitness for the<br />
offices of a priest a sign of vocation, for along with talent a holy<br />
life and a divine call are necessary. What, then, are the marks of<br />
a divine vocation to the ecclesiastical state? The first is a good<br />
intention. It is necessary to enter the sanctuary by the door, but<br />
there is no other door than Jesus Christ: I am the door of the<br />
sheep...if any man enter in he shall be saved. To enter, then, by the<br />
door is to become a priest not to please relatives, nor to advance<br />
the family, nor for the sake of self-interest or self-esteem, but to<br />
serve God, to propagate his glory, and to save souls. 38<br />
The contrast between virtue and vice hinges on the value of<br />
priesthood as a God-given-dignity. So a priest must be holy to<br />
37<br />
Dignity, 51. Selva, 18 (Pt. I. Cap. III. n. 4). The quotation is: “Piange s.<br />
Bernardo in vedere tanti che corrono a prendere i sacri ordini senza<br />
considerare la santità che si richiede in coloro che vogliono ascendere a<br />
tanta altezza.”<br />
38<br />
Dignity, 191-192. Selva, 81-82 (Pt. I. Cap. X. n. 6). “Non sono segni di<br />
vocazione al sacerdozio nè la nobiltà di nascita nè la volontà dei parenti: e<br />
neppure è segno il talento e l’abilità che forse avesse già taluno per gli ufficj<br />
di sacerdote...E quali dunque sono i segni per conoscere la vocazione allo<br />
stato ecclesiastico? Il primo segno è il retto fine. Bisogna entrare nel<br />
santuario per la porta, e questa non è altro che Gesù Cristo. Ego sum ostium<br />
ovium etc. per me si quis introierit salvabitur. Non è la porta dunque il voler<br />
piacere i parenti nè l’avanzamento della casa nè l’interesse o la stima<br />
propria, ma il retto fine di servire a Dio, per propagar la sua gloria e salvar<br />
anime.”
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 313<br />
sanctify the people, to nourish them with the Eucharist and<br />
forgive their sins in confession. How does he justify “dignity” as<br />
a definition or first premise? By the classic technique of<br />
reasoning through enthymemes and exempla, i.e., by deduction<br />
from the axiomatic wisdom of the Scriptures, Fathers and<br />
saints, and by induction from the lived experiences of the<br />
Church and her saints in history. These complement each other<br />
as they should in all good rhetoric. The argument of the Selva<br />
oscillates between imagining and thinking, appealing to heart<br />
and mind as appropriate.<br />
Part II uses the same rhetoric of opposition and contrast. It<br />
sketches a spirituality from both aspects, negatively as distacco<br />
mortifying worldly concerns, and positively as loving union with<br />
God by conforming our lives to His will. It comes to grips with<br />
the difficulties experienced by isolated, country priests with a<br />
remedial course in ministry that is not ashamed to descend to<br />
practicalities (cose di pratica) in a way scandalising to many<br />
well-healed retreat masters. St. Alphonsus wanted to restore to<br />
his often ignorant hearers their dignity as functional ministers<br />
of the Gospel in their home villages. He instructs them in their<br />
pastoral duties and in the spiritual life required to sustain their<br />
ministry. His rhetoric succeeds because he identifies with them,<br />
their needs and their mentality which he learnt from years on<br />
the missions. His slogan is, “But to obtain grace for others the<br />
priest himself must be holy.” 39 He formed sacerdotal character<br />
by exercising them in prayer and ministry. He realised rhetoric’s<br />
teaching purpose at its best by instructing them in mental prayer<br />
where they learnt the science of the saints. 40 He concretises the<br />
way of perfection into a rule of life (regolamento) based on deep<br />
personal commitment.<br />
In Part III St. Alphonsus describes the further possibilities<br />
of their life on a dryer, more objective level. He presents<br />
preaching missions as an evangelical project. A squad of secular<br />
priests might band together for a preaching campaign in their<br />
own area, or by dedicating their lives permanently and fully by<br />
39<br />
Dignity, 61. Selva, 22 (Pt. I. Cap. III. n. 14). “Ma per ottenere le grazie<br />
agli altri è necessario che il sacerdote sia santo.”<br />
40<br />
Selva, 129 (Pt. II. Istruz, V. n. 5). Note the dependence on St. Bernard.
314 TERENCE KENNEDY<br />
joining his own Redemptorists. Second, if not moved to become<br />
missionaries, at least, they should know the rationale of<br />
missions so as to be positively disposed and not negative and<br />
destructive toward them.<br />
What then is the purpose of St. Alphonsus’ tract on rhetoric<br />
in the Selva? In our terms, it corresponds to the yearning for a<br />
new language in which to socialise the faith. The sermon<br />
packaged the faith’s conversion content, and the mission<br />
institutionalised the Gospel’s energy for the Church. He shaped<br />
the project of preaching salvation to the people into a historical<br />
force by founding his own missionary institute. Rhetoric was the<br />
instruments he used to mold sermons into a unified plan and<br />
shape preaching as a social structure, an institution in the<br />
Church. 41 Rhetoric succeeds only when it adjusts its logical<br />
arguments and structures to the psychological condition and<br />
capacity of the people. Here one palpably touches the source of<br />
Alphonsus’ persuasiveness. His rhetoric is the fruit and image of<br />
his experience. In this sense there is a praxis (preaching) - theory<br />
(rhetoric) - praxis (mission) dynamic at work throughout the<br />
Selva. Neither praxis nor rhetoric are individualistic terms: they<br />
are essentially social and inter-related. St. Alphonsus knew he<br />
could change the Church’s praxis by transforming the practices<br />
of priests, the pastoral agents closest to the people. 42 Luigi<br />
Petrosino suggests St. Alphonsus had an end (vocation to<br />
holiness) - means (duties of clerics) - project (apostolate as<br />
mission) schema in mind as a practical plan to reform the<br />
priesthood in his time. 43 The fact that the Exercises were often<br />
preached during missions in order to evengelise the clergy and<br />
41<br />
The power of rhetoric to mold social structures is well treated in<br />
Richard Harvey Brown,” Rhetoric, Textuality and the Postmodern Turn in<br />
Sociological Theory,” in The Postmodern Turn, Steven Seidman (ed.),<br />
Cambridge University Press, Cambridge 1994, 229-241.<br />
42<br />
See my “Did St. Alphonsus practice practical Theology? “Per venire<br />
dunque alla pratica”: Practice or pragmatism?”, La recezione del pensiero<br />
alfonsiano nella chiesa, Collegium S. Alfonsi de Urbe, Roma 1998,155-167.<br />
43<br />
L. PETROSINO, C.SS.R. presented an unpublished tesina for the licence<br />
in moral theology in the Accademia Alfonsiana in 1985 entitled La “Selva” al<br />
servizio del sacerdozio nel ‘700. He draws attention to the importance of the<br />
libraries in the Redemptorist houses in Ciorani and Pagani and to the
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 315<br />
to make them evangelisers confirms this. Alphonsus stands<br />
firmly in the Augustinian tradition which argues from what<br />
priests are, to what they ought to be. His rhetoric appeals to<br />
them to be converted so as to convert others. He inserted<br />
rhetoric into the processes of conversion, sanctification and<br />
community building in the Church as a necessary means of<br />
spreading God’s merciful love to the world.<br />
St. Alphonsus’s list of sermons appears excessively negative,<br />
even harsh, and over-emphatic about sin. To get inside his<br />
approach to priests we need to know the conditions in which he<br />
laboured. 44 The state of the clergy at the time was a cause for<br />
serious concern. Although the priests he addressed celebrated<br />
Mass they were by and large incapable of hearing confessions or<br />
assisting the dying. Another problem was a type of parish, the<br />
parrocchia ricettizia, often found in the Kingdom of Naples. It<br />
answered more to powerful government-backed local families<br />
than to the bishop. This occurred against a background of<br />
Church-State tension that sometimes flared into open fights<br />
over taxes, property and jurisdiction. The Council of Trent had<br />
been officially accepted but was not effectively applied. The<br />
Diocesan Synod of 1726 and Cardinal Spinelli’s 1741 Pastoral<br />
Visitation set new clerical standards that inspired Blessed<br />
Gennaro Sarnelli’s L’ecclesiastico santificato in 1739. 45 St.<br />
Alphonsus also wrote on bishops and seminaries. 46 He knew that<br />
only learned and saintly priests dedicated to serving the poor<br />
could prevent a mass abandonment of the practice of the faith.<br />
Clergy numbers were quite excessive, even over 2% of the<br />
population. Many became priests from family pressure, a way of<br />
getting a son “set up” in life. Seminaries were in a pitiable state,<br />
being financially viable only because the wealthy sent their sons<br />
authors whose preached retreats St. Alphonsus had available there, e.g., L.<br />
Abelly, M. Beuvelet, C. A. Cattaneo, etc.<br />
44<br />
See G. ORLANDI, Il regno di Napoli nel settecento, Collegium S. Alfonsi<br />
de Urbe, Roma 1996, especially Parte II.<br />
45<br />
This is the date given by FRANCESCO CHIOVARA, Il beato Gennaro Maria<br />
Sarnelli Redentorista, Materdomini 1996, 141.<br />
46<br />
See Opere Ascetiche, III.; “Riflessioni utili ai vescovi,” 865-877;<br />
“Regolamento per i seminarj,” 878-886.
316 TERENCE KENNEDY<br />
for a good education with no notion of orders. Many students<br />
lived outside, like Alphonsus himself, often doing their studies<br />
under a pastor’s guidance who had to guarantee a candidate’s<br />
suitability. Standards were lax indeed, even on the part of<br />
bishops. There resulted a largely uneducated clergy, living with<br />
their families, frequently involved in business and secular<br />
affairs. Such worldliness was the price the Church paid for<br />
failing to be authentically spiritual, something against which<br />
St.Alphonsus rebelled with a rhetoric of contrast, prophetic in<br />
word and action.<br />
VI. Character and the Rhetoric of Liberty in St.Alphonsus.<br />
The author’s admonitions at the beginning of the Selva<br />
reveal his personal attitude to rhetoric. The freedom he expects<br />
of priests is very impressive. His approach to them could be said<br />
to be based on the principle of freedom. Sermons and a fortiori<br />
the Exercises, he notes, do not function according to a<br />
predetermined plan. But his plans are not haphazard for their<br />
matter, division and way of relating to the audience have to be<br />
invented. The title Selva or wood suggests that invention is a way<br />
of finding one’s way through a forrest of possible arguments as<br />
explained by “The Invention, or the Choice of Materials for<br />
composing a Sermon.” 47<br />
Great is the error of some who, having found the materials,<br />
set themselves to determine the points and to compose the<br />
sermon. One must before all prepare the materials, that is, the<br />
texts of Scripture, the arguments, the comparisons, etc.; which<br />
are to serve to prove the propositions that one has in view. 48<br />
47<br />
Preaching, 179. Selva, 228 (Pt. III, Cap VII, n. 1). “dell’invenzione o sia<br />
selva per formare la predica.”<br />
48<br />
Preaching, 179. Selva, 228 (Pt. III. Cap. VII. n. 1). “E’ grande errore<br />
quello d’alcuni che prima di trovar la materia si pongono a determinare i<br />
punti ed a stendere la predica. Bisogna dunque prima di tutto ritrovar la<br />
materia, cioè le scritture. le ragioni, le similitudini ec. che conducono a<br />
provar la proposizione che si propone di trattare.”
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 317<br />
St. Alphonsus evokes this response freely in the retreat<br />
master as well as in the person meditating his writings for<br />
spiritual light. He defends their liberty to create and arrange<br />
arguments which<br />
are given without order, and expressed briefly, that the reader<br />
may select the authorities, subjects, and thoughts that are most<br />
pleasing to him, and may afterwards arrange and extend them as<br />
he pleases, and thus make the discourse his own. 49<br />
Parts I and II furnish models of discourses from which a<br />
retreat master may choose and compose completed discourse as<br />
he desires. In communication a speaker’s integrity is most<br />
important. For people see quickly if the message pronounced is<br />
not his own. A vital stage in forming a preacher is personalising<br />
his message.<br />
For experience shows that a preacher will scarcely deliver<br />
sentiments with fervor and zeal unless he has first made them<br />
his own, 50<br />
Communication is a two-way process: a preacher fits his<br />
message to his hearers’ condition by entering their world. “The<br />
preacher must imagine himself to be one of them.” 51 Aflame<br />
with the love of God he can warm their hearts, opening them up<br />
to God’s action. God takes the initiative by operating in the<br />
preacher who calls his listeners to “the freedom.. of the children<br />
of God” (Rom 8: 21). St. Alphonsus strove vigorously to liberate<br />
49<br />
Duties, 19. Selva, 5 “Avvertimenti necessarj a chi da gli esercizi<br />
spirituali ai sacerdoti” “non si è dato l’ordine che ricerca un discorso formato<br />
per ciascuna materia; nè i sentimenti si sono distesi; si son notati questi alla<br />
rifusa, ed in breve; ma ciò si è fatto di proposito, affinchè il lettore<br />
scegliendone quelle autorità, dottrine e pensieri che più gli gradiscono, egli<br />
poi gli ordini e li stenda come meglio gli piacerà, facendosi con ciò proprio<br />
il discorso.”<br />
50<br />
Ibid. “l’esperienza fa vedere che ‘l predicatore difficilmente dirà con<br />
calore e spirito quei sentimenti, se prima non gli avrà fatti proprj,”<br />
51<br />
Dignity, 270. Selva, 117 (Pt. II. Istruz. IV. n. 6). “Bisogna che il<br />
predicatore si figura d’essere come uno di loro.”
318 TERENCE KENNEDY<br />
his hearers from every bondage, e.g. family pressure and secular<br />
affairs, and to release the abundant grace of redeeming love<br />
within them. Retreat masters are exhorted to “be careful to treat<br />
with respect and sweetness the priests who listen to him” 52<br />
The title Selva suggests a place of mystical encounter as in<br />
the pastoral poetry and opera of the period. This rhetoric set up<br />
an atmosphere of silent contemplation of God and his goodness,<br />
the reason St. Alphonsus make mental prayer with the people.<br />
He so fixed the social form of many practices of popular piety<br />
that they have lasted to the present day. To read the Selva<br />
through the lens of critical reason turns a living forest into a pile<br />
of fire-wood, depriving it of God’s living presence active through<br />
His Word. St. Alphonsus recommended the Selva for a private<br />
retreat, aspecially where a difficult life-decision or vocation<br />
hung in the balance. 53<br />
In preaching a priest communicates of himself. He becomes<br />
a mirror reflecting God’s goodness to people in their need.<br />
Cardinal Martini says preaching involves contact with self,<br />
others and God in his beautiful meditation on “The preacher<br />
before the mirror.” 54 Alphonsus projected multiple images of<br />
priesthood since no one alone could contain this mystery. He<br />
never sought to bolster his own reputation, yet he has testified<br />
to how God worked his own conversion, calling him to be his<br />
advocate pleading the cause of poor sinners. Here is the source<br />
of his rhetoric of contrast.<br />
The causes that a priest should advocate are the causes of<br />
poor sinners; and these he should seek to deliver from the hands<br />
of the devil and from eternal death by sermons, by hearing<br />
confessions, or at least by admonitions and prayers. 55<br />
52<br />
Dignity, 20-21. Selva, “Avvertimenti a chi dà gli esercizi spirituali a’<br />
sacerdoti,” 5. “di trattare que’ sacerdoti che l’ascoltano, con rispetto e con<br />
dolcezza.”<br />
53<br />
See, “Sull’utilità degli esercizj spirituali fatti in solitudine,” in Opere<br />
Ascetiche, III, Marietti, Torino 1847, <strong>Vol</strong>. III, 609-617.<br />
54<br />
CARLO MARIA MARTINI, Il predicatore allo specchio, Ancora, Milano 1986.<br />
See Selva, 103 (Pt. II, Istruz. II, n. 9).<br />
55<br />
Dignity, 350. Selva, 153 (Pt. II. Instruz. VIII. n. 11). “Le cause che ha<br />
da difendere sono le cause dei poveri peccatori, per liberarli colle prediche,
ST. ALPHONSUS’ SELVA. SHOUND IT BE UNDERSTOOD AS RHETORIC? 319<br />
This is how St. Alphonsus understood himself, God’s<br />
advocate using the priestly rhetoric of mercy in the service of the<br />
poor. It is not enough to treat the Selva as a treasure trove of<br />
sermon material or manual of how to conduct missions. It<br />
transcends these things to reveal what moved him as a priest, a<br />
missionary and a founder. Implicit in its structure, running<br />
through it from beginning to end are the presuppositions of<br />
classical rhetoric enunciated in Section II of this essay. We have<br />
seen his argument, the condition of his audience, and his own<br />
character, which in good rhetoric is the chief source of<br />
persuasion, the most important of these three elements that<br />
combine to create a discourse. The Selva is to be understood<br />
then not just as another great monument in the tradition of<br />
classic rhetoric, but as the active presence of the living God<br />
working through the mouth of the preacher. Perhaps it is only<br />
the poet who can catch this truth.<br />
What function is so noble as to be<br />
Ambassador of God and destiny?<br />
To open life! to give kingdoms to more<br />
Than kings give dignities? to keep heaven’s door?<br />
Mary’s prerogative was to bear Christ, so<br />
‘Tis preachers to convey him, for they do,<br />
As angels out of clouds, from pulpits speak,<br />
And bless the poor beneath, the lame, the weak. 56<br />
Accademia Alfonsiana<br />
Via Merulana 31<br />
C.P. 2458<br />
00100 Roma - Italy.<br />
TERENCE KENNEDY, C.Ss.R.<br />
—————<br />
colle confessioni o almeno colle ammonizioni ed le orazioni, dalle mani del<br />
demonio e dalla morte eterna.” See the reproduction of the engraving<br />
opposite the frontpiece in St. Alphonsus’ original edition in E. Marcelli and<br />
S. RAPONI, Un umanista del ‘700 italiano. Alfonso M. de Liguori, Provincia<br />
Romana C.SS.R, Roma 1992, 53.<br />
56<br />
JOHN DONNE, quoted by EDGAR N. JACKSON, A Psychology for Preaching,<br />
Hawthorn Books, New York 1961, 69.
320 TERENCE KENNEDY<br />
Summary / Resumen<br />
This essay describes the contemporary recovery of rhetoric and its<br />
importance in understanding G. B. Vico and St. Alphonsus Liguori.<br />
The Selva di materie predicabili of Saint Alphonsus is not just a<br />
manual of preaching technique. Its use of rhetoric reveals how he conceived<br />
the goals of the priesthood, of preaching, of missions to the<br />
people, and of their institutionalization in the Church.<br />
Este ensayo describe el rescate actual de la retórica y su importancia<br />
para la comprensión de Juan Bautista Vico y de San Alfonso de<br />
Liguori. La Selva de materias predicables de San Alfonso no es sólo<br />
un manual de predicación técnica. Su uso de la retórica demuestra<br />
cómo él concibió el fin del sacerdocio, de la predicación, de las misiones<br />
populares y de su establecimiento en la Iglesia.<br />
—————<br />
The author is an Ordinary Profesor at the Alphonsian Academy.<br />
El autor es profesor ordinario en la Academia Alfonsiana.<br />
—————
321<br />
StMor 37 (1999) 321-356<br />
SEBASTIANO VIOTTI<br />
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE<br />
La questione dell’impatto tra morale e legge civile incontra<br />
non poche difficoltà per approdare ad una soluzione adeguata<br />
e, soprattutto, condivisa dalle varie cosmovisioni e correnti di<br />
pensiero che animano e frastagliano le società contemporanee,<br />
complesse e pluralistiche; anzi, forse proprio questo frastagliamento<br />
culturale costituisce il maggiore ostacolo. Il rapporto tra<br />
etica e legge civile diventa problematico soprattutto con l’avvento<br />
della modernità e tale rimane anche oggi, sia per la prassi<br />
che per la teoria: l’irrilevanza della legge civile per la coscienza<br />
di molti cittadini e la discordanza circa i parametri che definiscono<br />
una legge buona o la sua legittimità sono i nodi del rapporto<br />
tra etica e diritto umano. Non pochi cittadini, infatti, e tra<br />
essi vanno annoverati anche parecchi cristiani, distinguono e<br />
separano la rettitudine morale personale dall’adempimento dei<br />
doveri civici, convinti che l’ordinamento giuridico non interpelli<br />
in qualche misura la responsabilità della persona, la sua coscienza.<br />
I criteri in base ai quali qualificare una legge come<br />
buona o norma sociale autentica suscitano discussioni e non sono<br />
parametri condivisi non solo nell’opinione pubblica, spesso<br />
umorale, facilmente suggestionabile e manipolabile, e tra gli<br />
uomini politici, sovente più interessati all’affermazione della loro<br />
parte e al conseguimento di un consenso maggiore che al bene<br />
della società, ma incontrano dissenso e contrasto anche tra<br />
gli stessi cultori di filosofia politica. Il problema poi balza prepotentemente<br />
in evidenza, sfociando spesso in accese polemiche<br />
che, come innescate da una miccia, si riaccendono e rinfocolano,<br />
specialmente quando vengono presentate determinate<br />
proposte di legge, o durante il loro iter di elaborazione, e raccomandazioni<br />
di organismi internazionali intese a regolamentare<br />
“aspetti delicati” per la convivenza, legati alle nuove situazioni<br />
sociali o alle possibilità di manipolazione aperte dalla scienza e
322 SEBASTIANO VIOTTI<br />
dalla tecnica 1 . Discussioni e polemiche che spesso assumono<br />
anche toni veementi con scambio di reciproche accuse tra le<br />
parti: integrismo e oscurantismo; relativismo e agnosticismo.<br />
Il problema morale della legge civile è certamente ascrivibile<br />
in primo luogo al venir meno di evidenze etiche comuni, ma,<br />
a mio avviso, soprattutto le polemiche, che rendono la discussione<br />
e la controversia più aspra e lacerante, in alcuni casi, non<br />
sono scevre da un qualche equivoco, connesso ad una precomprensione<br />
circa la natura e la funzione della legge civile. La parte<br />
cattolica, infatti, non sempre riesce a sfuggire alla tentazione<br />
di attribuire impropriamente alla legge civile, chiamata ad indicare<br />
la condotta sociale auspicabile, il compito di esprimere e<br />
definire la verità morale o di sanzionare e rafforzare con la coazione<br />
il vigore dell’intera legge morale. In sostanza, assegna alla<br />
legge civile un ruolo eminentemente educativo della coscienza 2 ,<br />
equiparandola tout-court alla legge morale, senza avvertire chiaramente<br />
che, se questa è chiamata ad esprimere la verità morale<br />
e formare i convincimenti morali della coscienza, il diritto po-<br />
1<br />
Mi riferisco in particolare alle proposte di legge per la regolamentazione<br />
dell’aborto, della fecondazione medicalmente assistita e della sperimentazione<br />
in genetica, per il riconoscimento dei diritti delle convivenze di<br />
fatto…<br />
2<br />
Questa era la convinzione condivisa dei teologi moralisti del passato,<br />
che mi limito a documentare con alcune affermazioni di Häring : “Le leggi<br />
dettate dagli uomini non offrono la chiarezza e la sicurezza del bene assoluto,<br />
come le leggi divine. Tuttavia sono richieste dalla stessa natura sociale<br />
dell’uomo. L’uomo ha bisogno dell’autorità e della sua legge per il proprio<br />
sviluppo morale. Ma soprattutto ha bisogno della legge la comunità per la<br />
propria stabilità (la legge è una realtà sociale), per rendere possibile a ogni<br />
singolo membro un ambiente d’ordine, in cui prestare il proprio servizio e<br />
svolgere la propria attività morale. Doppiamente necessaria è poi una rigida<br />
legislazione, a causa della colpa originale. Se la legge non ponesse un argine<br />
agli abusi della libertà da parte dei cattivi, i buoni perderebbero ben presto<br />
la loro libertà al bene, sedotti o costretti. (Qui sta il grande errore del « concetto<br />
di libertà » della democrazia occidentale). La legge con i suoi mezzi<br />
coattivi è un necessario strumento di educazione per la debolezza umana e<br />
una difesa contro la malvagità degli uomini”. B. HÄRING, La legge di Cristo,<br />
Morcelliana, Brescia 1967, V^ ed., voll,3, I, 327 In seguito, nell’opera Liberi<br />
e fedeli in Cristo, Paoline, Cinisello Balsamo 1987, l’autore si distaccherà da<br />
questa impostazione.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 323<br />
sitivo invece suppone dei convincimenti morali nelle persone ed<br />
è finalizzato a rendere possibile la compresenza e l’interazione<br />
di soggetti e mondi vitali diversi per convinzioni e progetti di vita.<br />
La funzione pedagogico-morale non può essere il ruolo primario<br />
e principale della legge civile, poiché lo Stato non può arrogarsi<br />
il compito di plasmare le coscienze, non può erigersi a<br />
maestro di morale, in quanto: “[...] non ha competenza in materia<br />
teologica e religiosa, perché per natura sua è «laico» e non<br />
può quindi emettere giudizi in materia che oltrepassino il livello<br />
sociologico” 3 . Negare alla legge civile la funzione di esprimere<br />
la verità morale e di formare le coscienze, non equivale ad affermare<br />
che essa possa disertare l’etica, che debba estraniarsi ed<br />
essere avulsa da considerazioni circa quanto è bene e giusto per<br />
la convivenza, che l’ordinamento giuridico non debba ispirarsi a<br />
dei valori, ma significa riconoscere che esso non “progetta” un’etica,<br />
non forgia una sua etica, ma solo assume e dà vigore sociale<br />
ai convincimenti morali dei cittadini circa quanto è eticamente<br />
significativo per la convivenza. La relazione tra legge civile e<br />
morale, per essere adeguatamente compresa, non può che essere<br />
pensata a partire dalla distinzione, per compito e per ambito,<br />
tra le due grandezze:<br />
“Bisogna distinguere e solo quando avremo distinto le due<br />
dimensioni, quando avremo capito che la politica non ha il compito<br />
di dirci quello che è giusto o non è giusto fare eticamente<br />
ma che ha il compito di stabilire le condizioni per favorire una<br />
presa di coscienza etica e far sì che una azione etica sia possibile,<br />
allora avremo fatto un passo avanti. [...] se noi distingueremo<br />
politica ed etica, cioè se davvero avremo compreso come la politica<br />
non sia se non quel gioco attraverso cui rendiamo possibili<br />
degli scenari in cui siamo liberi, in cui siamo capaci della nostra<br />
libertà, in cui siamo capaci di comportarci eticamente, allora<br />
avremo ritrovato, a quel punto, e solo a quel punto, il legame che<br />
lega queste due esperienze. Quindi distinguere per ritrovare ciò<br />
che lega” 4 .<br />
3<br />
G. MATTAI, Morale Politica, EDB, Bologna 1977, 2^ ed., 264-5.<br />
4<br />
S. GIVONE, La casa della verità è la storia, in AA.VV., L’Etica dei giorni<br />
feriti, Cittadella, Assisi 1997, 76.
324 SEBASTIANO VIOTTI<br />
L’altra parte, quella che si definisce laica (laicista?), viceversa,<br />
non riesce sovente a sfuggire alla tentazione opposta: separare<br />
e contrapporre legge civile e morale, dimenticando che l’ordinamento<br />
giuridico, quale norma per un bene-essere delle persone<br />
e della vita sociale nella convivenza politica, non può prescindere<br />
del tutto da una considerazione circa il significato e il<br />
fine della vita associata, espressi dall’etica. Giunge così a configurare<br />
e ridurre la legge civile unicamente ad imposizione, o comando,<br />
espressione della forza dei numeri o codificazione delle<br />
preferenze della maggioranza. In altre parole, non riesce ad evitare<br />
l’insidia del positivismo e del sociologismo giuridico, racchiudendo<br />
e facendo consistere la significatività della legge solamente<br />
nella correttezza del procedimento della sua emanazione,<br />
equiparando così legittimità a legalità, sostituendo il ius quia<br />
iussum al ius quia iustum.<br />
La zona d’ombra circa la natura dell’ordinamento giuridico<br />
si accompagna poi ad una non sempre puntuale attenzione e valutazione<br />
di tutti i fattori che entrano in gioco nella sua costituzione,<br />
che formano così, in buona misura, il nocciolo duro della<br />
controversia sul problema morale della legge civile.<br />
La riflessione filosofico-politica contemporanea sulla legittimità<br />
della legge civile è quindi una questione culturale intricata,<br />
ulteriormente complicata dalla molteplicità delle visioni del pianeta<br />
“uomo” e delle cosmovisioni morali presenti nelle nostre<br />
società pluralistiche. Essa si trova come di fronte ad un guado<br />
certamente difficile da superare, ma non impossibile, se si vorrà<br />
attivare un dialogo, scevro da pregiudizi e posizioni precostituite,<br />
un dialogo che, per approdare a dei risultati, certamente richiederà<br />
tempi lunghi e notevole impegno e pazienza. Senza alcuna<br />
presunzione o pretesa di indicare una facile soluzione,<br />
quasi un uovo di Colombo, vorrei intervenire nel dibattito con<br />
un obiettivo modesto e limitato: compiere una ricognizione dei<br />
fattori implicati nella questione del problema morale della legge<br />
civile, evidenziando gli elementi che devono essere considerati e<br />
composti, per richiamare una rinnovata riflessione su di essi,<br />
anche a costo di apparire banale e cadere nell’ovvio. Metodologicamente<br />
vorrei risalire dagli aspetti che appaiono più semplici<br />
e condivisi agli aspetti più complessi, problematici e controversi.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 325<br />
Norma necessaria, legale e chiara<br />
Le leggi civili, fenomenologicamente, possono essere descritte<br />
e comprese come determinazioni dell’autorità politica<br />
che esprimono l’atteso apporto collaborativo di ogni cittadino<br />
per la vita della comunità, in quanto con esse l’autorità cerca di<br />
promuovere la sinergia degli intenti e dell’operare di tutti e, contemporaneamente,<br />
di rassicurare ognuno circa il comportamento<br />
degli altri cittadini. Risulta così immediatamente chiara la loro<br />
valenza di forza finalizzata: sono norme autoritative e coattive,<br />
ma finalizzate a dare un volto ordinato e armonico alla convivenza<br />
socio-politica. Forza finalizzata, poiché sono contemporaneamente<br />
senso e coazione, poste a servizio della socialità<br />
umana, quali strumenti che propiziano il dipanarsi e lo svilupparsi<br />
ordinato della socializzazione e della vita sociale o convivenza<br />
politica. Il diritto umano è dunque uno strumento per veicolare<br />
una progettualità sociale e ha, quale caratteristica inscindibile,<br />
la necessità di essere efficace, deve cioè effettivamente incidere<br />
sulla pluralità delle relazioni, e dei gruppi, da cui la convivenza<br />
è costituita, per garantirle e sostenerle e per comporre le<br />
particolarità con la pluralità, in modo che l’agire di tutti sia concordemente<br />
orientato al perseguimento del bene comune, risultante<br />
da una composizione equilibrata tra esigenze di libertà ed<br />
esigenze di giustizia e di uguaglianza. Tale necessità di effettiva<br />
incidenza o di efficacia è messa particolarmente in risalto dalla<br />
sanzione, che accompagna ogni legge.<br />
E’ nella natura delle cose che uno strumento sia tale, se è veramente<br />
pertinente allo scopo, cioè se idoneo al fine, correttamente<br />
prodotto ed usabile; la legge civile dunque è veramente<br />
uno strumento a servizio dell’umanizzazione della convivenza se<br />
riveste un carattere di giustizia, di necessità o utilità, di correttezza<br />
procedurale nelle modalità di emanazione e di chiarezza e<br />
comprensibilità quanto alla formulazione. Caratteristiche queste<br />
che, a partire da Isidoro 5 , sono state costantemente ribadite<br />
5<br />
“Erit lex honesta, iusta, possibilis secundum naturam, secundum consuetudinem<br />
patriae, loco temporique conveniens, necessaria, utilis; manifesta<br />
quoque, ne aliquid per oscuritatem in captionem contineat; nullo privato<br />
commodo, sed pro communi utilitate civium scripta”. ISIDORO, Etymolo-
326 SEBASTIANO VIOTTI<br />
nella tradizione morale cattolica: “Sono da recensire come proprietà<br />
precipue della legge: l’onestà, la possibilità, la giustizia,<br />
l’utilità” 6 . Certo sono esigenze di spessore diverso, ma tutte significative<br />
e convergenti a qualificare una legge civile come buona<br />
legge, vera norma sociale.<br />
Nella convivenza politica, l’ordinamento giuridico non è un<br />
lusso o un optional, esso è necessario ed indispensabile quale<br />
supporto e condizione per il dipanarsi ordinato e concorde della<br />
vita sociale, poiché, se è vero che le varie relazioni sgorgano<br />
quasi spontaneamente dalla costitutiva dimensione sociale della<br />
persona, è altrettanto certo che il loro integrarsi armonico necessita<br />
di mediazioni. Le leggi sono la mediazione necessaria affinché<br />
“l’altro” possa essere riconosciuto nella sua fondamentale<br />
uguaglianza di dignità, possa essere effettivamente destinatario<br />
di giustizia e partner sociale: “Le leggi sono la struttura architettonica<br />
della comunità. La «comunità» [...] come tale si<br />
compone senza leggi, ma in seguito [...] esige le leggi per permettere<br />
ai suoi componenti - individui e gruppi - di coesistere e<br />
vivere ordinatamente” 7 . La necessità delle leggi è una logica e<br />
giarum, I, 10, 6 in J.P. MIGNE, Patrologiae cursus completus, serie latina, Garnier,<br />
Parigi 1844-64, 82, 203. Posizione che già san Tommaso riprende, affermando<br />
che Isidoro ha convenientemente posto le caratteristiche che la<br />
legge umana deve possedere. Cf. THOMAE, AQUINATIS, Summa Theologiae, I-II,<br />
95, 3.<br />
6<br />
M. ZALBA, Theologiae Moralis Compendium, BAC, Madrid 1958, voll. 2,<br />
I, 207. Confrontando le affermazioni di Isidoro e di Zalba si può notare che<br />
i manualisti non menzionano più tra le caratteristiche della legge “la chiarezza”,<br />
inoltre rapporteranno “possibilità” unicamente alle forze fisiche e<br />
morali della singola persona e non presteranno seria attenzione alla legalità<br />
o correttezza della procedura di emanazione della legge, non menzionabile<br />
da Isidoro per evidenti ragioni storiche, ma certamente da avvertire nella<br />
modernità.<br />
7<br />
R. SPIAZZI, Principi di Etica Sociale, ESD, Bologna 1990, 2^ ris., 100.<br />
La necessità dell’ordinamento giuridico e l’illustrazione della sua funzione<br />
sono un tema importante e ricorrente nel Magistero Sociale; paradigmatico<br />
al riguardo è quanto afferma Pio XII: “Affinché la vita sociale, quale è voluta<br />
da Dio, ottenga il suo scopo, è essenziale un ordinamento giuridico, che le<br />
serva di esterno appoggio, di riparo e protezione; ordinamento la cui funzione<br />
non è dominare, ma servire, tendere a sviluppare e accrescere la vitalità<br />
della società nella ricca molteplicità dei suoi scopi [...]. Un tale ordina-
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 327<br />
coerente conseguenza della naturale socialità dell’uomo e della<br />
naturalità della comunità politica: il concetto di legge è connaturato<br />
ai concetti di socialità umana e di comunità politica. Verità<br />
logica messa in luce e confermata anche dall’esperienza: la<br />
storia, infatti, testimonia come le norme sociali, consuetudinarie<br />
o scritte, abbiano sempre accompagnato e sostenuto l’esperienza<br />
socio-politica, la loro presenza è, infatti, attestata, in modo<br />
inequivocabile, anche nella vita associata dei popoli più antichi.<br />
La convivenza sociale, per essere ordinata ed armonica, ha<br />
dunque bisogno di leggi, ma solo nella misura adeguata, cioè il<br />
loro numero non deve essere insufficiente o smoderatamente<br />
moltiplicato. La mancanza di leggi o un loro numero insufficiente<br />
condannerebbe la convivenza alla legge della giungla, alla<br />
sopraffazione del più forte, ma una loro eccessiva proliferazione<br />
asfissierebbe e ingabbierebbe la vitalità della società, la<br />
snaturerebbe e ne sfigurerebbe il volto, riducendola all’immagine<br />
di una istituzione totale, la avvicinerebbe all’esperienza di un<br />
campo di concentramento. La libertà dei cittadini è un bene<br />
troppo prezioso perché il legislatore possa restringerla senza<br />
una vera necessità per il bene comune: “La «sottomissione» o<br />
consenso all’autorità politica non esige affatto che si sia disposti<br />
a lasciarsi privare senza necessità delle espressioni ragionevoli<br />
della libertà creativa o lasciarsi sovraccaricare di leggi inutili o<br />
non necessarie” 8 , per questo le leggi non devono essere moltiplicate<br />
e ognuna di essa deve rivestire un vero carattere di necessità<br />
per la comunità.<br />
La tradizione cattolica e le sane filosofie politiche, come<br />
concordano nel rivendicare la necessità dell’ordinamento giuridico,<br />
altrettanto fermamente e concordemente affermano che<br />
ogni singola legge deve rivestire un carattere di necessità o al-<br />
mento per garantire l’equilibrio, la sicurezza e l’armonia della società ha anche<br />
il potere di coercizione contro coloro, che solo per questa via possono essere<br />
trattenuti nella nobile disciplina della vita sociale; [...]. L’ordinamento<br />
giuridico ha inoltre l’alto e arduo scopo di assicurare gli armonici rapporti<br />
sia tra gli individui, sia tra le società, sia anche all’interno di queste”. PIO XII,<br />
Nuntius Radhiophonicus, 24.12.1942, nn. 10. 12 in R. SPIAZZI, I documenti<br />
sociali della Chiesa, Massimo, Milano 1988, 2^ ed., voll. 2, I, 459-61.<br />
8<br />
B. HÄRING, Liberi e fedeli in Cristo, Paoline, Cinisello Balsamo 1990, 4^<br />
ed., voll. 3, III, 443.
328 SEBASTIANO VIOTTI<br />
meno di utilità per la società, per il bene comune. Un primo assunto<br />
dunque: una legge è buona, se è necessaria.<br />
La legge è una determinazione che proviene dall’autorità politica,<br />
ma questa, nello Stato di Diritto, quali sono quasi tutti gli<br />
Stati contemporanei, non decide o governa a proprio piacimento<br />
o arbitrio, ma sub lege, vale a dire nell’ambito e secondo modalità<br />
prefissate dalla Costituzione o Carta Fondamentale, quale<br />
recezione basilare di valori condivisi per la convivenza e formulazione<br />
di un quadro procedurale generale, in cui sono delineati<br />
i diritti e doveri dei cittadini, le istituzioni e i poteri statuali, i loro<br />
reciproci ambiti e rapporti e i meccanismi secondo cui devono<br />
operare. Di più, nella forma democratica di Stato e di governo,<br />
propria ormai anch’essa della stragrande maggioranza degli<br />
Stati contemporanei, il potere politico trova la giustificazione<br />
prossima della sua esistenza e del suo operare nel consenso del<br />
corpo sociale: i governanti ricevono in affidamento dal popolo il<br />
mandato di governare, quali suoi rappresentanti ed interpreti,<br />
mandato che costituisce la giustificazione del loro potere e in<br />
pari tempo il suo limite. Certamente questo non implica di per<br />
sé che il vigore di una legge dipenda da un consenso o da un’accettazione<br />
formale o pratica di essa da parte della comunità 9 , ma<br />
questo non significa che non vi debba essere una corrispondenza<br />
tra quanto la legge prescrive e quanto nella coscienza sociale<br />
emerge e che le leggi non debbano essere emanate dall’autorità<br />
legittima, in coerenza con la Costituzione e secondo procedure<br />
previste. In caso contrario la sensibilità democratica ne sarebbe<br />
urtata. In democrazia, infatti, come già ho accennato, il potere è<br />
un potere consentito, che trova nel consenso del popolo, titolare<br />
naturale del potere, la sua radice prossima e il suo controllo,<br />
specialmente tramite le elezioni, quali scelta e revoca di persone<br />
e programmi; ne segue che anche le singole leggi, almeno indirettamente,<br />
sono al vaglio del popolo sia quanto alla loro legittimità<br />
che quanto alla loro legalità. Fattore che, senza dubbio,<br />
complica la soluzione del problema morale della legge civile, co-<br />
9<br />
“Necessitas acceptationis ex parte subitorum ut lex obliget nulla est<br />
per se”. M. ZALBA, Theologiae Moralis Compendium, BAC, Madrid 1958, voll.<br />
2, I, 243.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 329<br />
me emergerà meglio in seguito; infatti, la presenza, nel corpo sociale,<br />
di visioni etiche diverse, che emergono e vivacizzano un’opinione<br />
pubblica pluralista, non può non condizionare in qualche<br />
modo la formazione ed il dettato delle singole leggi.<br />
Legittimità dell’autorità e correttezza della procedura di<br />
emanazione sono dunque significative, anche se non in modo<br />
esclusivo, per definire la legittimità di una legge. Un secondo assunto<br />
dunque: una legge è buona se è valida o legale.<br />
Sembra lapalissiano affermare che una legge, poiché detta<br />
ai cittadini un comportamento, dovrebbe essere formulata chiaramente,<br />
in modo che quanto prescrive possa essere da essi facilmente<br />
compreso, almeno dalla stragrande maggioranza, e che<br />
l’obiettivo specifico in ordine al bene comune che con essa si<br />
persegue dovrebbe essere facilmente riconoscibile o individuabile<br />
dai cittadini 10 . Già Isidoro menzionava la necessità di chiarezza<br />
per la legge 11 , se essa è complicata e oscura per il linguaggio<br />
della formulazione, può trarre in inganno circa quanto effettivamente<br />
prescrive e diventa una trappola per il cittadino, se<br />
10<br />
Ho usato il condizionale in quanto l’aspettativa non sempre si realizza.<br />
E’ significativo che la Camera dei Deputati italiani abbia riscontrato la necessità<br />
di istituire una commissione ad hoc: rendere intelligibili i testi legislativi.<br />
Del resto è esperienza diffusa che la giurisprudenza deve ripetutamente<br />
intervenire per interpretare le leggi: ciò è una spia, un indice della non<br />
chiarezza di tante leggi. La “chiarezza” è una caratteristica non esplicitamente<br />
menzionata, come già ho notato, in buona parte dei manuali di Teologia<br />
Morale, anche se bisogna dire che il problema non è del tutto ignorato in<br />
quanto, ad esempio, Zalba menziona la facile e plurima modificazione del testo<br />
di una legge, che in una certa misura attiene al problema della chiarezza,<br />
tra le varie cause che giustificano e rendono plausibile la teoria delle leggi<br />
meramente penali, escamotage inventato dai moralisti del passato, in mancanza<br />
di altre soluzioni, per alleviare la coscienza dal gravame di troppe leggi:<br />
“Convenientia ipsa (che esistano leggi meramente penali ndr) nostris temporibus<br />
fortasse rationabilior apparet cum, neglectis a legislatore non raro<br />
rationibus moralibus, non ponderato adaequate bono communi secundum<br />
suam totalitatem et integritatem, iustitia distributiva et civium libertate insufficienter<br />
considerata, multiplicatis et saepe modificatis immoderate (corsivo<br />
mio) legibus, necessario hae amittunt nativam sanctitatem; tam in conscientia<br />
subditorum, quam in mente legislatorum”. M. ZALBA, o.c., I, 258.<br />
11<br />
“[...] manifesta quoque ne aliquid per oscuritatem in captionem contineat<br />
[...]”. Cf. sopra, nota 5.
330 SEBASTIANO VIOTTI<br />
l’obiettivo con essa perseguito non è chiaro e riconoscibile, può<br />
sorgere un dubbio circa la sua utilità. Un simile dubbio depaupera<br />
di significato la legge e la svisgorisce nella sua forza, rischiando<br />
di renderla addirittura “odiosa” agli occhi dei cittadini,<br />
e diventa quasi una premessa giustificatrice di un suo essere<br />
disattesa, che potrebbe anche travalicare in una disaffezione<br />
generale per le leggi. Mi pare indubbio che si debba affermare<br />
che anche la chiarezza della legge ha attinenza con la sua razionalità<br />
o giustizia; è questa un’esigenza unanimemente condivisa,<br />
ma purtroppo spesso è disattesa dal legislatore, in quanto<br />
non sempre il vero perché e significato di una legge è chiaro<br />
ai cittadini. Spesso poi le leggi sono formulate con un linguaggio<br />
astruso, la cui comprensione diventa affare degli addetti ai<br />
lavori ed inoltre determinate leggi sono facilmente e ripetutamente<br />
modificate ed integrate, per cui non è sempre agevole essere<br />
a conoscenza del testo in vigore. Un terzo assunto dunque:<br />
una legge è buona, se è chiara.<br />
Norma efficace<br />
La legge civile, già l’ho ricordato, è finalizzata ad ordinare la<br />
convivenza e quindi deve efficacemente incidere sul comportamento<br />
dei cittadini, infatti il potere dell’autorità politica non è<br />
un potere di proposta di valori e di ideali, o di consiglio e di guida<br />
dalla valenza pedagogico-educativa, ma è un potere impositivo<br />
in vista del raggiungimento del bene comune. Si può dire che<br />
la legge deve, in qualche misura, “costringere” i cittadini (pur<br />
non privandoli della libertà psicologica) ad assumere determinati<br />
comportamenti e compiere od omettere determinati atti; solo<br />
così essa può veramente adempiere la propria funzione. In altre<br />
parole essa deve effettivamente incidere sul tessuto sociale,<br />
ha necessità di essere efficace; proprio per questo abitualmente<br />
è integrata da una sanzione contro i trasgressori.<br />
La necessità che la legge sia efficace, nella riflessione di alcuni<br />
ambienti cattolici, è sottovalutata, probabilmente per il timore<br />
che efficacia ed efficienza diventino paravento di efficientismo<br />
o efficienza fine a se stessa, per giustificare un disattendere<br />
i valori da parte della stessa legge. Essa è invece sovradimensionata<br />
nella considerazione di taluni filoni laici, che non
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 331<br />
avvertono come spesso in tal modo si apra la strada per una resa<br />
al fattuale. Alcuni infatti, è un fatto innegabile, in nome dell’efficacia<br />
approdano a svuotare l’esigenza di razionalità o eticità<br />
inerente alla legge, accettando che il contenuto delle sue prescrizioni<br />
non sia che il frutto di opinioni mutevoli, in balia quindi<br />
degli umori e dell’emotività del momento, condannando così<br />
la legge ad essere unicamente imposizione o forza dei numeri,<br />
dicktat di una maggioranza. Ma, non riconoscere o trascurare<br />
l’esigenza dell’efficacia, è altrettanto innegabile, equivale ad ipotizzare<br />
la legge civile come indicazione o proposta di un ideale,<br />
anche affascinante, ma sovente confinabile nel libro dei sogni.<br />
L’efficacia o efficienza di una legge dipende dal radicamento<br />
che i valori da essa codificati hanno nella coscienza sociale,<br />
ossia dalla relazione tra quanto essa prescrive e i valori che<br />
emergono nel corpo sociale, nel concreto contesto socio-culturale,<br />
trova cioè il suo humus nella sensibilità morale del corpo<br />
sociale. La legge, per essere norma efficace, deve dunque essere<br />
adeguata al contesto, commisurarsi alla concreta realtà storica,<br />
come lo stesso Giovanni XXIII ricorda, quando afferma che, oltre<br />
ad essere in armonia con l’ordine morale, l’ordinamento giuridico<br />
deve essere rispondente al grado di maturità della comunità<br />
12 . In sostanza l’efficacia di una legge dipende dal suo saper<br />
contemperare o bilanciare e articolare l’immutabile con il contingente,<br />
i principi con la situazione, il dato oggettivo-veritativo<br />
con le percezioni comuni delle esigenze della giustizia (i contenuti<br />
concreti del bene comune) presenti in una determinata comunità<br />
politica. Efficacia della legge non è un suo piegarsi al puro<br />
dato fattuale, ma sinonimo di sano realismo, ossia prudente<br />
e sapiente interpretazione delle possibilità di incarnazione di un<br />
valore.<br />
L’esigenza di efficienza, ora messa in luce, mi pare rapportabile<br />
a quanto la tradizione morale cattolica ha costantemente<br />
insegnato: la legge deve essere possibile, poiché, se quanto essa<br />
12<br />
“Un ordinamento giuridico in armonia con l’ordine morale e rispondente<br />
al grado di maturità della comunità politica, di cui è espressione, costituisce,<br />
non è dubbio, un elemento fondamentale per l’attuazione del bene<br />
comune”. GIOVANNI XXIII, Pacem in terris, n. 29 in R. SPIAZZI, I documenti…<br />
cit., I, 751-2
332 SEBASTIANO VIOTTI<br />
prescrive non può essere osservato dai cittadini, la legge si rivela<br />
inutile per la convivenza, anzi è di danno. L’espressione tradizionale<br />
“deve essere possibile” è stata, abitualmente, quasi esclusivamente<br />
interpretata in riferimento alle possibilità o capacità<br />
fisico-psichiche della singola persona (possibile secondo la natura,<br />
nell’affermazione di Isidoro), ma, in virtù dell’analogia, si<br />
potrebbe intendere il “deve essere possibile” anche in riferimento<br />
al contesto socio-culturale, alla sensibilità morale del popolo,<br />
perché la persona-cittadino è un essere situato, e perciò condizionato,<br />
in un ben preciso contesto culturale, che gli offre possibilità<br />
ed insieme gli pone condizionamenti. Quest’interpretazione<br />
estensiva non mi pare arbitraria, si tratta di cogliere e sviluppare<br />
lo spunto offerto dall’affermazione di Isidoro: la legge deve<br />
essere “ […] possibile secondo il costume della patria, conveniente<br />
al tempo e al luogo […]” 13 , che san Tommaso riprende,<br />
spiegando come l’uomo, vivendo in società, non possa non risentire<br />
e non condividere il costume 14 , interpretazione a cui<br />
sembra alludere Häring, affermando che la legge: “[…] deve tener<br />
conto delle possibilità morali del popolo” 15 . Correlare l’efficacia<br />
di una legge alla sua possibilità nella cultura, che ispira e<br />
sorregge la vita di un popolo e quindi influisce e condiziona le<br />
espressioni, lo sviluppo e la maturazione della coscienza morale<br />
dei singoli e dell’insieme della comunità, significa riconoscere<br />
un dinamismo sociale ineludibile, ossia che primariamente sono<br />
i mores che influenzano l’ordinamento giuridico e non viceversa,<br />
sono i convincimenti del popolo che plasmano le legge e non il<br />
13<br />
“[...] possibilis [...], secundum patriae consuetudinem, loco temporique<br />
conveniens [...]”. Cf. sopra, nota 5.<br />
14<br />
“[…] Attenditur enim humana disciplina primum quidem quantum<br />
ad ordinem rationis, qui importatur in hoc quod dicitur iusta. Secundo,<br />
quantum ad facultatem agentium. Debet enim esse disciplinam conveniens<br />
unicuique secundum suam possibilitatem, obsevata etiam possibilitate naturae<br />
(non enim eadem sunt imponenda pueris, quae imponentur viris perfectis);<br />
et secundum humanam consuetudinem; non enim potest homo solus<br />
in societate vivere, aliis morem non agens. Tertio quantum ad debitas circunstantias,<br />
dicit, loco temporique conveniens. […]. THOMAE AQUINATIS, STh,<br />
I-II, 95, 3.<br />
15<br />
B. HÄRING, o.c., I, 441.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 333<br />
contrario. Tocca poi all’etica purificare ed elevare i costumi, questa<br />
elevazione a sua volta si rispecchierà in un affinamento della<br />
legislazione. Se è incontestabile l’adagio: ad impossibilia nemo<br />
tenetur, altrettanto incontestabile è un altro adagio: Quid lege sine<br />
moribus? Un dettame di legge non radicato e non supportato<br />
dalle convinzioni della coscienza sociale si rivela ben presto una<br />
fuga in avanti e risulta concretamente privo di efficacia; la legge<br />
cadrebbe in desuetudine e potrebbe anche rivelarsi dannosa.<br />
Queste considerazioni diventano ancor più rilevanti e significative<br />
se si avverte come, nelle società contemporanee, l’ordinamento<br />
giuridico non sia il frutto della riflessione e della decisione<br />
asettica di un legislatore solitario, ma sia il risultato di un<br />
dibattito e di un confronto tra visioni ideali diverse, se cioè si ha<br />
consapevolezza che il popolo in vari modi “partecipa” alla definizione<br />
di una legge. I valori significativi per la convivenza (le<br />
verità morali), infatti, passano al diritto, ricevono codificazione<br />
giuridica e forza sociale, attraverso un libero confronto intellettuale,<br />
un paziente dialogo di chiarificazione e di persuasione e<br />
l’azione di forze politiche diverse. Si deve affermare che vale per<br />
le leggi quanto è della politica in generale: “ Il riferimento dell’azione<br />
politica alla verità deve essere mediato dal libero confronto<br />
intellettuale in seno alla società, e i valori propri della verità<br />
fondante debbono essere resi operativi nell’ordine politico<br />
per via di consenso” 16 . La legge non può essere solo forza dei numeri,<br />
o espressione dell’opinione della maggioranza, poiché il<br />
consenso da solo non determina la giustizia o verità di una legge,<br />
ma tuttavia la codificazione giuridica di una esigenza di valore<br />
non può prescindere in assoluto dai convincimenti del corpo<br />
sociale. Una legge è dunque efficace se è una determinazione<br />
prudenziale dell’autorità, cioè un tradurre sapientemente e prudentemente<br />
in regole di convivenza quanto è compreso come<br />
esigenza per un corretto e ordinato vivere sociale: “ E’ compito<br />
della prudenza politica operare il congiungimento tra le esigenze<br />
proprie del tempo, dell’efficacia politica e delle forze in gioco,<br />
16<br />
A. ACERBI, Potere e sapere: la parabola dei loro rapporti nella teologia<br />
cattolica d’ottocento e novecento, in L. SARTORI / M. NICOLETTI (edd.), Teologia<br />
e Politica, EDB, Bologna 1991, 108.
334 SEBASTIANO VIOTTI<br />
con gli imperativi assoluti e non preteribili dell’ordine morale” 17 .<br />
Norma sociale efficace è dunque quella legge che codifica i valori<br />
nella misura in cui emergono alla coscienza sociale, che<br />
contempera la fedeltà a principi etici con un’intelligente attenzione<br />
ai dinamismi propri della vita sociale, che coniuga realisticamente<br />
valori e situazione concreta, che storicizza e dà forza<br />
coattiva alle esigenze della giustizia nella misura della loro<br />
possibile incarnazione. Efficacia significa per la legge evitare assolutizzazioni<br />
etiche, o fughe in avanti, che verrebbero a rendere<br />
impossibile un ordinamento, magari solo relativamente umano<br />
e giusto, ma che, nonostante la sua problematicità e i suoi limiti,<br />
viene ad esser meglio di nessun ordinamento, senza che<br />
tuttavia ciò significhi un suo arrendersi e arrestarsi alla pura fattualità,<br />
perché altrimenti scadrebbe a dominio, la legge non sarebbe<br />
più una forza finalizzata. Un quarto assunto dunque: una<br />
legge è buona, se è efficace.<br />
Norma giusta<br />
La legge civile è autentica norma sociale se è legge giusta, è<br />
questa la caratteristica o esigenza principale; siamo così al nodo<br />
cruciale e discriminante di tutta la questione. La tradizione cattolica,<br />
le varie filosofie politiche, i movimenti politici storici, l’opinione<br />
pubblica convergono nel riconoscere e asserire formalmente<br />
che la categoria “giustizia” è la discriminante per giudicare<br />
della bontà di una legge. La convinzione unanime, tuttavia,<br />
si disarticola e si frantuma quando si tratta di enucleare e tematizzare<br />
quali siano in concreto i contenuti che devono contraddistinguere<br />
una legge giusta, poiché le varie posizioni si diversificano<br />
in tanti rivoli sensibilmente divergenti, e spesso contrapposti,<br />
entrano cioè in gioco le diverse visioni etiche e scale di valori<br />
o sensibilità morali presenti nel corpo sociale, le diverse teorie<br />
sulla giustizia stessa e le concezioni, talora alternative, circa<br />
il significato stesso e lo scopo della convivenza politica. Il pluralismo<br />
si trasforma spesso in babele e talora decade a pretesto per<br />
17<br />
G. MATTAI, o.c., 68.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 335<br />
giustificare relativismo ed individualismi, piuttosto che essere<br />
opportunità di cogliere più compiutamente la verità. La delucidazione<br />
in concreto di che cosa significhi “legge giusta” è veramente<br />
il punto in cui la questione del rapporto tra morale e legge<br />
civile manifesta tutta la sua problematicità ed anche costituisce<br />
il pomo della discordia.<br />
Le varie interpretazioni dell’affermazione “ la legge deve essere<br />
giusta” possono, schematicamente e riassuntivamente, essere<br />
ricondotte a due poli significativamente contrapposti ed alternativi.<br />
La legge è giusta se si ispira ad una concezione sostanziale<br />
di giustizia, quale virtù che attribuisce ad ognuno il<br />
suo, e quindi riconosce la persona nella sua dignità e valore, la<br />
legge civile dunque va sottoposta ad un giudizio di valore o etico;<br />
la legge è giusta se si ispira ad una concezione procedurale<br />
di giustizia, se è emanata in modo corretto e in conformità ad alcuni<br />
presupposti di partenza concordati, la legge dunque va soltanto<br />
sottoposta ad un giudizio tecnico di validità, in questione<br />
è unicamente la correttezza della procedura della sua emanazione<br />
e la sua coerenza con l’insieme dell’ordinamento giuridico.<br />
Nel primo polo si riconoscono la tradizione morale cattolica, le<br />
filosofie personaliste che si ispirano al cattolicesimo ed alcune<br />
correnti umaniste, mentre nel secondo polo si riconoscono le varie<br />
concezioni di politica e di ordinamento giuridico che si ispirano<br />
al sociologismo e al positivismo giuridico, che fu teorizzato<br />
in modo radicale da Kelsen. Il filosofo austriaco, attivo nella<br />
prima metà del ’900, infatti, a partire dal suo relativismo filosofico<br />
(non è possibile, né è utile conoscere le verità e i valori assoluti),<br />
giunge ad affermare che il diritto deve prescindere da<br />
ogni considerazione di ideali e valori, esso non è che un sistema<br />
compiuto e coerente di norme, dove decisivo e qualificante è che<br />
esso sia in armonia con il maggior numero di soggetti. L’idea basilare<br />
è che l’ordinamento giuridico deve avere come unico referente<br />
la maggioranza delle opinioni, la giustizia della legge si radica<br />
nella forza dei numeri. L’agnosticismo filosofico ed il relativismo<br />
etico fondano l’assolutizzazione del positivismo giuridico:<br />
il diritto ha una totale autonomia e autogiustificazione, il sistema<br />
di norme della società ha il suo valore unicamente nella<br />
validità, nel rispetto di procedure o quadro istituzionale.<br />
La tradizione morale cattolica si pone a paladino della necessità<br />
che la legge civile sia giusta in senso sostanziale, cioè che
336 SEBASTIANO VIOTTI<br />
l’ordinamento giuridico riconosca e promuova dei valori autentici<br />
connessi alla verità della persona, vale a dire che quanto esso<br />
prescrive non misconosca o ferisca la dignità della persona e<br />
non contrasti con il bene comune, inteso come un bene-essere<br />
condiviso. Questa convinzione, che è un po’ il clou della riflessione<br />
cattolica sulla legge civile, già è espressa nel definire la legge<br />
civile “un ordinamento razionale”, dal momento che, quasi<br />
all’unanimità, i manualisti assumono come definizione specifica<br />
di legge civile la definizione di legge in genere posta da Tommaso:<br />
“ […] un ordinamento razionale in vista del bene comune,<br />
promulgato da chi ha cura della comunità” 18 . Convinzione che è<br />
sottolineata ulteriormente, affermando che la legge civile deve<br />
essere in armonia con l’ordine morale, da cui è evidenziato il valore<br />
ontologico e assiologico della persona, e che la legge civile<br />
deve rispettare ogni aspetto della giustizia 19 . Legge giusta è dunque<br />
quella che rispetta le esigenze della giustizia in senso lato,<br />
ossia quella che non prescrive qualche cosa che contrasti con il<br />
volere o bene divino, diversamente deve essere considerata legge<br />
disonesta (iniusta ex parte obiecti); e parimenti rispetta le esigenze<br />
della giustizia intesa in senso stretto, ossia non prescrive<br />
qualche cosa di contrario al bene umano, non contrasta cioè con<br />
il bene comune, diversamente deve essere considerata una legge<br />
ingiusta (iniusta ex parte finis), come già spiegava Tommaso 20 .<br />
18 THOMAE AQUINATIS, STh., I-II, 90, 4.<br />
19<br />
“Lex iusta est ea quae nulli iuri superiori nullique speciei iustititiae<br />
adversatur; quae scl. servat iustitiam: Legalem, nihil praescibendo quod ad<br />
bonum commune non conferat; distributivam, curando aequam proportionem<br />
in distribuendis oneribus et beneficiis inter subditos; commutativam,<br />
neque subditorum iura subiectiva violando neque limites potestatis trasgrediendo”<br />
. M. ZALBA, o.c., I, 208. Non deve meravigliare che tra le specie di<br />
giustizia non venga menzionata la giustizia sociale: ciò è spiegabile per la discussione,<br />
all’epoca ancora aperta, tra i teologi moralisti se la giustizia sociale<br />
dovesse essere considerata una specie di giustizia a se stante o una<br />
combinazione di esigenze della giustizia legale e della giustizia distributiva.<br />
20<br />
“Iniustae autem sunt leges dupliciter. Uno modo, per contrarietatem<br />
ad bonum humanum, e contrario praedictis: vel ex fine, sicut cum aliquis<br />
praesidens imponit onerosas subditis non pertinentes ad utilitatem communem<br />
[…]; vel etiam ex auctore, sicut cum aliquis fert legem ultra sibi commissam<br />
potestatem; vel etiam ex forma, puta cum inaequaliter onera multi-
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 337<br />
La mancanza di giustizia non solo rende la legge irrilevante per<br />
la coscienza, ma la fa scadere ad arbitrio, a danno per la convivenza<br />
e la stessa autorità che la pone in essere si svuota del suo<br />
significato e della sua funzione 21 .<br />
Tale convinzione viene poi rigorosamente giustificata e argomentata<br />
a partire dalla natura della filosofia, della scienza e<br />
dell’azione politica (progetto, programma e costruzione di una<br />
convivenza dal volto umano), dal significato e dal fine del diritto<br />
positivo (veicolo primo delle decisioni politiche in vista del<br />
bene della comunità) e dal fine stesso della convivenza sociale (il<br />
bene comune, che è un bene per la persona condiviso dai membri<br />
della comunità politica). Un progetto di una vita associata<br />
buona e la ricerca della sua realizzazione non possono astrarre<br />
da una considerazione di che cosa significhi il con-vivere umano,<br />
chiamano in causa una concezione di uomo, sottintendono<br />
cioè un’antropologia; la volontà di perseguire il bene comune<br />
della comunità, che è un bene per la persona, non può prescindere<br />
da una valutazione di ciò che è bene o male per la convivenza.<br />
Non è inoltre da trascurare il fatto che la politica, la formulazione<br />
delle leggi e la loro esecuzione sono attività umane e,<br />
come ogni altra attività umana, mettono in gioco la responsabilità<br />
della persona, il suo dovere di agire con senso. La politica e<br />
tudini dispensantur, etiam si ordinentur ad bonum commune. Et huiusmodi<br />
magis sunt violentiae quam leges […]. Unde tales leges non obligant in foro<br />
conscientiae: nisi forte propter vitandum scandalum, vel turbationem<br />
[…]. Alio modo leges possunt esse iniustae per contrarietatem ad bonum divinum:<br />
sicur leges tyrannorum inducentes ad idolatriam, vel ad quodcunque<br />
aliud quod sit contra legem divinam. Et tales leges nullo modo licet observare<br />
[…]”. THOMAE AQUINATIS, STh., I-II, 96, 4<br />
21<br />
“L’autorità, come si è detto, è postulata dall’ordine morale e deriva da<br />
Dio. Qualora pertanto le sue leggi o autorizzazioni siano in contrasto con<br />
quell’ordine, e quindi in contrasto con la volontà di Dio, esse non hanno alcuna<br />
forza di obbligare la coscienza […]; in tal caso, anzi, l’autorità cessa di<br />
essere tale e degenera in sopruso: «La legge umana in tanto è tale in quanto<br />
è conforme alla retta ragione e quindi deriva dalla legge eterna. Quando invece<br />
una legge è in contrasto con la ragione, la si denomina legge iniqua; in<br />
tal caso però cessa di essere legge e diviene piuttosto un atto di violenza»”.<br />
GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica Pacem in terris, 21b, in R. SPIAZZI, I docementi…<br />
cit., I, 745. Affermazioni riprese e citate da GIOVANNI PAOLO II, Lettera<br />
enciclica Evangelium Vitae, 70-73.
338 SEBASTIANO VIOTTI<br />
l’ordinamento giuridico non possono dunque essere solo una<br />
questione tecnica, di ingegneria costituzionale o di coerenza di<br />
sistema, ma prima ancora devono essere assoggettati ad un giudizio<br />
etico, in quanto toccano il regno dei fini e dei valori, che è<br />
campo di dominio dell’etica. Tra etica e politica e ordinamento<br />
giuridico c’è dunque un rapporto nativo, che costituisce e decide<br />
della verità stessa della politica e della legge civile: “La società,<br />
sia nel suo aspetto di vita sociale sia per l’ordinamento che<br />
la giustifica e la regola, non può disinteressarsi dell’etica. Il puro<br />
positivismo fattuale o giuridico introduce la società in un circolo<br />
vizioso, senza uscita e dominato in definitiva dal potere” 22 ,<br />
scindere la politica e la legge dall’etica non sarebbe a servizio<br />
dell’umanizzazione della vita sociale, ma causa di un suo imbarbarimento.<br />
Non costituisce un problema per i moralisti del passato spiegare<br />
quando concretamente la legge civile è giusta: se è coerente<br />
e congrua con la legge naturale da cui deriva e di cui è complemento<br />
23 . L’ordinamento giuridico è costituito norma di giustizia<br />
e regola sociale in virtù della sua connessione organica e<br />
derivata con la legge naturale, legge propria e prima dell’uomo:<br />
“Dotata di creatività giuridica, la legge naturale è la matrice di<br />
tutto lo ius che regola i rapporti umani nella formazione e nella<br />
vita della società; il primo germe dell’ordine giuridico” 24 . La gerarchizzazione<br />
dipendente con la legge naturale conferisce verità<br />
e nobiltà al diritto umano: “Nella legge naturale il diritto positivo<br />
trova la sorgente della sua forza vincolatrice e la giustificazione<br />
del suo potere sull’uomo, che, nella sua coscienza, sente<br />
di dover seguire l’impulso e il dettame di quella legge anche<br />
nella sua espressione societaria” 25 . Il percorso argomentativo dei<br />
manualisti si presenta semplice e lineare. La legge naturale è la<br />
legge primordiale della persona, regola di tutto il suo vivere e<br />
agire, quindi anche della vita sociale. Essa, tuttavia, presenta<br />
22<br />
M. VIDAL, Etica civile e società democratica, SEI, Torino 1992, 23.<br />
23<br />
“Lex humana est derivatio legis naturalis. […] Lex humana est complementum<br />
legis naturalis. […] Lex humana debet esse proportionata tum fini,<br />
tum legi naturali et divinae”. B.H. MERKELBACH, Summa Theologiae Moralis,<br />
Descleé de Brower, Bruges 1962, 11^ ed., voll. 3, I, 247-8.<br />
24<br />
R. SPIAZZI, Lineamenti di Etica Politica, ESD, Bologna 1989, 106.<br />
25<br />
ID., Principi di Etica Sociale, ESD, Bologna 1990, 1^ris., 106.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 339<br />
come un vuoto di normatività in riferimento alle situazioni concrete,<br />
parecchie questioni e problemi posti dal convivere politico<br />
non trovano immediatamente e direttamente una chiara e puntuale<br />
risposta o regolamentazione nelle sue determinazioni, poiché<br />
essa non contiene che principi o precetti generali e perciò indeterminati<br />
che, per di più, potrebbero anche essere ignorati da<br />
alcuni uomini. La regolamentazione della vita sociale non può<br />
pertanto essere unicamente affidata ai suoi dettami, significherebbe<br />
lasciare troppo spazio alle scelte ed opzioni individuali dei<br />
cittadini e non precisare a sufficienza la portata del comune intento<br />
che li deve animare e la fattiva collaborazione a cui sono<br />
chiamati, si rischierebbe così di compromettere l’efficace perseguimento<br />
del bene comune. Ne consegue pertanto che sono necessarie<br />
altre norme che colmino tale insufficienza della legge<br />
naturale, che ne specifichino ed integrino per via di deduzione o<br />
di enucleazione i principi indeterminati: ecco la legge civile.<br />
Il problema morale della legge civile trova nella posizione<br />
dei manualisti una soluzione compatta e armonica, che glissa<br />
difficoltà e tensioni nel rapporto tra ordine morale e ordine giuridico,<br />
illustra e salvaguarda molto positivamente il nesso tra le<br />
due grandezze, configurando quasi una simbiosi e omogeneità<br />
tra i due ordini, praticamente travasando il primo nel secondo.<br />
L’ordinamento giuridico trova il suo fondamento, la sua giustificazione<br />
e valenza nella connessione derivata da un ordinamento<br />
meta-positivo; il rapporto armonico tra etica e legge civile<br />
è garantito da un processo logico-deduttivo, da una applicazione<br />
al concreto di imperativi e precetti perenni, ossia da un<br />
passaggio dall’universale al particolare, dall’indeterminato allo<br />
specifico. Il carattere di giustizia della legge civile è insomma affidato<br />
alla correttezza di un sillogismo. La soluzione non è, però,<br />
del tutto adeguata, poiché non sembra prendere adeguatamente<br />
in considerazione la distinzione o autonomia della legge civile<br />
rispetto all’etica, perché lascia una zona d’ombra sulle peculiarità<br />
del diritto positivo, che risulta unicamente un corollario e<br />
un’appendice (espressione societaria, secondo la locuzione di<br />
Spiazzi) della legge naturale, quale passaggio da proposizioni<br />
generali a norme più concrete e specifiche. Esso è cioè ricondotto<br />
ad un’opzione puramente tecnica che, come esplicitazione<br />
di superiori esigenze esplicite o implicite, approda a norme più<br />
particolareggiate per dare vigore e attuazione concreta a detta-
340 SEBASTIANO VIOTTI<br />
mi indeterminati e generali. Non sarebbe dunque altro che una<br />
codificazione giuridico-positiva che concretizza, esplicita e conferma<br />
indicazioni superiori ed immutabili, favorendone in tal<br />
modo anche una conoscenza più puntuale e rafforzandone l’incisività<br />
con la coazione e la sanzione. Gli stessi manualisti, del<br />
resto, parzialmente avvertono l’inadeguatezza della loro posizione<br />
ed esplicitamente affermano che la legge civile non può sanzionare<br />
tutti gli atti di tutte le virtù, né può proibire tutti i vizi;<br />
tentano perciò un recupero della distinzione tra diritto e morale<br />
tramite il concetto di legge permittente: “Può essere onesta una<br />
legge che non punisca certi mali, anzi che positivamente, senza<br />
tuttavia una formale approvazione, li permetta” 26 . La morale è<br />
indicazione di una verità e di un dovere da cui non si può derogare,<br />
il diritto positivo, invece, stante la sua debolezza 27 , può tollerare,<br />
nel senso di limitare regolamentandolo circoscrittivamente,<br />
un qualche male per salvaguardare un bene maggiore<br />
della convivenza. Diventa però problema, che suscita vivaci discussioni,<br />
il precisare quali mali o vizi possano essere tollerati,<br />
tanto che Fuchs ne conclude: “ è cosa di cui non raramente è assai<br />
difficile prudentemente giudicare” 28 .<br />
La soluzione dei manualisti presenta poi un ulteriore e rilevante<br />
aspetto di problematicità a causa dell’ambiguità sottintesa<br />
nella loro interpretazione del concetto di legge naturale. Essi assumono<br />
la definizione di legge naturale di Tommaso: “[...] partecipazione<br />
della legge eterna nella creatura razionale” 29 , ma<br />
26<br />
H. VERMEERSCH, Theologiae Moralis. Principia-responsa-consilia. Gregoriana,<br />
Roma 1933-7, 3^ ed., voll.4, I, 148. Dalla precisazione del concetto<br />
di legge permittente si può arguire che in senso stretto legge disonesta è<br />
quella che impone un qualche comportamento direttamente contrario all’ordine<br />
morale, ossia un’azione intrinsecamente illecita ed anche quella che<br />
non prevede la possibilità dell’obiezione di coscienza per evitare una cooperazione<br />
ad una male, tollerato dalla legge, che un altro intende compiere.<br />
27<br />
Cf. THOMAE AQUINATIS, STh., I-II, 96, 2 cf. anche Ibidem, I-II, 96, 2, ad 2.<br />
28<br />
J. FUCHS, Theologiae Moralis Generalis. Prima Pars., PUG, Roma 1963,<br />
2^ed., 114.<br />
29<br />
“Inter cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae<br />
providentiae subiacet, in quantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi<br />
ipsi et aliis. Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem<br />
inclinationem ad debitum finem et actum. Et talis participatio legis
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 341<br />
mentre l’Aquinate sembra intenderla come un lumen insitum,<br />
capacità di cogliere ed interpretare le inclinazioni naturali generiche<br />
e specifiche dell’essere che è l’uomo e di formulare un progetto<br />
di vita adeguato, i manualisti invece, oscurando parzialmente<br />
il pensiero tommasiano, sembrano pensarla come un<br />
elenco organico e disponibile ad ogni uomo di principi già formulati,<br />
riconducibile ad una lettura scientifica della natura<br />
umana. Dalla conoscenza dell’uomo, in altre parole, si ricaverebbe<br />
immediatamente un complesso organico e formulato di<br />
principi etici, quasi che la creazione portasse in sé le istruzioni<br />
per l’uso; le strutture dell’uomo, espressione della volontà creatrice<br />
di Dio, sarebbero contemporaneamente direttamente ribaltabili<br />
in volontà etica divina, come se nelle strutture bio-psichiche<br />
fossero anche impressi i precetti per il comportamento dell’uomo,<br />
precetti che, per la loro genesi, devono essere ritenuti assoluti<br />
ed immutabili, universalmente condivisibili. La legge civile<br />
non sarebbe altro che una specificazione e un complemento<br />
di tali principi indeterminati. L’interpretazione dei manualisti<br />
della comune espressione “la legge naturale è scritta nel cuore<br />
dell’uomo” è in parte falsante, conducendo, per esprimermi con<br />
parole di Maritain, a: “rappresentarci la legge naturale come un<br />
codice del tutto avvolto nella coscienza di ciascuno e che ciascuno<br />
non ha che a svolgere e del quale tutti gli uomini dovrebbero<br />
avere un’eguale conoscenza” 30 . Inoltre essa denuncia un ulteriore<br />
aspetto di problematicità in quanto suppone che la natura<br />
dell’uomo sia oggettivamente, pienamente e univocamente<br />
descrivibile e che sia del tutto statica, mentre in realtà l’uomo è<br />
insieme natura e cultura, la storicità entra del definire la persona,<br />
che si sperimenta come un essere non esaustivamente definibile<br />
a priori, che si comprende progressivamente, e inoltre<br />
ogni concettualizzazione è culturalmente condizionata.<br />
aeternae in rationali creatura lex naturalis dicitur. […] quasi lumen rationis<br />
naturalis, quo discernimus quid sit bonum et malum, quod petinet ad naturalem<br />
legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in nobis. Unde patet<br />
quod lex naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternae in rationali<br />
creatura”. THOMAE AQUINATIS, STh., I-II, 91, 2 cf. anche ID., Summa<br />
contra Gentiles, III, 113-114.<br />
30<br />
J. MARITAIN, I diritti dell’uomo e la legge naturale, Vita e Pensiero, Milano<br />
1979, 1^ ris., 57-58.
342 SEBASTIANO VIOTTI<br />
Chiavacci puntualizza la questione ricordando che occorre<br />
porre una distinzione tra legge naturale come legge indita o<br />
scritta nel cuore e legge naturale come formulazione espressa di<br />
principi:<br />
“[…] la legge naturale è in primo luogo la stessa capacità<br />
dell’uomo di riflettere su se stesso, di ragionare sul proprio fine,<br />
sulla propria vocazione, sul significato della propria esistenza, e<br />
così stabilire quei criteri valutativi e quelle considerazioni di fatto<br />
in base ai quali scoprire la norma per la situazione concreta.<br />
[…] Primo principio, esperienza di valori, condizioni oggettive<br />
esterne sono le tre componenti che la ragione del singolo deve<br />
combinare insieme per trarne la norma operativa concreta: Ogni<br />
creatura razionale è capace di questo: le tre componenti sopraddette,<br />
e la ragione che le combina e le confronta, costituiscono la<br />
possibilità concreta di conoscere la chiamata di Dio, e – prese insieme<br />
– possono chiamarsi ‘legge naturale’ all’interno del singolo:<br />
Questa legge naturale è non-scritta né scrivibile: essa è piuttosto<br />
‘indita’.<br />
[…] capacità (di ragionare ndr) che si esercita sempre all’interno<br />
di un gruppo […] all’interno di una storia […]. Nasce così<br />
una riflessione dei gruppi – e dell’intera famiglia umana – sull’uomo<br />
e il suo significato, i cui risultati possono ben chiamarsi<br />
‘legge naturale’. Ma in questo caso, a differenza del precedente,<br />
la legge naturale deve essere detta o scritta […] la legge naturale<br />
‘scritta’ è sempre sussidiaria e subordinata alla legge naturale<br />
‘presente nel cuore’ […]” 31 .<br />
Non bisogna infine dimenticare che la categoria “legge naturale”<br />
incontra un rifiuto, o almeno diffidenza, in molte correnti<br />
culturali, critiche verso il concetto stesso o verso l’interpretazione<br />
di esso prodotta dai manualisti, per cui oggi non appare<br />
uno strumento adeguato per un dialogo etico alla ricerca di<br />
una fondazione condivisa del rapporto tra etica e legge civile.<br />
I teologi post-conciliari, animati da un sincero intento di<br />
dialogo etico in generale con la cultura contemporanea, caldeg-<br />
31<br />
E. CHIAVACCI, Teologia Morale, Cittadella, Assisi 1986, 4^ ed., voll. 4, I,<br />
164-8.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 343<br />
giato dal Concilio: “ Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono<br />
agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo<br />
verità numerosi problemi morali, che sorgono nella vita<br />
privata quanto in quella sociale” 32 , e desiderosi, nel contesto specifico<br />
del problema morale della legge civile 33 , di trovare una<br />
piattaforma etica condivisa da porre come base e guida per una<br />
convivenza umana e come fermento di giustizia per l’ordinamento<br />
giuridico, preso atto delle difficoltà connesse alla soluzione<br />
dei manualisti, tentano un approccio diverso alla questione.<br />
Operano, dapprima, una chiarificazione e purificazione del<br />
concetto di legge naturale, come già si nota nelle espressioni di<br />
Chiavacci, antecedentemente citate. Essa non viene più intesa<br />
come un insieme di principi espressi, da cui dedurre conseguenze<br />
operative per la vita sociale, ma come capacità di rettamente<br />
cogliere (la recta ratio, espressione dei migliori autori della<br />
Scolastica) 34 le esigenze fondamentali della vocazione umana<br />
a partire da alcune intuizioni di senso, riconducibili alle incli-<br />
32 CONCILIO ECUMENICO, VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et<br />
spes, 16b in R. SPIAZZI, I documenti… cit., I, 822.<br />
33<br />
La riflessione sul problema morale della legge civile, infatti, e i moralisti<br />
post-conciliari se ne mostrano consapevoli ed attenti, non è esclusiva<br />
della tradizione cattolica. Essa fin dall’antichità ha accompagnato le migliori<br />
filosofie politiche e, proprio sul versante laico, è diventata una questione<br />
più impellente e drammatica per le coscienze in questo ultimo scorcio di secolo,<br />
a seguito delle esperienze tragiche dei totalitarismi e delle guerre mondiali<br />
con i loro orrori, in cui più evidenti e macroscopiche sono apparse le<br />
conseguenze nefaste di una concezione della legge civile come puro comando,<br />
puro atto di una positiva volontà umana.<br />
34<br />
Già Leone XIII riprendeva questa locuzione, affermando: “ […] la legge<br />
naturale […] non essendo altro che la stessa ragione, che ci comanda di<br />
fare il bene, e proibisce di fare il male […]”. LEONE XIII, Lettera enciclica Libertas<br />
praestantissimum, 6a in R. SPIAZZI, I documenti… cit., I, 65. Giovanni<br />
Paolo II, rifacendosi all’insegnamento del venerato predecessore ricorda che<br />
la legge naturale non è altro che il riflesso nell’uomo dello splendore del volto<br />
di Dio, che ha voluto costituire la ragione umana interprete della ragione<br />
divina, in modo che l’uomo avesse l’inclinazione al fine e all’atto dovuti. Citando<br />
Tommaso, afferma: la legge naturale “[…] altro non è che la luce dell’intelligenza<br />
infusa in noi da Dio. Grazie ad essa conosciamo ciò che si deve<br />
compiere e ciò che si deve evitare: Questa luce e questa legge Dio l’ha donata<br />
nella creazione. […] mediante la ragione […] Dio chiama l’uomo a partecipare<br />
della sua provvidenza, volendo per mezzo dell’uomo stesso, ossia at-
344 SEBASTIANO VIOTTI<br />
nazioni naturali dell’uomo. La ragione umana è capace di scoprire<br />
e formulare un ordine, secondo il quale la volontà deve agire<br />
per raggiungere i fini necessari dell’essere umano. La legge<br />
naturale, come ricorda Aranguren, in quanto non data interamente,<br />
ma inscritta, si pone così come principio euristico, come<br />
impulso per la ricerca della verità e giustizia della convivenza,<br />
diventando richiamo ad un’attenzione vigile perché la legge civile<br />
abbia contenuti razionali o etici:<br />
“Il diritto naturale deve essere considerato, perché non sia<br />
unilateralmente reazionario né unilateralmente rivoluzionario,<br />
come un puro principio di significazione e di valore euristici, come<br />
impulso verso un bene sempre «cercato», come un concetto<br />
più intenzionale e funzionale che materiale, e, infine, come dialettico<br />
ed essenzialmente problematico […]” 35 .<br />
Quale impulso ad una tensione, che deve inerire al diritto<br />
umano, ad incarnare in regole per la convivenza l’esperienza<br />
morale e intuizione fondamentale “ fa il bene, evita il male”, unica<br />
categoria veramente trasculturale 36 , la legge naturale assolve<br />
così una duplice funzione nei confronti della legge civile: ispirazione<br />
e verifica, giustificazione e limitazione. In altre parole l’ideale,<br />
rappresentato dalla legge naturale, lancia una continua<br />
sfida al reale: ciò che deve essere si pone davanti a ciò che è e gli<br />
addita il cammino futuro. Il diritto umano è dunque significativo<br />
per la convivenza se i suoi dettami si ispirano, si armonizzano,<br />
convergono, incarnano al meglio possibile nel contesto sto-<br />
traverso la sua ragionevole e responsabile cura, guidare il mondo: non soltanto<br />
il mondo della natura, ma anche quello delle persone umane”. GIOVAN-<br />
NI PAOLO II, Lettera enciclica Veritatis Splendor, 40.43 in AA. VV., Lettera enciclica<br />
Veritatis Splendor del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, Libreria<br />
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, 59. 62.<br />
35 ARANGUREN, Etica e Politica, Morcelliana, Brescia 1966, 27.<br />
36<br />
“La sola conoscenza pratica che tutti gli uomini hanno naturalmente<br />
ed infallibilmente in comune è che bisogna fare il bene ed evitare il male. E’<br />
questo il preambolo e il principio della legge naturale […]”. J. MARITAIN, o.c.,<br />
58. “[…] postulare un’unità di vocazione e di significato di tutti gli esseri<br />
umani non vuol dire necessariamente che questa vocazione sia descrivibile<br />
o già descritta in acconce proposizioni”. E. CHIAVACCI, o.c., I, 170.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 345<br />
rico concreto le indicazioni primordiali per vivere con senso che<br />
provengono dalla legge naturale. Sono dunque due le strade seguite<br />
dai teologi moralisti per illustrare il nesso tra legge naturale<br />
e legge civile o tra ordine morale e ordine giuridico: derivazione<br />
e ispirazione o convergenza, come sono due i modi di pensare<br />
il rapporto tra etica e politica:<br />
“Col primo metodo viene comunicato al politico un dettagliato<br />
codice normativo strutturato entro un sistema dottrinale,<br />
mettendone in evidenza le rigorosità scientifiche e la sua imperiosità<br />
invariabile. Il politico ha il dovere di aderire agli elencati<br />
principi morali, cercando di applicare rigorosamente [...]. Un secondo<br />
metodo preferisce sollecitare il politico a osservare direttamente<br />
la realtà sociale nella sua concretezza storica, a riflettervi<br />
sopra per cogliere all’interno di essa quale sia il comportamento<br />
moralmente più benefico. E’ un osservare nei dettagli le situazioni<br />
cogliendo i valori in esse strutturati come in filigrana [...]” 37 .<br />
Parlare di derivazione significa supporre che il legislatore<br />
“riceve” un elenco di principi da completare e specificare con le<br />
sue disposizioni (è il pensiero dei manualisti), esprimersi in termini<br />
di ispirazione e convergenza significa che il legislatore è<br />
chiamato a intelligentemente discernere la situazione e le possibilità<br />
che essa offre di incarnare giuridicamente le esigenze di<br />
valore, benefiche per la convivenza, legate alle intuizioni morali<br />
fondamentali dell’uomo, ed è la convinzione dei teologi postconciliari.<br />
La volontà di dialogo e di intesa induce gli autori post-conciliari<br />
ad un ulteriore passo di avvicinamento alla categoria ed al<br />
linguaggio propri della modernità per fondare l’eticità della legge<br />
civile. Essi assumono la categoria dei Diritti Umani, espressione<br />
fenomenologica della convinzione comune circa la dignità<br />
ontologica e assiologica della persona, riconosciuta titolare di<br />
diritti originari, inviolabili ed inalienabili, che devono essere tutelati<br />
e promossi, come esigenze etiche impreteribili e criteri essenziali<br />
che devono stare a base della convivenza umana e ad<br />
37<br />
T. GOFFI, “Un metodo per la formazione morale del politico”, RTM 81<br />
(1989), 41.
346 SEBASTIANO VIOTTI<br />
ispirazione e limite per la legge civile 38 . Reinterpretano e rifondono<br />
il discorso della tradizione morale cattolica nel tema dei<br />
Diritti Umani. La Dichiarazione dei Diritti Umani viene ritenuta<br />
come “l’emergere almeno di un embrione di esperienza morale<br />
comune a tutta l’umanità” 39 , quali convinzioni etiche quasi universalmente<br />
condivise: “[...] già il tema dei diritti dell’uomo come<br />
è venuto a configurarsi nel dopoguerra [...] costituisce di fatto<br />
una piattaforma di finalità comuni in cui hanno potuto convergere<br />
uomini e gruppi con storie culturali e filosofiche, religioni,<br />
sistemi sociali diversi fra loro” 40 e quindi può essere assunta<br />
come base etica condivisa che deve ispirare e giustificare<br />
la razionalità della legge civile:<br />
“I diritti della persona - che le autorità politiche devono rispettare,<br />
onorare e promuovere - quali sono stati proclamati nel<br />
1948 e in seguito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, contengono<br />
una buona piattaforma di partenza nella quale le grandi<br />
religioni e gli umanisti autentici di ogni Paese possono incontrarsi<br />
e definire perlomeno alcuni principi fondamentali di politica.<br />
Il punto di partenza in ogni questione è una concezione dell’esistenza<br />
umana come un insieme di rapporti Io-Tu-Noi” 41 .<br />
I Diritti Umani, benché diversamente fondati e giustificati<br />
dalle diverse famiglie religiose e filosofiche, emergono come un<br />
plesso etico condiviso, per questo è logico pensare che gli uomini<br />
possano concordare, e di fatto ciò avviene, nel considerarli come<br />
una piattaforma normativa-funzionale per un’etica socio-politica<br />
condivisa, per un progetto di convivenza politica significativa,<br />
per dare legittimità ad un’esperienza sociale e alle leggi:<br />
“Affinché l’uso dei potere possa essere razionale, bisogna che gli<br />
38<br />
Il tema del rispetto dei Diritti Umani da parte dell’autorità e degli ordinamenti<br />
giuridici è un tema centrale , e talmente insistito, nel Magistero<br />
sociale di Giovanni Paolo II da apparire superfluo l’indicare specificamente<br />
delle referenze; esso poi è la linea su cui si muove la maggior parte dei moralisti<br />
nel discorso sul sociale.<br />
39<br />
E. CHIAVACCI, o.c., II, 219.<br />
40<br />
ID., o.c., III/2, 281-2.<br />
41<br />
B. HÄRING, o.c., I, 434-5.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 347<br />
scopi siano chiari e giusti e che nel ricorso ai mezzi si rispettino<br />
i diritti umani e i diritti fondamentali e la con-divisione della libertà,<br />
senza la quale il bene comune della città secolare non può<br />
essere sostenuto” 42 . Essi rappresentano idee di giustizia che per<br />
trasformarsi in norme, per diventare effettive, necessitano di un<br />
riconoscimento politico e di una protezione giuridica. Sono “dati<br />
nativi” dell’uomo, fondamentalmente gli stessi in ogni tempo<br />
e in ogni luogo, inalienabili ed inviolabili, perché inscritti nello<br />
statuto ontologico della persona, pur avendo una dinamica interna<br />
di sviluppo e di approfondimento in una loro progressiva<br />
scoperta e comprensione del significato. Il loro rispetto e la loro<br />
promozione, la realizzazione delle loro potenzialità sono fattore<br />
propulsore dell’incivilimento della convivenza sociale ed insieme<br />
sono in relazione alla maturazione della coscienza sociale.<br />
Le legge civile non interviene a fondare o definire tali diritti, non<br />
ne ha la capacità, né è suo compito, ma interviene ad interpretare<br />
e delineare le modalità o forme storiche della loro attuazione;<br />
i valori sono dati una volta per sempre, ma le regole che li<br />
traducono operativamente vanno individuate e ridefinite di volta<br />
in volta nel contesto. La legge civile è dunque giusta, è un ordinamento<br />
razionale per il bene comune della convivenza, ha<br />
uno spessore etico o di giustizia se tende effettivamente a riconoscere,<br />
rispettare e promuovere i Diritti Umani: in questo consiste<br />
la connessione tra ordine morale e ordine giuridico.<br />
I Diritti Umani vengono così a costituire quel plafond condiviso<br />
di valori, quel minimo-massimo etico, come si esprimono<br />
gli autori, irrinunciabile e condiviso, da difendere e promuovere,<br />
il patrimonio etico da porre a base di una convivenza umana<br />
pacifica e solidale, a cui la legge civile, finalizzata al perseguimento<br />
del bene comune, è chiamata a dare concreta tutela giuridica<br />
e possibilità di esercizio ed espressione, minimo-massimo<br />
che “[…] segna il livello di accettazione morale della società al di<br />
sotto del quale non può collocarsi alcun progetto sociale valido”<br />
43 . L’ordinamento giuridico dunque contribuisce a rianimare<br />
una società malata e a moralizzare la vita sociale, se si fa carico,<br />
42<br />
ID., o.c., III, 451.<br />
43<br />
M. VIDAL, o.c. 10 cf. pure A. CORTINA, Ética sin moral, Tecnos, Madrid<br />
1995, 3^ed., e ID., Ética civil y religión, PPC, Madrid 1995.
348 SEBASTIANO VIOTTI<br />
con sano realismo, di tali esigenze etiche possibili e condivise<br />
dai vari progetti umani presenti in una società libera, democratica<br />
e pluralista. La politica e il diritto umano sfuggono così alla<br />
sempre incombente tentazione del pragmatismo e dell’utilitarismo,<br />
vengono riscattati dal non senso, dall’insita tendenza a<br />
diventare ricerca e gestione del potere e dominio, per assumere<br />
il loro vero volto di empirismo sapienziale:<br />
“[...] potremmo indicare la politica come attività per la quale<br />
l’uomo, dinanzi al fatto acquisito di un’organizzazione statale<br />
della vita collettiva, impegna la propria riflessione e valuta le forme<br />
del proprio intervento per rendere più umane le strutture, ossia<br />
per richiamarle alla loro vocazione di servizio all’uomo. [...]<br />
La politica è dettata da un sentire sapienziale che per mantenere<br />
la propria dinamica rifugge dal segnare l’ambito della propria<br />
autonomia quanto dall’assumere su di sé il compito e il significato<br />
finale dell’uomo. Empirismo perché concreto umanesimo<br />
rivolto all’uomo come esso si presenta nella pluralità dei suoi interessi<br />
concreti. Sapienziale perché sensibile ai valori senza per<br />
questo assumersi la responsabilità o la pretesa di una loro deduzione<br />
metafisica. Sapienziale anche perché tiene conto dell’uomo<br />
reale che ha la passione dell’unità, pur nelle deficienze dei<br />
suo agire. La sapienza impedisce al politico di ridurre l’uomo alla<br />
«realtà effettuale», come pure di lavorare per una città tutta<br />
armoniosa della tradizione utopica” 44 .<br />
Questo minimo-massimo etico o convergenza etica, condizione<br />
necessaria per il dipanarsi di una convivenza umana pacifica,<br />
nel rispetto delle varie concezioni religiose e morali presenti<br />
all’interno di una società pluralista, ha trovato, per opera<br />
di alcuni autori contemporanei, specie di lingua spagnola, una<br />
teorizzazione in una figura etica: l’Etica Civile o etica dei cittadini.<br />
Questa consisterebbe in un complesso di valori, sia pure diversamente<br />
fondati e giustificati nelle varie e distinte concezioni<br />
dell’uomo e della storia, espressioni del legittimo pluralismo<br />
44<br />
A. RIGOBELLO, L’identità morale della politica tra calcolo e profezia, in<br />
A. LOBATO, Coscienza e responsabilità politica, ESD, Bologna 1990, 150-1.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 349<br />
all’interno della società, condivisibili e condivisi dai cittadini su<br />
cui si può, e si deve, costruire una convivenza ordinata e giusta.<br />
Vidal le assegna il compito attribuito in passato alla legge naturale,<br />
affermando che il suo ruolo è quello di: “fornire una «giustificazione<br />
morale della convivenza pluralistica e democratica»”<br />
45 , svolgendo una triplice funzione:<br />
“[…] 1) mantenere lo spirito etico (la capacità di «protesta»<br />
e di «utopia») all’interno della società e della civiltà nelle quali le<br />
ragioni «strumentali» hanno sempre più importanza, mentre diminuiscono<br />
le domande sui fini e significati ultimi dell’esistenza<br />
umana; 2) unire i diversi gruppi e le differenti opzioni creando<br />
un campo di gioco neutrale affinché, nell’ambito del necessario<br />
pluralismo, collaborino tutti per elevare la società verso livelli<br />
sempre più alti di umanizzazione; 3) screditare eticamente quei<br />
gruppi e quei progetti che non rispettano il minimo morale comune<br />
postulato dalla coscienza etica generale” 46 .<br />
Sorge non usa l’espressione “ Etica civile”, molto probabilmente<br />
per evitare anche solo ombre semantiche, per non correre<br />
cioè il rischio che denominare Etica Civile il nucleo etico su<br />
cui converge il consenso possa essere inteso come sostegno alla<br />
teoria dell’Etica del discorso o Etica consensuale (proprio per<br />
questo altri autori preferiscono usare l’espressione: consenso sociale<br />
in materia etica), ma la sua proposta è molto simile. Egli<br />
ritiene che si possa riscattare la politica e ridare senso alla convivenza<br />
sociale solo a partire da “una grammatica etica comune”,<br />
che dovrebbe ispirare e innervare naturalmente anche l’ordinamento<br />
giuridico:<br />
“Nessun progetto politico, nessuna proposta sociale si può<br />
elaborare, né tanto meno si può tradurre in pratica o trasformare<br />
in «programma politico», se manca il fondamento di una cultura<br />
politica comune. A sua volta, non è possibile convergere in<br />
una medesima cultura politica, se non c’è un comune sentire<br />
45<br />
M. VIDAL, o.c., 17.<br />
46<br />
Ibidem, 21.
350 SEBASTIANO VIOTTI<br />
morale, cioè se la maggioranza dei cittadini non è d’accordo su<br />
alcuni principi e valori etici fondamentali” 47 .<br />
A suo giudizio, tali valori etici fondamentali e impreteribili<br />
si riversano in alcuni principi basilari, del resto già comunemente<br />
riconosciuti: principio personalista o primato della persona,<br />
che, in quanto titolare di diritti nativi ed inviolabili, deve<br />
essere il soggetto, il fine e fondamento di tutta la vita economico-politica;<br />
principio di sussidiarietà o rispetto dell’autonomia e<br />
responsabilità della persona e delle varie formazioni sociali;<br />
principio di solidarietà o riconoscimento che la persona è chiamata<br />
a realizzarsi nella reciprocità e nella solidarietà; principio<br />
del bene comune, bene-essere o qualità di vita veramente umana,<br />
bene indivisibile e da condividere da tutti i cittadini, quale fine<br />
che dà senso alla convivenza politica. Sono principi, afferma<br />
ancora, conformi a retta ragione e quindi accessibili a tutti gli<br />
uomini di buona volontà, presenti nel vangelo e da esso illuminati,<br />
cosicché la fede può svolgere un ruolo di sostegno e purificazione<br />
del comune sentire morale.<br />
Parrebbe dunque che il dialogo sul problema morale della<br />
legge civile abbia trovato una soluzione anche nella modernità:<br />
la legge civile è giusta se rispetta i Diritti Umani, se si fa carico<br />
di un comune sentire morale (Etica civile, grammatica etica comune)…<br />
le difficoltà sembrerebbero dunque sciolte, ma in realtà<br />
non è così, come evidenziano le discussioni accennate in apertura<br />
di queste riflessioni e come è esperienza di tutti. Probabilmente<br />
si tratta solo, anche se è già significativo, di aver individuato<br />
una via percorribile per arrivare ad una soluzione condivisa,<br />
un terreno d’intesa da cui partire. La convergenza etica comune,<br />
infatti, spesso si arresta alle formulazioni di principio, alle<br />
dichiarazioni formali dei diritti; quando poi si tratta o di tematizzare<br />
la portata concreta di tali diritti o la loro gerarchizzazione,<br />
in non pochi casi, si evidenziano divergenze significative,<br />
ascrivibili alle diverse fondazioni dei diritti stessi, al bagaglio<br />
delle diverse concezioni del pianeta “uomo” e alle differenziate<br />
cosmovisioni morali che stanno a monte. Il problema morale<br />
47<br />
B. SORGE, Per una civiltà dell’amore, Queriniana, Brescia 1996, 115.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 351<br />
della legge civile dunque rimane, in larga misura, una sfida che<br />
il XX secolo lascia in eredità.<br />
La legge civile come un compromesso<br />
La ricognizione svolta ha evidenziato come siano numerosi<br />
i fattori che formano la fisionomia della legge civile e come la<br />
bontà o giustizia dell’ordinamento giuridico consista nella sua<br />
capacità di operare una loro armonica ed equilibrata sintesi, in<br />
altre parole la razionalità della legge civile sta nel suo sapiente<br />
bilanciare due esigenze ineludibili: esigenza di senso o fedeltà a<br />
dei valori ed esigenza di realismo o attenzione ed intelligente interpretazione<br />
della situazione. Le leggi civili devono, infatti,<br />
esprimere un comportamento sociale razionale in una situazione<br />
storica dalla fluidità estrema; non possono ignorare le esigenze<br />
della giustizia, ma neppure possono astrarre dal contesto<br />
socio-culturale. Il diritto umano non può non presentarsi come<br />
un’espressione reale dell’ideale etico della virtù della giustizia,<br />
ma sarà sempre ed unicamente una sua espressione parziale,<br />
perché, nei confronti dell’ideale di giustizia, ha comunque<br />
un’imperfezione strutturale, non può codificarne esaustivamente<br />
tutte le esigenze, sia perché è una realtà temporale e quindi<br />
imperfetta, sia perché non può non risentire del marchio della<br />
debolezza e della colpa insito nell’esperienza umana, sia perché<br />
ogni formulazione è culturalmente e storicamente condizionata.<br />
Le leggi civili tuttavia devono essere formulazioni, pur nella loro<br />
provvisorietà e apertura al futuro, di vere esigenze di giustizia,<br />
anche se mai pienamente adeguate, il rapporto stesso tra etica<br />
e ordine giuridico, infatti, è costituito da comunanza e insieme<br />
da distinzione:<br />
“Queste distinzioni e comunanze non seguono una logica<br />
sempre comune e parallela, bensì esse si ridisegnano in ogni caso<br />
concreto secondo modalità diverse. Se si volesse esprimere la<br />
complessità di queste multiformi relazioni tra diritto e morale<br />
con figure geometriche evocatrici si dovrebbe far dunque riferimento<br />
non tanto alla figura dei due cerchi separati, ancor meno<br />
a quella dei cerchi concentrici, quanto piuttosto alla figura emblematica<br />
di due ellissi che hanno in comune un «fuoco» […]
352 SEBASTIANO VIOTTI<br />
Dialetticamente non si dà diritto senza ricorso alla figura di un<br />
accordo su valori etici accettati, e d’altra parte questo universo<br />
di valori etici diventa reale quando una comunità accetta di renderli<br />
visibili e vincolanti” 48 .<br />
Non è pensabile che tra etica e ordinamento giuridico vi<br />
possa essere una simbiosi o un’omogeneità e coestensione, tra le<br />
due grandezze vi è un rapporto dialettico, quale intreccio di riferimento<br />
o connessione e di distanza o diversità:<br />
“La legge e la morale non sono né identiche né separate:<br />
stanno invece in un rapporto di polarità. La legge dovrebbe servire<br />
l’autorealizzarsi degli individui in reciprocità e solidarietà<br />
sociale. I cittadini, i legislatori e gli amministratori politici hanno<br />
una responsabilità morale in ordine a una buona legislazione<br />
e all’applicazione corretta di leggi buone. Ma sarebbe un’illusione<br />
nefasta sognare di formare una società perfetta cercando di<br />
sanzionare quasi tutto il campo della morale e della buona condotta<br />
con il codice penale” 49 .<br />
Tale raccordo sta in un equilibrio, mai posseduto una volta<br />
per sempre, ma fluido e ridefinibile, frutto della ricerca, che non<br />
può conoscere stanchezza e soste, in un bilanciamento sapiente<br />
tra le esigenze assolute del bene, della loro tutela e riconoscimento<br />
e le possibilità offerte dalla convivenza umana segnata da<br />
pluralità di posizioni e punti di vista (che talora sembrano inconfrontabili<br />
e irriducibili), da limiti e colpe.<br />
La legge civile dunque è un ordinamento razionale nella misura<br />
in cui si fa carico di obiettive esigenze di valore e di esigenze<br />
di realismo (mediante un’intelligente lettura delle possibilità<br />
offerte dalla situazione), se contempera cioè principi di giustizia<br />
ed efficacia; in altre parole la giustizia del diritto positivo<br />
si rivela come un punto di incontro, come una mediazione, operata<br />
dalla prudenza 50 , tra un ideale di convivenza e la possibilità<br />
48<br />
A. BONDOLFI, Diritto e Morale, in L. LORENZETTI (ed.), Trattato di Etica<br />
Teologica, EDB, Bologna 1992, 2^ ed., voll. 3, I, 413.<br />
49<br />
B. HÄRING, o.c., III, 456.<br />
50<br />
“E’ compito della prudenza politica operare il congiungimento tra le
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 353<br />
concreta di attuazione di esso o intelligente e prudenziale adattamento<br />
di principi perenni. La razionalità di una legge sta nel<br />
suo essere incarnazione nella misura del meglio possibile, attraverso<br />
la codificazione giuridica e la sanzione sociale, di esigenze<br />
di giustizia, in una tensione effettiva e dinamica verso “l’ideale<br />
etico impossibile” di una convivenza giusta, quale cammino di<br />
avvicinamento graduale ed instancabile ad un’incarnazione<br />
sempre più adeguata, che può avanzare e affinarsi in relazione<br />
al maturare della coscienza sociale, luogo storico-culturale dove<br />
emergono e sono riconosciuti i valori, dove costumi e riflessione<br />
etica si confrontano.<br />
L’identità della legge civile dunque, mi pare, si può rappresentare,<br />
mutuando le espressioni da Häring 51 , con le categorie di<br />
approssimazione non statica e autosoddisfatta e compromesso<br />
prudente, efficiente e aperto.<br />
La legge civile è approssimazione ad un ideale di giustizia,<br />
ove approssimazione non è sinonimo di arbitrarietà, pressapochismo<br />
o accondiscendenza al relativismo, ma avvicinamento<br />
graduale ed instancabile verso l’ideale in relazione alle opportunità<br />
presenti. Potrà essere una formulazione non perfettamente<br />
adeguata, da ascrivere al limite che segna l’esperienza umana, e<br />
provvisoria, ma pur sempre valida sul momento e aperta ad una<br />
possibile e ricercata migliore formulazione futura.<br />
La legge civile risulta come un compromesso, espressione<br />
da intendere non come negoziazione di quanto non è negoziabile,<br />
ma come interpretazione che fa vivere il valore nel contesto,<br />
quale mediazione tra poli diversi (ideale, possibilità reali) e<br />
frutto di dialogo tra prospettive diverse, quale riconoscimento,<br />
nella misura possibile nel contesto, di un ideale che continua<br />
sempre a trascendere la legge, perché è un paradigma che non<br />
è mai esauribile e non è mai racchiudibile in una formulazione:<br />
“[…] il compromesso politico e legislativo si configura quale<br />
mezzo con cui tradurre e vivere, pur nel rispetto della coscienza<br />
di ciascuno, alcuni impreteribili principi o diritti inviolabili<br />
esigenze proprie del tempo, dell’efficacia politica e delle forze in gioco, con<br />
gli imperativi assoluti e non preteribili dell’ordine morale”. G. MATTAI, o.c.,<br />
50.<br />
51<br />
Cf. B. HÄRING, o.c., I, 406-7.
354 SEBASTIANO VIOTTI<br />
dell’uomo […]” 52 . Compromesso aperto fra l’ideale e la concreta<br />
possibilità della situazione (frutto della prudenza che muove<br />
a proteggere e promuovere il bene comune in un mondo malvagio),<br />
perché porta in sé e riconosce l’esigenza di ulteriori<br />
avanzamenti, di un affinamento della legge. Compromesso prudente<br />
sul grado di pace e giustizia, che in un mondo segnato dal<br />
peccato si riesce a tutelare e difendere; storicizzazione e codificazione<br />
giuridica di quel minimo-massimo di valori di giustizia<br />
e correttezza nei comportamenti sociali, che la coscienza sociale<br />
riconosce come ciò da cui non si può prescindere per una<br />
convivenza razionale e ordinata. Compromesso efficiente, finalizzato<br />
alla necessità di garantire efficacemente alcune mete<br />
concrete e alcuni obiettivi comuni.<br />
Il problema morale della legge civile è dunque un problema<br />
avvertito, un problema che stimola una riflessione in cui i limiti<br />
di una prospettiva di soluzione inadeguata ed inaccettabile (legge<br />
giusta = legge correttamente emanata) sono ormai chiaramente<br />
denunciati, cosicché essa perde quota. Un embrione di intesa,<br />
quale pista per un dialogo da sviluppare, è stato rinvenuto<br />
nell’affermazione formale che la legge è giusta se rispetta i Diritti<br />
Umani. Rimane, tuttavia, da compiere un notevole lavoro<br />
culturale, si tratta di proseguire e di intensificare un dialogo rispettoso<br />
delle varie posizioni di partenza, un dialogo senza posizioni<br />
preconcette o riserve mentali per dare ai Diritti Umani<br />
una fondazione adeguata e condivisa, che li metta al riparo da<br />
interpretazioni riduttive (una loro fondazione unicamente nell’emergere<br />
storico è insufficiente e labile, facilmente degenerabile<br />
in fraintendimenti della loro assolutezza e dei loro contenuti).<br />
Un dialogo, affinché la loro proclamazione non resti una<br />
bandiera o si riduca a pura retorica (le dichiarazioni formali non<br />
trovano automaticamente un loro inveramento nelle situazioni<br />
concrete), affinché l’interpretazione dei loro contenuti sia purificata<br />
dalle incrostazioni dell’ideologia individualista e borghese,<br />
in cui storicamente si affermarono, e maturi sempre di più la<br />
convinzione che essi non sono una creazione o una concessione<br />
della legge positiva, ma che la precedono e la giudicano. Tutto<br />
52<br />
E. TREVISI, Coscienza morale e obbedienza civile, EDB, Bologna, 184.
IL PROBLEMA MORALE DELLA LEGGE CIVILE 355<br />
ciò significa che è ancora necessario proseguire a co-riflettere<br />
per conseguire una più puntuale, compiuta e condivisa idea di<br />
uomo, del significato dell’affermazione che l’uomo è persona e a<br />
interrogarsi ulteriormente sul significato e fine della vita associata.<br />
Il problema morale della legge civile rimane dunque ancora<br />
una sfida, ma non irrisolvibile anche per un’epoca e per una società<br />
caratterizzate dalla mancanza di evidenze etiche comuni e<br />
dalla crescente complessità delle esperienze morali. Sarebbe<br />
una iattura che le difficoltà e la complessità arrestassero una ricerca<br />
ed un dialogo, anche se problematici, faticosi e dai tempi<br />
lunghi, ed inducessero ad arrendersi passivamente, subendo la<br />
mera fattualità, sarebbe non aver fiducia nell’intelligenza umana,<br />
che è capace di verità, e nella sete del bene propria dell’essere<br />
umano.<br />
Via Padana Inferiore, 21<br />
10023 Chieri (TO)<br />
Italy<br />
SEBASTIANO VIOTTI<br />
—————<br />
Summary / Resumen<br />
The moral problem of the civil law (the relationship between ethics<br />
and juridical order) continues in that the various aspects, both of value<br />
and of procedure, which enter into defining a social norm as just are<br />
given a different weighting and evaluation. Harmonizing and reconciling<br />
the needs of a good life in community with the perceptions of such<br />
that are present in the social conscience marked by historicity and<br />
diverse cultures is no easy matter in our pluralistic and complex societies.<br />
Human right can only be a partial incarnation of the needs of value<br />
and of justice, as an approximation or a gradual and untiring approach<br />
to the ethical ideal or prudent compromise which, being efficient<br />
and open, tempers principles and realism. Human rights remain a still<br />
usable basis for dialogue insofar as they are a shared complex of ethical<br />
normativity: there remain, however, the differences to be overcome<br />
which are evident when the formal declarations or those of principle<br />
have to be translated into concrete rules for living together.
356 SEBASTIANO VIOTTI<br />
El problema moral de la ley civil (la relación entre ética y orden jurídico)<br />
continúa cuando varios aspectos tanto de valor como de procedimiento<br />
entran a definir como justa una norma social y adquieren un<br />
significado y valoración diferentes. No es fácil para nuestras pluralistas<br />
y complejas sociedades armonizar y reconciliar las exigencias de una<br />
vida honesta en comunidad con su percepción presente en la conciencia<br />
social marcada por la historia y las diversas culturas. El derecho<br />
humano no puede ser más que una encarnación parcial de las exigencias<br />
de valor y de justicia, como aproximación o acercamiento gradual<br />
e incansable al ideal ético o compromiso prudente que, siendo eficaz y<br />
abierto, modera principios y realismo. Los derechos humanos siguen<br />
siendo aún una base utilizable para el diálogo mientras sean un complejo<br />
compartido de normatividad ética: subsisten, sin embargo, diferencias<br />
evidentes que tienen que superarse, cuando las declaraciones<br />
formales o de principio tienen que plasmarse en reglas concretas de<br />
convivencia.<br />
—————<br />
The author is an invited Professor at the Alphonsian Academy.<br />
El autor es profesor invitado en la Academia Alfonsiana.<br />
—————
357<br />
StMor 37 (1999) 357-370<br />
JOSEF RÖMELT<br />
THEOLOGISCHE ETHIK<br />
UND IN-VITRO-FERTILISATION<br />
Die Techniken der Sterilitätstherapie entwickeln sich mit<br />
rasantem Tempo weiter. Intratubarer Gametentransfer (gamete<br />
intrafallopian transfer, GIFT), In-Vitro-Fertilisation (IVF) mit<br />
anschließendem Embryonentransfer (ET), intratubarer Zygotentransfer<br />
(zygote intrafallopian transfer, ZIFT),<br />
intracytoplasmatische Sameninjektion (ICSI) und<br />
Präimplantationsdiagnostik (PID) bzw. genetische Diagnostik<br />
vor der Implantation (Preimplantation Genetic Diagnosis, PGD)<br />
stehen für die mittlerweile breit gefächerten Möglichkeiten der<br />
Hilfe. Während dabei die ICSI als erfolgreiche Erweiterung<br />
möglicher Überwindung von Sterilitätsursachen zu sehen ist -<br />
durch die Anwendung dieser Methode wird eine Samenzelle des<br />
Mannes unmittelbar in die Eizelle durch Injektion eingebracht,<br />
so daß nun auch schwere Störungen männlicher Fruchtbarkeit<br />
überbrückt werden können 1 -, so führen die diagnostischen<br />
Verfahren vor der Implantation eines in vitro befruchteten Eies<br />
die IVF in neue Anwendungsbereiche. Die Möglichkeit,<br />
menschliche Prokreation nicht nur über psychische oder<br />
physische Fertilitätsprobleme hinweg zu ermöglichen, sondern<br />
zugleich auch auf ihre genetische “Korrektheit” hin zu prüfen,<br />
wie das innerhalb der künstlichen Befruchtung außerhalb des<br />
1<br />
1997 wurden 15365 Behandlungen dieser Art in der BRD durchgeführt.<br />
Dem stehen 9902 Behandlungen nach der herkömmlichen Form der<br />
IVF (Befruchtung in vitro mit dem aufbereiteten Samen des Mannes)<br />
gegenüber. Diese letztere Technik steht vor allem zur Verfügung, wenn die<br />
Ursachen für die Sterilität eines Paares auf seiten der Frau liegen (diverse<br />
Eileiterdefekte etc.). Vgl. J. Reiter, Problematische Eigendynamik.<br />
Fortpflanzungsmedizin 20 Jahre nach dem ersten Retortenbaby, in: HerKorr<br />
52 (1998) 407-412.
358 JOSEF RÖMELT<br />
Mutterleibes durch genetische Tests am erzeugten Embryo vor<br />
seiner Einführung in den Mutterleib möglich ist, macht die<br />
Techniken der IVF auch für sogenannte Risikopaare interessant:<br />
Menschen, die Träger einer genetisch vererbbaren Krankheit<br />
sind - sei es dominant oder auch nur rezessiv - könnten sich nun<br />
- obwohl sie ohne technische Hilfe ein Kind haben können - der<br />
In-vitro-Fertilisation und der Präimplantationsdiagnostik<br />
bedienen, um angstfrei ein Kind zeugen zu lassen und austragen<br />
zu können, das mit Hilfe bestimmter Testverfahren zumindest<br />
weniger wahrscheinlich den bestimmten genetischen Defekt<br />
übernommen hat 2 . In-vitro-Fertilisation wird so zu einer<br />
medizinischen Technik, die in den vielfältigen Risiken und<br />
Nöten menschlicher Fortpflanzung eine immer gewichtigere<br />
Aufgabe erhält, um Probleme zu überbrücken und zu lindern,<br />
aber auch um Belastungen zu erkennen und zu “meiden”.<br />
Angesichts solcher Tendenzen scheint auch innerhalb der<br />
katholischen Moraltheologie der Diskussionsbedarf über die<br />
ethische Legitimität dieser Techniken zu steigen. Auch wenn die<br />
Probleme der Sterilität (ca. 15% der Paare) und der genetisch<br />
bedingten Erbkrankheiten weit weniger Menschen betreffen, so<br />
darf die Kirche sicherlich nicht ein zweites Mal (nach der<br />
Enzyklika “Humanae vitae”) gerade in den so sensiblen<br />
Bereichen der Sexualität und Fortpflanzung in die Gefahr<br />
kommen, hilfreiche medinzinische Interventionen auf Grund<br />
moralischer Bedenken zu ängstlich zu blockieren. Aber es<br />
bedarf auch einer sachgerechten und offenen Bewertung, die<br />
den Bedürfnissen des Menschen und den ethischen Werten, die<br />
auf dem Spiel stehen, wirklich Rechnung zu tragen versucht.<br />
2<br />
Das heißt, alle in vitro erzeugten Embryonen werden auf das entsprechende<br />
genetische Merkmal hin untersucht. Bei positivem Befund wird<br />
der jeweilige Embryo “verworfen”. Nur unauffällige Befunde erlauben die<br />
Implantation. Bei dem heutigen Stand der prä-, intra- und<br />
postkonzeptionalen Präimplantationsdiagnosen bedarf es freilich auch nach<br />
der Implantation einer nochmaligen Pränataldiagnostik, um Testfehler aus<br />
der Phase vor der Einnistung und mögliche Veränderungen in den nach dem<br />
Test liegenden Entwicklungsphasen des Embryos zu erfassen.
THEOLOGISCHE ETHIK UND IN-VITRO-FERTILISATION 359<br />
1) Eine wachsende moraltheologische Pluralität in der ethischen<br />
Bewertung der IVF<br />
Zu Beginn der Entwicklung rangierte im Zentrum der<br />
Auseinandersetzung mit der modernen Technik für die<br />
Theologie das Argument, daß das Zugrundegehen menschlichen<br />
Lebens in frühesten Stadien durch die IVF in Kauf genommen<br />
werde. In diesem Sinne gab mit Hinweis auf die große Zahl an<br />
Follikelpunktionen und Befruchtungen in vitro, die aber<br />
schließlich begrenzte Erfolgsrate der Behandlungen im Sinne<br />
tatsächlich gelingender Schwangerschaften und Geburten Klaus<br />
Demmer 1987 noch zu bedenken: “Der Mensch provoziert [mit<br />
der Technik der IVF] künstlich ein Risiko, das notwendigerweise<br />
mit tödlichem Ausgang, der vorhergesehen wurde, verbunden<br />
ist. Dann läßt sich allerdings der Frage nicht ausweichen, ob der<br />
sehnliche Kinderwunsch eines sonst unfruchtbaren Paares<br />
Grund genug ist, ein solches Risiko hervorzurufen.” 3 Die<br />
modernen Erfolge der IVF liegen heute ein wenig höher als zu<br />
Beginn der Anwendung des Verfahrens (ca. 15% erfolgreiche<br />
Schwangerschaften pro Behandlungszyklus), bleiben damit aber<br />
immer noch unterhalb der natürlichen Fertilitätsrate. Dennoch<br />
bemüht sich heutige theologische Reflexion, Argumente für eine<br />
moralische Legitimierung der IVF zu finden, die den Verlust von<br />
menschlichem Leben in frühesten Stadien damit zu<br />
rechtfertigen versucht, daß auch die Natur offenbar in dieser<br />
Entwicklungsphase mit der menschlichen Zygote äußerst<br />
verschwenderisch umgeht, daß demgegenüber aber mit der<br />
künstlichen Befruchtungsmethode der IVF gerade um die<br />
Zeugung eines Kindes gerungen wird, welches ansonsten mit<br />
Sicherheit nicht auf die Welt kommen könnte: “Die anfänglichen<br />
therapeutischen Mißerfolge bei den Befruchtungsversuchen im<br />
Rahmen der IVF lassen sich” im Sinne solcher Überlegungen<br />
“mit den Prinzipien der ‘Handlung mit Doppelwirkung’ und der<br />
‘Verschwendung in der Natur’ ethisch rechtfertigen.” 4 Mit<br />
3<br />
K. Demmer, Leben in Menschenhand. Grundlagen des bioethischen<br />
Gesprächs (Studien zur theologischen Ethik 23). Freiburg i.Ue. 1987, 90.<br />
4<br />
J. Gründel, Art.: In-vitro-Fertilisation. III. Ethisch, in: LThK 5 ( 3 1996)<br />
576.
360 JOSEF RÖMELT<br />
diesem Gedanken nähert sich theologische Ethik einem<br />
Konzept, das zwar die prinzipielle Schutzwürdigkeit<br />
embryonalen menschlichen Lebens gegenüber bloßem<br />
Sachmaterial und nicht-menschlichen Feten nicht in Frage<br />
stellt, aber ähnlich nicht-theologischen Deutungen des<br />
moralischen Status des menschlichen Embryos dem<br />
menschlichem Leben in seinen frühesten Entwicklungsstadien<br />
nur eine Schutzwürdigkeit zuerkennt, die im Konfliktfall mit<br />
anderen moralischen Gütern (nicht nur im Sinne einer<br />
medizinisch-vitalen Indikation) in Konflikt geraten kann.<br />
Suchen nicht-theologische Theorien die eigentliche ethische<br />
Abwägung in den verschiedenen möglichen Konfliktsituationen<br />
menschlicher Fortpflanzung dadurch zu entlasten, daß sie die<br />
moralischen Rechte des heranreifenden Menschen gleichsam<br />
depotenzieren und reduzieren 5 , so spricht theologische Ethik bei<br />
der IVF von Kriterien der Rechtfertigung, die wohl die ethische<br />
Kompromißhaftigkeit menschlichen Handelns im Auge behält.<br />
Der Hinweis auf die Handlungen mit Doppelwirkung bei der<br />
Rechtfertigung des in Kauf genommenen Verlustes<br />
menschlicher Embryonen im Rahmen der IVF läßt die<br />
5<br />
Für die verschiedenen Entwicklungsstadien des Menschen (Eizelle in<br />
statu fertilisandi, Zygote [Präembryo], Embryo, Fetus) werden<br />
Differenzierungen in bezug auf das Lebensrecht des Embryos in<br />
Konfliktfällen vorgenommen: durch Unterscheidung zwischen dem durch<br />
das deutsche Embryonenschutzgesetz auch dem Embryo zugesprochenen<br />
Begriff der Menschenwürde als Gattungsbegriff auf der einen Seite und als<br />
(für alle ausgetragenen und geborenen Menschen geltenendem)<br />
individuellem Personbegriff auf der anderen (vgl. D. Birnbacher, Gefährdet<br />
die moderne Reproduktionsmedizin die menschliche Würde?, in: A. Leist<br />
[Hg.], Um Leben und Tod. Moralische Probleme bei Abtreibung, künstlicher<br />
Befruchtung, Euthanasie und Selbstmord [stw 846]. Frankfurt 2 1990, 266-<br />
281), durch Ergänzung des Potentialitätsarguments mit Gradualitätsargumenten<br />
im Sinne erst potientieller Handlungsfähigkeit (K. Steigleder, The<br />
moral significance of potential persons, in: E. Hildt/D. Mieth [Hg.], In Vitro<br />
Fertilization in the 1990s. Towards a Medical, Social and Ethical Evaluation.<br />
Aldershot 1998, 239-246) oder durch epigenetische, philosophisch<br />
begründete Stufenmodelle (Einnistung als Beginn auch leiblich fundierter<br />
Individualität, Ausbildung neurologischer Strukturen als Beginn der<br />
Schmerzempfindlichkeit, Ausbildung organischer Strukturen [Neocortex]<br />
als Besitz physiologischer Grundlagen selbstbewußten Daseins etc.).
THEOLOGISCHE ETHIK UND IN-VITRO-FERTILISATION 361<br />
Komplexheit menschlichen Handelns anklingen 6 . Aber das Bild<br />
von der Verschwendung der Natur dient in der Vorbereitung<br />
moralischer Bewertung der IVF offenbar dazu, von der übertriebenen<br />
Vorstellung zu befreien, daß im Verlauf menschlicher<br />
Intervention in den Lebensbeginn und technischer Manipulation<br />
nur ja auch nicht eine der befruchteten Eizellen<br />
verlorengehen dürfe.<br />
Dieses Argument erscheint gegenüber den differenzierten<br />
modernen moralphilosophischen und moraltheologischen<br />
Überlegungen in bezug auf den moralischen Status auch des<br />
frühen menschlichen Embryos global und grob, aber man kann<br />
sich seinem Gewicht kaum entziehen. Auch theologische<br />
Interpretation wird mit ihrer Deutung einer notwendigen<br />
Einbeziehung der menschlichen Zygote vom Beginn der<br />
Befruchtung an in den Schutz menschlicher Würde und<br />
menschlichen Lebens kaum pauschal behaupten wollen, “daß<br />
angesichts einer über 50% liegenden natürlichen Abortrate vor<br />
der Implantation wirkliche menschliche Personen mit einer<br />
unsterblichen Seele sich nicht über die ersten undifferenzierten<br />
Stadien des Lebens hinaus entwickeln” 7 .<br />
Hier liegt wohl der Grund, daß auch theologisch-ethische<br />
Reflexion beginnt, sich an der Kasuistik zu beteiligen, mit der<br />
die moderne Technik der In-vitro-Fertilisation und der<br />
verschiedenen Diagnosemöglichkeiten vor der Implantation der<br />
künstlich gezeugten Embryonen von seiten der philosophischethischen<br />
Reflexion begleitet wird. Bei der theologischen<br />
Bewertung spielen allerdings zentrale ethische Werte der<br />
moraltheologischen Tradition eine Rolle: Der theologischethischen<br />
Beurteilung der IVF geht es über den angemessenen<br />
Lebensschutz hinaus um die sozialen Rahmenbedingungen<br />
auch der künstlichen Fortpflanzung im Sinne des Schutzes der<br />
6<br />
Ähnlich etwa den tragischen Konflikten indirekter Tötung von Feten,<br />
um das Leben der Mutter zu retten, wie sie in der traditionellen Moraltheologie<br />
heftig diskutiert wurden.<br />
7<br />
H.-M. Sass, Hirntod und Hirnleben, in: Ders. (Hg.), Medizin und<br />
Ethik. Stuttgart 1989, 160-183; hier: 179.
362 JOSEF RÖMELT<br />
Ehe, um die Abwehr von genetisch-manipulativen Zugriffen auf<br />
den menschlichen Embryo, von Selektion des Geschlechtes oder<br />
anderen Eigenschaften usw. So werden IVF im heterologen<br />
System, Klonen, Kryokonservierung, Reduzierung von<br />
Mehrlingsschwangerschaften, Leihmutterschaft, Etablierung<br />
der IVF als “medizinisch routinemäßig empfohlenes<br />
Zeugungsverfahren” 8 - Verfahren und Techniken, die alle im<br />
Schlepptau von IVF mit ihren verschiedenen Spielarten folgen -<br />
abgelehnt. Theologisch positive ethische Wertung der In-vitro-<br />
Fertilisation beschränkt sich in diesem Sinne letztlich lediglich<br />
auf die medizinische Hilfe für ein verheiratetes Paar, bei der der<br />
Frau im Rahmen der Sterilitätstherapie die (in der BRD)<br />
gesetzlich erlaubten drei künstlich gezeugten Embryonen in einem<br />
Fruchtbarkeitszyklus eingepflanzt werden, ohne daß bei<br />
Mehrlingsschwangerschaften eine Reduktion oder bei pränatal<br />
festgestellter Behinderung eine Abtreibung vorgenommen<br />
werden dürfte. “IVF oder GIFT [gemeint ist hier offenbar ZIFT]<br />
lassen sich homolog zwischen Ehepartnern ethisch<br />
verantworten, wenn sie recht motiviert sind und keine<br />
Vernichtung von Embryonen mit einschließen.” 9<br />
8<br />
K. Hilpert, Art.: In-vitro-Fertilisation, in: Lexikon der Bioethik 2<br />
(1998), 295-297; hier: 296.<br />
9<br />
J. Gründel, Art.: In-vitro-Fertilisation. III. Ethisch, 575. Gründel<br />
betont in diesem Sinne: “Menschliches Leben bedarf von seinem Beginn an<br />
der Achtung und des Schutzes. Angesichts der differenzierten Entwicklung<br />
menschlichen Lebens muß mit wachsender Einsicht in die biologischen<br />
Abläufe auch sein Schutz verstärkt werden.” (Ebd.) Der Artikel von K.<br />
Hilpert im Lexikon der Bioethik scheint diese Wertung freilich nur noch als<br />
allgemeinen gesellschaftlichen Standard bei “sparsamer Anwendung der<br />
IVF” festhalten zu wollen, demgegenüber im Einzelfall aber viele<br />
Ausnahmen “diskutierbar” sind: heterologe IVF bei einer Wahrscheinlichkeit,<br />
“dass Eltern eine für das auf normalem Wege gezeugte Kind<br />
schwerste Erbkrankheit weitergeben würden”, Leih- oder<br />
Ersatzmutterschaft aus “seltenen rein altruistischen Motivationen ...<br />
(denkbar am ehesten innerhalb ein und derselben Familie)”. K. Hilpert, Art.:<br />
In-vitro-Fertilisation, 296.
THEOLOGISCHE ETHIK UND IN-VITRO-FERTILISATION 363<br />
2) Die vielen ungelösten ethischen Probleme der modernen Techniken<br />
der IVF und PID<br />
Gerade weil theologische Ethik aber um einen positiven<br />
ethischen Diskurs in bezug auf die modernen Verfahren<br />
künstlicher Befruchtung in vitro und diagnostischer Hilfen<br />
bemüht ist, nimmt sie die vielen ungelösten moralischen Fragen<br />
wahr, die sich mit der Anwendung der genannten Techniken<br />
verbinden.<br />
Gegenwärtige extrakorporale Fertilisierungstechnik bleibt<br />
nicht bei dem bloßen Versuch stehen, die biologischen (oder<br />
psychischen) Hindernisse einer Zeugung durch künstliche<br />
Assistenz zu überbrücken, die Natur lediglich in ihren gleichsam<br />
grob mechanischen Defekten (durch Imitation gelingender<br />
natürlicher Vereinigung von Ei- und Samenzelle) zu korrigieren.<br />
Moderne Fertilitätsmedizin steht unter Druck, ihren<br />
Substitutionserfolg durch weitere Maßnahmen zu perfektionieren,<br />
die garantieren sollen, daß mit solchen<br />
Hilfsmaßnahmen auch ein gesundes Kind geboren wird. Und<br />
diese Sorge betrifft nun nicht mehr nur die Sorgfalt bei der<br />
Überwindung der organischen Probleme der Sterilität der Eltern,<br />
sondern weitet sich irgendwie geradezu zwangsläufig auf<br />
die genetischen Prozesse der Fortpflanzung aus.<br />
Anders als in bezug auf die bloßen Schwierigkeiten der<br />
Sterilität bleiben freilich die Möglichkeiten genetischer<br />
Korrekturen (nicht nur) in bezug auf die Vorgänge der<br />
Prokreation zur Zeit noch äußerst begrenzt. Was sich durch heutige<br />
Anstrengungen auf dem Sektor der Humangenetik ständig<br />
weiter entwickelt, ist zunächst die Chance der diagnostischen<br />
Einsicht in genetische Strukturen, die durch die Prozesse der<br />
Fortpflanzung weitergegeben werden und eine mögliche<br />
Krankheit des Trägers disponieren 10 . Eine wirkliche Therapie -<br />
10<br />
Wichtig werden solche Erkenntnisse etwa zur Vorbereitung der<br />
Geburt, z.B. wenn ein Kind die Anlage zur Hämophilie geerbt hat. Allerdings<br />
gilt es auch hier zu differenzieren. Nur bei mongenetischen<br />
Krankheitsformen ist diese Disposition so eng, daß die epigenetische<br />
Entwicklung die genetische Anlage mit einiger Zwangsläufigkeit auch zum<br />
Ausdruck bringt. Die meisten Dispositionen bleiben multikausal.
364 JOSEF RÖMELT<br />
nicht einmal im Sinne der Substitution - ist für solche<br />
Diagnosen allerdings kaum gegeben.<br />
Diese gegenwärtige medizin-historische Situation führt in<br />
der beginnenden klinischen Praxis sowie der begleitenden<br />
moralischen Reflexion der Fertilitätstherapien zunehmend zu<br />
kontrovers geführten Überlegungen, ob parallel zur gesetzlichen<br />
Regelung der Abtreibungspraxis in den modernen Industriegesellschaften<br />
11 im Rahmen der IVF eine zumindest als<br />
Option offenzuhaltende Selektion kranker Embryonen vor der<br />
Implantation in den Mutterleib zur Verfügung gestellt werden<br />
müßte. Die moralische Situation tragischer<br />
Schwangerschaftskonflikte wird dabei unbesehen auf die Probleme<br />
der künstlichen Befruchtungshilfen, also auf die<br />
künstlich induzierte Risikosituation assistierter, artifizieller<br />
Fertilisation und die präimplantive Selektion kranker Embryonen<br />
ausgedehnt. Die ersten Testverfahren der<br />
Präimplantationsdiagnostik werden parallel zu den Instrumentarien<br />
pränataler Diagnostik entwickelt. Dabei wird auf den<br />
Vorteil abgehoben, daß mit Hilfe solcher Verfahren die riesigen<br />
Belastungen pränatal diagnostizierter, genetisch belasteter<br />
Schwangerschaften und mit diesem Befund durchgeführter<br />
Spätabtreibungen vermieden werden könnten. Und so wird die<br />
Indikation zur IVF über die Probleme der Fertilitätsstörungen<br />
hinaus auf die gesamten Konflikte sogenannter<br />
Risikoschwangerschaften erweitert, in denen genetische Defekte<br />
die Geburt eines kranken Kindes “heraufbeschwören” könnten.<br />
So wird IVF als indiziert angesehen als Hilfe bei Trägern<br />
schwerer Erbkrankheiten nicht nur im Sinne einer heterologen<br />
Fertilisierung (die das belastete Erbgut zu umgehen versucht),<br />
sondern als kontrollierte Zeugung im homologen System, bei<br />
dem nur gesunde Embryonen in den Mutterleib transferiert<br />
werden. Ethisch diskutiert werden die Sicherheit der angewendeten<br />
Methoden der PID 12 als auch auf die Frage, welche<br />
11<br />
Vgl. die Integration der embryopathischen Indikation in die medizinische<br />
Indikation in der BRD.<br />
12<br />
Hier gilt nicht: je früher, um so besser, weil in den Entwicklungen der<br />
menschlichen Zygote zu allen (frühen und späteren) Zeitpunkten immer
THEOLOGISCHE ETHIK UND IN-VITRO-FERTILISATION 365<br />
Dispositionsgrade zu welchen Krankheitsgraden einen entsprechenden<br />
Zugang zur Diagnostik und eine entsprechende<br />
Selektion rechtfertigen 13 .<br />
Kommen hier Fragestellungen zur Sprache, ob es für ein<br />
Kind zumutbar ist, von seinen Eltern und Ärzten mit Wissen um<br />
genetische Krankheitsdispositionen implantiert und<br />
ausgetragen zu werden, ob deshalb nicht gar die Autonomie der<br />
Eltern in der Verfügung über einen genetisch belasteten Embryo<br />
um der Gesundheit der genetischen Erbanlagen einer<br />
Population willen beschnitten werden muß, dann scheint<br />
paradoxerweise das Argument natürlicher Redundanz im Umgang<br />
mit menschlichem Leben in den frühsten Stadien vergessen.<br />
Es wird demgegenüber eine Rationalität menschlicher<br />
technischer Intervention in die Prozesse menschlicher Zeugung<br />
mit großer Strenge und Rigorosität offenbar. Die Überwindung<br />
natürlicher Defekte unter Berufung auf die Verschwendung der<br />
Natur wandelt sich zur technisch berechneten Abwehr natürlicher<br />
Defekte gegenüber der spontanen, unberechenbaren<br />
Offenheit der Natur, die nicht nur zahlreiche befruchtete<br />
Eizellen zugrundegehen läßt, sondern auch aus der Sicht<br />
humangenetischer Wissenschaft genetisch defekte Embryonen<br />
heranwachsen läßt. Und was zur Rechtfertigung der IVF<br />
bestritten wird, daß man in Rechnung stellen muß, aus jeder<br />
befruchteten Eizelle könne ein erwachsener Mensch heranreifen,<br />
das wird zur Begründung einer zunehmend als moralische<br />
Verpflichtung verstandenen Meidung von Krankheitsträgern<br />
im genetischen Sinne nun gerade als logischer<br />
Zusammenhang dargestellt: daß aus jeder Zygote, die einen bestimmten<br />
genetischen Befund von Aberration aufweist, ein<br />
Mensch heranreifen kann, der unter einer bestimmten<br />
Krankheit leidet. Der theologisch-ethische Tutiorismus im<br />
Verbot von menschlichen Manipulationen (wie etwa der IVF),<br />
bei denen der Verlust von menschlichen Zygoten in Kauf<br />
wieder das Risiko fehlerhafter genetischer Entwicklungen besteht.<br />
13<br />
Vgl. G. De Wert, Ethik der Praeimplantationsdiagnostik: Ein<br />
gordischer Knoten, in: Biomedical Ethics 1/1 (1996) 9-13.
366 JOSEF RÖMELT<br />
genommen wird, wandelt sich in der Semantik der Fortpflanzungsmedizin<br />
in den Tutiorismus moderner Selektionsbemühungen,<br />
die es mit zunehmendem, gleichsam moralischem<br />
Druck auf die Schwangeren für geboten erachtet, bei<br />
unsicherem genetischen Befund die Alternative der<br />
“Verwerfung” bzw. Abtreibung zu wählen.<br />
K. Ruppel und D. Mieth machen in diesem Zusammenhang<br />
darauf aufmerksam, daß innerhalb der modernen ethischen<br />
Wertung der Entwicklung menschlichen Lebens in seinen<br />
frühesten Stadien die Gefahr besteht, “an die Stelle der Entwicklungspotentialität”<br />
gleichsam eine “Qualitätspotentialität”<br />
treten zu lassen, freilich nicht mehr zur Begründung des<br />
Lebensschutzes, sondern zur ethischen Rechtfertigung von<br />
Selektion. Sie fordern deshalb dazu auf, “die Einwände gegen<br />
ein Potentialitätsargument” noch einmal zu durchdenken. “Die<br />
Koppelung von Lebensqualitäten mit Überlebensrechten [von<br />
zur Einpflanzung anstehenden menschlichen Zygoten und<br />
Embryonen] bleibt jedenfalls problematisch, wenn es nicht um<br />
Nicht-Überlebensfähige oder in dieser Fähigkeit erheblich eingeschränkte<br />
menschliche Wesen geht. Hier bleiben noch einige<br />
Fragen an die Wissenschaft offen, z.B. wie überlebensfähig sind<br />
in der sog. ‘natürlichen Lotterie’ signifikante Embryonen?<br />
Woher wissen wir, wieviele hiervon zur Einpflanzung gelangen?<br />
Vermutlich kann man diese Fragen aber nicht ohne die<br />
Techniken beantworten, die moralisch in Frage stehen, so daß<br />
wir zu dem Ergebnis kommen müssen, daß uns die PID im<br />
ganzen vor mehr Probleme stellt als sie in Einzelfällen - in sehr<br />
geringer Prozentzahl gesund geborener Kinder - zu lösen<br />
scheint.” 14<br />
Die moralischen Begründungen der Legitimität der neuen<br />
medizinischen Techniken - seien es Fertilitätsverfahren wie IVF,<br />
14<br />
K. Ruppel/D. Mieth, Ethische Probleme der Präimplantationsdiagnostik,<br />
in: M. Düwell/D. Mieth (Hg.), Ethik in der Humangenetik. Die<br />
neueren Entwicklungen in der genetischen Frühdiagnostik aus ethischer<br />
Perspektive (Ethik in den Wissenschaften 10). Tübingen 1998, 358-379; hier:<br />
373.
THEOLOGISCHE ETHIK UND IN-VITRO-FERTILISATION 367<br />
ZIFT oder ICSI, seien es diagnostische Instrumente wie PID<br />
oder PGD - gewinnen ihren Anspruch letztlich daraus, daß der<br />
Erfolg der Geburt eines gesunden Kindes, der durch die Technik<br />
möglich wird, mit den vielen Belastungen ungewollter<br />
Unfruchtbarkeit, vererblicher Krankheitsdispositionen usw.<br />
abgewogen wird. Die Unbestimmtheit der natürlichen Prozesse<br />
scheint dabei einmal die Unvollkommenheit technischer Maßnahmen,<br />
das andere mal die Entschiedenheit technischer<br />
Korrekturen zu legitimieren. An der Radikalität der Forderung<br />
der Selektion beschädigten Lebens gerade in sehr frühen<br />
Stadien aber wird die Ambivalenz dieses Unternehmens letztlich<br />
deutlich: der Zwang zur immer weitergehenden Korrektur der<br />
Natur, der schließlich den Horizont der Möglichkeit, ja unter<br />
Umständen sogar die Notwendigkeit einer umfassenden<br />
Kontrolle der von Natur aus offenbar immer riskanten Prozesse<br />
der Zeugung durch menschliche Technik eröffnet.<br />
Demgegenüber stellt sich aber ganz entschieden die Frage,<br />
welches Leitbild kultureller Entwicklung für eine menschliche<br />
Zukunft wirklich tragfähig ist: das einer vorrangigen Substitution<br />
der spontanen, technisch nicht kontrollierten <strong>Vol</strong>lzüge<br />
des Lebens durch technologische rationale Verfahren, oder das<br />
einer prinzipiell auf natürlich-spontanen Erfahrungen aufbauenden<br />
Kultur, die Technik wohl zur Bewältigung äußerster<br />
Konfliktsituationen für menschliche Existenz und Biosphäre in<br />
Anspruch nimmt 15 . Im Blick auf die tief sensiblen, die ganzheitlichen<br />
Erfahrungen menschlicher Sinnlichkeit, zwischenmenschlicher<br />
Begegnung und Leiberfahrung berührenden Akte<br />
menschlicher Prokreation bedarf es zur Beantwortung dieser<br />
Sinnfragen keines ökologistischen oder feministischen 16<br />
Technikpessimismus, um zu verstehen, was kirchliche Tradition<br />
15<br />
Läßt sich in diesem Sinne die Technik der IVF im homologen System<br />
im Rahmen der Sterilitätstherapie als äußerster Grenzfall legitimieren (ohne<br />
PID) - auch wenn die unfruchtbare Konstellation eines Paares kein<br />
menschliches Leben unmittelbar bedroht und auch ein positives Recht auf<br />
Nachkommenschaft kaum begründbar ist?<br />
16<br />
Vgl. R. Maguire, Personhood, Covenant and Abortion, in: P. Jung/T.<br />
Shannon (Hg.), Abortion and Catholicism. New York 1988, 100-120.
368 JOSEF RÖMELT<br />
mit dem Gedanken der “Natur als Schutz der Person” 17 meint:<br />
daß der Mensch vor dem größeren Ganzen der Natur seine<br />
eigene Begrenztheit auch annehmen muß, um seiner eigenen<br />
Identität gerecht zu werden.<br />
Letzter Anspruch dieser Begrenzung menschlicher<br />
Interessen in ihrer Durchdringung der Natur ist die notwendige<br />
Achtung der vorgegebenen Vielfalt natürlichen Lebens, die nicht<br />
nur in bezug auf die Fortpflanzungstechnik als solche<br />
Voraussetzung und Rahmen aller menschlichen kulturellen<br />
Formung und Gestaltung bleibt: Die Bewahrung z.B. der<br />
Artenvielfalt zur Sicherung eines gesunden Genpools etwa der<br />
natürlichen pflanzlichen Evolution ist nach dem gegenwärtigen<br />
Erkenntnisstand wohl durch keine menschliche Kreativität zu<br />
ersetzen. Heutige technische Forschung spielt mit dem<br />
Gedanken der unbegrenzten Horizonte weiterer Entwicklung,<br />
behauptet, daß nur unter dieser Idee einer prinzipiellen Beherrschbarkeit<br />
aller Lebensphänomene Fortschritt (nicht nur)<br />
um des Menschen willen möglich sei. Aber angesichts der<br />
Krisenphänomene technischer Zivilisation stellt sich immer<br />
dringlicher die Frage, ob dem Forschungsimpuls nicht eine<br />
nüchterne Akzeptanz der metaphysisch-apriorischen Einsicht in<br />
die bleibende Begrenztheit des Menschen an die Seite gestellt<br />
werden muß, damit das Gewicht der Folgen technischer Aktion<br />
sich nicht gegen den Menschen und die belebte Natur kehrt, ihre<br />
Lebensentfaltung zerstört. Diese Begrenzung technischer<br />
Aktivität ist dabei ein Desiderat kultureller Gestaltung durch den<br />
Menschen selbst 18 . Die Vogel-Strauß-Politik des Forschers, der<br />
sich nur seinem kleinen begrenzten Erkenntnisfortschritt<br />
17<br />
Vgl. J. Reiter, Problematische Eigendynamik, 409 (mit Berufung auf<br />
K. Demmer). In diesem Gedanken scheint eine moderne, nachmetaphysische<br />
Interpretation des Naturrechts auf.<br />
18<br />
Es geht hier nicht um eine Neuauflage naturrechtlichwesensintuitiver<br />
Einschränkung menschlicher Autonomie und Kreativität.<br />
Es geht vielmehr um eine kulturelle Selbstinterpretation des Menschen in<br />
seiner bleibenden Bezogenheit auf die Natur, um die “Hermeneutik” seiner<br />
natürlich fundierten, kreativ offenen Identität als Basis seines ethisch<br />
verantwortlichen Handelns. Vgl. J. Römelt, Realistische Freiheit. Gedanken<br />
zur Theologie der Verantwortung. Frankfurt 1995, 17-24.78-85.
THEOLOGISCHE ETHIK UND IN-VITRO-FERTILISATION 369<br />
widmet unter der insgeheimen Phantasie, der Mensch werde<br />
einmal alle Lebensprozesse der Natur und sogar des Lebensbeginns,<br />
des Alterns und Sterbens durchschauen, vergißt, daß<br />
diese gleichsam metaphysische Annahme durch keine<br />
Erfahrung zu belegen ist und gegenwärtig immer heftigere<br />
kulturelle und zivilisatorische Paradoxien produziert. Das gilt<br />
auch für eine weitgehende technische Kontrolle menschlicher<br />
Akte der Fortpflanzung. Vielleicht wird von diesem Gedanken<br />
her auch deutlich, warum katholische Theologie im Blick auf die<br />
Techniken der Fortpflanzungsmedizin - trotz unbestrittener<br />
Ziele, die leidvolle Erfahrungen zu mindern suchen - für einen<br />
Verzicht auf eine Manipulation wirbt, die die natürliche Basis<br />
menschlicher Prokreation immer weiter verläßt und die in<br />
diesem Zusammenhang das zugegebenerweise mit der Natur<br />
noch sehr undifferenziert verbundene Leben früher<br />
menschlicher Embryonen immer stärker instrumentalisiert<br />
(z.B. schon wenn sie dessen Verlorengehen allzu rasch in Kauf<br />
nimmt).<br />
Karthäuser Strasse 7a,<br />
99084 Erfurt<br />
Germany<br />
JOSEF RÖMELT<br />
—————<br />
Summary / Resumen<br />
The technological therapy of sterility problems has seen great advances<br />
in recent years. This is the case both on the level of overcoming sterility<br />
and in respect of the pre-diagnosis of pregnancies that carry the<br />
risk of genetic disorders. These advances pose important questions for<br />
moral theology. Some of these issues are examined, for instance IVF<br />
and its restriction to married couples. Precisely because moral theology<br />
should be a positive science that tries to understand modern developments,<br />
these problems have to be analyzed, complex though they be.<br />
This article examines some of these issues, particularly from the point<br />
of view of the possible manipulation of the human species, as could
370 JOSEF RÖMELT<br />
happen in selection of how, when and with whom one should genetically<br />
intervene. The fundamental issue is: how do we view cultural<br />
development, and what criteria do we propose to guide us in the resolution<br />
of the conflicts which arise?<br />
La terapia técnica de los problemas de esterilidad ha experimentado<br />
enormes adelantos en los últimos años. El caso se presenta en ambos<br />
niveles: al querer superar la esterilidad y cuando el diagnóstico previo<br />
del embarazo corre el riesgo de desórdenes genéticos. Estos adelantos<br />
plantean cuestiones importantes para la teología moral. Se examinan<br />
algunos de estos problemas, como el de la FIV y su restricción a los<br />
matrimonios. Precisamente porque la teología moral debe ser una ciencia<br />
positiva que intenta comprender los adelantos modernos, se deben<br />
analizar estos problemas así sean complejos. Este artículo examina<br />
algunos de ellos, sobre todo desde el punto de vista de la posible manipulación<br />
de la especie humana, como podría suceder cuando alguno<br />
debe intervenir genéticamente escogiendo el cómo, el cuándo y con<br />
quién. El problema fundamental es: ¿cómo vemos nosotros el desarrollo<br />
cultural, y qué criterios proponemos para guiarnos en la solución<br />
de los conflictos que se presentan?<br />
—————<br />
The author is Professor of Ethics and Moral Theology in the<br />
Catholic Faculty of Erfurt.<br />
El autor es profesor de ética y de teología moral en la Faculdad<br />
Teológica Católica de Erfurt.<br />
—————
371<br />
StMor 37 (1999) 371-411<br />
MAURIZIO P. FAGGIONI, Ofm.<br />
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE<br />
Nella prima parte del nostro studio sullo stato vegetativo persistente<br />
1 , abbiamo affrontato il problema dello status personale<br />
di questi soggetti, anche in relazione alla nozione di morte/vita<br />
corticale, e i criteri morali che dovrebbero guidare le decisioni<br />
terapeutiche e assistenziali nei loro confronti.<br />
In questa seconda parte, vogliamo esaminare dapprima il<br />
problema di chi sia idoneo a prendere queste difficili decisioni<br />
per pazienti che si trovano nell’impossibilità di farlo personalmente,<br />
con particolare riferimento al dibattito sul valore etico e<br />
giuridico del living will. Successivamente estenderemo la nostra<br />
riflessione alla questione, oggi tanto dibattuta, della disponibilità<br />
della vita umana e quindi se il progettare la propria soppressione<br />
e l’attuare tale decisione, da parte del medico e di chi<br />
assiste un malato in condizioni disperate, come quelle appunto<br />
dello stato vegetativo persistente, possano mai configurarsi come<br />
un esercizio ragionevole rispettivamente dell’autonomia personale<br />
e della nostra responsabilità nei confronti della vita.<br />
1. Una difficile decisione<br />
Nella notte dell’11 gennaio 1983, Nancy Cruzan, una donna<br />
di 25 anni, mentre è alla guida della propria auto lungo una strada<br />
di campagna nei pressi di Carthagena (Missouri), perde il<br />
controllo della vettura che finisce fuori strada, capovolgendosi.<br />
La donna viene ritrovata con assenza di funzione cardiaca e respiratoria:<br />
rianimata dal personale paramedico prontamente ac-<br />
1 FAGGIONI M. P., Stato vegetativo persistente. Prima parte, in “<strong>Studia</strong> <strong>Moralia</strong>”<br />
36 (1998), 523-552.
372 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
corso, riprende la funzione cardiorespiratoria, ma la ragazza resta<br />
in coma. All’ospedale viene ipotizzata una commozione cerebrale<br />
associata a grave anossia, che deve essersi protratta per almeno<br />
12-14 minuti prima della rianimazione, per cui - considerato<br />
che dopo 6 minuti il danno encefalico diventa permanente<br />
- la prognosi quoad valetudinem è molto preoccupante.<br />
Dopo circa un mese, pur rimanendo priva di conoscenza,<br />
Nancy fu in grado di deglutire e di alimentarsi per via orale, anche<br />
se i medici, per facilitare l’assistenza e il recupero della paziente,<br />
il 5 febbraio 1983 realizzarono, con il consenso del marito,<br />
una gastrostomia per l’alimentazione e inserirono una agocannula<br />
per l’idratazione. Nell’ottobre dello stesso anno la donna<br />
fu trasferita al centro statale di riabilitazione di Mount Vernon<br />
(Miss.), dove ella non dette però segni di ripresa dallo stato<br />
vegetativo persistente in cui era caduta. L’ospedale - particolare<br />
non irrilevante nel sistema sanitario americano - si faceva carico<br />
di tutte le spese di assistenza, che costavano ai contribuenti<br />
del Missouri circa 112 mila dollari l’anno.<br />
Dopo tre anni, il marito alla fine la abbandonò al suo destino<br />
e a quel punto i genitori chiesero allo staff medico di interrompere<br />
le procedure di alimentazione e idratazione. Di fronte<br />
al deciso rifiuto dei medici, il 23 ottobre 1987, i genitori si rivolsero<br />
alla Corte della Contea di Jasper per ottenere il permesso di<br />
rimuovere il tubo per l’alimentazione così che la figlia potesse<br />
morire, come essi pensavano che ella stessa avrebbe desiderato.<br />
L’udienza sulla richiesta avanzata dai genitori iniziò il 9 marzo<br />
1988, mentre intorno al caso si accendeva un vasto dibattito<br />
pubblico pro e contro la rimozione del life support. I Cruzan sostenevano<br />
che era un diritto riconosciuto dalla common law che<br />
Nancy fosse libera di non ricevere trattamenti medici indesiderati<br />
e che il diritto alla privacy riconosciuto dallo Stato e dalla<br />
Federazione tutelava il suo diritto di rifiutare trattamenti medici<br />
indesiderati. Il giudice C. Teel accolse la richiesta con la sentenza<br />
del 27 luglio 1988, ma una settimana dopo W. Webster,<br />
Procuratore Generale (Attorney General) del Missouri, annunciò<br />
che si sarebbe appellato alla Corte Suprema dello Stato. Questa,<br />
con quattro voti contro tre, nel novembre del 1988 capovolse la<br />
sentenza della Corte inferiore e allora la famiglia a sua volta fece<br />
appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti che il 25 giugno<br />
1990, con cinque voti contro quattro, bloccò la rimozione del
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 373<br />
tubo dicendo che lo Stato può mantenere un paziente nelle condizioni<br />
di sostegno vitale artificiale nell’assenza di una prova<br />
“chiara e convincente” che la persona stessa vuole morire.<br />
Il 30 agosto i Cruzan chiesero al giudice Teel una nuova<br />
udienza perché erano state rintracciate tre persone le quali ricordavano<br />
di aver sentito affermare da Nancy che avrebbe preferito<br />
morire piuttosto che vivere in uno stato vegetativo. Il Procuratore<br />
Webster, a questo punto, dichiarò che lo Stato non aveva<br />
più alcun interesse legale nella questione e chiese al giudice<br />
Teel di tenere fuori dalla causa il Dipartimento della Sanità e il<br />
Centro di Riabilitazione del Missouri. Nel corso della nuova<br />
udienza tre compagni di lavoro di Nancy riferirono di ricordare<br />
un conversazione nella quale la donna aveva detto che non<br />
avrebbe mai voluto vivere “come un vegetale” in una macchina.<br />
Anche il medico personale di Nancy, che si era opposto alla rimozione<br />
del tubo per l’alimentazione, definì la sua vita “un vero<br />
inferno” e dichiarò che ella avrebbe dovuto essere lasciata morire.<br />
Fu così che il 5 dicembre il tutore designato dalla Corte chiese<br />
di rimuovere il tubo dell’alimentazione così che la ragazza potesse<br />
morire e la richiesta fu approvata dal giudice Teel. Mentre<br />
le Corti di Stato e Federale respingevano varie richieste di ingiunzione<br />
provenienti da gruppi anti-eutanasia, nella settimana<br />
prima di Natale la sfortunata ragazza scivolava verso la morte.<br />
Nancy Cruzan cessò di vivere il 26 dicembre 1990 2 .<br />
Abbiamo voluto narrare ancora una volta la penosa storia di<br />
Nancy Cruzan perché in essa risalta con chiarezza l’importanza<br />
della questione di chi sono i soggetti idonei a fare scelte terapeutiche<br />
e assistenziali per malati incompetenti, incapaci cioè di<br />
prendere decisioni autonome per se stessi, soprattutto quando<br />
sono in gioco valutazioni inevitabilmente segnate da un margine<br />
di soggettività, quali l’ordine di non rianimare o la decisione<br />
di ridurre le terapie alle sole cure ordinarie, in cui le categorie di<br />
utilità e di danno non possono prescindere dall’apprezzamento<br />
del paziente stesso. Se pensiamo inoltre alla rilevanza che oggi<br />
2<br />
La storia giudiziaria della vertenza “Cruzan versus Director, Missouri<br />
Department of Health” è documentata e commentata in: BEAUCHAMP T. L.,<br />
WALTERS L. eds., Contemporary Issues in Bioethics, Belmont (California)<br />
19944, 383-412.
374 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
viene data al consenso libero e informato nell’ambito dell’attività<br />
medico-chirurgica, il problema assume contorni davvero dilemmatici<br />
3 .<br />
Quando non sono disponibili informazioni sulle reali attitudini<br />
del paziente nei confronti di un’evenienza clinica, si cerca<br />
onestamente di comprendere che cosa deciderebbe per il proprio<br />
bene una persona di buon senso che si trovasse in quelle<br />
stesse condizioni. In questo primo modello decisionale, detto del<br />
principio dei migliori interessi (the best interests), finché non<br />
emergono situazioni di palese violazione delle leggi vigenti o<br />
non intervengono conflitti - come accadde invece nel caso di<br />
Nancy Cruzan - fra sanitari e familiari, la società tende a demandare<br />
a costoro l’onere delle decisioni cliniche senza interferenze<br />
o controlli esterni. Si tratta di una forma tacita di fiducia<br />
(trust) fra lo stato, da una parte, in quanto deputato alla tutela<br />
del bene dei cittadini e i sanitari e i familiari dall’altra: l’attesa<br />
sociale è che i sanitari per coscienza professionale e i familiari<br />
per affetto naturale decideranno per il maggior bene in relazione<br />
alle condizioni del paziente, senza per questo predeterminare<br />
in modo univoco che cosa possa intendersi con “fare il bene<br />
di qualcuno”.<br />
Nel dubbio sul comportamento più corretto, trattandosi della<br />
vita di un’altra persona, nessuno potrà arrogarsi il diritto di<br />
disporre liberamente dell’altro come potrebbe forse ritenere di<br />
poter fare per sé e occorrerà giudicare il più oggettivamente possibile<br />
per il bene del paziente in modo da procurargli inutili danni<br />
aggiuntivi, ma fornendogli quanto può essergli anche solo<br />
3<br />
Fra i numerosi interventi sul tema, segnaliamo lo studio monografico:<br />
BUCHANAN A. E., BROCK D. W., Deciding for Others: The Ethics of Surrogate Decisions,<br />
New York 1989. Cfr. AIKMAN P. J., THIEL E. C., MARTIN D. K., SINGER<br />
P. A., Proxy, Health, and Personal Care Preferences: Implications for End-of-Life<br />
Care, in “Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics” 8 (1999), 200-210;<br />
BEAUCHAMP T. L., CHILDRESS J. F., Principles of Biomedical Ethics, New York-<br />
Oxford 19944, 170-181; CANTOR N., Advance Directives and the Pursuit of<br />
Death with Dignity, Bloomington-Indianapolis 1993; CAPRON A. M., Advance<br />
Directives, in KUHSE H., SINGER P. eds., A Companion to Bioethics, Oxford<br />
1998, 261-271; EMANUEL L. L., EMANUEL E. J., Decisions at the End of Life:<br />
Guided by Communities of Patients, in “Hastings Center Report” 23 (1993),<br />
n. 5, 6-14.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 375<br />
ipoteticamente utile dal punto di vista terapeutico e assistenziale.<br />
Nel caso di pazienti incompetenti, quali i neonati, gli handicappati<br />
mentali gravi o i soggetti in coma irreversibile, queste<br />
scelte dovranno ispirarsi al principio di non maleficenza e non<br />
potranno quindi mai prevedere la soppressione diretta della vita<br />
fisica per non cadere nell’ingiustizia o nell’arbitrio e non tradursi<br />
in una forma di violenza indebita verso un’esistenza che non<br />
ci appartiene, ma che ci viene a diverso titolo affidata. Questo atteggiamento,<br />
tanto più giustificato quanto più significativo e rilevante<br />
è il valore in gioco, quello della vita, impedisce il ricorso<br />
all’eutanasia diretta, tanto la attiva quanto la passiva, ma non<br />
esime dall’astenersi dall’accanimento, sino ad una riduzione<br />
estrema delle cure, secondo la criteriologia precedentemente<br />
elaborata.<br />
Nel caso di pazienti incapaci di decisioni autonome, ma che<br />
erano stati in precedenza padroni di sé, si configura la possibilità<br />
che i familiari e, in genere, coloro che avevano avuto rapporto<br />
di confidenza con il paziente, possano farsi interpreti della<br />
sua volontà e stabilire che cosa ritenesse effettivamente bene<br />
per sé. Questa seconda situazione, denominata del giudizio sostitutivo<br />
(substituted judgment), è stata che avevano avuto rapporto<br />
di confidenza con il paziente, possano farsi interpreti della<br />
sche gli intimi, congiunti o amici, abbiano conosciuto a fondo<br />
la sensibilità, le convinzioni, i desideri del paziente e che addirittura<br />
ricordino come il paziente avesse espresso un suo preciso<br />
punto di vista sull’argomento, per esempio affermando che<br />
se si fosse trovato in condizioni di grave menomazione avrebbe<br />
preferito esser lasciato morire che non condurre un’esistenza indegna<br />
della persona ed essere di peso a tutti.<br />
Rimandando per ora la discussione sul contenuto etico di<br />
una eventuale scelta dell’astensione terapeutica e assistenziale a<br />
scopo direttamente eutanasico, resta il problema di come fornire<br />
“una prova chiara e convincente” che i familiari stanno davvero<br />
rappresentando i desideri di un paziente riguardo alle terapie<br />
di sostegno vitale e alle stesse cure ordinarie. Durante il dibattito<br />
sul caso Cruzan è emerso più volte il dubbio che i membri<br />
della famiglia potessero desiderare la fine della vita della paziente<br />
e per motivi ben diversi dal benessere o dalla volontà presunta<br />
di Nancy. Nel dubbio sui desideri pregressi del paziente e<br />
sulla affidabilità dell’interpretazione della sua reale volontà data
376 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
dai familiari, che possono talora trarre un vantaggio dal decesso<br />
del paziente o essere influenzati nel loro giudizio dalla stanchezza<br />
e dalla disperazione o che semplicemente possono non<br />
aver avuto contatti col paziente stesso da lungo tempo, il loro<br />
ruolo come naturali surrogatori decisionali è alquanto discutibile<br />
4 . Se si prospetta tale situazione di incertezza, il medico, non<br />
potendo di sua iniziativa escludere i congiunti del malato dal<br />
processo decisionale, dovrà ricorrere al comitato etico della<br />
struttura sanitaria o al giudice, che provvederanno - se necessario<br />
- a indicare un soggetto idoneo a prendere decisioni nel miglior<br />
interesse del paziente.<br />
Può accadere che coloro che sono chiamati a formulare una<br />
decisione surrogatoria ritengano di interpretare la volontà del<br />
paziente secondo modalità apparentemente difformi dalle sue<br />
esplicite dichiarazioni, ma sostanzialmente in sintonia con la sua<br />
volontà autentica, benché talora solo implicitamente autentica 5 .<br />
Esemplare, a questo proposito, la storia paradigmatica di Teresa<br />
proposta da D. Gracia nel primo volume dei Fondamenti di bioetica,<br />
come ideale contesto della sua pensosa trattazione del principio<br />
del rispetto dell’autonomia 6 . La donna, affetta da carcinoma<br />
rettale in fase avanzata, informata delle possibilità terapeutiche<br />
offerte da un intervento estesamente demolitivo che prevede<br />
anche la realizzazione di un colostoma decide di non operarsi.<br />
Dopo un anno e mezzo, un’occlusione intestinale viene a far precipitare<br />
la grave situazione renale e determina un nuovo ricovero.<br />
Essendo Teresa in uno stato di sensorio obnubilato, non può<br />
essere consultata e il marito, pur conoscendo il parere della moglie,<br />
autorizza l’intervento chirurgico e la realizzazione della colostomia,<br />
unica via per evitare una penosa agonia. “Sembra chia-<br />
4<br />
Cfr. ARRAS J. D., Beyond Cruzan: Individual Rights, Family Autonomy<br />
and the Persistent Vegetative State, in “Journal of the American Geriatric Society”<br />
39 (1991), 1018-1024; SECKLER A. B. et al., Substituted Judgment: How<br />
Accurate are Proxy Predictions?, in “Annals of Internal Medicine” 117 (1992),<br />
599-606.<br />
5<br />
Cfr. FADEN R. R., BEAUCHAMP T. L., A History and Theory of Informed<br />
Consent, New York 1986, 266-268 (criterio della “decisione negativamente<br />
autentica”).<br />
6 GRACIA D., Fondamenti di bioetica, Cinisello Balsamo 1993, 141-142.<br />
231-233.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 377<br />
ro - conclude Gracia - che bisogna ritenere quella decisione assolutamente<br />
opportuna, se ebbe lo scopo di evitare una morte<br />
sgradevole e perfino inumana, e non di sostituirsi alla decisione<br />
della paziente. In questo caso si configurerebbe come paternalismo;<br />
nell’altro, invece, si tratterebbe di una decisione in sostituzione<br />
attuata correttamente, che viene presa a maggior beneficio<br />
della paziente (beneficio che in questa circostanza ha lo scopo di<br />
rendere più umana e degna non la vita, ma la morte)” 7 .<br />
Infine accenniamo soltanto - perché il tema richiederebbe di<br />
essere inquadrato nel vasto dibattito sulla giustizia sanitaria 8 -<br />
alla questione del peso relativo che dovrebbero avere nel processo<br />
decisionale, tanto quello sostitutivo quanto quello del miglior<br />
interesse, la considerazione degli effetti del prolungarsi indefinito<br />
di una assistenza in termini di costi umani ed economici<br />
per la famiglia e per la collettività. L’attuale situazione socioeconomica,<br />
infatti, caratterizzata dalla crisi dello Stato sociale,<br />
non permette, neppure nei paesi del primo mondo, di far fronte<br />
alla crescita della domanda sanitaria, alla lievitazione dei costi<br />
della sanità, all’aumento relativo della popolazione non produttiva<br />
e bisognosa di assistenza, soprattutto per malattie croniche.<br />
I primi a far le spese di questa crisi sono ovviamente i deboli, gli<br />
inefficienti, come gli handicappati psichici e fisici gravi, gli anziani<br />
non autosufficienti, i malati terminali 9 . Bisogna prendere<br />
atto che le risorse sanitarie a disposizione non sono infinite e<br />
che negli anni futuri sarà sempre più difficile fornire a tutti i malati<br />
tutta l’assistenza teoricamente indicata.<br />
7<br />
Ibid., 232-233.<br />
8<br />
Sulla questione della giustizia sanitaria, in generale: BRESCIANI C. cur.,<br />
Etica, risorse economiche e sanità, Milano 1998; ENGELHARDT H. T., The<br />
Foundations of Bioethics, New York 19962, 383-426; IANDOLO C., HANAU C.,<br />
Etica ed economia nella “azienda” sanità, Milano 1994 2 ; SGRECCIA E., SPAGNO-<br />
LO A. G. curr., Etica e allocazione delle risorse nella sanità, Milano 1996.<br />
9<br />
Cfr. BANKOWSKI Z., BRYANT J. H. eds., Health Policy and Human Values:<br />
European and American Perspectives, Geneva 1988; BOMPIANI A., Brevi riflessioni<br />
sugli aspetti etici dell’economia sanitaria, in “Credere oggi” 17 (1997), 4,<br />
80-91; PALAZZANI L., Per una giusta distribuzione delle risorse secondo la bioetica<br />
personalista, in “Medicina e Morale” 49 (1999), 485-496; PUCA A., Economia<br />
e politica come ideologia. Il problema del razionamento delle cure sanitarie,<br />
in “Medicina e Morale” 43 (1993), 307-330.
378 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
Se però la sanità e le decisioni in ambito sanitario non possono<br />
sottrarsi alle regole e alle necessità economiche, d’altra parte<br />
l’economia non può imporsi sul bene delle persone e di ciascuna<br />
persona. Nel valutare il rapporto costo/beneficio la bioetica<br />
cattolica, pur tenendo nel debito conto la questione dei costi 10 ,<br />
non dimentica mai che ogni vita umana indipendentemente dalla<br />
sua qualità e al valore che le viene attribuito, appella alla nostra<br />
responsabilità e alla nostra solidarietà, che è il volto sociale<br />
della carità. Si tratta quindi di praticare una giustizia che sappia<br />
distribuire le risorse umane e tecniche disponibili secondo il bisogno<br />
di ciascuno: non sarà giusto perciò con nessuno l’accanimento<br />
terapeutico in cui si ha sproporzione fra i mezzi usati, in<br />
termini di costi umani e materiali, e i benefici per il malato, ma<br />
sarà giusto e doveroso tutelare anche le vite apparentemente destituite<br />
di valore. <strong>Vol</strong>endo e dovendo tener conto, a livello decisionale,<br />
della distribuzione fra la popolazione di risorse cronicamente<br />
insufficienti, si dovrà procedere su basi oggettive privilegiando<br />
chi ha più bisogno e può trarre più vantaggio da una certa<br />
terapia, fermo restando che nessuno può essere privato delle<br />
cure ordinarie che permettono il mantenimento della vita, se<br />
queste sono di fatto disponibili e clinicamente utili 11 .<br />
10<br />
Nell’algoritmo, menzionato nella prima parte dell’articolo, i costi erano<br />
messi in relazione con la probabilità di risultati positivi e con la qualità e<br />
lunghezza presunte della vita restante: ID=PQI/C. L’etica medica cattolica ha<br />
da tempo introdotto la categoria della expensio nel giudizio sulla proporzionalità<br />
delle cure. Cfr. KELLY G., The Duty of Using Artificial Means of Preserving<br />
Life, in “Theological Studies” 11 (1950), 203-220.<br />
11<br />
Le esigenze della spesa sanitaria chiedono di ripensare l’assistenza ai<br />
lungodegenti e si prospettano nuove soluzioni, attraverso l’integrazione di<br />
cure domiciliari e cure ospedaliere e la promozione dell’esperienza degli hospice.<br />
Vedere, per esempio: SCARCELLA P., CALAMO-SPECCHIA P., Il problema del<br />
malato terminale nella società attuale, in “Medicina e Morale” 38 (1988), 69-<br />
87; ID. L’assistenza ai malati terminali: realtà internazionali e prospettive italiane,<br />
in “Medicina e Morale” 38 (1988), 411-431.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 379<br />
2. Le advance directives e il living will<br />
Abbiamo finora ipotizzato che medici e familiari si trovino<br />
a dover prendere angosciose decisioni sulla sospensione o il proseguimento<br />
di terapie senza conoscere o conoscendo solo in modo<br />
incerto o presunto la volontà del diretto interessato. Una situazione<br />
ben diversa si viene a realizzare quando un malato, attualmente<br />
incompetente, avesse in precedenza espresso direttive<br />
esplicite in merito alla sua assistenza nel caso si venisse a trovare<br />
in condizioni cliniche tali da impedirgli di decidere in modo<br />
autonomo. Tali direttive si iscrivono in un positivo processo di<br />
adeguamento della concezione tradizionale dell’atto terapeutico<br />
ai principi di autonomia decisionale del paziente. Una delle<br />
grandi rivoluzioni della filosofia medica contemporanea, recepite<br />
più o meno lentamente dai codici deontologici e dalle legislazioni,<br />
consiste proprio nel superamento del paternalismo medico<br />
di ippocratica memoria e nell’importanza crescente attribuita<br />
all’autonomia del paziente di fronte al sanitario.<br />
Ci sono fondamentalmente due tipi di direttive previe, meglio<br />
note nella dizione inglese di advance directives. Il primo tipo<br />
provvede a indicare un tutore che è autorizzato a prendere decisioni<br />
al posto del paziente, se questi si trovasse a non essere<br />
compos sui (le proxy directives). Il secondo tipo di direttive contiene<br />
invece istruzioni precise sul comportamento da tenersi in<br />
particolari evenienze cliniche (instructional directives), esonerando<br />
in qualche modo i familiari o i tutori dal dilemma di scegliere<br />
al posto di un altro. Una forma tipica di instructional directives,<br />
diffusasi dai primi anni ’70, è costituita dal living will,<br />
espressione inglese introdotta nel 1969 da L. Kutner 12 e tradotta<br />
in genere con testamento di vita o testamento biologico. In tale atto<br />
testamentario (will) sono contenute le dichiarazioni di volontà<br />
che un soggetto sottoscrive nel pieno delle sue facoltà psico-fisiche<br />
sulle cure mediche e il trattamento da ricevere in situazioni<br />
estreme nelle quali non fosse in grado di disporre ade-<br />
12 KUTNER L., Due Process of Euthanasia: The Living Will: A Proposal, in<br />
“Indiana Law Journal” 44 (1969), 539-554. Cfr. BELTRAN J. E., The Living Will,<br />
Nashville (TN) 1994.
380 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
guatamente intorno alla sua salute 13 . La struttura dei diversi modelli<br />
di living will in circolazione è piuttosto costante e comprende<br />
una indicazione dei destinatari del documento (in genere<br />
i congiunti e i medici curanti) e direttive sull’assistenza sanitaria<br />
e i trattamenti medici richiesti e rifiutati in situazioni di<br />
malattia in fase terminale o irreversibile (es. rianimazione cardio-polmonare).<br />
L’atto di Durable Powers of Attorney for Health Care o Poteri<br />
durevoli di procura per la cura della salute combina i due tipi di<br />
direttive, perché prevede sia la nomina di un tutore sia l’indicazione<br />
di direttive per lui e i sanitari intorno alle cure desiderate<br />
in una certa situazione clinica. Il tutore può essere semplicemente<br />
delegato a vigilare sull’osservanza della volontà del paziente<br />
o, come per esempio nello Stato di New York, può essere<br />
incaricato di praticare lui stesso l’eutanasia attiva sul tutelato. Il<br />
primo stato dell’Unione a dare riconoscimento legale esplicito a<br />
queste direttive del paziente fu la California con il Natural Death<br />
Act del 1976. Da allora la maggioranza degli stati americani ha<br />
approvato leggi che permettono ai pazienti di esprimere i loro<br />
desideri sulle cure terminali o in situazioni estreme, soprattutto<br />
dopo che una President’s Commission riconosceva valore legale<br />
ai living wills 14 . Inoltre nel 1990 il Patient Self-Determination Act<br />
o Atto di autodeterminazione del paziente impone a tutti gli ospedali<br />
e le case di cura che ricevono qualche finanziamento pub-<br />
13<br />
Per il dibattito nell’area italiana, vedere: BOERI R., La carta dell’autodeterminazione:<br />
un primo bilancio, in “Bioetica” 1 (1993), 339-345; BONDOLFI<br />
A., Il “living will” nel dibattito sulla “buona morte”, in “Kos” 8 (1992), 18-25;<br />
D’AGOSTINO F., D’ORAZIO E., Autodeterminazione, diritto alla vita e autonomia<br />
della persona di fronte alla propria morte, in “Politeia” 24 (1991), 3-5; FASA-<br />
NELLA G., Il testamento di vita (living will) e il rifiuto delle cure nella fase terminale<br />
della vita. Aspetti etici e deontologici, in “Anime e Corpi” 29 (1992),<br />
615-649; PERICO G., “Testamento biologico” e malati terminali, in “Aggiomamenti<br />
Sociali” 43 (1992), 677-692; SANTOSUOSSO A., A proposito di “living will”<br />
e di “advance directives”: note per il dibattito, in “Politica del Diritto” 21<br />
(1990), 477-497; SPAGNOLO A. G., Testamenti biologici, in “Vita e Pensiero” 76<br />
(1993), 576-590.<br />
14<br />
U. S. PRESIDENT’S COMMISSION FOR THE STUDY OF ETHICAL PROBLEMS IN<br />
MEDICINE AND BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH, Deciding to Forego Life-Sustaining<br />
Treatment: A Report on the Ethical, Medical, and Legal Issues in<br />
Treatment Decisions, Washington D. C., 1983.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 381<br />
blico di informare i pazienti del loro diritto legale di preparare<br />
direttive terapeutiche 15 .<br />
Benché il principio dell’inderogabilità del consenso informato<br />
agli atti medici sia ormai largamente recepito nella normativa<br />
deontologica e giuridica, si fatica ad accogliere l’idea di<br />
dare valore legale a indicazioni vincolanti per il medico in vista<br />
di situazioni future e solo ipotetiche e questo non solo per la difficoltà<br />
di inserire coerentemente nel quadro delle teorie giuridiche<br />
tradizionali tale inedito e singolare tipo di dichiarazione della<br />
propria volontà. La necessaria simultaneità fra l’espressione<br />
della volontà e l’oggetto della scelta viene, infatti, a mancare e si<br />
profila il rischio che un’indicazione di volontà previa, per quanto<br />
dettagliata e inequivocabile, non corrisponda alla scelta che<br />
di fatto il paziente farebbe, trovandosi realmente in una contingenza<br />
prima soltanto immaginata. Una decisione precostituita<br />
non potrà mai essere ritenuta del tutto equivalente a una reazione<br />
autonoma, ponderata e razionale che suppone, fra l’altro,<br />
la capacità di adattarsi di fronte alla estrema variabilità delle situazioni<br />
cliniche di soggetti diversi e di uno stesso soggetto nel<br />
tempo, senza considerare che una persona può mutare la sua<br />
posizione verso la vita, la malattia, le cure 16 . Perciò – conclude il<br />
deontologo italiano C. Lega – “a prescindere dall’efficacia giuridica<br />
di siffatti documenti (che vengono assimilati al testamento),<br />
generalmente si ritiene necessario che ... se è incosciente, si<br />
debba effettuare una diligente indagine sulla permanenza della<br />
volontà del testatore rapportandola al momento in cui si sono effettivamente<br />
verificate quelle condizioni e quegli eventi in vista<br />
dei quali la dichiarazione fu fatta poiché può darsi che, di fronte<br />
a una realtà, dapprima solo ipotizzata e poi verificatasi in termini<br />
precisi, il testatore cambi opinione” 17 .<br />
15<br />
Cfr. WOLF S. M. et al., Sources of Concern about the Patient Self-Determination<br />
Act; WHITE M. L.. FLETCHER J. C., The Patient Self-Determination<br />
Act: On Balance, More Help than Hindrance.<br />
16 EVERHART M. A., PEARLMAN R. A., Stability of Patient Preferences Regarding<br />
Life-Sustaining Treatments, in “Chest” 97 (1990), 159-164; SEEGAL A.<br />
et al., How Strictly Do Dialysis Patients Want Their Advance Directives Followed?,<br />
in “Journal of the American Medical Association” 267 (1992), 59-63.<br />
17 LEGA C., Manuale di bioetica e deontologia medica, Milano 1991,<br />
310-311.
382 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
In effetti, nei primi living wills le espressioni usate, soprattutto<br />
in merito ai trattamenti indesiderati, erano molto generiche<br />
in modo da coprire un’ampia gamma di evenienze, ma si<br />
prestavano per ciò stesso sia ad applicazioni meccaniche e non<br />
sempre ben riconducibili alla variegata realtà della clinica sia, di<br />
contro, a interpretazioni molto soggettive fino ai limiti del tradimento<br />
della volontà del testatore. La stessa vaghezza terminologica<br />
di una direttiva suggerisce, inoltre, o almeno fa sospettare<br />
una non adeguata informazione del sottoscrittore e certo qualunque<br />
direttiva “non vale più del counseling che le ha precedute”<br />
18 . È indubitabile pertanto che ogni direttiva anticipata perde<br />
in autorevolezza e potere vincolante, quanto più è espressa in<br />
maniera generica e imprecisa 19 . Un esempio di questa imprecisione<br />
si ha nella classica formulazione proposta nel 1974 dall’Euthanasia<br />
Educational Council, dove la richiesta di non essere<br />
mantenuto in vita con “mezzi artificiali o misure eroiche”<br />
(ìartificial means or heroic measures”) lascia del tutto indeterminata<br />
la questione - in vero essenziale - di che cosa si intenda<br />
per artificiale o eroico e quindi se si parli di una doverosa rinuncia<br />
all’uso di mezzi sproporzionati/straordinari oppure di<br />
abbandonare anche le cure ordinarie, come l’idratazione e l’alimentazione<br />
20 .<br />
Se dovesse insorgere la situazione in cui non esiste la ragionevole<br />
aspettativa della mia guarigione dalle condizioni di inva-<br />
18 LYNN J., TENO M. J., Advance Directives, in REICH W. ed., Encyclopedia<br />
of Bioethics, vol. 1, New York 1995 rev., 575: “Advance directives are limited<br />
by being no better than the counseling that preceded them”.<br />
19<br />
Cfr. CATTORINI P., Malato terminale. Una Carta per l’autodeterminazione,<br />
in ID., Sotto scacco. Bioetica di fine vita, Napoli 1993, 83-96.<br />
20<br />
È stata più volte constatata un’incredibile confusione, persino fra gli<br />
addetti ai lavori, relativamente ad espressioni tecniche essenziali per affrontare<br />
questa delicata materia, quali “eutanasia”, “sospensione delle cure”,<br />
“suicidio assistito”: EMANUEL E. J. et al., The practice of euthanasia and physician<br />
assisted suicide in the United States: adherence to proposed safeguards<br />
and effects on physicians, in “Journal of the American Medical Association”<br />
280 (1998), 507-513; WEHRWEIN P., US physicians confused about end-of-life<br />
care, in “Lancet” 352 (1998), 549.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 383<br />
lidità fisica o mentale, richiedo che mi si lasci morire e che non<br />
mi si tenga in vita con mezzi artificiali o misure eroiche 21 .<br />
Attualmente si tende a elaborare living wills dettagliati e tali<br />
da poter far fronte alle situazioni più diverse, sufficientemente<br />
sicuri di interpretare la volontà del paziente. La Medical Directive<br />
preparata da Linda ed Ezekiel Emanuel prevede sei scenari<br />
o situazioni tipiche e chiede alla persona che deve riempire<br />
il formulario di scegliere fra diverse opzioni terapeutiche e di<br />
stabilire la finalità del trattamento in ogni singola situazione 22 .<br />
Nella situazione A, per esempio, si ipotizza che il soggetto sia in<br />
coma o in uno stato vegetativo persistente e il medico curante e<br />
due medici consultori non sperano in una ripresa della coscienza<br />
e delle funzioni mentali superiori. In tale contingenza si invita<br />
il soggetto a esprimersi intorno a diversi interventi medici e<br />
assistenziali, sempre a condizione che essi siano “medicalmente<br />
ragionevoli”, dicendo se si vogliono, se debbono essere tentati,<br />
ma sospesi se non portano ad un chiaro miglioramento, se si è<br />
indecisi, se non si vogliono: rianimazione cardiopolmonare e<br />
chirurgia invasiva, respirazione assistita e dialisi, trasfusioni di<br />
sangue o di prodotti del sangue, nutrizione e idratazione artificiali,<br />
test diagnostici di routine o antibiotici, terapia del dolore<br />
(anche se indirettamente abbrevia la vita). Lo scopo dell’assistenza<br />
medica deve essere indicato fra prolungare la vita e trattare<br />
tutto, preferire la qualità della vita rispetto alla durata della<br />
vita (“longevity”), fornire soltanto conforto (“comfort care”) o altro<br />
scopo da specificare. Nella situazione B, invece, si ipotizza<br />
uno stato di coma in cui esista, a parere dei medici, soltanto una<br />
vaga probabilità (ìuncertain chance”) di recuperare le funzioni<br />
mentali ed una probabilità più grande di sopravvivere con gravi<br />
danni cerebrali. La situazione C ipotizza un danno cerebrale irreversibile<br />
e tale da impedire una adeguata vita di relazione, e<br />
così via. Il formulario del living will è completato da osservazio-<br />
21 CAUCANAS-PISIER P., Le associazioni per il diritto a morire con dignità.<br />
Documentazione, in “Concilium” 21 (1985), n. 3, 80-92.<br />
22 EMANUEL L. L., EMANUEL E., The Medical Directive, in CATE F. C., GILL<br />
B. A. eds., The Patients Self-Determination Act: Implementations and Opportunities,<br />
Washington 1991, 58-64.
384 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
ni e raccomandazioni personali del sottoscrittore, da disposizioni<br />
sull’eventuale prelievo di organi e dalla designazione di un tutore.<br />
Ancora più interessante è la proposta della Values History o<br />
Storia dei valori 23 . Partendo dall’osservazione che l’attuazione<br />
dell’autonomia è più che una pura potestà decisionale, ma piuttosto<br />
“l’esercizio di questa potestà nel concreto e palticolare contesto<br />
delle convinzioni e dei valori di un paziente”, D. Doukas e<br />
L. McCullogh hanno proposto un documento diviso in due sezioni:<br />
la prima contiene un’esplicita identificazione dei valori e<br />
delle convinzioni in gioco, la seconda contiene l’articolazione<br />
delle direttive previe sulla base dei valori espressi dal paziente 24 .<br />
“Ciascuna di queste direttive - sottolineano gli Autori - richiede<br />
che il paziente spieghi i motivi della sua decisione in rapporto<br />
con i valori precedentemente identificati. L’importanza di questa<br />
informazione è di capire le motivazioni del paziente, esaminare<br />
e discutere possibili valori incoerenti e mettere in luce e superare<br />
possibili fattori psicologici che possono impedire al paziente<br />
di partecipare al processo del consenso informato” 25 . In<br />
questo modo il testatore viene aiutato a chiarire a se stesso che<br />
cosa desidera e perché, mentre i sanitari possono meglio comprendere,<br />
rispettare e attuare l’insieme valoriale che ne risulta.<br />
Si supera infine anche la rigidezza dello schema “si o no” che<br />
mal si adatta alla realtà clinica, dove un presidio può essere utile<br />
solo temporanemente e poi viene sospeso o dove si rende talora<br />
necessario fare diversi tentativi terapeutici perché non è<br />
possibile prevederne con esattezza in anticipo gli effetti. La decisione<br />
che viene prodotta con questa procedura si avvicina di<br />
più ad un consenso informato autentico che non la semplice esecuzione<br />
di una opzione predeterminata.<br />
L’introduzione del sistema assiologico del paziente come<br />
elemento essenziale per una comprensione contestualizzata delle<br />
direttive previe sposta - a nostro avviso opportunamente - il<br />
23 GIBSON J., National Values History Project, in “Generations” 14 (1990),<br />
Suppl., 51-63.<br />
24 DOUKAS D J., McCULLOUGH, The Values History, in “Journal of Family<br />
Practice” 32 (1991), 145-153.<br />
25<br />
Ibid., 148.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 385<br />
fuoco del living will dalla dettatura di istruzioni previe più o meno<br />
dettagliate all’affidamento al medico e ai familiari della tutela<br />
e pratica attuazione delle proprie convinzioni, assumendo la<br />
categoria di decisione precostituita con intelligente flessibilità.<br />
Si è anzi proposto, per superare le difficoltà oggettive testé segnalate,<br />
nonché la riluttanza della classe medica ad abdicare<br />
dalla propria potestà decisionale per farsi mera esecutrice di<br />
istruzioni preconfezionate, di considerare i testamenti vitali non<br />
come documenti ingiuntivi, bensì come documenti orientativi<br />
“che danno al medico un appoggio indiretto nel conoscere o presumere<br />
quale possa essere la volontà del paziente in questa situazione<br />
particolare” 26 .<br />
In ogni caso, sia che si tratti di direttive vincolanti sia che si<br />
tratti di direttive orientative, chiunque sia il destinatario, un tutore<br />
o lo staff curante, la questione morale di fondo sta nello spirito<br />
e nei contenuti del living will. Esistono infatti diversi modelli<br />
di living will elaborati a partire da diversi contesti antropologici<br />
ed etici, ma riportabili a tre varianti fondamentali: autonomista,<br />
utilitarista e personalista 27 .<br />
Nella prospettiva autonomista - indubbiamente la più diffusa<br />
- si mette in risalto la volontà del paziente espressa nelle direttive<br />
stesse. L’autonomia nei confronti dell’atto medico, corrispondente<br />
sostanzialmente alla necessità di pervenire a un consenso<br />
libero e informato, si allarga fino a diventare autodeterminazione<br />
nei confronti del proprio corpo e della propria sussistenza,<br />
rivendicandone una completa autodisponibilità. L’approccio<br />
utilitarista tende, da parte sua, a sottolineare il risparmio<br />
di sofferenze al malato ottenuto anche a prezzo dell’eutanasia<br />
diretta, la riduzione delle difficoltà decisionali per medici e<br />
26 BONDOLFI A., Living Will, in LEONE S., PRIVITERA S. curr., Dizionario di<br />
Bioetica, Acireale-Bologna, 1994, 554.<br />
27<br />
Cfr. EISEMANN M., RICHTER J., Relationship between Various Attitudes<br />
Towards Self-detemination in Health Care with Special Reference to an Advance<br />
Directive, in “Journal of Medical Ethics” 25 (1999), 37-41; VECA S., SPA-<br />
GNOLO A., Autodeterminazione, diritto alla vita e autonomia della persona di<br />
fronte alla propria morte, in “Notizie di Politeia” 7 (1991), 3-9. Non si parla<br />
ovviamente di un living will paternalista, perché nel paternalismo, più meno<br />
modificato, le decisioni su qualsiasi malato spettano per definizione al medico.
386 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
familiari permessa da direttive univoche e precise, i benefici sociali<br />
derivanti dalla sospensione di cure e assistenze inutili o<br />
sproporzionatamente dispendiose.<br />
L’approccio personalista, caro alla morale cristiana, non<br />
esclude la pratica del testamento vitale, ma si caratterizza per<br />
l’accettazione adulta del limite costituito dalla malattia e dalla<br />
morte, per la esclusione di forme più o meno larvate di eutanasia,<br />
percepita come un attentato all’inviolabilità della persona, e<br />
per l’accento sugli aspetti spirituali e relazionali dell’assistenza 28 .<br />
Esemplare per questa impostazione è il Testamento vital che si<br />
trova in uno studio curato dalla Conferenza episcopale spagnola.<br />
Dopo aver affermato la propria accettazione della morte e il rifiuto<br />
di essere sottoposti, se irrecuperabili, a trattamenti sproporzionati<br />
o straordinari, il documento prosegue:<br />
Chiedo egualmente aiuto per accogliere in modo cristiano e<br />
umano la mia morte. Desidero potermi preparare a questo compimento<br />
finale della mia esistenza, in pace, con la compagnia dei<br />
miei cari e il conforto della mia fede cristiana 29 .<br />
Da qualunque spirito siano animati, il diffondersi dei testamenti<br />
biologici nelle loro diverse declinazioni sono indice dell’abisso<br />
che si va allargando in medicina fra le crescenti possibilità<br />
tecnologiche e la scarsa qualità umana della relazione medicomalato<br />
che si riflette, fra l’altro, nella profonda crisi del rapporto<br />
di fiducia (trust) del paziente verso i sanitari. La spersonalizzazione<br />
della relazione terapeutica, inevitabilmente connessa<br />
con l’estrema specializzazione medica e con la conseguente parcellizzazione<br />
dell’assistenza fra molteplici figure mediche, sospinge<br />
il malato verso una zona oscura di solitudine e di non pie-<br />
28<br />
Apparentemente la scelta personalista potrebbe inscriversi nella prospettiva<br />
dell’autonomia, ma soltanto se viene assunta come possibilità assiologicamente<br />
indifferente in mezzo ad altre: là dove infatti il principio formale<br />
del rispetto dell’autonomia del paziente è cardine di un corretto rapporto<br />
medico-paziente, il contenuto dell’opzione è eticamente meno rilevante<br />
del rispetto dell’opzione stessa.<br />
29 CONF. EP. ESPAÑOLA, La eutanasia. 100 cuestiones y respuestas sobre la<br />
defensa de la vida umana y la actitud de los católicos, Madrid 1993, 86-87.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 387<br />
na comprensione. Non dimentichiamo poi che si va diffondendo<br />
nell’opinione pubblica, alimentata anche dal sensazionalismo<br />
emotivo dei media, il timore, non sempre infondato, dell’accanimento<br />
terapeutico e quindi di una sopravvivenza assurda e indegna<br />
della persona, permessa dagli artifici di una scienza prometeica<br />
che non si arresta neppure alle soglie della morte e che obbliga<br />
a vivere chi dovrebbe essere lasciato morire. “Vivere attaccati<br />
ai tubi”, proprio come Ann Quinlan o Nancy Cruzan, è l’incubo<br />
di molte persone che ritengono al contrario ispirato a misericordia<br />
l’atto di “staccare i tubi” ai pazienti per cui si dispera<br />
una ripresa.<br />
Come abbiamo visto nella prima parte del nostro lavoro, fa<br />
parte di una ragionevole e saggia amministrazione della vita fisica<br />
chiedere l’interruzione di presidi medico-chirurgici inutili e<br />
alla fine dannosi e l’astensione da manovre rianimatorie una volta<br />
stabilita l’irreversibilità dello stato vegetativo, rinunciare, in<br />
una parola, all’accanimento senza tuttavia cadere nell’eutanasia<br />
passiva. A ben guardare, infatti, l’eutanasia, sia nella forma dell’abbandono<br />
o astensione terapeutica, quando la terapia avrebbe<br />
ancor ragione d’essere praticata, sia nella forma della soppressione<br />
attiva tanto di consenziente o richiedente quanto dell’incapace<br />
di esprimere una deliberazione, è soltanto un altro<br />
volto della logica operante nell’accanimento: è l’estremo approdo<br />
dell’hybris umana che cerca di impadronirsi della vita e quando<br />
questa sfugge, nonostante tutto, al suo controllo, cerca allora<br />
“di impadronirsi della morte, procurandola in anticipo” 30 . Proprio<br />
a questo aspetto inquietante dell’autonomia del malato nei<br />
30 GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enc. Evangelium Vitae, 25-3-1995, n. 64, in<br />
AAS 87 (1995), 475. A proposito della posizione cattolica, si è parlato di una<br />
innocenza pretecnologica che, in sostanza, rimanda alla natura fisica la soluzione<br />
pratica dei dilemmi di fine vita. “Questa posizione – scrive M. Mori<br />
– sembra essere sempre meno plausibile oggi, man mano che aumenta la capacità<br />
di controllo umano del mondo biologico. Oggi cresce la richiesta di<br />
autodeterminazione proprio perché l’uomo si rende conto che è urgente assumere<br />
nuove responsabilità per una parte della natura (quella biologica)<br />
che fino a qualche tempo fa non rientrava nell’ambito di controllo”: MORI M.,<br />
Dal vitalismo medico alla moralità dell’eutanasia, in “Bioetica” 7 (1999), 122-<br />
123. La questione, davvero fondamentale, mette in discussione tutto un orizzonte<br />
antropologico di riferimento, ma non è possibile qui approfondirla.
388 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
confronti della propria vita biologica e delle decisioni sul malato<br />
incompetente dedicheremo il prossimo paragrafo.<br />
3. La vita disponibile<br />
L’enfasi unilaterale sulla categoria dell’autodeterminazione<br />
coniugata con l’ideologia della qualità della vita, basata su criteri<br />
prestazionali ed efficientistici, sta favorendo la diffusione di living<br />
will di chiara impronta eutanasica. Sottesa ai living will che<br />
chiedono l’eutanasia attiva o passiva, soprattutto in casi analoghi<br />
a quello rappresentato dallo stato vegetativo persistente, sta<br />
l’idea che l’autonomia di una persona possa giungere a scegliere<br />
se continuare a vivere o darsi la morte. Si insinua inoltre, più o<br />
meno esplicitamente, la pretesa che il medico e i familiari abbiano<br />
il dovere di rispettare questa decisione e che anzi esista<br />
una forma di impegno fiduciario a cooperare all’atto suicidiario<br />
o, addirittura, a metterlo in atto qualora il soggetto fosse nell’impossibilità<br />
fisica e mentale di dar corso alla sua volontà di<br />
morte. Tutta la questione dell’autodeterminazione nei confronti<br />
della propria morte e quindi della liceità morale del suicidio assistito<br />
poggia appunto - come lucidamente sottolinea E.<br />
Schockenhoff - su due taciti presupposti: il primo è che il desiderio<br />
di morte possa essere espressione di una autonomia autentica,<br />
il secondo che l’appagamento di tale desiderio rappresenti<br />
per il malato un aiuto reale e, per di più, l’unico aiuto che<br />
noi possiamo dargli nella sua dolorosa situazione 31 .<br />
Il living will eutanasico si inscrive quindi nella logica che<br />
giustifica il ricorso al suicidio medicalmente assistito con la differenza<br />
che nel suicidio assistito stricto sensu il malato chiede di<br />
essere aiutato dal medico a morire per sfuggire una situazione<br />
in atto che viene sperimentata come dolorosa o indecorosa o in<br />
qualche modo insostenibile, mentre nel living will il testatore,<br />
pienamente padrone di sé e nella sola previsione di una situazione<br />
per il momento ipotetica, dispone per orientare e anzi determinare<br />
le decisioni dei medici e dei congiunti nei suoi ri-<br />
31<br />
Cfr. SCHOCKENHOFF E., Etica della vita. Un compendio teologico, Brescia<br />
1997, 345.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 389<br />
guardi. La tesi della legittimità o accettabilità del suicidio in particolari<br />
circostanze, un tempo proscritta dal senso comune e dalle<br />
leggi civili, sta entrando nella mentalità prevalente e, sotto la<br />
spinta dell’opinione pubblica e l’incalzare di agguerriti movimenti<br />
pro euthanasia, ci sono in vari paesi progetti di legge tendenti<br />
a legalizzare o almeno depenalizzare questa pratica. Nella<br />
attuale discussione sulla moralità del suicidio si confrontano<br />
due diverse concezioni della vita e il filosofo laico italiano U.<br />
Scarpelli ben sintetizza i due corni del dibattito affermando che<br />
“si tratta in sostanza di stabilire se gli esseri umani siano stati<br />
creati per appartenere, sino all’ultima stilla di vita, a qualcosa o<br />
a qualcuno che li trascende e vuole disporne, o se al contrario<br />
siano padroni della propria vita e legittimati a porvi fine quando<br />
non possa più trarre significato dall’amore, dall’intelligenza,<br />
dalla felicità” 32 .<br />
La nozione di suicidio razionale, di ascendenze stoiche, ma<br />
modernamente elaborata nel XVIII secolo con Hume, Montesquieu<br />
e Holbach, si oppone all’idea propria della tradizione teologico<br />
morale cristiana che il suicidio vero e proprio non possa<br />
mai essere davvero razionale, cioè in accordo con la recta ratio 33 .<br />
La dottrina teologica traeva i suoi argomenti sia dall’esperienza<br />
umana (filosofica e giuridica) sia dalla Rivelazione e, seguendo<br />
lo schema fornito da san Tommaso nella Summa Theologiae, può<br />
essere sintetizzata in tre ordini di ragioni 34 .<br />
In primo luogo il suicidio è ritenuto irrazionale perché con-<br />
32 SCARPELLI U., Bioetica laica, Milano 1998, 126.<br />
33<br />
Trattazioni sintetiche: BLÁZQUEZ N., Bioética Fundamental, Madrid<br />
1996, 530-537 (con particolare riferimento agli aspetti biblici e patristici);<br />
RUSSO G., Il suicidio, in ID. cur., Bioetica sociale, Leumann (To) 1999, 8-53<br />
(ampia bibliografia).<br />
34<br />
S. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-IIae, q. 6, art. 5, resp.<br />
Merita segnalare l’affermazione del cardinal de Lugo che è difficile trovare<br />
argomenti razionali per una verità che appare autoevidente e fondata su motivi<br />
estrinseci (es. di fede). Cfr. LUGO G., De iustitia et iure, disp. 10, n. 45: “Tota<br />
difficultas consistit in assignanda ratione huius veritatis: nam licet turpitudo<br />
haec statim appareat, non tamen facile est eius fundamentum invenire;<br />
unde (quod in aliis multis quaestionibus contigit) magis certa est conclusio<br />
(quia nempe aliunde certa est, puta ex fide), quam rationes, quae variae de<br />
diversis afferuntur ad huius probationem”.
390 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
traddice la naturale inclinazione all’autoconservazione e il naturale<br />
amore per se stessi 35 . “Questa inclinazione - scrive il<br />
Pinckaers - è fondamentale perché riguarda l’essere stesso dell’uomo,<br />
alla base dei suoi sentimenti e dei suoi atti. L’universalità<br />
dell’inclinazione ne manifesta il carattere originario: dipende<br />
dalla sostanza stessa dell’uomo e assicura la sua conservazione<br />
in vita ... Questa inclinazione è certamente così profonda che<br />
spesso sfugge alla nostra coscienza, ma agisce in noi come la<br />
fonte stessa di ogni volontà cosciente e libera. Essa produce il<br />
desiderio spontaneo di esistere e di vivere. Questo desiderio è irrefrenabile,<br />
e tuttavia non ci costringe; non limita la nostra libertà,<br />
ma la fa esistere e la ispira. L’inclinazione alla conservazione<br />
dell’essere è all’origine della vita e dell’azione. Ci porta verso<br />
quel bene primitivo che è la vita, secondo la nostra natura, come<br />
esseri viventi, ragionevoli e liberi” 36 .<br />
In secondo luogo il suicidio, come l’omicidio, contraddice la<br />
signoria di Dio sulla vita umana e la persuasione che ogni vita ha<br />
un senso e uno scopo degno solo in quanto è risposta fedele a<br />
una chiamata di Dio 37 . Il comando decalogico “non uccidere” -<br />
come sottolinea Agostino - esprime il divieto di sopprimere ogni<br />
vita umana, senza distinguere fra la vita propria o quella altrui 38 .<br />
Se si comprende che il senso dell’esistenza umana è il dialogo<br />
con Dio e che da questa relazione costitutiva trae valore e senso<br />
l’esistenza stessa, allora sarà chiaro che interrompere unilateralmente<br />
e arbitrariamente questo dialogo è un implicito rifiuto di<br />
Dio e della sua sovranità. L’uomo, in quanto immagine di Dio,<br />
ha una signoria autentica sulla sua vita, ma questa signoria ministeriale<br />
è subordinata al principale dominium di Dio. All’uomo<br />
devono pertanto essere riconosciuti veri spazi di libertà e il diritto<br />
di organizzarsi autonomamente l’esistenza, ma il fatto di<br />
vivere-una-vita non è oggetto di scelta per l’uomo: come nessuno<br />
35<br />
Sul tema delle inclinazioni naturali, vedere: PINCKAERS S., Le fonti della<br />
morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, Milano 1992, 468-532 (per l’inclinazione<br />
alla conservazione dell’essere, 493-497).<br />
36<br />
Ibid., 493-495 (passim).<br />
37<br />
Tommaso si appoggia su un’auctoritas biblica (Dt 32, 39: “Ego occidam,<br />
et vivere faciam”), ma la spiegazione rimanda agli argomenti socratici<br />
contro il suicidio in: PLATONE, Fedone, 62 c.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 391<br />
ha deciso di entrare nella vita, ma vi è stato chiamato, così nessuno<br />
può uscirne senza aver ricevuto la chiamata.<br />
Tommaso aggiunge un ulteriore motivo di rifiuto del suicidio,<br />
derivante dalla filosofia di Aristotele e in sintonia con la sua<br />
concezione dell’etica come impresa comunitaria e realtà eminentemente<br />
sociale:<br />
Ogni uomo è parte della comunità e perciò quello che è, è<br />
della comunità. Ne segue che nel momento in cui uccide se stesso,<br />
fa un’ingiustizia alla comunità, come si legge nel V libro dell’Etica<br />
di Aristotele.<br />
Queste parole contengono una intuizione profondamente<br />
vera perché riferisce l’assoluta indisponibilità da parte dell’individuo<br />
della propria vita “al carattere non solipsistico dell’esistenza,<br />
al fatto (indiscutibile) che il nostro io dipende sempre e<br />
comunque da un altro-da-noi e che sempre e comunque ha responsabilità<br />
verso altri alle quali non può unilateralmente sottrarsi”<br />
40 . Nella visione di Tommaso, ogni uomo è considerato<br />
parte di un unico disegno divino universale e, in questo senso,<br />
ogni uomo è parte di un tutto, rappresentato dalla communitas<br />
in cui egli è concretamente inserito. Nessuno è padrone di disporre<br />
della propria vita non solo perché essa viene da Dio, ma<br />
anche perché essa ha sempre un significato e un valore per gli<br />
38<br />
S. AGOSTINO, De civitate Dei, lib. 1, cap. 20 (PL 41, 35): “Restat ut de<br />
homine intelligamus quod dictum est ‘Non occides’. Nec alterum ergo nec te.<br />
Neque enim aliud quam hominem occidit, qui seipsum occidit”.<br />
39<br />
S. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-IIae, q. 64, art 5, resp.:<br />
“Quilibet utem homo est pars communitatis: et ita id quod est, est communitatis.<br />
Unde in hoc quod seipsum interficit, iniuriam communitati facit, ut<br />
patet per Philosophum, in V Ethicorum (Eth. Nic. V, 11, 1138a 11)”. Ovviamente<br />
se l’esistere non è valutato come un bene in sé, ma soltanto in rapporto<br />
con la possibilità di promuovere il benessere materiale, l’argomento<br />
può addirittura essere ribaltato e riconoscere, in certe circostanze, il suicidio<br />
come un lodevole atto di amore di sé e di responsabilità sociale, come fa David<br />
Hume nel saggio Of Suicide.<br />
40 D’AGOSTINO F., Morte, in COMPAGNONI F. ed., Etica della vita, 63.
392 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
altri uomini: il suicidio (diretto) è sempre anche in qualche modo<br />
una ingiustizia, un danno arrecato alla società 41 .<br />
Certamente la morale cattolica sa che non ogni azione con<br />
cui si rischia mortalmente o si perde la propria vita corrisponde<br />
all’oggetto morale che noi chiamiamo suicidio, che non è mai e<br />
in nessuna circostanza ordinabile al bene ultimo della persona.<br />
Il cristiano che rifiuta di bruciare incenso agli dei falsi e bugiardi,<br />
pur sapendo che questo gli costerà la vita, non è un suicida,<br />
ma un martire della fede. Il medico che, mentre infuria l’epidemia,<br />
soccorre gli infermi sprezzando il pericolo del contagio e<br />
muore lui stesso del terribile morbo non è uno scriteriato, ma un<br />
eroe o forse un santo. Sansone che perisce nel crollo del palazzo<br />
filisteo da lui stesso provocato, non agisce mosso da follia autodistruttiva,<br />
ma spinto dall’amor patrio e dallo zelo per il suo Dio.<br />
Secondo san Tommaso, che segue in questo l’impostazione agostiniana,<br />
Sansone compì la sua impresa suicida per ispirazione<br />
divina 42 . Ora il Dio di Tommaso non è nominalista e, se ordina<br />
qualcosa, la ordina non per semplice atto d’arbitrio, ma in sintonia<br />
con la recta ratio e quindi conformemente a quel bene autentico<br />
che realizza l’uomo nella verità. L’offerta della propria vita<br />
per motivi superiori, lungi dal negare il senso ultimo dell’esistenza,<br />
permette infatti di attuarne in modo eroico la fondamentale<br />
apertura oblativa.<br />
Risulta più difficile accettare la tesi stoica che il suicidio<br />
messo in atto per sfuggire l’imminente catastrofe non sia segno<br />
di pusillanimità o di rinuncia, ma costituisca al contrario una<br />
manifestazione eccelsa di eroismo e di forza 43 . Non possiamo<br />
negare il fascino che ancor oggi sprigionano le pagine degli an-<br />
41<br />
Si noti come l’appartenenza dell’uomo alla comunità da una parte<br />
possa richiedere anche il sacrificio della integrità fisica, come nel caso della<br />
donazione di organi, giustificata dal principio di solidarietà, dall’altra fonda<br />
l’indisponibilità della propria vita, in base al principio di responsabilità comunitaria.<br />
42<br />
S. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-IIae, q. 64, art. 5, ad 4.<br />
Cfr. AGOSTINO, De civitate Dei, lib. 1, cap. 21 (PL 41, 35).<br />
43<br />
Si veda, per esempio, il suicidio di Catone, nell’assedio di Utica del 46<br />
a. C: SENECA, De providentia, 2, 11-12; PLUTARCO, Vita di Catone Minore, 67-<br />
73. Addirittura il cristiano Dante ne fece il simbolo dell’uomo in ricerca della<br />
libertà (Purgatorio, I, 71-75).
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 393<br />
tichi scrittori in cui si riferiscono alcuni esempi di siffatti suicidi<br />
lucidi, né vogliamo giudicare la nobiltà e la rettitudine soggettiva<br />
di questi suicidi, bisogna però riconoscere che, tanto nel<br />
caso degli Stoici, come Seneca e Catone Uticense, come del re<br />
Saul o di Razis, menzionati dalla Scrittura 44 , si tratta pur sempre<br />
di suicidi voluti direttamente come mezzo per sfuggire all’infamia,<br />
allorché la morte appare preferibile a una vita senza onore:<br />
è difficile non vedere in questi gesti estremi una forma di fuga<br />
da una realtà percepita insostenibile, anche se l’exitus dal<br />
mondo si presenta ammantato di tragica grandezza. Per questo<br />
motivo, benché l’Agiografo tessa l’elogio di Razis come testimone<br />
della fede nella risurrezione, sant’Agostino sottolinea come la<br />
Scrittura affermi che volle morire nobilmente, ma non che volle<br />
morire saggiamente 45 e san Tommaso, rifacendosi alla dottrina<br />
di Aristotele, giudica Razis un debole e non un forte 46 . Per la morale<br />
cattolica, il suicidio non è giustificato neppure quando apparisse<br />
quale unico mezzo onde evitare la violazione della castità<br />
fisica, come nel caso di alcune donne venerate come martiri<br />
che, durante le persecuzioni anticristiane, si uccisero piuttosto<br />
che subire l’affronto della violenza carnale 47 . Agostino, pur<br />
non volendo criticare il pio sentire dei fedeli, insegna che – a meno<br />
che non intervenga un comando diretto di Dio – darsi la morte<br />
costituisce sempre un male, anche in tale frangente, ed è perciò<br />
un esempio da non imitare 48 .<br />
44<br />
Cfr. 1 Sam 31, 8 (suicidio di Saul); 2 Mac 14, 37-47 (raccapricciante<br />
suicidio di Razis).<br />
45<br />
S. AGOSTINO, Epistula 204, 8 (PL 33, 941): “Scriptum est quod voluerit<br />
nobiliter et viriliter mori, sed numquid ideo sapienter?”. Cfr. ID., Contra Gaudentium,<br />
lib. 1, cap. 31, 37 (PL 43, 733).<br />
46<br />
S. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, II-IIae, q. 64, a. 5, ad 5:<br />
“Non tamen est vera fortitudo, sed magis quaedam mollities animi non valentis<br />
mala poenalia sustinere”. Cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, III, 7,<br />
1116a 15.<br />
47<br />
Apollonia si buttò nel fuoco: EUSEBIO, Historia ecclesiastica, lib. 6, cap.<br />
41 (PG 20, 607); Pelagia si precipitò da un tetto: Ibid., lib. 8, cap. 12 (PG 20,<br />
770); Domnina e le figlie si annegarono in un fiume: Ibid., lib. 8, cap. 12 (PG<br />
20, 772).<br />
48<br />
S. AGOSTINO, De civitate Dei, lib. 1, cap. 26 (PL 41, 39-40). Poco prima<br />
aveva affermato, a proposito di alcuni esempi biblici, che “sana quippe ratio<br />
etiam exemplis anteponenda est”: Ibid., lib. 1, cap. 23 (PL 41, 36). Diversa l’o-
394 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
Per il credente stretto dalle prove della vita e persino ridotto<br />
in condizioni al limite dell’umano, ove non gli sia possibile più<br />
nemmeno pregare o compiere un atto di abbandono fiduciale,<br />
resta la possibilità di offrire agli altri, proprio con la nudità dell’esistere,<br />
una testimonianza. Accogliendo una vita umana crocifissa,<br />
il cristiano proclama la signoria di Dio. Il cristiano che apparentemente<br />
non ha più nulla da dare al prossimo con la sua<br />
attività, può dare molto al prossimo attraverso la accoglienza del<br />
proprio limite, che è indice di profonda saggezza e frutto di una<br />
fede autentica e così, forte nella sua impotenza, può amare sino<br />
alla fine.<br />
Questo che abbiamo appena delineato è senza dubbio un sublime<br />
ideale di vita cristiana e rappresenta un maximum morale<br />
cui aspirare, ma ci si può chiedere se, in condizioni estreme,<br />
non sia lecito o almeno non colpevole, come minimum morale,<br />
privarsi della vita fisica 49 . Dal momento che – come si è visto –<br />
l’amore per Dio e per il prossimo possono essere motivi adeguati<br />
per rischiare e perdere la vita fisica, ci si chiede insomma se<br />
possa far parte di una ragionevole amministrazione del dono di<br />
Dio privarsi della propria vita non solo per il bene fisico o spirituale<br />
degli altri, ma anche per il proprio bene, come attuazione<br />
di un ragionevole amore di sé. Benché questo territorio della<br />
morale cattolica appaia ancora largamente inesplorato e risulti<br />
pinione di Girolamo: S. GIROLAMO, Commentariorum in Ionam Prophetam liber,<br />
lib. 1, vers. 16 (PL25, 1129): “Et in persecutionibus non licet propria perire<br />
manu absque eo ubi castitas periclitatur”. Cfr. S. AMBROGIO, De virginibus,<br />
lib. 3, cap. 7, 33 (PL 16, 241-244); S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Homilia in<br />
Pelagiam (PG 50, 579-584); Homilia 1 in Bernicen (PG 50, 629-640); Homilia<br />
2 in Bernicen (PG 50, 641-644). Vedere: AMUNDSEN D. W., Suicide and Early<br />
Christian Values, in BRODY B. A. ed., Suicide and Euthanasia, Dordrecht<br />
1989, 77-153; NARDI C., Il martirio volontario nelle omelie di Giovanni Crisostomo<br />
sulle martiri antiochene, in “Ho Theològos” 2 (1983), 207-278.<br />
49<br />
Un aspetto da approfondire sarebbe quello del suicidio come difesa di<br />
fronte a una condizione patologica, soprattutto se dolorosa, che viene percepita<br />
come estranea e nemica alla corporeità: non si tratterebbe di un atto<br />
buono in senso proprio, ma di un atto non punibile nella logica della difesa<br />
da un’aggressione ingiusta. Sulla nozione di omicidio per necessità: GARCÍA<br />
de VICENTE J. C., Homicidio por necesidad. La legítima defensa en la teología<br />
tardomedieval, Berna 1999.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 395<br />
difficile applicare a situazioni estreme, come appunto quella dello<br />
stato vegetativo persistente, l’esortazione a valorizzare l’esperienza<br />
del dolore e della morte incombente, sembra arduo affermare<br />
che il suicidio possa talora configurare una possibile forma<br />
di attuazione della nostra responsabilità per la vita. Mentre<br />
infatti nel suicidio per amore di Dio o del prossimo, la responsabilità<br />
verso la vita si attua in modo sublime nella logica della<br />
carità che sa amare sino alla fine, nel suicidio per fuggire un dolore<br />
o una situazione comunque percepita come indesiderabile<br />
io mi rivolgo, da solo o con la cooperazione di altri, contro la<br />
mia vita. Perciò occorre distinguere il suicidio di chi si sente o si<br />
prevede incapace di abbracciare la morte imminente e “quel sacrificio<br />
con il quale per una causa superiore - quali la gloria di<br />
Dio, la salvezza delle anime, o il servizio dei fratelli - si offre o si<br />
pone in pericolo la propria via” 50 . Il suicidio compiuto per fuggire<br />
atroci sofferenze o situazioni incresciose presenti o in previsione<br />
di esse, anche se soggettivamente può essere non colpevole<br />
o collocarsi in un contesto esistenziale e psicologico tale da<br />
ridurre o addirittura togliere la responsabilità morale, resta tuttavia<br />
una forma di violenza contro se stessi che contraddice in<br />
modo radicale il messaggio evangelico.<br />
A questo punto dobbiamo però riconoscere - con F. D’Agostino<br />
- che “nella prospettiva soggettivistica della modernità il<br />
fondamento stesso di questo discorso viene invece meno e l’atto<br />
suicidiario, da cifra della disperazione, acquista una nuova valenza,<br />
ontologicamente positiva, sia pure di carattere estremo:<br />
quella di negazione di Dio (Dostoevskij) o di negazione del ‘prossimo’<br />
(Nietzsche) o comunque di riaffermazione di una peculiare<br />
forma di razionalità, la razionalità calcolante, prediletta dagli<br />
utilitaristi, che pretende di avere per oggetto una ponderata ge-<br />
50 CONGR. DOTTR. FEDE, Dich. Iura et bona, 5-5-1980, I, 3, in AAS 72<br />
(1980), 545. Non persuade la tesi proposta come Gedankexperiment da D. C.<br />
Thomasma che “in the case of killing out of love, the individual requests …<br />
death for a higher purpose, a symbol of some commitment to the Divine”,<br />
per cui “as the martyrdom stories suggest, actively assisting in that death<br />
may sometimes but rarely be subsumed into God’s greater redemptive plan”:<br />
THOMASMA D. C., Assisted Death and Martyrdom, in “Christian Bioethics” 4<br />
(1998), 122-142 (citazioni pp. 132-133. 137).
396 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
stione di sé” 51 . Fuori della logica di un Dio che chiama all’amore<br />
e alla vita piena, altra moralità non si dà che nella logica narcisistica<br />
dell’autorealizzazione e il suicidio può esser concepito<br />
come un modo possibile di realizzare se stessi e addirittura come<br />
suprema moralità, come riappropriazione da parte dell’uomo<br />
di tutta l’esistenza, inclusa la morte.<br />
L’uomo veramente uomo sa morire, secondo Nietzsche, “al<br />
momento giusto” (zur rechten Zeit) facendo del morire una festa<br />
in cui si celebra il raggiungimento della pienezza e della maturità<br />
52 . Una esemplificazione significativa di questo atteggiamento<br />
si può trovare nell’aforisma 80 di Umano, troppo umano:<br />
Perché dovrebbe essere più lodevole per un uomo invecchiato,<br />
che sente il declino delle proprie forze, attendere la propria<br />
lenta consumazione e il disfacimento, che non porre termine<br />
in piena coscienza alla propria vita? In questo caso il suicidio<br />
è un’azione del tutto naturale e a portata di mano che, come vittoria<br />
della ragione, dovrebbe giustamente suscitare rispetto 53 .<br />
Una concezione distorta della libertà umana che approva ed<br />
esalta lo svincolamento della libertà dagli assoluti morali e dalla<br />
relazione col mondo dei valori oggettivi porta a ritenere che<br />
l’autonomia di una persona possa giungere a scegliere se, quando<br />
e come continuare a vivere o darsi la morte, benché, dal punto<br />
di vista puramente razionale, questa giustificazione del suicidio<br />
sia - a ben guardare - assurda: è paradossale infatti che un<br />
soggetto morale realizzi compiutamente se stesso annientandosi<br />
come soggetto nell’atto suicida, è assurdo che la massima<br />
espressione della moralità coincida con l’annientamento dello<br />
stesso agente morale, che una libertà per affermarsi si autodi-<br />
51 D’AGOSTINO F., Morte, 63-64.<br />
52<br />
Vedere sul tema un suggestivo intervento: REGINA U., Nietzsche: morire<br />
al momento giusto, in BIOLO S. cur., Nascita e morte dell’uomo. Problemi filosofici<br />
e scientifici della bioetica, Genova 1993, 239-254. Cfr. LUCAS LUCAS R.,<br />
Il soggettivismo e l’individualismo della libertà radice della violenza contro la<br />
vita umana, in SGRECCIA E., LUCA LUCA R. curr., Commento interdisciplinare<br />
alla “Evangelium Vitae”, Vaticano 1997, 245-262.<br />
53 NIETZSCHE F., Umano troppo umano, n. 80, in COLLI G., MONTINARI M.<br />
curr., Opere di Friedrich Nietzsche, Milano 1964, vol. 4/2, 67.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 397<br />
strugga 54 . “Chi si dà la morte dichiara, paradossalmente, che l’unico<br />
modo per salvare la propria vita è quella di distruggerla” 55<br />
per cui, ponendosi nella prospettiva del rapporto ambivalente<br />
del soggetto con il suo corpo oggetto/corpo vissuto, C. Zuccaro<br />
giustamente osserva che il tentativo di superare attraverso il suicidio<br />
una condizione somatica ritenuta insostenibile è illusorio<br />
perché “il limite rappresentato da questo corpo mortale ... non<br />
può essere veramente tolto ed eliminato dal suicidio. Infatti il<br />
suicida non riesce ad affermare se stesso in quanto spirito libero,<br />
ma precisamente solo il suo essere ormai cadavere” 56 .<br />
Anche accogliendo l’idea del suicidio come genuina espressione<br />
di libertà, risulta parimenti un po’ difficile capire in che<br />
senso decidere o programmare con advance directives la propria<br />
fuga dalla vita possa essere considerato come un atto di libertà<br />
e una squisita espressione della propria umanità, quando, assediati<br />
e stremati da circostanze avverse, viene meno la volontà e<br />
la capacità di assumere e significare la fase estrema della propria<br />
vita. Possiamo ben comprendere che un soggetto sprofondato<br />
in una cupa depressione, tormentato dal dolore maligno di<br />
un cancro che lo corrode, abbandonato e solo davanti a una<br />
morte imminente o semplicemente terrorizzato al pensiero di<br />
essere un giorno ridotto a un’esistenza larvale possa desiderare<br />
di sfuggire a una situazione indegna e che la morte gli appaia<br />
preferibile a quella vita e soprattutto preferibile alla situazione<br />
infernale creata dall’accanimento terapeutico 57 . Qui però non si<br />
54<br />
Cfr. KANT I., Die Metaphysik der Sitten, in Immanuel Kants Werke (E.<br />
Cassirer ed.), b. 7, Berlin 1922, 234: “Das Subjekt der Sittlichkeit in seiner eigenen<br />
Person zernichten, ist eben so viel, als die Sittlichkeit selbst ihrer Existenz<br />
nach, so viel an ihm ist, aus der Welt vertilgen, welche doch Zweck an<br />
sich sebst ist”.<br />
55 REICHLIN M., Il suicidio e la morale cristiana, in “Rassegna di Teologia”<br />
39 (1998) , 877. Cfr. YOLIF J. F., Suicide et liberté, in “Lumière et Vie” 32<br />
(1957), 83-100.<br />
56 ZUCCARO C., La vita umana è indisponibile? Il giudizio etico relativo a<br />
suicidio ed eutanasia, in “Rassegna di Teologia” 38 (1997), 52.<br />
57<br />
Cfr. MORI M., Dal vitalismo medico, 114: “Chiamo condizione infernale<br />
questa situazione che sappiamo comportare persistenti dolori terminali (o persistente<br />
condizione di “indegnità esistenziale”), per cui per il paziente è meglio<br />
non esistere (morire) piuttosto che continuare ad esistere in tale stato”.
398 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
tratta di autodeterminazione, ma piuttosto di una decisione pesantemente<br />
condizionata dalla paura, dalla sofferenza, dalla solitudine:<br />
non sono questi i contesti più favorevoli per poter parlare<br />
di una scelta lucida, razionale, del tutto autonoma o addirittura<br />
per qualificarla come l’apice delle scelte della persona 58 .<br />
Nonostante queste innegabili debolezze teoriche, l’idea della<br />
accettabilità del suicidio, soprattutto quello a scopo eutanasico,<br />
così come è stata sviluppata da alcuni filoni della modernità,<br />
si dimostra rispondente al sentire del nostro tempo e cerca di<br />
farsi strada anche in campo legislativo, delegittimando l’antica<br />
convinzione giuridica della indisponibilità della vita 59 . Anche<br />
senza giungere a parlare apertamente di “right to die”, di diritto<br />
a morire ovvero di diritto all’autodeterminazione nei confronti<br />
della propria morte, sino ad annoverare il suicidio un diritto<br />
umano fondamentale 60 , aumenta tuttavia il numero di coloro<br />
che giudicano il suicidio una azione in qualche situazione permissibile<br />
61 . Esso viene percepito dalla gente come una risposta<br />
drastica, ma efficace al dramma del dolore e come possibilità di<br />
58<br />
Anche coloro che – come S. Maffettone – sono a favore dell’eutanasia<br />
e del suicidio a partire da una teoria del valore basata sull’autonomia delle<br />
persone, mettone in guardia circa “la difficoltà di ottenere un consenso veramente<br />
autonomo e informato in casi di persone che, anche se in grado di<br />
decidere, patiscono atroci sofferenze e vivono nell’orizzonte della morte”:<br />
MAFFETTONE S., Il valore della vita. Un’interpretazione filosofica pluralista, Milano<br />
1998, 284-285. Il cosiddetto suicidio lucido, l’unico che potrebbe esser<br />
detto “razionale”, presuppone un contesto psicologico ben diverso: CHIAVAC-<br />
CI E., Morale della vita fisica, Bologna 19792, 88-91. La lucidità potrebbe<br />
aversi nelle direttive previe, ma in questo caso si ricade nella questione della<br />
disarticolazione temporale fra decisione e attuazione.<br />
59<br />
Vedere le riflessioni del prof. D’Agostino sulla dimensione giuridica<br />
della questione : D’AGOSTINO F., Diritto e eutanasia, in “Bioetica” 7 (1999), 94-<br />
105.<br />
60<br />
Della vasta letteratura, segnaliamo: BATTIN M. P., Ethical Issues in Suicide,<br />
Englewood Cliffs 1995, 180-195; KASS L. R., Is There a Right to Die?, in<br />
“Hastings Center Report” 23 (1993), n. 1, 34-43. Vedere inoltre tutto il num.<br />
3 del 1985 di “Concilium”: POHIER J., MIETH D. curr., Suicidio e diritto alla<br />
morte.<br />
61<br />
“L’uomo - scrive per esempio A. Pieper - non ha alcun diritto al suicidio,<br />
ma gli è permesso uccidersi” : PIEPER A., Argomenti etici in favore del suicidio,<br />
in “Concilium” 21 (1985), 3, 72.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 399<br />
vivere con la dignità e con l’autonomia proprie degli esseri umani<br />
la malattia e la morte. Nello stato vegetativo, in cui manca la<br />
componente drammatica e rabbiosa della sofferenza, la componente<br />
autonomistica della scelta eutanasica viene alla luce con<br />
chiarezza: l’incapacità di immaginare una possibilità di senso<br />
per una vita marginale conduce al suo rifiuto, come estremo e<br />
contraddittorio tentativo di attribuire un senso umano, attraverso<br />
una decisione libera ancorché autodistruttiva, a ciò che viene<br />
percepito umanamente destituito di valore.<br />
4. Il suicidio assistito<br />
Legata alla questione dell’accettabilità morale di una volontà<br />
diretta di darsi la morte, in atto o espressa attraverso direttive<br />
previe o mediante un legittimo tutore, sta quella della<br />
cooperazione del medico ad eseguire tale intenzione suicida<br />
(suicidio assistito) 62 . Ci si chiede se aiutare un paziente a mettere<br />
in atto un suicidio già deciso sia, a certe condizioni, una modalità<br />
ragionevole di venire incontro ai suoi bisogni e urgenze o<br />
non piuttosto un modo discutibile per risolvere il dramma di<br />
un’assistenza penosa. L’obbligo morale del medico di aiutare<br />
l’ammalato nel morire, può comportare talora l’aiutarlo a morire?<br />
La risposta dovrebbe essere molto articolata, coinvolgendo<br />
la nostra concezione del rapporto fra medico e malato, l’idea che<br />
abbiamo della nostra responsailità verso la vita e ultimamente il<br />
senso che attribuiamo alle vite umane declinanti o in qualche<br />
modo deboli.<br />
Se si ritiene che il suicidio ammette una qualche giustificazione<br />
morale, allora non ci sono ostacoli insormontabili per il<br />
medico - in ossequio a una legittima volontà del paziente, anche<br />
emessa previamente e purché sia tuttora valida o validamente<br />
rappresentata - a prestarsi per assistere al suicidio. Nell’orizzonte<br />
dell’etica razionale laica di Engelhardt, per esempio, il male<br />
non sta nell’uccidere qualcuno, ma nell’uccidere qualcuno senza<br />
62 DWORKIN G., FREY R. G., BOK S., Euthanasia and Physician Assisted<br />
Suicide, Cambridge 1998; UHLMANN M. M. ed., Last Rights. Assisted Suicide<br />
and Euthanasia Debated, Washington 1998.
400 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
il suo permesso 63 . La logica del suicidio risponde al principio del<br />
rispetto dell’autonomia del paziente, purché essa venga chiaramente<br />
e certamente espressa. Come il medico deve rispettare la<br />
volontà del paziente di desistere dall’accanimento terapeutico o<br />
dall’impiego di mezzi che il malato ritiene per sé inutili e dannosi,<br />
così deve rispettare la sua eventuale volontà di morte. In<br />
questo caso non si chiede al medico di condividere o meno la ragionevolezza<br />
o la giustezza dell’intenzione suicida, ma soltanto,<br />
una volta esclusa la possibilità di interventi alternativi per il controllo<br />
dell’ansia o del dolore, di aiutare il paziente ad attuare una<br />
scelta deliberata. Affermare che la gente che vuole por fine alla<br />
sua vita dovrebbe provvedere da sola, non tiene conto che spesso<br />
si tratta di soggetti nell’impossibilità di darsi la morte desiderata<br />
(come nel caso di soggetti in stato vegetativo persistente)<br />
senza considerare che, come ha scritto M. Angell, “questo è forse<br />
il più crudele degli argomenti contro il suicidio assistito” 64 .<br />
Fanno davvero pensare le ultime parole vergate da Percy Bridgman,<br />
premio Nobel per la fisica, prima di spararsi per non soccombere<br />
a un cancro metastatico: “Non è onorevole per la Società<br />
lasciare che un uomo faccia questo a se stesso” 65 . In queste<br />
disperate parole risuona l’orrore per il suicidio e l’implorazione<br />
alla società di sostituirsi al suicida nel mettere in atto una tragica<br />
decisione.<br />
Il limite di queste posizioni sbilanciate sul versante dell’autonomia,<br />
non sta certo nel ridimensionare l’onnipotenza del paternalismo<br />
medico del passato, ma di pretendere la esautorazione<br />
della coscienza e della competenza del sanitario in una decisione<br />
di enorme portata. Il medico non può farsi meccanico esecutore<br />
di una qualsiasi volontà del paziente anche perché il paziente<br />
spesso non comprende senso e utilità dei presidi terapeutici<br />
che chiede o che rifiuta, e questo tanto più quando la deci-<br />
63 ENGELHARDT T., The Foundations, 350: “The central secular moral evil<br />
in murder is not taking the life of an individual, but taking that life without<br />
the individual’s permission”.<br />
64 ANGELL M., The Supreme Court and the Physician-Assisted Suicide. The<br />
Ultimate Right, in “The New England Journal of Medicine” 336 (1997), 52.<br />
65 NULAND S. B., How we die, New York 1994, 152: “It is not decent for<br />
Society to make a man do this to himself”.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 401<br />
sione dipende da una dichiarazione di volontà o di autodeterminazione<br />
dettata molto tempo prima o trasmessa e interpretata<br />
da un tutore. In modo particolare l’autodeterminazione del paziente<br />
non può obbligare il medico contro la coscienza, se egli ritiene<br />
il suicidio inammissibile in linea di principio - come abbiamo<br />
cercato di argomentare nel paragrafo precedente - o comunque<br />
ingiustificato in quelle particolari circostanze 66 .<br />
Il rifiuto del suicidio assistito era elemento qualificante dell’ethos<br />
ippocratico che, opponendosi alla diffusa prassi dei medici<br />
antichi i quali aiutavano a morire i malati incurabili o coloro<br />
che preferivano la morte all’esilio o al disonore o alla rovina<br />
politica, affidava al Giuramento un rifiuto esplicito e fermo:<br />
Mai, anche se richiesto, somministrerò farmaci letali né<br />
commetterò mai cose di questo genere 67 .<br />
Secondo la morale cristiana, dal momento che il suicidio per<br />
sfuggire il dolore o il disonore non è ritenuto conforme alla recta<br />
ratio, “condividere l’intenzione suicida di un altro e aiutarlo a<br />
realizzarla mediante il cosiddetto suicidio assistito significa farsi<br />
collaboratori, e qualche volta autori in prima persona, di<br />
un’ingiustizia, che non può mai essere giustificata, neppure<br />
quando fosse richiesta” 68 . Con toni drammatici, così si esprimeva<br />
Agostino:<br />
In nome di nessuna legge o autorità legittima, non è mai lecito<br />
uccidere un altro, anche se lui lo volesse e lo chiedesse e non<br />
fosse più capace di vivere … e, sospeso tra la vita e la morte, sup-<br />
66<br />
Se ha qualche ragione chi nega che aiutare nel suicidio sia propriamente<br />
un atto di ingiustizia, perché non si commette ingiustizia facendo<br />
qualcosa che una persona vuole (secondo l’aforisma che “volenti non fit iniuria”),<br />
tuttavia resta un atto di violenza contro una vita direttamente inteso.<br />
67<br />
Cfr. GRACIA D., Fondamenti di Bioetica, 57-88; LICHTENHAELER C., Le<br />
serment d’Hippocrate. Analyse d’ensemble, in “Revue Médical de la Suisse<br />
Romande” 100 (1980), 1001-1011.<br />
68 GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Evangelium Vitae, n. 66, in AAS 87 (1995),<br />
477.
402 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
plica di essere aiutato a liberare l’anima che lotta contro i legami<br />
del corpo e desidera distaccarsene 69 .<br />
Ammettere che sia ragionevole e addirittura raccomandabile<br />
aiutare a morire una persona che lo chiede o che lo avesse disposto<br />
preventivamente, non sfugge alla regola del piano inclinato<br />
o, come dicono icasticamente, gli Anglo-Sassoni, del pendio<br />
scivoloso (“slippery slope”), nel quale la velocità di colui che scivola<br />
verso la fine del pendio cresce progressivamente ed inarrestabilmente<br />
70 . Dalla tesi della legittimità e ragionevolezza del<br />
suicidio assistito (eutanasia volontaria) sarà infatti naturale<br />
trarre la conclusione che i medici o i congiunti possono prendere<br />
la stessa decisione a beneficio ovvero nel miglior interesse di<br />
un bambino o di un adulto malato incapace permanentemente<br />
di intendere e di volere (eutanasia involontaria). L’argomento<br />
del piano inclinato suona spesso retorico e allarmistico, ma la<br />
realtà dei fatti sta purtroppo dando conferma delle previsioni.<br />
Esemplare il caso olandese 71 .<br />
Fino a qualche anno fa l’eutanasia era esclusa, in quanto<br />
comportamento delittuoso, dal Codice penale olandese, ma il dibattito<br />
pubblico sul tema si è fatto sempre più scottante soprattutto<br />
a partire da una sentenza del 1973 che aveva inflitto una<br />
settimana (simbolica) di reclusione a un medico che aveva ucciso<br />
la madre, gravemente ammalata, con una dose letale di morfina<br />
72 . Nella stessa sentenza la Corte aveva dichiarato che avrebbe<br />
approvato l’azione eutanasica se fossero state soddisfatte alcune<br />
condizioni, fra le quali quella che il paziente, affetto da ma-<br />
69<br />
S. AGOSTINO, Epistula 204, 5 (PL 33, 940).<br />
70<br />
Cfr. FLEMING J. I., Euthanasia. The Netherlands and Slippery Slope, in<br />
“Bioethics Research and Notes” 2 (1992), 14; JOCHEMSEN H., KEOWN J., <strong>Vol</strong>untary<br />
euthanasia under control? Further empirical evidence from the Netherlands,<br />
in “Journal of Medical Ethics” 25 (1999), 16-22; VAN DER BURG W., The<br />
slippery slope argument, in “Ethics” 102 (1991), 42-65; WALTON D., Slippery<br />
Slope Arguments, Oxford 1992.<br />
71<br />
Sulla questione olandese: GOMEZ C., Regulating Death: Euthanasia and<br />
the Case of the Netherlands, NewYork I991; VIAFORA C. cur., Quando morire?<br />
Bioetica e diritto nel dibattito sull’eutanasia, Padova 1996, 120-231.<br />
72 DE WAHTER M. A. M., Euthanasia in the Netherlands, in “Hastings Center<br />
Report” 22 (1992), n. 2, 23-30.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 403<br />
lattia incurabile e da sintomatologia dolorosa grave, avesse chiesto<br />
lui stesso la morte al proprio medico curante. Questa posizione<br />
tendenzialmente favorevole all’eutanasia su richiesta fu ribadita<br />
da diverse sentenze olandesi fra il 1973 e il 1983 73 . Nel<br />
1984, alle due condizioni essenziali che il malato prendesse l’iniziativa<br />
della richiesta e che la sua situazione fosse obiettivamente<br />
grave, la Reale Associazione Medica Olandese aggiunse,<br />
come terza condizione, che un medico diverso dal curante verificasse<br />
la correttezza della diagnosi, della prognosi e di tutta la<br />
procedura eutanasica 74 .<br />
Questi orientamenti pro-eutanasia sono stati tradotti in un<br />
insieme di direttive emanate nel 1990 dalla Procura Generale.<br />
Da allora la pratica dell’eutanasia - non senza polemiche - si è<br />
diffusa sempre più tra i medici olandesi allargandosi non di rado<br />
dall’eutanasia su richiesta del paziente all’eutanasia su decisione<br />
del medico. Secondo il Rapporto Remmelink, richiesto<br />
congiuntamente dal Ministero della giustizia e dal Ministero della<br />
sanità, in Olanda i medici decidono la morte di 4000 pazienti<br />
sui circa 130 mila che muoiono ogni anno; il suicidio assistito è<br />
stato praticato solo 400 volte, la interruzione intenzionale della<br />
vita è stata praticata circa 2300 volte (nel 2% delle morti), ma in<br />
almeno 1000 casi i medici hanno affrettato o provocato il decesso<br />
in mancanza di esplicita richiesta del paziente e solo nel 17%<br />
di questi 1000 era possibile documentare una richiesta avanzata<br />
in precedenza dal paziente 75 . Secondo il Rapporto questi 1000<br />
casi di interruzione non volontaria della vita dovrebbero essere<br />
considerati “assistenza fornita al morente perché, quando le fun-<br />
73 LEENEN H. J. J., Euthanasia - assistence to suicide and the Law: Developments<br />
in the Netherlands in “Health Policy” 8 (1987), 197-206; VAN DER<br />
MAAS R. J., Euthanasia and Other Medical Decisions Concerning the End of Life<br />
in “Lancet” 338 (1991), 669-674.<br />
74 ROYAL DUTCH MEDICAL ASSOCIATION, Vision on Euthanasia, in “Medische<br />
Contact” 39 (1984), 990-998.<br />
75 COMMISSIE ONDERZOEK MEDISCHE PRAKTJIK INZAKE EUTHANASIE, Medische<br />
Beslissingen Rond Het Leveneinde, The Hague 1991. Cfr FENIGSEN R.,<br />
The Report of the Dutch Governmental Committee on Euthanasia, in “Issues<br />
in Law and Medicine” 7 (1991), 339-344.
404 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
zioni vitali han cominciato a venir meno, l’eutanasia rientra indiscutibilmente<br />
nella normale pratica medica” 76 .<br />
Dopo un estenuante dibattito, inficiato dall’uso di una nozione<br />
vaga e quasi onnicomprensiva di eutanasia, la Seconda<br />
Camera del Parlamento olandese ha approvato, il 9 febbraio<br />
1993, un Documento sull’eutanasia che prevede la depenalizzazione<br />
di alcune pratiche eutanasiche 77 . Un emendamento governativo<br />
al testo introduceva la possibilità che un medico, con la<br />
supervisione di un altro medico, potesse praticare, anche senza<br />
esplicita richiesta del paziente, l’eutanasia o meglio un “intervento<br />
medico attivo per abbreviare la vita” 78 , lasciando all’ufficiale<br />
giudiziario competente la decisione se ci sia stata violazione<br />
o no del codice penale, che ipocritamente continua a considerare<br />
l’eutanasia un reato. L’emendamento è stato approvato<br />
con una maggioranza risicata (37 favorevoli e 34 contrari) il 30<br />
novembre dello stesso anno ed ha avuto una immensa eco nel<br />
mondo. In un intervento, che voleva essere apologetico, il ministro<br />
della giustizia Hirsch Ballin ha spiegato che “persone malate<br />
non dovrebbero trovarsi mai nella situazione di sentirsi come<br />
un peso per gli altri e quindi costretti a chiedere che si ponga fine<br />
alla loro esistenza” 79 .<br />
76<br />
Medische Beslissingen Rond Het Leveneinde, 32. Cfr. WELIE J. V. M,.<br />
Euthanasia: Normal Medical Practice? in “Hastings Center Report” 22 (1992),<br />
n. 2, 212-217.<br />
77<br />
Il testo in “Medicina e Morale” 43 (1993), 446-448. Cfr. FRAVOLINI G.,<br />
La nuova normativa sull’eutanasia nei Paesi Bassi in “Aggiornamenti Sociali”<br />
45 (1994), 839-848; JOCHEMSEN H., Euthanasia in Holland. An Ethical Critique<br />
of the New Law, in “Journal of Medicine and Ethics” 20 (1994), 212-217.<br />
78<br />
La legge distingue fra eutanasia (soppressione di consenziente), suicidio<br />
assistito (aiuto nel porre fine alla propria vita) e LAWER (acronimo indicante<br />
la soppressione di un paziente che non ne ha fatto richiesta). “È significativo<br />
– scrive M. Reichlin – l’imbarazzo linguistico degli autori olandesi<br />
che, avendo improvvisamente deciso di limitare il termine eutanasia a<br />
quella volontaria, sono stati costretti ad inventare un nuovo termine per indicare<br />
quella che in tutti gli altri paesi è definita eutanasia non volontaria: il<br />
termine reso innocente dall’essere una sigla a prima vista incomprensibile è<br />
LAWER, cioè life-terminating acts without explicit request of patient: REICHLIN<br />
M., L’Eutanasia in Olanda: contraddizioni, ambiguità, alternative, in VIAFORA<br />
C. cur., Quando morire? 175-205 (la citazione a p. 186).<br />
79 HIRSCH BALLIN M. H., Cristiano-democratici e eutanasia in “Conci-
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 405<br />
Lo slittamento di prospettiva dall’autodeterminazione del<br />
paziente sofferente alla soppressione del paziente “che è di peso”<br />
è sconcertante e non può certo sfuggire una grave incoerenza<br />
negli argomenti addotti dai propugnatori dell’eutanasia, sia volontaria<br />
sia non volontaria 80 . Dapprima si è sostenuta l’eutanasia<br />
volontaria come diritto di ciascuno a morire nel tempo ritenuto<br />
più giusto e quindi come espressione di autodeterminazione,<br />
quando la vita viene sperimentata dall’agente morale insostenibile<br />
o indegna di essere vissuta. Essendo l’apprezzamento<br />
della sostenibilità della vita e della sua dignità un dato altamente<br />
soggettivo, si è ritenuto che il medico non dovesse filtrare tale<br />
apprezzamento attraverso le sue categorie etiche, ma rispettare<br />
il sentire e la decisione del malato e aiutarlo piuttosto a mettere<br />
in atto ciò che egli aveva deciso. Sembra giusto a molti riconoscere<br />
il diritto di porre fine ai propri giorni a una persona<br />
che si trovi in condizioni disperate e il medico non deve far altro<br />
che rispettare questa volontà del paziente e qualcuno arriva<br />
anzi ad equiparare l’aiuto del medico a compiere un suicidio ad<br />
un ultimo atto benefico compiuto in favore del malato. Secondo<br />
Brandt, per esempio, “l’obbligo morale delle altre persone nei<br />
confronti di chi ha intenzione di suicidarsi è un caso dell’obbligo<br />
più generale di prestare soccorso a chi si trova in gravi difficoltà,<br />
almeno quando ciò non comporta gravi costi per sé” 81 .<br />
La nozione di autodeterminazione nei confronti della morte<br />
è usualmente il perno intorno a cui ruota tutto l’argomento e, at-<br />
lium” 29 (1993), 741. Cfr. LOMBARDI RICCI M., GRILLO A., Riflessioni sull’intervento<br />
del Ministro olandese della Giustizia M. H. Hirsch Ballin in “Medicina<br />
e Morale” 44 (1994), 443-452 (citazione a p. 445).<br />
80<br />
Sottolineiamo l’inopportuna denominazione di volontaria e non volontaria<br />
entrata nell’uso per indicare rispettivamente l’eutanasia di soggetto<br />
competente che la chiede e quella di soggetto non competente che la subisce.<br />
Nel linguaggio dell’etica volontario e non volontario si riferiscono invece alla<br />
relazione di un atto con la liber volontà di chi lo compie. La confusione<br />
aumenta se consideriamo che qualcuno, come P. Singer, definisce involontaria<br />
l’eutanasia compiuta contro la volontà del soggetto.<br />
81 BRANDT R. B., The Morality and Rationality of Suicide, in SCHNEIDEMAN<br />
ed., Suicidology. Contemporary Issues, Orlando 1976 (trad it. in FERRANTI G.,<br />
MAFFETTONE S., Introduzione alla bioetica, Napoli 1992, 163-192, la citazione<br />
a p. 190).
406 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
traverso la categoria di qualità della vita, trova una sua applicazione<br />
allargata nella legittimazione delle direttive previe. In esse<br />
il soggetto può decidere autonomamente di essere lasciato morire<br />
senza alcuna cura o di essere attivamente soppresso, se si<br />
verificassero particolari situazioni di degrado della vita psicofisica:<br />
la decisione non parte da un concreto vissuto di malattia e<br />
di sofferenza, ma da un apprezzamento astratto che, ponendosi<br />
di fronte a possibili evenienze, giudica alcune situazioni non accettabili.<br />
L’ultimo passo consiste nel dare alla categoria “qualità di vita”<br />
una valenza oggettiva, indipendente dai vissuti soggettivi dei<br />
singoli agenti morali e quindi indipendente dall’esperienza<br />
estrema di dolore e di angoscia tanto spesso evocate dai fautori<br />
dell’eutanasia. Sulla base di questo nuovo assoluto morale, magari<br />
scientificamente quantificato in base a parametri misurabili<br />
di piacere/dolore o di desiderabilità o di costi sociali, il medico<br />
potrà giudicare l’accettabilità di una certa esistenza e agire di<br />
conseguenza con buona coscienza professionale e con la tutela<br />
della legge. Il processo di liberalizzazione dell’eutanasia, quindi,<br />
non solo sta accelerando lungo il piano inclinato per incremento<br />
numerico - come dimostrano dati recenti 82 - e per la tendenza<br />
ad allargarsi a sempre nuovi casi e fattispecie, ma sta slittando<br />
anche dal punto di vista argomentativo dall’autonomia del paziente<br />
di fronte alla morte e dal conseguente rispetto dell’autonomia,<br />
verso una beneficenza esercitata dal medico verso il paziente,<br />
dapprima in ossequio della sua volontà (un bene soggettivo)<br />
e poi come applicazione di parametri concernenti gli standard<br />
di vita accettabili (un bene oggettivo).<br />
La cultura della tarda modernità ha diffuso un senso crescente<br />
di angoscia per il dolore e la morte e una ripulsa per le<br />
espressioni fragili e decadenti dell’esistenza, tanto che eminenti<br />
scienziati, frai quali il premio Nobel J. Monod, hanno firmato<br />
nel luglio 1974 un Manifesto sull’eutanasia, pubblicato originariamente<br />
su The Humanist, nel quale si dice che “è immorale accettare<br />
o imporre la sofferenza”, facendo così dell’eutanasia non<br />
82 EIJK W. J., LELKENS J. P. M., Medical-Ethics Decisions and Life-Terminating<br />
Actions in The Netherlands 1990-1995. Evaluation of the Second Survey<br />
of the Practice of Euthanasia in “Medicina e Morale” 47 (1997), 475-501.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 407<br />
solo un diritto civile, ma addirittura un dovere morale 83 . Per<br />
molti il concetto di eutanasia coincide con quello di dignità della<br />
morte o con quello di umanizzazione del dolore e della morte e<br />
deve essere considerato un diritto delle persone sofferenti o in<br />
condizioni estreme e quindi un gesto benefico e dovuto da parte<br />
del medico. Se la morte viene “intesa come evento buono o felice<br />
per colui che muore”, allora sarà compito del buon medico,<br />
in ossequio al principio di beneficenza, dare la morte ai pazienti<br />
per i quali essa risulta un bene 84 .<br />
L’incoerenza sta nel fatto che nell’eutanasia medicalizzata la<br />
qualità della vita, oggettivamente ponderata dal medico, porta a<br />
compiere un atto eutanasico indipendentemente da una richiesta<br />
del soggetto che viene, ancora una volta, defraudato della sua<br />
morte in nome del paternalismo medico che si attribuisce la capacità<br />
di conoscere il bene autentico del paziente. “Quello che la<br />
pratica medica dell’eutanasia in Olanda rivela - commenta il<br />
professor Henk ten Have di Nimega - è che la giustificazione etica<br />
si è spostata dal rispetto per l’autonomia alla liberazione dalla<br />
sofferenza. Ma questi due argomenti si escludono l’un l’altro: ha<br />
senso parlare di rispetto per l’autonomia soltanto se un medico<br />
si astiene dall’esprimere giudizi su ciò che sia bene per il paziente”<br />
85 .<br />
Al di là della questione della violazione dell’autonomia del<br />
paziente insita nella pratica dell’eutanasia non volontaria di un<br />
paziente incompetente, nella prospettiva della morale cattolica,<br />
l’eutanasia non è eticamente praticabile neppure quando essa<br />
sembri costituire un bene per il paziente, perché l’eutanasia - per<br />
qualunque motivo o mezzo sia data - contraddice “l’inviolabilità<br />
del diritto alla vita dell’essere umano innocente, dal concepimento<br />
alla morte, è un segno e un’esigenza dell’inviolabilità stes-<br />
83<br />
Cfr. SGRECCIA E., Manuale di bioetica, I, Milano 1994, 639-641.<br />
84 FOOT PH, Euthanasia in ID., Virtues and Vices, Berkeley 1978 (trad. it.<br />
in FERRANTI G., MAFFETTONE S. curr., Introduzione alla bioetica, 81-111, la citazione<br />
a p. 82). Cfr. CHIODI M., Eutanasia e modelli teorici in bioetica, in<br />
“Teologia” 23 (1998), 150-185 (su Philippa Foot, pp. 163-167).<br />
85 TEN HAVE H., L’eutanasia in Olanda: un’analisi critica della situazione<br />
attuale, in VIAFORA C., Quando morire?, 132.
408 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
sa della persona, alla quale il Creatore ha fatto il dono della vita”<br />
86 . La vita corporea non è uno strumento della persona, ma la<br />
sua modalità concreta di esistere nello spazio e nel tempo: la vita<br />
biologica è intrinseca alla persona e la sussistenza fisica coestensiva<br />
con l’esistere della persona. Pertanto sopprimere una vita<br />
fisica è un atto che non si ferma mai alla sola dimensione somatica<br />
della persona, ma tocca la persona nella sua intimità,<br />
violandone lo spazio esistenziale: l’eutanasia, in quanto soppressione<br />
diretta di una persona, non può mai configurare in senso<br />
stretto un bene per essa. L’eventualità che un medico possa annoverare<br />
l’eutanasia fra gli interventi che egli può di sua iniziativa<br />
predisporre nei confronti del paziente, avrebbe inoltre conseguenze<br />
disastrose sulla relazione medico-malato e su tutta l’etica<br />
professionale del medico. Infatti - come afferma E. Pellegrino<br />
- “l’uccisione intenzionale, se accolta nel corpus dell’etica medica,<br />
distorcerebbe l’etica e gli scopi della relazione terapeutica<br />
almeno sotto tre punti di vista: beneficenza, protezione dell’autonomia<br />
e rispetto della fiducia (“fidelity to trust”)” 87 .<br />
Proprio la categoria interpretativa di relazione, versante esistenziale<br />
della categoria etica di responsabilità, ci permette di<br />
trovare un avvio di risposta alla domanda iniziale, se cioè soddisfare<br />
il desiderio di morte pregresso di un paziente o addirittura<br />
dare di propria iniziativa la morte a un paziente in condizioni<br />
estreme sia davvero la risposta più corretta al dramma proposto<br />
dalle esistenze ridotte ai limiti dell’umano. Lo stato vegetativo<br />
persistente è miserevole esempio di tale condizione marginale<br />
dal punto di vista della dignità, anche se non forse della sofferenza.<br />
La priorità del tu rispetto all’io fonda nella relazionalità interumana<br />
e non nella pura autodeterminazione la possibilità<br />
dell’esistere e dell’attuarsi di ciascuno come persona, di modo<br />
che prendersi cura dell’altro e tutelare la sua esistenza, nella mi-<br />
86 CONGR. DOTTR. FEDE, Istr. Donum Vitae, 22-2-1987, Introduzione, n. 4,<br />
in AAS 80 (1998), 76.<br />
87 PELLEGRINO E. D., Intending the Patient’s Death. Conceptual and Practical<br />
Issues for the Ethics of Clinical Decision-making, in ROMANO C., GRASSA-<br />
NI G. curr., Bioetica, Torino 1995, 420.
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 409<br />
sura del ragionevole, rappresenta la sostanza di un agire moralmente<br />
responsabile che mi libera da una autoreferenzialità annichilente<br />
88 . Noi riteniamo che, anche quando si sia spenta l’autocoscienza<br />
del proprio esistere personale, l’essere umano resti<br />
un possibile referente di responsabilità per coloro che se ne<br />
prendono cura e che lo fanno, in qualche modo, a nome della società<br />
di cui quel soggetto era e - finché vive - è parte. Se pertanto<br />
una società ritiene di dover difendere il valore della vita umana,<br />
deve impegnarsi a difenderla e tutelarla anche dove essa raggiunge<br />
i suoi confini, senza introdurre utili, ma alla fine pericolose,<br />
distinzioni assiologiche fra le esistenze e soprattutto senza<br />
estromettere, con la violenza, dalla rete delle relazioni umane<br />
coloro che dal concepimento alla morte ne sono parte integrante.<br />
Solo a queste condizioni è possibile salvaguardare integro il<br />
senso e il valore di ogni vita umana. “Data la sua grande importanza<br />
simbolica - scrive E. Schockenhoff - che sottolinea la chiara<br />
volontà di una società di tutelare la vita umana, il divieto di<br />
uccidere può a lungo andare assolvere la sua funzione pacificatrice<br />
solo quando venga efficacemente osservato anche in zone<br />
marginali e in situazioni conflittuali” 89 .<br />
Di fronte al malato in stato vegetativo persistente, che con<br />
ogni probabilità non potrà mai più riprendere coscienza di sé e<br />
del mondo, che si consuma come una candela dalla fiamma tremolante,<br />
che logora con la sua resistenza alla morte la pazienza<br />
di coloro che lo servono, avvertiamo forte ed esigente più che<br />
mai la sfida della nostra responsabilità verso la vita. Abbandonarlo<br />
al suo tragico destino e addirittura portare violenza contro<br />
la sua esistenza languente significherebbe privare una creatura<br />
umana della dignità del morire e rinunciare a cogliere nell’ultimo<br />
tratto dell’avventura terrena di un uomo lo schiudersi di una<br />
possibilità di senso. Ha umanamente senso prendersi cura della<br />
88<br />
Sul tema della relazionalità in bioetica, vedere: DONATI P., Le dimensioni<br />
relazionali della bioetica in “Transizione” 8 (1989), 59-72; FURNARI M. G.,<br />
Ethos relazionale e bioetica. Riflessioni alla luce dell’«Evangelium vitae», in<br />
RUSSO G. cur., Evangelium vitae. Commento all’enciclica sulla bioetica, Leumann<br />
(To) 1995, 193-217.<br />
89 SCHOCKENHOFF E., Etica della vita, 353.
410 MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
sua vita fragile e declinante, ha un senso per noi e ha virtualmente<br />
un senso per lui, anche se forse egli non lo saprà mai.<br />
Via Merulana 124<br />
00185 Roma<br />
Italy.<br />
MAURIZIO P. FAGGIONI, ofm<br />
—————<br />
Summary / Resumen<br />
Following a previous article in this review (StMor, 26 (1998) 523-<br />
552), the author continues his analysis of the persistent vegetative state<br />
(PVS) : the personal status of people in this situation was discussed, as<br />
well as the criteria to guide decisions regarding the therapy and help to<br />
be given. In this second article, the author examines first the problem<br />
of who should be the suitable person to take decisions for patients who<br />
find themselves personally incapable of so doing. Particular reference is<br />
made to advance directives and the living will. Then follows a study of<br />
the fundamental question of the disposability of life and, thus, whether<br />
projecting its actual suppression or taking such a decision, either by the<br />
doctor or the person assisting the ill patient, can ever be seen as a reasonable<br />
exercise with respect to personal autonomy and of responsibility<br />
with regard to human life.<br />
En base a un artículo ya publicado en esta revista (StMor 26 (1998)<br />
523-552), el autor continúa su análisis sobre el Estado Vegetativo<br />
Persistente (EVP): estudiaba la situación personal de estas personas, al<br />
igual que los criterios para orientar las decisiones respecto a la terapia<br />
y a las ayudas que se deben proporcionar. En este segundo artículo examina,<br />
en primer lugar, el problema de quién debe ser la persona idónea<br />
para decidir sobre pacientes que se encuentran en la imposibilidad de<br />
hacerlo personalmente. Hace referencia especial a las decisiones previas<br />
y a la voluntad del viviente. Estudia luego la cuestión fundamental de<br />
la disponibilidad de la vida y, por tanto, cuando se planea su actual<br />
supresión o se toma semejante decisión, ya por parte del médico o de la<br />
persona que asiste al paciente, pueden considerarse como un ejercicio
STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 411<br />
razonable de autonomía personal y de responsabilidad en cuanto a la<br />
vida humana.<br />
—————<br />
The author is associate Professor of Bioethics at the Alphonsian<br />
Academy.<br />
El autor es profesor adjunto de Bioética en la Academia<br />
Alfonsiana.<br />
—————
413<br />
StMor 37 (1999) 413-429<br />
RÉAL TREMBLAY C.Ss.R.<br />
VARIATIONS THÉRÉSIENNES<br />
SUR LE THÈME DE “L’ENFANT PRODIGUE”<br />
“(Dans l’Évangile) je trouve tout ce<br />
qui est nécessaire à ma pauvre<br />
petite âme. J’y découvre toujours de<br />
nouvelles lumières, des sens cachés<br />
et mystérieux…”<br />
THÉRÈSE DE LISIEUX<br />
Le titre de ces pages convient exactement au type d’exégèse<br />
que Thérèse fait de la péricope biblique de “l’enfant prodigue”<br />
(cf. Lc 15, 11-32) que l’on sait lui tenir particulièrement à coeur.<br />
Les variations musicales par exemple ont toujours comme<br />
point de départ un thème à ligne mélodique réduite à l’essentiel<br />
et, par là, parfaitement identifiable. Pensons entre bien d’autres<br />
modèles aux Goldberg-Variationen de J.-S. Bach. En tête de<br />
l’opus qui porte justement ce nom 1 , le compositeur met bien en<br />
évidence le thème qui servira de base aux trente modifications<br />
d’ordre modal, rythmique, mélodique ou autre qui suivront.<br />
Il en est un peu ainsi pour Thérèse en ce qui a trait à notre<br />
parabole. À l’horizon de sa pensée, il y a le texte évangélique en<br />
sa ligne de fond que, pratiquement, elle suppose connu de ses<br />
lecteurs. Tantôt elle le cite en filigrane et y fait allusion comme<br />
à un tout; tantôt elle en retient un aspect accompagné<br />
ordinairement d’une citation explicite. Dans les deux cas, elle y<br />
rattache des commentaires variés et très personnels qui ouvrent<br />
des perspectives souvent neuves dans l’histoire de<br />
l’interprétation de cette parabole.<br />
Dans les pages qui vont suivre, nous voudrions les recueillir<br />
1<br />
Pour plus de détails sur ce point, voir les considérations critiques de<br />
G. CANTAGREL publiées dans la pochette du disque de la compagnie<br />
Astrée/France: Johann Sebastian Bach, Variations Goldberg (interpr. Blandine<br />
Verlet), 1993, 4-7.
414 RÉAL TREMBLAY<br />
pour compléter les réflexions faites ailleurs 2 et ainsi démontrer<br />
avec une évidence encore plus grande la signification qu’un<br />
aspect non marginal de sa contribution doctrinale peut prendre<br />
dans l’hodie de grâce d’une l’Église et d’un monde sur le point de<br />
franchir le nouveau millénaire.<br />
Nous procèderons en trois étapes en nous laissant guider en<br />
grande partie par Thérèse elle-même et en tenant compte, là où<br />
ce sera nécessaire pour la clarté de la pensée, de la chronologie<br />
des textes. Dans les deux premières, nous fixerons notre<br />
attention sur les protagonistes de la parabole, entendons sur les<br />
deux fils d’abord (I) et sur le père ensuite (II), en les considérant<br />
comme points de cristallisation de la réflexion de notre docteur.<br />
Dans la troisième, nous tenterons de tirer quelques lignes<br />
majeures de l’interprétation thérésienne du texte sacré pour<br />
ensuite les mesurer aux résultats essentiels de l’exégèse<br />
scientifique (III).<br />
I. Les deux “fils” de la parabole<br />
À titre de préliminaire, notons l’habitude de Thérèse<br />
d’inscrire, comme des fils en un tissu, les textes scripturaires les<br />
plus estimés d’elle dans la trame concrète du quotidien. Que ce<br />
soit implicitement ou explicitement, la Bible a toujours chez elle<br />
un rapport immédiat à la vie, la sienne et celle des autres qui lui<br />
sont proches. Symptomatique à cet égard est l’usage qu’elle fait<br />
d’un extrait de la “prière sacerdotale” de Jésus (Jn 17, 4-24). Se<br />
voyant arrivée à la fin de sa vie terrestre et désirant que ceux que<br />
Dieu a confiés à sa sollicitude de contemplative soient en<br />
quelque sorte associés à sa destinée éternelle (juillet 1897), elle<br />
coule sa prière en celle du Seigneur au point d’en modifier<br />
grammaticalement le texte et ainsi de se substituer à la personne<br />
même de Jésus: “«Mon Père, je souhaite qu’où je serai, ceux que<br />
vous m’avez donnés y soient avec moi, et que le monde<br />
2<br />
R. TREMBLAY, Brèves réflexions sur la signification du doctorat de Thérèse<br />
de Lisieux pour le message moral de l’Église d’aujourd’hui, dans StMor<br />
36(1998), 577-586.
VARIATIONS THÉRÉSIENNES SUR LE THÈME DE “ L ’ ENFANT PRODIGUE ” 415<br />
connaisse que vous les avez aimés comme vous m’avez aimée<br />
moi-même»” 3 .<br />
L’audace dont Thérèse fait preuve ici nous conduit<br />
directement à la première tranche de notre recherche.<br />
1. Le fils aîné<br />
À la suite du passage à peine cité, Thérèse écrit:<br />
“Oui Seigneur, voilà ce que je voudrais répéter après vous,<br />
avant de m’envoler en vos bras. C’est peut-être de la témérité?<br />
Mais non depuis longtemps vous m’avez permis d’être<br />
audacieuse avec vous, comme le père de l’enfant prodigue<br />
parlant à son fils aîné, vous m’avez dit: «Tout ce qui est à moi est<br />
à toi.» Vos paroles, ô Jésus, sont donc à moi et je puis m’en servir<br />
pour attirer sur les âmes qui me sont unies les faveurs du Père<br />
Céleste” 4 .<br />
Vouloir répéter sous cette forme la prière du Seigneur est-il<br />
“téméraire”? Thérèse se pose la question et y répond par la<br />
négative en évoquant justement la figure du fils aîné de la<br />
parabole. Lui qui n’a pas, comme le fils cadet, quitté la maison<br />
paternelle mais qui y est resté, il s’entend dire par le père: “Toi,<br />
mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est<br />
à toi” (Lc 15, 31). Il est important ici de bien identifier le noyau<br />
de la pensée. Thérèse n’insiste pas directement sur l’opposition<br />
entre rester à la maison ou la quitter, ni sur la supériorité, en<br />
raison de sa fidélité, de l’aîné sur le cadet. Elle table plutôt sur le<br />
fait d’être pleinement de la maison et, par là, d’être propriétaire<br />
de ce qui appartient (les paroles de Jésus) au père (ici identifié à<br />
Jésus 5 ). Dans cette foulée, elle ajoute qu’elle peut disposer de ces<br />
biens pour faire descendre sur les personnes qui lui sont<br />
confiées la bienveillance du Père du ciel. C’est de cette manière<br />
3<br />
Manuscrit C 34v o , dans THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE,<br />
Oeuvres complètes, Paris, 1996, 282. (C’est moi qui souligne).<br />
4<br />
Ibid. (C’est Thérèse qui souligne).<br />
5<br />
Nous reviendrons sur ce point un peu plus bas.
416 RÉAL TREMBLAY<br />
que Thérèse justifie son audace dont elle est parfaitement<br />
consciente. Comme l’aîné de la parabole, elle est de la famille et,<br />
à ce titre, ce qui est au père est à elle. Elle peut donc oser se<br />
comporter comme propriétaire du bien paternel et en user pour<br />
l’avantage de ses amis.<br />
Dans une situation bien différente, Thérèse justifie son<br />
audace en se mettant, sans le dire explicitement, à la place du<br />
fils aîné de la parabole. Au cours de sa visite de l’Église de la<br />
Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome (novembre 1887), elle<br />
raconte avoir “coulé (son) petit doigt dans un des jours du<br />
reliquaire” et ainsi avoir pu “toucher au clou qui fut baigné du<br />
sang de Jésus …”. Et elle ajoute dans le récit qu’elle fait de cette<br />
épisode en 1895:<br />
“J’étais vraiment par trop audacieuse!… Heureusement le<br />
bon Dieu qui voit le fond des coeurs sait que mon intention était<br />
pure et que pour rien au monde je n’aurais voulu lui déplaire,<br />
j’agissais avec Lui comme un enfant qui se croit tout permis et<br />
regarde les trésors de son Père comme les siens” 6 .<br />
C’est au fond une donnée en substance identique à la<br />
précédente qui s’affirme ici, celle d’être enfant de la maison et de<br />
pouvoir en conséquence considérer les biens du père comme<br />
siens et les utiliser à sa guise, n’excluant même pas une certaine<br />
démesure.<br />
Dans une lettre à Céline datée du 6 juillet 1893, Thérèse<br />
s’identifie encore au fils aîné de la parabole, mais pour des<br />
motifs différents des cas précédents. Comme elle est en train de<br />
passer par une période de sécheresse spirituelle, elle se compare<br />
au premier-né de la famille pour dire qu’elle n’a pas besoin,<br />
comme le fils cadet, du “festin” qui lui est offert pour marquer<br />
son retour à la maison paternelle. Elle est toujours avec<br />
Jésus/père. Voilà sa joie par-delà ses peines!<br />
“Ta Thérèse ne se trouve pas dans les hauteurs à ce moment<br />
mais Jésus lui apprend «A tirer profit de tout, du bien et du mal<br />
6<br />
Manuscrit A 66r o -v o , dans o.c., 181. (C’est Thérèse qui souligne).
VARIATIONS THÉRÉSIENNES SUR LE THÈME DE “ L ’ ENFANT PRODIGUE ” 417<br />
qu’elle trouve en soi». Il lui apprend à jouer à la banque de<br />
l’amour ou plutôt, non Il joue pour elle sans lui dire comment Il<br />
s’y prend car cela est son affaire et non pas celle de Thérèse, ce<br />
qui la regarde c’est de s’abandonner, de se livrer sans rien<br />
réserver, pas même la jouissance de savoir combien la banque lui<br />
rapporte. Mais après tout elle n’est pas l’enfant prodigue, ce n’est<br />
donc pas la peine que Jésus lui fasse un festin «puisqu’elle est<br />
toujours avec Lui»” 7 .<br />
Ailleurs elle s’identifie encore implicitement au fils aîné qui<br />
jouit de tous les biens de son père pour dire qu’elle possède plus<br />
que le fils prodigue pourtant lui aussi objet de l’amour de Jésus<br />
et principal invité d’un “festin splendide” offert pour souligner<br />
son repentir (vs 1):<br />
“Jésus avec amour tu reçois le prodigue<br />
Mais les flots de ton Coeur pour moi n’ont pas de digue<br />
Mon Bien-Aimé, mon Roi<br />
Que tes biens sont à moi<br />
Rappelle-toi” 8 .<br />
Sans aucune allusion explicite à la figure de la parabole,<br />
l’idée d’être en possession de tous les biens de Jésus/père revient<br />
dans une récréation pieuse de juillet 1895. En l’occurrence, c’est<br />
Jésus lui-même qui répond à Marthe qui lui demande ce qu’elle<br />
peut espérer dans l’au-delà après tous les travaux faits pour lui:<br />
“Au Ciel ma gloire sera vôtre/Et tous mes biens seront à vous” 9 .<br />
Comme on l’aura sans doute remarqué, ces cinq renvois plus<br />
ou moins explicites au fils aîné de la parabole de Luc marquent<br />
une certaine évolution dans la pensée thérésienne. Au point de<br />
départ, l’allusion à cette figure sert à traduire la conviction de<br />
Thérèse de faire partie de la famille de Dieu. Fille de la maison,<br />
elle prend ensuite conscience que ce qui appartient au “père” lui<br />
appartient aussi. De là, elle comprend qu’elle peut user, pour<br />
7<br />
Lettre 142 1v o , dans o.c., 464. (C’est Thérèse qui souligne). Remarquons<br />
encore ici l’application du texte scripturaire à sa situation.<br />
8<br />
Poésie 24, str. 18, vs 5-9, dans o.c., 697.<br />
9<br />
Récréation pieuse 4 4v o , dans o.c., 871.
418 RÉAL TREMBLAY<br />
elle-même et pour les autres, des biens paternels comme elle<br />
l’entend 10 , sans exclure même une certaine audace 11 .<br />
2. Le fils cadet<br />
Selon son habitude d’entremêler les textes scripturaires à la<br />
vie, Thérèse a déjà parlé du fils cadet de la parabole pour dire<br />
qu’elle ne s’y identifiait pas. Elle revient à la charge dans un<br />
passage théologiquement très dense du Manuscrit A (1895).<br />
Lisons d’abord le texte avant de le commenter brièvement:<br />
“A moi Il (le Bon Dieu) a donné sa Miséricorde infinie et c’est<br />
à travers elle que je contemple et adore les autres perfections<br />
Divines!… Alors toutes m’apparaissent rayonnantes d’amour, la<br />
Justice même (et peut-être encore plus que toute autre) me<br />
semble revêtue d’amour…<br />
Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est Juste, c’està-dire<br />
qu’Il tient compte de nos faiblesses, qu’Il connaît<br />
parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc aurais-je<br />
peur? Ah! le Dieu infiniment juste qui daigna pardonner avec<br />
tant de bonté toutes les fautes de l’enfant prodigue, ne dit-il pas<br />
être Juste aussi envers moi qui «suis toujours avec Lui»?…<br />
Cette année le 9 juin fête de la Sainte Trinité, j’ai reçu la<br />
grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire être<br />
aimé” 12 .<br />
Dieu juste ou Dieu Amour? Thérèse refuse de se voir<br />
entraînée dans ce dilemme. Nous savons que, dans les carmels<br />
10<br />
Cf. Manuscrit C 33v o , dans o.c., 280.<br />
11<br />
Attitude de Thérèse qui se manifeste surtout dans ses rapports avec<br />
Dieu et qui est directement proportionnelle à la conscience qu’elle a d’être<br />
fragile et faible. Cf. en plus des textes cités en ces pages: Manuscrit A 48v o ,<br />
dans o.c., 148; Manuscrit B 3v o , 5r o , dans o.c., 226. 230; etc.<br />
12<br />
Manuscrit A 83v o -84r o , dans o.c., 211-212. (C’est Thérèse qui<br />
souligne).
VARIATIONS THÉRÉSIENNES SUR LE THÈME DE “ L ’ ENFANT PRODIGUE ” 419<br />
français du temps de Thérèse et même au carmel de Lisieux, on<br />
insistait beaucoup sur la justice de Dieu. Nous savons également<br />
qu’il y existait - et Thérèse le note explicitement - des “âmes qui<br />
s’offr(aient) comme victimes à la Justice de Dieu afin de<br />
détourner et d’attirer sur elles les châtiments réservés aux<br />
coupables” 13 .<br />
La jeune carmélite brille ici par son équilibre. Elle ne nie pas<br />
que Dieu soit “infiniment juste”. Mais elle choisit de contempler<br />
cette “perfection divine” à travers la “miséricorde infinie” qui lui<br />
semble encore plus fondamentale. Cela la conduit à comprendre<br />
la justice non pas en termes d’exigence et de punition, mais en<br />
termes de prise en compte de “la fragilité de la nature” humaine.<br />
Dès lors, il n’y a pas de place pour la “peur”.<br />
Thérèse reconnaît le fondement scripturaire de sa réflexion<br />
dans l’attitude de Dieu face à l’enfant prodigue, attitude qu’elle<br />
s’applique ensuite par contraste. Si Dieu pardonne avec tant de<br />
bonté (Dieu est Amour) au fils cadet dont il mesure pourtant<br />
exactement la faiblesse (Dieu est juste), ne doit-il pas a fortiori<br />
exercer le même type de justice à l’égard de celui qui ne l’a<br />
jamais quitté, entendons le fils aîné auquel s’identifie Thérèse?<br />
Comme objet de la justice amoureuse de Dieu, Thérèse se<br />
rattache encore ici au fils aîné de la parabole, mais à partir du<br />
cadet qui lui sert, pour ainsi dire, de contrefort. Si Dieu se<br />
comporte avec tant d’amour à l’égard de celui qui l’a quitté et<br />
donc qui mérite moins, selon quelle intensité d’amour se<br />
comportera-t-il envers celui qui est resté et donc qui mérite<br />
plus?<br />
13<br />
Ibid., 84r o , dans o.c., 212. À l’appui de la constatation de Thérèse,<br />
l’auteur des notes ajoutées à L’Offrande de moi-même comme Victime<br />
d’Holocauste à l’Amour Miséricordieux du Bon Dieu (Pri, 6) fait l’observation<br />
suivante qu’il n’est pas sans importance de transcrire ici: “On peut se<br />
demander si, le 9 juin 1895, Thérèse ne pense pas plus particulièrement à<br />
cette soeur Marie de Jésus, carmélite de Luçon, dont la circulaire vient<br />
justement d’arriver à Lisieux le 8 juin. Cette soeur «s’est bien souvent offerte<br />
comme victime à la Justice divine», révèle sa circulaire. Son agonie le<br />
Vendredi Saint 1895 est terrible. La mourante laisse échapper ce cri<br />
d’angoisse: «Je porte les rigueurs de la Justice divine… la Justice divine!… la<br />
Justice divine!…» Et encore: «Je n’ai pas assez de mérites, il faut en acquérir.»<br />
Le récit est impressionnant, il a pu frapper les auditrices” o.c., 1446.
420 RÉAL TREMBLAY<br />
Deux textes rédigés par une Thérèse désormais aux portes de<br />
la mort nous parlent encore du fils cadet de la parabole. Le<br />
premier (début juillet 1897) renvoie pratiquement aux toutes<br />
dernières lignes du Manuscrit C. Il se lit comme suit:<br />
“Ce n’est pas à la première place, mais à la dernière que je<br />
m’élance, au lieu de m’avancer avec le pharisien, je répète,<br />
remplie de confiance, l’humble prière du publicain, mais surtout<br />
j’imite la conduite de Madeleine, son étonnante ou plutôt son<br />
amoureuse audace qui charme le Coeur de Jésus, séduit le mien.<br />
Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les<br />
péchés qui se peuvent commettre, j’irais le coeur brisé de<br />
repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il<br />
chérit l’enfant prodigue qui revient à Lui. Ce n’est pas parce que<br />
Le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde a préservé mon<br />
âme du péché mortel que je m’élève à Lui par la confiance et<br />
l’amour” 14 .<br />
Thérèse affirme ici la conscience qu’elle a de l’amour que<br />
Jésus porte au fils prodigue qui se convertit, amour qui se<br />
présente comme l’assise inébranlable de sa confiance envers<br />
Dieu 15 . Cela est si vrai que même coupable des pires péchés elle<br />
irait sans hésitation se jeter, comme le cadet de la parabole, dans<br />
les bras du père/Jésus. Thérèse s’identifie donc ici<br />
14<br />
Manuscrit C 36v o -37r o , dans o.c., 285. (C’est Thérèse qui souligne).<br />
15<br />
Intéressant ce témoignage de Marie de la Trinité lors du procès de<br />
l’Ordinaire: “Je lui fis de la peine un jour en ne voulant pas reconnaître les<br />
torts qu’elle me reprochait. La cloche nous appelant, nous nous quittâmes<br />
brusquement pour nous rendre à une réunion de communauté. Je<br />
commençai alors à regretter ma conduite et m’approchant d’elle, je lui dis<br />
tout bas: «J’ai été bien méchante tout à l’heure...». Je ne lui en dis pas<br />
davantage et je vis aussitôt ses yeux se remplir de larmes. Me regardant avec<br />
beaucoup de tendresse, elle me dit: «... Non, jamais je n’ai senti si vivement<br />
avec quel amour Jésus nous reçoit quand nous lui demandons pardon après<br />
l’avoir offensé. Si moi, sa pauvre petite créature, j’ai senti tant d’amour pour<br />
vous au moment où vous êtes revenue à moi, que doit-il se passer dans le<br />
coeur du bon Dieu quand on revient vers lui?…»” Procès de béatification et<br />
canonisation de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face. I. Procès<br />
informatif ordinaire, Rome, 1973, 455.
VARIATIONS THÉRÉSIENNES SUR LE THÈME DE “ L ’ ENFANT PRODIGUE ” 421<br />
hypothétiquement au fils prodigue en tant qu’il est le réceptacle<br />
du pardon illimité de Dieu. Dans ces conditions, c’est selon la<br />
logique la plus stricte qu’elle précise ce qui suit: ce n’est pas<br />
l’oeuvre de Dieu en sa faveur ou le fait d’avoir été protégée du<br />
péché mortel par la “prévenante miséricorde” de Dieu qui la<br />
rend confiante comme le publicain ou audacieuse comme<br />
Madeleine. C’est Dieu lui-même, plus précisément Jésus en sa<br />
bonté sans mesure envers les pécheurs.<br />
Un autre texte pratiquement de la même époque (26 juillet<br />
1897) vient confirmer et compléter ce passage où en définitive<br />
Thérèse centre toute son existence sur l’amour miséricordieux<br />
de Dieu. Elle parle en l’occurrence de la “joie” qu’éprouve le<br />
Seigneur à pardonner et des conditions nécessaires pour “jouir<br />
(des) trésors” de “l’amour miséricordieux de Jésus” comme la<br />
demande de pardon, l’humilité, etc. Remarquons en passant<br />
l’importance conférée à la joie que l’on retrouve aussi bien chez<br />
Dieu qui pardonne que chez l’homme qui reçoit son pardon:<br />
“Pour ceux qui aiment (Jésus) et qui viennent après chaque<br />
indélicatesse Lui demander pardon en se jetant dans ses bras,<br />
Jésus tressaille de joie, Il dit à ses anges ce que le père de l’enfant<br />
prodigue disait à ses serviteurs: «Revêtez-le de sa première robe,<br />
mettez-lui un anneau au doigt, réjouissons-nous.» Ah! mon<br />
frère, que la bonté, l’amour miséricordieux de Jésus sont peu<br />
connus!… Il est vrai que pour jouir de ces trésors, il faut<br />
s’humilier, reconnaître son néant, et voilà ce que beaucoup<br />
d’âmes ne veulent pas faire, mais (…) ce n’est pas ainsi que vous<br />
agissez, aussi la voie de la confiance simple et amoureuse est<br />
bien faite pour vous” 16 .<br />
La figure de l’enfant prodigue est encore ici le point de<br />
référence de la pensée. La joie de Dieu et des anges avec lui 17<br />
vient du fait qu’il retrouve son fils perdu et qu’il lui donne accès<br />
16<br />
Lettre 261 2r o , dans o.c., 619. (C’est Thérèse qui souligne).<br />
17<br />
“Rappelle-toi de la fête des Anges,/ Rappelle-toi de l’harmonie des<br />
Cieux/ Et de la joie des sublimes phalanges/ Lorsqu’un pécheur vers toi lève<br />
les yeux” Poésie 24, str. 16, v. 1-4, dans o.c., 696.
422 RÉAL TREMBLAY<br />
à ses “trésors”. La joie du fils en revanche vient du fait qu’il est,<br />
en dépit de son indignité reconnue, le dépositaire des “trésors”<br />
paternels. Malgré ses faiblesses et à la condition de reconnaître<br />
“son néant” 18 , l’interlocuteur de Thérèse pourra donc s’engager<br />
sur “la voie de la confiance simple et amoureuse”.<br />
Récapitulons. Alors que dans le premier texte Thérèse<br />
s’identifie encore au fils aîné de la parabole considéré comme<br />
objet de la justice amoureuse de Dieu et qu’elle le fait en se<br />
démarquant de la sorte du fils cadet comme le plus du moins,<br />
dans le second texte elle s’identifie plutôt au fils prodigue.<br />
Pourquoi ce changement de perspective? C’est que son point de<br />
référence n’est plus le même en ce sens que ce n’est plus l’oeuvre<br />
de Dieu accomplie en sa faveur qui a priorité, mais Dieu luimême<br />
dans l’exercice de sa miséricorde. Le raisonnement est en<br />
substance le suivant: puisque Dieu est d’autant plus lui-même,<br />
c’est-à-dire Amour, qu’il a devant lui un homme qui se reconnaît<br />
faible et besogneux de tout 19 , elle n’hésite pas à s’identifier au<br />
cadet, même au pire des pécheurs, pour laisser à Dieu la joie<br />
d’être lui-même. Dans le troisième texte, on est mis en présence<br />
de la même conception de la divinité comme de l’invitation<br />
pressante adressée à son correspondant de permettre à Dieu<br />
d’être Dieu en son égard. Présente en sourdine est l’idée, déjà<br />
rencontrée dans le paragraphe précédent, de la possession ou de<br />
la jouissance des “trésors” de Jésus cette fois-ci cependant<br />
attribuée au cadet.<br />
18<br />
Cette expression de Thérèse dans le présent contexte n’est pas le<br />
résultat du hasard ou de la stéréotypie. En témoigne ce qu’elle écrit en<br />
rapport avec son “Offrande à l’Amour miséricordieux”: “Oui, pour que<br />
l’amour soit satisfait, il faut qu’Il s’abaisse jusqu’au néant et qu’il transforme<br />
en feu ce néant…” Manuscrit B 3v o , dans o.c., 227. (C’est Thérèse qui<br />
souligne).<br />
19<br />
Est-ce à dire que Thérèse favoriserait l’image d’un Dieu qui aurait<br />
besoin d’un homme écrasé pour être ce qu’il est? Certes non! Mais d’un Dieu<br />
qui ne peut rien faire pour l’homme qui ne vit pas dans la vérité ou dans la<br />
reconnaissance de ce qu’il est? Certes oui! Dans la pensée thérésienne,<br />
l’amour et la vérité s’embrassent toujours.
VARIATIONS THÉRÉSIENNES SUR LE THÈME DE “ L ’ ENFANT PRODIGUE ” 423<br />
II. Le “père” de la parabole<br />
Il est étonnant de constater que le père de la parabole<br />
lucanienne n’est jamais, pour Thérèse, le Père céleste ou le Père<br />
de Jésus, mais Jésus lui-même 20 . Cela est d’autant plus frappant<br />
que le texte scripturaire oriente spontanément la pensée vers la<br />
figure du “Père qui est aux cieux” qui du reste est loin d’être<br />
absente de la pensée thérésienne 21 . Qu’est-ce qui pourrait<br />
expliquer ce fait? Après réflexion, nous pensons qu’il faille<br />
recourir aux rapports de Thérèse à son père de la terre 22 . Ces<br />
rapports furent en son cas si intimes et si profonds qu’ils lui<br />
serviront, une fois devenue religieuse, de lentilles à travers<br />
lesquelles elle considèrera son amour pour Dieu envisagé aussi<br />
bien comme Père que comme Fils 23 .<br />
Lors de la mort de Monsieur Martin survenue le 29 juillet<br />
1894, Thérèse écrit à sa soeur Céline cette phrase qui en dit long<br />
dans la ligne de ce que nous venons de suggérer: “Il (Jésus) nous<br />
a pris celui que nous aimions avec tant de tendresse […], mais<br />
n’est-ce pas afin que nous puissions dire véritablement: «Notre<br />
Père qui êtes dans les Cieux»” 24 . L’amour filial de Thérèse pour<br />
son père terrestre est, maintenant qu’il a quitté cette terre,<br />
reporté au Père céleste et vécu en une relation renouvelée, voire<br />
même plus authentique avec lui. Soit qu’elle parle du Père à<br />
travers des textes bibliques qui le mentionnent explicitement 25 ,<br />
soit qu’elle le nomme elle-même, comme en cette expression<br />
20<br />
Voir les textes à peine cités. - Même si, à première vue, le passage du<br />
Manuscrit A transcrit plus haut (cf. à la note 6) pouvait laisser planer un<br />
doute sur cette affirmation, rien ne nous autorise à penser que ce texte soit<br />
de teneur différente que les autres de même venue.<br />
21<br />
Cf. Manuscrit A 75v o , dans o.c., 197; Manuscrit C 19v o , 28v o , dans o.c.,<br />
260.273; etc.<br />
22<br />
Cf. Manuscrit A 14v o , 17r o -v o , 21r o -v o , 50r o , 55r o , 57v o , 59r o , 69r o , 73r o ,<br />
dans o.c., 91.96.102.151.161.165.168.185-186.192.<br />
23<br />
Sur ce rapport entre la nature et le surnaturel chez Thérèse, nous<br />
suivons H.U VON BALTHASAR, Therese von Lisieux. Geschichte einer Sendung,<br />
Leipzig, 1958, 109 (ouvrage déjà publié en 1950 à Olten). Par contre voir: A.<br />
COMBES, Sainte Thérèse de Lisieux et sa mission, Paris, 1954, 218-219.<br />
24<br />
Lettre 127 v o , dans o.c., 437.<br />
25<br />
Voir par exemple Manuscrit C 34r o -v o , dans o.c., 281.
424 RÉAL TREMBLAY<br />
proche de l’“Abba” de Rm 8, 15 26 , “Papa le bon Dieu” 27 , tous ces<br />
textes et particulièrement ceux qui évoquent le type de son<br />
rapport avec le Père sont à interpréter dans la foulée de son<br />
expérience humaine de la paternité de son “papa” de la terre.<br />
La même observation pourrait être faite à l’égard de l’amour<br />
qu’elle témoigne au Fils. Le prouve le fait qu’elle comprend la<br />
maladie de son père terrestre à travers la figure du “Serviteur”<br />
souffrant d’Is 53 28 . Si la passion de Monsieur Martin lui rappelle<br />
tout spontanément celle du Christ, il n’y a rien d’étonnant à ce<br />
que la figure du Christ qu’elle aime soit en retour associée à celle<br />
de son père. Ce raccord se justifie d’autant plus qu’il est question<br />
en l’occurrence de la miséricorde infinie de Jésus et qu’entre elle<br />
et la bonté presque légendaire de son père de la terre 29 il y a<br />
profonde similitude 30 . Nous retrouvons ainsi le rapprochement<br />
père/Jésus de la parabole lucanienne accompagné d’une<br />
explication qui fait qu’il ne détonne plus ou détonne un peu<br />
moins.<br />
À ce sujet, ne peut-on pas faire un pas de plus et voir se<br />
profiler en filigrane sous la figure du père/Jésus du texte biblique<br />
la présence du Père? Si Jésus est considéré par Thérèse comme<br />
“père” en raison de l’expérience qu’elle fait de l’amour de son<br />
père de la terre et que la même expérience détermine ses<br />
rapports filiaux avec le Père du ciel, serait-ce mal à propos de<br />
penser que le “père” de la parabole est pour elle le lieu d’une<br />
superposition des deux personnes divines? On pourrait trouver<br />
un appui scripturaire à cette hypothèse dans le fait que Thérèse<br />
n’accorde aucune attention au titre “Père à jamais” 31 attribué à<br />
26<br />
Qu’elle connaît et qu’elle cite explicitement dans un autre contexte: cf.<br />
Manuscrit C 19v o , dans o.c., 260.<br />
27<br />
Cahier Jaune, 5.6.4, dans o.c., 1009.<br />
28<br />
Cf. Manuscrit A 20v o , 73r o , dans o.c., 101.192. Sur l’importance de ce<br />
passage d’Isaïe dans la spiritualité thérésienne et sur son lien avec le culte de<br />
la Sainte-Face, voir la note 321 de l’o.c., 1266.<br />
29<br />
Voir Manuscrit A 13v o , dans o.c., 89.<br />
30<br />
Voir le texte impressionnant de ce point de vue dans la Lettre 258 2r°-<br />
2v o , dans o.c., 615.<br />
31<br />
Comme c’est aussi le cas par exemple pour l’expression “mes petits<br />
enfants” de Jn 13, 33 qu’elle ne cite pas. Par contre, elle cite Jn 21, 5: “les
VARIATIONS THÉRÉSIENNES SUR LE THÈME DE “ L ’ ENFANT PRODIGUE ” 425<br />
l’Enfant de la prophétie messianique d’Is 9, 5 alors qu’elle en<br />
retient les titres “Dieu fort” et “Prince de la paix” 32 . Autant dire<br />
qu’il y aurait chez elle une espèce de souplesse dans l’attribution<br />
de la paternité de la parabole à Jésus, souplesse qui lui<br />
permettrait de voir apparaître comme en arrière-plan ou comme<br />
en une seconde profondeur les traits du Père à travers ceux de<br />
son Fils. “Qui m’a vu a vu le Père”, dit Jésus à Philippe (Jn 14, 9).<br />
Même si Thérèse ne cite jamais explicitement cette parole de<br />
Jésus dans son oeuvre, on pourrait penser en l’occurrence qu’elle<br />
l’a bel et bien transcrite, mais dans la trame de son existence.<br />
III. L’opus thérésien et l’exégèse scientifique<br />
Avant de passer à l’exégèse dans le but indiqué plus haut, il<br />
convient d’attirer l’attention sur les traits majeurs qui émergent<br />
des “variations” de Thérèse sur le texte lucanien. Ces traits<br />
feront bien voir que nous nous trouvons en présence d’un opus<br />
parfaitement identifiable et jouissant, en dépit de sa brièveté,<br />
d’une densité théologique de nature à lui conférer une place de<br />
choix dans l’ensemble du corpus doctrinal thérésien.<br />
Trois motifs mélodiques principaux pourraient être dégagés<br />
de la réflexion de notre docteur.<br />
Un premier consiste dans la prise de conscience de plus en<br />
plus vive que “Dieu est Amour” (1 Jn 4, 8.16) et qu’il prend<br />
plaisir à faire miséricorde à ceux qui le lui demandent. Tous les<br />
attributs de Dieu, y compris sa justice, doivent être considérés<br />
sous cet angle.<br />
Un second motif mélodique se réfère à l’homme objet de<br />
cette miséricorde. Moyennant l’humble reconnaissance de son<br />
état véritable, cet homme est réintroduit dans l’intimité de Dieu<br />
à titre de fils. Cela vaut surtout pour le cadet qui, en raison<br />
justement du Dieu de la miséricorde, est mis en possession,<br />
enfants, avez-vous du poisson?” sans lui attacher une importance<br />
particulière (cf. Lettre 161 v o , dans o.c., 494).<br />
32<br />
“Dieu fort”: cf. Lettre 213 1v o , dans o.c. 569; Lettre 220 1r o dans o.c.,<br />
575. “Prince de la paix”: cf. Poésie 24, str. 23, v. 7, dans o.c., 698; Récréation<br />
pieuse 6 2v o , 8v o , dans o.c., 891.906.
426 RÉAL TREMBLAY<br />
comme l’aîné, de tous les “trésors” paternels et peut en disposer<br />
comme bon lui semble, non pas pour les dissiper, mais pour le<br />
salut des frères.<br />
Un troisième motif enfin concerne Jésus qui, en tant que<br />
miséricordieux, est identifié au père de la parabole. Ce rôle<br />
attribué au Fils ne porte pas ombrage ou n’enlève rien au “Père<br />
des miséricordes” (2 Co 1, 3; cf. Ep 2, 4) puisque, en définitive, il<br />
ne fait qu’user des biens de son Père et en manifester la bonté<br />
sans limite à l’égard des pécheurs repentants.<br />
Comment un exégète de métier réagirait-il devant cet opus<br />
thérésien? Le jugerait-il fidèle ou non aux intentions profondes<br />
du texte sacré? Sa réponse pourrait-elle être à la fois oui et non<br />
en ce sens par exemple que, tout en étant fidèle à des éléments<br />
centraux de la parabole, Thérèse en aurait laissé d’autres<br />
importants dans l’ombre au profit d’accentuations bien à elle<br />
plus suggérées qu’explicitement affirmées par le texte biblique?<br />
Pour en savoir plus long sur ce point, ouvrons un commentaire<br />
autorisé de l’Évangile de Luc.<br />
La lecture attentive du commentaire de Ernst par exemple 33<br />
laisse clairement voir que Thérèse a visé juste en choisissant<br />
cette parabole pour présenter Dieu sous les traits de la<br />
miséricorde. “Le thème prioritaire (de la parabole), écrit-il après<br />
avoir considéré divers types d’interprétation sur ce point, est<br />
avant comme après l’amour sans limite de Dieu. «Ainsi est Dieu,<br />
si bon, si bienveillant, si riche en miséricorde, si débordant<br />
d’amour» (Jeremias)”. Et il ajoute un peu plus loin: “À sa façon,<br />
Luc a donné une forme à «l’évangile dans l’évangile» que Paul a<br />
porté à la formulation «la justification du pécheur par grâce»” 34 .<br />
Thérèse a encore visé juste lorsqu’elle insiste sur la priorité<br />
et le caractère illimité de l’amour de Dieu qui réinsère dans la<br />
famille le fils qui s’en était séparé et pose ce geste avant même<br />
que le fils le lui demande. Commentant les comportements du<br />
père de la parabole (la course au devant du fils, l’étreinte et le<br />
baiser) (v.20), notre exégète écrit: Ces gestes “font voir à celui qui<br />
revient à la maison qu’il est pleinement accueilli comme fils<br />
33<br />
J. ERNST, Das Evangelium nach Lukas (RNT), Regensburg, 1976 4 .<br />
34<br />
O.c., 455-456. (C’est l’auteur qui souligne et c’est moi qui traduis).
VARIATIONS THÉRÉSIENNES SUR LE THÈME DE “ L ’ ENFANT PRODIGUE ” 427<br />
même avant qu’il ait eu l’opportunité d’avouer sa faute. L’amour<br />
de Dieu va toujours au devant de l’homme” 35 .<br />
Enfin Thérèse a encore visé juste lorsqu’elle a interprété<br />
christologiquement la figure du père de la parabole sans<br />
pourtant séparer Jésus de son Père. Toujours selon notre<br />
exégète, le père du texte biblique se rapporte en premier lieu à<br />
Jésus. En raison de son rapport singulier avec Dieu, il exerce luimême<br />
la miséricorde divine; en vertu de la connaissance qu’il a<br />
de la volonté du Père, il manifeste du même coup “l’attitude de<br />
Dieu le Père” à l’égard de ceux qui se convertissent 36 .<br />
Contrairement à la parabole en revanche, Thérèse ne<br />
s’arrête pas à décrire la situation tragique où aboutit le cadet par<br />
suite de l’abandon de la maison paternelle (v. 15-16) 37 comme<br />
elle ne fait aucune mention de l’incompréhension du fils aîné<br />
devant l’amour miséricordieux du père à l’égard de son fils<br />
converti (v. 29).<br />
De cette dernière partie de la parabole (v. 25-32), elle ne<br />
retient pratiquement que le second membre de la réponse du<br />
père au fils aîné: “…Tout ce qui est à moi est à toi” (v. 31) qu’elle<br />
applique aussi au cadet pardonné.<br />
Ici, me semble-t-il, se trouve la contribution spécifique de<br />
Thérèse à l’interprétation chrétienne de la parabole de Luc: la<br />
certitude d’être en possession de tous les avoirs paternels<br />
35<br />
O.c., 459. (C’est moi qui traduis).<br />
36<br />
Cf. o.c., 456. 460. – Dans son article “Substitution”, J. RATZINGER parle<br />
de cette parabole lucanienne comme d’un texte qui s’étend aux dimensions<br />
de l’ensemble de l’histoire du salut. Il écrit: “À travers le fils perdu qui revient<br />
à la maison apparaît manifestement le monde des nations, qui a poursuivi<br />
pendant des millénaires ses courses errantes loin de la maison du Père, le<br />
Dieu unique, pour se livrer aux fallacieuses réjouissances du service des<br />
idoles et finir par la banqueroute. Dans le frère juste, resté à la maison et<br />
maintenant jaloux, apparaît Israël le juste, qui ne peut tolérer le retour des<br />
païens, la bonté inconditionnelle de Dieu à l’égard des pécheurs, et qui se<br />
sent frustré de la récompense due à une persévérance séculaire dans la foi”<br />
(Encyclopédie de la foi, IV, Paris, 1966, 272). Suggestive en soi, cette idée<br />
n’affleure pourtant à nulle part dans le commentaire de Ernst.<br />
37<br />
Après avoir noté l’indifférence des hommes envers le prodigue, Ernst<br />
continue: “Tiefer konnte er nicht fallen: von den Menschen verlassen und<br />
verachtet, dazu noch ohne den Segen des Gesetzes, für den Juden ist er eine<br />
«Unperson»” o.c., 458.
428 RÉAL TREMBLAY<br />
destinés au service des frères parce que vivement consciente<br />
d’être la fille de “Papa, le bon Dieu”, d’appartenir à sa famille 38 . La<br />
prodigieuse renommée dont est l’objet l’humble carmélite de<br />
Lisieux depuis son retour à la “maison” du Père a montré qu’une<br />
telle contribution n’était pas pure fantaisie…<br />
Via Merulana, 31<br />
C.P. 2458<br />
00185 Roma<br />
Italy.<br />
RÉAL TREMBLAY, C.Ss.R.<br />
—————<br />
Summary / Resumen<br />
In a previous article in this review (StMor 36 (1998), 577-586) we<br />
attempted to reflect on the meaning which the elevation of ThérËse of<br />
Lisieux to the rank of Doctor of the Church (19th October 1997) could<br />
have for moral theology. In its essential elements, the parable of the prodigal<br />
son (Lk 15, 11-32) served us as a guide to discover in the teresian<br />
message the elements of a response to the question posed. In the present<br />
article, we wish to enrich these reflections by considering what the<br />
same sacred text can become once it is shaped by the believing intelligence<br />
of the new Doctor. As in the second panel of a diptych, similar elements<br />
return, for example the “tutiorism” of the loving mercy of God,<br />
but others are added such as the vivid consciousness of being a member<br />
of the Family of the Trinity and of being thus capable of freely availing<br />
of its “treasures”.<br />
En un artículo anterior publicado en esta revista (StMor 36 (1998)<br />
577-586) intentamos reflexionar acerca del significado que podría tener<br />
para la teología moral la elevación de Teresa de Lisieux al rango de doctora<br />
de la Iglesia (19 de octubre de 1997). La parábola del hijo pródigo<br />
(Lc 15, 11-32) nos orientó en sus elementos esenciales para descubrir<br />
38<br />
Mutatis mutandis, on sent résonner ici l’écho de ce que Jean-Baptiste<br />
dit du Seigneur: “Le Père aime le Fils; il a tout remis en sa main” (Jn 3, 35;<br />
cf. 13, 3), avoir paternel ou pouvoir que le Fils est bien conscient de posséder<br />
(cf. Jn 10, 28; 17, 2).
VARIATIONS THÉRÉSIENNES SUR LE THÈME DE “ L ’ ENFANT PRODIGUE ” 429<br />
en el mensaje teresiano las pautas de una respuesta a nuestro interrogante.<br />
Quisiéramos en este artículo enriquecer estas reflexiones, considerando<br />
qué puede quedar del mismo texto sagrado una vez modelado<br />
por la comprensión en la fe de la nueva doctora. Como en el segundo<br />
panel de un díptico, vuelven parecidos elementos, por ejemplo el “tuciorismo”<br />
del amor misericordioso de Dios, pero se añaden otros como el<br />
de la conciencia viva de ser miembro de la familia trinitaria y ser así<br />
capaz de disponer libremente de sus “tesoros”.<br />
—————<br />
The author is Professor of Fundamental Moral Theology at the<br />
Alphonsian Academy.<br />
El autor es profesor titular de moral fundamental en la<br />
Academia Alfonsiana.<br />
—————
431<br />
StMor 37 (1999) 431-451<br />
BRIAN V. JOHNSTONE C.Ss.R.<br />
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH?<br />
A REPLY TO KARL-WILHELM MERKS<br />
There is an important debate in moral theology or<br />
theological ethics between those who are seeking to revive the<br />
notion of tradition as a basic theme and those who oppose such<br />
a move. An important contribution by Karl-Wilhelm Merks<br />
presents a strong argument for the second view. 1 The purpose of<br />
this article is to offer a case for the first.<br />
Merks’s basic claim is that while tradition has indeed<br />
preserved many positive values, it has also justified things that<br />
we now recognize as evil. Since it is ambiguous, tradition itself<br />
cannot be a source of truth. That is, tradition cannot itself<br />
provide the criterion of the truly good. Where then is this to be<br />
found? Merks argues that the criterion is the human subject,<br />
seeking to give meaning to life, and in so doing experiencing the<br />
self as free and responsible. 2 Thus, the determination of the<br />
criterion of truth in ethics is the task of the responsible freedom<br />
of that subject. 3 The human subject becomes the measure of<br />
ethics in general and of the morality of traditions. Tradition has<br />
a place, but only an instrumental one in that the ethics of the<br />
person can only exist and be communicated within historical<br />
traditions. Tradition, therefore, is a means of moral education,<br />
of the communication of ethical values; it cannot be a<br />
foundation for ethics. 4<br />
In presenting his case, Merks assumes that there is a<br />
meaningful general concept of “tradition” that denotes a special<br />
1 KARL-WILHELM MERKS, “De sirenenzang van de tradities: Pleidooi voor<br />
een universele ethiek,” Bijdragen 58 (1997), 122-143.<br />
2<br />
Ibid., 131, 137.<br />
3<br />
Ibid., 137.<br />
4<br />
Ibid., 132.
432 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
kind of anthropological-cultural reality. He also presumes that<br />
we can know the way in which such realities function or the<br />
laws that govern their behavior. The Catholic tradition he<br />
considers as a special case of tradition, which, while it has<br />
specific characteristics, follows these same laws. All these<br />
presuppositions I would accept. Our positions differ in that<br />
while Merks argues that the laws or characteristic ways of<br />
behavior of tradition are such that it cannot furnish a criterion<br />
of moral truth, I propose to argue that it can.<br />
The debate is not about dogmatic questions, but about a<br />
specific issue in the area of moral theology. In particular it is<br />
concerned with a problem of moral epistemology, namely,<br />
whether or not tradition, and the Catholic tradition as an<br />
instance of tradition, can be a source of moral truth. Merks<br />
argues that it cannot. I will seek to show that this is possible.<br />
The author’ s first criticism of traditions is that they have<br />
brought ruin and destruction to many people. We can begin then<br />
with an analysis of one proven instance where a tradition did<br />
indeed destroy many, namely, when the Catholic tradition<br />
supported the execution of heretics. It may help to remind<br />
ourselves how strong was the support for this practice in the<br />
tradition.<br />
Roman law included burning as a form of summa supplicia,<br />
or maximum punishment. 5 Following Roman Law the penalty<br />
was applied in parts of Europe in the eleventh century. Pope<br />
Gregory IX (1227-1241), in his constitution Excommunicamus<br />
(1231), alligned canon law with the imperial constitution<br />
expressly allowing the burning of heretics. Leo X (1513 - 1521)<br />
in his Bull Exsurge Domine (1520), condemned the opinion of<br />
Luther that burning heretics is against the will of the Spirit. 6<br />
Heretics were executed under the authority of Popes such as<br />
Julius III, Paul IV, Pius V, Gregory XIII, Sixtus V, and Clement<br />
VIII (who ordered Giordano Bruno to be burned). 7 Eminent<br />
5 DENISE GRODZYNSKI, “Tortures mortelles et catégories sociales,” in Du<br />
châtiment dans la cité (Rome: École Française de Rome, 1984), 364.<br />
6<br />
Corp. Iur. Can. V.7.13; DS 1483.<br />
7 JAMES J. MEGIVERN, The Death Penalty (New York/Mahwah, N.J.:<br />
Paulist Press, 1997), 110, 146, 148, 150, 152, 154, 158, documents the<br />
practice of these Popes.
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 433<br />
theologians such as St. Thomas Aquinas, 8 Francisco de Vittoria, 9<br />
and Francisco Suarez 10 approved ofthe execution of heretics. St.<br />
Thomas More, also approved. 11 So Merks’s charge stands:<br />
Tradition can be destructive. How do we make moral sense of<br />
this? 12 Must we say that, considering this and similar examples,<br />
such as the approval of slavery, the moral witness of the Catholic<br />
tradition is so ambiguous that it cannot be a source of moral<br />
truth?<br />
A theory of tradition as a way of moral knowledge<br />
Merks would grant that tradition can communicate moral<br />
knowledge, so this point is not a matter of dispute. 13 What is in<br />
dispute is whether it can also establish that knowledge as true.<br />
In order to show that it can, we need an account of what<br />
tradition means. Alasdair MacIntyre has defined tradition as<br />
follows: “A living tradition then is an historically extended,<br />
socially embodied argument, and an argument precisely in part<br />
about the goods which constitute that tradition.’’ 14 This is a more<br />
sophisticated version of the common description of tradition as<br />
a process of transmission, across generations, within a<br />
community, of content, in the form of beliefs and practices. The<br />
8<br />
Summa Theologiae, II-II, q. 11, a. 3.<br />
9 FRANCISCO DE VITORIA, O.P., Comentarios a la Secunda Secundae de<br />
Santo Tomás, vol. I (Salamanca: Biblioteca de Teólogos Españoles, 1932),<br />
220.<br />
10 FRANCISCO SUAREZ, Opera Omnia, (Paris: Vivés, 1858), <strong>Vol</strong>. 12, De Fide<br />
Theologica, Disputatio 23, pp. 577-586.<br />
11 PETER ACKROYD, The Life of Thomas More (London: Chatto and<br />
Windus, 1998), 296.<br />
12<br />
It might be said that the Church in its formal teaching never positively<br />
approved the burning of heretics: in fact, the only formal papal statement on<br />
the issue seems to be that of Leo X, rejecting the view of Luther. The Pope<br />
did not expressly say, in a formal document, that burning heretics was<br />
morally good and right, nor did any other Pope.<br />
13 MERKS, “Die sirenenzang,” 132.<br />
14 ALASDAIR MACINTYRE, After Virtue, 2 nd . ed. (Notre Dame, Ind.:<br />
University of Notre Dame University, 1984), 222.
434 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
merit of MacIntyre’s definition is that it highlights the nature of<br />
the transmission as a dynamic, conflicted process, and focuses<br />
especially on the goods which make the tradition what it is.<br />
These features I will seek to develop in proposing that tradition<br />
is an argument that takes the form of a process of testing beliefs<br />
and practices in respect to the constitutive goods of the<br />
tradition, so as to make possible the testimony by which the<br />
tradition is communicated. The test would show whether the<br />
belief or practice is coherent with the constitutive goods, both in<br />
theory and in practice. In this way I will suggest a theory of<br />
moral truth in tradition according to which it is possible to<br />
affirm as true that certain beliefs and practices do not<br />
correspond to the constitutive goods. 15 This is, of course,<br />
essential to the argument I intend to make that tradition can be<br />
a source of truth.<br />
I am not claiming to produce a timeless idea of tradition<br />
that could stand apart from and above all traditions. The notion<br />
of tradition has to be derived from historical experiences and<br />
their interpretations. If, in the course of reflection and testing, a<br />
particular notion of tradition proved to be inadequate, it would<br />
have to be transformed. 16 Étienne Gilson described his approach<br />
as “methodical realism,’’ 17 I would consider the approach I am<br />
advocating as “methodical tradition.” By methodical I mean that<br />
tradition serves as an interpretative key to the testimony of those<br />
persons who form the community that sustains and is sustained<br />
by the tradition.<br />
The formal analysis needs to be complimented by some<br />
account of the historical traditions with which this paper is<br />
concerned. A tradition can be recognized where the following<br />
15<br />
On a correspondence theory of truth, see ALASDAIR MACINTYRE, Whose<br />
Justice? Which Rationality (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame<br />
Press, 1988), 357.<br />
16<br />
Indeed, such a transformation is already evident in the writings of<br />
MacIntyre and of others who have recently dealt with the topic. Tradition no<br />
longer means what it meant in Josef Pieper’s Über den Begriff der Tradition<br />
(Cologne and Opladen: Westdeutscher Verlag, 1958).<br />
17 ÉTIENNE GILSON, Methodical Realism (Front Royal, Christendom<br />
Press, 1990), 17.
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 435<br />
elements are present: the transmission across time in a<br />
community of content, in the form of beliefs and practices, and<br />
a doctrine by which the members of the community justify the<br />
truth of the content transmitted. Traditions may be very broad<br />
in scope; thus Hannah Arendt can write of “our tradition” as<br />
including the whole political-philosophical tradition of the<br />
“west.’’ 18 There are traditions within traditions, where the<br />
broader provides the justifying framework for the narrower.<br />
The “Catholic tradition” refers to a distinctive set of beliefs<br />
and practices that have been transmitted across time, through<br />
generations, and whose validity is justified by a particular<br />
doctrine of linkage to the original testimony of authentic<br />
witnesses (the Apostles) through their valid successors (the Pope<br />
and Bishops). Not all the elements of this tradition have actually<br />
been shown to be linked in this way to the authentic witnesses,<br />
but the justification of this tradition requires that they could be.<br />
Historical experience has shown that there can be elements in<br />
the tradition that cannot be so linked, (such as the burning of<br />
heretics), but whose incoherence with the original testimony<br />
became apparent only after a very long time. In the light of this<br />
experience, it would be rash to presume that there are no similar<br />
elements, incoherent, but as yet unrecognized as such, in the<br />
tradition today. The term “the Catholic tradition,” as used here,<br />
therefore, does not refer only to formally approved beliefs and<br />
practices; it includes those which are widely accepted or at least<br />
tolerated, among which there may be some that will later have<br />
to be rejected.<br />
The Catholic tradition seems to have assumed, very early, a<br />
certain interpretation of tradition and made this its own.<br />
According to Arendt, the pre-Christian, Roman model was<br />
characterized by reference to a sacred foundation in the past,<br />
namely, the founding of the city of Rome. Within this model<br />
what we could call a historical logic developed: the sacred<br />
foundation was witnessed to by the ancestors, who gave it<br />
institutional form in the city, tradition handed down from<br />
generation to generation the testimony of the ancestors, by<br />
18 HANNAH ARENDT, Between Past and Future (Penguin, 1968), 17.
436 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
which process their founding authority was affirmed and<br />
augmented through the ages. Religion provided the bonds by<br />
which men and women were bound by tradition to the<br />
authoritative foundation. 19<br />
Arendt argues plausibly that the Christian Church took and<br />
transformed this model, making the death and resurrection of<br />
Christ the foundation of a new institution, but preserving what<br />
I would call the same historical logic. Thus where, in the original<br />
Roman model, tradition meant continuity with the foundation,<br />
it now came to mean, in the Christian understanding, continuity<br />
with the foundation of the Church. Again, according to Arendt,<br />
the basis or foundation of the community as a public institution<br />
became no longer faith in the resurrection itself, “… but rather<br />
the testimony of the life, of the birth, death, and resurrection, of<br />
Jesus of Nazareth as an historically recorded event,” analogous<br />
to the founding event of Rome. The Apostles as witnesses of this<br />
event, are now the “founding fathers” of the community as<br />
public institution, which retains its authority insofar as it hands<br />
down their testimony from generation to generation. 20<br />
These suggestions are, at present, little more than an<br />
hypothesis, and more historical evidence would be needed to<br />
confirm them. However, the notion of the Roman foundational<br />
model may help to explain some of the issues which have arisen<br />
within the tradition and, in particular, to identify the historical<br />
logic of this model. The essential structures of the Roman<br />
foundational model of tradition are the triad of traditionauthority-religion<br />
and the historical logic of the tradition must<br />
be such as to preserve the relationships of that triad. Authority<br />
is justified in that it maintains continuity with the foundation,<br />
both through an historical series of successors of the original<br />
witnesses, the Apostles, and through the tradition itself that<br />
sustains authority and is sustained by it.<br />
Within this model it is unthinkable that reason could<br />
function apart from the tradition and so apart from authority.<br />
There is no place here for “autonomous reason” as this would be<br />
19 ARENDT, Between Past and Future, 124.<br />
20 ARENDT, Between Past and Future, 125.
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 437<br />
understood in the Kantian tradition. Within the Roman<br />
foundational model, reason, operating apart from tradition,<br />
would become inevitably lost, wandering in the void, and<br />
leading itself to destruction. This model of tradition and its<br />
political embodiment have passed the test of endurance in an<br />
extraordinary way. But, precisely because of its political<br />
embodiment, I refer in particular to the medieval symbiosis<br />
between Church and political power, it was liable in part to be<br />
distorted into a tradition of identity. Reason, which cannot but<br />
function in an historical tradition, may become a rationale that<br />
stabilizes the identity of a certain form of political institution.<br />
This, I suggest, is what happened in the case of the justification<br />
of the burning of heretics. It becomes a crucial question,<br />
therefore, whether we can distinguish between a tradition of<br />
identity and a tradition of truth.<br />
Tradition of truth<br />
Tradition, in our post-traditional age, cannot any longer be<br />
thought of as a given, waiting to reveal the truth to us. A<br />
tradition now requires a conscious commitment to search for<br />
the truth. Tradition cannot be reduced to the consciousness of<br />
the individual subject: it is irretrievably other, yet it necessarily<br />
calls for active participation and not mere passive acceptance. 21<br />
The members of the community testify that they have<br />
discovered the true good and live their lives accordingly, so that<br />
the tradition becomes not only a way of thinking, but a body of<br />
practices, a way of living, with characteristic patterns of<br />
educated feeling. Others, both those already in the community<br />
and those still outside who seek the true good, may recognize it<br />
through the testimony of the community. They then either<br />
reconfirm or initiate a commitment to the community of<br />
tradition, and participate in its continuing search for the true<br />
21<br />
This active participation is, however, not the same as learning, i. e. the<br />
response of a pupil to a teacher, but a response to testimony. Such a response<br />
is a type of faith, but not a blind faith. Cf., for an apparently different view,<br />
PIEPER, Über den Begriff der Tradition, 19.
438 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
good. A tradition is not merely a coming and holding together<br />
under the pressure of intense emotion. Such a gathering would<br />
be unable to carry out a reasoned test of the testimonies<br />
provided by its members, and so would not be able to assess<br />
their truthfulness. If tradition is to be a source of truth, then it<br />
must include something like the reasoned tradition as proposed<br />
by MacIntyre.<br />
What I am proposing here is precisely a denial of the thesis,<br />
attributed to the Enlightenment, that tradition and reason must<br />
be mutually opposed. 22 Tradition requires critical reason if the<br />
tradition is to continue to be a tradition which can claim to be<br />
seeking truth. On the other hand, critical reason cannot exist in<br />
a timeless world of its own, but only within an historical<br />
tradition. There is, after all, no guarantee that critical reason<br />
will produce truth rather than mere destruction: critique implies<br />
criteria, and the criteria are developed only through the testing<br />
processes provided by a tradition.<br />
The suggestion that moral knowing is possible only in<br />
tradition may produce objections. Are there not ways of moral<br />
knowing which are independent of tradition? Are there not<br />
moral truths which we know naturally and are there not moral<br />
intuitions, neither of which seem to be tradition dependent? To<br />
say that we naturally know certain moral truths does not have to<br />
mean that these ideas somehow automatically appear on our<br />
mental screen when we turn our minds on. When we say that we<br />
naturally know that certain things are morally wrong, we could<br />
mean that our minds have been so shaped historically, and seem<br />
to be so structured in their fundamental character, that our<br />
natural way of knowing is through participating in a tradition.<br />
According to St. Thomas, a proposition is said to be per se nota<br />
when we know that the predicate is contained in the meaning of<br />
the subject. 23 But, I would suggest, we come to know the<br />
meaning of the subject and predicate only by exploring the<br />
usage of the terms in a tradition. “Natural” knowing is,<br />
22 CHARLES LAMORE, The Morals of Modernity (Cambridge: Cambridge<br />
University Press, 1966), 59.<br />
23<br />
Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2.
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 439<br />
therefore, no less tradition dependent than any other form of<br />
knowing.<br />
If there are moral intuitions, they are not some kind of<br />
peculiar, immediate insights into moral truth that can claim a<br />
special status simply because they seem to be immediate and<br />
thus underived. 24 Such intuitions can be best explained as the<br />
merging into a coherent pattern of several, hitherto<br />
unconnected strands of a tradition within the mind of a person<br />
seeking moral truth. That these linkages are made rapidly does<br />
not give them any special truth status.<br />
Moral knowledge is generated and communicated in<br />
tradition by testimony. 25 When a person testifies that he or she<br />
has found this to be a good way of life, they offer something of<br />
themselves to another. Testimony engages me with the other to<br />
whom I testify at the deepest level: if what I say is of no worth,<br />
then my life is of no worth. Again, the very offer of testimony to<br />
another, on this most profound of matters, is a recognition of<br />
that other as a genuine searcher for the moral truth; an<br />
acknowledgment of the other’s being a subject of intelligence,<br />
will and the capacity to love the good, in short, to recognize that<br />
other as a person of dignity and of moral worth.<br />
This theory of tradition requires therefore an account of the<br />
virtues. People commit themselves to a tradition because they<br />
desire the goods that the tradition promises. But people desire<br />
many different things (as Kant insisted); it would seem then<br />
that, with such a plurality of desired goods, there could never be<br />
a coherent tradition and the whole case for tradition as a source<br />
of moral direction would seem to collapse. Yet people do<br />
commit themselves to tradition, and they do so because<br />
tradition offers them the possibility of dealing with the plurality<br />
of different goods, and focusing their desires more specifically.<br />
The good that is offered in a tradition as true is not the sum of<br />
24<br />
Cf. TADEUSZ STYCZEN, “Das Problem der allgemeingültigtigkeit<br />
ethischer Normen in epistemologischer Sicht,” in SERVAIS PINKAERS and<br />
CARLOS JOSAPHAT PINTO DE OLIVEIRA, eds., Universalité et permanence des lois<br />
morales (Fribourg: Editions Universitaires, 1986), 241.<br />
25<br />
Cf. JEAN NABERT, Le désir de dieu (Paris: Aubier-Montaigne, 1966), 273.
440 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
the objects of any and all empirical desires, but the object of<br />
desires that have been educated within the tradition. The<br />
tradition presents these goods as those that have been lived and<br />
found to be the substance of a good life. A tradition calls, in<br />
particular, for the skills needed both to give and receive<br />
testimony. These skills or virtues would include truthfulness,<br />
fidelity in pursuing the truth intensely and (usually) over a long<br />
time, justice as the capacity to recognize another, the recipient<br />
of the testimony, as one with equal dignity, and love as the will<br />
to communicate to that other the goods that have been found to<br />
be true. The virtues required in a tradition carry a guarantee of<br />
truth not simply because they are of the past 26 but precisely<br />
because they are ways that have been tested and proved by<br />
persons seeking the true good.<br />
When we ask whether and how the testimony of tradition<br />
can be true, the first step must be to determine the appropriate<br />
stance of the questioner with regard to the tradition. Let us<br />
suppose that we can pose the question of the true good from the<br />
point of view of a neutral observer standing in a position outside<br />
and above the historical tradition. From such a viewpoint, the<br />
observer could regard all the different testimonies within the<br />
tradition, even those that contradict each other, as having equal<br />
claims to be considered testimonies. This would produce an<br />
ambiguous testimony that could not claim to be a manifestation<br />
of truth. In such a case, Merks’ critique would stand. But one<br />
who attends to the testimony of a tradition cannot be merely a<br />
neutral observer interested in the facts about the tradition, he or<br />
she is committed to searching for the true good, and in<br />
accordance with that commitment, attends to the testimony of<br />
those who participate in the tradition and who witness to what<br />
they have discovered to be the true good. That testimony<br />
includes both an affirmation that the community of the tradition<br />
has found the true good, and a promise that by following the<br />
community’s paths, others can find it also.<br />
Coherence with such a commitment to seek the true good,<br />
leads a person to accept that testimony with faith in the<br />
26<br />
As MERKS seems to believe, “Sirenenzang,” 126.
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 441<br />
witnesses’ promise. Subsequently, the same commitment to the<br />
true good requires one to participate in the testing processes<br />
carried out in the tradition, reforming them in the mind, and<br />
also refining them according to the exigencies of the pursuit of<br />
the true good. My own “experiments” may then confirm the<br />
truthfulness of the tradition’s promises and my testimony<br />
becomes part of the general testimony. It is in this sense that I<br />
am responsible for the norms of tradition, that is, the norms of<br />
communal life. To claim that I have a responsibility for these<br />
norms, as the author does 27 cannot mean that I stand apart from<br />
and over tradition, in a kind of god-like detachment, freely<br />
determining the norms for myself and everyone else in the<br />
tradition.<br />
If, by participating in the traditions’ processes of searching,<br />
I discover in the beliefs and norms of this tradition, both an<br />
objective coherence, and a source of coherence within myself, a<br />
coherence that enables me to move beyond interior conflicts and<br />
doubts and so pursue in a more integrated way the good that I<br />
originally sought by committing myself to the tradition, then I<br />
will judge these ways to be morally true. The theory thus<br />
includes a necessary reference to the moral identity of the<br />
subject, 28 but considers the subject, not in isolation, but as a<br />
member of the community of tradition. In participating in the<br />
tradition, the subject may creatively transform the tradition<br />
itself and so be able to communicate to the tradition new<br />
resources. This is what the great innovators within traditions<br />
were able to do and each member of the community of the<br />
tradition exercises such creativity even if in a less dramatic way.<br />
What the theory I am proposing cannot accept is that it is<br />
the morality of the subject (separated from tradition) which<br />
must guarantee the standards presented in the tradition. It is not<br />
a matter of imposing the standards of the tradition on a passive<br />
subject, but neither is it a matter of imposing the standard of the<br />
subject on a passive tradition. There cannot be an ethics of the<br />
subject outside and above all tradition, by which the tradition<br />
27 MERKS, “Sirenenzang,” 131, citing W. KORFF.<br />
28<br />
Cf. MERKS, “Sirenenzang,” 131.
442 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
must be judged. 29 The process of proving or testing always<br />
includes both tradition and subject as active participants.<br />
This brings us to an important point in the argument: what<br />
provides a guarantee that a belief to which the tradition testifies<br />
is true, is that the belief has been tested adequately within the<br />
tradition. The mere presence of a belief in tradition, even over a<br />
long time, does not provide a guarantee of its truthfulness. This<br />
is clear, for example, in the specific case of the Catholic<br />
tradition’ s acceptance over centuries of the moral lawfulness of<br />
executing heretics. “Long shelf life” in a tradition is not an<br />
adequate criterion of the truth of a belief.<br />
A more developed account of the process of testing is called<br />
for. I am not proposing a test of a consequentialist type. It is not<br />
being suggested that the burning of heretics was tried as a way<br />
of preserving the unity and identity of the faith of the Church,<br />
which failed and therefore ought to have been abandoned. The<br />
test concerns rather the internal coherence of the tradition,<br />
where the coherence applies to the tradition itself and to the<br />
subject who is participating in it. The test, involving both<br />
tradition and subject in the way described above, can show that<br />
this practice is incoherent with the tradition’s search for the<br />
goods it promises, and so incoherent also with the subject’s<br />
commitment to the tradition as a way of seeking the true good.<br />
The testimony here does not have the form, “If you want X,<br />
then you must do Y;” this hypothetical statement would be<br />
appropriate to a neutral, external observer, and indeed is not<br />
testimony at all. Testimony is something like this: “Granted that<br />
you are participating in our commitment to seek the goods<br />
promised by our tradition, and you must be or you would not be<br />
here attending to us, then these are the goods you ought to will.”<br />
By which is meant: “These are the goods that will lead you to the<br />
good to which you are already committed.” Where the test has<br />
indicated otherwise, the testimony takes the form: “This is not a<br />
good that you ought to will.”<br />
Nor am I proposing a purely procedural notion of truth in<br />
tradition. This would mean attempting to discover the laws or<br />
29<br />
Contrary to MERKS, “Sirenenzang,” 138.
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 443<br />
procedures by which tradition functions, and then assuming<br />
that, where our thinking follows these laws or procedures, what<br />
emerges can be considered the truth. If this were the case, there<br />
would be no basis on which to criticize and change the<br />
procedures. Thinking in tradition would mean an endless<br />
following of procedures; we would simply have a petrification of<br />
procedures in place of a petrification of substantive doctrines. If<br />
a tradition is to have the resources within it to prevent<br />
petrification and keep it open to change, these must be found in<br />
the substantive content of the tradition, not merely in its<br />
procedures.<br />
Tradition as a process of testing requires a framework<br />
within which we can assess the test itself and its procedures. The<br />
Christian tradition, for example, promises certain goods, peace,<br />
liberty, the knowledge and love of God, but the goods it promises<br />
can only be understood in reference to the testimony of the<br />
Christian community to the life, death and resurrection of an<br />
historical person, Jesus of Nazareth. For the Christian tradition<br />
the framework is provided by the testimony presented in the<br />
New Testament. I do not intend to say that Gospel provides us<br />
directly with a list of rules for testing tradition, but it does give<br />
us a focus in which all judgments about the truly good may be<br />
tested for coherence. It is beyond the limits of this paper to go<br />
into detail here so an example must suffice.<br />
The Gospel provides us with a narrative of the death and<br />
resurrection of Jesus. Faith in the resurrection in its concrete<br />
historical form, means accepting the testimony of the witnesses<br />
of the resurrection, and participating in the tradition which<br />
carries on that testimony. The death of Jesus is a violent act on<br />
the part of men, but totally non-violent on the part of Jesus; the<br />
resurrection is a response to human violence, but is itself utterly<br />
non-violent. A commitment in faith to the resurrection, through<br />
the reasoned reflection to which it gives rise, generates a moral<br />
ontology or framework within which violence is incoherent.<br />
This implies a basic assumption in the whole argument that<br />
needs to be recalled here: reason operates within historical<br />
traditions, which is not to say that it is limited to such traditions.<br />
Thus, reason within the Catholic historical tradition must<br />
operate according to the ontology that emerges from reflection<br />
on the death and resurrection of Jesus; an ontology which does
444 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
not allow that violence can be the ultimate reality. Reflection<br />
within the terms of this ontology, leads to the recognition of the<br />
moral truth that violence is not a way by which we can pursue<br />
the goods promised by the tradition. Thus, in particular, the<br />
violent execution of heretics must be morally rejected.<br />
What this theory is proposing is that traditions may have<br />
internal resources that make such a process of self-correction<br />
possible, without the destruction of the tradition itself. This may<br />
not apply to all traditions, indeed it seems to be clear from the<br />
observation of history that some traditions cannot self-correct<br />
so that, when a serious challenge emerges, they simply collapse.<br />
I am arguing that the Catholic tradition does have such internal<br />
resources. These are not embodied in the laws of tradition in<br />
general, in which we have presumed that the Catholic tradition<br />
participates, but in the particular form that tradition takes by<br />
reason of its specific content. A tradition, if it is to continue to<br />
be a tradition, must be able to promise a transcendent good that<br />
goes beyond the mere preservation of its identity. The Catholic<br />
tradition, of course, promises such a transcendent good, namely<br />
union with God, revealed in the death and resurrection of Jesus.<br />
Testimony that the beliefs and practices of the tradition are<br />
morally true, means confirming that these beliefs and practices<br />
have been found to lead to the goods promised by the tradition,<br />
that is to a form of the good life. To testify that this form of life<br />
is truly good, means to affirm that it has been lived and tested in<br />
the community and found to be so. But in the Christian tradition<br />
there is a further test, namely, is this form of life coherent with<br />
that ontology that emerges from faith in the resurrection of<br />
Jesus?<br />
This does not mean that the criterion is totally dependent on<br />
faith, such that it must be exclusive to one particular community<br />
and its tradition. The theory does not entail a lapse into some<br />
kind of ethical “fideism,” and I am not claiming that we can<br />
derive moral norms by deduction from the scriptural narratives<br />
or from dogmatic teachings about the death and resurrection.<br />
Rather, the argument is, as explained earlier, that faith in the<br />
resurrection of Jesus generates an ontology, an historical mode<br />
of reason, that excludes violence as the ultimate reality. It is<br />
within this reasoned ontology, not by immediate deduction from<br />
faith, that the specific moral norms are constructed.
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 445<br />
Such an ethical position is not incommunicable to those<br />
who are not members of the tradition. The question as to<br />
whether the fundamental constitution of reality entails violence<br />
or not, has been an element in our “western” tradition since its<br />
very beginning, as it has been in other traditions. Thus, those<br />
who inhabit these other traditions can understand what a<br />
fundamental non-violence means, even though they do not share<br />
a faith in the resurrection of Christ. What the members of the<br />
Christian tradition offer to these others is their testimony that a<br />
life lived on this basis has been found to be a good life. They in<br />
no way impose their tradition on others.<br />
The issue of universality emerges here. Universality cannot<br />
be grounded in what the individual subject, in his search to give<br />
meaning to his life, thinks is universal; the idea of universality is<br />
not the reality of the universal. Universal reason is not<br />
something we have in hand: it can be found through the<br />
dialogue of traditions, where particular forms of tradition-based<br />
reason are tested with other forms of tradition-based reason, so<br />
that all may move closer to universal reason. Universality is<br />
possible only where the basic ontology of a tradition is such that<br />
it interprets difference not as violent separation, but as<br />
difference in unity. Such an ontology is that which derives from<br />
reflection on the death and resurrection of Jesus, and on the<br />
Trinity which those events manifest. 30<br />
Some might object that we have no need of some kind of<br />
special internal criterion of truth within the Catholic tradition,<br />
since the truth of a belief is declared by the Magisterium. But if<br />
this were the case, how could the Magisterium appeal to<br />
tradition in support of its teaching? If indeed God commands<br />
certain things because they are good, and forbids others because<br />
they are bad, this must be the case also with Church authority.<br />
Documents of the Magisterium have described the role of the<br />
theologian as seeking reasons to support official teaching. This<br />
presumes, of course, that there are such reasons; and that it is<br />
these, and not solely the act of authority, which gives those<br />
teachings a claim to truth.<br />
30<br />
Cf JOHN MILBANK, Theology and Social Theory (Oxford: Blackwell,<br />
1990), 428.
446 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
Another similar objection might be that we believe the<br />
Catholic tradition is guided by the Holy Spirit and therefore<br />
does not need to appeal to this criterion of coherence to<br />
establish that its teachings are true. Accordingly while to<br />
demonstrate coherence after the fact of the teaching may be<br />
helpful for apologetic purposes, it is not needed to establish the<br />
truth of the teaching. Here, however, we have to deal with issues<br />
such as the burning of heretics, where the guidance of the Spirit<br />
seems to have been resisted, since the authorities of the Church<br />
did not forbid the practice for centuries. All we can say is that<br />
the Spirit seems to guide the Church through some such process<br />
of historical testing as has been described above, in which the<br />
discovery of the incoherence of some positions is made only<br />
after long effort.<br />
However, while we may say that the tradition and the<br />
persons who live in that tradition, may, indeed must, carry out<br />
the process of testing, and themselves have authority to do so,<br />
there must be some structure of authority within tradition.<br />
Because there are many who test the tradition, there must be<br />
some instance to coordinate their efforts and to collate, sift and<br />
ultimately validate their findings. An historical tradition cannot<br />
survive without such a structure of authority. Thus, the notion of<br />
tradition includes the notion of authority, and therefore, the<br />
activity of authority is not external but internal to the tradition.<br />
It can of course, become purely external if it resorts to arbitrary<br />
decrees which have no basis in the truth of the tradition, but it<br />
is not necessarily so. Thus, in insisting on the internal character<br />
of the criterion of truth in tradition, the theory I am proposing<br />
by no means excludes the role of the Magisterium in the<br />
Catholic tradition.<br />
Having outlined a theory of tradition, I now move to the<br />
second step of the argument If tradition is to be a source of<br />
truth, it must have the resources within it to distinguish<br />
“legitimate” from “illegitimate” elements. 31 Thus for example,<br />
there must be resources within the tradition which can enable<br />
us to say why the burning of heretics was an illegitimate element<br />
31 MERKS, “Sirenenzang,” 128.
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 447<br />
in the tradition. Such resources are present, as I have already<br />
indicated, in the testimony to the death and resurrection of<br />
Jesus. But we must also be able to show how the incoherence<br />
between this fundamental testimony and the practice could have<br />
remained unnoticed for so long; it is by showing the incoherence<br />
in a particular case, that we can demonstrate the presence of<br />
coherence in the tradition as a whole.<br />
The argument is that a tradition or elements of a tradition,<br />
can be so affected that the tradition of truth is displaced by a<br />
“tradition of identity.” It was because certain beliefs were caught<br />
up in a tradition of identity that they were removed from the<br />
process of testing, and so could remain for a long time in the<br />
tradition, even though, as would be discovered subsequently,<br />
they were quite incoherent with it.<br />
Tradition of Identity<br />
A tradition can become a tradition of identity. What counts<br />
above all in such a tradition is the group identity, which in turn<br />
supports individual identity. Truth, then, comes to be<br />
understood in terms of what sustains identity. The doctrine of<br />
justification in a tradition of identity will tend to be a version of<br />
the positivist appeal to authority, or an appeal to feeling, or quite<br />
likely to both of these together. There are many examples of<br />
traditions of identity, some of which, like traditions of ethnic<br />
identity, can be very dangerous, as we have seen all too often in<br />
recent times. I would distinguish a “tradition of identity” from a<br />
“tradition of truth” which I have endeavored to describe earlier.<br />
In the latter, identity is not ignored, any historical tradition<br />
needs an identity; identity is a good, but as a condition for<br />
seeking a good which transcends group identity. If an inquirer is<br />
seeking solely to sustain his own identity, then a tradition of<br />
identity will suit his needs; but if the inquirer asks the moral<br />
question as to where is the true good to be found, a tradition of<br />
identity is helpless. Such a tradition can only reply that the good<br />
simply is identity and that subordinate, instrumental goods are<br />
those that sustain identity.<br />
A practice, for example, the burning of heretics, is accepted<br />
for certain contingent historical reasons, and justified by certain
448 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
arguments. The justifications become a set of formulas which<br />
are repeated over and over again, so that, over time, they come<br />
to be considered important because they themselves become<br />
symbolic of the identity of the tradition. 32 There is a move from<br />
the assertion: “The Catholic tradition justifies the burning of<br />
heretics,” to the further assertion: “The Catholic tradition is a<br />
tradition which justifies the burning of heretics.” Thus, it comes<br />
to be assumed that the practice and the accompanying<br />
justification cannot be rejected without at the same time<br />
denying the identity of the tradition, and with that the identity<br />
of the community, that is the Church, which it sustains. 33<br />
My suggestion is that Merks’ critique bears on a particular<br />
historical form of the tradition, namely the Roman foundational<br />
model, when it had, on certain issues, lapsed into a tradition of<br />
identity. Indeed, my notion of the tradition of identity seems to<br />
be very close to what Merks refers to and critiques as the<br />
stabilizing, as contrasted to the critical, use of tradition. 34 When<br />
it functions in this way, the tradition cannot be a source of truth.<br />
However, and this is the key point of my argument, the<br />
tradition has also carried within it the resourçes necessary to<br />
correct distortions, and eventually did so in this case.<br />
Sometimes, of course, those resources can be petrified in a<br />
tradition of identity and can only be set free by a sharp impetus<br />
from outside, as happened for example in the question of capital<br />
punishment. 35 Petrification set in when a tradition of identity<br />
dominated the tradition of truth, and moral theological reason<br />
became essentially apologetics. Concern with identity also led to<br />
an unwillingness to allow the Catholic tradition to be challenged<br />
by other traditions, challenges which it demonstrably needed.<br />
According to the author, the notion of the person 36 and the<br />
ideals of freedom and responsibility, emerge from a paradigm<br />
32<br />
For an historical example, see Megivern, The Death Penalty, 214.<br />
33<br />
There may very well have been other, theological reasons why the<br />
tradition clung on to the acceptance of such punishment. cf. TIMOTHY<br />
GORRINGE, God’s Just Vengeance (Cambridge: Cambridge University Press,<br />
1996).<br />
34<br />
MERKS,”Sirenenzang,” 133.<br />
35 MEGIVERN, The Death Penalty, 214.<br />
36 MERKS, “Sirenenzang,” 135.
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 449<br />
shift from a cosmocentric to an anthropocentric world view. 37<br />
But why does this cultural shift have truth founding properties<br />
if tradition does not? Who are the “we,” the human persons who<br />
are explaining what is good for us? 38 What is it about this<br />
testimony that justifies us in accepting it as true, if we may not<br />
accept the testimony of the tradition? How do we know that<br />
“we” are right? If I have understood the article correctly, we<br />
know this by consulting the conscious experience of the<br />
individual subject, and in particular of the subject as giving<br />
meaning to life.<br />
The philosophical option underlying Merks’s article seems<br />
to find its focal point in autonomous subjectivity, presupposing<br />
that modern self-consciousness can draw from itself the norms<br />
for guiding thought and action, above all freedom and<br />
responsibility. In qualification of this, it must be admitted that<br />
Merks acknowledges that the subject cannot do without his<br />
history and his being-situated, 39 and thus is not a totally<br />
disengaged subject. Nevertheless, the philosophical option that I<br />
propose is of a different kind. It looks not to the self-conscious<br />
autonomous subject, but to the engaged person, who is not<br />
above and separate from the world, the community and the<br />
tradition, but inherently related to them. This person chooses<br />
freely to be so related, and it is in this that responsibility<br />
consists. Which of these options is correct can be decided only<br />
by the testing process of the tradition.<br />
Conclusion<br />
This article has argued that tradition and specifically the<br />
Catholic tradition, can be, when understood in a particular<br />
sense, and under certain conditions, a source of moral truth.<br />
Merks critique of tradition is valid, but it touches particular<br />
forms of tradition, rather than tradition in its whole range; it<br />
does not justify a rejection in toto of the capacity of tradition to<br />
37 MERKS, “Sirenenzang,’’ 133.<br />
38 MERKS, “Sirenenzang,” 135.<br />
39 MERKS, “Sirenenzang,” 135.
450 BRIAN V. JOHNSTONE<br />
be a source of truth. I would argue that the notion of the person<br />
itself emerges from a long and complex process of historical<br />
testing within the tradition. Only when considered as such, from<br />
within a tradition, can the person be a norm of traditions, both<br />
of the tradition of which it is a part, and of other traditions with<br />
which it enters into critical dialogue. Indeed the capacity of the<br />
tradition to arrive at the awareness of the normative significance<br />
of the person is itself the best proof that the Catholic tradition<br />
can indeed be a source of moral truth.<br />
Accademia Alfonsiana<br />
Via Merulana 31<br />
C.P. 2458<br />
00100 Roma, Italy.<br />
BRIAN V. JOHNSTONE, C.Ss.R.<br />
—————<br />
Summary / Resumen<br />
Can tradition be a source of moral truth? This article develops an<br />
argument to show that it can be, in reply to the recent claim by another<br />
author to the contrary. The opening argument is that traditions have<br />
damaged many people. It is accepted that this has happened: the example<br />
of the tradition of burning heretics is examined. Proceeding from<br />
this, the body of the article is dedicated to developing a theory of tradition,<br />
in order to show that there is an inherent criterion of truth which<br />
makes it possible to distinguish true tradition from false. An adequate<br />
defense of truth in tradition must also be able to demonstrate how such<br />
false traditions as the burning of heretics could have been sustained for<br />
so long. Here we need to make a distinction between a tradition of truth<br />
and a tradition of identity: a tradition of identity may, in certain historical<br />
circumstances, obscure the tradition of truth.<br />
¿Puede la tradición ser una fuente de verdad moral? En respuesta a<br />
la reciente pretensión de un autor que afirma lo contrario, el presente<br />
artículo expone un argumento para demostrar que sí es posible. La primera<br />
razón es que las tradiciones han producido daño a muchas personas.<br />
Ciertamente la tradición de quemar herejes ha existido y es un<br />
ejemplo a examinar. Con esta premisa, el cuerpo del artículo se orienta<br />
a desarrollar una teoría de la tradición para mostrar que existe un cri-
CAN TRADITION BE A SOURCE OF MORAL TRUTH? A REPLY TO K.-W. MERKS 451<br />
terio inherente de verdad que hace posible distinguir la verdadera de la<br />
falsa tradición. Una defensa adecuada de verdad en la tradición tiene<br />
que demostrar también cómo las falsas tradiciones como las de quemar<br />
herejes, pudieron mantenerse durante tanto tiempo. Hay que hacer<br />
aquí la distinción entre tradición de verdad y tradición de identidad:<br />
una tradición de identidad puede, en determinadas circunstancias<br />
históricas, eclipsar la tradición de verdad.<br />
—————<br />
The author is ordinary Professor of Systematic Moral Theology<br />
at the Alphonsian Academy.<br />
El autor es profesor ordinario de Teología Moral Sistemática en<br />
la Academia Alfonsiana.<br />
—————
Chronicle / Crónica<br />
ACCADEMIA ALFONSIANA<br />
Cronaca relativa all’anno accademico 1998-1999<br />
1. Eventi principali<br />
1.1.Inaugurazione dell’anno accademico<br />
Il 10 ottobre 1998 l’Accademia Alfonsiana ha inaugurato,<br />
sotto la presidenza di S.E.R. Mons. Marcello Zago, Segretario<br />
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, il nuovo<br />
anno accademico con una messa solenne, concelebrata da<br />
S.E.R. Mons. Antonio Napoletano, Vescovo di Sessa Aurunca<br />
(Caserta), da Mons. Renzo Gerardi, Decano della Facoltà di Teologia<br />
della Pontificia Università Lateranense, dal Prof. Bruno<br />
Hidber, Preside dell’Accademia, e da altri professori e studenti.<br />
Durante l’omelia Mons. Zago ha enfatizzato l’essenzialità di<br />
una educazione energica e viva nella teologia morale per un’evangelizzazione<br />
che sia autentica nel mondo di oggi. Egli ha insistito<br />
sull’importanza della missione dell’Accademia, dei corsi<br />
da essa offerti e della preparazione che al termine degli studi gli<br />
studenti porteranno con sé nei loro paesi di origine.<br />
Al termine della celebrazione, nell’aula magna dell’Accademia<br />
ha avuto luogo un atto accademico che si è sostanzialmente<br />
articolato in tre momenti:<br />
- il primo, conclusosi con la relazione sull’anno accademico<br />
1997-1998 svolta dal Preside, Prof. Bruno Hidber, che ha riepilogato<br />
gli avvenimenti più salienti della vita dello scorso anno<br />
accademico;<br />
- il secondo, marcato dalla prolusione tenuta dal Prof. Martin<br />
McKeever, C.Ss.R., professore invitato dell’Accademia Alfon-
454 DANIELLE GROS<br />
siana, sul tema “Il dilemma etico-politico del discorso sui diritti<br />
umani nella cultura odierna”;<br />
- il terzo, sostanziatosi nella descrizione e nella spiegazione<br />
dei propri murales, sviluppata dal pittore G. Alessandro Simone,<br />
realizzati per decorare l’aula magna e che rappresentano, in stile<br />
astratto e simbolico, la storia della creazione e della redenzione.<br />
L’intero atto accademico, conclusosi con un rinfresco che ha<br />
rappresentato una utile occasione per un ricco scambio d’idee<br />
tra professori, ufficiali e studenti, è stato accompagnato per tutta<br />
la sua durata da un intrattenimento musicale, curato dal<br />
quartetto da camera “I solisti di Roma” che hanno eseguito brani<br />
di W. A. Mozart.<br />
Il 23 ottobre 1998, il Preside ha concelebrato, insieme al<br />
Prof. Andrzej Wodka e ad alcuni studenti dell’Accademia, la<br />
messa d’inaugurazione dell’anno accademico di tutti gli atenei<br />
ecclesiastici romani, presieduta da Sua Eminenza Rev.ma il Sig.<br />
Card. Pio Laghi, Prefetto della Congregazione per l’Educazione<br />
Cattolica.<br />
L’omelia di questa cerimonia, che si è svolta presso la Basilica<br />
di San Pietro, è stata tenuta da Sua Santità Giovanni Paolo II.<br />
1.2. Nomine<br />
Quest’anno accademico ha fatto registrare numerose nuove<br />
nomine, confermandone altre già in essere:<br />
- il Santo Padre, lo scorso mese di aprile del corrente anno,<br />
ha nominato Presidente della Pontificia Accademia di Teologia il<br />
Prof. Marcello Bordoni, docente dell’Accademia Alfonsiana da<br />
oltre 20 anni;<br />
- il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense,<br />
S.E.R. Mons. Angelo Scola, il 17 dicembre 1998 ha nominato<br />
Prorettore della stessa Università il Prof. Ignazio Sanna, anch’egli<br />
professore invitato dell’Accademia Alfonsiana;<br />
- il Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana, Rev.mo<br />
P. Joseph W. Tobin, C.Ss.R., il 28 ottobre 1998 ha nominato il<br />
Prof. Sabatino Majorano Vicepreside, il 28 marzo 1999 ha rinnovato<br />
l’incarico del R.P. John C. Vargas quale Executive Director for<br />
Development, e l’8 aprile dello stesso anno ha riconfermato il<br />
mandato di Segretario Generale alla Sig.ra Danielle Gros.
CHRONICLE / CRÓNICA 455<br />
1.3. Commemorando e ringraziando<br />
Il 17 novembre 1998, nella Chiesa di Sant’Alfonso e sotto la<br />
presidenza del Moderatore Generale è stata celebrata una messa<br />
commemorativa per i professori Peter Lippert, Bernhard Häring<br />
e Julio De La Torre, deceduti nel corso del 1998.<br />
Nell’omelia, tenuta dal Prof. Sante Raponi, è stato enfatizzato<br />
il rapporto tra orientamento scientifico e pastorale di questi<br />
tre professori, quale espressione tipica dell’essere redentorista.<br />
1.4. Presentazioni di libri<br />
Il 28 novembre 1998, nell’aula Pio XI dell’Università Cattolica<br />
del Sacro Cuore di Milano, l’Associazione Biblica Italiana ha<br />
presentato, in onore di Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Card. Carlo<br />
Maria Martini, il libro “La parola di Dio cresceva”. Alla cerimonia<br />
ha partecipato, in rappresentanza del Preside dell’Accademia,<br />
il Prof. Andrzej Wodka.<br />
Il 20 marzo 1999, nei locali dell’Accademia Alfonsiana, la<br />
Prof.ssa Nella Filippi ha presentato il libro del Prof. Sante Raponi<br />
intitolato “Alla scuola dei padri. Alcuni saggi tra cristologia,<br />
antropologia e comportamento morale”. Alla cerimonia, aperta<br />
dal Preside, erano presenti il Moderatore Generale, alcuni superiori<br />
redentoristi, altri professori e numerori familiari del Prof.<br />
Raponi. La presentazione del libro è stata organizzata dal Prof.<br />
Dennis Billy, in qualità di responsabile di Edacalf.<br />
Il 24 marzo 1999, nell’Aula Magna dell’Accademia Alfonsiana,<br />
è stato presentato il libro del Prof. Lubomir Zak, insegnante<br />
presso la Pontificia Università Lateranense ed ex-studente dell’Accademia<br />
Alfonsiana, intitolato “Pavel A. Florenskij: Un progetto<br />
di ontologia ed etica trinitaria”. All’atto sono intervenuti i<br />
Professori Piero Coda della Pontificia Università Lateranense,<br />
Marko Rupnik del Pontificio Istituto di Studi Orientali, Natalino<br />
Valentini dell’Università di Urbino e Basilio Petrà della Facoltà<br />
Teologica di Firenze, nonché professore invitato dell’Accademia<br />
Alfonsiana.
456 DANIELLE GROS<br />
1.5. Incontri<br />
Il 2 dicembre 1998, il Preside ha organizzato un incontro tra<br />
S.E.R. Mons. Marcello Zago ed i professori dell’Accademia.<br />
Il 13 gennaio 1999, gli studenti hanno organizzato un incontro<br />
tra professori e studenti, in occasione dell’inizio del nuovo<br />
anno civile.<br />
Il 22 marzo 1999, il Preside ed i Rappresentanti degli Studenti<br />
hanno organizzato un incontro con la Prof.ssa Maria Campatelli,<br />
del Pontificio Istituto di Studi Orientali, che si è tenuto<br />
nell’Aula Magna dell’Accademia. In tale ambito, la Professoressa<br />
ha svolto una meditazione quaresimale dal titolo “Lo spirito penitenziale<br />
della Quaresima”.<br />
2. Consiglio di amministrazione<br />
Dal 15 al 17 febbraio 1999, convocato dal Moderatore Generale,<br />
si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia<br />
Alfonsiana.<br />
In occasione di tali incontri, sono intervenuti:<br />
- il Preside, che ha svolto un rapporto sulla situazione accademica;<br />
- la Segretaria Generale, che ha relazionato sulla situazione<br />
amministrativa e su vari aspetti inerenti gli studenti;<br />
- il Prof. Lorenzo Alvarez, quale delegato del Consiglio dei<br />
Professori, per descrivere la situazione del corpo docente;<br />
- l’Economo, per esporre la situazione finanziaria;<br />
- l’Executive Director for Development, per informare sulla situazione<br />
delle relazioni pubbliche.<br />
Il C.d.A., presieduto dal Moderatore Generale, ha esaminato<br />
i vari rapporti con grande attenzione ed è con soddisfazione che<br />
ha potuto constatare che con l’inserimento di cinque nuovi professori<br />
a tempo pieno, la situazione del corpo docente è sostanzialmente<br />
migliorata, e che l’Accademia è cresciuta nella sua capacità<br />
di autogestione finanziaria, ma che sono necessari ulteriori<br />
sforzi per raggiungere lo scopo di autonomia finanziaria<br />
che è stato prefissato.<br />
Il C.d.A., inoltre, ha preso atto della necessità di trovare un
CHRONICLE / CRÓNICA 457<br />
nuovo Prefetto della Biblioteca e un nuovo Economo con una<br />
certa urgenza, data la ravvicinata scadenza di quelli attualmente<br />
in carica.<br />
3. Corpo insegnante<br />
3.1. Stato attuale<br />
In quest’anno accademico l’Accademia Alfonsiana si è avvalsa<br />
della collaborazione di 33 professori, dei quali sei ordinari,<br />
due straordinari, uno associato, venti invitati e quattro emeriti.<br />
Tra questi, 28 hanno svolto 29 corsi, diretto 25 seminari e numerose<br />
tesi di licenza e di dottorato. Altri ancora, in veste di professori<br />
invitati, hanno anche insegnato presso diversi centri ecclesiastici.<br />
3.2. Nuovi docenti<br />
L’Accademia Alfonsiana si è avvalsa della collaborazione di<br />
due nuovi professori invitati (di cui uno Redentorista alla sua<br />
prima esperienza didattica), che hanno insegnato durante l’anno<br />
accademico 1998-1999. Si tratta del Prof. Edmund Kowalski,<br />
C.Ss.R., per la sezione di antropologia filosofica, e del Prof. Don<br />
Silvio Sassi, S.S.P., per la sezione di antropologia empirica.<br />
3.3. Pubblicazioni dei Professori<br />
Da evidenziare che molti docenti, oltre alla loro principale<br />
attività didattica e di assistenza agli studenti, hanno anche pubblicato<br />
diverse opere, offrendo in tal senso un utile contributo<br />
alla ricerca scientifica.<br />
3.4. In memoriam<br />
L’anno accademico 1998-1999 è stato funestato dal decesso<br />
di due professori: il Prof. Andreas Sampers, C.Ss.R., che insegnò
458 DANIELLE GROS<br />
all’Accademia Alfonsiana dal 1957 al 1986, ed il Prof. Vernon<br />
Sattler, C.Ss.R., che vi insegnò nell’anno accademico 1969-1970.<br />
3.5. Docenti che lasciano l’Accademia Alfonsiana<br />
Il Prof. Marcello Bordoni, per raggiunti limiti di età, si è ritirato<br />
dopo 27 anni di insegnamento presso l’Accademia Alfonsiana,<br />
nella sezione di morale sistematica fondamentale.<br />
Il 24 maggio 1999, dopo la sua ultima lezione, il Preside ed<br />
i Professori dell’Accademia, in segno di stima e di ringraziamento<br />
per il suo prezioso contributo offerto durante tutti questi<br />
anni, si sono riuniti per salutarlo.<br />
3.6. Consulenti accademici<br />
Nella riunione del 28 ottobre 1998 il Consiglio dei Professori<br />
ha designato, quali consulenti accademici per il prossimo<br />
triennio, i seguenti professori: Sabatino Majorano per la lingua<br />
italiana, Dennis Billy per la lingua inglese, Lorenzo Alvarez per<br />
la lingua spagnola, Réal Tremblay per la lingua francese, e Andrzej<br />
Wodka per le lingue slave.<br />
4. <strong>Studia</strong> <strong>Moralia</strong><br />
L’impegno della Commissione per <strong>Studia</strong> <strong>Moralia</strong> e la collaborazione<br />
dei Professori interni ed esterni, hanno permesso la<br />
regolare pubblicazione dei due fascicoli della rivista <strong>Studia</strong> <strong>Moralia</strong>,<br />
per l’anno 1998.<br />
5. Studenti<br />
In quest’anno accademico gli studenti sono stati 301 (285<br />
uomini e 16 donne), di cui 281 ordinari che si sono preparati a<br />
conseguire i gradi accademici, e 20 ospiti. Tra gli ordinari, 138<br />
sono del secondo ciclo, 142 del terzo, mentre 1 è iscritto al programma<br />
biennale per il diploma.
CHRONICLE / CRÓNICA 459<br />
La provenienza degli studenti è riferita a tutti i continenti:<br />
127 dall’Europa, 71 dall’Asia, 31 dall’America del Nord, 31 dall’America<br />
del Sud, 39 dall’Africa e 2 dall’Australia/Oceania.<br />
Divisi per appartenenza religiosa, 165 sono del clero secolare,<br />
126 tra religiosi e religiose appartengono a 55 diversi ordini,<br />
mentre 10 sono laici.<br />
Durante l’anno accademico 1998-1999 sono state difese con<br />
successo 19 tesi di dottorato e 23 studenti, dopo la pubblicazione<br />
delle loro rispettive tesi, sono stati proclamati dottori in teologia<br />
della Pontificia Università Lateranense, con specializzazione<br />
in teologia morale. Inoltre, 69 studenti hanno conseguito la<br />
licenza in teologia morale, mentre uno studente ha ottenuto il<br />
diploma in teologia morale.<br />
Il 24 novembre 1998, l’assemblea degli Studenti ha eletto i<br />
propri rappresentanti, membri del Consiglio Accademico e portavoce<br />
presso le autorità accademiche ed amministrative dell’Accademia<br />
Alfonsiana. Si tratta di due studenti ordinari iscritti<br />
al secondo anno di licenza.<br />
Per la prima volta, quest’anno, durante il mese di marzo, il<br />
Preside ha incontrato individualmente tutti gli studenti del primo<br />
anno di licenza per verificare insieme la programmazione<br />
accademica, ed il loro orientamento. Inoltre, numerosi sono<br />
stati gli incontri tra il Preside ed i Rappresentanti degli Studenti,<br />
allo scopo di discutere varie questioni riguardanti gli studenti<br />
stessi.<br />
6. Informazioni sugli ex studenti<br />
6.1. Nomine<br />
Durante l’anno accademico 1998-1999, il Santo Padre ha nominato<br />
Arcivescovo di Torino S.E.R. Mons. Severino Poletto, finora<br />
Vescovo di Asti (Italia). Monsignor Poletto è stato studente<br />
dell’Accademia dal 1975 al 1977.<br />
6.2. In memoriam<br />
E’ giunta la notizia del decesso dell’ex studente Hendrik<br />
Berybe, C.Ss.R.. Nato il 1 maggio 1951 a Manggarai Flores (In-
460 DANIELLE GROS<br />
donesia), ha frequentato l’Accademia Alfonsiana dal 1987 al<br />
1994, ottenendo la licenza in teologia morale il 20 giugno 1990,<br />
ed il dottorato il 17 febbraio 1994.<br />
7. In vista dei cinquant’anni dell’Accademia Alfonsiana<br />
Il 9 febbraio 1949, il Rev.mo P. Buijs, allora Superiore Generale<br />
dei Padri Redentoristi, fondava l’Accademia Alfonsiana quale<br />
Istituto interno alla Congregazione del Santissimo Redentore.<br />
Tale evento verrà commemorato durante il prossimo anno accademico,<br />
insieme al 40° anniversario dell’incorporazione dell’Accademia<br />
Alfonsiana nella Facoltà Teologica della Pontificia Università<br />
Lateranense, avvenuta il 2 agosto 1960.<br />
L’inaugurazione dell’anno accademico 1999-2000, che si<br />
terrà l’8 ottobre 1999 sotto la presidenza di S.E.R. Mons. Angelo<br />
Scola, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense,<br />
verrà caratterizzata proprio da queste due ricorrenze.<br />
8. Gradi accademici conferiti<br />
8.1. Dottori designati<br />
Nel corso dell’anno accademico 1998-1999, 19 studenti hanno<br />
difeso pubblicamente la loro dissertazione dottorale:<br />
AUDU, Matthew (Nigeria – diocesi di Makurdi): A Smaller Family<br />
Size, the Alleged Solution to the Predicaments of Poverty and<br />
Hunger in Developing Countries (A Moral Evaluation of the<br />
Arguments For and Against) – 31 maggio 1999; Moderatore:<br />
Prof. Brian Johnstone<br />
The thesis examines the offer of the smaller family size as the<br />
only solution to the predicaments of poverty and hunger in developing<br />
countries in light of the Christian moral understanding<br />
of the human person, his dignity, his work, his sights, and his responsibility<br />
towards God and his neighbours.<br />
The result of the research is that there are many factors responsible<br />
for the poverty and hunger in developing nations, therefo-
CHRONICLE / CRÓNICA 461<br />
re smaller family size as their solution is erroneous and deceptive.<br />
Multiple solutions are required.<br />
CHAPEL, Joseph R. (U.S.A. – arcidiocesi di Newark): Why Confess<br />
Our Sins Out Loud? An Analysis Based on the Dialogical Philosphy<br />
of Ferdinand Ebner in Light of the Philosophy of Language<br />
and the Symbolic Sacramentology of Louis-Marie Chauvet<br />
– 11 marzo 1999; Moderatore: Prof. Bruno Hidber<br />
This dissertation responds to the commonplace question, “why<br />
should I tell my sins to another person? I confess directly to God;<br />
God knows I’m sorry for my sins and I know He forgives me.” The<br />
decline in recourse to sacramental reconciliation – specifically at<br />
the level of confession of sins out loud is examined using language<br />
philosophy as a means of dialogue between the dialogical personalism<br />
of Ferdinand Ebner and the sacramental theology of<br />
Louis-Marie Chauvet to explore the constitutive nature of “word”<br />
as it relates specifically to the confession of sins: as human<br />
beings, because we “have the word”, we must “say the word”.<br />
ETTIEN, Narcisse (Costa d’Avorio – diocesi di Yopougon): Des<br />
exigences éthiques préalables à un développement authentique.<br />
Réflexions à partir du cas du Sahel – 13 maggio 1999;<br />
Moderatore: Prof. Sebastiano Viotti<br />
Face aux défis du Sahel, de nombreuses solutions à caractère technique<br />
et matériel ont été proposées, mais sans véritable résultat.<br />
Au coeur des relations entre nations, inscrit dans la perspective<br />
du bien véritable de l’homme, on ne saurait atteindre aucun<br />
développement authentique, tant au niveau conceptuel que pragmatique,<br />
sans mettre l’accent sur des exigences éthiques indispensables.<br />
Entre autres, il nous semble opportun de porter l’insistance<br />
sur la solidarité, la justice et le respect de la personne<br />
humaine. C’est en les insérant au coeur des solutions préconisées<br />
que l’homme peut parvenir à une véritable libération des<br />
contraintes qui l’oppriment et donner, à long terme, totale expression<br />
à sa dignité d’image de Dieu.<br />
HOSTETTER, Laurence D. (U.S.A. – diocesi di Owensboro): The<br />
Ecclesial Dimension of Personal and Social Reform in the
462 DANIELLE GROS<br />
Writings of Isaac Thomas Hecker - 18 maggio 1999; Moderatore:<br />
Prof. Raphael Gallagher<br />
This dissertation seeks to address the question of the church’s role<br />
in reform from the perspective of Isaac Thomas Hecker (1819-<br />
1888). For Hecker, personal and social reform ultimately meant<br />
the realization of human and societal potential. The church, as<br />
Christ’s presence in history, enables this realization through the<br />
sanctification of individuals and through its work in society by<br />
means of those same individuals. Through narrative analysis<br />
this study traces the development of Hecker’s thought and isolates<br />
four core concepts upon which Hecker’s theology of reform<br />
is based: the human potential for communion with God; the role<br />
of the Holy Spirit in the life of the individual; the authority of<br />
the Catholic church; and the organic and development nature of<br />
the church<br />
KAMBANDA, Antoine (Rwanda – diocesi di Kigali): Structural Sin<br />
in Sollicitudo Rei Socialis in Relation to some Aspects of<br />
North-South Trade Structures - 27 gennaio 1999; Moderatore:<br />
Prof. Raphael Gallagher<br />
It is a study of structural sin in Sollicitudo Rei Socialis. The thesis<br />
discusses the situation of poverty and misery in the world of<br />
wealth and advanced technology in terms of structural sin. It gives<br />
the origin and evolution of the concept of structural sin. It<br />
shows the structural sin basically to be the sin of idolatry which<br />
is structured in the society. The moral nature of the problem of<br />
underdevelopment of the South, particularly in the North-South<br />
trade structures, is confirmed in the study of the Brandt Commission<br />
Report. This underdevelopment is evaluated in the light<br />
of the principle of solidarity and here structural sin is described<br />
as the sin of unsolidarity. It calls for conversion which is realised<br />
by the constructing structures of solidarity.<br />
KARUTA, Wenceslas (Rwanda – diocesi di Ruhengeri): La sacramentalité<br />
de la famille. Données théologiques fondamentales<br />
pour une redécouverte de l’identité de la famille. Conséquences<br />
pour la réflexion de l’Eglise - 26 febbraio 1999; Moderatore:<br />
Prof. Silvio Botero
CHRONICLE / CRÓNICA 463<br />
La famille est une réalité théologique; sa source et son prototype<br />
est Dieu Trine et Un. Sa sacramentalité consiste dans la “participation”<br />
et la “signification” de la relation Dieu-humanité, Christ-<br />
Eglise. Il s’agit de la sacramentalité latente (créaturelle ou embryonnaire);<br />
fondamentale (ou chrétienne); plénière (ou recherche<br />
de la réalisation plénière de la signication du mariage). La<br />
famille est donc: sacrement de la création et de l’alliance; sacrement<br />
de la Trinité comme “Prototype” sacrement de l’Eglise; sacrement<br />
de cohumanité. La famille doit développer sa potentialité<br />
sacramentelle.<br />
MAZUELOS PEREZ, José (Spagna – diocesi di Sevilla): Posibilidad<br />
y significado de una bioética mediterránea. Comparación de<br />
los modelos bioéticos de H.T. Engelhardt y D. Gracia – 13 novembre<br />
1998; Moderatore : Prof. Maurizio Faggioni<br />
El trabajo está enfocado a determinar si es posible, frente a la<br />
bioética de corte anglosaj plénière de la signication du mariage).<br />
La famille est donc: sacrement de la création et de l’alliance; sacrement<br />
de la Trinité comme “Prototype” sacrement de l’Eglacia,<br />
intentando alcanzar los siguientes fines: 1) descubrir si en ellos<br />
es posible determinar una conexión con los presupuestos filosóficos<br />
clásicos y con la ética hipocrática, algo que determina la<br />
existencia o no de una raíz mediterránea; 2) ver si dicha conexión<br />
influye a la hora de configurar el modelo bioético, lo que<br />
posibilita calificarlo como mediterráneo; 3) delimitadas las raíces,<br />
deducir a partir de ellas las posibles características de una<br />
bioética mediterránea.<br />
MBUMBA NGUVULU, Bonaventure (Repubblica Democratica del<br />
Congo – diocesi di Boma): La théologie politique selon Jean-<br />
Marie Aubert. Jalons pour un engagement socio-politique du<br />
chrétien africain. - 21 gennaio 1999; Moderatore: Prof. Brian<br />
Johnstone<br />
Depuis sa décolonisation, l’Afrique Sub-Saharienne est en proie<br />
à des problèmes multiformes: guerres tribales, famine, dictature,<br />
etc. Le manque d’une élite bien préparée et donc non mûre<br />
politiquement en est une des causes. Devant d’immenses potentialités<br />
dont dispose l’Afrique, nous pensons que les valeurs pro-
464 DANIELLE GROS<br />
mues par la pensée théologique-politique d’Aubert peuvent éclairer<br />
l’action socio-politique des africains en vue d’un avenir meilleur.<br />
La recherche des voies et des moyens qui peuvent aider l’Afrique<br />
à sortir de son marasme constitue l’objectif poursuivi<br />
dans notre dissertation doctorale.<br />
MIKODA, Dariusz (Polonia – diocesi di Legnica): La “Vita in Cristo”<br />
nella proposta di don Giuseppe Dossetti: un solo battesimo,<br />
un solo fine, due vie – 7 giugno 1999, Moderatore: Prof.<br />
Sabatino Majorano<br />
La tesi prende in esame la “Vita in Cristo”, fondata sul mistero<br />
dell’Incarnazione, secondo don Giuseppe Dossetti, docente di Diritto<br />
Ecclesiastico, deputato alla Costituente e alla camera, stretto<br />
collaboratore del Card. G. Lercaro al Vaticano II, monaco. Una<br />
proposta e un modello validi per tutti i cristiani che in quanto tali<br />
hanno ricevuto la “consacrazione” fondamentale nel Battesimo.<br />
La sua Famiglia religiosa, che ha voluto essere giuridicamente<br />
riconosciuta come Associazione di laici, accomuna quanti<br />
sono chiamati alla castità per il regno e coloro che sono chiamati<br />
a vivere il sacramento del matrimonio. Due vie verso un unico<br />
scopo: lo sviluppo coerente della vita battesimale sino alla sequela<br />
pura e totale del Cristo, la lode della gloria della Trinità Santissima,<br />
l’attesa vigilante e amorosa del ritorno del Signore, l’intercessione<br />
incessante per la Chiesa e per tutta l’umanità.<br />
MRIGHWA, Novatus Silvery (Tanzania – diocesi di Same): The Pastoral<br />
Diocesan Synod as an Instrument of New Evangelization<br />
and Moral Renewal –27 maggio 1999; Moderatore: Prof.<br />
Seán Cannon<br />
Through a judicious blend of historical, canonical, pastoral and<br />
above all moral considerations, this study focuses on the pastoral<br />
diocesan synod in its present structure which is based on the<br />
Vatican II ecclesiology of communion and service. The study<br />
proposes that with the active involvement of the laity as well as<br />
clergy and religious, the diocesan synod must now widen its scope<br />
beyond its predominantly juridical concern, and be adapted<br />
as a fitting instrument for renewal activities in evangelization<br />
and moral life. This work reinterprets further the scope and
CHRONICLE / CRÓNICA 465<br />
method of the diocesan synod, so as to forge a closer relationship<br />
between ecclesiology and a community oriented moral<br />
theology.<br />
OSORIO SIERRA, Rosa Adela (Colombia – F.M.M.): KuRosa Adela<br />
(Colombia – F.M.M.): ts further the scope and method of – 28<br />
maggio 1999; Moderatore: Prof.ssa Nella Filippi<br />
Según la obra de Waman Puma, una tentativa de rescatar históricamente<br />
la mujer en el contexto y visión antropolófica-cultural<br />
de Abia Yala. Su aporte moral en el nacimiento de América.<br />
PALAZZI, Marcello (Italia – diocesi di Cesena-Sarsina): La condizione<br />
anziana, una sfida per la società e per la Chiesa: studio<br />
socio-psicologico, etico e pastorale - 20 novembre 1998; Moderatore:<br />
Prof. Maurizio Faggioni<br />
Questa tesi intende: Fare il punto sulla nuova visione complessa<br />
e problematica, determinatasi con la variazione demografica di<br />
questi ultimi anni che ha fatto assistere ad un aumento della popolazione<br />
anziana, tentando di rispondere agli interrogativi del<br />
tutto inediti, che il singolo e la comunità civile ed ecclesiale si ritrova<br />
ad affrontare; Favorire la riscoperta e la valorizzazione della<br />
condizione anziana, delineando per questa fase della vita una<br />
teologia per l’agire morale, mirante a formare e sostenere la consapevolezza<br />
sulle sue potenzialità.<br />
PANACHICKAVAYALIL, Thomas Sebastian (India – O.F.M.Cap.):<br />
Ethical Perspectives of the Waste Land of T. S. Eliot in the<br />
Multi-Religious Context of Today - 13 gennaio 1999; Moderatore:<br />
Prof.ssa Nella Filippi<br />
A critical analysis of The Waste Land is done here. Eliot’s high<br />
sense of morality and intuitive insights prompted him to point<br />
out the absence of moral values in the society and individual.<br />
The poet has presented here the whole spiritual story of humanity,<br />
fallen humanity, and pointed a way out to salvation by the<br />
process of purification and practice of moral virtues. The wisdom<br />
of the East and West are combined here in a harmonious<br />
way. The poet offers certain ethical provocations and conse-
466 DANIELLE GROS<br />
quences for the men and women of today. The message of The<br />
Waste Land is to be taken seriously while it is vital for our own<br />
meaningful existence as well as for the cultural, ethical and spiritual<br />
transformation of today’s world.<br />
SIMONE, Giannicola Maria (Italia – B.T.A.): Lo Spirito Santo radice<br />
del rinnovamento della vita cristiana. Il contributo di Papa<br />
Paolo VI alla svolta pneumatologica del Concilio Vaticano<br />
II – 14 giugno 1999; Moderatore: Prof. Sabatino Majorano<br />
In questo lavoro si è cercato di comprendere come lo Spirito<br />
Santo aiuta il cristiano a vivere la sua vita quotidiana. Poi, si è<br />
studiato come Paolo VI, in tutta la sua vita, ha spiegato ai cristiani<br />
il modo in cui lo Spirito Santo aiuta a essere più fedeli a<br />
Cristo.<br />
SMYKSY, Jsef (Polonia - C.Ss.R.): La diagnosi e il superamento<br />
della coscienza fallibile in Sant’Alfonso e nei manuali di teologia<br />
morale dei redentoristi fino al Concilio Vaticano II – 20<br />
aprile 1999; Moderatore: Prof. Sabatino Majorano<br />
La coscienza, santuario della persona, può, quasi cieca in seguito<br />
all’abitudine e al peccato (cf. GS 16) errare: per questa ragione<br />
non può essere considerata un giudice infallibile. La vasta<br />
problematica riguardante la coscienza fallibile, la sua diagnosi e<br />
il suo superamento, strutturata principalmente intorno alle nozioni<br />
di coscienza erronea, lassa, perplessa, scrupolosa, dubbia e<br />
probabile, nei trattati sulla coscienza in alcuni manuali del rigorismo,<br />
probabiliorismo, probabilismo e lassismo, come anche<br />
nel pensiero teologico morale di Sant’Alfonso e di alcuni redentoristi,<br />
è stato oggetto di ricerca della presente dissertazione.<br />
SON, Josephus Sung-Ho (Corea – diocesi di Daegu): L’atto coniugale<br />
come espressione d’amore. Un confronto tra la tradizione<br />
e il post-concilio - 18 dicembre 1998; Moderatore: Prof.<br />
Silvio Botero<br />
Nella tradizione l’atto coniugale veniva scusato solo per il motivo<br />
della procreazione della prole. Con una prospettiva più aperta,<br />
dopo il Concilio l’atto coniugale viene inteso come una
CHRONICLE / CRÓNICA 467<br />
espressione intima d’amore reciproco, sia da parte dei teologi sia<br />
da parte del Magistero. Questa sottolineatura non è una nuova<br />
invenzione, ma è un ricorso alla Bibbia e una riscoperta della<br />
tradizione dimenticata.<br />
SOPI, Mikel (Kosovo – diocesi di Prizren): I fondamenti ontologici<br />
della dignità dell’uomo. La soggettività della persona umana<br />
in Pavan – 11 dicembre 1998; Moderatore: Prof. Brian<br />
Johnstone<br />
L’argomento ricopre un ambito semantico ampio. Il motto “conosci<br />
te stesso” (a partire dalla fondazione ontologica) si impone<br />
all’uomo di oggi – “perso” e senza punti di riferimento – come<br />
la chiave di lettura della propria realtà, affinché possa assumere<br />
la responsabilità e “comprendere” la vita “in pienezza”. L’obiettivo<br />
è stato quello di ricostruire i concetti basilari di Pavan,<br />
fino a mettere in luce le basi del suo discorso teologico-morale e<br />
filosofico-giuridico. La persona porta in sé l’impronta divina:<br />
l’uomo anela alla libertà, alla verità, alla bontà, alla giustizia; Dio<br />
è la Libertà, la Verità, La Bontà, La Giustizia. L’uomo è, e resta<br />
il fondatore di ogni storia, il costruttore di ogni assetto sociale,<br />
l’essere continuamente in tensione trascendentale.<br />
TARABAY, Antoine (Libano - O.L.M.): Bioéthique catholique et<br />
bioéthique musulmane: étude d’éthique comparée en vue d’une<br />
bioéthique interreligieuse - 16 giugno 1999; Moderatore:<br />
Prof. Maurizio Faggioni<br />
Cette recherche vise un rapprochement entre l’Eglise Catholique<br />
et l’Islam sur la bioéthique. Elle constitue un essai pour une<br />
bioéthique interreligieuse. La confrontation éthique entre les<br />
deux religions met en évidence les points communs qui expriment<br />
une possible collaboration et révèlent la volonté d’un dialogue<br />
bioéthique. En revanche, elle dévoile aussi que les divergences<br />
ne sont pas sur les questions apparentes mais qu’elles<br />
touchent des principes fondamentaux. Cette étude d’éthique<br />
comparée pointe les efforts de l’Eglise pour l’ouverture, l’entente<br />
et le dialogue avec l’Islam.
468 DANIELLE GROS<br />
ZAPALA, Janusz (Polonia – S.D.B.): La configurazione a Cristo<br />
Buon Pastore fondamento e fulcro della vita sacerdotale alla<br />
luce dell’esortazione post-sinodale Pastores Dabo Vobis – 10<br />
maggio 1999; Moderatore: Prof. Sabatino Majorano<br />
L’aspetto teologico-morale della vita sacerdotale, che scaturisce<br />
dalla “configurazione” a Cristo Buon Pastore, e che costituisce il<br />
punto focale della ricerca, viene esaminato alla luce dell’esortazione<br />
post-sinodale Pastores Dabo Vobis di Giovanni Paolo II. Lo<br />
studio si articola in quattro capitoli: le prospettive conciliari e il<br />
loro sviluppo da parte del magistero successivo (cap. 1); l’approfondimento<br />
e l’attualizzazione nell’VIII° Assemblea generale<br />
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (cap. II); l’esortazione post-sinodale<br />
Pastores Dabo Vobis (cap. III); l’aspetto teologico-morale<br />
del tema della configurazione del presbitero a Cristo Buon Pastore<br />
nella Pastores Dabo Vobis (cap. IV). Dopo aver considerato<br />
come Gesù Cristo costituisca il principio fondante ed esemplare<br />
del presbitero e come l’unica santità del battezzato si esprima<br />
nella vita del presbitero stesso, sono state approfondite e tracciate<br />
delle linee pratiche, rispondenti ad una profonda attualità<br />
e urgenza storica. Trattando dell’esistenza sacerdotale nel suo essere,<br />
vivere ed operare, ne sono stati puntualizzati i vari aspetti,<br />
con riferimento all’impenetrabile amore di Cristo Buon Pastore,<br />
ponendo in rilievo alcuni, tra i più significativi, tratti teologico<br />
morali della vita del presbitero.<br />
8.2. Dottori proclamati<br />
Durante l’anno accademico 1998-1999 i 23 studenti di seguito<br />
indicati, ai quali è stato conferito il titolo di dottore in teologia<br />
con specializzazione in teologia morale, hanno pubblicato,<br />
alcuni in versione integrale, la loro tesi dottorale:<br />
AERTS, Bruno, Solidarity Born out of Communion. An Inquiry into<br />
the Social Dimension of Premonstratensian Spirituality.<br />
Excerpta. Roma 1998, 214 pp.<br />
ANZALONE, Giuseppe, Teologia della tenerezza e stile di vita cristiana<br />
di fronte al fenomeno mafioso. Caltanissetta 1998, 232 pp.
CHRONICLE / CRÓNICA 469<br />
BILOKAPIC, Simun, Problemi morali riguardanti la violenza carnale<br />
con riferimento particolare allo stupro di massa nella<br />
guerra della ex-Jugoslavia. Excerpta. Roma 1999, 198 pp.<br />
CHAPEL, Joseph R., Why Confess Our Sins Out Loud? An Analysis<br />
Based on the Dialogical Philosophy of Ferdinand Ebner in<br />
Light of the Philosophy of Language and the Symbolic Sacramentology<br />
of Louis-Marie Chauvet. Roma 1999, 331 pp.<br />
CHIRAPPANATH, Stephen, An Ethics of Cooperation in Health Ministry.<br />
The Catholic Physician and Sterilization Procedures.<br />
Excerpta. Roma 1998, 133 pp.<br />
FERNANDEZ ANTA, Zacarias, La utopia de la nueva cristiandad en<br />
Jacques Maritain. Roma 1999, 360 pp.<br />
HOSTETTER, Laurence D., The Ecclesial Dimension of Personal<br />
and Social Reform in the Writings of Isaac Thomas Hecker.<br />
Roma 1999, 442 pp.<br />
JERUMANIS, Andris-Marie, L’homme, splendeur de la gloire de<br />
Dieu. Les fondements esthétiques de la morale chrétienne selon<br />
Saint Paul, Saint Augustin et Hans Urs Von Balthasar. Excerpta.<br />
Roma 1998, 191 pp.<br />
KAMBANDA, Antoine, Structural Sin in SOLLICITUDO REI SO-<br />
CIALIS in Relation to some Aspects of North-South Trade<br />
Structures. Excerpta. Roma 1999, 158 pp.<br />
KRAJ, Jerzy, “Mysterium Iniquitatis” e “Mysterium Pietatis” nell’insegnamento<br />
di Giovanni Paolo II sulla redenzione (1978-<br />
1992).Excerpta. Gerusalemme 1998, 151 pp.<br />
KUZMINSKI, Dariusz, Educazione della coscienza nel giorno del Signore.<br />
Itinerario di vita cristiana proposto dal lezionario festivo<br />
del rito romano. Excerpta. Roma 1999, 102 pp.<br />
MARTELLA, Luigi, La centralità di Cristo nella vita cristiana. Analisi<br />
del magistero C.E.I. negli anni ‘80. Roma 1999, 280 pp.
470 DANIELLE GROS<br />
MATULIC, Tonci, Lo statuto dell’embrione umano. Lo statuto ontologico<br />
dell’embrione umano nella prospettiva storica e nel<br />
dibattito bioetico attuale alla luce dei dati scientifici moderni.<br />
Excerpta. Roma 1999, 224 pp.<br />
MAZUELOS PEREZ, José, Posibilidad y significado de una bioética<br />
mediterránea. Comparacine umano nella prospettiva storica e<br />
nel dibattito bioetico Excerpta. Roma 1999, 117 pp.<br />
MAZZEO, Antonio, Il dinamismo dell’ethos. Una rilettura del metodo<br />
filosofico-teologico di Karol Wojtyla. Excerpta. Roma<br />
1998, 70 pp.<br />
PALAZZI, Marcello, La condizione anziana, una sfida per la società<br />
e per la Chiesa. Excerpta. Roma 1999, 169 pp.<br />
PANACHICKAVAYALIL, Thomas S., Ethical Perspectives of the Waste<br />
Land of T.S.Eliot in the Multi-religious Context of Today. Roma<br />
1999, 260 pp.<br />
PISANA, Domenico, La famiglia santuario della vita. La riprogettazione<br />
dell’ethos familiare siciliano alla luce di “Evangelium<br />
Vitae”. Roma 1999, 492 pp.<br />
SMYKSY, Jozef, La diagnosi e il superamento della coscienza fallibile<br />
in Sant’Alfonso e nei manuali di teologia morale dei Redentoristi<br />
fino al Concilio Vaticano II. Excerpta. Roma 1999,<br />
75 pp.<br />
SON, Josephus Sung Ho, L’atto coniugale come espressione d’amore.<br />
Un confronto tra la tradizione e il post-concilio. Excerpta.<br />
Roma 1999, 85 pp.<br />
TATI, Raul, Crise africana e processo de democratizaçao em Africa.<br />
Pertinência e implicaçoes ético-antropola moraleRoma<br />
1998, 294 pp.<br />
WROBEL, Józef, I fondamentali doveri e i diritti della persona<br />
nelle opere di Jacques Maritain. Excerpta. Roma 1999, 118<br />
pp.
CHRONICLE / CRÓNICA 471<br />
ZAK, Lubomir, “Verità ed ethos”. Il pensiero etico nella “teodicea”<br />
di P.A. Florenskij. Excerpta. Roma 1998, 108 pp.<br />
8.3. Licenza in teologia morale<br />
Nel corso dell’anno accademico 1998-1999, 69 studenti hanno<br />
ottenuto la licenza in teologia morale:<br />
AFOLA, Kossi M. (Togo - M.C.C.J.): Une éthique sociale pour le Togo:<br />
une esquisse basée sur des documents de l’Eglise catholique.<br />
AL-ALAM, Elie (Libano - B.M.V.): La famiglia Chiesa Domestica<br />
secondo il pensiero di Giovanni Crisostomo.<br />
ALBAO, Alan (Filippine - M.F.): L’impossibilità di assumere gli obblighi<br />
essenziali del matrimonio per motivi psicologici. (Studio<br />
comparativo tra il Codice di Diritto Canonico ’83, can.<br />
1095, § 3 e l’articolo 36 del Codice sulla famiglia delle Filippine<br />
‘87).<br />
AMAN, Petrus Kanisius (Indonesia - O.F.M.): Preferential Option<br />
for the Poor as a Moral Category according to “Sollicitudo Rei<br />
Socialis”.<br />
ANTHONY, Augustine (India - O.P.): Mixed and Interfaith Marriages<br />
in Central India. Ecumenical and Moral Perspectives.<br />
ANUFORO, Vincent Chinwem (Nigeria - R.C.J.): La bioetica dell’infanzia.<br />
Con particolare riferimento al contesto socio-culturale<br />
nigeriano.<br />
AROCKIA SAMY SOOSAI, John Peter (India - diocesi di Tanjore):<br />
Parents: The Co-creators in the Creative Plan of God. A Special<br />
Reference to the Teachings of Pope John Paul II on Marriage.<br />
ATJAS, Yonas (Indonesia - diocesi di Amboina): I contributi della<br />
teologia morale alla cultura tanimbarese nell’evangelizzazione<br />
nuova.
472 DANIELLE GROS<br />
AUNGWIN, Cyprian (Myanmar - diocesi di Mandalay): The Concept<br />
of Justice in the Teaching of St. Thomas Aquinas.<br />
BEAUDRY, Anne (Canada): Our Adoptive Filiation as it is revealed<br />
in the Paschal Mystery according to F.-X. Durrwell’s “Le Père,<br />
Dieu en son Mystère”.<br />
BUNGAMA, Aspego T. (Repubbica Democratica del Congo -<br />
M.C.C.J.): L’action non-violente dans le contexte actuel du<br />
Congo.<br />
CACCAVALE, Charles (U.S.A. - diocesi di Brooklyn): Resurrection<br />
and the Moral Life: An Analysis of Three Texts on the Resurrection<br />
of Jesus Christ<br />
CANNIZZARO, Corrado (Italia - diocesi di Venezia): La clonazione.<br />
Prospettive per una valutazione etica.<br />
CARVALHO DE SIQUEIRA, José (Brasile - diocesi di Parnaiba): Os<br />
excluídos na consciência da Igreja do Brasil (1991-1998)<br />
CENDEJAS ALEJANDRE, Manuel (Messico - diocesi di Zamora):<br />
Guerra justa: estudio sobre la carta “Firmissimam constantiam”<br />
de Pio XI al Epescopado Mexicano, respecto a la situación<br />
religiosa en Mexico.<br />
CHITTUPARAMBIL, Francis (India - O.C.D.): Moral and Pastoral<br />
Dimensions of Integral Healing.<br />
CICCARELLI, Lida (Italia - diocesi di Firenze): L’ethos dell’unità alla<br />
luce della proposta di Chiara Lubich.<br />
CIURARU, Ion (Romania - O.F.M.Conv.): La pastorale dei divorziati<br />
risposati. Il principio dell’indissolubilità e la sua applicazione<br />
nella realtà odierna.<br />
COLOPELNIC, Vasile (Romania - diocesi di Raramures): La dimensione<br />
morale della politica nell’insegnamento di Giovanni<br />
Paolo II.
CHRONICLE / CRÓNICA 473<br />
CORREIA CRUZ, Valtewan (Brasile - diocesi di Aracaju): A fome e<br />
a pobreza na América Latina. Suas causas e reflexao éticoteológica.<br />
COUTINHO, Matthew (India - S.D.B.): Moral Education and the<br />
Role of the Moral Theologian.<br />
CREANZA, Giuseppe (Italia - diocesi di Altamura): Il fenomeno<br />
“vita”. Prospettive scientifiche, filosofiche e teologico-morali.<br />
DA SILVA, Mário Antonio (Brasile - diocesi di Jacarezinho): A<br />
família e os desafios da educaçao para o discernimento ético.<br />
Uma reflexao sobre o ideal ético da família crista brasileira.<br />
DEL BROCCO, Salvatore E. (Italia - C.P.): Il grido della storia nell’opera<br />
“La Storia” di Elsa Morante. Prospettive etiche.<br />
DEL MISSIER, Giovanni (Italia - diocesi di Udine): Considerazioni<br />
etiche sugli interventi normativi riguardanti l’AIDS in Italia.<br />
DEL TORO RUEDA, Noé H. (Messico - O.F.M.): La comunicación<br />
en la pareja, elemento indispensable en la formación del “nosotros<br />
conyugal”.<br />
DROTAR, Kent Fabian (U.S.A. - diocesi di Denver): The Fundamental<br />
Option in Contemporary Moral Theology.<br />
ESCOBAR HUAMANI, Freddy J. (Perù - C.Ss.R.): Perú: De la crisis<br />
de valores hacia una cultura de la vida y de la paz. (Reflexiones<br />
sobre la realidad peruana en la etapa de 1979-1992).<br />
GALDEANO, Cristobal José (Argentina - diocesi di Mendoza): La<br />
dignidad Humana en Tres Documentos de la Conferencia Episcopal<br />
Argentina.<br />
GALLARDO, Jorge Alberto (Argentina - F.M.S.): La educación moral<br />
en la escuela media.<br />
GIOBBI, Ileana (Italia - diocesi di Roma): Lo spirito come legge<br />
nuova nella catechesi morale oggi.
474 DANIELLE GROS<br />
GRECO, Vincenzo (Italia - S.J.): Guerra e pace negli scritti politici<br />
di Martin Lutero.<br />
IGWE, Veronica (Nigeria - D.M.M.M.): Human Sexuality as an Indispensable<br />
Factor in Inter-personal Relationships: Ethical<br />
Implications.<br />
KILADA, Indrawes Bisada (Egitto - diocesi di Luxor): La famiglia<br />
cristiana tra la Chiesa e la società in Egitto.<br />
KULCHANDRA D’CRUZ, Alphonse (India - diocesi di Delhi): The<br />
Influence of Original Sin on The Just War Theory of St. Augustine.<br />
LEFORT, David R. (U.S.A. - diocesi di Albany): Futility and Proportionality:<br />
Decision-Making for Patients Whose Treatments<br />
Offer No Hope of Recovery.<br />
LOMBARDI, Filippo (Italia - diocesi di Matera): Educare alla speranza.<br />
Itinerario etico pedagogico allla luce dei Catechismi della<br />
Chiesa italiana.<br />
LOPES RICCI, Luiz Antonio (Brasile - diocesi di Bauru): Escolha<br />
a vida (Dt 30, 19). Alguns princípios para uma cultura da vida<br />
na encíclica “Evangelium vitae”.<br />
MADATHIKUNNEL, Augustine (India - diocesi di Khandwa): Abortion:<br />
Destruction of a Person.<br />
MEDINA SANCHEZ, Juan José (Colombia - C.Ss.R.): El eclipse de<br />
la imagen del Padre.<br />
MONTEVERDE, Giuseppe (Italia - S.J.): Il “Satyagraha” una possibile<br />
via per un’attuazione sociale e politica di un “sogno”. “Se<br />
amiamo coloro che ci amano, questa non è non violenza. Non<br />
violenza è amare coloro che ci odiano” (M.K. Gandhi).<br />
MULAKKAL, Franco (India - diocesi di Jullundur): Concept of<br />
‘Good Life’ according to Guru Nanak.
CHRONICLE / CRÓNICA 475<br />
N’DZENDZE, Paul (Congo - diocesi di Owando): Le guerre civili<br />
del Congo-Brazzaville e le grandi sfide etiche lanciate dal Sinodo<br />
per l’Africa: La posizione e la situazione della Chiesa locale.<br />
NASR, Youssef (Libano - B.S.): “Etre fils dans le fils”. Essai de fondation<br />
de la morale chrétienne sur le mystère du Christ chez<br />
Réal Tremblay, C.Ss.R.<br />
NYUNT WAI, Maurice (Myanmar - diocesi di Pathein): The Value<br />
of Life. Theravada Buddhist Perspective and Catholic Christian<br />
Perspective. (A Comparatve Study towards Interreligious<br />
Dialogue).<br />
ONOFRI, Alberto (Italia - F.F.B.): L’amore coniugale nella catechesi<br />
della Chiesa italiana. Un confronto tra i catechismi dei giovani<br />
e il catechismo degli adulti.<br />
PAIZANO, Heriberto (Nicaragua - diocesi di Granada): Aspecto<br />
antropológico de la justicia sociale, en la enciclica “Centesimus<br />
annus”.<br />
PALOMINO OUTON, Angel N. (Spagna - O.C.D.): La corporeidad<br />
presupuesto de la relación conyugal. Una reflexión antropológica-teológica<br />
del cuerpo.<br />
PASCUCCI, Luciano (Italia - diocesi di Roma): La fraternità sacerdotale<br />
alla luce della “Pastores dabo vobis” e del “Direttorio per<br />
il ministero e la vita dei presbiteri”.<br />
PEREZ SILVAN, José Manuel (Messico - diocesi di Tabasco): Las<br />
relaciones sexuales prematrimoniales. Una reflexión ético-pastoral.<br />
PINTO, Denver John (India - C.Ss.R.): The Significance of “Person”<br />
in the Bio-ethical Writings of Bernhard Häring and Stanley<br />
Hauerwas.<br />
POTTER, David (Gran Bretagna - diocesi di Liverpool): Human<br />
Cloning: A Theological Evaluation.
476 DANIELLE GROS<br />
QUARANTA, Giuseppe (Italia - O.F.M.Conv.): La metodologia della<br />
dottrina sociale della Chiesa: un confronto tra “Rerum novarum”<br />
e “Sollicitudo rei socialis”.<br />
RASCHI, Gabriele (Repubblica di San Marino - O.F.M.): Etica dell’infanzia.<br />
Il bambino sano e malato come soggetto etico.<br />
RAYAPPAN PADMAVATHI, Vincent (India - diocesi di Neyyattinkara):<br />
The Ethical Implications of Genetic Engineering with Special<br />
Reference to Human Cloning.<br />
REYES ROMERO, Filiberto (Messico - M.S.F.): Hacia una ética de<br />
la misericordia.<br />
RIBEIRO, Antonio de Assis (Brasile - S.D.B.): As ambiguidades éticas<br />
da pós-modernidade: desafios e propostas para a educaçao<br />
moral juvenil à luz da ética crista.<br />
RIVERA HERNANDEZ, Luis Alberto (Colombia - diocesi di Socorro):<br />
Amor y verdad presupuestos para una ética sexual conyugal<br />
en la propuesta moral de Juan Pablo II.<br />
SOLA, Ivica (Croazia - diocesi di Djakovo): I significati del concetto<br />
della decisione nella filosofia di Martin Buber.<br />
SOOS, György (Ungheria - O.Praem.): Il fondamento antropologico<br />
della giustizia sociale: Un confronto tra John Rawls e Carlos-Josaphat<br />
Pinto De Oliveira.<br />
STACHERSKI, Remigiusz (Polonia - diocesi di Plock): Solidarietà<br />
come principio etico-morale nel dialogo cristiano-ebraico.<br />
Un’analisi alla luce di alcuni documenti della Chiesa.<br />
TOLO, Paulus (Indonesia - S.V.D.): Theology of the Body in the<br />
Teachings of John Paul II.<br />
TONDE, Bernard (Burkina Faso - diocesi di Bondoukou): Perspectives<br />
fondamentals sur l’éthique sexuelle dans la catéchèse<br />
morale en Côte D’Ivoire.
CHRONICLE / CRÓNICA 477<br />
TORRES ZEGARRA, Paúl Martín (Perù - O.F.M.Cap.): La relación<br />
ético-epiritual en Tullo Goffi.<br />
TOZZO, Massimo (Italia - S.J.): Affettività e moralità: una riflessione<br />
a partire dalla ricerca del p. L. M. Rulla.<br />
VALERO SANCHEZ, Erasmo (Messico - diocesi di San Luis Potosi):<br />
Nueva evangelización y moral en contexto mexicano a la<br />
luz de la visión alfonsiana.<br />
VALKOVIC, Jerko (Croazia - diocesi di Krk): Mass media e responsabilità<br />
morale nell’insegnamento di Paolo VI e Giovanni<br />
Paolo II.<br />
WIDYANTARDI, Fransiscus (Indonesia - diocesi di Purwokerto):<br />
Preparation for the Sacrament of Marriage.<br />
ZUMBA, Ailson Pinheiro (Brasile - diocesi di Cruzeiro Do Sul): A<br />
Família no Acre, objeto de evangelizaçao e instrumento evangelizador<br />
à luz da CNBB.<br />
DANIELLE GROS<br />
Segretaria Generale
Reviews / Recensiones<br />
Borriello, L., Caruana E., Del Genio M. R., Suffi N. (a cura di),<br />
Dizionario di mistica. Roma: Liberia Editrice Vaticana, 1998,<br />
1301 p.<br />
This work is a timely and much needed tool for researchers on<br />
Christian mysticism and related fields. It contains over 600 entries<br />
from 228 scholars and will almost certainly become the standard<br />
reference for anyone wishing to delve more deeply into the<br />
theoretical and practical nuances of contemporary mystical<br />
experience. The aim of the work is to bring clarity to the problem of<br />
mysticism as it is understood and disseminated in the current world<br />
arena. Although it focuses specifically on Christian mysticism, it<br />
makes appropriate references to mystical experience in other<br />
religions and takes great pains to integrate its insights with the<br />
psychological, social, and religious sciences. Serious efforts are also<br />
made both to present the historical and cultural contours that helped<br />
to shape the Christian mystical tradition and to highlight the great<br />
individuals, religious movements, and schools that went into making<br />
it so exceedingly rich and bountiful. Readers will also appreciate the<br />
way in which mysticism is related to other important fields of<br />
Christian experience, most notably: conversion, the virtues and vices,<br />
Christian asceticism, the liturgy, and spiritual theology.<br />
The entries themselves are compact, well-researched, written in<br />
a clear, generally uniform style, and conclude with a selected<br />
bibliography at the end that promises to guide interested readers to<br />
further primary and secondary sources. Of special interest are the<br />
* Las obras están ordenadas según el orden alfabético. / The works are<br />
arranged in alphabetical order.
480<br />
“Suggerimenti per una Lettura Sistematica del DIM” (pp. 11-15),<br />
which order the entries in such a way so that the reader can use the<br />
work not merely as a reference book (to be used as random questions<br />
arise), but also as a kind of “textbook” on the mystical life (to be read<br />
in a more methodical and reflective manner). This valuable<br />
hermeneutical key guides the reader first through those entries<br />
dealing with the basic distinctions between spirituality and<br />
mysticism, then through those that focus on the diverse mystical<br />
experiences present throughout the course of history (with particular<br />
reference to their geographic provenance), and then through those<br />
that treat the various types of mysticism. It continues with articles<br />
dealing with mysticism as it is incarnated in daily life, moves on to<br />
those that delve into the specifically experiential dimensions of<br />
mysticism, and then to those concerned with how those experiences<br />
are lived by “l’uomo spirituale.” It concludes by suggesting that the<br />
reader go through those articles dealing with the actual expressions<br />
of mystical experience, then through those which discuss some of the<br />
typical movements of mysticism that have arisen through the course<br />
of time, and finally through those dealing with the various problems<br />
arising from specific cultural contexts. Anyone who takes the time<br />
and the effort to go through the work in this way will be exposed to<br />
a comprehensive account of how mystical experience is understood<br />
in the Catholic Church today. Those who do not, can still use these<br />
suggestions as a way of placing a particular entry in the context of a<br />
larger theological and structural whole. For this reason, the<br />
“Suggerimenti” can be considered an integral part of the work and<br />
should be read through and studied carefully if the reader wishes to<br />
make full use of the material at his or her disposal.<br />
It would be next to impossible to provide an adequate critique of<br />
the scholarship presented in this massive work. To do so would<br />
require a small volume in its own right, one that would take the time<br />
to examine with a critical eye not only the individual entries<br />
themselves, but also the cumulative effect they have on the volume<br />
as a whole. Care would also have to be given to what the editors have<br />
judiciously decided to omit. On the positive side, this reviewer<br />
concurs with the observations made by Raffaele Farina in the<br />
Introduction which applaud the Dictionary’s attempt to offer: (1) a<br />
doctrinal corpus of material rooted in the tradition of the Church<br />
and (2) the experience of mystics who are open to the action of the<br />
Spirit in every age, in every place, in every stage of life, and in every
481<br />
state of life (p. 6). On the more critical side, this reviewer finds it<br />
strange that the editors would include individual entries on the<br />
Father, Son (under “Cristo – Cristocentrismo”) and Spirit, but choose<br />
to omit a corresponding synthetic entry on the Trinity. He does not<br />
understand, moreover, why they would include an entry on the gifts<br />
of the Spirit, but fail to include a corresponding one on the fruits. He<br />
also finds it curious that they would permit an entry on friendship<br />
which has virtually nothing to say about Aelred of Rievaulx’s twelfthcentury<br />
treatise on Spiritual Friendship, one of the classic texts –<br />
Christian or otherwise – on the subject. He wonders, moreover, how<br />
their claim in the Preface to examine mystical experience in all times<br />
and in all geographical areas (“...in tutti i tempi e in tutte le aree<br />
geografiche,” p. 7) would account for the book’s near total disregard<br />
for the mystical experience on the American continent. The entries<br />
on “Americanismo” and “Thomas Merton,” while interesting and<br />
valid in their own right, do not even begin to tap the wealth of<br />
spiritual and genuinely mystical experiences which touched the<br />
human spirit long before the white man ever touched the shores of<br />
the Americas. An entry on Native American mysticism would have<br />
been a welcome complement to the very fine entries dedicated to<br />
other geographical areas. A similar critique could be made regarding<br />
the lack of inclusion of the native African religions. These curious<br />
omissions point to the selective nature of reference works of this<br />
kind and of the difficult task the editors had in integrating the vast<br />
amount of material relating to the study of mystical experience in the<br />
present day.<br />
Despite these few and relatively minor lapses, the work is<br />
masterfully conceived and executed. Whatever lacunae the reader<br />
might find can easily be supplemented by parallel and<br />
supplementary reading. As a collaborative, interdisciplinary effort of<br />
experts in theology, the social sciences, and the humanities, it is a<br />
remarkable work that deserves a wide dissemination and readership.<br />
Although it is geared toward a wide (even popular) audience, the<br />
work would be especially useful to theologians, students of the<br />
religious sciences, and anyone with general or specialized interests<br />
in what mysticism has to say about the ultimate meaning of human<br />
existence.<br />
DENNIS J. BILLY, C.Ss.R.
482<br />
Chimirri, Giovanni (a cura di), L’Etica dell’idealismo. La filosofia<br />
morale italiana tra neohegelianismo, attualismo e spiritualismo.<br />
Milano: Associazione Culturale Mimesis, 1999, 192 p.<br />
El autor presenta, en este libro, una selección de textos<br />
“suficientemente amplia y representativa de lo que fue el idealismo<br />
italiano contemporáneo en sus principales corrientes:<br />
neohegelianismo, actualismo y espiritualismo cristiano de<br />
inspiración gentiliana” (p. 9). Su interés, sin embargo, se limita a la<br />
parte ética del pensamiento idealista y al rescate de algunos textos de<br />
importantes pensadores de esta corriente que no suelen aparecer en<br />
los libros de historia de la filosofía. Todo esto se refleja cabalmente<br />
en el título y subtítulo de la obra.<br />
La antología va precedida de una amplia introducción que<br />
ocupa un poco más de la mitad del libro. En ella el autor desarrolla<br />
un pequeño tratado sobre el idealismo, y particularmente sobre el<br />
idealismo moral, en una serie de breves capítulos que siguen un<br />
orden temático lógico. Chimirri comienza describiendo la herencia<br />
idealista y su actualidad (cap. 1), sus principales figuras (cap. 2) y su<br />
relación con otras filosofías (cap. 3). Focaliza después la esencia del<br />
idealismo (cap. 4) y expone sus reflexiones críticas (cap. 5) que<br />
formula “sobre todo en función de la legitimidad y posibilidad de<br />
una ética filosófica” (p. 47). A partir de allí el autor se concentra en<br />
la parte ética del idealismo desarrollando las relaciones entre el<br />
idealismo y la ética (cap. 6) y los temas más significativos de la ética<br />
idealista (cap. 7). Concluye su exposición con una serie de breves<br />
fichas bio-bibliográficas sobre los autores presentes en la antología y<br />
sobre otros filósofos importantes en el panorama italiano (cap. 8).<br />
Interesante es también la bibliografía que cierra la introducción.<br />
Creemos de utilidad señalar algunos presupuestos que sostienen<br />
y alimentan esta reflexión histórico-teorética. El autor parte de una<br />
doble constatación historiográfica: está convencido, por un lado, que<br />
ciertas nociones y reflexiones típicas del idealismo italiano<br />
sobreviven en otras corrientes filosóficas y, por otro, que no<br />
contamos todavía con una seria investigación sobre el idealismo<br />
desde el punto de vista moral. Otros dos presupuestos significativos,<br />
plenamente condivisibles, son de naturaleza crítico-teorética: la<br />
convicción de “la perenne validez de algunas tesis fundamentales del<br />
idealismo” y la certeza crítica que muchas de las páginas estupendas<br />
que el idealismo ha escrito sobre la ética pueden tener un sentido y
483<br />
un valor en el marco de una “metafísica creacionista” y de una “ética<br />
personalista cristiana” (p. 7).<br />
NARCISO CAPPELLETTO C.Ss.R.<br />
Ciorra, Anthony J. and Keating, James, Moral Formation in the<br />
Parish. New York: Alba House, 1998, 179 p.<br />
The dominating questions of this book are succinctly put on p.<br />
xv, and correspond to the six subsequent chapters: an over-view of<br />
parish life in the USA, the Eucharist as heart of the parish, the need<br />
for a process of discernment, a discussion of current pastoral<br />
problems and a headline-guide how to go about moral formation in<br />
the parish. Behind the outline the authors have a clear purpose. In<br />
their view the major issues in the Church are poor doctrinal<br />
formation, the prevalence of the autonomous conscience and a<br />
culture of individualism (xii, 28). Rejecting a return to<br />
authoritarianism as a solution to these issues (xiv), the authors try to<br />
write in a non-ideological way, a trait heartily to be recommended to<br />
all moral theologians (3, 4, 5, 6, 17, 55-59, 105). Though the topics of<br />
the book are not particularly novel, two characteristics should be<br />
noted. This is a book directed at the generation born after 1960, and<br />
it makes a sincere effort to avoid the theological wars that divided<br />
the pre-1960 generation who were writing in the 1970’s and 1980’s.<br />
Labels are eschewed as not being clear in meaning (5) and there is a<br />
serious effort to understand the arguments of authors as diverse as<br />
B. Häring, G. Grisez, C. Curran, E. Vacek Collins. Not that Ciorra-<br />
Keating agree with the various views of these authors (how could<br />
they?) but it is refreshing to read a theological work that rates<br />
arguments as more important than personalities, and proceeds<br />
accordingly. The other refreshing feature of the book is that the fairly<br />
traditional topics are put in a context wider than that found in most<br />
moral theological books. Discernment (xiv, 10, 15, 71, 76, 77),<br />
spirituality (8, 12,30) and friendship (59ff, 86ff) give a vibrancy to the<br />
discussion, especially when the practical issues of marriage, money,<br />
health care ethics and poverty are treated. I suspect these emphases<br />
arise from the authors’ commendable desire to avoid a ghetto-type<br />
Church (145) and, perhaps, a familiarity with some ideas of Saint<br />
Bonaventure, an authority not notably cited in theological ethics.
484<br />
The audience that could best profit from this book are pastoral<br />
leaders with a moderate theological training. The book lacks enough<br />
critical apparatus to be a standard text-book, but it is more than a<br />
run-of-the-mill adult education book. The difficulty of the questions<br />
treated is acknowledged (111), especially in the American cultural<br />
context (6-8). Though the book has merits given its particular scope,<br />
I would advert to two lacunae. The emphasis on discernment,<br />
already noted, is laudatory but the authors themselves acknowledge<br />
an intellectual gridlock on this topic (3). Could it be that the basis<br />
within which discernment is placed, largely of an ignatian<br />
provenance, would benefit from a wider treatment precisely as one of<br />
the cardinal virtues? It is not that the authors ignore the virtues, but<br />
I noted an insufficient integration of discernment (or, more<br />
classically, prudence) with the other virtues. More problematic is the<br />
call to tradition as a key to many of our current impasses (xvii, 31,<br />
etc.). I have sympathy with this position, particularly in view of the<br />
authors’ concern with combating an inadequate individualism (28).<br />
But: what tradition? One has only to recall recent works which show<br />
the great difficulty in deciphering the varieties of tradition within<br />
Thomism, as illustrated in T. O’Meara, Thomas Aquinas Theologian<br />
(1997) or G. Prouvost, Thomas d’Aquin et les thomismes (1996), and<br />
people familiar with the early 19 th century debates on tradition<br />
(moderate and otherwise) will know how de Maistre, de Bonald,<br />
Bautain, de Lamennais, Bonnetty and many others would have used<br />
the word tradition in widely differing senses. The appeal to tradition<br />
is not at all as easy as it seems. It would be a very interesting<br />
challenge for Ciorra-Keating to follow up this present useful book<br />
with an analysis of how precisely their idea of tradition functions as<br />
a criterion of justification in the discernment of difficult moral<br />
problems. Meanwhile, this useful work can provoke others to think<br />
in this direction which, I suspect, may be the next great debate for<br />
fundamental moral theology, under either the guise of ‘tradition’ or<br />
‘development’.<br />
RAPHAEL GALLAGHER C.Ss.R.
485<br />
Gaziaux, É., L’autonomie en morale. au croisement de la philosophie<br />
et de la théologie. Leuven: University Press, 1998, xvi + 760 p.<br />
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium<br />
C<strong>XXXVII</strong>I).<br />
This work is a post-doctoral dissertation presented at<br />
L’Université Catholique de Louvain. The aim, as declared by the<br />
author, is to study the issue of autonomy as a hinge concept between<br />
philosophy and theology. In particular, his intention is to develop an<br />
ethics in a theological context, an ethics that has its own identity and<br />
is, at the same time, open to critical dialogue with secular ethics.<br />
There are two basic questions: how can ethics in a theological<br />
context be rational, and how can it be communicable to others who<br />
do not share that particular context? Autonomy is proposed as the<br />
answer.<br />
The work has four parts: the first provides an analysis of<br />
autonomy in Kant; the second reviews the work of Th. Steinbüchel,<br />
Die philosophische Grundlegung der katholischen Sittenlehre (1939),<br />
as an example of the reception of Kantian thought into moral<br />
theology; the third that of A. Auer, whose work Autonome Moral und<br />
christlicher Glaube (2 nd . ed. 1989) initiated the debate on the subject<br />
in Catholic moral theology. The fourth deals with autonomy in terms<br />
of the relationship between philosophy and theology, where<br />
autonomy provides the link. A lengthy conclusion draws together the<br />
principle insights that have been gained.<br />
The aim of Steinbüchel and of Auer in particular, was to provide<br />
Christian ethics with a philosophical foundation, autonomous with<br />
regard to the particular world view of Christianity, and to its<br />
confessional presuppositions, and so make possible communication<br />
between Christians and those professing a secular ethic. The<br />
autonomy thesis, if we can call it that, would seem to be the<br />
following: It is impossible to found the truth claims of practical<br />
reason on grounds outside practical reason, that is, for example, on<br />
the doctrines of a particular faith or the decrees of religious<br />
authority. This raises, of course, questions concerning the<br />
relationship of such autonomous reason to faith and Church<br />
authority and these questions are dealt with in the work.<br />
In the fourth part Gaziaux studies the relationship between<br />
philosophy and theology. He begins with a study of autonomy from<br />
a philosophical perspective, again referring to the three principle
486<br />
authors, but now including a study of the history of the concept in<br />
antiquity, the middle ages and the modern period, again with<br />
particular reference to Kant and the relation between Kant and<br />
Hegel. Autonomy appears now in relation to radical evil and liberty,<br />
in that evil seems to remove the very possibility of liberty and with<br />
that of autonomy. The hope for a possibility of a recovered liberty<br />
and autonomy, opens up a path to God, thus providing a connection<br />
with religion and theology. The author then explores the notion of<br />
autonomous praxis in Marx, Scheler, Hartman, Apel, and Habermas.<br />
Here autonomy is manifested in its modern expression, namely,<br />
responsibility.<br />
The next section considers autonomy from the perspective of<br />
theology, considering autonomy specifically as a reality created by<br />
God, and examining the relation between faith and morality,<br />
redemption and autonomy. The author resists any reduction of faith<br />
to morality. Created reality is not merely reality, but a manifestation<br />
of the divine will. But this reality cannot be seen solely under the<br />
aspect of its beginning, creation, but must be viewed in terms of its<br />
future, that is salvation made present in Jesus Christ. Here again, he<br />
studies the three principal authors, and then relates autonomy to the<br />
notion of radical evil and to sin, particularly as this is presented in<br />
the Old and New Testament. There follows an analysis of liberty in<br />
relation to autonomy. Autonomy is the necessary foundation of<br />
ethics, autonomous ethics is founded on reality, which believers see<br />
as created by God, and ordered to salvation in Jesus Christ. Reality,<br />
(Wirklichkeit, effectivité) with which human life is lived, presents<br />
itself as a collection of active potentialities that are to be realized.<br />
Obligation is accounted for as founded on the non-fully realized<br />
potentiality of reality (724). The basic obligation of the autonomous<br />
ethic is to realize these potentialities.<br />
This ethic is autonomous with regard to bio-physiological<br />
nature, to metaphysics, and to faith. Nevertheless, faith does not<br />
suppress autonomy, but presents its ultimate ground of possibility, in<br />
offering the horizon of its ultimate fulfilment. Faith contributes a<br />
specific meaning, via a trinitarian hermeneutic of reality. The<br />
conclusion seeks to draw together the main lines of the argument,<br />
particularly with reference to autonomy as the principle and<br />
condition of morality and the basis of communicability. Autonomy<br />
means autonomy in the quest for meaning and truth in the search for<br />
the good. It is not absolute but relative, in the sense that it makes
487<br />
possible a communication between faith and ethics, such that faith<br />
can generate action in the world<br />
In seeking to follow through the long and complex argument the<br />
following questions emerged. The author has covered a wide range<br />
of material and probed the origins and meaning of autonomy at<br />
depth. But is it possible, with such an encyclopedic range of<br />
material, to research adequately each specific topic, and at the same<br />
time to integrate them into a coherent argument? Is the presumption<br />
that we can trace the emergence of the one idea of “autonomy”<br />
through the history of its emergence across such a vast range really<br />
justified? While it is true that both the Old Testament and the New<br />
integrated significant elements from the ethos of other peoples, may<br />
we equate the insights of these others as instances of a human ethic<br />
in general? Might they not have been highly particularized<br />
community ethics legitimated by appeals to other gods and other<br />
religious authorities? How do we know that what is left when we<br />
subtract these gods and authorities is the “human ethic”? Might not<br />
the process be better understood as a dialectic of traditions fraught<br />
with contingency, rather than the gradual, progressive emergence of<br />
an idea?<br />
There is a review of criticisms and the replies given by Auer at<br />
the end of the third part (328), and G. is not uncritical of the authors<br />
studied. For example, he finds the concept of reason developed by<br />
Auer to be inadequate, in that he has tried unsuccessfully to integrate<br />
several points of view without complete success (552). But a more<br />
systematically and developed critique by the author himself would<br />
have been welcome. It must be said, that, even at the end of the<br />
dissertation, this reviewer was still unable to find a clear notion of<br />
“reason.” However, one must remember that the author is seeking to<br />
discover the inner logic of the emergence of an idea rather than to<br />
establish the timeless essence of things.<br />
The autonomy thesis seems to claim three points: (1) It is<br />
possible to discover or construct a notion of reason or rationality<br />
that transcends the limits of particular communities and cultures, (2)<br />
This reason is best construed in terms deriving from the Kantian<br />
tradition, (3) Such a notion of reason will be found meaningful by<br />
those who inhabit the secular world, and so provides a basis for a<br />
common ethic. Each of these presuppositions would be controversial<br />
at least for some significant currents in contemporary philosophy. Of<br />
course G. is not saying that if we are to communicate with the world
488<br />
we must convert all non-Catholics into Kantians; what he offers is a<br />
second-level, meta-ethical thesis on how such communication may<br />
be justified. But the problems still remain: given this particular<br />
justification of autonomy-based communication, how is the<br />
universal human ethic itself to be recognized? The author replies: by<br />
discerning the possibilities which are given to us in reality (712). This<br />
appears to be a version of the natural law. Indeed Auer himself gives<br />
an important role to the natural law according to St Thomas (549).<br />
And yet the autonomous ethic is also autonomous with regard to<br />
nature. Is the autonomous ethic then a purely formal ethic?<br />
There is a troubling feature of the autonomy thesis, that G.<br />
seems to let pass. Reality is understood (by Auer) as an ontological<br />
order of creation that is a “manifestation of the will of God.” Is there<br />
an echo here of that philosophical and theological tradition which<br />
held that law, and in particular the natural law, was, if it were to have<br />
binding force, essentially a declaration of the will of God? The whole<br />
autonomy movement, if it may be called such, sought to break with<br />
the idea that morality is something decreed by external authority;<br />
but has it completely escaped from this notion? We cannot but note<br />
that the guiding concept is still law, “nomos,” as in heteronomous,<br />
autonomous, and finally theonomous. Similarly, the two key<br />
concepts Weltethos, that is the autonomous rational ethic, and the<br />
Heilsethik, concerned with the relation to Christ, are described as<br />
distinct sets of obligations. But there are other ways of explaining<br />
ethics than by law and obligation, for example, in terms of the<br />
attractiveness of the good. Kant did not favor this approach, but was<br />
he necessarily right?<br />
The notion of autonomy is said to rest on the distinction<br />
between “is” and “ought” (562). Here the author does not seem to be<br />
aware of the philosophical critique of this distinction that has been<br />
developed over a number of years in English language philosophy.<br />
This distinction is not a necessary feature of thought as such; it<br />
emerged in a quite particular setting, and remains one particular<br />
(contested) doctrine. With a profound cultural change, reflected in<br />
philosophy and theology, reality or the world lost its inner principle<br />
of reason that could provide direction for practical reason, and<br />
became morally inert. For a theory which accepted this conception<br />
of reality, it is self evident that “ought” cannot be derived from “is”,<br />
because the whole point is that “is” has already, in principle, been<br />
deprived of any relevance to “ought”. Indeed, Auer’ s whole argument
489<br />
is evidently directed to linking ethics once more with reality which<br />
does have an inner principle of reason. It would seem more<br />
appropriate to say, not that the autonomy theory, at least for Auer,<br />
rests on the distinction, but rather that it sets out to refute it.<br />
G.’s work provides difficult but stimulating reading on a topic<br />
which is vitally important both for moral theology and pastoral<br />
practice. For anyone wishing to understand the contemporary issue<br />
of autonomy in ethics, this book is well nigh indispensable. The work<br />
is admirably produced and there is an extensive bibliography and a<br />
helpful index of names.<br />
BRIAN V. JOHNSTONE, C.Ss.R.<br />
Giardini, Fabio, Pray without Ceasing: Toward a Systematic<br />
Psychotheology of Christian Prayerlife. Rome/Leominster,<br />
Herefordshire: Millennium/Gracewing: 1998, 426 p. (Millennium<br />
5).<br />
This book is a masterful analysis of the Pauline injunction “to<br />
pray without ceasing” (1Thes 5:17). The author, a professor of<br />
spiritual theology at the Pontifical University of St. Thomas in Urbe<br />
(PUST), affirms the close interconnection between the experience of<br />
prayer and theological reflection upon that experience. In carrying<br />
out his analysis, he tries to make his reflections “as objective and<br />
universal as possible, while at the same time allowing its experiential<br />
character to emerge” (p. 11). In doing so, he takes into account all<br />
three dimensions of the emerging academic discipline of spirituality:<br />
the experiential, the doctrinal, and the analytical. The result is a<br />
comprehensive and probing investigation of two fundamental<br />
questions of the spiritual life: “What are people doing when they<br />
pray?” and “Why is doing that ‘praying?’” (p. 11).<br />
The book recognizes a broad spectrum of definitions of prayer<br />
and explicitly refers to the great variety and complexity of all forms<br />
of prayer (p. 12). Its twelve chapters provide an orderly and<br />
systematic presentation of the principal components of prayer, the<br />
kinds and acts of prayer, integration and growth in prayer, and the<br />
transcendent attitude of prayer (p. 13). The topics covered include:<br />
“body, soul and spirit in prayer” (chapter one), “the mind’s attention<br />
in prayer” (chapter two), “the heart of prayer” (chapter three),
490<br />
“knowing and loving in prayer” (chapter four), “prayer as ascent”<br />
(chapter five), “prayer as address” (chapter six), “prayer as worship”<br />
(chapter seven), “prayer as communion” (chapter eight), “the<br />
dynamic integration of all forms of prayer” (chapter nine), “the<br />
growth process of the Christian prayerlife” (chapter ten), “unceasing<br />
prayer” (chapter eleven), and “the attitude of prayerfulness” (chapter<br />
twelve). When taken together, these topics point to (and validate) the<br />
author’s fundamental intention of providing what he calls in his<br />
subtitle “a systematic psychotheology of Christian prayerlife.”<br />
The book has many strengths, not the least of which is the way<br />
the author integrates the findings of both psychology and spiritual<br />
theology in his study. This reviewer was particularly impressed with<br />
the biblical basis of the author’s theological anthroplogy and the way<br />
he incorporates the insights of Jungian psychology (particularly that<br />
of the unconscious) into his analysis of the various dimensions of<br />
prayer. He was also impressed with the author’s thorough knowledge<br />
of the various traditions of prayer within the Catholic tradition (e.g.,<br />
Benedictine, Dominican, Carmelite, Jesuit) and the way he focuses<br />
on the key contributions each makes to understanding the meaning<br />
of Paul’s call for unceasing prayer.<br />
Each chapter is well-written and substantially documented<br />
through footnotes and an extensive bibliography. Each builds on<br />
what has gone before and contains a wealth of scholarly yet practical<br />
insights into the nature and scope of Christian prayer. Time and<br />
space do not permit anything more than a mere cursory listing of the<br />
author’s more important findings. Among these are: (1) his<br />
distinction between the body, soul, and, spirit of prayer, (2) his<br />
analysis of the various kinds of attention (e.g., active, receptive, and<br />
ecstatic), (3) his emphasis on the distinction between “attentiveness”<br />
and “awareness”, (4) his analysis of the various kinds of intention<br />
(e.g., receptive, active, and ecstatic love-intention), (5) his discussion<br />
of the essential roles of loving and knowing in the life of prayer, (6)<br />
his operative distinction between “prayer as ascent” and “prayer as<br />
address,” (7) his corresponding relational distinction between<br />
“prayer as worship” and “prayer as communion,” (8) his insightful<br />
integration of the operational (i.e., “ascent and address”) and<br />
relational (i.e., “worship and communion”) dimensions of Christian<br />
prayer, (9) his correlation of these different movements of prayer<br />
with the supernatural virtue of religion and the theological virtues of<br />
faith, hope, and charity, (10) his distinction between a habitus, which
491<br />
is caused by the repetition of a person’s acts, and an attitude, which<br />
is caused by the repetition of a person’s options (11) his emphasis on<br />
the close connection between the psychological notion of<br />
“personality” and the biblical category of “heart,” and (12) his<br />
presentation of “the attitude of prayerfulness” as a continuous<br />
awareness, remembrance, and expectation of God.<br />
These are just some of the probing insights that enable the<br />
author to map out with psychological sensitivity and sharp<br />
theological acumen the multifaceted and complex nature of prayer in<br />
the Catholic spiritual and thelogical tradition. While they in no way<br />
exhaust the depth of knowledge displayed throughout the book, they<br />
give a good indication of the author’s high quality of scholarly<br />
discourse and the direction he wishes to take his reader. That<br />
direction comes out most clearly in the book’s postscript (pp. 397-99),<br />
where the author first outlines many of the common biases and<br />
misunderstandings people have about prayer and then goes on to<br />
draw out the practical value of the various distinctions made<br />
throughout the work.<br />
Toward the end of his postscript, the author provides an apt<br />
summary of all that has gone on in the preceding chapters: “The<br />
desire of attaining an intimate union with God is the sine qua non of<br />
prayerful living. Yet the desire without acts and exercises of prayer<br />
becomes mere wishful thinking and reverie. Acts and exercises of<br />
prayer are absolutely necessary to acquire, feed, and renew the union<br />
of the prayer with God, so that the prayer eventually succeeds in<br />
discovering union with God in the very depths of his or her spirit”<br />
(pp. 398-99). For the author, a person develops the capacity “to pray<br />
without ceasing” by fostering an attitude of prayerfulness in a<br />
constant and persistent manner. Such an attitude is a gift from God,<br />
but comes about only by the continual repetition of one’s option to<br />
live in the awareness of God’s presence in one’s midst. This book<br />
provides the theological and experiential basis for understanding<br />
what such an attitude consists of and points the way to how it can be<br />
practically achieved in one’s life. For this reason alone, it is a<br />
welcome contribution to the current literature in the field. In this<br />
reviewer’s opinion, it is and will be an important scholarly point of<br />
reference for all future discussions of the topic.<br />
DENNIS J. BILLY, C. Ss.R.
492<br />
Kelly, Kevin T., From a Parish Base: Essays in Moral and Pastoral<br />
Theology. London: Darton, Longman and Todd, 1999, 226 p.<br />
In a recent editorial of Theological Studies 60 (1999), 207,<br />
Michael A. Fahey SJ provoked by saying: “Are theologians making<br />
themselves irrelevant because of ponderous and undistinguished<br />
writing? Yes… a disturbing number of theologians write as though<br />
dullness and mystification create an impression of importance… Too<br />
much theology appears as turgid prose lacking lilt and directness”.<br />
Kevin T. Kelly escapes this stricture. He writes with a direct clarity, a<br />
trait I fear may be a reason why many of his views are contested. You<br />
know where Kelly stands on an issue: not for him the qualifications<br />
of a myriad of contorted footnotes.<br />
Kelly’s latest book is a collage of essays written between 1985<br />
and 1996. There is however a thread uniting the 14 chapters of the<br />
four sections: moral theology as pastoral ministry. The basis of this<br />
ministry is the parish and is the substance of part one: the tension<br />
such a ministry gives rise to takes up part two. In part three the<br />
academic agenda of the cross-over between pastoral care and parish<br />
ministry is covered, while the last section takes up three topics of<br />
current interest: embryo research, the (undue) prolongation of life<br />
and the positive challenge of living in a time of AIDS. The disparity<br />
of topics should not distract the reader from a substantial continuity<br />
in Kelly’s methodology which is that of trying to make faith-sense of<br />
experience and experience-sense of faith (1) especially through the<br />
events of ordinary life (99). Kelly is a theological optimist arising, I<br />
suspect, from his deep sense that the Kingdom of God is breaking<br />
out in the most unexpected places, from the local parish of the<br />
deprived area of Eldon (Liverpool) to the universal parish of those<br />
affected, directly and indirectly, by AIDS.<br />
This gift of seeing what is good, under a Kingdom-perspective,<br />
takes on many particular guises in Kelly’s writing: a broad view of the<br />
deep-down sacramentality of life (31), a commitment to a<br />
collaborative Church where we do it better together (45, 55, 56), a<br />
sense of prayer rather than prayers (33), an inclusive Church where<br />
the learning and teaching distinction is not unduly strained (77). Not<br />
that Kelly is a simplistic radical, though he does rather like the idea<br />
of the foundations being shaken (113) if only to see the solid things<br />
that will survive the storm. He presumes the continued necessity for<br />
a parish structure (35) and he returns to a very traditional moral
493<br />
topic, sin, on with he has written with notable insight over the years<br />
(here, at Chapter 11). Kelly’s traditional concerns are, admittedly,<br />
tempered by a forward-gazing perspective, that of new forms of<br />
growth (172) in a Church which, while giving a due role to principles<br />
and norms, does not limit itself to these (154).<br />
In such a wide-ranging book, written with an eye to lucidity, it<br />
should not surprise that there are views propounded that, for me,<br />
could be more accurately phrased: women and priesthood (28),<br />
epikeia as a gap-virtue (70), general absolution (73), the absoluteness<br />
of norms (104), homosexuality (105), the dialectic between gospel<br />
and norms (108). I would have appreciated more refined distinctions<br />
on these type of questions. Kelly clearly has the ability to do so: his<br />
presentation of distinctions on prolonging life unduly or letting die<br />
(190 ff) is a model. I would appreciate if Kelly could bring this<br />
considerable skill, honed on a classic familiarity with the moral<br />
manuals of older days, to bear on the new questions.<br />
This need for precision is not an appeal for a return to pedantic<br />
casuistry. The importance of Kelly’s book is precisely in the fact that<br />
he is in the vanguard of those who are developing moral theology in<br />
a new (pastoral) setting (35). He is aware that he is breaking new<br />
ground, and gave up a prestigious lectureship in Heythrop College to<br />
do so: he gives the nine factors which he considers have changed<br />
moral theology in our time (116 ff) and he courageously outlines his<br />
credo for moral truth at 178. Kelly is neither agnostic nor relativist<br />
regarding such truth: he calls himself a realist (188). My concern is<br />
not with the context of Kelly’s moral theology. We have witnessed<br />
other historical contextual changes in our discipline (from monastic<br />
to scholastic through the seminary to the university setting), each of<br />
which had to make methodological adjustments precisely to preserve<br />
the theological integrity of the salvific truth of moral inquiry. The<br />
issue raised by Kelly’s book, arising from the context out of which he<br />
writes, is whether an aristotelian or a platonic conception of truth<br />
will prove adequate to the new pastoral setting. I suspect that Kelly<br />
would go for the former, as I too would: but that means a close<br />
examination of the nature of moral knowledge, a precision in the use<br />
of moral distinctions and a sharp sensitivity to the relationship<br />
between circumstances and principles (a topic Kelly does indeed<br />
touch on at 106). I accept that a book should be judged according to<br />
its literary genre, and Kelly’s book is not an attempt to give a full<br />
epistemology of his chosen discipline. But I believe that the issues he
494<br />
raises, and particularly the relative novelty of the context in which he<br />
believes moral theology should be practiced, are now ripe for the<br />
type of discussion I am hinting at. Without that further development<br />
Kelly’s book could be too easily dismissed as ephemeral good-will.<br />
What Kelly has done is broken silence on some topics. This is<br />
important if only for the reason that we cannot reach a consensus<br />
fidelium if we do not know what the fideles are saying, or if their<br />
saying of certain things is gone so underground as to be inaudible.<br />
This book is provocative, and one could react by saying that this or<br />
that view is poorly presented. While I have expressed my own<br />
reservations I would rather say: these are some of the important<br />
questions, let us hear them debated by the theological public so that<br />
we can develop a scientifically based, distinction-conscious<br />
theological ethics adequate to the emerging pastoral context Kelly is<br />
committed to. The alternative is too alarming to contemplate: highly<br />
skilled moral theologians conversing among themselves on the one<br />
hand, a hungry people without the courage or the opportunity to<br />
voice their views on the other.<br />
RAPHAEL GALLAGHER C.Ss.R.<br />
Mascia, Matteo e Pegoraro, Renzo (a cura di), Da Basileia a Graz.<br />
Il movimento ecumenico e la salvaguardia del creato. Padova:<br />
Fondazione Lanza e Euganea Editoriale Communicazioni, 1999,<br />
261 p.<br />
This volume is the second to be published in the Lanza<br />
Foundation’s project on the environment. It is part of a wider plan to<br />
make clear the principles and the hierarchy of values that people can<br />
recognise as underlying a coherent public and private morality today.<br />
The theme of the book is environment as a moral issue and so as<br />
something to which the community is to be educated so that it may<br />
have “peace with the Creator and peace with the whole creation” as<br />
the Pope proclaimed in his message for the 1990 World Day for<br />
Peace. The volume has an ecumenical intent which is seen as<br />
integrating concern for the environment into the Churches’<br />
programmes for justice and peace in the world.<br />
Antonio Autiero’s, “Esiste un’etica ambientale?” is the keynote<br />
essay since it registers the novelty of ecological issues for ethics and
495<br />
provides an introduction to the whole question, its history, the<br />
underlying philosophy and the conflict between use and<br />
conservation of nature and how to come to ethical decisions in this<br />
matter. Aldo Giordano, general secretary of the Council of European<br />
Bishops’ Conferences addresses the theme of the relationship of<br />
reconciliation and creation from Basel to Graz, that is as an<br />
ecumenical effort after the fall of the Berlin wall in 1989. M. Mascia,<br />
a Padua University expert on the defense of human rights, discusses<br />
what would be a sustainable level of development for this new<br />
Europe in view of globalisation. He sees the rights outlines in various<br />
international agreements as providing a basic strategy for securing<br />
economic advancement without damaging the environment. Luigi<br />
Mariani who is the assistant mayor of Padua lists a number of<br />
measures a local, city administration can take when it becomes<br />
sensitive to preserving the environment. G. Giuliucci illustrates how<br />
programmes in the schools are necessary not only to educate youth<br />
but the public in general to this sensitivity.<br />
The second part of the volume is dedicated to an ecumenical<br />
dialogue on the care of creation. This follows very closely the 1990<br />
Seoul World Council of Churches’ statement on the same subject.<br />
The Catholic, Protestant and Orthodox approaches are each<br />
represented by experts from these Churches. There are also papers<br />
on St. Francis and ecology and the description of a common<br />
ecumenical experience in this field. The third part is a detailed<br />
analysis by Karl Golser on the European Council of Churches’<br />
documents on the care of the environment, Graz 1997. He notes how<br />
they provide an inspiring theology and spirituality of creation that<br />
still needs to become practical. This will depend on how the local<br />
Churches receive these documents and put them into action. The<br />
fourth section is a useful collection of recent ecumenical statements<br />
on the environment with the addition of some relevant international<br />
statements on the same.<br />
This volume is the fruit,in part, of interdisciplinary study and so<br />
moves at many levels. In that sense it seems to offer something to<br />
everybody. Autiero helps to open our eyes not just to the ecological<br />
crisis the planet is undergoing but to how ethicists can come to grips<br />
with that challenge. This is a worthy theme in itself and could have<br />
been further expanded. Another theme the book helps us appreciate<br />
is ecumenism and how the Churches need to cooperate together on<br />
that issue. This in fact becomes the main thrust of the volume
496<br />
particularly with Golser’s analysis of the most recent policy<br />
statements by the Churches. These two themes are then linked to the<br />
civic concerns of city administrations and educational planning. We<br />
can conclude that the aim of the volume is to make the Churches and<br />
Christians in public life more aware of environmental ethics so as to<br />
apply it more effectively for the common good. The danger in such<br />
as effort as undertaken in this book is that its effort may easily<br />
become so dispersed that no issue is really studied in depth. As an<br />
attempt to bring various social and religious groups with an interest<br />
in ecology together it must be rated as a great success.<br />
Moral theologians will find particularly interesting and fruitful<br />
reflections for their discipline in the essays by Autiero and Golser.<br />
TERENCE KENNEDY, C.Ss.R.<br />
Moraglia, Francesco (a cura di), Dio Padre misericordioso. Genova:<br />
Casa Editrice Marietti, 1998, 388 p.<br />
Les membres de la faculté théologique de l’Italie septentrionale<br />
(section de Gênes) ont été bien inspirés en projetant, dans l’orbite de<br />
l’année préparatoire au grand Jubilé 2000 consacrée au Père, un livre<br />
sur la miséricorde divine. La réalisation du projet est digne<br />
d’attention. Envisageant le thème sous différents angles selon la<br />
compétence de chacun des intervenants, on est placé devant une<br />
véritable petite somme in materia. On y trouve en effet des réflexions<br />
relevant de l’exégèse (les deux Testaments) [S. Carbone; C. Doglio; R.<br />
Fornara], de la patrologie [G. Cavalli], de l’histoire de l’Église [P.<br />
Fontana], de la théologie fondamentale [L. Pedemonte], de la<br />
dogmatique [F. Moraglia], de l’ecclésiologie [G. Calabrese], de la<br />
théologie morale [A. Bellon; M. Doldi], du droit canonique [G.<br />
Marini] et, pour finir, de la philosophie de la religion [G. Noberasco].<br />
Comme c’est souvent le cas dans des ouvrages de ce genre, les<br />
interventions ne sont pas toutes d’égale valeur. En revanche toutes<br />
jouissent du minimum requis pour faire partie de l’entreprise. Bien<br />
des données pourraient être évoquées pour fonder ce jugement<br />
d’ensemble. Puisqu’un tel travail risquerait d’allonger une recension<br />
qui doit être brève, je me contenterai d’attirer l’attention sur trois<br />
contributions et dire rapidement ce que j’en pense.<br />
La première est une étude exégétique sur la parabole lucanienne
497<br />
de “l’enfant prodigue” (cf. Lc 15, 11-32) (p. 83-98). Ayant profité<br />
intelligemment des travaux de M. Gourgues sur cette péricope<br />
biblique, R. Fornara nous offre un texte à mon sens remarquable.<br />
Sans accabler son lecteur de notes techniques souvent impénétrables<br />
à qui n’est pas plongé dans la recherche exégétique au sens strict,<br />
l’auteur a su, tout en ne sacrifiant rien aux exigences de l’analyse<br />
littéraire du texte sacré, en faire émerger la richesse toujours<br />
étonnante et ainsi conférer à la Parole de Dieu sa beauté bonifiante<br />
qui attire et fait vivre. La contribution de C. Doglio sur le “Notre<br />
Père” présenté comme “la prière «pascale» du Fils” mérite d’être<br />
mentionnée pour son caractère suggestif et stimulant (p. 39-81).<br />
Dommage que la démonstration n’ait pas toujours été à la hauteur.<br />
C’est comme si l’auteur arrivait à des affaissements de terrain qu’il<br />
enjambe plutôt que de les combler (cf. par exemple, p. 67. 72. 75. 79).<br />
Cela a pour conséquence d’affaiblir une thèse pourtant fascinante et,<br />
à mon avis, plus que justifiable, comme l’auteur l’a du reste démontré<br />
en partie. Enfin, je voudrais fixer le regard sur la dernière<br />
contribution de ce volume collectif, celle de G. Noberasco (p. 357-<br />
388). Il y aurait beaucoup à redire sur ce texte. Je me contenterai de<br />
trois observations qui suffiront, je crois, à justifier mes réticences. 1)<br />
D’abord le titre de cette contribution relève de l’artifice. Je ne vois<br />
pas en effet comment l’auteur peut placer le contenu de ses réflexions<br />
sous l’expression “vérité comme paternité” (formule du reste déjà<br />
bizarre en elle-même!). Pour s’insérer après coup dans la thématique<br />
de l’ouvrage?… Heureusement que l’auteur se rachète un peu par un<br />
sous-titre plus conforme au contenu de l’exposé. 2) Je me demande<br />
aussi pourquoi l’auteur a eu recours à la théologie d’E. Jüngel pour<br />
surmonter les réserves de Vattimo et de Ruggenini touchant<br />
l’accessibilité de l’homme à la vérité. Le motif de ma question? Sans<br />
parler du fait qu’il y a des théologiens catholiques de grande stature<br />
qui auraient pu offrir des pistes de solution autrement plus<br />
pondérées au problème en distinguant par exemple, plus résolument<br />
que Jüngel toujours enclin à un certain hégélianisme, entre la Trinité<br />
immanente et la Trinité “économique”; sans parler du fait que la<br />
pensée de Jüngel est présentée en un premier temps comme si, en<br />
dépit de ses nombreuses apories, tout y était en parfait ordre, l’on<br />
voit notre auteur passer, pour ainsi dire, du blanc au noir. Point de<br />
référence d’abord, la pensée de Jüngel devient finalement pour lui<br />
inapte à résoudre le problème envisagé (cf. p. 385ss). Le moins que<br />
l’on puisse dire est que cette manière de faire est fort surprenante. 3)
498<br />
Au terme de son travail, l’auteur semble retrouver un plus grand<br />
équilibre en écrivant ce qui suit. Je traduis: “En réalité Jésus décide<br />
de s’en remettre inconditionnellement à son Père, reconnaissant en<br />
lui cette vérité qui n’élimine pas sa liberté, mais qui l’a fait être telle.<br />
Il choisit la volonté du Père comme principe de son agir. L’agir libre<br />
de Jésus se manifeste ainsi comme la révélation de la vérité de Dieu.<br />
D’autre part en Jésus la vérité de Dieu se montre définitivement<br />
impliquée dans l’historicité de la liberté” (p. 388). (C’est l’auteur qui<br />
souligne). Mais là encore une question se pose: quelle différence<br />
existe-t-il entre le comportement de Jésus et celui de tout bon<br />
chrétien? Pour être théologiquement plus exact et aussi plus probant,<br />
ne faudrait-il pas ajouter que Jésus est le Fils de Dieu en personne et<br />
que sa liberté humaine est, pour parler avec Maxime le Confesseur,<br />
animée et affermie dans le bien par sa liberté divine? Or, ici comme<br />
ailleurs, de cette identité proprement divine de Jésus de laquelle<br />
dépend en définitive l’instance de vérité attribuée à l’exercice de sa<br />
liberté dans l’histoire, il n’en est pas ou, en tout cas, pas clairement<br />
question … C’est incontestable. Si Noberasco se montre capable de<br />
penser avec vigueur, il ne brille pas par la rigueur.<br />
RÉAL TREMBLAY C.Ss.R.<br />
Müller, Denis, L’éthique protestante dans la crise de la modernité.<br />
Généalogie, critique, reconstruction. «Passages», Les Éditions du<br />
Cerf, Paris; Labor et Fides, Genève, 1999, 369 p.<br />
The link between Protestantism and modern capitalist culture,<br />
while certainly not as simple as has sometimes been suggested, is<br />
nonetheless of considerable importance, not least in the matter of<br />
ethics. Since postmodernity is in such large measure the wayward<br />
offspring of modernity, interesting questions arise about the link<br />
between Protestantism and what many are now calling postmodern<br />
culture (Müller prefers the adjective “metamodern”). In this<br />
substantial work, Denis Müller investigates these questions at some<br />
depth, both by spelling out the implications of postmodernity for<br />
theological ethics as a discipline and by defending the “plausabilité<br />
culturelle” (p. 21) of the protestant ethical tradition in the<br />
contemporary public forum. If protestant ethical thought can learn<br />
from the various levels of critique offered by postmodernism, and if
499<br />
postmodern culture can learn to appreciate the voice of christian<br />
ethicists, Müller is convinced that Protestantism and postmodernity<br />
can live at least as comfortably together as did (and do?)<br />
Protestantism and modernity. Whether or not one shares such<br />
optimism, the theme is certainly topical and provocative.<br />
This brief review will offer an evaluation of Müller’s work from<br />
an historical, a thematic and a methodological point of view.<br />
In historical terms, this is a most useful and interesting study.<br />
The work makes no pretence at being a formal historical inquiry of<br />
the kind that employs the methods of academic historiography.<br />
Nonetheless it is packed with solid historical information and<br />
generous bibliographical references in the meticulous notes. Most of<br />
Müller’s sources are secondary and contemporary, giving the work at<br />
times an almost encyclopaedic quality, but this is a necessary<br />
limitation given the range of material he attempts to cover. In a word,<br />
the book is an excellent panoramic presentation of the protestant<br />
ethical tradition and will be read with profit by anyone who feels the<br />
need to know, understand and appreciate this tradition in a more<br />
adequate way.<br />
In thematic terms, the work has also much to recommend it.<br />
One could perhaps usefully distinguish between themes inherent to<br />
the protestant ethical tradition (liberty, autonomy, Sacred Scripture,<br />
responsibility etc.), and themes which derive from Müller’s reading<br />
of contemporary culture in sociological, philosophical and<br />
theological terms. As regards the former, these are treated in a<br />
balanced and readable manner, using the method selected by the<br />
author (see below). This generally involves a clear and critical<br />
account of a given author’s position and an evaluation of the<br />
contribution of this author to the broader tradition. Thus Müller<br />
could be described as presenting a useful synthesis of the thought of<br />
many key authors on certain important themes and weaving these<br />
accounts into a narrative upon which he offers critical reflection.<br />
This critical reflection is based on the other set of themes, those<br />
which Müller derives from contemporary thought. Of particular<br />
interest on this score is the author’s noticeable sensibility toward the<br />
social context in which theology is done. While openly<br />
acknowledging the degree to which he borrows from David Tracey on<br />
this score, Müller is nonetheless most interesting on the need to<br />
attend to the “publics” to which theological discourse is addressed.<br />
He illustrates his case effectively in an insightful review of recent
500<br />
touchstone bioethical debates. As regards the major themes of<br />
postmodernity itself, Müller is always interesting and is certainly not<br />
uncritical, but he does seem to take a great deal for granted which<br />
some of us would consider very much in need of demonstration. One<br />
example is the rather cavalier fashion in which the very idea of<br />
foundations and universals is dismissed, as if nobody today could be<br />
so primitive as still to entertain such quaint notions.<br />
In methodological terms, the work is impressive and plausible,<br />
but by no means invulnerable to criticism. The key to understanding<br />
Müller’s method is the subtitle: Généalogie, critique, reconstruction.<br />
We are dealing here with a method which has been developed in<br />
critical reflection on postmodemist thinkers, most obviously<br />
Foucault. The “theoretical model” out of which Müller operates<br />
involves tracing the origins and evolution of the great themes of<br />
protestant ethics in the texts of authors such as Barth, Bonhoeffer,<br />
Tillich and Troeltsch. These are reconstructed in the light of<br />
contemporary culture through critical dialogue with such authors as<br />
Ricoeur, Derrida, Hauerwas, Tracey, Milbank and Bauman. Apart<br />
from the sheer erudition in evidence, one has to admire the<br />
intellectual honesty with which Müller revisits the “fathers” of his<br />
tradition and rereads them in the light of contemporary insights. If<br />
he is to be faulted it could be in terms of a tendency to reject highly<br />
sophisticated ethical and theological theories (I am thinking mainly<br />
of the thought of Alasdair MacIntrye and John Milbank) on the basis<br />
of a rather trite presentation of same, which is then rebuffed with a<br />
line of critique which does not do justice to the sophistication of the<br />
original theory. A similar line of criticism could perhaps be levelled<br />
at Müller’ s approach to Catholicism in general and Veritatis Splendor<br />
in particular, which at times comes close to being dismissive.<br />
One final pernickety comment on the composition of this work.<br />
A genealogical investigation would reveal that it has its origins in a<br />
list of articles on various themes, listed on p. 23. While Müller has no<br />
doubt considerably reworked this material and has managed to<br />
produce a new, coherent and wellargued study, one cannot but notice<br />
at times a certain staccato effect resulting from the fusing of<br />
heterogenous materials. In a metamodern world where pastiche has<br />
almost become the norm, this is a very minor flaw in a fine book.<br />
MARTIN MCKEEVER C.Ss.R.
501<br />
Pacia, Olindo, Giulio Nicolò Torno. Un teologo e giurista del<br />
Settecento Napoletano. Napoli: Liguori Editore 1999, 265 p.<br />
Lo studio della figura e dell’opera di Giulio Nicolò Torni (1672-<br />
1756) costituisce un importante tassello per la comprensione della<br />
storia culturale, religiosa e teologica del Settecento napoletano.<br />
«Ebbe la fortuna, nota Raffaele Ajello nella prefazione, di vivere nei<br />
decenni più produttivi della cultura napoletana, e d’impersonare una<br />
funzione critica di primario risalto in quella società politicoletteraria.<br />
Infatti a Napoli poté entrare in rapporto diretto con<br />
quattro tra gli uomini di pensiero che meglio hanno illustrato, da<br />
posizioni diversissime, il pensiero dell’intero Settecento italiano: due<br />
laici, Vico e Giannone, due ecclesiastici, Alfonso Maria de Liguori e<br />
Genovesi. Il primo e il terzo furono rispetto agli altri due su fronti<br />
per molti aspetti antitetici. Di Vico e Giannone Torno fu<br />
contemporaneo e delle loro opere censore rigoroso. Gli altri due, nati<br />
una generazione più tardi, subirono più o meno direttamente<br />
l’influenza del Teologo, tanto che il futuro Santo lo considerò suo<br />
maestro» (p. IX).<br />
La ricostruzione storica che il Pacia traccia è attenta e<br />
dettagliata. Viene delineato innanzitutto un quadro biografico, che fa<br />
emergere il ruolo di primo piano giocato dal Torno nelle complesse<br />
vicende ecclesiali e socio-religiose della prima metà del Settecento<br />
(cap. 1). Vengono poi esaminati più dettagliatamente i rapporti con<br />
S. Alfonso, Vico e Genovesi (cap. 2). I restanti capitoli analizzano i<br />
principali scritti del Torno, preoccupandosi di stabilirne innanzitutto<br />
la paternità: i Commentari di Estio (cap. 3); lo scritto<br />
antigiannoniano con le complesse vicende in cui si inserisce (cap. 4);<br />
le Allegazioni in difesa della Certosa di San Martino (cap. 5). Notevole<br />
è l’appendice documentaria (p. 209-247), seguita dalla bibliografia e<br />
l’indice dei nomi.<br />
La documentazione archivistica, raccolta con paziente e lunga<br />
ricerca, permette all’autore di filtrare correttamente i riferimenti al<br />
Torno presenti negli studi dedicati alle personalità con le quali ha<br />
incrociato il suo cammino. La discussione delle diverse<br />
interpretazioni è fatta in maniera serena e costruttiva.<br />
La figura del Torno emerge così con chiarezza: come studioso e<br />
docente di teologia, radicato sinceramente nel tomismo, e come<br />
protagonista delle vicende pastorali e politico-religiose del suo<br />
tempo. Nella prospettiva della teologia morale, mi sembra meriti di
502<br />
essere sottolineato il carattere pratico e benigno delle soluzioni da lui<br />
proposte: «È legittimo ritenere che Torno, guidato dal suo<br />
temperamento equilibrato e dall’esperienza del ministero<br />
sacerdotale, formulava con sufficiente elasticità le sue soluzioni per<br />
centrarle nel giusto mezzo, scegliendo l’aurea mediocritas tra i due<br />
estremi del rigorismo e del lassismo. Non fa meraviglia perciò che<br />
Alfonso abbia potuto offrirci la sua preziosa testimonianza secondo<br />
la quale il suo illustre e dotto “maestro” è annoverato tra i “molti<br />
uomini di grande saggezza e probità che condividevano la dottrina<br />
benigna”» (p. 93).<br />
S. MAJORANO C.Ss.R.<br />
Palumbieri, Sabino, Amo dunque sono. Presupposti antropologici<br />
della civiltà dell’amore. Milano: Paoline Editoriale Libri 1999,<br />
261 p. (Cammini dello Spirito – Spiritualità 19).<br />
Con questo nuovo saggio, don Sabino Palumbieri aggiunge un<br />
ulteriore tassello alla sua proposta antropologica che, proiettando la<br />
luce del vangelo sul travaglio culturale contemporaneo, tende a<br />
mettere in evidenza concrete possibilità di speranza. Questa nota di<br />
positività, realisticamente radicata, è la nota caratteristica del libro.<br />
Viene dallo stesso autore precisata nell’introduzione: «La presente<br />
trattazione non intende essere pelagiana o romantica, ottimista ad<br />
oltranza cioè sulla natura umana capace d’amare... Si vuol soltanto<br />
affermare qui che la difficoltà dell’amore come cammino non<br />
connota l’impossibilità. L’essere umano ha già la struttura d’essere di<br />
tipo agapico. Solo che, per farla funzionare in pienezza e<br />
perseveranza, occorre la forza d’amore dall’alto» (p. 25).<br />
La struttura agapica dell’essere umano costituisce il punto focale<br />
del libro. Con ricchezza di dati filosofici e teologici, utilizzando la<br />
metodologia fenomenologica, viene delineato un cammino che porta<br />
a coglierne il significato e le conseguenti responsabilità: «l’amore,<br />
prima che virtù, è struttura dell’essere. Anzi, è virtù in quanto<br />
comporta fedeltà alla struttura dell’essere. L’essere umano è attitudine,<br />
oltre che intellettiva e volitiva, anche agapica. La definizione classica<br />
di animal rationale non è sufficiente. L’uomo è anzitutto animal<br />
amans. E l’amore assume intelletto e volontà» (p. 26).<br />
Su queste premesse, il capitolo primo si preoccupa innanzitutto
503<br />
di approfondire il sentimento «come struttura metafisica della<br />
persona», secondo «l’impostazione rosminiana e ricoeuriana» (p.<br />
30). Ne vengono evidenziati i caratteri fondamentali con cui «nel suo<br />
indefinito dispiegarsi, si presenta nella coscienza: profondità,<br />
vibratilità, unicità, comunicabilità, polarità, dinamicità, tensionalità.<br />
Tutto ciò con la costante della stabilità» (p. 42).<br />
L’aver meglio compreso il sentimento come dimensione<br />
fondamentale dell’io, permette una più attenta precisazione<br />
dell’interiorità umana, cogliendone il «centro» nel cuore (cap. II): «si<br />
può affermare che c’è un sistema del sentire che ha un suo centro<br />
vitale chiamato il cuore. Tale sistema ha come base la percezione del<br />
proprio essere o sentirsi essere in dinamismo verso la pienezza: con<br />
le variabili di calibro esistenziale della gioia, noia, nausea, gusto,<br />
angoscia, speranza, attrazione, repulsione, fiducia, timore. Questi<br />
sentimenti di fondo, prodotti dal centro vitale, costituiscono la<br />
struttura portante della gamma infinita dei sentimenti del<br />
quotidiano. Sono, altresì, il punto di sintesi del pluridimensionale<br />
interiore» (p. 58-59).<br />
Il terzo capitolo può così mettere in risalto la fondamentalità e<br />
la universalità dell’amore, capace, in quanto originale struttura<br />
dell’essere, di dare significato e soggettività autentica: «Amare<br />
significa accettare l’altro come soggetto e operare costantemente alla<br />
sua crescita soggettuale. Non è un moto centripeto, inteso come<br />
attirare l’altro a sé facendolo rimanere nella propria area, ma<br />
piuttosto un moto ek-statico, come entrare cioè nell’area dell’altro e<br />
collaborare con lui alla sua autonoma costruzione. Tutta<br />
l’operazione così articolata non può verificarsi nella sfera dell’avere,<br />
ma è solo possibile in quella dell’essere: far essere di più e così<br />
diventare di più: la mia capacità di promuovere l’altro come soggetto<br />
ricade sul potenziamento di me come soggetto» (p. 86).<br />
Solo alla luce del suo fondamentale valore ontologico è possibile<br />
leggere correttamente i «caratteri di base» dell’amore (cap. IV), che<br />
vengono dall’autore individuati nella sensibilità, specificità<br />
affettività, arazionalità, cognitività, volontarietà, interpersonalità,<br />
ambiguità, conflittualità.<br />
Si passa poi a delineare lo «spazio di investimento» dell’amore<br />
(cap. V), fermandosi sugli orizzonti e sulle prospettive più decisive<br />
(globalità, totalitarietà, singolarità, diversità, esteticità, estaticità,<br />
attrattività, lucidità). Sempre però alla luce del «nucleo ontologico»,<br />
che si esprime come sacrificalità, allocentricità, oblatività,
504<br />
recettività, fecondità, comunionalità (cap. VI), e delle conseguenti<br />
«modalità essenziali» di povertà, gratuità, realisticità, dialogicità,<br />
educatività, rispettosità, adattabilità (cap. VII).<br />
È così possibile che l’amore determini una feconda «dialetticità<br />
esistenziale», in cui s’intrecciano specularità, reciprocità e<br />
unipluralità (cap. VIII), dagli «orizzonti sempre aperti» nelle<br />
prospettive di universalità, prassicità, politicità, fedeltà, definitività,<br />
religiosità, incommensurabilità (cap. IX).<br />
Il cap. X («condizioni e puntualizzazioni») può perciò<br />
evidenziare il clima e le condizioni psicoetiche dell’amore, prima di<br />
enuclearne sinteticamente i caratteri, alla luce anche del Cantico dei<br />
Cantici, e riaffermarne la possibilità, in quanto radicato sull’essere e<br />
fonte di autentico umanesimo.<br />
I passi precedentemente compiuti sfociano nell’affermazione<br />
convinta della circolarità e reciprocità tra amore e spiritualità.<br />
L’ultimo capitolo («Dall’amore come struttura alla spiritualità come<br />
amore») insiste infatti sulla necessità di leggere la ricchezza<br />
antropologica dell’amore in prospettiva spirituale e, allo stesso<br />
tempo, di comprendere la spiritualità alla luce dell’amore. Di qui la<br />
conclusione di taglio pedagogico: «L’amore è tutto. Pertanto, tutto va<br />
fatto nell’amore. E il cuore ne è il centro. Ora, se la spiritualità è la<br />
più alta delle forme dell’educazione permanente, si approda qui al<br />
codice metodologico della civiltà dell’amore: il cuore dell’educazione<br />
è l’educazione del cuore» (p. 249).<br />
Questi rapidi cenni danno solo un’idea sommaria della ricchezza<br />
del volume, corredato anche da una bibliografia selezionata e da un<br />
indice onomastico. L’ampia documentazione filosofica e teologica e<br />
il carattere rigoroso delle riflessioni si sintetizzano felicemente con<br />
la partecipazione profonda con cui l’autore scrive, anche se a volte il<br />
linguaggio rischia di farsi troppo evocativo se non addirittura un po’<br />
ermetico. Il lettore resta così personalmente coinvolto dalla<br />
proposta: non solo sulla possibilità della civiltà dell’amore, ma anche<br />
sulle responsabilità che la sua realizzazione invita ad assumere con<br />
coraggio e fiducia.<br />
S. MAJORANO C.Ss.R.
505<br />
Piva, Pompeo, L’evento della salvezza fondamento dell’etica<br />
ecumenica, Padova: Edizioni Messaggero, 1997, 295 p. (Coll. a<br />
cura dell’Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino”, Facoltà<br />
Teologica dell’Antonianum, Venezia).<br />
Pompeo Piva, profesor de Moral en el Seminario diocesano de<br />
Mantova y en el Istituto di Studi Ecumenici “S. Bernardino” di<br />
Venezia, nos ofrece una síntesis de lo que, según él, constituye la<br />
base común a cualquier reflexión ética cristiana. En una época,<br />
como la nuestra, dominada por un creciente relativismo, se impone<br />
la necesidad de repensar las bases sobre las que se pueda apoyar<br />
sólidamente la estructura de una ética cristiana. El autor encuadra<br />
su estudio en una perspectiva ecuménica, lo que le mueve a recurrir<br />
a las fuentes del N.T. como clave de interpretación del sujeto moral<br />
y de las normas por las que éste debe regir su conducta. Fuentes<br />
complementarias de su estudio son la reflexión de los teólogos y los<br />
documentos de carácter ecuménico elaborados por las iglesias<br />
cristianas en los últimos decenios.<br />
Esta triplicidad de fuentes le ofrece la pauta para estructurar su<br />
análisis en tres partes: a) dato bíblico (cc. I-II); b) aportación de los<br />
teólogos (c. III); c) aportación de los documentos ecuménicos (c. IV).<br />
Al final el autor trata de elaborar una síntesis con los resultados<br />
obtenidos, perfilando lo que él llama un “posible estatuto<br />
metodológico de la ética ecuménica” (c. V).<br />
No podemos menos de contemplar con satisfacción el esfuerzo<br />
teológico realizado por el Prof. Piva. Es evidente que, como biblistas,<br />
hubiéramos deseado un estudio más riguroso de los datos de la Sda<br />
Escritura, particularmente de la doctrina paulina; a pesar de todo,<br />
consideramos un hecho importante el que los moralistas<br />
sistemáticos hayan percibido la necesidad de recurrir al dato bíblico<br />
cuando se trata de establecer las bases del quehacer ético cristiano.<br />
La tesis defendida por el autor es que la base de toda ética<br />
cristiana ha de colocarse en lo que él llama “il fatto previo”,<br />
entendido como “l’autocomunicazione di Dio per mezzo di Cristo<br />
nella persona dello Spirito Santo, per cui ogni uomo è creatura<br />
nuova in Cristo”. Lógicamente, la vía ética del cristiano no será otra<br />
que Jesucristo “che nella potenza dello Spirito Santo illumina e<br />
vivifica il singolo e la comunità credenti, li inizia alla vita nascosta in<br />
Dio, li guida alla pienezza della verità negli atteggiamenti di ogni<br />
giorno” (87).
506<br />
El “hecho previo” viene dado en los evangelios en términos de<br />
“anuncio” de lo que Cristo ha dicho y ha hecho para la salvación del<br />
hombre. El “anuncio” es complementado por la fe, dando como<br />
resultado la “nueva criatura” y la nueva vida. El autor toma como<br />
lema dos frases joánnicas que le sirven para encabezar sendos<br />
capítulos: “quien posee al Hijo posee la vida eterna (1 Jn 5,12) y<br />
“quien cree que Jesús es el Cristo, ése ha nacido de Dios” (1 Jn 5,1).<br />
En términos paulinos, el “hecho previo” sería la muerte-resurreción<br />
de Cristo y nuestra integración en ese misterio a través de la fe y del<br />
bautismo. Este “anuncio” estaría en la base de todos los imperativos<br />
y exhortaciones. Según el autor, no existiría primariamente una ética<br />
sino un “hecho”. No hay que partir, pues, de “un deber” a priori de<br />
cuño kantiano, ni de la promulgación de una ley sino de un “hecho”<br />
que genera un deber y avala la necesidad de unas leyes.<br />
Desde este presupuesto de base el Prof. Piva pasa revista a las<br />
opiniones de algunos teólogos más importantes de los campos<br />
católico y protestante, tomando en consideración particularmente la<br />
relación ley-gracia-justificación. Hace especial hincapié en el<br />
concepto de “ley nueva” formulado por Sto Tomás (149ss) y en las<br />
diversas funciones y “usos de la ley, propuestos por los reformadores<br />
(Lutero, Melancton etc., 162ss).<br />
Entre los autores protestantes contemporáneos presta una<br />
atención particular a la ética teológica de K. Barth con su conocida<br />
teoría de la “ley como forma del evangelio” (175ss) y al discurso<br />
epistemológico de W. Pannenberg que coloca “prolépticamente” la<br />
ética teológica en el horizonte de la resurrección (188ss). No falta<br />
una referencia especial al gran teólogo católico K. Rahner que desde<br />
la dogmática ofrece elementos metodológicos interesantes para el<br />
discurso ético (184ss).<br />
Al pasar revista al material propiamente ecuménico tal como<br />
aparece en los numerosos documentos elaborados conjuntamente<br />
por las diversas iglesias cristianas (193ss), el autor se siente forzado<br />
a hacer una selección, centrando su atención en los documentos que<br />
abordan explícitamente el problema ético, como Choix éthiques et<br />
communion ecclésiale (1992) y Life in Christ (1993). Desde el punto<br />
de vista de la fundamentación teológica el a. concede especial<br />
atención al Documento de Lima: Bautismo, eucaristía y ministerio<br />
(1982), al Documento de Basilea: Paz y justicia y al Documento<br />
Iglesia y Justificación. La comprensión de la Iglesia a la luz de la<br />
doctrina sobre la justificación.
507<br />
En el análisis de estos documentos, el autor suele tomar en<br />
consideración el método, los contenidos fundamentales y la<br />
valoración personal de los mismos partiendo de su tesis sobre la<br />
fundamentación de la ética en el “hecho previo”.<br />
Al final de sus análisis el autor cree llegado el momento de<br />
formular un “posible estatuto metodológico de la ética ecuménica”<br />
(239ss), que permita responder a la pregunta ¿cómo es posible<br />
identificar un fundamento crítico para una legitimación teológica<br />
del juicio moral en perspectiva ecuménica? La respuesta estará en la<br />
“decifrazione” de la autoconciencia del creyente, entendida como<br />
“matriz genética normativa del obrar moral” (239). Sin pretender<br />
negar lo Absoluto (que entraría siempre como parte integrante del<br />
horizonte hermenéutico), el a. pone en el centro la dimensión<br />
histórica del sujeto ético y, en definitiva, su condición de persona: “la<br />
persona umana e quindi la persona cristiana, dev’essere considerata<br />
fondazione adeguata della norma e sua condizione ermeneutica”<br />
(240). De la persona brotan los actos y hacia ella convergen como<br />
horizonte hermenéutico unificador (241). En este contexto, la<br />
“norma” representa la “objetivación en términos racionales de actos<br />
intencionales referidos al sentido de la vida” (242). Esta referencia<br />
esencial a la vida y, en definitiva, a la persona, impide que la norma<br />
pueda fundarse exclusivamente sea en el ámbito de la pura situación<br />
sea en la sola referencia a normas universales, quedando así<br />
salvaguardadas tanto la objetividad como la subjetividad del<br />
quehacer moral y del proceso hermenéutico. En el contexto de la<br />
persona se puede identificar, en efecto, la presencia objetiva del<br />
“hecho previo”, entendido como participación en la vida de Cristo y<br />
como dinamismo subjetivo que se proyecta imperativamente hacia la<br />
acción: “dal cuore nuovo, creato dallo Spirito Santo, nascono le<br />
esigenze spirituali, oggettive, obbliganti...” (247). La persona, como<br />
centro unificante de las vivencias y, por tanto, de la vivencia<br />
constitutiva del ser cristiano es, por esta razón, fundamento y<br />
criterio hermenéutico de toda norma.<br />
Al tratar de valorar la obra del Prof. P. Piva tenemos que<br />
comenzar reconociendo el no pequeño mérito de haber reunido y<br />
dado forma orgánica a un abundante material que normalmente es<br />
posible encontrar sólo en forma dispersa. El recurso a este variado<br />
material venía exigido por la pluralidad temática del argumento<br />
tratado. Tenemos que reconocer, en líneas generales, que el autor ha<br />
logrado su cometido. Las observaciones que se pueden hacer nacen
508<br />
fundamentalmente de la imposibilidad de tratar con profundidad<br />
científica todos y cada uno de los temas tocados. Nos referiremos<br />
solamente a algunos de ellos.<br />
Al hablar del método (10ss) el a. da la impresión de poner en un<br />
plano de igualdad o de identidad método y discurso hermenéutico.<br />
Los métodos científicos con que se puede abordar el estudio de la<br />
Biblia no prejuzgan la posición hermenéutica que se pueda adoptar,<br />
aunque tengamos que admitir, con P. Ricoeur, que la elección del<br />
método no es ajena a la misma. Método y hermenéutica (al menos en<br />
el sentido moderno del término) son cosas distintas. Si el autor<br />
quiere entender la “hermenéutica” en el sentido clásico debiera<br />
indicarlo explícitamente. En todo caso, los problemas metodológicos<br />
que el autor “considera necesario tocar” (10) como cuestión previa al<br />
estudio del dato bíblico no son suficientemente tratados.<br />
En la presentación del dato bíblico procede “sistemáticamente”,<br />
como lo indican los dos epígrafes bajo los que coloca los primeros<br />
capítulos (“El que posée al Hijo posée la vida” y “el que cree que<br />
Jesús es el Cristo ha nacido de Dios”). Con ello resulta muy difícil un<br />
estudio de carácter analítico rigurosamente científico, que tenga en<br />
cuenta la evolución y características propias que cada tema ha tenido<br />
en las diversas épocas y en los diversos autores del N.T. Todo esto<br />
resulta aun más llamativo cuando el proceso “homologador” se<br />
extiende a los textos del A.T. que el a. va entremezclando demasiado<br />
fácilmente con los del N.T. En particular, consideramos bastante<br />
deficiente el estudio de la doctrina paulina, que tantos elementos<br />
ofrece precisamente para iluminar lo que el autor presenta como<br />
punto central de su argumentación: la fundamentación del<br />
imperativo en el indicativo (“fatto previo”). Una mayor<br />
profundización en el pensamiento paulino hubiera ayudado también<br />
a una mejor comprensión de ciertos temas, como la naturaleza del<br />
“pecado” o la función de la ley. Cuando Pablo, por ejemplo, se<br />
expresa en términos de “hê hamartía” se refiere a algo mucho más<br />
profundo de las meras acciones personales (132) y más activo que el<br />
“pecado-situación” (133).<br />
Son muchos los puntos en los que se podrían introducir<br />
precisaciones importantes, pero creemos que el insistir sobre este<br />
aspecto no haría justicia a la obra, que se presenta como un intento<br />
de abrir pistas para una reflexión convergente entre las diversas<br />
iglesias cristianas en materia ética. Esta convergencia sólo será<br />
posible apuntando a la base del proyecto ético cristiano. Localizar
509<br />
esta “base” imponía un esfuerzo de aproximación al mensaje<br />
cristiano originario y, más en concreto, a los textos del N.T. El autor<br />
ha emprendido esta no fácil tarea, consciente de la dificultad que ello<br />
supone para un moralista sistemático. Ello representa sin duda un<br />
mérito y un ejemplo no sólo a nivel ecuménico sino a nivel<br />
simplemente teológico-moral. La moral cristiana tiene todavía<br />
abierto el problema de la identificación del propio estatuto<br />
científico, que comporta necesariamente un retorno decidido a las<br />
fuentes. Desde este punto de vista la obra del Prof. Piva constituye<br />
sin duda una valiosa aportación.<br />
LORENZO ALVAREZ C.Ss.R.<br />
Privitera, Salvatore, La questione bioetica. Nodi problematici e<br />
spunti risolutivi, Acireale: Istituto Siciliano di Bioetica 1999,<br />
160 p. (Conchiglie n.1)<br />
David, Vincenzo, La tutela giuridica dell’embrione umano. Legislazione<br />
italiana ed europea, Acireale: Istituto Siciliano di Bioetica<br />
1999, 144 p. (Conchiglie n.2)<br />
L’Istituto Siciliano di Bioetica ha incominciato la publicazione<br />
della nuova collana di libri consecrata alla riflessione bioetica<br />
intitolata Conchiglie. Questa serie apre il volume La questione<br />
bioetica. Nodi problematici e spunti risolutivi di S.Privitera, preside e<br />
professore di quest’Istituto. L’Autore ha cercato - in primo luogo - di<br />
evidenziare alcuni nodi del dibattito bioetico del punto di vista<br />
scientifico (di natura logica, etico-linguistica, metaetica, normativa)<br />
e culturale (rapporto tra bioetica laica e religiosa, bioetica<br />
nordamericana e europea, la bioetica mediterranea). Poi Privitera ha<br />
tentato di presentare La vita come mistero nelle culture<br />
mediterranee, quella vita che sta alla base di tutti gli altri valori e<br />
rappresenta “quella perla che costituisce l’oggetto principale<br />
dell’interesse della bioetica che, come conchiglia, la custodisce,<br />
protegge e difende, promuovendone per tutti ed in ogni sua fase una<br />
sempre migliore dimensione qualitativa” (p.55). Dopo questa poetica<br />
definizione del ruolo della bioetica possiamo capire meglio il senso<br />
del titolo di questa collana.<br />
Per S.Privitera la bioetica “si è autopresentata come scienza<br />
della sopravvivenza della specie umana, della vita in genere”, dove in
510<br />
gioco c’è anzitutto la vita dell’uomo, perché “l’etica non fa<br />
antropologia, ma si fonda sull’antropologia”. L’Uomo nella<br />
prospettiva filosofico-etica e biblico-teologica si presenta come la<br />
base, il centro ed il fine della riflessione bioetica secondo Privitera.<br />
Ma è un peccato che l’autore in detta ottica abbia trattato soltanto<br />
due problemi strettamente bioetici, quelli della genetica e della pena<br />
di morte.<br />
La tutela giuridica dell’embrione umano. Legislazione italiana ed<br />
europea è il secondo volume della stessa collana. L’Autore, Vincenzo<br />
David, avvocato specializzato in Diritto delle regioni e degli enti<br />
locali presso l’Università degli Studi di Palermo e in Bioetica presso<br />
l’Università Cattolica del S.Cuore di Roma, tratta il tema dello<br />
statuto giuridico dell’embrione umano, “nei confronti di quel<br />
soggetto debole che non ha una capacità comunicativa verbale e di<br />
autonomia” (Introduzione). V.David, cosciente che lo statuto<br />
giuridico dell’embrione umano è fondamentale nel dibattito in<br />
bioetica, ha cominciato la sua riflessione giuridica dalla<br />
presentazione del rapporto tra la legge morale secondo la dottrina<br />
ufficiale della Chiesa e la legge civile attraverso le dichiarazioni<br />
internazionali, i documenti del Consiglio d’Europa e del Parlamento<br />
europeo e l’esperienza legislativa in Italia. Secondo la legge morale<br />
l’embrione umano è l’essere umano e il soggetto titolare di diritti<br />
umani. Ma nella società multietica, dove il relativismo etico è una<br />
condizione della democrazia, avanza troppo rapido il processo di<br />
separazione fra la legge morale e la legge civile, che ha portato il<br />
riconoscimento del diritto di aborto e della fecondazione artificiale<br />
assistita, che ledono il complesso dei diritti dell’embrione umano.<br />
Questa situazione è molto pericolosa non soltanto per la vera salute<br />
della società, ma soprattutto per la coscienza dell’uomo. “Se una<br />
legge civile non tutela un bene essenziale alla convivenza, come il<br />
diritto fondamentale alla vita, elemento costitutivo del bene comune,<br />
la legge non è legge, deve essere modificata e può essere oggetto di<br />
obiezione di conscienza” (p.16). Nonostante la presenza di varie<br />
forme di attentato alla vita umana nascente e l’assenza di un serio<br />
intervento legislativo – secondo V.David – appaiono all’orizzonte<br />
segni di speranza: movimenti spontanei di forze sociali e politiche in<br />
varie parti del mondo chiedono la rivisione delle leggi permissive che<br />
ledono i diritti dell’embrione, il legislatore italiano assuma un ruolo<br />
attivo e di promozione della vita del concepito (per il 64% degli<br />
italiani l’embrione è un essere umano).
511<br />
Due volume scritti nel linguaggio contemporaneo, vivace e ben<br />
ordinato del punto di vista epistemologico-metodologico, che<br />
esprimono i valori da mantenere e perfezionare nella nostra<br />
moderna, un po’ ammalata società; che deve intendere che il rispetto<br />
della vita e dei diritti della singola persona, anche pre-natale sta<br />
nell’assumersi la responsabilità della sua tutela, in quanto bene<br />
comune e patrimonio di tutta l’umanità.<br />
EDMUND KOWALSKI, C.Ss.R.<br />
Privitera S., Vecchio G., (a cura di), La notizia a confronto con<br />
l’etica, Acireale: Facoltà Teologica di Sicilia, Istituto Siciliano di<br />
Bioetica 1999, 128 p. (Etica e Società n.1)<br />
Nessuna disciplina umana è fuori dal campo della morale,<br />
perché tocca, riguarda e concerne direttamente o indirettamente la<br />
persona umana. Una notizia quotidiana che noi leggiamo ogni<br />
giorno sul nostro giornale preferito è scritta da una persona per<br />
un’altra persona. Noi, lettori, esigiamo che essa sia soprattutto vera<br />
ed obbiettiva. Ma non tutti i giornalisti rispettano o stimano i<br />
suddetti criteri del giornalismo. Alcuni giornalisti utilizzano i diversi<br />
metodi (vedi per esempio i famosi “paparazzi”) per scoprire o per<br />
colorare un fatto e di conseguenza riempire una colonna con lo<br />
scoop, con ambizioni esclusivamente scandalistiche o<br />
senzazionalistiche, al solo scopo di autopubblicizzarsi e di<br />
aumentare il numero dei lettori del loro giornale. Ma ci sono “i<br />
giornalisti cattolici e no”, che vogliono vivere coerenetemente ed<br />
eticamente la loro professione (Indroduzione di G.Vecchio). Per i<br />
giornalisti per cui non bastano le varie Carte dei doveri ed i Codici<br />
deontologici l’UCSI Sicilia ha organizzato - in collaborazione con<br />
l’Istituto Siciliano di Bioetica - il primo seminario di etica<br />
professionale per giornalisti nel quadro dei “Seminari di etica<br />
professionale”. Il volume presentato e commentato è il frutto di<br />
questo primo seminario, visto come “l’inizio di una serie di incontri<br />
finalizzati alla sensibilizzazione di una coscienza etica nel contesto<br />
della vita professionale contemporanea” (Introduzione).<br />
“La notizia a confronto con l’etica” è l’insieme degli interventi di<br />
due gruppi dei professionisti: giornalisti (M.Petrina, Presidente<br />
dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, N.Barraco, A.Fisichella,
512<br />
A.Ruggieri, G.Zizola) e moralisti (S.Leone, S.Privitera). I giornalisti<br />
coscienti di dover essere non soltanto informatori, ma soprattutto<br />
formatori dell’opinione e della coscienza in Italia (Barraco, Ruggieri,<br />
Zizola) – è un peccato che ciò sia limitato soltanto al paese di Virgilio<br />
e di Dante – chiedono ai moralisti di presentare il punto di vista<br />
dell’etica cristiana su tanti problemi con cui quotidianamente loro<br />
hanno da confrontarsi (adesso problemi di biomedicina e di<br />
bioetica). Le risposte dei moralisti presenti sono state adeguate agli<br />
interrogativi. S.Leone (“Medicina e Bioetica nei mass media”)<br />
parlando del giornalismo medico ha ricordato “le linee-guida di una<br />
corretta informazione medica” del Comité Consultatif National<br />
d’Ethique della Francia (!). Secondo S.Privitera (“Per una ‘notizia’<br />
dell’etica e della bioetica: il ruolo ‘maieutico’ del giornalista”) il<br />
giornalista come informatore “non dovrà limitarsi a riferire la<br />
notizia del fatto ma dovrà anche presentare le diverse interpretazioni<br />
del fatto... obiettivamente corrispondenti alla realtà delle cose”<br />
(p.116).<br />
Dopo la lettura di questo libro possiamo soltanto unirci ai<br />
ringraziamenti al Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti<br />
Mario Petrina all’UCSI Sicilia e all’Istituto Siciliano di Bioetica<br />
(chiamato da lui Laboratorio di Cultura Bioetica per l’uomo del terzo<br />
millennio) per la loro iniziativa dell’incontro interdisciplinare ed<br />
aspettare i prossimi contributi dei Seminari di etica professionale.<br />
EDMUND KOWALSKI, CSsR<br />
Russo G., (a cura di). Leumann (Torino): Editrice Elle Di Ci, 336 p.<br />
(Evangelium vitae 59).<br />
La collana Evangelium vitae curata da don Giovanni Russo si<br />
arricchisce di un nuovo volume a più voci che, collegandosi<br />
idealmente ai precedenti, contribuisce a delineare un quadro<br />
organico e sfaccettato degli interessi e problemi della bioetica. La<br />
bioetica infatti, non può essere ristretta all’ambito della medicina e<br />
tanto meno della sola medicina di frontiera, anche se in questi settori<br />
emergono per la bioetica le sollecitazioni più pressanti e più vivo è<br />
l’interesse del dibattito pubblico, ma deve allargare i suoi interessi a<br />
tutto il fenomeno vita e, per quanto riguarda la vita umana, alle<br />
questioni connesse con la qualità della vita della gente, le politiche
513<br />
sociali e sanitarie, i comportamenti di massa che toccano da vicino<br />
l’integrità psicofisica della vita. Perciò, dopo il volume di commento<br />
dell’enciclica Evangelium vitae, che contiene i fondamenti filosofici e<br />
teologici della disciplina, e dopo i testi riguardanti la bioetica clinica,<br />
quella ambientale e quella animale, ora ci viene offerto uno studio<br />
approfondito sulla bioetica sociale “vale a dire tutto quel campo della<br />
vita che è in stretto rapporto con l’organizzazione sociale e politica”<br />
(p. 5). Anche alcuni dei temi classicamente presenti in tutti i manuali<br />
di teologia morale in relazione al comandamento “Non uccidere”, in<br />
particolare suicidio, legittima difesa, omicidio e pena di morte, vengono<br />
presentati non in quanto violazioni o eccezioni al comandamento,<br />
bensì nella prospettiva di problemi sociali emergenti che<br />
interpellano la responsabilità individuale e collettiva verso il valore<br />
della vita umana.<br />
Il volume si apre con uno studio sul suicidio dovuto allo stesso<br />
Curatore, la cui attività nel campo della bioetica è a tutti nota. Dopo<br />
un rapido schizzo sulla storia della riflessione morale sul tema,<br />
ampio spazio viene dedicato alla sociologia e psicologia delle<br />
condotte suicidiarie con particolare riferimento ad alcune tipologie<br />
oggi più rilevanti (adolescenti, anziani, militari), fornendo infine<br />
preziose indicazioni psicopedagogiche per gli educatori ed i<br />
responsabili della salute pubblica.<br />
Più classiche le pagine che il prof. Lino Ciccone dedica alla<br />
legittima difesa e all’omicidio. In questi due capitoli, fra loro in stretta<br />
continuità, ci pare soprattutto da sottolineare il tentativo di uscire da<br />
una lettura formalistica della legittima difesa attraverso<br />
l’applicazione quasi meccanica della figura del duplice effetto, per<br />
aprirsi ad una comprensione dinamica della articolata relazione<br />
conflittuale che si realizza fra aggressore e aggredito. La centralità<br />
assiologica del valore della vita umana risalta con chiarezza nella<br />
trattazione dell’omicidio in cui si rivendica, fra l’altro, la<br />
ragionevolezza e la radicazione antropologica del precetto divino, in<br />
garbata polemica con quegli studiosi di etica che “data la diffusa<br />
ignoranza del cristianesimo” spingono a “far pensare che il motivo<br />
primo per cui l’omicidio è moralmente riprovevole è perché è<br />
proibito da una legge, sia pure divina” (p. 77).<br />
L’articolo del prof. Mario Di Ianni, dell’Urbaniana, offre una<br />
puntuale informazione biblica, patristica e teologico morale sulla<br />
pena di morte, per poi soffermarsi sul dibattito attuale intorno alla<br />
sua legittimità: l’Autore sostiene che “gli argomenti di ambo gli
514<br />
schieramenti vanno rispettati e che il riconoscimento, da parte della<br />
Chiesa, del diritto che lo Stato ha di comminare questa pena, per<br />
gravissimi motivi, ha avuto nel passato delle spiegazioni storico<br />
culturali, ma che oggi, alla luce delle spinte degli uomini di buona<br />
volontà, i credenti in Cristo non possono più sostenere, senza una<br />
forte riserva morale, che la pena di morte sia un punizione adeguata<br />
alla dignità della persona umana, e non-in-sintonia perfetta con i<br />
valori del Vangelo” (pp. 86-87). La posizione dell’Autore è esemplata,<br />
in sostanza, su Evangelium Vitae e la typica del Catechismus, ma è<br />
interessante che egli respinga a ragione l’uso della figura della<br />
legittima difesa usato da questi recenti testi magisterali (cfr. p. 111).<br />
Questa prima ideale sezione è chiusa da una stringata<br />
trattazione dell’insolito tema della cremazione del cadavere dovuta al<br />
dott. Anfelo Cafaro, medico e cultore di bioetica, spiegando i motivi<br />
della legislazione canonica antica e di quella attuale, ma non<br />
dissimulando la propria diffidenza dal punto di vista sanitario e<br />
psicologico per la prassi dell’incenerimento.<br />
I tre capitoli seguenti studiano una delle più drammatiche<br />
emergenze socio-sanitarie dei nostri giorno, quello delle dipendenze<br />
da sostanze chimiche. Il dott. Salvino Leone, docente di bioetica<br />
presso la facoltà di medicina di Palermo, traccia le coordinate<br />
mediche, culturali, psicologiche ed etiche delle tossicodipendenze,<br />
interessandosi alle questioni morali e giuridiche poste dalla<br />
prevenzione, dalla liberalizzazione, dalla riabilatazione. Il dott.<br />
Gialuigi Conte e la dottoressa Angela Maccallini, psichiatri<br />
dell’Università Cattolica di Roma, completano la trattazione generale<br />
con un capitolo sullo spinoso problema di Tossicomanie e<br />
adolescenza. Lo stesso dott. Conte, in collaborazione con la<br />
dottoressa Patrizia Giura, ha steso anche il suggestivo capitolo su<br />
Alcolismo e tabagismo.<br />
Il contributo di Massimo Petrini, dell’Università Cattolica del<br />
Sacro Cuore di Roma, affronta uno dei nodi della sociologia e della<br />
medicina di oggi e ancor più di domani, quello dell’invecchiamento.<br />
Il capitolo su Geriatria e gerontologia ovvero sulla Bioetica<br />
dell’anzianità, esamina con ordine e grande competenza i dati<br />
demografici, psicologici e teologico-spirituali dell’età anziana e offre<br />
interessanti spunti per quello che riguarda l’accompagnamento e<br />
l’assistenza dell’anziano sino alle soglie della morte attraverso la<br />
cosiddetta death education. Un altro argomento di grande rilevanza<br />
sociale, ma poco frequentato dai moralisti, è quello dello sport. Il
515<br />
dott. Salvino Leone dà un quadro molto limpido del soggetto,<br />
dapprima con alcune riflessioni sui valori etici ed antropologici<br />
come movimento, gioco ed agonismo, quindi affrontando il<br />
controverso tema del doping ed infine analizzando con grande<br />
equilibrio la questione del rischio sportivo e degli sport pericolosi.<br />
Gli ultimi due interventi riguardano problematiche del mondo<br />
della medicina. Il famoso pediatra Giuseppe Roberto Burgio compie<br />
una acuta e appassionata disanima in materia di vaccinazioni, un<br />
campo piuttosto turbolento dal punto di vista sia medico sia etico, nel<br />
quale le critiche di alcuni medici si sono trovate in sinergia con le<br />
paure irrazionali di molti genitori ed un malinteso diritto dei genitori<br />
di decidere autonomamente per i figli. Il prof. Burgio conclude la sua<br />
trattazione affermando che “gli immancabili nuovi successi daranno<br />
le migliori risposte alla irresponsabile e colpevole dialettica della<br />
confutazione” (p. 293). Il volume è chiuso da uno studio sintetico, ma<br />
soddisfacente come primo approccio, su uno dei problemi più tipici<br />
della bioetica contemporanea quello della Distribuzione delle risorse<br />
sanitarie o, se si vuole, della giustizia sanitaria. La trattazione è<br />
dovuta ad uno dei più fini bioetici italiani, il prof. Massimo Reichlin,<br />
ricercatore al San Raffaele di Milano, e ripercorre con semplicità e<br />
rigore le questioni più rilevanti che animano il dibattito odierno: dal<br />
diritto alla salute o meglio dal diritto ad accedere alle cure sanitarie e<br />
dal sistema sanitario ottimale per tutelarlo, all’obiettivo modesto, ma<br />
forse l’unico possibile nell’attuale contesto socio-sanitario, del<br />
minimo decente, alla questione del razionamento delle cure e dei<br />
criteri per operarlo secondo equità. Da segnalare l’ampia discussione<br />
sul criterio dei QALYS (quality-adjusted life years) che, sotto<br />
l’apparenza di oggettività, contiene una pesante ipoteca ai danni di<br />
coloro che per età o condizioni di handicap sono già svantaggiati in<br />
partenza perché “tende a far prevalere l’esigenza economica di<br />
ricavare la maggior quantità di benefici possibili dall’impiego delle<br />
risorse sanitarie, rispetto all’esigenza etica di mantenere un criterio di<br />
equità nel trattamento delle persone” (p. 316).<br />
Pur nella legittima e nel complesso piacevole varietà delle<br />
impostazioni dei diversi contributi, si può senz’altro rintracciare nel<br />
volume un saldo filo conduttore: il nostro atteggiamento verso la vita<br />
non può essere strutturato nel paradigma di una autonomia<br />
individualista, ma, nel momento che la vita umana presenta sempre<br />
anche aspetti interpersonali e sociali, il nostro atteggiamento verso<br />
la vita deve essere strutturato sul paradigma di una libertà
516<br />
relazionale. Una bioetica dell’autonomia deve quindi sapersi<br />
armonizzare con una bioetica della responsabilità e in questa<br />
accentuazione del “prendersi cura” rispetto al “dovere” o al<br />
“rispettare” è possibile, fra l’altro, ravvisare l’importanza di quella<br />
che potremmo definire dimensione femminile della disciplina, come<br />
il Curatore non manca di sottolineare (p. 6). Deriva da questa<br />
opzione di fondo, così fortemente radicata nell’ethos cristiano, la<br />
persuasione che il nostro futuro “dipenda dall’impegno per la<br />
promozione di una qualità della vita che è dialogica, interpersonale,<br />
appunto sociale. Occorre camminare – avverte perciò Russo – verso<br />
una positiva convergenza sociale sulla vita e sul suo valore … e porre<br />
al centro la vita altra come paradigma. Leggere la vita senza questa<br />
alterità è il fallimento di ogni paradigma. Leggere la vita senza<br />
questa alterità è il fallimento di ogni paradigma” (p. 7).<br />
Auguriamo al volume la diffusione che si merita e lo<br />
raccomandiamo a tutti coloro che, fra gli appassionati di bioetica e<br />
gli operatori pastorali, vogliono avere una informazione seria,<br />
aggiornata, ben argomentata su temi di così scottante attualità.<br />
MAURIZIO P. FAGGIONI<br />
Scola, Angelo, Il mistero nuziale. 1. Uomo-donna. Roma: PUL-<br />
Mursia, 1998, 208 p.<br />
Esta obra entra a formar parte de la rica y abundante literatura<br />
que se está difundiendo para iluminar un campo de la teología de la<br />
pareja humana hasta el presente un poco en la penumbra: ‘la<br />
dimensión nupcial’. El autor es Mons. Angelo Scola, Rector<br />
Magnífico de la Universidad de Letrán, y Presidente del Pontificio<br />
Instituto Matrimonio y Familia ‘Juan Pablo II’ con sede en Roma.<br />
La nueva contribución de Angelo Scola a la teología del<br />
matrimonio está programada en dos volúmenes enfocados a la<br />
antropología teológica: el primero dedicado a la pareja varón-mujer,<br />
el segundo al matrimonio-familia.<br />
El primer volumen titulado Il mistero nuziale está concebido<br />
como pre-requisito para la lectura del segundo y aparece<br />
estructurado en dos partes con un total de seis capítulos y cuatro<br />
apéndices (pp. 145-195). El texto va acompañado de 521 notas, lo<br />
que sugiere la seriedad y calidad de la reflexión.
517<br />
Ya desde el prefacio, el autor relaciona los términos ‘amor’ y<br />
‘misterio’, porque para entender la naturaleza del amor humano se<br />
hace necesario entrar en el misterio. Para comprender que el amor<br />
es misterio, Scola plantea dos condiciones: que se considere el<br />
misterio como una modalidad personal y que se acepte mirar como<br />
una unidad la pluralidad de formas con que se revela el amor. Fuente<br />
de inspiración ha sido la enseñanza de Juan Pablo II, antes y durante<br />
su pontificado, en particular las catequesis sobre el libro del Génesis<br />
y la Mulieris dignitatem de la que toma los fundamentos<br />
antropológicos y teológicos.<br />
La primera parte del primer volumen se centra en tres ideas:<br />
varón y mujer son personas humanas porque fueron creados a<br />
imagen de Dios; en cuanto ‘unidad de dos’ son ‘imago Dei’; y como<br />
tal, están orientados a la procreación. Esta parte demuestra que<br />
varón-mujer son ‘imago Dei’ no sólo en su vocación de ‘uni-dualidad’,<br />
sino también en su vocación de paternidad-maternidad.<br />
La segunda parte se centra en los tres últimos capítulos en los<br />
que el autor examina la perspectiva del ‘misterio nupcial’. También<br />
aquí aparecen tres ideas principales: los dinamismos de la<br />
nupcialidad (afecto, amor y sexualidad), la descripción del misterio<br />
nupcial y la relación entre nupcialidad y fecundidad. Leyendo con<br />
atención se podrá descubrir que el capítulo IV sobre ‘los dinamismos<br />
de la nupcialidad’ hace el nexo entre las dos partes; este nexo lo<br />
constituye el amor del varón y de la mujer (amor sexual o erótico), al<br />
que el autor llama “forma paradigmática del amor”.<br />
Il mistero nuziale es el tema analizado a lo largo de las 208<br />
páginas, es la clave de lectura y de la originalidad del libro. El<br />
misterio nupcial es como el hilo de oro que une toda la historia de<br />
salvación: la creación del hombre, la alianza vetero y<br />
neotestamentaria, la estructura de los sacramentos; revela el ser y el<br />
hacer de la Trinidad Divina que es precisamente la fuente de la unidualidad<br />
que se manifiesta en toda la creación.<br />
Por esta razón, la condición nupcial es un misterio: no porque<br />
sea desconocida, sino a causa de su riqueza, de su profundidad, de la<br />
forma como abraza lo increado y lo creado. En el Dios Trino y Uno<br />
se halla la explicación y fundamentación de la uni-dualidad. En Dios<br />
Uno en Tres Personas radica el principio de toda nupcialidad.<br />
Incluso la virginidad no es ajena a esta dinámica. De ahí que los dos<br />
estados (matrimonio y virginidad) realizan mutuamente la plena<br />
nupcialidad.
518<br />
Esta obra, sin decirlo expresamente, es una respuesta a quienes<br />
afirman hoy ‘el imperativo tecnológico’ que pretende disociar<br />
sexualidad, amor y procreación. Se trata de una reflexión en la que<br />
se conjugan la filosofía, la antropología y la teología en orden a<br />
iluminar la “communio personarum”, que no es otra cosa que la<br />
proyección de la ‘Imago Dei’, que es fundamentalmente ‘Imago<br />
Trinitatis’.<br />
Al terminar la lectura de esta obra aparece con claridad el<br />
objetivo que el autor se había propuesto: rechazar las diversas<br />
formas de reproducción humana que la biogenética está inventando,<br />
porque no responden al plan creador de Dios que hizo del hombre su<br />
propia imagen, ‘Imago Dei’.<br />
J. SILVIO BOTERO GIRALDO, CSsR.<br />
Scola, Angelo (a cura di), Quale vita? La bioetica in questione,<br />
Milano: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 1998, 416 p. (I<br />
edizione Leonardo Saggistica)<br />
La riflessione morale nel campo biomedico si va sviluppando in<br />
un momento di grande rinnovamento socio-culturale, caratterizzato<br />
dal passaggio epocale del paradigma della modernità a quello del<br />
postmoderno, che si accompagna al passaggio da una scienza<br />
eticamente libera a una scienza eticamente responsabile. Questa<br />
nuova realtà ha rinverdito una vecchia polemica sui rapporti tra<br />
etica e ricerca scientifica per cui oggi si parla di “ritorno all’etica”.<br />
La bioetica è un tema che oggi va molto di moda; l’antropologia<br />
filosofica o teologica molto meno. Eppure non ci può essere un ethos<br />
autentico della vita umana senza un’adeguata visione dell’uomo.<br />
Quale vita? La bioetica in questione è l’insieme di 13 articoli di 12<br />
autori che “intendono offrire al lettore qualche approfondimento sul<br />
fenomeno della vita umana” (Prefazione). Questo fenomeno della<br />
vita umana è stato elaborato da diversi, ma complementari, punti di<br />
vista.<br />
D.Biju-Duval (Francia) sulla lettura del Fenomeno umano di<br />
Teilhard de Chardin ha tentato ricordare non soltanto la riflessione<br />
teilhardiana sulla storia del cosmo nel quadro della storia della<br />
salvezza attraverso il suo tema di Omega, ma soprattutto sottolineare<br />
l’attualità del suo dialogo tra la teologia e le altre scienze umane, la
519<br />
sua grande unità nella visione del mondo basata “sulla tipologia del<br />
primo e dell’ultimo Adamo” e infine, ritrovare per mezzo di finalità<br />
l’importanza dell’uomo (senso ultimo della vita umana) e l’esistenza<br />
di Dio (Il fenomeno umano: vita ed etica).<br />
Dopo questa visione globale della vita umana gli altri autori<br />
hanno preso in considerazione l’uomo e la vita umana come tali alla<br />
luce di diversi aspetti dal punto di vista antropologico: filosoficoetico<br />
(S.Grygiel, Cracovia, Per guardare il cielo. Vita, vita umana e<br />
persona), psicologico-psichiatrico (G.Zuanazzi, Verona, Etica e vita<br />
psichica; Vita, etica ed esercizio della psichiatria), sociologico<br />
(W.Waldstein, Salisburgo, Vita e vita sociale: pluralismo e regole<br />
sociali), ecologico (H.Hude, Parigi, La temperanza, virtù ecologica),<br />
teologico, prendendo specialmente in considerazione il Mistero<br />
pasquale (J.Laffitte, Tolosa, Vita umana: dono, vita e perdono;<br />
D.Schindler, Washington, Sacralità della vita e cultura di morte),<br />
escatologico (M.Hendrickx, Bruxelles, La vita e la vita eterna).<br />
A monte spuntano pertanto gli interrogativi fondamentali<br />
dell’antropologia filosofica: Chi è l’uomo? Quale la sua dignità?<br />
Quale il suo valore? L’uomo è soltanto un essere biologico?<br />
Sappiamo bene che ci sono tante bioetiche quante sono le etiche<br />
professate, così come queste derivano dalle diverse antropologie<br />
seguite (L.Melina, Roma, Riconoscere la vita. Problematiche<br />
epistemologiche della bioetica). La morale presuppone l’antropologia<br />
e non viceversa. Le moderne scoperte e gli sviluppi della<br />
tecnoscienza intorno all’uomo esigono una più stretta collaborazione<br />
tra antropologia e bioetica nella nostra epoca della postmodernità,<br />
dove regna il nichilismo tecnologico, “il nichilismo massivo diffuso<br />
dai mezzi di communicazione sociale” e dove c’è “consenso e<br />
legittimità rispetto alle regole del gioco” (P.Morandé, Santiago del<br />
Cile, Vita e persona nella postmodernità).<br />
La cultura umana che in passato si limitava ad educare l’uomo,<br />
con la moderna tecnologia può ormai intervenire direttamente<br />
sull’origine dell’uomo, scegliere il suo sesso, predeterminare le sue<br />
qualità somatiche e psichiche. Da questa nuova situazione sorgono<br />
gli inquietanti interrogativi che si pone la bioetica: Quali sono i<br />
diritti della vita umana? L’uomo per le biotecnologie o le<br />
biotecnologie per l’uomo? Procreazione senza sessualità? Fecondità<br />
senza amore? La dignità umana e l’aspetto umano della sessualità e<br />
della procreazione delle persone esigono una collaborazione stretta<br />
tra la biologia con le sue nuove biotecnologie e la bioetica fondata
520<br />
sulla verità dell’uomo come l’unità corporeo-spirituale indissolubile<br />
(A.Scola, Roma, Differenza sessuale e procreazione, R.Colombo,<br />
Milano, Vita: dalla biologia all’etica).<br />
Quale vita? La vita pienamente umana con il rispetto adatto alla<br />
dignità della persona umana nella totalità della sua natura e del suo<br />
essere in quanto unità sprirituale e corporea, in cui la dimensione<br />
biologica non può essere separata da quelle spirituale, familiare e<br />
sociale – ecco la risposta degli autori di questo volume agli<br />
interrogativi fondamentali della bioetica in questione.<br />
EDMUND KOWALSKI, C.Ss.R.<br />
Università Cattolica del Sacro Cuore, Chiesa, usura e debito estero.<br />
Giornata di studio su: «Chiesa e prestito a interesse, ieri e oggi» in<br />
occasione del Cinquantennio della Facoltà di Economia (Milano,<br />
19 dicembre 1997). Milano: Vita e pensiero, 1998, 177 p.<br />
(Supplemento al quaderno n. 6, ottobre 1998).<br />
È la raccolta dei contributi presentati nel corso della giornata di<br />
studio promossa dalla Facoltà di Economia per celebrare il<br />
cinquantesimo della sua fondazione, dove, in premessa, si sottolinea<br />
che il prestito a interesse è stato interpretato per molto tempo in<br />
termini di usura, in forza di quella visione che considera la<br />
solidarietà il valore fondamentale, vincolante il rapporto di prestito<br />
relativo a qualsiasi bene. Un affermazione di principio che sarebbe<br />
però stata travolta dal mondo moderno, che assunse a valore<br />
l’efficienza e lo sviluppo economico finanziato da soggetti diversi e<br />
che, di fatto, ha instaurato «quella dialettica tra efficienza e<br />
solidarietà che non ha ancora conosciuto il suo momento di sintesi»<br />
(p. 2). Nel ricordare che: «la realtà contemporanea, anche di paesi<br />
caratterizzati dall’abbondanza, sperimenta, non marginalmente, ma<br />
drammaticamente e paradossalmente il fenomeno dell’usura» (p. 6),<br />
si spiega che, fra i vari motivi che hanno portato ad affrontare il tema<br />
in prospettiva storica, vi è: «la necessità, culturalmente fondata, di<br />
riprendere criticamente una valutazione secondo la quale la Chiesa,<br />
assumendo un atteggiamento di chiusura in ordine alla liceità del<br />
prestito ad interesse, avrebbe di fatto ostacolato lo sviluppo<br />
dell’economia moderna» (p. 7), andando a confliggere con la realtà<br />
contemporanea della finanza internazionale, delle economie
521<br />
integrate a scala planetaria, dell’incessante progresso tecnologico.<br />
Nella prima parte della giornata di studio i vari contributi si<br />
articolano attraverso la rivisitazione delle idee e delle enunciazioni in<br />
argomento, nel periodo che intercorre tra le due grandi rivoluzioni:<br />
quella commerciale e quella industriale; per concentrarsi, nella<br />
seconda parte dei lavori, sull’attualità, consistente nell’analisi dei<br />
nessi tra finanza e sviluppo economico, nel riflettere sul ruolo delle<br />
istituzioni finanziarie internazionali e, infine, nell’affrontare la<br />
questione del debito estero.<br />
Relativamente alla prima sessione, Giancarlo Andenna,<br />
introducendo al panorama delle Riflessioni canonistiche in materia<br />
economica dal XII al XV secolo, mette in risalto che la<br />
preoccupazione fondamentale che domina il periodo, mutuata dal<br />
pensiero dei Padri della Chiesa, consiste nel percepire il prestito ad<br />
interesse come capace di scardinare la visione di una società intenta<br />
a mantenere compatto il gruppo e ad incrementare i rapporti sociali,<br />
nonché fondata sulla caritas, cioè sul mutuo aiuto economico e<br />
sociale. Dopodiché scandisce le tappe di un periodo ricco di<br />
contributi, attraverso gli apporti di Raimondo di Peñafort, del card.<br />
Sinibaldo Fieschi poi Papa Innocenzo IV, del card. Enrico da Susa<br />
Vescovo di Ostia, del francescano Pietro Olivi il cui pensiero sarà<br />
inconsapevolmente ripreso da San Bernardino da Siena e da<br />
Sant’Antonino da Firenze, mostrando l’itinerario che porta<br />
all’accettazione dell’idea che un’istituzione finalizzata al credito<br />
quale quella del Monte di Pietà, possa chiedere in modo legittimo un<br />
interesse per le proprie prestazioni, sfociando anche nella ratifica da<br />
parte del Lateranense V, che farà propria la bolla inter multiplices di<br />
Leone X.<br />
Paolo Vismara, con la relazione su Valori morali e autonomia<br />
della coscienza. Il dibattito sul prestito ad interesse nella Chiesa<br />
moderna, nel sottolineare che la tematica del prestito ad interesse<br />
vede intersecarsi, in un panorama complesso, elementi diversi: «dai<br />
dati economico-sociali alle riflessioni teologiche, dalle tematiche<br />
giuridico politiche alle questioni pastorali» (p. 44), si domanda<br />
perché essa riveli posizioni contrastanti nel mondo cattolico<br />
mettendo in luce, in più di un caso, «una certa rigidità nella<br />
concezione del denaro (e, in ultima analisi in campo economico)» (p.<br />
45). Dopo un exursus che delinea le sottili distinzioni, le diverse<br />
interpretazioni e le accese diatribe che la realtà vissuta sollecitava<br />
alla riflessione dottrinale, egli rileva che «nelle posizioni della Chiesa
522<br />
moderna a proposito di prestito a interesse (…), rimane salda e<br />
invariata la tematica di fondo, che consiste essenzialmente nella<br />
volontà di garantire la riflessione etica nell’evoluzione delle dottrine<br />
economiche e nella pratica economica» (p. 80), facendo leva su<br />
ragioni di carattere etico-religioso piuttosto che economico. Il tutto<br />
nella consapevolezza della necessità di rispettare quella gerarchia dei<br />
valori che non consente di «fare del profitto la regola esclusiva e il<br />
fine ultimo dell’attività economica» (p. 81). Ed è proprio la scelta<br />
radicale, drammatica e complessa tra Dio e mammona posta di<br />
fronte all’uomo, che gli impone di «ristabilire in sé e intorno a sé<br />
l’ordo amoris» (p. 82), in una sintesi tra coscienza e valore, che spiega<br />
la compresenza di tematiche con aspetti, a volte, contraddittori, nel<br />
tentativo, in alcune correnti ecclesiastiche, «di coniugare<br />
attaccamento alla tradizione e assunzione dialettica della modernità,<br />
entro un quadro di forte appello ai valori cristiani» (p. 83).<br />
Paolo Pecorari nel tratteggiare gli Orientamenti della cultura<br />
cattolica sul prestito ad interesse nel secolo XIX, ci introduce a quella<br />
temperie economico-sociale, prodotta dalla rivoluzione industriale,<br />
che induce ad attribuire al denaro una produttività virtuale che<br />
prima non aveva e che vede l’affermarsi del pensiero liberale che<br />
ritiene il capitale intrinsecamente produttivo, indipendentemente<br />
dall’apporto del lavoro. Visione liberale, portatrice di una concezione<br />
consuntiva del credito, che si contrappone a quella produttiva di<br />
stampo più marcatamente cattolico, che è fermamente criticata dalla<br />
Rerum Novarum e che, con caratteri di grande attualità, è<br />
decisamente posta in discussione dal Toniolo, fondatore dell’Unione<br />
cattolica per gli studi sociali in Italia, il quale denuncia, fra le altre<br />
cose, il venire meno del primato della morale nella vita economica a<br />
seguito della riforma protestante prima e del razionalismo<br />
illuministico poi (p. 94). Il tutto proprio nel momento in cui il<br />
quadro economico internazionale è in una fase di forte evoluzione.<br />
La seconda sessione dei lavori, dal carattere marcatamente più<br />
tecnico, delinea con ricchezza di dati la fisionomia dell’attuale<br />
situazione economica, portatrice della grave crisi finanziaria e<br />
debitoria. Degna di nota, in particolare, è la comunicazione di Oscar<br />
Garavello che presenta il problema del Condono del debito estero dei<br />
paesi meno avanzati alla fine degli anni ’90, in maniera efficace e<br />
completa, accessibile anche ai non addetti ai lavori. Altre<br />
affermazioni richiederebbero, tuttavia, una qualche precisazione,<br />
come quando, per esempio, L. Boggio riferendosi al prestito ad
523<br />
interesse, sostiene che un’economia in fase di sviluppo costituisce un<br />
contesto che: «può spiegare perché anche la posizione della Chiesa in<br />
proposito è cambiata» (p. 111); oppure come quando G.<br />
Zampaglione, riferendosi alle istituzioni monetarie internazionali,<br />
parla di un «continuare ad avere un ruolo importante di “Lender di<br />
Last Resort” (“Prestatore di ultima istanza” ndr.)» (p. 124) che pur<br />
presente nella mens constitutiva di tali istituzioni si è svolto con tutta<br />
una serie di problematiche di non poco conto, che tuttora ne<br />
inficiano l’efficacia. E comunque le tre relazioni presentano un<br />
profilo in cui la dimensione morale non risulta essere un elemento<br />
dell’analisi, andando indirettamente a confermare la fondatezza<br />
della preoccupazione costantemente presente all’interno del pensiero<br />
cattolico, di dare rilevanza alla dimensione mutualistica in ambito di<br />
analisi economica. Ci pare, inoltre, che l’economia dei lavori avrebbe<br />
richiesto una comunicazione di sintesi dal taglio etico e morale che<br />
non fosse soltanto storico.<br />
Da segnalare un probabile errore di trascrizione quando a p. 113<br />
si parla di «285 milioni di dollari» che, coerentemente con le cifre<br />
riportate anche nelle altre relazioni dovrebbero essere 285 miliardi di<br />
dollari.<br />
Il libro risulta essere un prezioso strumento per iniziare ad<br />
addentrarsi nel complesso problema dei criteri per un’attività<br />
finanziaria secondo lo spirito evangelico e del debito estero, che<br />
rende ragione dello sforzo di approfondimento piuttosto che<br />
dell’atteggiamento di chiusura della Chiesa nel suo complesso in<br />
materia di prestito ad interesse, e che sollecita la teologia odierna a<br />
recuperare un livello qualitativo di ricerca consono alla ricca ed<br />
attiva tradizione precedente.<br />
DON LEONARDO SALUTATI<br />
Vidal, Marciano, Bernhard Häring un rinnovatore della morale<br />
cattolica. Trad. dallo spagnolo di Fabio Ruggiero. Bologna:<br />
Edizioni Dehoniane 1999, 147 p. (Trattati di etica teologica, 10).<br />
Scritto a pochi mesi di distanza dalla morte di B. Häring (3<br />
luglio 1998), il volume è molto più di una semplice<br />
commemorazione. Ricostruendone gli aspetti fondamentali della<br />
proposta, M. Vidal si preoccupa di porre in luce il ruolo decisivo
524<br />
svolto da B. Häring per il rinnovamento della teologia morale in<br />
questo secolo. Diventa perciò un invito non solo a non dimenticare,<br />
ma a continuare nell’impegno per una proposta evangelicamente<br />
fedele e rispondente ai bisogni e alle attese del nostro tempo.<br />
Giustamente l’autore si ferma sulle opere maggiori di B. Häring:<br />
la tesi dottorale del 1947 sui rapporti tra etica e religione (p. 15-34);<br />
il manuale rinnovatore dei primi anni Cinquanta, La legge di Cristo<br />
(p. 35-85); la sintesi postconciliare Liberi e fedeli in Cristo (p. 103-<br />
117). Esse però non vengono isolate, ma considerate nel tessuto<br />
biografico e ecclesiale in cui si radicano, ricorrendo anche agli altri<br />
scritti, particolarmente quelli di taglio più biografico. In questa<br />
maniera Vidal riesce a far emergere l’unità e la dinamica continuità<br />
della proposta di Häring: «Di pari passo con l’attività di scrittore va<br />
quella dedicata alla formazione spirituale (ritiri, esercizi spirituali,<br />
campi), tanto che è lecito affermare che esse finiscono col dare vita<br />
a un tutt’uno teologico-pastorale-spirituale. E questo per così dire<br />
“corpus theologicum-pastorale-spirituale” costituisce la “summa”<br />
viva e scritta che Häring ci offre» (p. 132).<br />
Nella presentazione de Il sacro e il bene, Vidal sottolinea l’ambito<br />
esperenziale (formativo e pastorale) che determinano le scelte del<br />
volume. L’analisi de La legge di Cristo è sviluppata ponendo in luce<br />
soprattutto il radicamento nella tradizione della scuola di Tubinga.<br />
Per Liberi e fedeli in Cristo viene privilegiata la partecipazione al<br />
Vaticano II e al difficile cammino del rinnovamento postconciliare.<br />
Nella conclusione riceve particolare risalto il radicamento nella<br />
tradizione alfonsiano-redentorista (p. 132-134).<br />
Una nota particolare va all’attenzione con la quale Vidal utilizza<br />
gli studi finora fatti su Häring. La parte ottava del volume è dedicata<br />
appunto a “Riconoscimento dell’opera di Häring” e offre un quadro<br />
non solo delle opere di maggior respiro, ma anche di ciò che di più<br />
significativo è stato scritto subito dopo la sua morte (p. 119-128).<br />
Pur nella sinteticità e immediatezza con cui è stato redatto, il<br />
libro mi sembra costituisca uno strumento molto utile non solo per<br />
l’approfondimento della figura e dell’opera di Häring, ma anche per<br />
chiunque voglia capire meglio il tormentato cammino della teologia<br />
morale in questo nostro secolo.<br />
S. MAJORANO C.Ss.R.
Short Notices / Noticias<br />
CHIOVARO, FRANCESCO, Alfonso di Liguori avvocato. Palermo: Segno<br />
Mensile Supplemento a n. 202, 1999, 63 p. (Piccola Biblioteca di<br />
Segno 3).<br />
This pamphlet is the printed version of a talk delivered on the occasion<br />
of the unveiling of a bust of St. Alphonsus in the Palazzo di<br />
Giustizia di Palermo on the 29th of October, 1998. The author begins<br />
with a reference to Sicily. When the Redemptorists first arrived there<br />
opposition to their presence was concentrated against Alphonsus’<br />
moral theology as jesuitical. He defended himself with the finest skill<br />
of a practiced advocate. Hence the question of how far his moral<br />
theology is dependent on his legal training? Chiovaro believes it led<br />
him to treat cases not as stereotypes as with the classical moralists<br />
but as issues tauching life at its deepest level. He was educated as a<br />
defense lawyer and so as one specialised in securing the rights of his<br />
clients. This view is confirmed by the twelve point “codice morale<br />
dell’avvocato” that he wrote at the start of his professional activity.<br />
Chiovaro calculates that law, canonical and civil, accounts for about<br />
a quarter of the sources of his Theologia Moralis. Alphonsus’ moral<br />
system is formed in a way typical of a lawyer’s style of reasoning. On<br />
one hand his training confirmed him as a man of tradition. On the<br />
other he learnt from the enlightened minds in the University of<br />
Naples that only reason is capable of judging the good and evil in human<br />
actions. His priestly training probably dampened the effect of<br />
his legal experience. It was as a missionary that he brought his legal<br />
genius to bear on his pastoral experience. This excellent pamphlet<br />
also provides an invaluable bibliography of legal sources and literature<br />
in the Theologia Moralis.<br />
Terence Kennedy, C.Ss.R.
526<br />
DE LIGUORI, ALFONSO, Degli obblighi de’ giudici, avvocati, accusatori e<br />
rei. Palermo: Sellerio Editore, 1998, 100 p. (Il Divano 134).<br />
Father Nino Fasullo must be congratulated for achieving what<br />
experts on St. Alphonsus have not dared to attempt, that is, to make<br />
his authentic thought known to his fellow judges and advocates, the<br />
professions he himself exercised. Happily Fasullo understands how<br />
Alphonsus’ teaching remains not just a valid but a necessary foundation<br />
of their professional ethics. Because Alphonsus shares their<br />
culture he can play a unique role in solving the current problems of<br />
corruption and criminality which they face. The wise selections from<br />
Alphonsus’ writings Fasullo has here published illustrate his contention<br />
that St. Alphonsus has been venerated but not studied. Hence<br />
his alienation from contemporary intellectual culture, the “modernità<br />
di un antimoderno.” The concluding essay by Francesco Viola<br />
proves what a positive, inspirational effect Alphonsus can have when<br />
judges and advocates discover in his moral theology the appealing<br />
face of a God who is in our favour. This small and elegantly presented<br />
volume extends the mission of the review Segno and of the Institute<br />
founded by Father Fasullo to prepare judges for their tasks in the<br />
civil forum. This timely publication shows how a Saint could formulate<br />
the moral principles underlying his profession in a mode that remains<br />
efficacious even today.<br />
Terence Kennedy C.Ss.R.<br />
KEATING, JAMES, Pure Heart, Clear Conscience: Living a Catholic Moral<br />
Life. Huntington, Indiana: Our Sunday Visitor, 1999, 120 p.<br />
This is a booklet to encourage thinking Catholics to take their religious<br />
based morality more seriously in practice. In eight clearly<br />
written chapters, at times bordering on the colloquial, Keating touches<br />
on some central Christian moral themes from the assumption<br />
that “we do not create what is good or evil. Goodness and evil creates<br />
us.” (7). The vision is to call people back to their religious identity (9):<br />
this occurs in an historical community (37) where the journey into<br />
truth (5) occurs in a developmental way (112). For Keating this historical<br />
community is clearly the parish: the importance of communal<br />
worship (Chaper 2), sacramental forgiveness (Chapter 4) and dis-
527<br />
cernment (Chapter 6) clearly presuppose a parish structure, particularly<br />
of a certain type found in the USA (92, 103). The book makes<br />
no pretence to address the academic community. The style is exhortatory,<br />
with useful allusions to prayer and practical dilemmas such as<br />
gossip, pornography and selfishness (12). The tone is irenic and nonconfrontational:<br />
the reference to dissent (113) is charitably phrased.<br />
Though not for the academic market, the reader should be aware of<br />
the particular methodological choices which Keating makes: in his<br />
general concern to offset the problems of over-institutionalization<br />
and individualism, which he notes as the twin dangers of American<br />
Catholicism (31), Keating tends to collapse human morality, religious<br />
motivation and Christian worship into the one broad matrix. It<br />
is not a proposition which I share, and I think that parish audiences<br />
who could profit from this book should be allowed raise different<br />
methodological approaches, if they so wish. The book is peppered<br />
with an abundance of anecdotes and stories: some are pertinent, but<br />
too many were (for this European) a little syrupy and not quite ad<br />
rem. This is surely a matter of taste: de gustibus non est disputandum.<br />
But there is a long tradition of the use of exempla (as in Saint Alphonsus)<br />
that has a sound literary structure and might be worth revisiting<br />
by contemporary authors who wish to be practical. I welcome Keating’s<br />
book as a further sign of the growing number of able lay moral<br />
theologians capable of addressing issues free of clerical jargon and<br />
writing in a direct and communicable manner.<br />
Raphael Gallagher C.Ss.R.<br />
FUCHS, ÉRIC, Tout est donné, tout est à faire. Geneva: Fides-Labor et Fides,<br />
1999, 95 p.<br />
This slim volume presents the four valedictory public addresses<br />
of É. Fuchs at the theological faculty of Geneva. Elegantly written by<br />
one of the more important Protestant theologians of our generation,<br />
the book can be profitably read at two levels, either as a summary of<br />
Fuchs’ mature ethical thought or as a statement of the emerging questions<br />
common to all Christian ethicists. The major themes of Fuchs’<br />
theological concerns are here. The Scriptural basis is presented in<br />
chapter one with the exquisite exegesis one associates with Fuchs:<br />
the critical dialogue with the Calvinist tradition is the substance of
528<br />
the second chapter. The other two chapters are an exemplary presentation<br />
of the author’s longstanding awareness of the complex nature<br />
of contemporary society, with many allusions to his control of<br />
the human sciences, and a synthetic presentation of how Fuchs sees<br />
the Biblical tradition as having the internal resources to dialogue<br />
with a secularized society. Notable is his argument that the sapiential<br />
tradition may prove particularly helpful in present circumstances,<br />
while not neglecting a continuing role for the prophetic and sacerdotal<br />
traditions. More tantalizing is the prospect of seeing in this<br />
book the outline of a new approach to the justification of Christian<br />
ethics in general. Fuchs is ecumenically sensitive: he is, for instance,<br />
a valued editorial collaborator of Le Supplément. It is my impression<br />
that, at least in the western part of Europe, ecumenical dialogue on<br />
ethical questions is less vibrant than thirty years ago. Part of the reason,<br />
I suspect, is that the disputes of the Reformation are, to an extent,<br />
passé. There is a range of new questions around the survival of<br />
the humanum in a socially coherent community that raise similar ultimate<br />
questions for all the major Christian traditions. Posing these<br />
questions, for instance the meaning of equality or progress or liberalism,<br />
makes some of our quarrels of the past seem trite. The fundamental<br />
question is no longer how the divisions between the Christian<br />
Churches work themselves out in ethical positions, though they retain<br />
their own importance, but whether the very concept of any<br />
Christian ethic is viable, given the crassness of so much of our<br />
unjustly structured post-liberal societies. Fuchs is provocative on<br />
this point and makes a credible case for the contribution of the<br />
Calvinist tradition towards overcoming the deficit of hope (93) which<br />
one notes in the tired language of too many Christian institutions.<br />
Raphael Gallagher C.Ss.R<br />
ORLANDI, GIUSEPPE, Alfonso de Liguori Scrittore. Palermo: Segno Mensile<br />
Supplemento a n. 199, 1998, 47 p. (Piccola Biblioteca di Segno<br />
2).<br />
This booklet is a finely printed presentation of Prof. Orlandi’s<br />
talk on St. Alphonsus as a literary author at the convention on “Il libro<br />
alfonsiano nel Settecento,” at Palermo in 1997. He shows how<br />
Alphonsus’ writing career was a natural extension of his vocation to
529<br />
the popular missions and his apostolate to the most abandoned. It<br />
really formed the substance of his pastoral activities in the second<br />
half of his life. Orlandi explains how Alphonsus got started, how writing<br />
became his main apostolate, his extraordinary relation with his<br />
publisher Remondini in Venice, and his difficulties with State and<br />
ecclesiastical censors. Orlandi concludes by illustrating how Alphonsus<br />
really invented a pocket edition spirituality, low cost and available<br />
to everyone who could read. He notes how he adjusted his language<br />
to this aim. There is also a valuable bibliography with an historical<br />
table of the main events of Alphonsus’ life in view of his<br />
publishing efforts.<br />
Terence Kennedy C.Ss.R.
Books Received / Libros recibidos<br />
BENIGNI, Mario, Papa Giovanni XXIII chierico e sacerdote a Bergamo<br />
1892-1921. Milano: Edizioni Glossa, 1998, 391 p. (‘Studi e<br />
Memorie’ del Seminario di Bergamo 5).<br />
BRUCH, Richard, Person und Menschenwürde. Ethik im<br />
lehrgeschichtlichen Rückblick. Münster: LII Verlag, 1998, 120 s.<br />
(Studien der Moraltheologie Abteilung Beihefte 3).<br />
CASTELLO, Gaetano (a cura di), <strong>Vol</strong>ti del Messia. Gesù di Nazaret e il<br />
dialogo ebraico-cristiano. Napoli: Edizioni Eurocomp 2000,<br />
1999, 217 p. (Biblioteca Teologica Napoletana 20).<br />
CHIMIRRI, Giovanni, L’etica dell’idealismo. La filosofia morale italiana<br />
tra neohegelismo, attualismo e spiritualismo. Milano: Mimesis,<br />
1999, 192 p.<br />
CHIOVARO, Francesco, Alfonso de Liguori avvocato. Palermo:<br />
Supplemento a Segno n. 202, 1999, 63 p. (Piccola Biblioteca di<br />
Segno 5).<br />
CIORRA, Anthony and KEATING, James, Moral Formation in the Parish.<br />
New York: Alba House, 1998, 179 p.<br />
CURRAN, Charles E., The Catholic Moral Tradition Today. A Synthesis.<br />
Washington D.C.: Georgetown University Press, 1999, 255 p.<br />
DAVID, Vincenzo, La tutela giuridica dell’embrione umano.<br />
Legislazione Italiana ed Europea. Arcireale: Ed. ISB, 1999, 143 p.<br />
FABRI DOS ANJOS, Márcio (org.), Sob o fogo do Espírito. Sao Paolo:<br />
Soter - Paulinas, 1998, 345 p.<br />
FABRI DOS ANJOS, Márcio (org.), Experiência religiosa risco ou<br />
aventura? Sao Paolo: Soter - Paulinas, 1998, 167 p.<br />
FABRI DOS ANJOS, Márcio, (org.), Teologia abierta ao futuro. Sao Paolo:<br />
Soter - Paulinas, 1997, 261 p.<br />
FASULLO, Nino (a cura di), Alfonso de Liguori: degli obblighi de’ giudici,<br />
avvocati, accusatori e rei. Palermo: Sellerio Editore, 1998, 100 p.<br />
FUCHS, Eric, Tout est donné, tout est à faire. Genève: Labor et Fides,<br />
1999, 95 p.<br />
GERARDI, Renzo, Alla sequela di Gesù. Etica delle beatitudini, doni dello<br />
Spirito, virtù. Bologna: Edizioni Dehoniane, 1999, 160 p.
532<br />
GUTH, Rupert, Der Ausdruck von Wahrheit und Freiheit. Berlin - New<br />
York: Walter de Gruyter and Company, 1999, 194 p.<br />
(Theologische Bibliotek Töpelmann 98).<br />
HUBERT, Marianne, Moraltheologie im Kontext Ihrer Zeit. Beiträge zu<br />
Themen der Moral in den Stimmen aus Maria Laach der Jahre<br />
1871-1914. Trier: Paulinus Verlag, 1999? 262 s. (Trierer<br />
Theologische Studien 63).<br />
KEATING, James, Pure Heart Clear Conscience. Living a Catholic Moral<br />
Life. Huntington, Ind.: Our Sunday Visitor, 1999, 120 p.<br />
KELLY, Kevin, From a Parish Base. Essays in Moral and Pastoral<br />
Theology. London: Darton, Longman and Todd, 1999, 226 p.<br />
KOCHEROLS, Jean, L’Esprit à la Croix. La dernière onction de Jésus.<br />
Bruxelles: Editions Lessius, 1999, 174 p.<br />
LARRABE, José Luis, Escritos teológicos postconciliares, <strong>Vol</strong>. 1. Madrid:<br />
Institutos Pontificios de Teología y Filosofia O.P., 1998, 390 p.<br />
LETIZIA, Nicola, Padre Antonio Grimaldi CM tra poesia, filosofia e<br />
teologia. Napoli: Luciano Editore, 1999, 128 p.<br />
LÓPEZ, Teodoro, Mancio y Bartolomé de Medina: Tratado sobre la<br />
usura y los cambios. Pamplona: EUNSA, 188 p. (Faculdad de<br />
Teología Universidad de Navarra, Colección Teológica 91).<br />
MANZONE, Gianni, Libertà cristiana e istituzioni. Mursia: PUL, 1998,<br />
221 p.<br />
MASCIA, Matteo e PEGORARO, Renzo, Da Basileia a Graz. Il movimento<br />
ecumenico e la salvaguardia del creato. Padova: Fondazione<br />
Lanza, 1999, 261 p.<br />
MASTROCINQUE, Simona, Il dono segreto di Sant’Antonio. Padova:<br />
Messagero di S. Antonio, 1999, 93 p.<br />
MAZZANTI, Giorgio, I Sacramenti: simbolo e teologia 2. Eucaristia,<br />
battesimo e confermazione. Bologna: Edizioni Dehoniane, 1998,<br />
295 p.<br />
MERKS, Karl-Wilhelm, Gott und die Moral. Theologische Ethik Heute.<br />
Münster, LIT Verlag, 1998, 414 s.<br />
MILLER, Mark, Living Ethically in Christ. Is Christian Ethics Unique?<br />
New York-Bern, 1999, 311 p. (American University Studies,<br />
Series VII, Theology and Religion 173).<br />
MORAGLIA, Francesco (a cura di), Dio Padre misericordoso. Genova:<br />
Marietti, 1998, 388 p.<br />
MORENO REJÓN Francisco, Historia de la teología moral en América<br />
Latina. Ensayos y materiales. Lima: Istituto Bartolomé de Las<br />
Casas, 1994, 258 p. (CEP 136).
533<br />
MÜLLER, Denis, L’éthique protestante dans la crise de la modernité.<br />
Paris: Editions du Cerf, Genève: Labor et Fides, 1999, 343 p.<br />
MUÑOZ DE JUANA, Rodrigo, Moral y economía en la obra de Martín de<br />
Azpilcueta. Pamplona: EUNSA, 1998, 374 p. (Faculdad de<br />
Teología Universidad de Navarra. Colección Teológica 95).<br />
NAPPO, Carmine, La decisione: culmine della moralità personale.<br />
Napoli: Tipografia Russo, 1996, 97 p.<br />
ORLANDI, Giuseppe, Alfonso de Liguori scrittore. Palermo:<br />
Supplemento a Segno n. 199, 1998, 47 p.<br />
ORLANDO, Pasquale (ed.), Gesù come uomo-Cristo come Dio: unaidentica-persona.<br />
Napoli: Luciano Editore, 1998, 132 p.<br />
(Filosofia e Religione 4).<br />
PERINI, Giovanni, Le domande di Gesù nel Vangelo di Marco. Milano:<br />
Edizioni Glossa, 1998, 149 p (Dissertatio Series Romana 22).<br />
PRIVITERA, Salvatore e VECCHIO, Giuseppe (a cura di), La notizia a<br />
confronto con l’etica. Palermo: ISB, 1999, 127 p. (Etica e Società<br />
1).<br />
PRIVITERA, Salvatore, La questione bioetica. Palermo: ISB, 1999, 158<br />
p. (Conghiglie, 1).<br />
PUCCI, Renato e RUGGIERI, Giuseppe (a cura di), Inizio e futuro del<br />
cosmo: linguaggi a confronto. Cinisello Balsamo (Milano):<br />
Edizioni San Paolo, 1999, 280 p.<br />
ROSMINI, Antonio, Amore e preghiera. Milano: Edizioni Ares, 1999,<br />
122 p.<br />
RUSSO, Giovanni (a cura di), Bioetica sociale. Leumann (Torino):<br />
ElleDiCi, 1999, 335 p.<br />
SACCONE, Carlo, Allora Ismaele s’allontanò nel deserto. Padova:<br />
Edizioni Messaggero, 1999, 352 p.<br />
SCHMIDT, Eduardo, Ética y Negocios para América Latina. Lima:<br />
Universidad del Pacífico, 1997, 587 p.<br />
SCHMIDT, Eduardo, Moralización a fondo. Lima: Universidad del<br />
Pacífico, 1997, 333 p.<br />
SCOLA, Angelo (a cura di), Quale Vita? La bioetica in questione.<br />
Milano: Mondadori, 1998, 410 p.<br />
SCOLA, Angelo (a cura di), Il mistero nuziale: 1. Uomo-Donna Roma:<br />
PUL, 1998, 208 p.<br />
TREMBLAY, Réal, Radicati e fondati nel Figlio. Contributi per una<br />
morale di tipo filiale. Roma: Edizioni Dehoniane, 1997, 167 p.<br />
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Chiesa, usura e debito estero.<br />
Supplemento al quaderno n. 6, Milano, 1998, 177 p.
534<br />
VIDAL, Marciano, Un renovador de la moral católica: Bernhard Häring<br />
C.Ss.R. (1912-1998). Madrid: PS Editorial, 1999, 134 p.<br />
VIDAL, Marciano, Bernhard Häring. Un rinnovatore della morale<br />
cattolica. Bologna: Edizioni Dehoniane, 1999, 147 p. (Collana<br />
Trattati di etica teologica C 1).
INDEX OF VOLUME XXXVI 1999<br />
ÍNDICE DEL VOLUMEN XXXVI 1999<br />
ARTICLES / ARTÍCULOS<br />
BILLY, D.J., Christ’s Redemptive Journey and the Moral<br />
Dimensions of Prayer ...................................................<br />
BOTERO G., J. S., Conciencia de pareja. Hacia la<br />
recuperación de un proyecto inicial.............................<br />
CÓRDOBA CHAVES, A., La Academia Alfonsiana: cincuenta<br />
años al servicio de la Teología Moral ...........................<br />
FAGGIONI, M. P., Stato vegetativo persistente (seconda parte)<br />
JOHNSTONE, B. V., Can Tradition Be a Source of Moral<br />
Truth? A Reply to Karl-Wilhelm Merks ........................<br />
KELLY, A., “God is Love”: A Theological Moral Reading of 1<br />
John ..............................................................................<br />
KENNEDY, T., St. Alphonsus’ Selva. Should It Be<br />
Understood as Rhetoric ? .............................................<br />
KOWALSKI, E., Bioetica e tutela della persona ......................<br />
MCKEEVER, M., Postmodern with a Difference: Simone<br />
Weil’s Ethico-Theological Critique of Totalitarianism<br />
in L’Enracinement.......................................................<br />
MIMEAULT, J., Paternité de Dieu et pénitence des fils.<br />
(Première partie)...........................................................<br />
PADOVESE, L., La dimensione sociale del pensiero<br />
patristico: considerazioni generali ...............................<br />
RÖMELT, J., Theologische Ethik und In-Vitro-Fertilisation..<br />
TREMBLAY, R., La paternité de Dieu, fondement de la morale<br />
chrétienne et de l’éthique humaine ..............................<br />
TREMBLAY, R., Variations thérésiennes sur le thème de<br />
“l’enfant prodigue” ........................................................<br />
VIOTTI, S., Il problema morale della legge civile ..................<br />
WODKA, A., L’oblatività neotestamentaria e il discorso<br />
etico-morale. II: Il dono del dare (2 Cor 8-9) ..............<br />
127<br />
95<br />
229<br />
371<br />
431<br />
35<br />
295<br />
215<br />
185<br />
153<br />
273<br />
357<br />
73<br />
413<br />
321<br />
5
536<br />
EVENTS / EVENTOS<br />
Gros, D., Accademia Alfonsiana: Cronaca relativa all’anno<br />
accademico 1998-1999.................................................<br />
453<br />
REVIEWS / RECENSIONES<br />
BORRIELLO, L., CARUANA, E., DEL GENIO, M. R., SUFFI, N. (a<br />
cura di), Dizionario di mistica (D. J. Billy) ................<br />
CHIMIRRI, G., L’etica dell’idealismo (N. Cappelletto) ..........<br />
CIORRA, A. J. and KEATING, J., Moral Formation in the<br />
Parish (R. Gallagher) ...................................................<br />
GAZIAUX, É., L’autonomie en morale: au croisement de la<br />
philosophie et de la théologie (B. V. Johnstone)..........<br />
GIARDINI, F., Pray without Ceasing. Towards a Systematic<br />
Psychotheology of the Christian Prayerlife (D. J. Billy)<br />
DAVID, V., La tutela giuridica dell’embrione umano (E.<br />
Kowalski) .....................................................................<br />
KELLY, K., From a Parish Base (R. Gallagher) ...................<br />
MASCIA, M. e PEGORARO, R. (a cura di), Da Basileia a Graz.<br />
Il movimento Ecumenico e la salvaguardia del creato<br />
(T. Kennedy).................................................................<br />
MORAGLIA, F. (a cura di), Dio Padre misericordioso (R.<br />
Tremblay) .....................................................................<br />
MÜLLER, D., L’éthique protestante dans la crise de la<br />
modernité (M. McKeever)............................................<br />
PACIA, O., Giulio Nicolò Torno. Un teologo e giurista del<br />
Settecento Napoletano (S. Majorano)..........................<br />
PALUMBIERI, S., Amo dunque sono. Presupposti<br />
antropologici della civiltà dell’amore (S. Majorano) ...<br />
PIVA, P., L’evento della salvezza fondamento dell’etica<br />
ecumenica (L. Alvarez) ................................................<br />
PRIVITERA, S., La questione bioetica (E. Kowalski).............<br />
PRIVITERA, S. e VECCHIO, G. (a cura di), La notizia a<br />
confronto con l’etica (E. Kowalski).............................<br />
RUSSO, G. (a cura di), Bioetica sociale (M. P. Faggioni)....<br />
SCOLA, A., Quale Vita? La bioetica in questione (E.<br />
Kowalski) .....................................................................<br />
SCOLA, A., Il mistero nuziale. 1: Uomo-Donna (J. S. Botero<br />
G.) .................................................................................<br />
479<br />
482<br />
483<br />
485<br />
489<br />
509<br />
492<br />
494<br />
496<br />
498<br />
501<br />
502<br />
505<br />
509<br />
511<br />
512<br />
518<br />
516
537<br />
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, Chiesa, usura e<br />
debito estero (L. Salutati).............................................<br />
VIDAL, M., Bernhard Häring un rinnovatore della morale<br />
cattolica (S. Majorano) ................................................<br />
520<br />
523<br />
SHORT NOTICES / NOTICIAS<br />
CHIOVARO, F., Alfonso de Liguori avvocato (T. Kennedy)....<br />
FASSULLO, N. (a cura di), Alfonso de Liguori. Degli obblighi<br />
de’ giudici, avvocati, accusatori e rei (T. Kennedy) ....<br />
FUCHS, E., Tout est donné, tout est à faire (R. Gallagher)..<br />
KEATING, J., Pure Heart Clear Conscience (R. Gallagher)...<br />
ORLANDI, G., Alfonso de Liguori scrittore (T. Kennedy)......<br />
525<br />
526<br />
526<br />
527<br />
528<br />
BOOKS RECEIVED / LIBROS RECIBIDOS<br />
531<br />
INDEX OF VOLUME <strong>XXXVII</strong> /<br />
ÍNDICE DEL VOLUMEN <strong>XXXVII</strong><br />
535