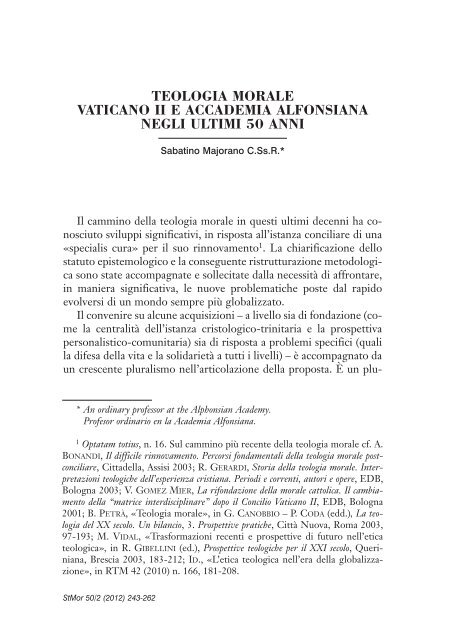teologia morale vaticano ii e accademia alfonsiana ... - Studia Moralia
teologia morale vaticano ii e accademia alfonsiana ... - Studia Moralia
teologia morale vaticano ii e accademia alfonsiana ... - Studia Moralia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
248 SABATINO MAJORANOSono le prospettive ribadite dal Reggente, il Prof. J. Visser, nellasolenne seduta inaugurale dei corsi, avvenuta il 15 ottobre 1957. Ilfine dell’AA è «contribuire a colmare il vuoto che si riscontra nellostudio della <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>», attraverso un duplice impegno: a)l’approfondimento dei «principi generali della <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> e delsuo metodo» e delle risposte concrete, da proporre nella pratica pastorale;b) la formazione «di adeguati cultori e professori nelle scienzemorali». Radicato «in spiritu et virtute S. Alfonsi», lo studioscientifico della <strong>morale</strong> dovrà essere retto da quattro istanze fondamentali:1) «spirito apostolico e pastorale»; 2) praticità preoccupatadi arrivare a «formulare norme concrete e particolari per la vita cristiana»;3) visione unitaria, che esige l’incontro tra «la <strong>teologia</strong> dellamisericordia» e «la <strong>teologia</strong> della perfezione» (<strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> insenso stretto e <strong>teologia</strong> ascetica); 4) «fedele ossequio per il Magisterodella Chiesa» 11 .Nella lectio inaugurale del successivo anno scolastico, D. Caponepone l’accento sulla dimensione pastorale del pensiero <strong>morale</strong> di S.Alfonso come punto di riferimento fondamentale: «Il metodo dellapastoralità ha assunto in lui [S. Alfonso] una forma caratteristica chedeve essere sottolineata, perché lo rende veramente maestro. Se dauna parte la praticità pastorale lo ha portato al singolare tipizzato delcasus e alla concretezza della quotidianità della vita <strong>morale</strong> in ascetica,dall’altra egli, staccandosi dal pragmatismo di altri casisti e maestridi perfezione, si mantiene continuamente nella dialettica risolutiva,non logica nei principia cognoscendi, ma pastorale nei principia essendi,che nel campo <strong>morale</strong> si pongono con valore di finalità. Così incasistica ogni atto è giudicato, meglio è insinuato sottolineando il suovalore di salvezza; in ascetica pastoralmente egli insinua nell’anima laconcretezza di una norma, di un atto virtuoso ma allo stato intensivodi preghiera, o di amore di Dio che risolve in volontà di Dio, anchecome forma ma soprattutto come fine ultimo, tutta la quotidianitàdella vita. Questa risoluzione non logica ma pastorale nel principio di11 «Academia Alfonsiana. Sermo inauguralis anni academici 1957-58», inAnalecta CSSR 29 (1957) 239-245.
VATICANO II E ACCADEMIA ALFONSIANA NEGLI ULTIMI 50 ANNI 249finalità, meglio nel valore assoluto di finalità, sotto le forme psicologichedella preghiera e dell’amore di Dio, è la MENS caratteristica diS. Alfonso, visibile in ogni sua pagina; questa MENS lo rende veroDoctor, e più ancora: Doctor salutis; perché, come egli dice basandosisulla gerarchia dei valori, che non è estrinseca ma intrinseca alla veritàentitativa ed assoluta, “omnium scientiarum finis nihil aliud essedebet quam salus aeterna” (Prax. Conf. Ed. Gaudé, IV / n. 17). Nonè agnosticismo scientifico, ma sintesi ascensionale della Sapienza cherisolve il molteplice nell’Uno» 12 .Il 2 agosto 1960 l’AA diventa «parte» della Facoltà di Teologiadella Pontificia Università Lateranense, con la possibilità di conferireil dottorato in <strong>teologia</strong> re morali specialiter exculta. Il 29 ottobre,inaugurando l’anno accademico, il Rettore Magnifico, Mons. A. Piolanti,si esprime in questi termini: l’AA «è un vero e proprio Istitutodi <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>, il primo del genere in tutta la storia della Chiesa,che, ispirandosi all’insegnamento di S. Alfonso de Liguori, intendeapprofondire tutti i problemi della vita <strong>morale</strong> nei suoi aspetti naturalie soprannaturali, secondo le istanze del mondo moderno e sottola guida del Magistero della Chiesa» 13 .Scorrendo la programmazione dei primi anni Sessanta apparechiaro che queste istanze di rinnovamento determinano la scelta deicorsi e dei seminari che vengono tenuti in AA 14 . È un rinnovamentoche confluisce e trae nuovo impulso dai lavori del Vaticano II, aiquali l’AA partecipa attivamente. Mi limito a trascrivere il “ricordo”di uno dei maggiori protagonisti della vita dell’AA in quegli anni, ilprof. S. O’Riordan: «Gli stessi testi del Concilio rispecchiano il contributodell’Accademia al rinnovamento conciliare della <strong>teologia</strong><strong>morale</strong>. Porto due esempi tra i tanti che si potrebbero citare. Il primoè il tanto discusso articolo della Gaudium et spes sulla dignità dellacoscienza <strong>morale</strong> dell’uomo (art. 16) nel quale si trova l’insegna-12 «S. Alfonso “Doctor salutis”», dattiloscritto conservato nell’archivio dell’AA,14b.13 D. CAPONE, «Historia», 29.14 Per un quadro sintetico cf. S. MAJORANO, «Cinquan’anni di impegno»,29-35.
250 SABATINO MAJORANOmento del P. Capone su questo argomento. Il secondo è l’intero trattatosulla dignità del matrimonio e della famiglia nel medesimo documento(art. 47-52), dovuto in gran parte agli interventi del P. Häringnelle lunghe discussioni che hanno preceduto la redazione deltesto definitivo» 15 .Non fa perciò meraviglia che negli anni successivi il riferimento alConcilio caratterizza tutto l’insegnamento e la ricerca dell’AA. Anzidall’insieme dei corsi appare con chiarezza che essa ha fatto suo l’auspiciodi B. Häring: «Nutriamo la speranza che il Concilio avrà unaforte ripercussione sull’insegnamento della <strong>morale</strong>, rendendo l’eticaparte integrante dell’intera struttura dell’insegnamento cristiano» 16 .Nel primo articolo degli Statuti, approvati dalla Congregazioneper l’Educazione Cattolica il 30 marzo 1995, viene così delineato ilmodello di <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> a cui tende l’impegno dell’AA: «theologiam<strong>morale</strong>m sub lumine Myster<strong>ii</strong> Christi, ita excolere atque provehere,ut, novis progredientibus aetatis inventis atque culturae instant<strong>ii</strong>sconsideratis, veritas vitae moralis hominis in Historia salutis etChristi Mysterio fundata profundius penetretur; systematice enucleaturet problemata moralia recte investigantur et pro posse solventur,respectu Magister<strong>ii</strong> Ecclesiastici semper habito». Pur proponendosi didare «specialisationem veri nominis in theologia morali», la farà allaluce dell’unità del soggetto della <strong>teologia</strong> e «ratione habita oecumenismi,doctrinarum moralium religionum non christianarum atqueatheismi moderni». Perciò l’insegnamento della <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> riguarderà«eius fontes, principia, methodos, applicationes et omnesscientias cum ipsa connexas, methodo interdisciplinari servata» 17 .15 S. O’RIORDAN, «Il teologo moralista», 51.16 Verso una <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> cristiana, Ed. Paoline, Roma 1967, 28.17 All’inizio dell’Ordo Biennio Accademico 2012-2014, troviamo la seguente sintesi:«L’Accademia Alfonsiana, secondo lo spirito di sant’Alfonso, ha come fine:a) Investigare la <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> alla luce del mistero del Cristo, dal quale tuttoè stato creato e riconciliato; approfondirne la ricerca secondo l’evoluzione deltempo e le necessità del popolo di Dio. b) Formare gli studenti in <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>,nella ricerca intorno alle fonti, ai principi, ai metodi, alle applicazioni della<strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>, alle altre scienze in relazione con la stessa» (Roma 2012, 9-10).
VATICANO II E ACCADEMIA ALFONSIANA NEGLI ULTIMI 50 ANNI 251Una visione unitaria e articolataIl radicamento nel mistero pasquale del Cristo, vertice e fulcro dellastoria della salvezza, permette di dare alla proposta <strong>morale</strong> il respiropropriamente teologico e al tempo stesso la prontezza a farsi caricodella concretezza della vita quotidiana. È questo un dato generalmentecondiviso nella riflessione teologico-<strong>morale</strong> odierna. In fedeltàalla visione <strong>alfonsiana</strong>, l’AA cerca di sottolineare che si tratta soprattuttodi chenosi misericordiosa (copiosa redemptio) e che, perciò, la verità<strong>morale</strong> è sempre e fondamentalmente verità salvifica: va sempreenucleata e proposta in maniera “sanante”, perché destinata a uominie donne segnati dalle conseguenze nefaste del potere del peccato 18 .La dimensione pastorale si svela allora una componente imprescindibile.Il riferimento alla maniera in cui la Gaudium et spes affrontale diverse problematiche diventa un punto di riferimento prezioso.Viene dall’AA concretizzato alla luce della sottolineatura <strong>alfonsiana</strong>sulla praticità della <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>: le affermazioni di principiosono certamente importanti e necessarie, ma non ci si può fermaread esse: occorre incarnarle nella concretezza della vita 19 . È questaincarnazione che, secondo S. Alfonso, rende particolarmente impegnativoil lavoro del moralista e del confessore: la <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>«difficillima evadit propter innumeras casuum circumstantias, ex quibusresolutionum pendet variatio: nam ex circumstantiarum diversitate,diversa applicanda sunt principia; et in hoc difficultas consistit,18 È significativo il fatto che S. Alfonso attribuisca al confessore in quantomedico la comunicazione salutare della verità, ricordando che «dev’egli sì beneinsegnar le verità, ma quelle sole che giovano, non quelle che recano la dannazionea’ penitenti» (Istruzione e pratica pei confessori, cap. XVI, punto VI, n. 110,in Opere, vol. IX, Torino 1861, 415). Per l’approfondimento, rimando a quantoho scritto in Sant’Alfonso Maria de Liguori: il confessore “officio di carità istituito dalRedentore solamente in bene delle anime”, in Chiesa e storia 1 (2011) 285-306.19 «Benché la legge sia certa, non però le circostanze diverse che occorronofanno che la legge ora obblighi ed ora non obblighi; giacché i precetti sono bensìimmutabili, ma alle volte non comandano sotto questa o quella circostanza. Quindi...non vale il dire che le leggi son certe, perché, mutandosi le circostanze de’ casi,si rendono dubbie, e come dubbie non obbligano» (ALFONSO DE LIGUORI, Dell’usomoderato dell’opinione probabile, cap. III, n. 89, Corbetta, Monza 1831, 199).
252 SABATINO MAJORANOcum nequeat id fieri sine magna discussione, vel plurium accuratalectione librorum qui res examinant et dilucidant» 20 .Il percorso di studio proposto dall’AA è sorretto da questi convincimenti.L’approfondimento delle tematiche fondamentali va sempredi pari passo con quello delle problematiche concrete 21 . Le rispostenon possono essere semplicemente dedotte dai principi, ma vanno ritrovatein ascolto costante dell’esperienza: «alla luce del Vangelo edell’esperienza umana» 22 . Per questo si richiede che la <strong>teologia</strong> mo-20 Theologia moralis, lib. VI, tract. IV, cap. II, n. 628, ed. L. Gaudé, III, PoliglottaVaticana, Roma 1909, 652-653. È quanto ricorda anche ai confessori,contestando la posizione di coloro che «dicono che basta, per confessore, possederei principi generali della <strong>morale</strong>, poiché con quelli possono sciogliersi tutt<strong>ii</strong> casi particolari. Chi niega che tutti i casi si hanno da risolvere coi principi?Ma qui sta la difficoltà: in applicare a’ casi particolari i principi che loro convengono.Ciò non può farsi senza una gran discussione delle ragioni che son dall’unae dall’altra parte; e questo appunto è quel che han fatto i moralisti: hanprocurato di chiarire con quali principi debbano risolversi molti casi particolari»(Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero, cap. I, § III, n. 17, CasaMariana, Frigento 1987, 26).21 Nella programmazione, prevista per l’anno accademico 2012-2013, i corsisono così distribuiti: 1 nell’area metodologica, 4 in quella biblica, 4 in quella patristico-storica,10 in quella sistematico-fondamentale e 9 in quella sistematicospeciale,3 in quella antropologico-sistematica e 3 in quella antropologico-empirica.Quanto ai seminari, 5 appartengono all’area biblica, 1 a quella storica, 9 aquella sistematico-fondamentale, 6 a quella sistematico-speciale, 2 a quella antropologico-sistematica,2 a quella antropologico-empirica (Ordo, 43-45 e 79-82).22 Gaudium et spes, n. 46. Resta significativa la “confessione” di S. Alfonso sullasua “conversione” dal probabiliorismo della sua prima formazione: «In seguito,scrive lo stesso Alfonso, nel corso del lavoro missionario, abbiamo scopertoche la sentenza benigna è comunemente sostenuta da numerosissimi uomini digrande onestà e sapienza... Ne abbiamo perciò ponderato accuratamente le ragionie ci siamo accorti che la sentenza rigida non solo ha pochi patroni e seguaci– e questi dediti forse più alle speculazioni che all’ascolto delle confessioni –,ma è anche poco probabile, se si vagliano i principi, e per di più circondata daogni parte da difficoltà, angustie e pericoli. Al contrario abbiamo scoperto che lasentenza benigna è accettata comunemente, è molto più probabile dell’opposta,anzi probabilissima e, secondo alcuni, non senza un fondamento molto grave,moralmente certa» (Dissertatio scholastico moralis pro usu moderato opininis probabilisin concursu probabilioris, in Dissertationes quatuor, Corbetta, Monza 1832, 77-78).
VATICANO II E ACCADEMIA ALFONSIANA NEGLI ULTIMI 50 ANNI 253rale resti in costante dialogo con le scienze 23 , realizzando un attentodiscernimento dei segni dei tempi 24 .È facile cogliere queste istanze nell’articolazione del curriculumper la licenza secondo l’Ordo dell’attuale biennio 25 . Sono cinque leparti o aree in cui risulta distribuito l’insegnamento. La prima concernele problematiche metodologiche con «una ermeneutica, nelloSpirito di Cristo, del senso e del significato <strong>morale</strong> sia dei fatti e documentidel passato sia dell’epoca contemporanea stessa, per quanto23 Nella visione <strong>alfonsiana</strong> la <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> «generalem notitiam requiritomnium aliarum scientiarum, officiorum et artium» (Theologia moralis, loc cit.).Lo ricordava con le stesse parole al confessore: «l’officio di confessore richiedela conoscenza quasi di tutte l’altre scienze e di tutti gli altri offici ed arti» (Praticadel Confessore, loc.cit.). Quanto alla sua maniera concreta di lavorare scriveva.«Nelle questioni più dubbie non ho sparambiata fatica in osservare gli autori cosìmoderni come antichi, così della benigna come della rigida sentenza... Specialmentepoi mi sono affaticato ad osservare in fonte tutti i testi canonici ches’appartenevano alle materie trattate… Di più nelle controversie più intrigate,non avendo potuto risolvere i miei dubbj colla lettura degli autori, ho procuratodi consigliarmi con diversi uomini dotti. Nella scelta poi delle opinioni hocercato sempre di preferire la ragione all’autorità; e prima di dare il mio giudizioho procurato di mettermi in una totale indifferenza e di spogliarmi da ognipassione che mi avesse potuto trasportare a difendere qualche opinione non abbastanzasoda» (Risposta a un anonimo, in Apologie e confutazioni, I, Corbetta,Monza 1831, 77-78).24 «È dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarlialla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione,possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vitapresente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna infatti conoscere ecomprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suocarattere spesso drammatico» (Gaudium et spes, n. 4).25 Riguardo al secondo ciclo, viene precisato: «la dottrina è trasmessa e l’investigazionepersonale condotta in modo analitico e sintetico in vista di una specializzazione,in senso stretto, in <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>. Questa specializzazione non èmonografica, come sarà nel 3° ciclo, perché in forza della sua natura la <strong>teologia</strong><strong>morale</strong> riassume i grandi temi della <strong>teologia</strong> (biblica, dogmatica, <strong>morale</strong>, spirituale,ecc.) affinché, alla luce del mistero del Cristo, la visione sintetica del candidatoal grado di 2° ciclo sia più profonda e più feconda “per la vita del mondo”.In questo ciclo hanno prevalenza le lezioni ed i seminari» (Ordo, 12).
254 SABATINO MAJORANOè protesa al futuro» e con «una metodologia tecnica per la ricerca e lacomposizione di un lavoro scientifico».La parte biblica «presenta i principi e i grandi temi della vita <strong>morale</strong>,per quanto si possano enucleare a partire dall’Antico e dal NuovoTestamento». Quella patristico-storica «tratta della dottrina <strong>morale</strong>,dapprima come è stata elaborata e tramandata dai Padri (patristica) edagli scrittori ecclesiastici, e poi della sua evoluzione nei secoli, sia neicostumi e culture dei popoli, sia nelle opere degli scrittori (storia)».Nella parte sistematica vengono approfonditi «i principi teologicie antropologici della <strong>morale</strong>» (<strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> fondamentale) e gli«argomenti di grande importanza» (<strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> speciale).Nella parte antropologica lo studio viene polarizzato sulla «verità<strong>morale</strong> della persona umana e dell’umanità sia teoricamente, sia storicamente»(antropologia sistematica filosofica) e sulle «scienze moralida un punto di vista biologico, sociologico, medico, sociale, socio-culturale,politico, economico, ecc.» (antropologia empirica) 26 .Nel piano di studio occorre che corsi e seminari delle diverse areeo parti siano presenti in modo da facilitare la visione globale del sapere<strong>morale</strong>. I 19 corsi, previsti per il conseguimento della licenza,dovranno comprendere un corso di metodologia, due della parte biblica(uno dell’Antico e l’altro del Nuovo Testamento), due di quellapatristico-storica (uno di patristica e uno di storia), quattro della partesistematica (due di fondamentale e due di speciale), due della parteantropologica (uno di sistematica filosofica e uno di antropologiaempirica). Gli altri otto sono lasciati alla «libera scelta» dello studente«purché non tutti nella stessa “sezione”» 27 .Negli ultimi anni questa articolazione per aree o parti è stata ulteriormentearricchita con l’introduzione di indirizzi di studio più spe-26 Ivi, 15-16.27 Ordo, 17. Credo sia degno di nota il fatto che nel programma dell’AA non sidiano corsi obbligatori, tranne quello iniziale di metodologia. La determinazioneconcreta del piano di studio è affidata allo studente con l’aiuto di un consulente,scelto dallo stesso studente, che deve garantire della sua completezza e organicità:«La definizione del piano di studio sarà fatta con l’aiuto e l’approvazione delConsulente Accademico, rispettando le indicazioni del regolamento» (ivi, 12).
VATICANO II E ACCADEMIA ALFONSIANA NEGLI ULTIMI 50 ANNI 255cifici, nel contesto sempre di una formazione integrale: «Nel rispettodi questa formazione globale, gli studenti che lo desiderano possonoaccentuare nel loro curriculum un indirizzo più specifico (<strong>morale</strong>fondamentale, bioetica, <strong>morale</strong> sociale). L’indirizzo scelto verràsegnalato sul Diploma di licenza» 28 .Per una effettiva maturità delle coscienzeIl radicamento nel mistero di Cristo, visto soprattutto come chenosimisericordiosa, porta l’AA ad accentuare la dimensione di ministerialitàpropria di ogni riflessione teologica 29 . In continuità con leprospettive alfonsiane, assume la chenosi pasquale come via (cf. Gv14,6) secondo la quale articolare la proposta <strong>morale</strong> 30 .Fin dai primi anni, la prospettiva ministeriale ha spinto l’AA a porsial servizio delle giovani chiese dei paesi africani e asiatici e di quelledei paesi dell’Est europeo sotto il giogo del socialismo reale per laformazione dei futuri docenti di <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>. Questo ha comportatolo sviluppo di un’accoglienza retta dalla consapevolezza delledifficoltà reali, vissute dai giovani nella loro prima formazione, perpoterli aprire gradualmente alle esigenze della ricerca scientifica. Èstato e continua ad essere un impegno faticoso, ma indispensabile peril futuro della Chiesa. Del resto l’AA in questo è convinta di dovercontinuare la scelta fondamentale di S. Alfonso per gli abbandonati:«coloro che, come si legge nelle Costituzioni della CSSR, non hanno28 Ivi, 12.29 «I teologi, ricorda la Commissione Teologica internazionale, hanno ricevutouna particolare chiamata al servizio nel corpo di Cristo. Per questa chiamatae per i doni ricevuti sono in un rapporto particolare con il corpo e tutti isuoi membri» (La <strong>teologia</strong> oggi, n. 94; cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINADELLA FEDE, Donum veritatis, n. 6-7).30 Cf. S. MAJORANO, «Kénosis y verdad moral: el significado de la visión <strong>alfonsiana</strong>»,in M. RUBIO – V. GARCIA – V. GÓMEZ MIER (eds.), La ética cristianahoy: horizontes de sentido. Homenaje a Marciano Vidal, Ed. Perpetuo Socorro –Instituto Superior de Ciencias Morales, Madrid 2003, 193-211.
256 SABATINO MAJORANOpotuto avere ancora dalla Chiesa mezzi sufficienti di salvezza; coloroche non hanno ascoltato mai il suo messaggio, o non lo ascoltano piùcome “buona novella”; e infine coloro che sono danneggiati dalla divisionedella Chiesa» (n. 3).La chenosi misericordiosa esige però che la visione stessa di <strong>teologia</strong><strong>morale</strong> venga caratterizzata dalla diaconia. Vale in maniera particolareper la <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> l’affermazione di Giovanni Paolo II sulladiaconia della Chiesa alle coscienze: «La Chiesa si pone solo e sempreal servizio della coscienza, aiutandola a non essere portata qua elà da qualsiasi vento di dottrina secondo l’inganno degli uomini (cf.Ef 4,14), a non sviarsi dalla verità circa il bene dell’uomo, ma, specialmentenelle questioni più difficili, a raggiungere con sicurezza laverità e a rimanere in essa» 31 . Lo stesso vale per la maniera con laquale questa diaconia va articolata: «Quest’opera della Chiesa trovail suo punto di forza – il suo “segreto” formativo – non tanto neglienunciati dottrinali e negli appelli pastorali alla vigilanza, quanto neltenere lo sguardo fisso sul Signore Gesù. La Chiesa ogni giornoguarda con instancabile amore a Cristo, pienamente consapevole chesolo in lui sta la risposta vera e definitiva al problema <strong>morale</strong>» 32 .Sullo sfondo di queste affermazioni è possibile cogliere la sceltadecisiva della Gaudium et spes: «il santo Concilio, proclamando lagrandezza somma della vocazione dell’uomo e la presenza in lui diun germe divino, offre all’umanità la cooperazione sincera dellaChiesa, al fine d’instaurare quella fraternità universale che corrispondaa tale vocazione. Nessuna ambizione terrena spinge la Chiesa;essa mira a questo solo: continuare, sotto la guida dello Spiritoconsolatore, l’opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo arendere testimonianza alla verità, a salvare e non a condannare, a serviree non ad essere servito» 33 .31 Veritatis splendor, n. 64.32 Ivi, n. 85.33 Gaudium et spes, n. 3. È una diaconia da vivere nella reciprocità: «Come èimportante per il mondo che esso riconosca la Chiesa quale realtà sociale dellastoria e suo fermento, così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevutodalla storia e dall’evoluzione del genere umano. L’esperienza dei secoli passati, il
VATICANO II E ACCADEMIA ALFONSIANA NEGLI ULTIMI 50 ANNI 257Credo che la visione ministeriale della <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>, sviluppatadall’AA, è ben sintetizzata dalle parole con cui B. Häring apriva la suaultima opera sintetica di <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>: «La <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> non riguardainnanzitutto la decisione <strong>morale</strong> singola o gli atti singoli. Suocompito e scopo basilare è quello di aiutare a raggiungere la giusta visione,di fissare le prospettive fondamentali e di presentare quelle veritàe quei valori che dovrebbero poi condurre alle decisioni da prenderedavanti a Dio… Il lettore deve tener presente che l’autore nonsegue la corrente di coloro che praticamente riducono la <strong>teologia</strong><strong>morale</strong> a “etica normativa”. Mia intenzione primaria è di formare unamentalità cristiana a quella visione profonda che è essenziale per lamaturità cristiana» 34 .Il riferimento al progetto formativo che Presbyterorum ordinis proponeai presbiteri, in quanto «educatori nella fede», viene spontaneo:occorre che «ciascuno dei fedeli sia condotto nello Spirito Santo asviluppare la propria vocazione personale secondo il Vangelo, a praticareuna carità sincera e attiva, a esercitare quella libertà con cuiCristo ci ha liberati». Senza un tale respiro formativo «di ben pocautilità saranno le cerimonie più belle o le associazioni più fiorenti, senon sono volte a educare gli uomini alla maturità cristiana». A questofine occorre che i presbiteri aiutino i fedeli «a diventare capaci dileggere negli avvenimenti stessi – siano essi di grande o di minoreportata – quid res exigant, quae sit Dei voluntas» e a «non vivere egoisticamentema secondo le esigenze della nuova legge della carità, laquale vuole che ciascuno amministri in favore del prossimo la misu-progresso della scienza, i tesori nascosti nelle varie forme di cultura umana, attraversocui si svela più appieno la natura stessa dell’uomo e si aprono nuove vieverso la verità, tutto ciò è di vantaggio anche per la Chiesa… Anzi, la Chiesa confessache molto giovamento le è venuto e le può venire perfino dall’opposizionedi quanti la avversano o la perseguitano» (n. 44).34 Liberi e fedeli n Cristo, I, San Paolo, Cinisello Balsamo 1987 3 , 18. Vi ritornain seguito: «la <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> cristiana è più di un’etica normativa; è la <strong>teologia</strong>della vita in Cristo Gesù, uno sforzo per giungere alla piena intelligenza diciò che significa sequela per i cristiani e per il mondo. Comunque l’etica normativacostituisce una parte indispensabile della <strong>morale</strong> cristiana» (400).
258 SABATINO MAJORANOra di grazia che ha ricevuto e che in tal modo tutti assolvano cristianamentei propri compiti nella comunità umana» 35 .Il riferimento alle indicazioni conciliari viene sviluppato dall’AAfacendo propria la visione <strong>alfonsiana</strong> della centralità della coscienza.Basta ricordare le parole iniziali della Theologia moralis del Santo. Lacoscienza è «aditus ad universam <strong>morale</strong>m Theologiam», perché èregola formale dell’agire umano: «Duplex est regula actuum humanorum;una dicitur remota, altera proxima. – Remota, sive materialis, estlex divina; proxima vero, sive formalis, est conscientia: quia, licet conscientiain omnibus divinae legi conformari debeat, bonitas tamenaut malitia humanarum actionum nobis innotescit, prout ab ipsa conscientiaapprehenditur» 36 .È una circolarità che deve ispirare tutto il cammino della <strong>teologia</strong><strong>morale</strong>. La verità <strong>morale</strong> va proposta in maniera che venga riconosciutacome tale dalla coscienza: le stesse «esigenze etiche» della leggenaturale, scriveva Giovanni Paolo II, «non si impongono alla volontàcome un obbligo, se non in forza del riconoscimento previodella ragione umana e, in concreto, della coscienza personale» 37 . Seinfatti la <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> deve affermare con forza che la ricerca e l’adesionealla verità sono essenziali per la dignità della coscienza, deveugualmente affermare che esse sono «doveri» che «attingono e vincolanola coscienza degli uomini» 38 .35 Presbyterorum ordinis, n. 6. È un progetto formativo in sintonia con la descrizionedella condizione battesimale sintetizzata in Lumen Gentium: «Questopopolo messianico ha per capo Cristo… Ha per condizione la dignità e la libertàdei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio.Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati(cf. Gv 13,34). E finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terradallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secolisia da lui portato a compimento» (n. 9).36 Theologia moralis, lib. I, tract. I, Monitum e, cap. I, n. 1, ed. L. Gaudé, I,Poliglotta Vaticana, Roma 1905, 3.37 Veritatis splendor, n. 36; cf. S. MAJORANO, «Il riconoscimento previo dellacoscienza», in F. ATTARD – P. CARLOTTI, Teologia e pastorale in dialogo. Studi inonore del prof. Guido Gatti, Las, Roma 2002, 183-197.38 Dignitatis humanae, n. 1. Il Concilio poi afferma: «L’uomo coglie e riconoscegli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza, che è tenuto a se-
VATICANO II E ACCADEMIA ALFONSIANA NEGLI ULTIMI 50 ANNI 259Una <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong>, che riconosce la profondità e il ruolo “formale”della coscienza, permette di ridare significatività vera all’imperatività<strong>morale</strong>, riconducendola all’amore: «Nell’intimo della coscienzal’uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla qualeinvece deve obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad amare,a fare il bene e a fuggire il male, al momento opportuno risuona nell’intimitàdel cuore: fa questo, evita quest’altro. L’uomo ha in realtàuna legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità stessadell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato… Tramite la coscienzasi fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suocompimento nell’amore di Dio e del prossimo» 39 .Le due encicliche di Benedetto XVI sulla carità (Deus caritas est eCaritas in veritate) sono stimoli preziosi per l’ulteriore approfondimento.Mi limito solo a ricordare l’insistenza sulla priorità dell’amoredi Dio: «Egli per primo ci ha amati e continua ad amarci per primo;per questo anche noi possiamo rispondere con l’amore. Dio nonci ordina un sentimento che non possiamo suscitare in noi stessi. Eglici ama, ci fa vedere e sperimentare il suo amore e, da questo “prima”di Dio, può come risposta spuntare l’amore anche in noi» 40 .Credo che la <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> debba dire con maggiore chiarezzaquesto “prima” dell’amore di Dio come esigenza e fondamento dellarisposta dell’uomo. Questo le permetterà di aiutare gli uomini di oggia riscoprire il “perché” del bene e di contribuire all’impegno dinuova evangelizzazione, prioritario per tutta la comunità cristiana.La visione di S. Alfonso è stimolante al riguardo. Egli infatti riconducetutta la vita cristiana all’amore: «Tutta la santità e la perfe-guire fedelmente in ogni sua attività per raggiungere il suo fine che è Dio. Non sideve quindi costringerlo ad agire contro la sua coscienza. E non si deve neppureimpedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso» (n. 3).39 Gaudium et spes, n. 16.40 Deus caritas est, n. 17. Nel paragrafo seguente il Papa aggiunge: «Amore diDio e amore del prossimo sono inseparabili, sono un unico comandamento. Entrambiperò vivono dell’amore preveniente di Dio che ci ha amati per primo.Così non si tratta più di un “comandamento” dall’esterno che ci impone l’impossibile,bensì di un’esperienza dell’amore donata dall’interno, un amore che,per sua natura, deve essere ulteriormente partecipato ad altri» (n. 18).
260 SABATINO MAJORANOzione di un’anima consiste nell’amare Gesù Cristo nostro Dio, nostrosommo bene e nostro Salvatore». Si tratta però di amore chescaturisce dall’esperienza e dalla memoria dell’anticipo di amore, cheDio non si stanca di farci in Cristo: il Redentore «ci amò e, perché ciamava, si diede in mano de’ dolori, dell’ignominie e della morte piùpenosa che abbia patito alcun uomo sovra la terra. Quindi ebbe a direil grande amante di Gesù Cristo, S. Paolo: Caritas... Christi urgetnos (2Cor 5,14). E volle dire l’Apostolo che non tanto ciò che ha patitoGesù Cristo, quanto l’amore che ci ha dimostrato nel patire pernoi, ci obbliga e quasi ci costringe ad amarlo» 41 .La prospettiva allora non potrà essere altra che quella della santità:«È un grande errore poi quel che dicono alcuni: Dio non vuol tuttisanti. No, dice S. Paolo: Haec est... voluntas Dei, sanctificatio vestra(1Ts 4,3). Iddio vuol tutti santi, ed ognuno nello stato suo, il religiosoda religioso, il secolare da secolare, il sacerdote da sacerdote, ilmaritato da maritato, il mercadante da mercadante, il soldato da soldato,e così parlando d’ogni altro stato» 42 .ConclusioneNell’Instrumentum laboris del recente Sinodo dei Vescovi, dopoaver ricostruito sinteticamente gli «scenari» che caratterizzano ilmondo attuale, si osserva: «l’esame di questi scenari permette di fare41 Pratica di amar Gesù Cristo, cap. 1, n. 1 e 7-8, in Opere ascetiche, I, Sant’Alfonso,Roma 1933, 1 e 5. Dovrà essere questo l’impegno centrale di chi evangelizza:«da noi non si parla d’altro che della passione del Redentore, affin di lasciarele anime legate con Gesù Cristo». Occorre infatti «persuadersi che leconversioni fatte per lo solo timore de’ castighi divini son di poca durata... senon entra nel cuore il santo amore di Dio, difficilmente persevererà». Perciò«l’impegno principale del predicatore nella missione ha da esser questo, di lasciarein ogni predica che fa i suoi uditori infiammati del santo amore» (Fogliettoin cui si tratta brevemente di cinque punti su de’ quali nelle missioni deve il predicatoreavvertire il popolo di più cose necessarie al comun profitto, in Opere, III, Marietti,Torino 1847, 288-289).42 Pratica di amar, cap. 8, n. 10, 79.
VATICANO II E ACCADEMIA ALFONSIANA NEGLI ULTIMI 50 ANNI 261una lettura critica degli stili di vita, del pensiero, dei linguaggi propostiattraverso di essi. Questa lettura serve anche come autocriticache il cristianesimo è invitato a fare su di sé, per verificare quanto ilproprio stile di vita e l’azione pastorale delle comunità cristiane sianostate realmente all’altezza del loro compito evitando l’immobilismoattraverso una attenta lungimiranza» (n. 68).Si tratta di un discernimento al quale la <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> deve contribuirein maniera convinta. L’obiettivo è una proposta <strong>morale</strong> cheporti a «rinnovare noi stessi, per rendere presente con maggiore incisivitànel mondo in cui viviamo la speranza e la salvezza donataci daGesù Cristo. Si tratta di imparare un nuovo stile, di rispondere “condolcezza e rispetto, con una retta coscienza” (1Pt 3,16). È un invito avivere con quella forza mite che ci viene dalla nostra identità di figlidi Dio, dall’unione con Cristo nello Spirito, dalla novità che questaunione ha generato in noi, e con quella determinazione di chi sa diavere come meta l’incontro con Dio Padre, nel suo Regno» (n. 118).Il cammino finora compiuto deve essere di stimolo per l’AA a contribuirecostruttivamente a queste nuove sfide, continuando semprea lasciarsi guidare dalle prospettive delineate dal Vaticano II e dalleintuizioni alfonsiane, sviluppandole alla luce dei segni dei tempi.
262 SABATINO MAJORANOSUMMARIESThe research and teaching of the Alphonsian Academy appear as supportedby three fundamental aspirations: the actualization of the moral and pastoralproposal of Saint Alphonsus, the fidelity to the renewal aspirations of the SecondVatican Council, and the practicality which is the fruit of an attentive listeningto the signs of the times. From these emerge a moral theology that, indialogue with other disciplines, aims at placing itself at the service of the fullmaturing of consciences and consequently capable of contributing to thechallenges of the new evangelization.* * *La investigación y la enseñanza de la Academia Alfonsiana aparecen orientadaspor tres instancias fundamentales: la actualización de la propuesta moraly pastoral de San Alfonso, la fidelidad a las instancias renovadoras del VaticanoII, la practicidad como fruto de la escucha atenta a los signos de lostiempos. De ahí surge una teología moral que, en diálogo con las otras disciplinas,tiende a servir a la madurez integral de las conciencias y, por eso, estáen capacidad de colaborar a los desafíos de la nueva evangelización.* * *La ricerca e l’insegnamento dell’Accademia Alfonsiana appaiono retti da treistanze fondamentali: l’attualizzazione della proposta <strong>morale</strong> e pastorale di S.Alfonso, la fedeltà alle istanze di rinnovamento del Vaticano II, la praticità fruttodi un ascolto attento dei segni dei tempi. Ne deriva una <strong>teologia</strong> <strong>morale</strong> che,in dialogo con le altre discipline, mira a porsi al servizio della maturazione pienadelle coscienze e perciò capace di contribuire alle sfide della nuova evangelizzazione.