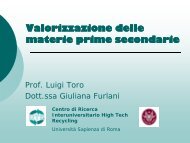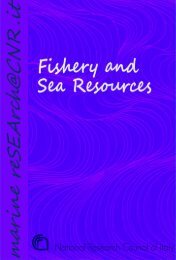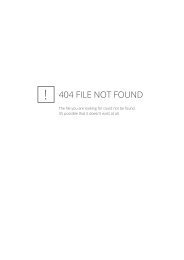Riscaldamento delle acque profonde nei laghi italiani: un ... - CNR
Riscaldamento delle acque profonde nei laghi italiani: un ... - CNR
Riscaldamento delle acque profonde nei laghi italiani: un ... - CNR
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Clima e cambiamenti climatici: le attività di ricerca del <strong>CNR</strong><br />
p<strong>un</strong>to <strong>un</strong> programma (LIMNOX), che ha permesso<br />
di determinare la distribuzione metro<br />
per metro dalla superficie al fondo del contenuto<br />
di calore, nonché della stabilità e del lavoro<br />
del vento anche negli altri <strong>laghi</strong> profondi<br />
della zona pre-alpina (Orta, Como, Iseo e<br />
Garda) dove sono già evidenti sintomi di variabilità<br />
legati ai mutamenti climatici. Inoltre<br />
attraverso <strong>un</strong> modello matematico CFD<br />
(Computational Fluid Dynamics) si è eseguita<br />
<strong>un</strong>a simulazione dell’idrodinamica lacustre a<br />
partire dallo scambio energetico entro il lago e<br />
con l’atmosfera (Ambrosetti et al., 2006).<br />
3 RISULTATI<br />
Valutate le quantità energetiche in gioco <strong>nei</strong><br />
processi di stratificazione e destratificazione<br />
termica, nonché le profondità di mescolamento<br />
invernale (determinanti per identificare gli<br />
strati di lago potenzialmente interessati al ricambio<br />
idrico), si è visto che negli ultimi 50<br />
anni e, in particolare, a partire dalla metà<br />
degli anni ottanta è aumentata sensibilmente<br />
la stabilità della massa d’acqua e si sono ridotte<br />
le profondità raggi<strong>un</strong>te dal mescolamento<br />
convettivo invernale proprio nel momento<br />
in cui nel lago viene a formarsi la cosiddetta<br />
“massa d’acqua nuova”. All’incremento del<br />
lavoro necessario alla piena circolazione <strong>delle</strong><br />
<strong>acque</strong>, per l’aumento di temperatura entro<br />
tutta la colonna d’acqua, si è affiancato <strong>un</strong> minore<br />
effetto destabilizzante invernale esercitato<br />
dall’azione <strong>delle</strong> forze esterne. È quindi venuta<br />
a mancare l’energia cinetica necessaria al<br />
processo di destratificazione che è progressivamente<br />
diminuita nell’ultimo ventennio.<br />
Le profondità di mescolamento verticale<br />
(Fig. 1), essenzialmente dovute ai movimenti<br />
convettivi innescati durante la fase di raffreddamento<br />
sono state valutate nel Lago<br />
Maggiore per il periodo 1951-2007 sulla base<br />
della distribuzione verticale della temperatura<br />
dell’acqua, <strong>delle</strong> concentrazioni di ossigeno<br />
disciolto, di nitrati e silicati utilizzati come<br />
traccianti; è stata anche messa a p<strong>un</strong>to <strong>un</strong>a<br />
formulazione che individua le forze meteorologiche<br />
che intervengono nel processo e cioè<br />
Figura 1. Profondità di mescolamento verticale <strong>delle</strong><br />
<strong>acque</strong> del Lago Maggiore per moti convettivi alla fine<br />
dell’inverno limnologico nel periodo 1963-2007.<br />
la quantità giornaliera di vento filato, la differenza<br />
fra le temperature medie giornaliere<br />
dell’acqua superficiale e dell’aria e la radiazione<br />
solare attraverso <strong>un</strong> parametro M.<br />
(Ambrosetti e Barbanti, 1999).<br />
Come si può osservare in Figura 1 ad <strong>un</strong> ciclo<br />
di 7 anni riscontrabile sino al 1970 è succeduto<br />
<strong>un</strong> periodo di 36 anni nel quale lo strato<br />
mescolato invernale per moti convettivi non<br />
ha superato i 200 metri di profondità. Da sottolineare<br />
il fatto che la piena circolazione del<br />
1956 è avvenuta con <strong>un</strong>a temperatura dell’acqua<br />
su tutta la colonna di 5,8 °C, mentre nel<br />
1963 è stata di 5,9 °C e nel 1970 di 6,0 °C; il<br />
processo è avvenuto nel 2006 a 6,22°C. Con<br />
l’uso della stepwise multiple regression si è<br />
potuto verificare che il parziale mescolamento<br />
degli anni dal 1970 al 1980 fu dovuto principalmente<br />
ad <strong>un</strong>a diminuzione di vento filato<br />
sulla superficie del lago mentre nella seconda<br />
fase (1987-2006) esso è invece da accreditare<br />
ad <strong>un</strong> incremento della temperatura dell’aria<br />
rispetto a quella dell’acqua superficiale. E’<br />
<strong>un</strong>a prima constatazione del fatto che nel<br />
corso di questi ultimi 50 anni si è verificato <strong>un</strong><br />
notevole accumulo di calore entro tutta la<br />
massa d’acqua del Lago Maggiore negli anni<br />
dal 1963 al 2006: il suo andamento mostra la<br />
presenza di <strong>un</strong> evidente ciclo stagionale molto<br />
netto ed <strong>un</strong> trend generale in ascesa (Fig. 2).<br />
Sulla base <strong>delle</strong> profondità raggi<strong>un</strong>te dal mescolamento<br />
verticale al termine dell’anno limnologico,<br />
del bilancio termico annuo, nonché<br />
della distribuzione l<strong>un</strong>go la verticale del contenuto<br />
calorico e del rapporto tra il logaritmo<br />
602