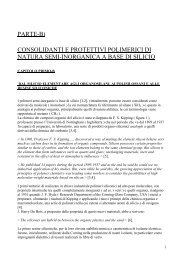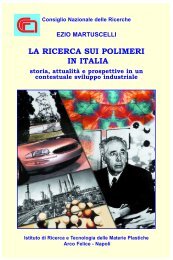L'ISTITUTO DI RICERCA E TECNOLOGIA DELLE ... - ezio martuscelli
L'ISTITUTO DI RICERCA E TECNOLOGIA DELLE ... - ezio martuscelli
L'ISTITUTO DI RICERCA E TECNOLOGIA DELLE ... - ezio martuscelli
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PARTE II<br />
L’ISTITUTO <strong>DI</strong> <strong>RICERCA</strong> E <strong>TECNOLOGIA</strong><br />
<strong>DELLE</strong> MATERIE PLASTICHE DEL CNR.<br />
Il suo ruolo nel sistema di ricerca nazionale<br />
ed internazionale: “a case history”<br />
121
122
CAPITOLO PRIMO<br />
IL LABORATORIO <strong>DI</strong> RICERCHE SU <strong>TECNOLOGIA</strong><br />
DEI POLIMERI E REOLOGIA (LTPR)<br />
Come già precedentemente scritto, il 10 Giugno 1968, il CNR, nel<br />
ristrutturare il “Centro Nazionale di Chimica delle Macromolecole”<br />
(CNCM), istituì a Napoli il “Laboratorio di Ricerche su Tecnologia dei<br />
Polimeri e Reologia” (LTPR), che, di fatto, iniziò la sua attività, a partire<br />
dal 1969. Alla creazione del LTPR contribuirono personalità di grande<br />
spicco del mondo della ricerca scientifica napoletana quali il Prof. Paolo<br />
Corradini, uno dei principali collaboratori del Prof. Giulio Natta, il Prof.<br />
Alfonso Maria Liquori ed il Prof. Giovanni Astarita.<br />
Il LTPR fu allocato, insieme ad altri tre istituti del CNR, ad Arco Felice<br />
(Na). Di fatto questo insieme di istituti rappresentò il primo caso in Italia<br />
di “area della ricerca” (figura 53).<br />
Contribuirono attivamente alla definizione delle linee guida del LTPR<br />
un gruppo di allora giovani ricercatori (Rosario Palumbo, Alfredo Musto,<br />
Natalino Neto, lo scrivente ed altri). L’Autore ricorda ancora oggi le<br />
interminabili riunioni (molte delle quali si tenevano in casa del Prof.<br />
Corradini e spesso finivano con una cena e con una giocata a tressette<br />
oppure al bridge) durante le quali, attraverso un confronto dialettico,<br />
spesso duro, ma sempre costruttivo, furono delineate le linee di intervento<br />
e le caratteristiche di questo nuovo organo del CNR.<br />
Su di un punto fu trovato un accordo unanime: il LTPR doveva avere le<br />
caratteristiche di un moderno centro di ricerca le cui competenze avrebbero<br />
dovuto coprire un ampio spettro della scienza e tecnologia dei polimeri.<br />
Questo concetto fu recepito dall’allora Comitato per le Scienze<br />
Chimiche e dagli organi deliberanti del CNR, come traspare dagli obiettivi<br />
primari sanciti dallo Statuto:<br />
"correlare la struttura chimica, la struttura fisica e la morfologia dei materiali<br />
polimerici con proprietà termodinamiche, termiche, meccaniche e reologiche,<br />
al fine di definire un “sistema di relazioni tra proprietà e struttura dei<br />
materiali polimerici” e quindi sviluppare una serie di studi tendenti al<br />
123
miglioramento di proprietà tecnologiche ed applicative dei materiali polimerici".<br />
In particolare il piano di ricerca, contenuto nello statuto, prevedeva le<br />
seguenti tematiche:<br />
- Sterochimica di complessi metallorganici e macromolecole sintetiche.<br />
- Relazioni tra proprietà, struttura e morfologia di polimeri sintetici.<br />
- Ricerche sul comportamento reologico di polimeri fusi e in soluzione.<br />
Indagini teorico-sperimentali sulla connessione tra comportamento<br />
reologico macroscopico e struttura microscopica.<br />
- Indagini sulla struttura del moto turbolento di liquidi con caratteristiche<br />
reologiche particolari e sui fenomeni di trasporto di calore e<br />
di materia.<br />
- Indagini sulla reologia e fluodinamica di sistemi plurifasici: schiume,<br />
fanghi, sospensioni, emulsioni, polveri e solidi granulati.<br />
Fig. 53: La sede “provvisoria” di Arco Felice dove ha trovato collocazione il laboratorio<br />
di Ricerche su Tecnologia dei Polimeri e Reologia del CNR, trasformato successivamente<br />
in “Istituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche”.<br />
124
Nell’individuazione di queste tematiche si dovette, all’epoca, necessariamente<br />
tenere in debita considerazione il fatto che alla costituzione del<br />
LTPR contribuirono due scuole, una di tipo chimica, facente capo<br />
all’Istituto Chimico della facoltà di scienze e l’altra di estrazione ingegneristica<br />
che afferiva all’Istituto di Ingegneria Chimica della facoltà di<br />
ingegneria. Questo dualismo trovò conferma nella composizione del<br />
primo Consiglio Scientifico (CS) (figura 54). Il Prof. Paolo Corradini fu<br />
nominato Presidente del CS. Il Prof. Alberto Ciferri venne chiamato a<br />
svolgere le funzioni di Direttore.<br />
Il laboratorio, inizialmente, attraversò una delicata fase di assestamento<br />
che si concluse con l’allontanamento della componente ingegneristica.<br />
Questa fase ebbe fine nel 1973 con la nomina dello Scrivente, prima a<br />
Commissario e quindi a Direttore [63]. Le fotografie riportate nella figura<br />
55, che si riferiscono al 1978, raffigurano giovani ricercatori, tecnici e<br />
studenti intenti a svolgere attività di sperimentazione su sofisticati macchinari<br />
locati presso i vari laboratori dell’ LTPR. Una fotografia del<br />
nucleo storico di ricercatori, tecnici ed amministrativi, a cui si deve la<br />
realizzazione culturale e scientifica del LTPR e il suo definitivo consoli-<br />
Membri Esterni<br />
GIOVANNI ASTARITA (fino al 1970)<br />
Istituto di principi di Ingegneria Chimica<br />
Università di Napoli<br />
ENZO BUTTA (dal 1971)<br />
Istituto di Chimica Industriale ed Applicata<br />
Facoltà di Ingegneria - Università di Pisa<br />
PAOLO CORRA<strong>DI</strong>NI<br />
Istituto Chimico, Facoltà di Scienze<br />
Università di Napoli<br />
MARIO BRUZZONE<br />
SNAM Progetti - S. Donato Milanese<br />
WALTER CONTI (dal 1973) GIOVANNI PEZZIN (fino al 1973)<br />
SNAM Progetti - S. Donato Milanese<br />
Montedison S.p.A. - Porto Marghera<br />
Membri Interni<br />
ALBERTO CIFERRI, Direttore (fino al 1970)<br />
FRANCESCO DE CAN<strong>DI</strong>A (dal 1970)<br />
EZIO MARTUSCELLI (fino al 1970) dal 1972 Commissario<br />
ALFREDO MUSCO (fino al 1970)<br />
ROSARIO PALUMBO (dal 1970)<br />
Fig. 54: Composizione del Primo Consiglio Scientifico del LTPR-CNR (1969-1974).<br />
125
126<br />
damento, è riprodotta nella figura 56 (anno 1979). Molti dei personaggi<br />
rappresentati in questa figura fanno parte dell’attuale staff dell’IRTeMP<br />
ricoprendo ruoli di grande responsabilità.<br />
Dopo circa dieci anni di attività le ricerche che si svolgevano nell’ambito<br />
del LTPR erano riconducibili alle seguenti tematiche:<br />
- Correlazioni tra paramentri morfologici e termodinamici di polimeri<br />
sintetici cristallizzati da soluzioni diluite, dal fuso e allo stato<br />
di fibre orientate.<br />
- Studio dello stato ordine-disordine nei cristalli singoli di polimeri<br />
mediante reazioni chimiche degradative.<br />
- Influenza dei difetti di catena di tipo costituzionale e configurazionale<br />
sulla morfologia e sulle proprietà termodinamiche di polimeri<br />
semicristallini.<br />
- Sintesi e caratterizzazione di polimeri di condensazione modificati.<br />
- Proprietà fisiche di sistemi elastomerici.<br />
- Studio delle proprietà meccaniche e di trasporto di materiali polimeri<br />
semicristallini.<br />
- Studio mediante tecniche roentgenografiche della struttura e dell’<br />
ordine a livello supermolecolare di elastomeri e di sistemi amorfi.<br />
- Studio della diffusione dei raggi X a basso angolo di catalizzatori<br />
Ziegler-Natta in matrici polimeriche.<br />
- Studio dell’effetto della temperatura sulla resistività elettrica di<br />
compositi metallo-polimero.<br />
- Sintesi e caratterizzazione di copolimeri aventi applicazione biomedica<br />
come materiali antitrombogenici.<br />
- Proprietà viscoelastiche di polimeri amorfi.<br />
- Studio di transizioni vetrose in polimeri semicristallini.<br />
- Preparazione, caratterizzazione termodinamica, meccanica e<br />
morfologica di leghe polimeriche [63].
Fig. 55a<br />
Fig. 55b<br />
Fig. 55: Fotografie scattate intorno al 1978 che documentano la fase di consolidamento<br />
dell’allora LTPR attraverso l’acquisizione di sofisticate apparecchiature e la formazione<br />
di giovani ricercatori e tecnici. a) e b): Il Laboratorio di Proprietà Meccaniche; c),<br />
d), e): Il Laboratorio di Microscopia Elettronica ed ottica.<br />
127
Fig. 55c<br />
Fig.55e<br />
Fig. 55d<br />
128
Fig. 55f<br />
Fig. 55g<br />
Fig. 55:<br />
f) Il Laboratorio di Diffrazione dei Raggi X.<br />
g) Il Laboratorio di Calorimetria Differenziale a Scansione [Rif. 63].<br />
129
130<br />
Fig. 56: Il nucleo “storico” di ricercatori e tecnici dell’LTPR (foto scattata in occasione del “First Italian-Polish Seminar on Multicomponent<br />
Polymer Sistems” Capri- 16-21 October 1979). Sono presenti anche alcuni docenti del dipartimento di chimica dell’università di Napoli.<br />
Accosciati da sinistra a destra: M. Malinconico, R.Greco, A. Sirigu, G. Maglio, G. Demma;<br />
In piedi da sinistra: R. Ragosta, N. Lanzetta, F. Calandrelli, C. Marchetta, E. Martuscelli, G. Avitabile, A. Botta, C. Silvestre, E. Scafora, M.<br />
C. Carelli, E. Mansi Forlani, M. Pracella, R. Palumbo.
CAPITOLO SECONDO<br />
L’ISTITUTO <strong>DI</strong> <strong>RICERCA</strong> E <strong>TECNOLOGIA</strong> <strong>DELLE</strong><br />
MATERIE PLASTICHE (IRTeMP)<br />
a) Struttura, funzioni ed attività.<br />
In data 20 Dicembre 1979 (provvedimento n. 1864) il Laboratorio di<br />
Ricerche su Tecnologia dei Polimeri e Reologia fu trasformato in Istituto<br />
(ITPR). Successivamente con DPCNR n. 12645 del 17/12/1993 la denominazione<br />
dell’Istituto di Ricerche su Tecnologia dei Polimeri e Reologia<br />
veniva modificata in:<br />
“Istituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche” (IRTeMP)<br />
Il decreto prevedeva un nuovo Statuto con una ridefinizione del piano<br />
di ricerca e degli obiettivi che risultavano essere così riformulati:<br />
"L’Istituto ha lo scopo di svolgere in modo permanente attività di ricerca<br />
programmata nel campo della tecnologia delle materie plastiche in armonia<br />
con i piani generali e le direttive del CNR.<br />
Nell’ambito delle attività di ricerca l’Istituto:<br />
a) intratterrà rapporti di collaborazione con istituzioni scientifiche italiane e<br />
straniere;<br />
b) attuerà accordi di collaborazione, contratti di ricerca e prestazioni per<br />
conto terzi;<br />
c) contribuirà alla formazione ed al perf<strong>ezio</strong>namento del personale scientifico<br />
e tecnico, anche nell’ambito di corsi di laurea e di diploma, di dottorati<br />
di ricerca, di scuole di specializzazione e perf<strong>ezio</strong>namento e di scuole dirette<br />
a fini speciali;<br />
d) organizzerà ed erogherà servizi tecnico-scientifici di alta qualificazione;<br />
e) svolgerà ricerche nel campo della normativa tecnica di competenza;<br />
f) curerà la documentazione scientifico-tecnica di competenza."<br />
Per quanto riguardava l’attività di ricerca venivano ad essere indicate le<br />
seguenti priorità:<br />
i) studio delle metodologie di sintesi e modificazione chimica; ii) studio<br />
delle relazioni struttura molecolare-proprietà; iii) studio delle caratteristiche<br />
chimico fisiche, strutturali, meccaniche e di processo, delle seguenti classi<br />
di polimeri:<br />
√ polimeri con elevata resistenza termomeccanica;<br />
131
√ polimeri termoplastici e termoindurenti modificati con gomme;<br />
√ nuove leghe polimeriche;<br />
√ compositi rinforzati e modificati, a matrice termoplastica e termoindurente;<br />
√ polimeri liquido-cristallini.<br />
I direttori e commissari, che si sono succeduti alla guida del LTPR<br />
prima, e dell’IRTeMP dopo, sono indicati nella figura 57.<br />
A. CIFERRI (Direttore) dal 1968 al 1970<br />
R. CIPOLLINI (Commissario) dal 1970 al 1971<br />
P. A. TEMUSSI (Commissario) dal 1971 al 1972<br />
E. MARTUSCELLI (Commissario) dal 1972 al 1973<br />
E. MARTUSCELLI (Direttore) dal 1973 ad oggi<br />
Fig. 57: Direttori e Commissari che si sono succeduti alla guida dell’LTPR prima e<br />
dell’IRTeMP dopo.<br />
L’IRTeMP, dall’atto della sua istituzione, si è profondamente trasformato,<br />
innovando costantemente sia il suo assetto organizzativo che gli<br />
argomenti oggetto di ricerca, di formazione e di trasferimento.<br />
Il ventaglio delle attività dell’IRTeMP si è modificato e consolidato in<br />
relazione ad uno scenario di riferimento in base al quale la possibilità di<br />
accedere ai “necessari” finanziamenti straordinari ed esterni (Progetti<br />
Finalizzati, Programmi Quadro dell’UE, Programmi Nazionali del<br />
MURST e Programmi Regionali) era vincolata, sempre di più, ad un “framework”<br />
di tipo “top-down”.<br />
L’insufficienza dei fondi ordinari, generalmente erogati per finanziare<br />
progetti elaborati seguendo una filosofia “bottom up”, ha, in un certo<br />
qualsenso, avuto un risvolto positivo, avendo costretto l’Istituto a “mettersi<br />
sul mercato” e quindi a competere a livello nazionale e internazionale<br />
con istituzioni simili, ma anche a collaborare con esse, al fine di<br />
costituire reti tematiche nazionali e transnazionali, presupposto necessario<br />
per reperire finanziamenti attraverso la partecipazione a programmi<br />
nazionali e comunitari.<br />
Questo nuovo contesto ha richiesto implicitamente che la ricerca fosse<br />
sempre di più finalizzata al “problem solving”, piuttosto che alla produ-<br />
132
zione di un know-how semplicemente conoscitivo.<br />
Gli obiettivi principali delle ricerche svolte nell’ambito dell’IRTeMP,<br />
come riportato nel consuntivo 1998 [64], possono essere così sintetizzati:<br />
- Correlare, struttura molecolare, composizione, struttura fisica e<br />
morfologia, proprietà chimico-fisiche e lavorabilità di materiali<br />
polimerici.<br />
- Realizzare nuovi materiali innovativi a base polimerica (miscele,<br />
leghe, compositi e nuove formulazioni) con caratteristiche mirate<br />
all’utilizzo in settori ad elevato tasso di sviluppo tecnologico<br />
(packaging, beni culturali, auto, aerospaziale, agro-alimentare,<br />
ambiente, ecc.).<br />
L’attività di ricerca, svolta a livello operativo da gruppi omogenei di<br />
ricercatori e tecnici (GOR), supportati da una rete di laboratori tecnicoscientifici,<br />
dove sono concentrate la quasi totalità delle “facilities”<br />
dell’Istituto, è stata incentrata, negli ultimi anni, sulle seguenti tematiche:<br />
- Preparazione e caratterizzazione di copolimeri, compositi e leghe<br />
biocompatibili e/o biodegradabili ottenuti mediante processi di<br />
miscelazione reattiva tra i componenti.<br />
- Sintesi e caratterizzazione di nuovi omopolimeri e copolimeri a<br />
base poliidrazidica con migliorata termoplasticità.<br />
- Sistemi polimerici reattivi a più componenti: studio delle correlazioni<br />
fra la struttura molecolare, la struttura delle fasi e le proprietà<br />
fisico-meccaniche.<br />
- Miscibilità, compatibilità e proprietà di film polimerici a base di<br />
poliolefine di interesse tecnologico.<br />
- Leghe polimeriche cristallizzabili: struttura delle fasi, morfologia<br />
e processi di cristallizzazione.<br />
- Leghe polimeriche a matrice di polipropilene isotattico: reologia<br />
dei fusi, morfologia e struttura, cristallizzazione, compatibilizzazione<br />
e proprietà.<br />
- Studio dei fenomeni interfacciali in compositi a matrice polimerica.<br />
- Correlazione tra organizzazione strutturale e proprietà fisiche di<br />
materiali polimerici.<br />
- Caratterizzazione viscoelastica, reologica ed allo stato solido di<br />
omopolimeri, leghe e materiali polimerici interpenetrati.<br />
- Studio del grado di ordine, a livello superreticolare, in sistemi<br />
133
polimerici prevalentemente amorfi.<br />
- Materiali polimerici e metodologie ecosostenibili per la salvaguardia<br />
e la valorizzazione di beni culturali.<br />
- Nuovi materiali e nuove tecnologie per l’imballaggio alimentare<br />
sostenibile.<br />
L’Istituto ha partecipato e partecipa tuttora con proprie unità operative<br />
(UO) a progetti finalizzati e strategici del CNR e a programmi finanziati<br />
dall’Unione Europea (Progetti Brite, Craft, ecc.), dalla Regione<br />
Campania e dal MURST.<br />
In particolare nell’ambito del progetto finalizzato “Materiali Speciali<br />
per Tecnologie Avanzate II”, sottoprogetto “Materiali polimerici e relativi<br />
compositi”, tre UO sono attive sui seguenti argomenti:<br />
i) multistrati a base polipropilenica per la realizzazione di componenti<br />
di finizione interna in autovetture;<br />
ii) sviluppo di sistemi polimerici multicomponenti a base poliammidica<br />
e poliestere per la realizzazione di nuovi film multistrato;<br />
iii) studio della fluidodinamica per la tecnologia di stampaggio sequenziale:<br />
caratterizzazione reologica, termica e meccanica di<br />
manufatti stampati.<br />
Un’altra UO è inserita nel Progetto Strategico “Valutazione, caratterizzazione<br />
e valorizzazione del legno” con una ricerca finalizzata all’utilizzo<br />
di fibre cellulosiche, estratte dal legno di eucalipto, in compositi a<br />
matrice polimerica.<br />
Nell’ambito della Legge Regionale 31/12/94 n.41, emanata dalla<br />
Regione Campania e dei Programmi Plurifondo (POP), l’IRTeMP ha presentato<br />
alcune proposte di ricerca, già finanziate, finalizzate alla messa a<br />
punto di :<br />
- nuove matrici termoindurenti ad elevate prestazioni fisico-meccaniche<br />
per compositi avanzati;<br />
- materiali plastici per imballaggio alimentare riciclabili e biodegradabili.<br />
Le cooperazioni nazionali e internazionali sviluppate nell’ambito di<br />
progetti finanziati dal MURST e dall’UE sono molto significative e qualificate.<br />
In particolare le UO dell’IRTeMP partecipano, in collaborazione con il<br />
CAMPEC (Consorzio per le Applicazioni dei Materiali Plastici e per i<br />
Problemi di Difesa dalla Corrosione), al Progetto Europeo Brite (N.<br />
134
BE95-2185 “CERAPOL”) e al Progetto Craft (BE-S2-5081) con ricerche<br />
dal titolo: “Integration of conventional polymers with ceramic nanoparticles<br />
to produce structural composites with enhanced performances”, e<br />
“New materials deriving from cellulosic fibers, agricultural commodities<br />
and wastes”.<br />
Interessanti collaborazioni internazionali di tipo bilaterale sono in atto<br />
con l’ “Institute of Polymer Technology and Materials Engineering”<br />
dell’Università di Loughborough, UK (con l’obiettivo di studiare la possibilità<br />
di realizzare leghe termoindurenti a matrice epossidica con caratteristiche<br />
innovative) e con il “Department of Polymer Science and<br />
Engineering”, University of Massachusset (con la finalità di mettere a<br />
punto “Innovative materials for food packaging applications: poly(vinyl<br />
butyral) based blends”).<br />
Particolarmente rilevanti sono le collaborazioni con centri di ricerca<br />
industriali, tra le quali vanno ricordate quella con la Montell (oramai<br />
divenuta Basell), incentrata sullo studio dell’influenza delle caratteristiche<br />
molecolari dei componenti sulle proprietà di leghe<br />
polipropilene/gomme e sulla messa a punto di film polipropilenici per un<br />
imballaggio innovativo ed ecosostenibile, e quella con la FIAT-ELASIS<br />
finalizzata alla individuazione di nuove metodiche atte a realizzare materiali<br />
con caratteristiche d’uso derivanti dal riciclo di componenti di autovetture<br />
a fine vita, in particolare plance portastrumenti di bordo, fabbricati<br />
secondo il concetto “monomateriale”.<br />
Le attività di formazione sono prevalentemente indirizzate verso i paesi<br />
emergenti della regione mediterranea e questo in linea con la nuova politica<br />
di partenariato lanciata dalla conferenza di Barcellona (27-28<br />
Novembre 1995) e con il Progetto Mediterraneo attivato dal CNR e gestito<br />
dallo “Sportello per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica con i<br />
Paesi del Mediterraneo” (SMED) attivato presso l’IRTeMP a partire dal<br />
9 Marzo 1995 (tavola XVIII).<br />
In questo contesto sono state organizzate una serie di scuole internazionali<br />
dal titolo generale “Mediterranean School on Science and<br />
Technology of Advanced Polymer Based Materials” in ognuna delle quali<br />
sono stati trattati argomenti di grande interesse scientifico e tecnologico.<br />
A queste scuole hanno partecipato un numero rilevante di giovani provenienti<br />
dai Paesi del Mediterraneo usufruendo di borse di studio finanziate<br />
dal CNR e da Enti pubblici e privati.<br />
In collaborazione con l’Unesco, l’UE, il Ministero degli Affari Esteri ed<br />
altri importanti organismi stranieri, si è tenuta, dal 3 al 17 Ottobre 1999<br />
135
a Napoli e a Venezia, la:<br />
“Euro-Mediterranean post-graduate advanced school on: New materials<br />
and technologies for the conservation and restoration of cultural<br />
heritage consisting of natural fibrous polymers”(tavola XIX).<br />
A questa scuola di formazione hanno partecipato circa una quarantina<br />
di giovani ricercatori provenienti da molti paesi dell’area mediterranea<br />
(Egitto, Siria, Israele, Palestina, Giordania, Algeria, Marocco, Malta)<br />
insieme a ricercatori USA, Svedesi ed Austriaci (tavola XX).<br />
Per la disseminazione, la valorizzazione e il trasferimento dei risultati<br />
l’IRTeMP, tra l’altro, utilizza in parte anche la rivista dal titolo<br />
“Mediterranean Magazine: Science, Training and Technology”, edita<br />
dallo SMED, diffusa anche via internet attraverso un apposito sito (tavola<br />
XXI). Inoltre esso ha contribuito all’organizzazione dei Convegni-<br />
Mostra: “Mediterranean Exhibition of Technological Innovation”<br />
Mediterintec (tavola XXII), che si propongono di offrire ai ricercatori<br />
accademici ed industriali, ai produttori, ai trasformatori, agli utilizzatori<br />
e agli operatori di mercato un’opportunità per mettere a confronto conoscenze<br />
e tecnologie innovative con l’obiettivo di identificare ed esplorare<br />
prospettive per lo sviluppo eco-sostenibile dei Paesi del Mediterraneo.<br />
Mediterintec si articola in una s<strong>ezio</strong>ne espositiva suddivisa per settori<br />
ed aree tematiche, ed in una s<strong>ezio</strong>ne convegnistica su argomenti di interesse<br />
strategico.<br />
La terza edizione di Mediterintec (Dicembre 1998) si è incentrata sulle<br />
seguenti aree:<br />
Salute – Ambiente – Biotecnologie – Energia – Trasporti – Agricoltura<br />
e Agro-Industria – Chimica e Materiali – Economia e Statistica – Storia,<br />
Filosofia e Diritto – Beni Culturali –Tecnologie dell’Informazione e<br />
Telematica – Trasferimento Tecnologico e Marketing.<br />
Sono questi anche i settori su cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche<br />
ha dato il via alla realizzazione e alla implementazione del “Progetto<br />
Mediterraneo: Ricerca e formazione per i paesi Terzi”, con l’intento di<br />
essere parte attiva della nuova politica Euro-Mediterranea, sancita dalla<br />
Conferenza di Barcellona del novembre 1995 che, ponendosi come obiettivo<br />
primario la creazione di una “Zona di Libero Scambio” entro il 2010,<br />
rivolge uno sguardo attento alla costituzione di uno “Spazio Euro-<br />
Mediterraneo della Scienza e della Tecnologia”.<br />
Rilevante è l’attività di alta formazione svolta dall’IRTeMP in collabo-<br />
136
azione con altri organi del CNR che hanno fatto parte dell’INC-<br />
MACRO. In particolare nell’ambito del "Programma Operativo 1994/99<br />
“Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” - Misura I.1: “Alta<br />
Formazione” - Fondo Sociale Europeo" sono stati finanziati sei diversi<br />
corsi, integrati, di formazione per 14 giovani laureati, relativamente ai<br />
seguenti percorsi:<br />
1. formazione di esperti nella formulazione, caratterizzazione e trasformazione<br />
di materiali innovativi e avanzati (compositi e leghe) per applicazioni<br />
nei settori biomedicale, auto, edilizia e agroindustriale;<br />
2. formazione di esperti nella preparazione, caratterizzazione e trasformazione<br />
di materiali polimerici innovativi per film a migliorata riciclabilità<br />
da utilizzare nel settore dell’imballaggio alimentare intelligente;<br />
3. formazione di figure professionali esperte nella messa a punto di<br />
nuovi materiali polimerici per applicazioni nel settore dei cavi elettrici ed<br />
automobilistici;<br />
4. formazione di esperti di processi e tecnologie chimiche innovative<br />
finalizzate al riciclo di materiali polimerici a fine vita e di metodiche atte<br />
allo studio della stabilizzazione e di degradazione termo e foto ossidativa<br />
di polimeri;<br />
5. formazione di esperti in nuovi materiali polimerici ed in processi e<br />
tecnologie innovative ecocompatibili per la conservazione ed il restauro<br />
di beni culturali;<br />
6. formazione di figure professionali esperte in modellistica molecolare<br />
per la messa a punto di sistemi macromolecolari per utilizzi nel settore<br />
farmacologico e tecnologico.<br />
Le scuole di formazione organizzate dall’IRTeMP sono spesso integrate<br />
da stage sperimentali di ricerca effettuati per periodi più o meno lunghi,<br />
ma comunque non inferiori a tre mesi, durante i quali giovani ricercatori<br />
italiani e stranieri hanno l’opportunità di approfondire le loro conoscenze<br />
seguendo un percorso basato sul concetto del “Training Through<br />
Research” [65].<br />
137
) L’Istituto di ricerca e tecnologia delle materie plastiche attraverso<br />
alcune delle sue più significative ricerche.<br />
Le ricerche svolte nell’ambito dell’IRTeMP sono, in generale, di tipo<br />
fondamentale. Tuttavia, il loro obiettivo è quasi sempre collegato a problematiche<br />
applicative per le quali è importante non solo la conoscenza<br />
del “know-how”, ma anche del “know-why”. In alcuni casi le ricerche<br />
sono caratterizzate da una finalizzazione più spinta, orientata verso il<br />
“problem solving” e questo in sintonia con i presupposti di tipo “top<br />
down” del Quinto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico<br />
(1998-2002) dell’UE di cui si è ampiamente scritto nella parte I della presente<br />
opera [66].<br />
Particolarmente degne di menzione sono quelle ricerche che riguardano<br />
lo studio dei sistemi a più di un componente (miscele e leghe polimeriche<br />
e compositi con fibre naturali e con nanoparticelle).<br />
La formulazione di questi sistemi ibridi permette di realizzare nuovi<br />
materiali con caratteristiche mirate all’utilizzo (ad esempio, materiali con<br />
elevata resistenza all’urto e film con permeabilità e resistenza superficiale<br />
controllata) [67].<br />
In particolare nel campo della “Rubber Modification” di polimeri termoplastici<br />
cristallizzabili, quali il polipropilene, il nylon ed altri, nell’ambito<br />
dell’istituto, si sono raggiunti importanti obiettivi la cui valenza<br />
ha trovato ampi riconoscimenti a livello internazionale.<br />
I risultati ottenuti in anni di intensa attività furono così riassunti<br />
dall’Autore in una sua pubblicazione:<br />
"The physical behaviour as well as the final use-properties of this type of<br />
crystallizable blend will result from a combination of effect related to the<br />
influence of the following main factors:<br />
- molecular structure and chemical nature of the components;<br />
- blending procedure and blend composition;<br />
- melt viscosity of the components and phase viscosity ratio;<br />
- conditions of crystallization (low or high undercooling, stationary – quiescent<br />
crystallization or crystallization during flowing under shear forces);<br />
- processing condition;<br />
- adhesion between the disperse phase and matrix and structure of interfaces;<br />
- location and structure of the elastomeric phase in the blend material after<br />
crystallization" [68].<br />
Gli studi condotti dall’Autore, in collaborazione con un folto gruppo di<br />
138
Fig. 58a<br />
Fig. 58b<br />
Fig. 58: Micrografie ottiche<br />
di film di miscele polipropilene<br />
(PP)/poliisobutilene (PIB)<br />
con una composizione (80/20)<br />
in peso. Temperatura di cristallizzazione<br />
pari a 133°C:<br />
a) prima della fusione degli<br />
sferuliti di PP;<br />
b) dopo la fusione degli sferuliti<br />
di PP [Rif. 68, 69].<br />
Fig. 59: Resistenza all’impatto (Notched Charpy) in funzione della temperatura<br />
nel caso di polipropilene puro (PP), di miscele PP/gomme etilene-propilene<br />
(EPR) a diverso peso molecolare [alto (EPR HM ) e basso (EPR LM )] [Rif. 69].<br />
139
a)<br />
Fig. 60: Resistenza all’impatto di<br />
polipropilene puro (PP) e di sue<br />
miscele con gomme etilene-propilene<br />
(EPR) in funzione della temperatura<br />
di testing (ascissa), della<br />
composizione della gomma (misurata<br />
dal rapporto C 2 /C 3 )e della<br />
composizione globale della lega<br />
PP/EPR (riportata su ciascuna delle<br />
curve):<br />
a) PP/EPR (C 2 /C 3 =35/65);<br />
b) PP/EPR (C 2 /C 3 =8/92);<br />
[Rif. 68].<br />
b)<br />
ricercatori e tecnici, hanno portato a comprendere quali fattori (molecolari,<br />
fisici e di lavorazione) determinassero la strutturazione delle fasi in<br />
sistemi cristallizzabili a più di un componente. Queste conoscenze hanno<br />
permesso di realizzare sistemi a matrice polipropilenica con caratteristiche<br />
innovative e mirate all’utilizzo (figure 58, 59 e 60) [68, 69].<br />
Utilizzando la metodologia del “reactive blending” è stato possibile<br />
realizzare poliammidi ad elevata resistenza all’impatto a temperature<br />
anche relativamente basse (figure 61-a e 61-b) [70]. E’ importante sottolineare<br />
come questi sistemi abbiano trovato utilizzo pratico presso industrie<br />
del settore.<br />
Di grande interesse speculativo ed applicativo si sono rilevati materia-<br />
140
R(KJ/m 2 )<br />
LEGEND PA6% EPR% EPR-g-SA%<br />
Curve A 100 0 0<br />
95 0 5<br />
90 0 10<br />
90 10 0<br />
90 5 5<br />
Curve B 80 0 20<br />
Curve C 80 10 10<br />
Curve D 80 20 0<br />
T(C°)<br />
Fig. 61a<br />
Fig. 61b<br />
Fig. 61: a) Resistenza all’impatto (R) nel caso della poliammide 6 (PA6) e di sue leghe<br />
con gomme etilene/propilene opportunamente funzionalizzate (EPR-g-SA), in funzione<br />
della temperatura di testing [Rif. 70].<br />
b) La reazione chimica che avviene durante il mescolamento (reactive blending approach)<br />
tra i gruppi terminali delle molecole di PA6 e quelli inseriti lungo le macromolecole<br />
della gomma attraverso reazione di funzionalizzazione con anidride maleica [Rif. 70].<br />
141
Fig. 62a Fig. 62b<br />
Fig. 62c Fig. 62d<br />
Fig. 62: a) Micrografia<br />
elettronica a scansione<br />
della superficie di frattura<br />
del nanocomposito<br />
PMMA/CaCO 3 contenente<br />
il 3% in peso di<br />
nanoparticelle.<br />
b) Come a) ma con il<br />
6% di nanoparticelle.<br />
c) Micrografia al SEM<br />
della superficie di frattura<br />
del nanocomposito<br />
Nylon 6/CaCO 3 contenente<br />
il 2% in peso di<br />
nanoparticelle.<br />
d) Come in c) ma con il<br />
6% in peso di nanoparticelle<br />
[Rif. 71].<br />
142
li innovativi caratterizzati da una matrice polimerica rinforzata con nanoparticelle<br />
di natura inorganica (figure 62-a, b, c, d) [71].<br />
Altri importanti studi riguardano la messa a punto di nuovi materiali<br />
compositi, costituiti da una matrice polimerica e da fibre naturali. Tali<br />
ricerche hanno l’obiettivo di rivalutare le fibre naturali di origine vegetale<br />
quali, ad esempio, le fibre di ginestra e quelle cellulosiche da paglia<br />
esplosa, che possono essere utilizzate in sostituzione delle fibre di vetro.<br />
Questi compositi “eco-sostenibili” sono caratterizzati da elevate prestazioni,<br />
da basso peso specifico e costo e, in alcuni casi, da biodegradabilità<br />
e biocompatibilità. Tra i risultati ottenuti, tutti contraddistinti da un<br />
notevole grado di applicabilità, si ricordano quelli che hanno permesso la<br />
realizzazione di materiali compositi rinforzati con fibre naturali, che<br />
hanno trovato utilizzo nel settore automobilistico (figure 63, 64, 65, 66)<br />
[72, 73].<br />
Fig. 63: Micrografie elettroniche a scansione di superfici di frattura di campioni di compositi<br />
a base di polipropilene isotattico (PP) e di polipropilene isottattico modificato con<br />
anidride maleica (PPMA) e di fibre cellulosiche ottenute da paglia esplosa [Rif. 72].<br />
143
144<br />
In collaborazione con il Museo Archeologico di Napoli e con la<br />
Sovraintendenza Archeologica agli Scavi di Pompei, Ercolano e Scafati,<br />
con il Museo Archeologico del Cairo e con la Missione Archeologica<br />
delle Università degli Studi di Bologna e di Lecce a Bakchias nel<br />
Fayyum, Egitto, si stanno conducendo studi finalizzati al riconoscimento<br />
di reperti tessili archeologici e alla messa a punto di nuove formulazioni,<br />
a base di polimeri, utili al loro restauro conservativo (figure 67, 68, 69,<br />
70) [74, 75, 76].<br />
La conservazione di tessili, di interesse storico-artistico-culturalearcheologico<br />
(arazzi, tessuti, broccati, sete, paramenti ecclesiastici, vestiti,<br />
tele per dipinti ecc.), rappresenta un interessante campo di impiego dei<br />
polimeri a causa di una sempre maggiore domanda, finalizzata al mantenimento<br />
conservativo di manufatti, attraverso la cui fruizione è possibile<br />
ripercorrere la storia dell’umanità [77] (tavola XXIII).<br />
La rilevanza della conservazione del patrimonio culturale e il ruolo<br />
determinante delle tecnologie chimiche e delle metodologie di analisi<br />
chimiche e fisiche emerge chiaramente dal documento dal titolo<br />
“Chimica, l’Europa e il futuro” dove viene testualmente riportato:<br />
"Conservazione è termine generale che comprende tutte le operazioni di prot<strong>ezio</strong>ne<br />
dell’integrità di un’opera d’arte, sia essa di un edificio, una statua,<br />
un dipinto, un mobile, un pezzo di vasellame, un monile o un tessuto. Essa<br />
richiede, talvolta, la riparazione di parti dell’oggetto, che possono essere<br />
contenute o anche molto estese, la stabilizzazione del colore o della struttura<br />
e la prot<strong>ezio</strong>ne della superficie dalla corrosione o dal deterioramento fisico<br />
dovuto ad eccessiva esposizione al calore o alla luce.<br />
La ripulitura delle opere d’arte richiede l’uso di detergenti, di acidi, di alcali,<br />
di agenti sequestranti e di solventi organici, tutti da utilizzare sull’oggetto<br />
con il minimo danno: di conseguenza, è necessaria una conoscenza<br />
approfondita della natura del materiale –età, costituenti e metodi di fabbricazione-<br />
unita ad una perfetta comprensione della chimica del processo di<br />
pulizia e della successiva stabilizzazione della superficie ripulita. La possibilità<br />
di prot<strong>ezio</strong>ne della pietra degli edifici antichi è strettamente legata alla<br />
conoscenza degli inquinanti atmosferici localmente presenti e delle variazioni<br />
climatiche che si hanno nel volgere delle stagioni, nonché al comportamento<br />
che la pietra può avere verso i materiali protettivi. La riparazione di<br />
oggetti può richiedere l’uso di adesivi che permettano ai frammenti di stare<br />
insieme come in origine, così come di nuovi materiali resinosi per il rifacimento<br />
delle parti mancanti, smalti ed agenti coprenti per oggetti in ceramica<br />
e vernici per i dipinti. Milioni di libri nelle biblioteche di tutta Europa<br />
sono in un vero e proprio stato di degrado e vanno lentamente deteriorandosi<br />
in quanto la carta è di per sé instabile nell’aria. La domanda di agevoli tecniche<br />
di conservazione andrà sempre aumentando e, quindi, sarà necessaria<br />
una più approfondita conoscenza della chimica della carta, degli inchiostri
da stampa e del loro comportamento verso gli stessi materiali usati per la<br />
conservazione" [78].<br />
L’importanza della conservazione dei beni culturali ed il ruolo fondamentale<br />
della chimica in questo settore è stato ampiamente riconosciuto<br />
allorquando nell’organizzare la “Euro-Mediterranean Conference” on<br />
“The Role of the Chemical Industry and Chemical Research for the Eco-<br />
Sustainable Development of the Mediterranean Area”- (Rome, June 22,<br />
23 -1998) tra gli argomenti trattati figurava: “The Chemistry for the preservation<br />
and conservation of cultural heritage” [79].<br />
Fig. 64a<br />
Fig. 64: Micrografie<br />
elettroniche a scansione<br />
di superfici di frattura<br />
di campioni di<br />
compositi a base di<br />
poliidrossibutirrato<br />
(PHB) e fibre cellulosiche<br />
da paglia esplosa,<br />
in funzione della<br />
composizione.<br />
a), b) PHB puro a<br />
diversi ingrandimenti<br />
(160 x e 320 x).<br />
c) Composito PHB/<br />
fibre (90/10), 640 x.<br />
d) Composito PHB/<br />
fibre (80/20), 640 x.<br />
e) Composito PHB/<br />
fibre (70/30), 160 x.<br />
f) Composito PHB/<br />
fibre (50/50), 320 x<br />
[Rif. 73].<br />
Fig. 64b<br />
145
Fig. 64c<br />
Fig. 64d<br />
Fig. 64e<br />
Fig. 64f<br />
146
Da alcuni anni è operativa, in ambito IRTeMP, una unità di ricerca che<br />
ha concentrato la propria attività sulla messa a punto di polimeri innovativi<br />
per il restauro conservativo di beni culturali costituiti da sistemi<br />
macromolecolari naturali fibrosi (tessili, cartacei, ecc.) e sullo sviluppo<br />
di processi caratterizzati da: ecosostenibilità, durabilità, reversibilità ed<br />
economicità.<br />
Gli sforzi in questo settore sono stati premiati dall’UE che ha approvato<br />
e ammesso a finanziamento nell’ambito del V PQ-INCO-MED<br />
Fig. 65a<br />
Fig. 65b<br />
Fig. 65: Sferuliti di polipropilene isotattico modificato con anidride maleica (PPMA)<br />
cresciuti isotermicamente a due diverse temperature di cristallizzazione in presenza di<br />
fibre di ginestra trattate con NaOH : a) Tc=135°C; b) Tc=129°C [Rif. 73].<br />
147
(International Cooperation with Mediterranean Countries) un importante<br />
progetto trasnazionale, coordinato dall’IRTeMP, dal titolo: “New<br />
Materials and Eco-Sustainable Technologies for the Conservation and<br />
Restoration of Textiles”. Altro rilevante risultato è quello riguardante il<br />
finanziamento ottenuto dal Consorzio CAMPEC di un importante Piano<br />
Nazionale di Ricerca sulla conservazione e restauro dei tessili al quale<br />
l’IRTeMP parteciperà sia come esecutore di ricerca che come partner per<br />
la formazione.<br />
I materiali polimerici oramai trovano largo impiego nel campo del<br />
restauro conservativo dei beni culturali. Le ragioni sono da ricercare nel<br />
fatto che spesso i polimeri, a causa del particolare “mixing” di caratteristiche<br />
chimiche, fisiche, reologiche, di resistenza alla corrosione ambien-<br />
Fig. 66: Proprietà meccaniche<br />
a confronto tra<br />
compositi a matrice di<br />
PPMA rinforzati con<br />
fibre di ginestra (broom)<br />
e con fibre di vetro<br />
(glass):<br />
in alto: modulo specifico<br />
di elasticità lineare;<br />
in basso: sforzo a rottura<br />
specifico, in funzione<br />
della % di fibre presenti<br />
[Rif. 73].<br />
148
Fig. 67: sinistra: Fotografia di un frammento di tessuto, in parte carbonizzato, trovato tra le rovine dell’antica città di Pompei.<br />
destra: Micrografia elettronica al SEM di fibre estratte dal frammento che, dopo opportuno trattamento di stabilizzazione, sono state identificate<br />
come canapa [Rif. 74, 75].<br />
Fig. 68: sinistra: Fotografia di un frammento di tessuto, parzialmente carbonizzato, trovato tra le rovine dell’antica città di Pompei.<br />
destra: Micrografia elettronica al SEM delle fibre costituenti identificate essere di lino [Rif. 74, 75].<br />
149
Fig. 69: sinistra: Fotografia di un frammento di un antico tessuto ritrovato a Bakchias durante la campagna di scavi del 1997. - destra:<br />
Micrografia elettronica di fibre componenti il tessuto identificate come fibre derivanti dalle piante appartenenti alla famiglia delle Arecaceae<br />
[Rif. 76].<br />
Fig. 70: sinistra: Fotografia di un frammento di un antico tessuto trovato a Bakchias durante la campagna di scavi nel 1996. - destra:<br />
Micrografia elettronica al SEM di fibre componenti identificate come lana [Rif. 76].<br />
150
Fig. 71: PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) costituito da una resina epossidica bifunzionale,<br />
curata con anidride metilnadica, ed una sostanza liquido cristallina, a basso peso<br />
molecolare (LC).Composizione della miscela: Resina/LC (60/40 in peso) [Rif. 83].<br />
tale e di sostenibilità, si lasciano preferire ad altri tipi di materiali.<br />
Due interessanti e recenti applicazioni di materiali polimerici nel<br />
campo dei beni culturali ed artistici sono illustrati nelle tavole XXIV e<br />
XXV [80, 81].<br />
In particolare nella tavola XXIV viene mostrata una scultura in vetro,<br />
raffigurante un cavallo (peso 10 chilogrammi, altezza un metro) realizzata<br />
con la tecnica di lavorazione a caldo che, durante il trasporto dall’Italia<br />
all’Inghilterra, aveva subito la grave rottura di una delle zampe anteriori<br />
che era andata praticamente in frantumi.<br />
Utilizzando una particolare resina polimerica, l’Araldite 2020 (un adesivo<br />
epossidico bicomponente a bassa viscosità che polimerizza a temperatura<br />
ambiente), è stato possibile restaurare e ricostruire la scultura [80].<br />
Le fotografie della tavola XXV, mostrano come sfruttando le caratteristiche<br />
di lavorabilità, di leggerezza, di trasparenza e di sicurezza del polimetilmetacrilato<br />
(PMMA) è stato possibile realizzare una struttura estremamente<br />
complessa per la chiusura dell’ “occhio” della sala ottagonale<br />
151
152<br />
Fig. 72: Frontespizio del volume pubblicato dall’IRTeMP-CNR in occasione dei trenta<br />
anni di attività (1969-1999) [Rif. 67].
della Domus Aurea il cui progetto era stato avviato a Roma nel 64 d.C.<br />
dall’allora imperatore Nerone [81].<br />
Studi di rilevante interesse, riguardanti il settore dell’optoelettronica,<br />
sono finalizzati alla realizzazione di materiali intelligenti, in grado cioè<br />
di reagire alle sollecitazioni fisiche ed ambientali. In quest’ambito si sono<br />
realizzati dei sistemi compositi a matrice epossidica, “polymer dispersed<br />
liquid crystals” (PDLC), con caratteristiche interessanti, in termini di utilizzo,<br />
nel settore dell’ottica guidata e dell’ottica integrata [82].<br />
La morfologia e la distribuzione delle fasi di un composito tipo PDLC<br />
è illustrata nella figura 71, dove è riportata una micrografia, ottenuta<br />
mediante microscopia elettronica a scansione, di una resina epossidica<br />
bifunzionale, curata con anidride metilnadica, che ingloba, come fase<br />
dispersa, una sostanza a basso peso molecolare con proprietà liquido-cristalline<br />
[83].<br />
Ricerche suscettibili di applicazioni nel settore aeronautico riguardano<br />
la problematica dell’assorbimento di acqua delle resine epossidiche tetrafunzionali.<br />
E’ stata messa a punto una nuova tecnica per la determinazione<br />
dei parametri assoluti del processo diffusivo basata sulla spettroscopia<br />
FTIR nel vicino infrarosso [84]. Tale approccio ha permesso di ottenere<br />
importanti informazioni sulle interazioni molecolari polimero-solvente e<br />
sullo stato di aggregazione del penetrante.<br />
Le particolari competenze sviluppate nell’ambito dell’IRTeMP hanno<br />
fatto di questo Istituto un interessante ed appropriato interlocutore dei<br />
centri di ricerca delle grandi e medie industrie. Infatti importanti collaborazioni<br />
si sono sviluppate con la Fiat, l’Alenia, la Snia-Ricerche, la<br />
Montell, la Lonza, l’Enichem, la Fiat-Elasis ed altre.<br />
A livello locale (regione Campania), tali rapporti sono facilitati dalla<br />
presenza del CAMPEC (Consorzio per le Applicazioni dei Materiali<br />
Plastici e per i Problemi di Difesa dalla Corrosione) il quale, valorizzando<br />
i risultati ottenuti nell’ambito dell’IRTeMP e di altre strutture similari<br />
ne facilita la trasformazione in innovazioni tecnologiche da introdurre<br />
nel sistema produttivo del nostro paese (Tavola XXVI).<br />
L’attività trentennale dell’IRTeMP è stata ampiamente documentata<br />
attraverso la pubblicazione del volume dal titolo “Istituto di Ricerca e<br />
Tecnologia delle Materie Plastiche dal 1969 al 1999: Trenta anni di attività<br />
scientifica”, a cura di E. Martuscelli et al. [67] (figura 72 e tavola<br />
XXVII). Dall’insieme dei dati contenuti in questo volume si ricavano<br />
importanti e significativi elementi, alcuni dei quali sono qui di seguito<br />
153
iportati.<br />
- I gruppi di ricerca dell’IRTeMP hanno pubblicato, nel periodo che va<br />
dal 1969 alla fine del 1998, un totale di 735 lavori a stampa, la maggior<br />
parte su riviste internazionali provviste di referees, con una media annuale<br />
di circa 25 (se ci si riferisce agli ultimi dieci anni di attività il numero<br />
medio di lavori pubblicati per anno è di ~34), inoltre sono stati depositati<br />
23 brevetti dei quali, alcuni sono stati utilizzati da industrie italiane per<br />
importanti innovazioni tecnologiche.<br />
- Nel periodo considerato (1969-98) le ricerche condotte nell’ambito<br />
dell’IRTeMP possono essere raggruppate in 27 tematiche. Attualmente<br />
l’attività viene ad essere concentrata su circa una decina di tematiche; le<br />
più rilevanti sono state precedentemente descritte.<br />
- Gran parte delle ricerche e dei lavori pubblicati sono il frutto di proficue<br />
collaborazioni tra gruppi di ricerca dell’IRTeMP e di centri di ricerca<br />
appartenenti ad università italiane e straniere e a centri di ricerca industriali<br />
(questo a dimostrazione del fatto che il grado di internazionalizzazione<br />
e di capacità a partecipare a reti tematiche nazionali e transnazionali<br />
è molto elevato).<br />
154
c) L’IRTeMP e le sue più interessanti collaborazioni con centri di<br />
ricerca industriali.<br />
Molti degli studi condotti, nell’ambito dell’IRTeMP, riguardano il polipropilene<br />
e le sue leghe con gomme ed elastomeri (principalmente copolimeri<br />
etilene-propilene). Questo conferma che ancora oggi ricerche<br />
significative hanno come oggetto la comprensione di fenomeni, processi<br />
e meccanismi fondamentali per il miglioramento delle prestazioni di una<br />
serie di sistemi a base di polimeri la cui sintesi fu scoperta oltre quarant’anni<br />
fa da G. Natta e successivamente sviluppata dalla Montedison<br />
e quindi dall’Himont e dalla Montell [67].<br />
Il processo sostitutivo, a favore dei polimeri di sintesi, è stato reso pos-<br />
Fig. 73: Il nuovo centro tecnologico poliammidi della SNIA di Ceriano Laghetto (fotografia<br />
gentilmente messa a disposizione per la riproduzione dal dott. A. Casale).<br />
155
sibile da una intensa attività di ricerca che si è sviluppata specialmente<br />
negli ultimi trenta quaranta anni, alla quale l’IRTeMP, per quanto di sua<br />
competenza, ha dato in alcuni settori, quali quello delle miscele e delle<br />
leghe polimeriche e in generale quello dei sistemi a più di un componente,<br />
dei significativi contributi sia a livello di ricerca di base che nella<br />
messa a punto di materiali con caratteristiche fortemente innovative.<br />
Un’interessante collaborazione con la SNIA (il cui nuovo centro di<br />
ricerca sulle poliammidi di Ceriano Laghetto è illustrato nella figura 73),<br />
nell’ambito del Progetto Finalizzato Chimica Fine e Secondaria, ha portato<br />
alla messa a punto di una nuova tecnologia per la realizzazione di<br />
poliammidi modificate mediante l’aggiunta di gomme funzionalizzate<br />
(reactive blending technology). Questi nuovi materiali, come già precedentemente<br />
riportato, sono caratterizzati da un elevata resistenza all’impatto,<br />
specialmente alla basse temperature. Essi furono sviluppati, industrializzati<br />
e commercializzati dalla stessa SNIA.<br />
Restando nel settore dei materiali ibridi, importanti risultati (ottenuti in<br />
stretta collaborazione con l’Alusuisse, successivamente Lonza) hanno<br />
permesso di realizzare sistemi a base di polimeri termoindurenti (poliesteri<br />
insaturi e resine epossidiche) modificati, mediante processi reattivi,<br />
attraverso l’aggiunta di un secondo componente. Questi nuovi sistemi<br />
ibridi presentano una elevata resistenza all’urto (figure 74, 75, 76 e 77)<br />
[85-a,b].<br />
Risale ai primi anni ottanta l’inizio di una proficua collaborazione tra<br />
l’IRTeMP e il Centro di Ricerche G. Natta di Ferrara (Tavola XXVIII).<br />
Dalla seconda metà del 2000 il Centro Giulio Natta di Ferrara è parte<br />
integrante della BASELL Polyolefins; "a new global company that has been<br />
formed through a merger of Elenac, Montell and Targor ........ 50-50 joint<br />
venture between Shell and Basf..." [86].<br />
A seguito di questa operazione tutto il business concernente il polipropilene<br />
che faceva capo alla Montell, è stato conferito alla BASELL.<br />
"The polypropylene business unit has a global team of sales representatives<br />
and technical staff who specialize in providing world class service to their<br />
customers. For BASELL, creating innovative polypropylene products that<br />
meet customer needs is a way of life" [86].<br />
Per la prima volta, dalla sua scoperta nei laboratori della Montecatini il<br />
polipropilene italiano, viene prodotto e commercializzato da una società,<br />
la Basell, nella cui denominazione non appare il riferimento alla<br />
Montecatini, al contrario di quanto avveniva nel caso dell’ Himont e della<br />
156
Fig. 74a<br />
Fig. 74b<br />
Fig. 74: Poliesteri insaturi ad elevata resistenza all’impatto. Processo per l’ottenimento<br />
di un copolimero reattivo capace di agire da agente compatibilizzante in un sistema resina<br />
poliestere insatura/gomma (UP/PB<strong>DI</strong>).<br />
a) Primo Stadio – i gruppi ossidrili terminali della gomma (polibutadiene-ossidrile terminale-PBD)<br />
sono trasformati in gruppi isocianati (PB<strong>DI</strong>).<br />
b) Secondo stadio – la gomma PB<strong>DI</strong> reagisce con un ammontare stechiometrico del prepolimero<br />
del poliestere insaturo (UP) dando luogo alla formazione del copolimero a<br />
blocchi del tipo UP-PB<strong>DI</strong>-UP che agisce da agente compatibilizzante del sistema<br />
UP/PBD [Rif. 85-a].<br />
Montell, che attraverso “mont” ricordavano al mondo la paternità di una<br />
grande scoperta italiana.<br />
Le ricerche, condotte in collaborazione con i ricercatori del Centro di<br />
ricerca di Ferrara, sono state finalizzate alla comprensione dei meccanismi<br />
molecolari che sono alla base del comportamento alla frattura di leghe<br />
polipropilene isotattico/gomme etilene-propilene. In particolare, come<br />
già precedentemente accennato, gli studi hanno evidenziato l’influenza di<br />
157
Fig. 75a<br />
Fig. 75c<br />
Fig. 75b<br />
Fig. 75: Realizzazione di<br />
poliesteri insaturi ad elevata<br />
resistenza all’impatto<br />
mediante miscelazione<br />
reattiva con gomme funzionalizzate.<br />
Influenza<br />
della composizione sulla<br />
morfologia e struttura<br />
delle fasi e quindi sulle<br />
proprietà. Micrografie<br />
elettroniche a scansione di<br />
superfici di frattura di una<br />
lega ternaria UP/PBD/<br />
copolimero UP-PB<strong>DI</strong>-UP<br />
(vedasi figura 74) aventi<br />
diversa composizione:<br />
a) UP/PBD/copolimero<br />
(UP-PB<strong>DI</strong>-UP) (90/10/1)<br />
(parti in peso);<br />
b) 90/10/3;<br />
c) 90/10/5;<br />
[Rif. 85-a].<br />
158
Fig. 76a<br />
Fig. 76b<br />
Fig. 76: Preparazione di<br />
resine a base di poliestere<br />
insaturo (UP) ad elevata<br />
resistenza all’impatto attraverso<br />
un processo di miscelazione<br />
reattiva e con l’ausilio<br />
di un agente compatibillizzante<br />
(vedasi figure 74 e<br />
75).<br />
Nella figura sono riportati i<br />
parametri di frattura Kc (a)<br />
e Gc (b) (rispettivamente:<br />
critical stress intensity factor<br />
e critical strain energy<br />
release rate) in funzione del<br />
contenuto di gomma polibutadienica<br />
(PBD) nel caso<br />
di leghe ternarie e binarie:<br />
• curva A – Lega binaria<br />
UP/PBD;<br />
• curve B, C, D – Leghe ternarie<br />
UP/PBD/copolimero-<br />
UP-PB<strong>DI</strong>-UP; contenenti<br />
rispettivamente 1,3 e 5 parti<br />
in peso del copolimero che<br />
agisce da compatibilizzante<br />
[Rif. 85-a].<br />
un componente non cristallizzabile sui parametri cinetici, morfologici e<br />
termodinamici, propri della matrice polipropilenica. Inoltre è stata delucidata<br />
l’influenza di una serie di fattori, quali ad esempio il peso molecolare<br />
e la sua distribuzione, la costituzione del copolimero, il grado di<br />
stereoregolarità della matrice, sui processi di reologia del fuso, sulla<br />
lavorabilità, sulla cristallizzabilità e quindi sulle proprietà ultime di questi<br />
materiali “ibridi” a più di un componente.<br />
I risultati di tali studi hanno chiarito importanti processi, contribuendo<br />
al successo delle leghe polipropileniche, sviluppate e industrializzate<br />
dall’Himont e successivamente dalla Montell (Tavola XXIX).<br />
Molte aziende produttrici di auto, hanno sostituito i tradizionali paraurti<br />
in metallo con quelli realizzati con polipropilene tenacizzato con<br />
gomme. La strutturazione delle fasi che si viene a realizzare in un sistema<br />
polipropilene/gomma (figura 78) rende conto delle particolari pro-<br />
159
Fig. 77: Superficie di frattura di una resina epossidica tetrafunzionale tenacizzata<br />
mediante un fluoro-oligomero telechelico. Composizione della miscela: 95/5 in peso.<br />
Le proprietà del materiale dipendono, tra l’altro, dal modo e dallo stato di dispersione<br />
della fase gommosa [Rif. 85-b].<br />
prietà di resistenza all’impatto di questa tipologia di materiali innovativi<br />
[87] (Tavola XXX).<br />
Polipropileni, ad elevata tenacità, ottenuti mediante nuove tecnologie,<br />
si sono rilevati, tra l’altro, particolarmente adatti, nel campo degli imballaggi<br />
da trasporto a rendere.<br />
Questi materiali, sviluppati negli ultimi dieci anni, comunemente noti<br />
come copolimeri polipropilenici eterofasici, presentano le seguenti proprietà:<br />
" -elevata resistenza all’urto anche alle basse temperature, per esempio<br />
-20° C.......;<br />
- aumentata rigidità, che porta a possibilità di carico molto alte;<br />
- scorrimento ridotto, che consente di migliorare le prestazioni di stabilità<br />
dimensionale, anche in presenza di carico costante e a temperature di<br />
160
servizio ancora più alte;<br />
- eccellente bilanciamento tra rigidità e resistenza all’urto;<br />
- riduzione del peso complessivo dell’articolo;<br />
I nuovi PP a elevata resistenza all’urto presentano caratteristiche migliorate<br />
rispetto a quelli tradizionali o agli HDPE. Tutte le maggiori aree di prestazione<br />
ne risultano migliorate: la rigidità e le deformazioni, la resistenza ad<br />
alte temperature e –soprattutto- la resistenza all’urto" [88].<br />
Le caratteristiche principali di questi nuovi polipropileni antiurto sono<br />
messe a confronto con quelle del polietilene nelle figure 79 e 80 [88].<br />
Nell’ambito dell’IRTeMP importanti ricerche sono state avviate negli<br />
anni scorsi e sono tuttora in corso finalizzate a migliorare le caratteristiche<br />
fisiche e meccaniche di film di polipropilene da utilizzare nel settore<br />
dell’imballaggio.<br />
Fig. 78: Morfologia di un paraurti a base polipropilenica tenacizzato con un terpolimero<br />
etilene-propilene-diene [Rif. 87].<br />
161
Fig. 79: Confronto tra le proprietà dei nuovi PP antiurto e quelle dell’HDPE [Rif. 88].<br />
L’obiettivo è quello di realizzare film, con caratteristiche innovative,<br />
attraverso la tecnologia del “melt blending” e/o del “reactive blending”.<br />
Il settore dell’imballaggio, per le sue implicazioni tecniche, industriali<br />
Fig. 80: Confronto tempi di ciclo nello stampaggio a ini<strong>ezio</strong>ne tra polipropileni antiurto<br />
tipo standard, nuovo polipropilene antiurto e polietilene ad alta densità [Rif. 88].<br />
162
Poliolefine<br />
• migliorare la barriera al vapore d’acqua<br />
• aumentare il “range” di proprietà fisiche e meccaniche<br />
• ampliare l’intervallo di temperatura di utilizzo<br />
• migliorare le caratteristiche ambientali<br />
Poliesteri<br />
• realizzare contenitori resistenti alle alte temperature<br />
• raggiungere una maggiore ottimizzazione dei materiali attraverso un migliore<br />
controllo del peso molecolare e della cristallinità<br />
• migliorare la progettazione di imballaggi<br />
• aumentare l’orientazione molecolare<br />
Poliammidi<br />
• sviluppare un sistema di controllo più adeguato per lo stoccaggio<br />
• sviluppare nuove tecnologie di imballaggio (ad esempio in atmosfera modificata<br />
e controllata)<br />
Fig. 81: Miglioramenti di proprietà auspicati per alcune famiglie di polimeri usati nell’imballaggio<br />
alimentare [Rif. 89].<br />
Fig. 82: L’evoluzione funzionale del sistema packaging [Rif. 89].<br />
163
e socio-economiche, è uno dei settori prioritari di tutta l’industria di trasformazione<br />
mondiale ed è caratterizzato da un elevato grado di intersettorialità<br />
e competitività tra i vari materiali e le sue possibili tecnologie.<br />
In particolare l’imballaggio rappresenta uno dei principali settori di utilizzo<br />
delle plastiche.<br />
Un incremento ulteriore dell’uso dei polimeri nel settore dell’imballaggio,<br />
ed in particolare in quello per alimenti, è collegato alla possibilità di<br />
apportare una serie di innovazioni di processo e di prodotto.<br />
Alcuni dei miglioramenti prestazionali più auspicati, relativamente alle<br />
poliolefine, poliesteri e poliammidi, sono indicati nella figura 81 [89]. Le<br />
ricerche in corso nell’IRTeMP tendono al raggiungimento di questi obiettivi<br />
che, per altro, sono congruenti con l’evoluzione funzionale del settore<br />
(figura 82). Infatti dalla figura 82 si evince come il sistema “packaging”<br />
sia passato da una fase primaria caratterizzata da un imballaggio<br />
industriale, finalizzato alla prot<strong>ezio</strong>ne e al contenimento, ad una fase<br />
attuale, definita di imballaggio sociale, dove il fattore preminente è quello<br />
della compatibilità ambientale [89].<br />
Le ricerche condotte hanno, tra l’altro, l’obiettivo di ottenere materiali<br />
per imballaggio, “intelligenti”, più leggeri, più resistenti e caratterizzati<br />
da un elevato grado di riciclabilità a fine utilizzo, capaci inoltre di operare<br />
in condizione di atmosfera controllata e di non contaminare gli alimenti<br />
con i quali vengono a contatto.<br />
Questi obiettivi sono in linea con quanto riportato sull’argomento da<br />
M.U. Gandhi e B.S. Thompson nel loro libro dal titolo “Smart Materials<br />
and Structures”:<br />
"The food packaging industry, which generally harvest fruit and vegetables<br />
before they have fully ripened in an effort to present ripe produce in the retail<br />
stores, would significantly benefit from thin film wrapping materials that<br />
embody adaptation characteristics and also the ability to respond to local<br />
environment conditions. These wrapping materials would not only possess<br />
the ability to optimally control the maturing of vegetables, for example, by<br />
controlling the emission of ethylene gas, but they could also predict the window<br />
of opportunity for consuming the product in the most palatable condition"<br />
[90].<br />
Nel contesto sopra delineato particolarmente rilevanti appaiono gli<br />
studi, avviati nell’ambito dell’IRTeMP, il cui scopo è quello di realizzare<br />
nuovi materiali idonei a produrre film plastici con bassa permeabilità ai<br />
più importanti gas (ossigeno, vapore d’acqua, anidride carbonica, ecc.).<br />
Questi gas, molto spesso, penetrando all’interno della conf<strong>ezio</strong>ne, entra-<br />
164
no a contatto con l’alimento compromettendone le caratteristiche di edibilità.<br />
Gli imballaggi plastici, con effetto barriera, costituiscono un settore<br />
applicativo che è in grande sviluppo. Da uno studio pubblicato recentemente<br />
dalla Business Communication Company USA, in relazione all’argomento<br />
di cui sopra si ricava che:<br />
"Nell’ambito del mercato statunitense degli imballaggi plastici, le resine barriera<br />
detengono la più ampia quota di consumo, con una quantità complessiva<br />
venduta nel 1999 di 1,6 milioni di ton. Con un tasso di crescita medio<br />
annuo del 9,7% ci si attende che questo segmento superi entro il 2004 i 2,5<br />
milioni di ton. Esso include copolimeri di EVOH, PCTFE, resine nitriliche,<br />
poliammidi, poliesteri termoplastici e PVC. Il contributo principale viene<br />
apportato dai poliesteri termoplastici e tra essi, ………, dal PET. L’impiego<br />
di quest’ultimo nelle bottiglie barriera è cresciuto a doppia cifra negli scorsi<br />
anni, sebbene fino al 2004 sia previsto un tasso di crescita medio annuo inferiore<br />
al 10%. Per cui da 1,5 milioni di ton del 1999, dovrebbe raggiungere i<br />
2,3 milioni entro il 2004.<br />
Altri imballaggi barriera selettivi includono film che consentono soltanto ad<br />
alcuni vapori di attraversarli. Essi comprendono PVC, nontessuti e film permeabili<br />
per imballaggio in atmosfera controllata e modificata (CAP/MAP).<br />
Ci si aspetta che da 168.000 ton del 1999 essi salgano a 228.000 entro il<br />
2004…….<br />
Quanto alle applicazioni, predomina l’imballaggio per alimenti e bevande,<br />
che occupa più del 90% del mercato statunitense delle resine considerate.<br />
Altre, di minor rilevanza ma comunque importanti, includono gli imballaggi<br />
per prodotti chimici e industriali, oltre a quelli farmaceutici" [91].<br />
Il polietilenetereftalato (PET), che come già scritto rientra a pieno titolo,<br />
se opportunamente modificato mediante processi e tecnologie innovative,<br />
tra le plastiche “barriera”, trova ampio utilizzo nella produzione di<br />
bottiglie per l’imbottigliamento di liquidi gassati (quali ad esempio la<br />
birra (tavola XXXI) e l’acqua minerale) e di olio edibile (tavola XXXII)<br />
[92, 93].<br />
Il consumo di resine barriera negli Stati Uniti relativo all’anno 1999<br />
insieme alle previsioni per il 2004, è riportato nella tabella 12. Dai dati<br />
si ricava come questo settore sia divenuto, oramai, una importante realtà<br />
economica e produttiva [91].<br />
Gli studi sono mirati, oltre che al miglioramento della qualità dell’imballaggio,<br />
anche alla possibilità di un suo riciclo. I materiali infatti devono<br />
essere progettati affinché possano essere riutilizzati, e ciò richiede la<br />
messa a punto di tecnologie innovative a livello di processo e di prodot-<br />
165
Tabella 12<br />
Consumo di resine barriera per<br />
imballaggio negli Stati Uniti 1999 2004<br />
(migliaia di Tonn.)<br />
Resine barriera 1586 2524<br />
- poliesteri 1437 2312<br />
- altre 149 212<br />
Film permeabili 168 227<br />
- PVC 109 121<br />
- altri 59 106<br />
Resine adesive 43 59<br />
Totale 1797 2810<br />
to.<br />
Le problematiche ambientali connesse all’utilizzo delle plastiche sono<br />
oggetto di studio da parte di vari gruppi dell’IRTeMP. L’attività di ricerca<br />
segue due direttrici; la prima è finalizzata alla messa a punto di procedure<br />
innovative per il riciclo e riutilizzo di plastiche derivanti da oggetti<br />
a fine vita utilizzati nel settore dell’imballaggio alimentare (in particolare<br />
bottiglie di polietilenetereftalato) e nel settore delle colture protette<br />
(film poliolefinici per pacciamatura e per coperture di vario tipo). La<br />
seconda ha come obiettivo l’identificazione di nuove metodologie per il<br />
riciclo di componenti di autovetture realizzati utilizzando materiali polimerici<br />
multistrato.<br />
In quest’ambito è stato sviluppato un nuovo tipo di approccio per la<br />
fabbricazione di plance (figura 83), basato sull’utilizzo, per i vari strati,<br />
di materiali chimicamente simili, e quindi tra loro compatibili (soluzione<br />
monomateriale). Questo metodo si discosta da quello normalmente<br />
impiegato che prevede l’utilizzo di polimeri di natura diversa (soluzione<br />
multimateriale) che, essendo incompatibili, possono essere riciclati solo<br />
dopo una preventiva separazione meccanica, con conseguente aumento<br />
della complessità e dei costi del processo (figura 84) [94].<br />
Ricerche sviluppate in collaborazione con la FIAT-ELASIS hanno<br />
dimostrato la riciclabilità di una plancia portastrumenti a tre strati a base<br />
poliolefinica (figura 85). Inoltre è stato possibile, attraverso l’aggiunta di<br />
opportuni additivi, ottenere un materiale riciclato riutilizzabile per lo<br />
166
Fig. 83: Plancia portastrumenti di una tipica autovettura costruita utilizzando vari materiali<br />
polimerici secondo una configurazione a multistrato.<br />
Fig. 84: Problematiche e possibili soluzioni concernenti il riciclo di componenti in plastica<br />
nel settore auto [Rif. 94].<br />
167
Fig. 85: Per favorire il recupero e il riciclo delle plastiche nel caso delle plancie portastrumenti<br />
delle auto si è passati dalla soluzione “multimateriale” (a sinistra) a quella<br />
“monomateriale” (a destra) [Rif. 94].<br />
stesso tipo di applicazione o per la produzione di manufatti simili.<br />
La metodologia seguita rappresenta un aspetto innovativo nel riciclo di<br />
materiali polimerici nel settore automobilistico. Infatti, essa si discosta<br />
notevolmente dal sistema tradizionale a “cascata” che prevede l’utilizzo<br />
del materiale riciclato per la realizzazione di manufatti con valore<br />
aggiunto via via inferiore rispetto al manufatto originale.<br />
La ricerca descritta rappresenta un interessante esempio di collaborazione<br />
e di sinergia tra un Istituto del CNR, il CAMPEC, un Consorzio di<br />
ricerca pubblico/privato (di cui il CNR è uno dei soci maggioritari), idoneo<br />
alla valorizzazione e al trasferimento dei risultati e un Centro di ricerca<br />
industriale capace di realizzare prototipi e di avviarne la produzione.<br />
Le ricerche condotte presso l’IRTeMP nel campo del riciclo di materiali<br />
polimerici a fine vita sono in linea con le direttive internazionali e<br />
dell’UE le quali prevedono, per il 2010, una drastica riduzione delle frazioni<br />
di materiali derivanti dagli scarti urbani ed industriali che potranno<br />
essere smaltite nelle discariche a cielo aperto (~10%) ed un aumento<br />
sostanziale della aliquota di materiali da riciclare (~60%).<br />
In un futuro non lontano nelle discariche a cielo aperto potranno essere<br />
avviati solo residui solidi urbani di natura organica e pertanto facilmente<br />
biodegradabili.<br />
Il raggiungimento di questi obiettivi potrà avvenire solo attraverso lo<br />
sviluppo di materiali e processi industriali che prevedano la riduzione alla<br />
168
fonte dei fattori inquinanti e la minimizzazione dei rifiuti. Questo nuovo<br />
concetto di produzione (“Environmentally Conscious Manufacturing<br />
Approach”) è basato sui seguenti presupposti:<br />
- scelta di materiali con caratteristiche tali da permettere il riutilizzo<br />
per impieghi a uguale o minore valore aggiunto, una volta terminato<br />
il ciclo di vita, in altri cicli produttivi;<br />
- sviluppo di una filosofia produttiva basata su un approccio diretto<br />
allo studio dell’intero ciclo di vita dei materiali;<br />
- individuazione e riduzione di nuovi problemi ambientali che possano<br />
scaturire dall’impiego di materiali innovativi (tecnopolimeri, compositi<br />
avanzati, materiali multistrato, ecc…).<br />
Le competenze acquisite, negli anni, dai ricercatori e tecnici<br />
dell’IRTeMP, nel campo delle metodologie chimiche e fisiche, finalizzate<br />
allo sviluppo di processi innovativi di riciclo e riutilizzo di materiali<br />
polimerici derivanti da filiere produttive quali l’imballaggio, l’auto ed<br />
altre, rappresentano un rilevante bagaglio culturale e tecnologico utile per<br />
una nascente industria del riciclo delle plastiche in Italia e in Europa. In<br />
relazione a questo ultimo aspetto recentemente è stato scritto:<br />
"L’industria del riciclo della plastica in Europa si presenta come un settore<br />
relativamente giovane con un potenziale di crescita ed espansione di rilievo<br />
derivante da innovazioni tecniche e sviluppi di mercato. La topografia del<br />
comparto è frantumata in una miriade di piccole imprese, inibite, in Europa<br />
come in Italia, da: costi elevati del trattamento, estrema fluttuazione delle<br />
quotazioni delle materie prime, variabilità della qualità e degli standard delle<br />
plastiche da riciclo che spesso non permettono ai materiali riciclati di essere<br />
adoperati in un ciclo di lavorazione complesso…… Il mercato europeo della<br />
plastica riciclata si è incrementato stabilmente negli anni Ottanta e agli inizi<br />
degli anni Novanta per entrare in un periodo di forte crescita tra il 1993-1995<br />
con un trend del +15-20% annuo….. L’ammontare dei rifiuti in plastica riciclati<br />
ha raggiunto 1,4 milioni di tonnellate nel 1997 e ci si aspetta che cresca<br />
moderatamente. In relazione ai diversi polimeri e settori di mercato la predetta<br />
crescita annuale si stima possa oscillare tra il 4-8% fino al 2006, quando<br />
si valuta che il riciclo meccanico dei rifiuti in plastica post-uso avrà raggiunto<br />
2,7 milioni di tonnellate" (figura 86) [95].<br />
Negli ultimi anni si è assistito allo sviluppo di processi alternativi al<br />
riciclo meccanico attraverso i quali le plastiche recuperate possono essere<br />
“termovalorizzate” oppure riciclate mediante metodologie chimiche.<br />
Quest’ultimo processo, denominato “Feedstock Recycling” "industrialmen-<br />
169
te inesistente sino al 1993, ha conosciuto un certo sviluppo tecnologico negli<br />
anni successivi raggiungendo nel 1995 le 99.000 tonn. sino a conseguire in<br />
Europa Occidentale le 400.000 tonn. nel 1998" [95].<br />
Fig. 86: L’industria del riciclo della plastica in Europa [Rif. 95].<br />
170
d) Le funzioni dell’IRTeMP. - collaborazioni internazionali più<br />
significative - ruolo dei membri esterni del Consiglio Scientifico<br />
Nell’ambito dell’IRTeMP si sono via via consolidate una serie di funzioni<br />
(tavola XXXIII) che lo caratterizzano rispetto ad altri centri similari,<br />
siano essi industriali che accademici. Queste funzioni hanno favorito<br />
lo sviluppo di iniziative che, opportunamente combinate, bilanciate e<br />
modulate, hanno prodotto delle interessanti ed originali sinergie a seguito<br />
delle quali l’Istituto è di fatto divenuto un punto nodale di riferimento<br />
scientifico e culturale nel settore di propria competenza, non solo a livello<br />
nazionale ma anche internazionale.<br />
La rilevanza ed il significato dell’insieme di queste attività sono stati<br />
evidenziati e sottolineati con grande chiarezza dal Presidente del<br />
Consiglio Scientifico dell’Istituto, il Prof. F. E. Karasz (Università del<br />
Massacchussetts - USA), uno dei più eminenti scienziati nel campo della<br />
scienza dei polimeri, il quale nella sua introduzione al libro, pubblicato<br />
in occasione della celebrazione del Trentennale dell’IRTeMP (settembre<br />
1999) così ebbe a scrivere:<br />
"Historically Italy has been recognised as a leader in macromolecular science<br />
and technology, and IRTeMP has more than played its part in continuing<br />
and enhancing this well-deserved reputation.<br />
Altough research has been and should remain the central focus of the<br />
IRTeMP mission, the Institute, through the farsightedness of its leadership,<br />
has also spawned a remarkable array of “out-reach” venture – in education,<br />
in technology- transitioning, and famously in international co-operation. The<br />
climate for research is vastly different from what it was in 1969.<br />
In one way or another, we all must now compete for resources from a far<br />
more critical and demanding public pursue ………. It is by such out-reach<br />
activity that we can more readily demonstrate our relevance. In this respect<br />
IRTeMP has been far ahead of its time" [67].<br />
Tra le attività sviluppate particolarmente rilevante è quella rivolta alla<br />
diffusione e all’editoria, come si evince dalla tavola XXXIV, dove sono<br />
riprodotti i frontespizi delle principali opere pubblicate a cura<br />
dell’IRTeMP.<br />
Allo sviluppo culturale-scientifico dell’IRTeMP, e al suo consolidamento<br />
negli anni hanno dato un contributo di grande rilievo i membri<br />
171
fig. 87a<br />
fig. 87b<br />
Fig. 87:<br />
a) Fotomicrografia elettronica di cristalli singoli di polietilene cresciuti da soluzione<br />
diluita (Keller – 1958).<br />
b) Corrispondente spettro di diffrazione elettronica dei cristalli in a) (Keller – 1958).<br />
172
esterni del consiglio scientifico che fin dalla nascita dell’istituto, per consuetudine,<br />
ma anche per motivi di opportunità, erano stati scelti pariteticamente<br />
tra personalità di grande spicco appartenenti al mondo universitario-accademico<br />
e a quello industriale. Le fotografie di alcuni di essi<br />
sono riprodotte nella tavola XXXV.<br />
La crescita del grado di internazionalizzazione dell’IRTeMP è stata una<br />
costante strategica di tutti i Consigli Scientifici che si sono succeduti nel<br />
tempo e una politica fortemente voluta e perseguita dalla Dir<strong>ezio</strong>ne.<br />
Sicuramente il raggiungimento di questo obiettivo è stato facilitato dal<br />
consolidarsi di rapporti con centri internazionali di eccellenza nel settore<br />
della scienza e tecnologia dei polimeri.<br />
La collaborazione con il Prof. Andrew Keller (Physics Department of<br />
Bristol University – UK) e con i suoi collaboratori rappresenta uno degli<br />
esempi più significativi di questo processo.<br />
I rapporti tra l’IRTeMP e il Prof. Andrew Keller (tavola XXXVI), che<br />
si intrecciarono con la nascita di una profonda amicizia tra questa grande<br />
figura di uomo e scienziato, purtroppo recentemente scomparso, e<br />
l’Autore del presente volume, sono stati raccontati in un editoriale dal<br />
titolo “In memory of Andrew Keller: a great scientist, an unforgettable<br />
friend” [96], scritto anche per ricordare l’enorme e decisivo contributo<br />
dato da Andrew Keller allo sviluppo della scienza dei polimeri.<br />
Nel 1957 Andrew Keller, studiando il processo di cristallizzazione dei<br />
polimeri, che da soluzioni diluite portava alla formazione di cristalli singoli,<br />
scoprì il fenomeno del “Chain Folding”. Questa scoperta, che rappresentò<br />
una pietra miliare per la comprensione del complesso processo<br />
di cristallizzazione dei polimeri, anche in massa, fu determinante per lo<br />
sviluppo di una “vera” scienza dei polimeri, con risvolti non solo fondamentali,<br />
ma anche applicativi e tecnologici.<br />
Andrew Keller, nel suo lavoro, oramai di valore storico, dal titolo “A<br />
note on single crystals in polymers: evidence for a folded chain configuration”<br />
così descrisse la sua scoperta:<br />
" … “The most striking feature is the orientation of the molecules. It is found<br />
by selected area electron diffraction that the c axis (the direction of the molecular<br />
chains) is perpendicular to the surface of the crystal, the a and b axes<br />
being respectively along the long and short diagonals of the lozenge … the<br />
thickness of the basic layer is about 100 Å … Secondly, the length of the<br />
molecules has to be assessed … Consequently it can be stated that the phenomena<br />
observed were typical of molecules many hundred and thousand<br />
angströms long …., the above findings lead to the inescapable conclusion<br />
173
that the long chain molecules must bend back on themselves forming a folded<br />
configuration …”" [97].<br />
La fotomicrografia elettronica di cristalli singoli di polietilene, e il corrispondente<br />
spettro di diffrazione elettronico, dalla cui analisi comparativa<br />
si giunse alla conclusione univoca che alla superficie dei cristalli le<br />
macromolecole dovessero necessariamente rientrare nel cristallo, sono<br />
riportati nella figura 87 [97].<br />
I primi modelli proposti da Keller, per spiegare, a livello molecolare e<br />
strutturale, il fenomeno di ripiegamento e rientro delle macromolecole<br />
alla superficie dei cristalli sono illustrati nella figura 88 [97, 98, 99].<br />
"Keller first recognised that the phenomenon of chain folding may occur<br />
according to several processes which give origin to different structures for<br />
the surfaces of lamellar single crystals..................................Keller himself,<br />
referring to it, wrote:<br />
“… That is how in 1957 in an –office- filled with fumes, sparks and scattered<br />
x ray, amidst total isolation from, in fact in ignorance of the rest of polymer<br />
science, single crystals and chain folding were recognized”" [96].<br />
L’Autore, nel suo già citato scritto, così ricorda la collaborazione e la<br />
profonda amicizia con A. Keller che tanto peso ebbe sulla sua formazione<br />
di “scientist”:<br />
"Under the knowledgeable guidance of Professor Keller, I followed up my<br />
research activities in the field of morphology and the cristallisation of<br />
macromolecules, with particular regard to the relationship between the properties<br />
and the structures of polymers.<br />
In an atmosphere animated by the fullness of our meetings and the disinterested<br />
passion for pure research, friendship soon grew up between us, a<br />
friendship which blossomed into our mutual feelings of esteem and affection.<br />
Two years of intellectual fervour went by, during which my scientific training<br />
received both a boost and a consolidation of knowledge which is still<br />
essential for me today. His masterly lessons always had the rare power of<br />
transmitting new stimuli and original ideas to his collaborators.<br />
From 1969 onwards, the CNR – Institute for Research and Technology of<br />
Plastic Materials built up relationship of intense exchange with Professor<br />
Keller, who, at regular intervals, stayed in Naples, where he brought knowledge,<br />
discoveries and last but not least, human warmth, through the various<br />
conferences and debates held.<br />
It was indeed possible to discuss not only science but culture, history and art<br />
too with Andrew Keller. He loved the city of Naples very deeply …. A large<br />
number of researchers owes a great deal to Keller and I personally owe a<br />
great deal to Keller too. Under his farsighted and enthusiastic guidance, I<br />
learned the art of the science of polymers with all the wealth of its theoreti-<br />
174
cal and technological applicatory varieties. The latter were the permanent<br />
object of his sensivity as a scientist" [96].<br />
La collaborazione tra l’IRTeMP ed il Prof. A. Keller favorì lo sviluppo<br />
di competenze, non solo nell’ambito dell’Istituto, ma anche in altri centri<br />
di ricerca italiani, nel campo della morfologia e struttura dei polimeri<br />
e dei processi di cristallizzazione. Si aprì un nuovo filone di ricerca con<br />
l’obiettivo di correlare la strutturazione delle fasi nei possibili stati condensati<br />
dei materiali polimerici (morfologia e struttura) con le proprietà<br />
applicative e con i processi di lavorazione.<br />
Di grande rilevanza risultarono anche i rapporti che la Dir<strong>ezio</strong>ne e molti<br />
ricercatori ebbero con il Prof. E. Frank Karasz, dal 1995 Presidente del<br />
Consiglio Scientifico dell’IRTeMP, che permisero di consolidare una<br />
importante tematica di ricerca sulle miscele di polimeri, ancora oggi fortemente<br />
presente e attiva nell’ambito dell’Istituto. Su questo tema da<br />
circa 15 anni si è concentrata una buona parte dell’attività più significativa<br />
dei gruppi di ricerca dell’IRTeMP.<br />
Fig. 88: I primi modelli molecolari proposti<br />
da Keller per dare una spiegazione al<br />
fenomeno del “Chain Folding” alla superficie<br />
dei cristalli singoli di polimeri cresciuti<br />
da soluzioni diluite [Rif. 96, 97, 98,<br />
99].<br />
175
Gli studi hanno portato a risultati di grande rilevanza con ampi riconoscimenti<br />
a livello nazionale ed internazionale sia dal punto di vista fondamentale<br />
che applicativo. In particolare, facendo riferimento alla figura<br />
89, le ricerche condotte hanno permesso di delucidare il processo di strutturazione<br />
delle fasi in funzione della composizione, della storia termica,<br />
delle condizioni di cristallizzazione e di lavorazione in una serie di sistemi<br />
polimerici binari e ternari (miscibili, immiscibili, incompatibili e<br />
compatibili), sviluppando altresì una metodologia chimica finalizzata<br />
alla compatibilizzazione, mediante, processi di “reactive blending” e l’utilizzo<br />
di copolimeri aventi capacità “compatibilizzanti”.<br />
Come già precedentemente riportato, attraverso processi di “blending”<br />
mirati è stato possibile modulare, nel caso di sistemi binari miscibili nel<br />
Fig. 89: La tecnologia del “Blending” e del “Reactive Blending” permette di realizzare<br />
una vasta gamma di materiali con caratteristiche innovative e con una varietà di strutturazione<br />
delle fasi e della morfologia dalle quali ultime dipendono le proprietà finali del<br />
sistema.<br />
176
fuso, la velocità di crescita radiale degli sferuliti (G), la temperatura di<br />
fusione Tm e di transizione vetrosa (Tg) di polimeri termoplastici cristallizzabili.<br />
A titolo esemplificativo nella figura 90 viene riportata la variazione di<br />
G con la temperatura di cristallizzazione (Tc) relativamente alla coppia,<br />
miscibile, poli(3-idrossibutirrato) (P3HB) e poli(epicloroidrina) (PECH)<br />
[Rif. 100, 101, 102].<br />
Come evidenziato anche dall’andamento delle curve in figura 91, la<br />
velocità di crescita radiale di sferuliti di P3HB, a Tc costante, decresce<br />
monotonicamente al crescere della concentrazione di un secondo componente<br />
termodinamicamente miscibile nel fuso. In particolare i dati relati-<br />
Fig. 90: La velocità di crescita radiale degli sferuliti (G) di poli (3-idrossibutirrato)<br />
(P3HB) è riportata in funzione della temperatura di cristallizzazione (Tc).<br />
Le curve si riferiscono al P3HB puro e a miscele contenenti poli(epicloroidrina) (PECH)<br />
che, agendo da diluente, a parità di Tc, abbassa la G del P3HB.<br />
La composizione delle miscele PHB/PECH (w/w) è indicata su ciascuna delle curve<br />
[Rif. 100, 101, 102].<br />
177
Fig. 91: Variazione della velocità di crescita radiale degli sferuliti di P3HB in funzione<br />
della composizione, a Tc costante, nel caso di sistemi binari miscibili:<br />
• P3HB/polivinilacetato (PVAc).<br />
•<br />
P3HB/Polietilene ossido (PEO) [Rif. 103].<br />
vi alle curve della figura 91 si riferiscono a miscele di P3HB con polivinilacetato<br />
(PVAc) e con polietilene ossido (PEO) [103].<br />
In sistemi binari miscibili si osserva, di regola, che la temperatura di<br />
transizione vetrosa Tg, una grandezza dalla quale dipendono importanti<br />
caratteristiche applicative e tecnologiche, varia monotonicamente con la<br />
composizione, così come viene mostrato in figura 92 nel caso del sistema<br />
P3HB/PEO [104, 105].<br />
Nel caso di sistemi binari i cui componenti non siano miscibili tra loro,<br />
allora la possibilità di un loro utilizzo dipende dal modo e stato di dispersione<br />
del componente minore, dalla struttura delle fasi e dall’adesione<br />
all’interfaccia matrice/fase dispersa. Una tipica morfologia di un sistema<br />
non miscibile, ma compatibile, cioè con una buona adesione interfacciale,<br />
è illustrata nella figura 93 dove viene riportata una micrografia elet-<br />
178
Fig. 92: Variazione della temperatura di transizione vetrosa (Tg) con la composizione<br />
nel caso del sistema binario miscibile poli(3-idrossibutirrato) (P3HB)/polietilene ossido<br />
(PEO) [Rif. 104].<br />
Fig. 93: Micrografia elettronica a scansione della superficie di frattura di un campione<br />
della lega P3HB/POM (20/80) (w/w)[Rif. 106].<br />
179
tronica a scansione della superficie di frattura di una lega P3HB/poliossimetilene<br />
(POM) avente una composizione in peso 20/80. Sono facilmente<br />
visibili i domini sferici di P3HB dispersi nella matrice di POM<br />
[106, 107].<br />
In oltre trenta anni di attività l’IRTeMP ha centrato importanti obiettivi<br />
scientifici, culturali e tecnologici. Esso rappresenta un importante anello<br />
di quella che può essere definita la rete di ricerca italiana nel campo della<br />
scienza dei polimeri.<br />
L’Istituto ha svolto, così come fa tuttora, in molte occasioni, un ruolo<br />
trainante attraverso il coordinamento e la gestione di importanti programmi<br />
nazionali ed internazionali che prevedono la partecipazione di<br />
altre istituzioni (italiane e straniere, pubbliche e private).<br />
Una visione moderna e dinamica della ricerca in un contesto caratterizzato<br />
da una rapida evoluzione delle conoscenze a da una globalizzazione<br />
dell’innovazione, richiede agli organismi scientifici una grande capacità<br />
di competizione a livello internazionale, che per essere costantemente<br />
mantenuta deve necessariamente prevedere continui adeguamenti organizzativi<br />
e di indirizzo scientifico. Quanto sopra vale anche per l’IRTeMP<br />
per il quale ci si auspica l’avvio di una appropriata revisione delle attività<br />
che abbia l’obiettivo di accrescerne la competitività ed incisività in un<br />
settore trainante, per il sistema paese, quale è quello delle “tecnologie<br />
chimiche innovative ed ecosostenibili finalizzate alla realizzazione e alla<br />
caratterizzazione di materiali polimerici con caratteristiche mirate a specifici<br />
utilizzi”.<br />
Importanti eventi quali la riforma della rete scientifica del CNR, la<br />
creazione di uno spazio europeo della ricerca, la disponibilità, dopo oltre<br />
trent’anni, di una nuova e più adeguata sede (Tavola XXXVII), potranno<br />
favorire il potenziamento in termini di uomini, apparecchiature ed infrastrutture<br />
dell’IRTeMP e quindi una sua più idonea ricollocazione quale<br />
centro di eccellenza nello scenario nazionale ed internazionale della<br />
ricerca nel campo della scienza e tecnologia dei polimeri [108].<br />
180
TAVOLA XVIII<br />
Tavola XVIII: Il logo dello “Sportello per la Cooperazione Scientifica e<br />
Tecnologica con i Paesi del Mediterraneo” (CNR) così come riportato sul<br />
frontespizio della brochure illustrativa delle sue finalità.<br />
181
TAVOLA XIX<br />
Tavola XIX:<br />
Frontespizio della brochure della “Euro-Mediterranean post-graduated advanced<br />
school” on "New materials and technologies for the conservation and restoration of cultural<br />
heritage consisting of natural fibrous polymers" organizzata dallo SMED e<br />
dall’IRTeMP in collaborazione con Enti Pubblici italiani e stranieri.<br />
182
TAVOLA XX<br />
a)<br />
b)<br />
Tavola XX: Serie di<br />
fotografie scattate<br />
durante momenti topici<br />
della “Euro-<br />
Mediterranean<br />
School” descritta in<br />
tavola XIX:<br />
a) l<strong>ezio</strong>ne di apertura<br />
tenuta dall’ Autore.<br />
b) il simbolo della<br />
scuola: la riproduzione<br />
di un antico telaio<br />
verticale a pesi.<br />
183
TAVOLA XX<br />
c)<br />
d)<br />
Tavola XX: Serie di fotografie scattate durante momenti topici della “Euro-<br />
Mediterranean School” descritta in tavola XIX:<br />
c) discenti provenienti da molti paesi dell’area mediterranea e non, in aula durante una<br />
delle l<strong>ezio</strong>ni;<br />
d) la seduta di apertura; vari relatori al tavolo della presidenza (da sinistra a destra: l’addetto<br />
scientifico italiano in Egitto, il dott. G. Marino, il prof. A. Guarino, l’Autore e il<br />
prof. V. Kouzminov - Unesco Venice Office).<br />
184
TAVOLA XX<br />
e)<br />
Tavola XX: Serie di fotografie scattate durante momenti topici della “Euro-<br />
Mediterranean School” descritta in tavola XIX:<br />
e) la seduta di apertura; vari relatori al tavolo della presidenza;<br />
f) la foto di gruppo a ricordo dell’evento, sono presenti gli organizzatori, i docenti e i<br />
discenti.<br />
185
TAVOLA XX<br />
f)<br />
186
TAVOLA XXI<br />
Tavola XXI: Frontespizio di<br />
“Mediterranean Magazine,<br />
Science, Training and<br />
Technology” (N.2 July 1999);<br />
periodico di diffusione e trasferimento<br />
edito dallo SMED.<br />
TAVOLA XXII<br />
Tavola XXII: Frontespizio<br />
della brochure di “announcement”<br />
della “Third Mediterranean<br />
Exhibition of technological<br />
Innovation” - Naples -<br />
December - 9, 12 (1998).<br />
187
TAVOLA XXIII<br />
Tavola XXIII: Frontespizio del libro pubblicato dall’Autore nell’ambito del quale<br />
viene messa in risalto, tra l’altro, l’importanza della conservazione e restauro del patrimonio<br />
culturale basato sui tessili (arazzi, tappeti, tele ecc.) [Rif. 77].<br />
188
TAVOLA XXIV<br />
Tavola XXIV: Esempio di applicazione dei polimeri nel campo del restauro conservativo<br />
di beni culturali: cavallo in vetro, restaurato e parzialmente ricostruito con Araldite<br />
2020 [Rif. 80].<br />
189
TAVOLA XXV<br />
a)<br />
b)<br />
Tavola XXV: utilizzo dei polimeri nel settore dei beni culturali: a) Veduta della sala<br />
ottogonale della “domus aurea” (Roma) prima dell’intervento; si nota, in alto, l’apertura<br />
chiusa da una rudimentale grata metallica; b) Vista dall’alto della struttura intermedia<br />
e del relativo cupolino semisferico in PMMA usato per la chiusura dell’occhio<br />
[Rif. 81].<br />
190
TAVOLA XXVI<br />
Tavola XXVI: Le funzioni e l’assetto societario del Consorzio sulle Applicazioni delle<br />
Materie Plastiche e per i Problemi di Difesa dalla Corrosione (CAMPEC).<br />
191
TAVOLA XXVII<br />
a)<br />
b)<br />
Tavola XXVII: Alcuni momenti significativi del Convegno “I Materiali Polimerici del<br />
21° Secolo” organizzato dall’IRTeMP in occasione della celebrazione dei Trent’anni di<br />
Attività (1969-1999) (Napoli, 17-18 Settembre 1999).<br />
a) e b) Il Prof. F.E. Karasz, Presidente del Consiglio Scientifico dell’Istituto, il Prof. A.<br />
Sgamellotti, membro del Consiglio Direttivo del CNR, ed il Direttore dell’IRTeMP E.<br />
Martuscelli durante i loro interventi di apertura.<br />
192
TAVOLA XXVII<br />
d 1 )<br />
c)<br />
Tavola XXVII:<br />
c) Il Prof. V. Kouzminov<br />
(Unesco-Venice Office)<br />
(al centro), il Prof. A Zihlif<br />
(University of Jordan-<br />
Amman) (a destra) durante<br />
i loro interventi insieme<br />
al Direttore, E. Martuscelli,<br />
che presiede.<br />
d) La consegna di targhe<br />
ed attestati a personalità<br />
che nel corso degli anni<br />
hanno contribuito alla crescita<br />
culturale e scientifica<br />
dell’IRTeMP.<br />
d 1 ) Il Direttore consegna<br />
la targa al Presidente del<br />
C.S., Prof. F. E. Karasz.<br />
193
TAVOLA XXVII<br />
d 3 )<br />
d 2 )<br />
Tavola XXVII:<br />
d 2 ) il Presidente del C.S.<br />
consegna la targa al Prof.<br />
R. Cipollini;<br />
d 3 ) consegna della targa<br />
al Dr. T. Simonazzi.<br />
194
TAVOLA XXVII<br />
d 4 )<br />
d 5 )<br />
Tavola XXVII:<br />
d 4 ) il Prof. R. Palumbo<br />
mentre riceve la targa dal<br />
Presidente del C.S.;<br />
d 5 ) il Prof. A. Zihlif ringrazia<br />
dopo aver ricevuto l’attestato.<br />
195
TAVOLA XXVII<br />
Tavola XXVII:<br />
d 6 ) il conferimento della<br />
targa alla Dott.ssa C.<br />
Kummerlowe;<br />
d 7 e d 8 ) il Direttore<br />
dell’IRTeMP ed il<br />
Presidente del C.S. premiano<br />
il Rag. P. Buono ed il Sig.<br />
A. Botta per la loro attività<br />
di grande profilo svolta a<br />
favore dell’Istituto.<br />
d 7 )<br />
d 6 )<br />
196
TAVOLA XXVII<br />
d 8 )<br />
197
TAVOLA XXVIII<br />
Tavola XXVIII: Ingresso del Centro di Ricerca “Giulio Natta” di Ferrara. Sulla destra<br />
è visibile la catena del polipropilene isotattico (ingrandita di 4 miliardi) dedicata alla<br />
grande scoperta di questo polimero (foto da archivio personale del dott. T. Simonazzi).<br />
198
TAVOLA XXIX<br />
Tavola XXIX: Visione notturna dell’impianto pilota per la produzione di poliolefine<br />
(Himont - Ferrara - anno 1994). Foto gentilmente concessa dal dott. Tonino Simonazzi.<br />
199
TAVOLA XXX<br />
b)<br />
a)<br />
Tavola XXX:<br />
a) Paraurti a base di polipropilene antiurto rinforzato con gomme etilene-propilene<br />
montato su auto Fiat (anno 1994).<br />
b) Studio dei meccanismi e dei processi di frattura nel caso di polipropilene ad alta resistenza<br />
alla frattura. Effetti termici osservabili quando un campione di polipropilene<br />
modificato con gomma viene sottoposto ad urto (metodo Charpy).<br />
Foto gentilmente concesse dal dott. Tonino Simonazzi.<br />
200
TAVOLA XXXI<br />
Tavola XXXI: I produttori di birra in paesi quali Germania, Regno Unito, Belgio,<br />
Francia e Austria utilizzano bottiglie in PET [Rif. 92].<br />
TAVOLA XXXII<br />
Tavola XXXII:<br />
Il PET, per le sue proprietà<br />
barriera trova utilizzo nella<br />
produzione di bottiglie per<br />
acqua minerale ed olio edibile<br />
[Rif. 93].<br />
201
TAVOLA XXXIII<br />
Tavola XXXIII: Attività e funzioni sviluppatesi, negli anni, nell’IRTeMP.<br />
202
TAVOLA XXXIV<br />
a)<br />
b)<br />
Tavola XXXIV: attività editoriale svolta dall’ IRTeMP. Sono riportati i frontespizi di<br />
alcuni dei più significativi volumi editi dall’Istituto e pubblicati da case editrici di livello<br />
internazionale.<br />
a) Plenum Press - New York (1980); volume 1;<br />
b) Plenum Press - New York (1984); volume 2.<br />
203
TAVOLA XXXIV<br />
c)<br />
d)<br />
Tavola XXXIV:<br />
c) Science Press - Utrecht (1987);<br />
d) Technomic, Publishing Company Inc. - Lancaster - Basel (1987).<br />
204
TAVOLA XXXIV<br />
e)<br />
Tavola XXXIV:<br />
e) Elsevier - Amsterdam (1996).<br />
205
TAVOLA XXXV<br />
a)<br />
b)<br />
Tavola XXXV: I membri esterni<br />
del Consiglio Scientifico dell’<br />
IRTeMP hanno fortemente contribuito<br />
alla crescita culturale e scientifica<br />
dell’Istituto.<br />
Alcuni di essi sono raffigurati nelle<br />
fotografie qui di seguito riportate:<br />
a) Il Prof. Paolo Corradini (nella<br />
foto il secondo da destra con gli<br />
occhiali) all’epoca in cui era un<br />
giovane collaboratore del Prof.<br />
Natta; fra i fondatori dell’Istituto<br />
fu Presidente del Consiglio<br />
Scientifico dell’ IRTeMP – dal<br />
1969 al 1995.<br />
b) Il Dott. Mario Buzzone, all’epoca<br />
responsabile della ricerca e sviluppo<br />
di EniChem Elastomeri<br />
s.p.a. (membro del C.S. dal 1969 al<br />
1978). Dal 1945 al 1961 ha collaborato,<br />
presso il politecnico di<br />
Milano (allora dipendeva dalla<br />
Montecatini s.p.a.) con il prof. G.<br />
Natta nella messa a punto di elastomeri<br />
innovativi.<br />
206
TAVOLA XXXV<br />
c)<br />
d)<br />
Tavola XXXV:<br />
c) Il Prof. Giovanni Pezzin, fu membro<br />
del C.S. dal 1969 al 1973 e dal 1981 al<br />
1990. La foto è stata scattata a Siena<br />
nel 1973 in occasione del II Convegno<br />
della Società Italiana di Reologia di<br />
cui fu il primo presidente.<br />
d) Il prof. Mario Butta, dipartimento di<br />
Ingegneria Chimica, Chimica<br />
Industriale e Scienza dei Materiali<br />
dell’ Università di Pisa. Fu membro<br />
del C.S. dal 1975 al 1978 e, successivamente,<br />
dal 1979 al 1980.<br />
207
TAVOLA XXXV<br />
e)<br />
f)<br />
Tavola XXXV:<br />
e) Il Dott. Giovanni Di Drusco (in piedi nella foto scattata nel Gennaio 1984 durante la<br />
cerimonia di consegna delle targhe commemorative per la costituzione di Himont, joint<br />
venture tra Montedison ed Hercules (1983)), fu membro del C.S. dal 1981 al 1986.<br />
f) Il Dott. Tonino Simonazzi (il primo a partire da sinistra) all’epoca Director of<br />
Research and Development del Centro Ricerche G. Natta dell’Himont (Ferrara) (membro<br />
del C.S. dal 1991 al 1995).<br />
208
TAVOLA XXXV<br />
g)<br />
h)<br />
Tavola XXXV:<br />
g) Il dott. Fabio Garbassi (EniChem) fece parte del C. S. dal 1991 al 1995.<br />
h) Il dott. Antonio Casale (SNIA- Ricerche) (membro del C.S. dal 1995).<br />
La fotografia è stata scattata mentre viene consegnata al dott. A. Casale (a destra), in<br />
rappresentanza della SNIA Tecnopolimeri, l’oscar dell’imballaggio (1986).<br />
209
TAVOLA XXXV<br />
i)<br />
l)<br />
Tavola XXXV:<br />
i) Il Dott. Giuliano Cecchin, Director of Research and Development of Montell<br />
Technology- Centro Ricerche G. Natta (Ferrara) (membro del C.S. dal 1995).<br />
l) Il Prof. Enrico Pedemonte (Università di Genova – Dipartimento di Chimica e<br />
Chimica Industriale) (membro del C.S. dal 1995), a destra nella foto con l’Autore.<br />
210
TAVOLA XXXV<br />
m)<br />
Tavola XXXV:<br />
m) Il prof. Frank Erwin Karasz, University of Massachussets (USA),<br />
Presidente del CS dell’IRTeMP dal 1995.<br />
211
TAVOLA XXXVI<br />
a)<br />
Tavola XXXVI:<br />
a) Frontespizio di Journal of Material Science dedicato al prof. Andrew<br />
Keller.<br />
212
TAVOLA XXXVI<br />
b)<br />
Tavola XXXVI:<br />
b) L’Autore con il Prof. Andrew Keller (a destra nella foto) che scoprì il fenomeno del<br />
“Chain Folding”. Il Prof. Keller ha rappresentato per l’IRTeMP un importante punto di<br />
riferimento scientifico. Alla sua scuola si sono formati l’autore e altri ricercatori<br />
"Of Hungarian origin, Andrew Keller entered the H. H. Wills Physics<br />
Laboratory in Bristol, having won a scholarship in 1955, where he taught for<br />
more than 35 years".<br />
Fotografia scattata durante la Second Mediterranean School on “Science and<br />
Technology of Advanced Polymer based Materials” 26 May – 7 June 1991, Capri.<br />
213
TAVOLA XXXVII<br />
a)<br />
Tavola XXXVII:<br />
Lo stabilimento olivetti di Pozzuoli (Na) nel cui ambito ha trovato collocazione l’<br />
IRTeMP<br />
a) Il complesso Olivetti visto nel contesto urbano ed ambientale con, sullo sfondo, il<br />
castello di Baia.<br />
214
TAVOLA XXXVII<br />
b)<br />
Tavola XXXVII:<br />
b) Il giardino e la piscina cisterna<br />
215
TAVOLA XXXVII<br />
c)<br />
Tavola XXXVII:<br />
c) Particolare dell’ex officina<br />
216
TAVOLA XXXVIII<br />
Trent’anni<br />
(1968-1998)<br />
Da grande tumulto<br />
di gente che lotta<br />
tra prove e sudori<br />
di buon pensatori<br />
nel pieno vigore<br />
di fuoco ch’avvampa<br />
sei nata splendente<br />
o gemma sapiente.<br />
Cresciuta nel grembo<br />
di forti valori<br />
guidata nel tempo<br />
da prodi nocchieri<br />
nei lunghi orizzonti<br />
di terre lontane<br />
Sicura tu miri<br />
progresso e virtù.<br />
Hai dato speranza<br />
a chi la cercava<br />
hai fatto gioire<br />
chi tanto soffriva<br />
colmato di luce<br />
i molti credenti<br />
offerto il tuo cuore<br />
a gente che muore<br />
fornito gioielli<br />
a menti eccellenti<br />
che ora coscienti<br />
li serban contenti.<br />
Il volto risplende<br />
dei savi dottori<br />
venuti a mirare<br />
ricerche ed allori<br />
chi quanto ha pensato<br />
studiato e provato<br />
chi tanto ha cercato<br />
il buon risultato<br />
e tornano lieti<br />
alle loro nazioni<br />
facendo tesoro<br />
di sagge l<strong>ezio</strong>ni.<br />
Sei giunta a trent’anni<br />
di aspro cammino<br />
tra rupi e rovine<br />
esami e fatiche<br />
siam lieti d’offrire<br />
a cielo e creato<br />
buon luce di scienza<br />
scoperte inebrianti<br />
Tavola XXXVIII: Poesia scritta dal Geometra Francesco Palumbo, responsabile dell’ufficio<br />
tecnico e della sicurezza dell’IRTeMP, in occasione della celebrazione dei<br />
trent’anni di attività dell’Istituto.<br />
217
218
PARTE III<br />
PROSPETTIVE PER LA <strong>RICERCA</strong><br />
SUI POLIMERI IN ITALIA.<br />
219
220
Lo sviluppo di materiali polimerici, con caratteristiche innovative, rappresenta<br />
uno dei fattori determinanti per l’introduzione di nuove tecnologie<br />
in settori dal cui progresso può dipendere l’economia dei paesi più<br />
industrializzati.<br />
L’Accademia svedese delle Scienze ha conferito il premio Nobel 2000,<br />
per la Chimica, a due scienziati americani, Alan J. Heeger e Alan G.<br />
MacDiarmid e ad uno scienziato giapponese, Hideki Shirakawa, per<br />
avere scoperto e sviluppato polimeri, che, opportunamente “drogati”,<br />
sono capaci di condurre la corrente elettrica (figure 94, 95 e 96) [109,<br />
110, 111].<br />
Questa scoperta ha posto le basi, per la realizzazione di nuovi dispositivi<br />
per l’elettronica (diodi ad emissione di luce, schermi elettromagnetici,<br />
celle elettrovoltaiche, sensori, transistor, display elettrocromici, fine-<br />
Fig. 94: I vincitori del Premio Nobel 2000, per la Chimica.<br />
Da sinistra: Alan J. Heeger (nato nel 1936, dal 1982 professore di fisica all’Università<br />
della California, Santa Barbara, (USA)); Alan G. MacDiarmid (nato nel 1927, dal 1988<br />
Professore di Chimica – Università della Pensilvania, (USA)); Hideki Shirakawa (nato<br />
nel 1936, dal 1982 alla primavera del 2000 Professore all’Università di Tsukuba,<br />
(Giappone)).<br />
221
Fig. 95: Struttura Chimica di polimeri che, convenientemente drogati, possono esibire<br />
elevata conduttività [Rif. 110].<br />
Fig. 96: Conducibilità di polimeri conduttivi paragonata a quella di altri materiali, dal<br />
quarzo (isolante) al rame (conduttore). I polimeri possono anche avere conducibilità<br />
corrispondente a quella dei semi-conduttori.<br />
222
stre auto-oscuranti ecc.) e per lo sviluppo dell’elettronica molecolare e<br />
della miniaturizzazione di componenti elettronici [109, 110, 111, 112].<br />
Il Premio Nobel 2000 per la Chimica, assegnato a Heeger, MacDiarmid<br />
e Shirakawa conferma la centralità e la pervasività dei polimeri in un<br />
moderno sistema la cui produzione sia indirizzata prevalentemente verso<br />
prodotti ad alto tasso di tecnologia.<br />
Le industrie ad alta tecnologia, cioè quelle dove è maggiore l’investimento<br />
in ricerca, sono quelle che creano più posti di lavoro e come si<br />
evince dai dati dell’Ocse le nazioni, ma anche le regioni europee, che<br />
investono in Ricerca & Sviluppo sono quelle più capaci a combattere la<br />
disoccupazione (figura 97) [Rif. 113].<br />
La centralità dei polimeri è stata riaffermata in un recente rapporto pubblicato<br />
dall’ “Istitute for Prospective Technological Studies” (Joint<br />
Research Centre, European Commission):<br />
"Of the four main categories (metals, polymers, composites and ceramics),<br />
future growth areas will be in ceramics and polymers, with metals remaining<br />
significant but shrinking in relative importance. Top application fields are in<br />
transport, electronics and mechanical systems, construction and packaging.<br />
Of increasing importance are applications in the two key generic technologies:<br />
Information and communication technologies and life sciences.<br />
For example, most recent foresight studies have suggested that the biocompatibility<br />
of materials, such as polymers … is now a key issue" [114] (figura<br />
98).<br />
Fig. 97: Spesa in R&S e disoccupazione [Rif. 113].<br />
223
224<br />
Fig. 98: Il bilancio dei materiali in funzione del tempo. Dalla pre-istoria al terzo millennio [Rif. 114].
Il rafforzamento della ricerca sui polimeri viene visto, quindi, come uno<br />
strumento necessario per realizzare prodotti meno costosi, più affidabili,<br />
con qualità e prestazioni migliori e dotati, tra l’altro, di una maggiore idoneità<br />
al riciclo e alla sostenibilità ambientale (environmental friendly<br />
advanced polymers and related technologies).<br />
Esempi emblematici di come sia possibile, attraverso l’utilizzo di nuovi<br />
materiali polimerici e di nuove tecnologie di processo, affrontare problematiche<br />
ambientali di grande rilevanza, sono illustrati nelle tavole<br />
XXXIX e XL [115 e 116].<br />
Nelle tavole XLI, XLII e XLIII sono documentate applicazioni di polimeri<br />
in campi di grande attualità, quali quelli del restauro e conservazione<br />
dei beni culturali, dell’imballaggio alimentare, dell’auto e dell’attrezzistica<br />
industriale [117 e 118].<br />
L’implementazione del sistema ricerca sulle plastiche richiede l’attivazione<br />
di percorsi formativi per creare profili di ricercatori e tecnici con<br />
competenze sulle proprietà dei materiali (termiche, meccaniche, fotoelettromagnetiche,<br />
biochimiche ecc.), sui processi (progettazione, formulazione,<br />
lavorazione ecc.), oltre che sulle metodologie di sintesi, sulla<br />
catalisi e sulle tecniche di caratterizzazione molecolare e strutturale.<br />
La scienza dei polimeri rappresenta pertanto un importante elemento<br />
propulsivo, parte integrante di uno scenario internazionale che rapidamente<br />
evolve verso una “Knowledge Driven Economy” ed una “Global<br />
Knowledge Society”.<br />
"Exciting discoveries and inventions have given the field of polymers and<br />
plastics great vitality and significant growth over the recent years. A continuous<br />
flow of new materials and new processing technologies has led us to<br />
applications unknown or not possible before" [119].<br />
In Italia, come già ampiamente scritto nel presente volume, grazie alla<br />
spinta propulsiva di Giulio Natta e dei suoi collaboratori, fin dalla fine<br />
degli anni ’50 si è andata costituendo una importante rete di organismi di<br />
ricerca pubblici e privati nel campo della scienza delle macromolecole.<br />
Particolarmente interessante e rilevante appare il patrimonio culturale e<br />
scientifico rappresentato dalla rete tematica nel settore dei polimeri che<br />
negli anni si è consolidata nell’ambito del Consiglio Nazionale delle<br />
Ricerche.<br />
Questa rete, nel suo insieme, stenta a mantenere il grado di competitività<br />
e di eccellenza raggiunto dopo anni di laboriosa e fruttuosa attività.<br />
La fase di stallo dipende da una serie di fattori, oramai ben noti, che<br />
riguardano in generale tutto il sistema ricerca del nostro paese, che pre-<br />
225
senta significativi elementi di debolezza, collegati alla difficoltà di:<br />
a) disporre di finanziamenti ed infrastrutture adeguati;<br />
b) dotarsi in tempi brevi di nuove apparecchiature;<br />
c) avviare un efficace “turnover”, per abbassare l’età media dei ricercatori;<br />
d) sviluppare rapporti paritetici, con scambio di addetti, tra centri di<br />
ricerca afferenti all’Università, agli Enti Pubblici e alle industrie.<br />
Il perdurare negli anni di questi fattori ha determinato un progressivo<br />
abbassamento della capacità di competizione, sia a livello nazionale che<br />
internazionale, degli Organi del CNR che operano nel settore della scienza<br />
dei polimeri i quali, pertanto, appaiono strutturalmente poco attrezzati<br />
a svolgere quel ruolo operativo congruente con le finalità richieste da<br />
una società industriale in rapida evoluzione basata sempre più sulla veloce<br />
acquisizione delle conoscenze e sulla globalizzazione dell’innovazione<br />
tecnologica, sia essa di processo che di prodotto.<br />
Da questo quadro emerge l’esigenza di adeguare le potenzialità degli<br />
organi del CNR che costituiscono la “rete tematica di ricerca nel settore<br />
delle macromolecole sintetiche e naturali” al fine di dotare il paese Italia<br />
di uno strumento operativo che sia in grado di inserirsi, a pieno titolo, in<br />
un contesto europeo, dove la ricerca scientifica e tecnologica assume<br />
sempre di più un ruolo trainante per lo sviluppo socio-economico delle<br />
nazioni.<br />
"Il XXI secolo può essere considerato, ancor di più di quello che lo ha preceduto,<br />
il secolo della scienza e della tecnologia e l’attività di ricerca e sviluppo<br />
tecnologico appare, oggi come non mai, una delle vie più promettenti<br />
per il futuro" [120].<br />
Fig. 99: La tendenza da parte delle aziende ad affidare a centri esterni attività di ricerca<br />
e sviluppo aumenta nel tempo [Rif. 121].<br />
226
Fig. 100: Le aziende affidano attività in “outsourcing”. Tra queste prevalgono quelle<br />
concernenti la ricerca (53%) [Rif. 121].<br />
La necessità che il nostro paese abbia un sistema di ricerca efficiente e<br />
competitivo nel campo dei polimeri è da mettere in relazione, tra l’altro,<br />
alle seguenti specifiche problematiche:<br />
i) una domanda di supporto, ad elevato contenuto scientifico e tecnologico,<br />
proveniente da una ampia platea di piccole e medie aziende,<br />
molte delle quali attive in nicchie caratterizzate da produzioni<br />
innovative ad alto valore aggiunto;<br />
ii) la chiusura e/o il progressivo trasferimento all’estero di centri di<br />
ricerca industriali;<br />
iii) la tendenza da parte dell’UE a riorientare le attività di ricerca<br />
scientifica e tecnologica verso un “problem solving approach”<br />
[108];<br />
iv) un contesto industriale dove l’ “outsourcing” di attività di ricerca<br />
scientifica e tecnologica, finalizzate allo sviluppo di prodotti innovativi,<br />
è sempre più rilevante ("There is a common trend in Europe,<br />
the United States, and Japan for companies to rely more and more, on<br />
external resources for R&D activities. According to various studies<br />
European companies spend between zero and 10 percent of their total<br />
R&D budgets outside the company. In the United Kingdom, the figure is<br />
around 16 percent. This is a trend that is growing quite dramatically<br />
around the world") [121] (figura 99).<br />
Un’analisi concernente la tipologia delle attività date in “outsourcing”<br />
227
porta alla conclusione che quelle concernenti la ricerca predominano nettamente<br />
rispetto a quelle di sviluppo e progettazione (rispettivamente<br />
53%, 20% e 27%) (figura 100). Inoltre i principali beneficiari delle commesse<br />
esterne di ricerca risultano essere proprio le istituzioni accademiche<br />
e i centri di ricerca (pubblici e privati) di provata eccellenza [121].<br />
Il processo di rimodulazione e di riassetto della rete di ricerca del CNR<br />
nel campo dei polimeri appare quindi ineludibile e non ulteriormente procrastinabile<br />
nel tempo.<br />
Il suo successo dipenderà dal tipo di azioni che saranno intraprese, le<br />
più significative delle quali sembrano essere le seguenti:<br />
1) rafforzare in termini di strutture, attrezzature, addetti e finanziamenti,<br />
prioritariamente, gli Istituti più idonei alla partecipazione<br />
attiva e trainante di “network” tematici trans-nazionali europei;<br />
2) consolidare ed accorpare le attività degli organi su tematiche di<br />
grande rilevanza, sia dal punto di vista scientifico che tecnologico;<br />
3) favorire lo sviluppo di nuove competenze e attivare nuove infrastrutture<br />
di supporto tecnico dove concentrare costose e sofisticate<br />
apparecchiature al fine di potenziare attività connesse a particolari<br />
settori di frontiera;<br />
4) promuovere attività di ricerca di base inedite ed innovative capaci<br />
di stimolare la crescita scientifica e culturale del settore contribuendo<br />
anche alla soluzione di problematiche di grande rilevanza<br />
applicativa;<br />
5) riallineare gli obiettivi delle ricerche affinché collimino con le<br />
richieste di supporto espresse dall’industria delle plastiche, il cui<br />
percorso evolutivo è caratterizzato da uno sviluppo, sempre più<br />
compatibile con le esigenze di prot<strong>ezio</strong>ne dell’ambiente e della<br />
qualità della vita, basato quindi sulla individuazione di tecnologie<br />
innovative e sostenibili per il quale è essenziale un rapporto sempre<br />
più sinergico con il mondo della ricerca pubblica.<br />
Le azioni sopra indicate dovrebbero portare ad una evoluzione culturale<br />
degli organismi di ricerca capace di riconfigurare le loro attività finalizzandole<br />
non solo alla progettazione di macromolecole, bensì a quella<br />
dei materiali [(passaggio dal concetto di scienza dei polimeri (figura 101)<br />
228
Fig. 101: Il processo evolutivo della rete di ricerca del CNR attiva nel campo della<br />
scienza dei polimeri: situazione attuale [Rif. 108].<br />
a quello di scienza dei materiali polimerici (figure 102 e 103)] [108].<br />
Come si evince dallo schema della figura 102 l’elemento caratterizzante<br />
è rappresentato da un circuito di competenze basato sulle conoscenze<br />
delle possibili correlazioni tra -composizione chimica, struttura, morfologia,<br />
processi di trasformazione, proprietà e caratteristiche d’uso-.<br />
Una rete di organi di ricerca con le caratteristiche culturali sopra delineate<br />
si inserirebbe a pieno titolo in quello che può essere definito come<br />
il ciclo virtuoso delle sinergie per l’innovazione, con la possibilità di<br />
svolgere un rilevante ruolo di cerniera tra la ricerca accademica e quella<br />
industriale, capace quindi di contribuire incisivamente allo sviluppo:<br />
1) dell’industria dei polimeri, fornendo strumenti conoscitivi utili ad<br />
implementare e velocizzare i processi di sostituzione di altri materiali<br />
in settori di grande rilevanza;<br />
2) dell’innovazione dei processi di produzione e delle tecnologie di<br />
229
trasformazione, favorendo la realizzazione di materiali ad elevato<br />
valore aggiunto idonei per applicazioni in nuovi settori (figura 104)<br />
[122];<br />
3) di know-how finalizzati a “nobilitare” polimeri di massa, attraverso<br />
la messa a punto di materiali ibridi innovativi (leghe, miscele e<br />
compositi), con caratteristiche mirate al tipo di utilizzo;<br />
4) di una più profonda conoscenza dei sistemi polimerici, correlando<br />
tra loro fattori molecolari, sopra-molecolari e di processo.<br />
Con la ristrutturazione della rete tematica del CNR nel campo della<br />
scienza e tecnologia delle macromolecole, secondo i criteri sopra delineati,<br />
verrebbe finalmente a completarsi quel disegno che era stato, con<br />
grande lungimiranza pensato e progettato, già all’atto della istituzione del<br />
Centro di Chimica Macromolecolare, nel lontano 1961, da coloro i quali<br />
possono essere considerati i padri fondatori della ricerca sui polimeri in<br />
Italia, primo fra tutti Giulio Natta. Ad essi va tutta la riconoscenza per<br />
aver dato al sistema paese un importante strumento di ricerca che in circa<br />
quarant’anni di attività ha dimostrato di meritare ampiamente la fiducia<br />
di coloro i quali lo avevano fortemente voluto.<br />
230
Fig. 102: Il processo evolutivo della rete tematica di ricerca del CNR nel settore della<br />
scienza e tecnologia dei polimeri [Rif. 108].<br />
Fig. 103: Il processo evolutivo della rete del CNR attiva nel campo della scienza e tecnologia<br />
delle macromolecole [Rif. 108].<br />
231
fig. 104a<br />
fig.104b<br />
Fig. 104: Compositi innovativi a matrice termoindurente rinforzati con “silicon carbide whiskers”<br />
(SiCW) modificati. Micrografie elettroniche, al SEM, della superficie di frattura del:<br />
a) composito resina poliestere–SiCW (ricoperto con poli(divinilbenzene) e innestato<br />
con poli(glicidilacrilato));<br />
b) composito resina epossidica–SiCW (non trattato).<br />
[Rif. 122].<br />
232
TAVOLA XXXIX<br />
Tavola XXXIX: La nuova tecnologia “Environmentally Friendly” sviluppata dalla Halmatic (UK) per la produzione di barche.<br />
Il processo utilizza un composito termoplastico costituito da un tessuto (ottenuto mediante l’accoppiamento di fibre di vetro e di<br />
polipropilene) impregnato da una matrice di polipropilene. Il processo offre una alternativa “eco-sostenibile” alla tecnologia tradizionale<br />
basata su compositi termoindurenti a matrice poliestere insaturi che prevede l’impiego di elevati quantitativi di solventi tossici<br />
quale lo stirene [Rif. 115].<br />
233
TAVOLA XL<br />
a)<br />
b)<br />
Tavola XL: Pneumatici per auto a bassissimo impatto ambientale basati sulla sostituzione<br />
del nerofumo e della silice con filler-biopolimerico (un polimero derivato dall’amido<br />
di mais):<br />
a) un’immagine che sottolinea la composizione “naturale” dei pneumatici con cariche<br />
a base di amido;<br />
b) l’evoluzione del pneumatico dal nero di carbonio al biopolimero passando attraverso<br />
la silice [Rif. 116].<br />
234
TAVOLA XLI<br />
Tavola XLI: Nuovi polimeri per<br />
il restauro e la conservazione dei<br />
beni culturali. Il caso del restauro<br />
di un “Landmark Clock”.<br />
"The four-faced, wooden gothic style<br />
clock that had graced the front of Thorpe<br />
& Co. Jewelers in down-town Sioux City,<br />
Iowa, for nearly a hundred years stood in<br />
need of refurbishment. A custom shop<br />
called Taylor Plastics was tasked with<br />
using plastic to rejuvenate the clock’s<br />
appearance and improve its durabilitywithout<br />
losing the craftsmanship of a century-old<br />
landmark".<br />
[Rif. 117].<br />
TAVOLA XLII<br />
Tavola XLII: Bottiglie speciali in<br />
polietilenetereftalato (PET) sono utilizzate<br />
per imbottigliare il rum<br />
“Bacardi”.<br />
"Bacardi USA of Miami is using PET packaging<br />
for the first time in the United States. It has<br />
rolled out Bacardi Light rum in 750-ml PET<br />
bottles with 33-ml finish from Schmalback-<br />
Lubeca, Plastic Containers USA.<br />
The new PET bottle answers customer requests<br />
for a convenient “traveller” size, says the company:<br />
It weighs 62,5 grams, giving it a “premium<br />
feel, says Bacardi".<br />
[Rif. 117].<br />
235
TAVOLA XLIII<br />
Tavola XLIII: Compositi a matrice poliarilammide competono con i metalli.<br />
"IXEF Plastic polyarylammide compounds from Solvay Advanced Polymers are said to combine features that<br />
make them competitive with metal alloys: extreme rigidity, high fluidity, excellent surface finish, very low<br />
creep, and high dimensional stability. Additionally, says Solvay, the high-performance plastic provides excellent<br />
fatigue resistance, high resistance to a wide range of chemicals, and a very low coefficient of linear thermal<br />
expansion. Most IXEF grades are reinforced with 50% to 60% glass fibers.<br />
This combination of properties suits the IXEF compounds to automotive, industrial tooling, electronic, and<br />
domestic (house-hold and furniture) applications, according to Solvay" [Rif. 118].<br />
236
RIFERIMENTI<br />
1) “Guglielmo Marconi, Presidente del CNR”, Giornata di Studio, 7<br />
Aprile 1995, CNR, Roma (1996).<br />
2) A. La Bella in "Il nuovo Consiglio Nazionale delle Ricerche"<br />
“Premessa”, a cura di F. Merloni, Hoepli, D’Anselmi Editore, Roma<br />
(1999).<br />
3) M.R. Valensise, “I settanta anni del Consiglio Nazionale delle<br />
Ricerche -1923-1993”, CNR, Roma (1994).<br />
4) P. Bisogno “La politica scientifica in Italia negli ultimi 40 anni”,<br />
CNR, Roma (1988).<br />
5) “Aree della Ricerca in Italia”, CNR, Roma (1999).<br />
6) L. Bianco “Presentazione” in "Il nuovo consiglio Nazionale delle<br />
Ricerche", a cura di F. Merloni, Hoepli – D’Anselmi Editore, Roma<br />
(1999).<br />
7) Decreto Legislativo del 30 gennaio 1999, n. 19, -Riordino del<br />
Consiglio Nazionale delle Ricerche- Guri - Serie Generale – N. 29, 5/2<br />
(1999).<br />
8) Comunicazione della Commissione al Consiglio del Parlamento<br />
Europeo: “Verso uno spazio europeo della ricerca”, Bruxelles, Com<br />
237
(2000) 6 - 18/01 (2000).<br />
9) P. H. Spitz, “Petrochemicals-the rise of an industry”, J. Wiley and<br />
Sons, New York (1988).<br />
10) I. Pasquon “Principali tappe e prospettive della chimica industriale”,<br />
relazione al Convegno internazionale: “Chimica, Storia, Fondamenti,<br />
Prospettive”, Roma, 6-7 Novembre 1989; articolo pubblicato da “La<br />
Chimica e l’Industria” n 8/9 – Agosto/Settembre (1990).<br />
11) G. Serravalle, “L’industria Chimica in Italia e in Europa” Clup-<br />
Clued, Milano (1980).<br />
12) “Storia della Chimica” a cura di A. Di Meo, Enimont, Venezia<br />
(1989).<br />
13) E. Martuscelli, "Dalla scoperta di Natta, lo sviluppo dell’industria e<br />
della ricerca sulle plastiche in Italia" CNR, Serie “Scienze Chimiche”,<br />
in pubblicazione e in stampa, Roma (2001).<br />
14) R. Magri, La Chimica e l’Industria, 75, pag. 582 (1993).<br />
15) G. Natta, “Una nuova classe di polimeri di -olefine, aventi ecc<strong>ezio</strong>nale<br />
regolarità di struttura”, Atti dell’Accademia Nazionale Lincei, Serie<br />
VIII, Vol. IV, s<strong>ezio</strong>ne II, fascicolo 4, pp. 69-71 (1955).<br />
16) “Le fibre intelligenti”, Electa, Milano (1991).<br />
17) R. Scandurra, “Proteine da Petrolio”, Le Scienze, N. 64, Dicembre<br />
(1973).<br />
18) M. Kaufman, “The First Century of Plastics”, Plast. Inst., London<br />
(1963).<br />
19) G. Natta, Le Scienze, N. 3, Novembre (1968).<br />
20) P. J. T. Morris, “Polymer Pioneers”, The Beckman Center for the<br />
History of Chemistry (1990).<br />
238
21) H. Morawetz, “Polymers-The origins and growth of a science”, John<br />
Wiley and Sons, New York (1985).<br />
22) K.H. Meyer, “Natural and Synthetic High Polymers”, Interscience<br />
Publishers, Inc., New York (1950).<br />
23) Paul J. Flory, “Principles of Polymer Chemistry” Cornell University<br />
Press, New York (1953).<br />
24) H. Mark, Chemical and Engineering News, April 6, 183 (1976).<br />
25) A. Di Meo, “Giulio Natta (1903-1979)”, in "Storia della Chimica in<br />
Italia" pagg. 409-419, a cura di A. Di Meo, Montedison, Roma (1989).<br />
26) Giulio Natta, “L’uomo e lo scienziato”, a cura del Dipartimento di<br />
Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali “Giulio Natta” del<br />
Politecnico di Milano, Aidic Servizi Editore, Milano (1988).<br />
27) P. Maltese, Materie Plastiche ed Elastomeri, pag. 277-287, (1995).<br />
28) G. Natta “Introduzione” al corso di "Chimica delle Macromolecole";<br />
Libro delle l<strong>ezio</strong>ni - Varenna, 18-30- Settembre 1961, CNR, Roma<br />
(1963).<br />
29) G. Natta, “Relazione generale sull’attività del Centro Nazionale di<br />
Chimica delle macromolecole” in "Chimica delle Macromolecole", atti<br />
del Convegno tenutosi a Roma il 12-14 Dicembre 1966; CNR, Roma<br />
(1968).<br />
30) P. Bisogno, “Introduzione” in "Il Consiglio Nazionale delle Ricerche;<br />
contributi per una riforma", pagg. 7-48, Prometheus-24, F. Angeli, Roma<br />
(1997).<br />
31) E. Martuscelli, La Chimica e l’Industria, 61, 491 (1979).<br />
32) Relazioni presentate al “Convegno sullo stato di avanzamento della<br />
ricerca nel settore delle macromolecole per il triennio 1970-73”, Padova<br />
25-26 Novembre, CNR (1974).<br />
239
33) Istituti e Centri del CNR: struttura e risultati - 1995, CNR, Roma<br />
(1997).<br />
34) CNR - Ordinanza del Presidente del CNR n. 13940, posiz. 126.210,<br />
prot. n. 070997 del 18 Giugno 1996, (4 giugno 1996) Roma.<br />
35) Atti del “I° Convegno nazionale degli istituti e centri del CNR afferenti<br />
al settore della chimica, fisica e tecnologia dei sistemi macromolecolari<br />
sintetici e naturali”, a cura di E. Martuscelli et al., Napoli (1992).<br />
36) L. Calandrelli, L. D’Orazio, F. Riva, “Offerta scientifica e tecnologica<br />
e di formazione degli Istituti e Centri del C.N.R. afferenti al settore<br />
delle macromolecole sintetiche e naturali”, Napoli (1994).<br />
37) F. Merloni, “Il nuovo Consiglio Nazionale delle Ricerche”<br />
D’Anselmi Editore, Milano (1999).<br />
38) R. Cipollini, Mediterranean Magazine, N. 2, 4, July (1999).<br />
39) E. Martuscelli, Mediterranean Magazine, N. 2, 8, July (1999).<br />
40) “I Progetti Finalizzati”, Gennaio (1978) e Aprile (1981), CNR,<br />
Roma.<br />
41) “Atti del Convegno: i Progetti Finalizzati del CNR; esperienze e prospettive”,<br />
CNR, Montecatini, 4-6 Maggio (1981).<br />
42) E. Martuscelli, “La Chimica e l’Industria”, 63, 360 (1981).<br />
43) Atti del Convegno “Progetto Finalizzato Chimica Fine e<br />
Secondaria” "Risultati e prospettive", CNR – Federchimica,<br />
Farmindustria, Milano (1985).<br />
44) E. Martuscelli, “Il sottoprogetto Materiali Polimerici del Progetto<br />
Finalizzato Chimica Fine del CNR: un Primo Consuntivo a tre anni dall’inizio”,<br />
Bollettino di Informazione e Documentazione Scientifica nel<br />
settore della Scienza e tecnologia dei polimeri; IRTeMP-CNR, Arco<br />
Felice (Napoli); n. 2, Dicembre (1983).<br />
240
45) “Progetto Finalizzato Chimica Fine” Vol.1 - Relazione finale del<br />
Direttore e dei Coordinatori dei Sottoprogetti, CNR, Settembre (1996).<br />
46) E. Martuscelli, relazione finale del Sottoprogetto “Chimica e<br />
Tecnologia dei Polimeri” in “Progetto Finalizzato Chimica Fine”, Vol. 2,<br />
CNR, Settembre (1996).<br />
47) R. Cipollini, C. Battistoni, A. Lapiccirella, F. Tuzi, I. Bencini, E.<br />
Bemporad, “La chimica nel CNR e la ricerca sui materiali in Italia”, PF-<br />
MSTA- CNR, La Chimica e l’Industria, 77, 342, (1995).<br />
48) CIPE, delibera del 29/12/1986, Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10-2<br />
(1987).<br />
49) CIPE, delibera del 30/03/1988, Gazzetta Ufficiale N. 123 del 27-06<br />
(1988).<br />
50) Science and Technology Statistics, Institute for Studies on Scientific<br />
Research Documentation, CNR, Roma, (1990).<br />
51) “La ricerca scientifica e tecnologica in Italia: un’analisi di politica<br />
scientifica” CNR, ROMA, (1989).<br />
52) CIPE, delibera del 29/12/1995, Gazzetta Ufficiale N. 84 del 10-07<br />
(1996).<br />
53) G. Tognon, Europa, N. 25, 53, dicembre (1999).<br />
54) “Towards an European Research Area”, European Commission -<br />
General Information, January (2000).<br />
55) Commissione Europea - Attività di Ricerca e di Sviluppo<br />
Tecnologico dell'Unione Europea - Relazione annuale 1998 - COM (98)<br />
439 (15.07.1998).<br />
56) Consiglio e Parlamento dell'Unione europea - Decisione n.182/1999<br />
relativa al "V Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e<br />
Attività di dimostrazione (1998-2002)"- (22.12.1998).<br />
241
57) European Commission -"A new deal for European research" - RTD<br />
Info, N. 20 (November '98).<br />
58) European Commission - "Strenghtening European Research: the<br />
challenges of partnership" - RTD Info, N. 22 (May '99).<br />
59) “TRA on polymer materials” - Newsletter, Issue N. 99 (November -<br />
1999).<br />
60) Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole<br />
(AIM), AIM-Magazine, Anno XXV 54, n° S-1, 2, Gennaio (2000).<br />
61) E. Pedemonte, AIM-Magazine, Anno XXV, 54, n° s-1, 9, gennaio<br />
(2000).<br />
62) G. Allegra, AIM-Magazine, anno XXV, 54, n° S-1, 7, gennaio (2000).<br />
63) Laboratorio di Ricerche su Tecnologia dei Polimeri e Reologia –<br />
CNR "Attività di Ricerca 1969-1978", edito dal LTPR-CNR (Napoli<br />
1979).<br />
64) Istituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche del CNR,<br />
Consuntivo (1998).<br />
65) E. Martuscelli, M. Rossano, “Le politiche formative e le prospettive<br />
di sviluppo e di interazione tra l’Italia e i Paesi del Mediterraneo” in<br />
“Viaggio tra i perché della disoccupazione intellettuale in Italia”, pagg.<br />
241-282, Fondazione Aristeia, Ed. A. Giuffrè, Milano (2000).<br />
66) RTD – INFO, “Magazine for European Research”; numeri 18, 19, 20,<br />
21, 22, 23, 24 (1999).<br />
67) E. Martuscelli, P. Buono, G. Narciso, P. Russo, A. Taglialatela,<br />
“Istituto di Ricerca e Tecnologia delle Materie Plastiche– dal 1969 al<br />
1999: Trent’anni di attività”, edito da IRTeMP-CNR-Napoli (1999).<br />
68) E. Martuscelli, “Rubber modification of polymers: phase structure,<br />
crystallization, processing and properties” in "Thermoplastic Elastomers<br />
from rubber- plastic blends" pagg. 27-70, Editors S. K. De, A. K.<br />
242
Bhowmick, Ellis Horwood, New York (1990).<br />
69) E. Martuscelli “Structure and properties of polypropylene-elastomer<br />
blends” in "Polypropylene Structure, blends and composites" Vol. 2,<br />
pagg. 95-140, Edited by J. Karger-Kocsis, Chapman & Hall, London<br />
(1995).<br />
70) S. Cimmino, L. D’Orazio, R. Greco, G. Maglio, M. Malinconico, C.<br />
Mancarella, E. Martuscelli, R. Palumbo, G. Ragosta, Polymer Eng. Sci.,<br />
24, 48 (1994).<br />
71) M. Avella, M. Errico, E. Martuscelli, Dati non pubblicati, (brevetto in<br />
fase di deposito).<br />
72) M. Avella, C. Bozzi, R. Dell’Erba, B. Focher, A. Marzetti, E.<br />
Martuscelli, Die Ang. Makromol. Chem. 233, 149 (1995).<br />
73) M. Avella, E. Martuscelli B. Pascucci, M. Raimo, B. Focher, A.<br />
Marzetti; J. Appl. Polym. Sci. 49, 2091 (1993).<br />
74) L. D’Orazio, E. Martuscelli et al., J. of Archaelogical Science, 27,<br />
745 (2000).<br />
75) L. D’Orazio, E. Martuscelli et al., Mediterranean Magazine, N. 1, 11,<br />
March (1999).<br />
76) L. D’Orazio, E. Martuscelli et al. Monografie di SEAP –Series Major,<br />
5 “Bakchias V Rapporto preliminare della Campagna di scavo del 1997”<br />
Isti. Poligrafici Intern. Pisa-Roma (1997).<br />
77) E. Martuscelli, “Le fibre di polimeri naturali nell’evoluzione della<br />
civiltà”, Monografie Scientifiche, Serie Scienze Chimiche, edito dal<br />
C.N.R., Roma (1999).<br />
78) “Chimica, l’Europa e il Futuro” preparato da Alliance for Chemical<br />
Sciences and Technologies in Europe.<br />
79) “Introduction” to the special issue of Mediterranean Magazine, N. 2,<br />
3, July (1999).<br />
243
80) “Per restaurare una scultura in vetro”, Plast, pag. 20, novembre<br />
(1999).<br />
81) C. Giavarini, G. Cantucci, La chimica e l’Industria, 82, 183 (2000).<br />
82) P. Mormile, L. Petti, M. Abbate, G. Ragosta, P. Villano, Optics<br />
Communications, 147, 269 (1998).<br />
83) M. Abbate, E. Martuscelli, P. Musto, G. Ragosta, Polymer (in pubblicazione).<br />
84) P. Musto, E. Martuscelli, G. Ragosta, P. Russo, G. Scarinzi, P.<br />
Villano, J. Mat. Science, 33, 4595 (1998).<br />
85) a) G. Ragosta, M. Bombace, E. Martuscelli, P. Musto, P. Russo, G.<br />
Scarinzi, J. Mat. Sci., 34, 1037 (1999).<br />
b) G. Ragosta, P. Musto, E. Martuscelli, P. Russo, L. Mascia. G.<br />
Scarinzi, J. Appl. Polym. Sci. (in stampa).<br />
86) Internet Basell Site 20/10 (2000).<br />
87) E. Martuscelli, P. Musto, G. Ragosta, P. Russo, J. Mat. Sci. (in stampa).<br />
88) I. Lehtinen, Macplas, 221, 88 (2000).<br />
89) E. Martuscelli, C. Salvatore, “The future of plastic packaging: economic<br />
and environmental issues” in "Fifth Mediterranean school on<br />
Science and Technology of Advanced Polymer-based Material" Edited by<br />
E. Martuscelli, P. Musto, G. Ragosta, pp 1-30, CNR-Napoli (1998).<br />
90) M. V. Gandhi, B. S. Thompson, “Smart materials and structures“,<br />
Chapman and Hall, London (1992).<br />
91) "Resine barriera", Marketing, Macplas, 42, 221 (2000).<br />
92) European Plastics News, Reader Reply, N. 219, 27, October (2000).<br />
244
93) European Plastics News, Reader Reply N. 206, 35, October (2000).<br />
94) D. Martorana, L. Zeloni, Mediterranean Magazine, N. 2, 36 July<br />
(1999).<br />
95) E. Chiacchia, Macplas, 221, 47 (2000).<br />
96) E. Martuscelli, “In memory of Andrew Keller: a great scientist, an<br />
unforgettable friend”, Mediterranean Magazine, N. 1, Editors Page,<br />
March (1999).<br />
97) A. Keller, Phil. Mag., 2, 1171 (1957).<br />
98) A. Keller, E. Martuscelli, Die Makromol. Chem., 151, 189 (1972).<br />
99) A. Keller, E. Martuscelli, D. J. Priest, Y. Udagawa, J. Polym. Sci.Part<br />
A-Z, 9, 1807 (1971).<br />
100) E. Dubini Paglia, P. L. Beltrame, M. Canetti, A Seves, B.<br />
Marcandalli and E. Martuscelli, Polymer, 34, 996 (1993).<br />
101) P. Sadocco, M.Canetti, A. Seves and E. Martuscelli, Polymer, 34,<br />
3368 (1993).<br />
102) L. Finelli, B. Sarti, M. Scandola, J. Macromol. Sci. Pure Appl.<br />
Chem., A34,13 (1997).<br />
103) P. Greco and E. Martuscelli, Polymer, 30, 1475 (1989).<br />
104) M. Avella and E. Martuscelli, Polymer, 29, 1731 (1988).<br />
105) M. Avella and E. Martuscelli, and M. Raimo, B. Pascucci, Polymer,<br />
34, 3234 (1993).<br />
106) M. Avella, E. Martuscelli, G. Orsello, M. Raimo, B. Pascucci,<br />
Polymer, 38, 6135 (1997).<br />
107) M. L. Di Lorenzo, M. Raimo, E Cascone, E. Martuscelli, “Poly(3-<br />
245
Hydroxybutyrate) based copolymers and blends: influence of a second<br />
component on crystallization and thermal behaviour” J. Mat. Sci., in pubblicazione.<br />
108) E. Martuscelli, “Ipotesi di riordino e ricollocazione nazionale ed<br />
internazionale dell’IRTeMP”, CNR – Napoli - Arco Felice, febbraio<br />
(2000).<br />
109) “News”, The Society of Plastic Engineers, Eng. Prop. Struct.<br />
Division, pag. 1-2 Fall (2000).<br />
110) P. Costa Bizzarri, C. Della Casa, M. Lanzi; La Chimica e L’Industria<br />
82, 929 (2000).<br />
111) E. Riande, Revista De Plasticos Modernos, 80, 644 (2000).<br />
112) L. Caglioti, Il Sole 24 Ore, N. 274, pag. 7, Mercoledì 11 Ottobre<br />
(2000).<br />
113) R. Viale, Il Sole 24 Ore, pag. 6, Mercoledì 3 gennaio (2001).<br />
114) “The IPTS Futures Project“, Synthesis Report, Eur-19038 EN,<br />
January (2000).<br />
115) RTD Info (European Commission), 27, 15, September (2000).<br />
116) L’industria della gomma/elastica, 483, 23 Novembre (2000).<br />
117) Plastics Engineering, pag. 8-9, December (2000).<br />
118) Plastics Engineering, pag. 33, November (2000).<br />
119) Dalla brochure di presentazione di “Antec” 2001, Dallas, Texas,<br />
May (2001).<br />
120) Comunicazione della Commissione al Consiglio del Parlamento<br />
Europeo al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni,<br />
Bruxelles COM. 6 del 18/01/2000.<br />
246
121) J. V. Buckley, “Going for Growth”, Mc Graw-Hill, London (1998).<br />
122) M. Avella, R. dell’Erba, E. Martuscelli, R. Partch, J. Polym. Mater.,<br />
17, 445 (2000)<br />
247