memoria e oblio, vendetta e perdono nell'atene del ... - Rivista S.S.E.F.
memoria e oblio, vendetta e perdono nell'atene del ... - Rivista S.S.E.F.
memoria e oblio, vendetta e perdono nell'atene del ... - Rivista S.S.E.F.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
MEMORIA E OBLIO, VENDETTA E PERDONO NELL’ATENE DEL 403 A.C.<br />
Sommario: 1. La frattura nella comunità cittadina – 2. Oblio, <strong>perdono</strong>, recupero <strong>del</strong>la concordia:<br />
Trasibulo e l’invito a “non ricordare il male subito” –3. Memoria, <strong>vendetta</strong>, giustizia: la diversa<br />
prospettiva di Lisia. – 4. Conclusioni.<br />
1. LA FRATTURA NELLA COMUNITÀ CITTADINA<br />
Tucidide dedica un celebre passo <strong>del</strong> III libro (§§ 82-83), nell’ambito <strong>del</strong> racconto sulle vicende<br />
interne di Corcira, ad una riflessione generale sul tema <strong>del</strong>la guerra civile (stasis), cogliendo due aspetti<br />
caratterizzanti <strong>del</strong> fenomeno. Prima di tutto, il collegamento con la guerra esterna: i capi <strong>del</strong> popolo,<br />
divisi in fazioni filoateniesi e filospartane, in tempo di pace non avevano pretesti per far appello alle<br />
potenze nemiche, mentre in tempo di guerra “coloro che desideravano novità politiche” usavano le<br />
alleanze esterne per colpire i nemici e procurarsi dei vantaggi. La guerra è potente fattore di stasis in<br />
quanto “maestra violenta”, che togliendo il benessere quotidiano scatena la rabbia <strong>del</strong>le masse: i<br />
rapporti all’interno <strong>del</strong>la polis ne risultano snaturati. Il secondo elemento caratterizzante è il<br />
rovesciamento dei valori che la stasis determina: “E l’usuale valore che le parole avevano in rapporto<br />
all’oggetto fu mutato a seconda <strong>del</strong>la sua stima” (III, 82, 4). Lo storico pone qui l’accento sul venir<br />
meno di valori comuni universalmente riconosciuti: ciò che cambia non è tanto il significato <strong>del</strong>le<br />
parole, quanto il giudizio di valore annesso alle azioni che le parole individuano. Il rovesciamento dei<br />
valori porta con sé un profondo imbarbarimento dei rapporti politici; l’abbandono <strong>del</strong>la prospettiva <strong>del</strong><br />
comune interesse in favore di quella <strong>del</strong>l’utile personale determina un disinteresse sia per la giustizia, sia<br />
per l’utile <strong>del</strong>la città, e l’unico obiettivo diviene il potere: “Nelle città i capi di fazione ... a parole<br />
curavano gli interessi comuni, ma a fatti ne facevano un premio <strong>del</strong>la loro lotta” (III, 82, 8).<br />
La valutazione generale <strong>del</strong> fenomeno <strong>del</strong>la stasis che Tucidide offre qui parte dall’episodio<br />
corcirese, ma ha intende fornire una chiave interpretativa valida per il complesso <strong>del</strong>le vicende greche<br />
<strong>del</strong>l’ultimo quarto <strong>del</strong> V secolo (cfr. III, 82, 1 e 3; 83, 1). Essa mostra infatti significative consonanze<br />
con il giudizio che lo storico dà sulla crisi <strong>del</strong>l’Atene postpericlea: crisi determinata proprio<br />
dall’affermarsi di ambizioni personali fra gli uomini politici ateniesi, interessati più al potere e ai vantaggi<br />
privati che al comune interesse (II, 65, 7; 11-12; VIII, 89, 3-4). E’ stato inoltre ipotizzato che Tucidide,<br />
nel trattare il fenomeno <strong>del</strong>la stasis nel libro III, avesse presenti le vicende ateniesi <strong>del</strong> 411 (oligarchia dei<br />
Quattrocento) e <strong>del</strong> 404 (tirannide dei Trenta e successiva guerra civile): vicende entrambe collegate con<br />
una guerra esterna e, soprattutto, caratterizzate da profonde lacerazioni <strong>del</strong> tessuto civico e dal<br />
rovesciamento <strong>del</strong>la tradizionale scala di valori. Per la crisi <strong>del</strong> 411, il racconto di Tucidide consente in<br />
effetti di cogliere significative affinità tra l’interpretazione generale <strong>del</strong> fenomeno <strong>del</strong>la stasis fornita dallo<br />
storico e le vicende <strong>del</strong> colpo di stato: penso soprattutto al ruolo condizionante <strong>del</strong>la guerra, all’azione<br />
<strong>del</strong>le società segrete (le cosiddette eterie), al clima di sfiducia e di incertezza creato dallo snaturamento<br />
dei rapporti all’interno <strong>del</strong>la comunità civica, al carattere distruttivo <strong>del</strong>le ambizioni personali. Per le<br />
vicende <strong>del</strong> 404 non abbiamo il racconto di Tucidide; ritroviamo però in uno dei maggiori testimoni<br />
<strong>del</strong>la vicenda, Lisia, aspetti presenti nell’opera <strong>del</strong>lo storico, come il legame tra guerra e stasis, il ruolo<br />
<strong>del</strong>le ambizioni personali e <strong>del</strong> disinteresse per il bene comune nello snaturamento dei rapporti<br />
all’interno <strong>del</strong>la polis e nella perversione <strong>del</strong> clima politico, la disintegrazione etico-politica provocata dal<br />
rovesciamento dei valori comuni.<br />
Le due esperienze oligarchiche di fine V secolo determinarono una profonda frattura nel corpo<br />
civico ateniese: il rovesciamento dei valori e la dissoluzione <strong>del</strong>l’esperienza comunitaria imponevano<br />
pertanto, all’indomani <strong>del</strong>la restaurazione <strong>del</strong>la democrazia nel 403 (seguita ad una sanguinosa guerra<br />
civile), di trovare dei punti in comune da cui ripartire. Facendo appello a valori collegati con i due<br />
ambiti costitutivi <strong>del</strong>l’esperienza <strong>del</strong>la polis, quello politico e quello religioso, attraverso un acceso<br />
dibattito dominato dai concetti di <strong>oblio</strong> e di <strong>memoria</strong>, gli Ateniesi seppero superare le ferite lasciate da<br />
1
una dittatura sanguinaria e inaugurarono, con insperato successo, una nuova e serena convivenza<br />
democratica 1 .<br />
2. OBLIO, PERDONO, RECUPERO DELLA CONCORDIA: TRASIBULO E L’INVITO A “NON<br />
RICORDARE IL MALE SUBITO”<br />
Lo strumento principale per rendere possibile questa rinnovata convivenza fu, come è noto,<br />
l’amnistia: essa fu promulgata nel 403, alla fine <strong>del</strong>la guerra civile ateniese, per favorire una rapida<br />
ricomposizione <strong>del</strong>la concordia civica tra il “partito <strong>del</strong>la città”, i Tremila che avevano conservato il<br />
diritto di cittadinanza sotto la tirannide dei Trenta, e i democratici <strong>del</strong> “partito <strong>del</strong> Pireo”. Sulle sue<br />
clausole siamo informati da Senofonte (Elleniche II, 4, 38-39; 43), Andocide (I, 90-91), Aristotele<br />
(Costituzione degli Ateniesi, 39); Lisia e Isocrate offrono poi diverse testimonianze <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>le<br />
clausole d’amnistia in ambito giurisdizionale negli anni successivi alla restaurazione democratica 2 .<br />
Le fonti principali sintetizzano il senso profondo <strong>del</strong>l’amnistia, indipendentemente dalle singole<br />
clausole, nell’espressione mè mnesikakein 3 , il cui significato letterale è “non mi ricordo <strong>del</strong> male subito” e<br />
quindi “non mi vendico”. L’amnistia propugnava quindi la necessità, per i cittadini democratici che<br />
erano stati duramente provati dalla tirannide dei Trenta, di non ricordare il male subito e, di<br />
conseguenza, di perdonare ai nemici le colpe commesse, in nome di un superiore ideale di concordia<br />
civica, ritenuto di primario interesse per la città: permettere l’esercizio <strong>del</strong>la <strong>vendetta</strong> avrebbe infatti<br />
scatenato una spirale di violenze e di contese giudiziarie difficilmente arginabile.<br />
La storia giuridica greca non ignora precedenti nel campo <strong>del</strong>la promulgazione di amnistie (si<br />
pensi alla celebre amnistia soloniana), né l’espressione mè mnesikakein può essere ritenuta nuova nel 403:<br />
per quanto rara, essa è presente in fonti <strong>del</strong> V secolo 4 . Ma l’idea che l’amnistia debba essere la<br />
conseguenza giudiziaria <strong>del</strong>l’<strong>oblio</strong> <strong>del</strong> male subito e <strong>del</strong> <strong>perdono</strong>, nella prospettiva di una autentica<br />
riconciliazione fra le parti e di una effettiva ricomposizione <strong>del</strong>le fratture all’interno <strong>del</strong>la comunità<br />
civica, sembra conoscere una rinnovata valorizzazione, a partire dal 412/11, da parte di Trasibulo,<br />
l’uomo politico democratico artefice <strong>del</strong>la liberazione di Atene dalla tirannide dei Trenta e <strong>del</strong>la<br />
restaurazione <strong>del</strong>la democrazia.<br />
Una serie di recenti studi su Trasibulo e sull’ispirazione <strong>del</strong>la sua prassi politica, dalla<br />
controrivoluzione di Samo <strong>del</strong> 412/11 all’amnistia <strong>del</strong> 403 e anche in seguito, ha messo in luce i<br />
caratteri originali di tale prassi, ponendo l’accento, in particolare, sulla valorizzazione <strong>del</strong> <strong>perdono</strong><br />
reciproco come strumento di ricomposizione sociale e politica <strong>del</strong>la comunità civica ateniese, dopo le<br />
gravi fratture determinate dalla crisi costituzionale e dalla guerra civile. Tale originalità, che supera la<br />
tradizionale etica <strong>del</strong>la <strong>vendetta</strong> per proporre un approccio nuovo al problema <strong>del</strong>la ricomposizione dei<br />
contrasti politici anche più gravi, come furono quelli collegati con la vicenda <strong>del</strong>la guerra civile ateniese,<br />
sembra sostanziarsi di ideali non solo politici, ma anche religiosi 5 .<br />
Il mo<strong>del</strong>lo politico coerentemente difeso e sostenuto da Trasibulo è quello di una democrazia<br />
dai contenuti “periclei”, che si presentava come governo caratteristico <strong>del</strong>la tradizione ateniese, dunque<br />
1 Per i temi trattati in questo paragrafo cfr. C. Bearzot, Esilii, deportazioni ed emigrazioni forzate in Atene sotto regimi non democratici,<br />
in Emigrazione e immigrazione nel mondo antico, CISA 20, Milano 1994, pp. 141-167; Ead., Stasis e polemos nel 404, in Il pensiero sulla<br />
guerra nel mondo antico, CISA 27, Milano 2001, pp. 19-36; M. Intrieri, Biaios didaskalos. Guerra e stasis a Corcira fra storia e<br />
storiografia, Soveria Mannelli 2002; C. Bearzot, Atene nel 411 e nel 404. Tecniche <strong>del</strong> colpo di stato, in Terror et pavor. Violenza,<br />
intimidazione, clandestinità nel mondo antico (Atti <strong>del</strong> Convegno, Cividale <strong>del</strong> Friuli 22-24 settembre 2005), in corso di stampa.<br />
2 In generale sulla questione cfr. l’eccellente messa a punto di Th.C. Loening, The Reconciliation Agreement of 403/2 in Athens.<br />
Its Content and Application, Hermes Einzelschriften 53, Stuttgart 1987.<br />
3 Senofonte, Elleniche II, 4, 43; Andocide I, 90; Aristotele, Costituzione degli Ateniesi 39, 6.<br />
4 Erodoto III, 49, 2; VIII, 29, 2; Tucidide IV, 74, 2; Aristofane, Nuvole, 999; Lisistrata, 590; Antifonte, Tetralogie, I, 1, 6; IG I 3 ,<br />
76.<br />
5 Cfr., anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, E. Ciarfera, Lealtà democratica e pietà eleusina in Trasibulo di Stiria, in<br />
L’immagine <strong>del</strong>l’uomo politico: vita pubblica e morale nell’antichità, CISA 17, Milano 1991, 51-63; M. Sordi, La fortuna <strong>del</strong>l’amnistia <strong>del</strong><br />
403, in Amnistia, <strong>vendetta</strong> e <strong>perdono</strong> nel mondo antico, CISA 23, Milano 1997, pp. 79-90; C. Bearzot, Perdono e riconciliazione nella<br />
politica di Trasibulo, Zetesis 1999, pp. 2, 9-28; M. Moggi, Strategie e forme <strong>del</strong>la riconciliazione: mè mnesikakein in Salvare le poleis,<br />
costruire la concordia, progettare la pace, (Atti <strong>del</strong> Convegno, Torino 5-7 aprile 2006), in corso di stampa. Per una recente sintesi<br />
sulla figura di Trasibulo si veda R.J. Buck, Thrasybulus and the Athenian Democracy, Historia Einzelschriften 120, Stuttgart 1998.<br />
2
come l’unica vera patrios politeia (“costituzione patria”) di Atene, e come governo di tutta la comunità e<br />
non <strong>del</strong>la sola parte popolare (di contro all’opposta visione <strong>del</strong>la democrazia come governo <strong>del</strong>le masse<br />
ignoranti, diffusa dalla propaganda antidemocratica). Tale mo<strong>del</strong>lo, tuttavia, non basta a spiegare le<br />
scelte di conciliazione effettuate da Trasibulo in frangenti particolarmente <strong>del</strong>icati, quali appunto quelli<br />
<strong>del</strong>la controrivoluzione di Samo e <strong>del</strong>la restaurazione democratica. Le ragioni profonde<br />
<strong>del</strong>l’orientamento trasibuleo risultano più chiare se collegate con le conseguenze etiche <strong>del</strong>la spiritualità<br />
tipica <strong>del</strong>la religione eleusina, i cui caratteri innovativi rispetto alla religione olimpica (che vedeva la<br />
giustizia divina soprattutto in senso punitivo e, di conseguenza, propugnava il dovere sacrale prima<br />
ancora che politico <strong>del</strong>la <strong>vendetta</strong>) privilegiavano invece, in ambito etico e politico, il <strong>perdono</strong> e il<br />
recupero <strong>del</strong>la concordia e <strong>del</strong>la solidarietà umana rispetto ad ogni fattore di divisione, in nome<br />
<strong>del</strong>l’uguaglianza <strong>del</strong>la natura umana e <strong>del</strong>la comune necessità di redenzione e di salvezza.<br />
L’ispirazione religiosa <strong>del</strong>la politica di Trasibulo è stata messa in luce attraverso l’analisi di alcuni<br />
momenti <strong>del</strong>la sua carriera. Egli, indiscusso ispiratore <strong>del</strong> mè mnesikakein nel 403, aveva proposto questa<br />
medesima impostazione, e con la stessa terminologia, già nel 412/11, in relazione ai fatti di Samo, dove<br />
si trovava stanziata la flotta ateniese e dove, in connessione con il colpo di stato ateniese dei<br />
Quattrocento, era stata tentata una rivoluzione antidemocratica, prontamente stroncata dalla reazione<br />
dei democratici samii, guidati da strateghi e ufficiali ateniesi, tra cui Trasibulo (Tucidide VIII, 73 ss.).<br />
Nel rivolgersi ai suoi uomini dopo la repressione <strong>del</strong>la rivoluzione antidemocratica di Samo, Trasibulo li<br />
invitava infatti a “governarsi democraticamente e a mantenere la concordia” (Tucidide VIII, 75, 2); esito<br />
<strong>del</strong>l’impegno assunto con solenne giuramento, su invito di Trasibulo, dai soldati ateniesi, democratici e<br />
oligarchici, fu la pacificazione in Samo, realizzata secondo Tucidide attraverso l’esercizio <strong>del</strong> <strong>perdono</strong>: “i<br />
democratici di Samo … senza serbar rancore (ou mnesikakountes) agli altri, da allora in poi si governarono<br />
democraticamente” (Tucidide VIII, 73, 6).<br />
In questo episodio <strong>del</strong> 412/11 Trasibulo sembra proporre per la prima volta la sua idea di<br />
pacificazione come risultato <strong>del</strong> reciproco <strong>perdono</strong> <strong>del</strong>le colpe commesse e di concordia politica come<br />
riflesso <strong>del</strong>la profonda solidarietà fra tutte le componenti di un corpo cittadino che si riconosceva nella<br />
sottomissione a leggi liberamente e concordemente accettate, ma anche in culti e tradizioni religiose<br />
comuni. Sulla base <strong>del</strong>la stessa ispirazione politica, ma con più evidente sottolineatura religiosa, furono<br />
sostenuti gli appelli alla riconciliazione rivolti alle parti nel 403, da Cleocrito, l’araldo eleusino voluto da<br />
Trasibulo accanto a sé sul campo di Munichia, all’indomani <strong>del</strong>la battaglia (Senofonte, Elleniche II, 4, 20-<br />
21), e dallo stesso Trasibulo dopo il rientro dei democratici in Atene (Senofonte, Elleniche II, 4, 40-42).<br />
Cleocrito, araldo dei Misteri eleusini, si era unito ai democratici dopo l’occupazione di Eleusi da<br />
parte dei Trenta. Durante la tregua successiva alla battaglia di Munichia vi furono, fra i democratici<br />
vincitori e gli oligarchici, tentativi di trovare un accordo, grazie anche alla moderazione dei democratici,<br />
che rinunciarono ad inseguire gli sconfitti ed evitarono di spogliare i cadaveri (Senofonte, Elleniche II, 4,<br />
19; Lisia XII, 53). Durante le trattative Cleocrito pronunciò un appello al “partito <strong>del</strong>la città”, ovvero a<br />
quei Tremila con i quali i democratici, una volta abbattuti i tiranni, intendevano recuperare una piena<br />
concordia. Tema fondamentale <strong>del</strong> discorso di Cleocrito è il recupero <strong>del</strong>l’unità nazionale, da realizzare<br />
sulla base <strong>del</strong>la comunione di esperienza religiosa (sacrifici, feste), di esperienza civile e sociale (cori,<br />
scuole), di esperienza politica (servizio militare, servizio al salvezza e libertà comuni), che unisce i<br />
cittadini di Atene in una comunità ora attraversata da una profonda frattura. Cleocrito richiama agli<br />
avversari i diversi vincoli che li legano agli esuli stessi, utilizzando una terminologia che rimanda al<br />
concetto di polis come comunità politica e religiosa 6 . Il suo discorso si chiude, significativamente, con<br />
l’invocazione agli dei: l’araldo chiede al “partito <strong>del</strong>la città” un impegno in favore <strong>del</strong>la riconciliazione<br />
nazionale in nome di una serie di fattori di aggregazione <strong>del</strong>la comunità cittadina tra i quali l’esperienza<br />
religiosa è messa significativamente in primo piano.<br />
Sullo sfondo <strong>del</strong> discorso di Cleocrito, che fu certamente ispirato da Trasibulo (tant’è che<br />
Giustino V, 10, 1-3, lo attribuisce direttamente a lui), troviamo una concezione di democrazia<br />
caratterizzata da una reale collaborazione tra le diverse componenti <strong>del</strong> corpo civico, dall’accettazione<br />
<strong>del</strong>le leggi comuni e dall’adesione ad una comune esperienza religiosa, fortemente espressa a livello<br />
6 Significativo il ricorrere dei verbi metechein, “partecipare”, e koinonein, “aver parte comune”, e <strong>del</strong>l’aggettivo koinós,<br />
“comune”.<br />
3
comunitario e quindi ricca di risvolti civili. Nell’ambito di questa esperienza religiosa, un ruolo<br />
certamente importante hanno, accanto ad Atena, le divinità eleusine, Demetra e Core, al cui culto<br />
Cleocrito era legato. Ora, la pietà eleusina sottolineava fortemente l’uguaglianza di natura tra gli uomini<br />
e la comune esigenza di salvezza: nella prospettiva radicalmente innovativa di Cleocrito, i fondamenti<br />
<strong>del</strong>la concordia venivano ricercati, con ogni probabilità, proprio nei contenuti umanitari e solidaristici<br />
<strong>del</strong>la religiosità eleusina, espressione di un culto, i Misteri, profondamente inserito nella tradizione<br />
democratica ateniese.<br />
Il discorso di Trasibulo, che si colloca nel corso di un’assemblea svoltasi successivamente al<br />
rientro dei democratici in Atene, dunque nel momento <strong>del</strong>icatissimo <strong>del</strong>la ripresa <strong>del</strong>la convivenza tra le<br />
parti, conferma, nella sua impostazione più strettamente politica, i tratti principali <strong>del</strong> discorso di<br />
Cleocrito. Trasibulo si rivolge agli “uomini <strong>del</strong>la città” invitandoli a “conoscere se stessi”, secondo<br />
l’etica <strong>del</strong>fica, e contestando le pretese di superiorità degli oligarchici, basate sul presunto possesso di<br />
qualità come la giustizia, il coraggio, le superiori capacità intellettuali. Il discorso esprime la visione<br />
democratica di Trasibulo, in linea con la teoria democratica di V secolo e in contrapposizione con il<br />
pensiero antidemocratico contemporaneo. Alle contestazioni <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong> demos a governare, in quanto<br />
privo <strong>del</strong>le necessarie qualità morali ed intellettuali (che trovano espressione, per esempio, nella<br />
posizione di Megabizo nel dibattito sulle costituzioni in Erodoto III, 81, o in quella <strong>del</strong>lo Pseudo-<br />
Senofonte, Costituzione degli Ateniesi I, 1-2), Trasibulo risponde rivendicando la superiorità <strong>del</strong> popolo sul<br />
piano <strong>del</strong>le qualità morali, <strong>del</strong> coraggio e <strong>del</strong>l’intelligenza. Con ciò, Trasibulo si esprime in linea con due<br />
celebri “manifesti” <strong>del</strong> pensiero democratico, l’Epitafio di Pericle (Tucidide II, 37, 1; 40, 2) e,<br />
soprattutto, il discorso <strong>del</strong> siracusano Atenagora <strong>del</strong> 415 (Tucidide VI, 39, 1) 7 .<br />
Ma Trasibulo dà un contributo in più rispetto alla teoria democratica con la quale pure si trova<br />
in linea. La conclusione <strong>del</strong> discorso contiene un appello alla riconciliazione, rivolto agli “uomini <strong>del</strong><br />
Pireo” (cioè a coloro che più potevano essere tentati di vendicarsi), su basi non politiche ma religiose:<br />
viene chiesto loro di essere euorkoi kai hosioi, di “ tener fede ai patti e rispettare gli dei”, cioè di osservare<br />
con rigore il giuramento di “non ricordare il male subito”. Tale giuramento, prestato probabilmente al<br />
momento <strong>del</strong>la ratifica <strong>del</strong> trattato di pace concluso tra esuli e oligarchici (Senofonte, Elleniche II, 4, 38),<br />
fu ripetuto solennemente dopo il rientro degli esuli in Atene: “Giurarono così di non serbare rancore<br />
per i torti subiti,e ancor oggi le due parti si governano nella concordia e il popolo rispetta il giuramento<br />
fatto” (Senofonte, Elleniche II, 4, 43). L’appello di Trasibulo, che chiede ai democratici vincitori di essere<br />
rispettosi <strong>del</strong>le leggi umane e divine, di far mostra <strong>del</strong>le virtù che qualificano pienamente all’esercizio <strong>del</strong><br />
potere in democrazia e che dimostrano agli oligarchici l’infondatezza <strong>del</strong>le loro critiche, e infine di<br />
rispettare gli archaioi nomoi, cioè la patrios politeia democratica, si rivela in continuità con quanto già<br />
proposto da Trasibulo nel 412/11, quando egli aveva chiesto ai suoi uomini, impegnati nella<br />
controrivoluzione di Samo, di mè mnesikakein (Tucidide VIII, 73, 6) e li aveva invitati al rispetto rigoroso<br />
dei patrioi nomoi(Tucidide VIII, 76, 6), e con le tematiche di natura religiosa, prima ancora che politica,<br />
emergenti dal discorso di Cleocrito.<br />
Il successo di questo appello, i cui contenuti rivelano una sensibilità peculiare, che considera la<br />
divinità garante <strong>del</strong>l’ordine civile, è attestato da Senofonte (Elleniche II, 4, 43) e da Aristotele (Costituzione<br />
degli Ateniesi 40, 3), i quali ammettono che il popolo restò fe<strong>del</strong>e al giuramento e che la concordia civica<br />
venne rapidamente ristabilita; esso si deve, da una parte, alla riproposizione convinta <strong>del</strong>la teoria<br />
democratica e dei suoi contenuti qualificanti contro le contestazioni <strong>del</strong>la parte avversa; dall’altra al<br />
riferimento ad un’etica innovativa, l’etica <strong>del</strong> <strong>perdono</strong> e <strong>del</strong>la solidarietà, di probabile ispirazione<br />
eleusina, che contrapponendosi efficacemente all’etica tradizionale <strong>del</strong>la <strong>vendetta</strong> rese possibile il rapido<br />
ristabilimento di una serena convivenza civile 8 .<br />
7 Trasibulo sembra riprendere, nella contestazione <strong>del</strong>la presunta superiorità degli oligarchici, anche i contenuti <strong>del</strong> discorso<br />
tenuto davanti all’assemblea di Samo da uno dei capi democratici (Tucidide VIII, 76), forse Trasibulo stesso, a giudicare<br />
dall’insistenza sull’idea di maggioranza e, soprattutto, dal richiamo ai patrioi nomoi).<br />
8 Per i fondamenti religiosi <strong>del</strong>la visione politica di Trasibulo cfr. anche C. Bearzot, Perdonare il traditore La tematica amnistiale<br />
nel dibattito sul richiamo di Alcibiade, in Amnistia, <strong>perdono</strong> e <strong>vendetta</strong> nel mondo antico, CISA 23, Milano 1997, 29-52; Ead., Euripide,<br />
Trasibulo e il dibattito sul richiamo di Alcibiade, in Aspirazione al consenso e azione politica: il caso di Alcibiade (Atti <strong>del</strong> Seminario<br />
interdisciplinare di Storia greca e di Epigrafia greca, Chieti 12-13 marzo 1997), Alessandria 1999, pp. 29-47; A. Ferrari,<br />
Trasibulo e la pietà eleusina. Stasis e idia kerdea nelle Rane di Aristofane, Aevum 74 (2000), 47-52; M. Lodigiani, Perdono e<br />
4
3. MEMORIA, VENDETTA, GIUSTIZIA: LA DIVERSA PROSPETTIVA DI LISIA<br />
Di fronte alla promulgazione <strong>del</strong>l’amnistia, destinata ad evitare l’innescarsi di una spirale di<br />
persecuzioni giudiziarie e di reciproche vendette, e alla proposta di riconciliazione promossa da<br />
Trasibulo su basi politiche ed etico-religiose, non tutti i settori <strong>del</strong>l’opinione pubblica ateniese reagirono<br />
con favore. Molti Ateniesi avevano subito gravissime perdite in termini di affetti umani e di interessi<br />
economici sotto la tirannide dei Trenta, che aveva visto un drammatico susseguirsi di confische,<br />
espulsioni, condanne a morte, eliminazioni sommarie nei confronti di cittadini e meteci di orientamento<br />
democratico. Quindi, se è vero che sostanzialmente l’amnistia fu osservata, è vero anche che vi furono<br />
diversi tentativi di violazione (Aristotele, Costituzione degli Ateniesi 40, 2; Isocrate XVIII, 2) e di<br />
aggiramento. Particolarmente interessante in proposito appare l’atteggiamento di Lisia nei confronti<br />
<strong>del</strong>l’amnistia <strong>del</strong> 403: l’oratore interviene frequentemente in modo critico sulle modalità di applicazione<br />
<strong>del</strong>le convenzioni, in particolare sulle clausole che regolavano il diritto di godere <strong>del</strong>la protezione<br />
amnistiale 9 .<br />
Lisia, che possiamo considerare portavoce <strong>del</strong>l’ala radicale <strong>del</strong> partito democratico, sembra<br />
assumere in diverse occasioni posizioni apparentemente contraddittorie sulla questione ed è stato per<br />
questo accusato di invocare l’amnistia per motivi di comodo e di chiederne poi spregiudicatamente la<br />
violazione, a seconda degli interessi <strong>del</strong>la causa: con un atteggiamento che rivelerebbe più<br />
l’opportunismo <strong>del</strong> logografo che la rigida coerenza <strong>del</strong>l’ideologo. Io credo invece che Lisia sia<br />
sostanzialmente coerente nell’accostare, al sicuro e convinto riconoscimento <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>l’amnistia, il<br />
rifiuto <strong>del</strong>la sua applicazione indiscriminata. Al tema <strong>del</strong>l’<strong>oblio</strong> dei mali subiti egli contrappone con<br />
convinzione il tema <strong>del</strong>la <strong>memoria</strong>, che impone non tanto la <strong>vendetta</strong>, quanto la giustizia.<br />
Le convenzioni d’amnistia vietavano di perseguire, per i reati contro lo stato commessi all’epoca<br />
dei fatti relativi alla caduta <strong>del</strong>la democrazia e all’instaurazione <strong>del</strong>la tirannide, nonché per quelli<br />
commessi nel corso <strong>del</strong> 404/3 10 , qualunque cittadino, ad esclusione degli oligarchi stessi (i Trenta, i<br />
Dieci, i Dieci <strong>del</strong> Pireo, gli Undici) e dei colpevoli di omicidio o di tentato omicidio, purché autocheires<br />
(cioè colpevoli di aver agito direttamente, di propria mano). Per gli oligarchi era prevista la possibilità di<br />
rientrare negli accordi sottoponendosi ad un rendiconto; nulla di questo genere era invece ammesso per<br />
gli omicidi autocheires, a motivo <strong>del</strong>la particolare gravità <strong>del</strong> reato. La seconda categoria risultava però, nei<br />
fatti, estremamente difficile da individuare e da colpire: la necessità di dimostrate rigorosamente<br />
l’autocheiria escludeva infatti dal perseguimento tutti i mandanti e persino molti degli esecutori, e finiva<br />
per trasformare l’amnistia stessa in una sorta di “colpo di spugna” anche di fronte alle responsabilità più<br />
gravi. Il che era peraltro gravido di rischi politici, giacché consentiva un pieno reinserimento nella vita<br />
riconciliazione nei misteri di Eleusi: il caso <strong>del</strong>l’Ippolito euripideo (428 a.C.), RIL 133 (1999), pp. 459-478; C. Bearzot, Il dibattito sul<br />
richiamo di Alcibiade nel teatro ateniese: il Filottete e il Ciclope, in Studi Aricò, in corso di stampa.<br />
9 Cfr. su questi temi C. Bearzot, Lisia e la tradizione su Teramene. Commento storico alle orazioni XII e XIII <strong>del</strong> corpus lysiacum,<br />
Biblioteca di Aevum Antiquum 10, Milano 1997; Ead., Lisia e l’amnistia: lo sfondo politico <strong>del</strong>l’orazione XXV, CISA 23, Milano<br />
1997, pp. 59-77; Ead., Criteri alternativi di applicazione <strong>del</strong>l’amnistia in Lisia, in Responsabilità, <strong>vendetta</strong> e <strong>perdono</strong> nel mondo antico,<br />
CISA 24, Milano 1998, pp. 111-144.<br />
10 A proposito dei termini cronologici <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>l’amnistia – se cioè essa riguardasse anche reati (e quali)<br />
commessi prima <strong>del</strong> 404/3 – appare convincente la ricostruzione di Loening, The Reconciliation Agreement, pp. 121 ss. In base a<br />
tale ricostruzione:<br />
Furono amnistiati i crimini contro lo stato commessi sotto l’oligarchia e anche in precedenza, mentre non furono ritenuti<br />
amnistiabili quanti erano stati già condannati per analoghi crimini prima <strong>del</strong> 404/3 e non erano stati espressamente<br />
perdonati con le misure <strong>del</strong> 405/4 (decreto di Patroclide); analogamente, non si consentì alla sospensione <strong>del</strong>le pene già<br />
irrogate prima <strong>del</strong> 404/3.<br />
Furono esclusi dall’amnistia i responsabili di omicidi diretti (autocheires), commessi sotto l’oligarchia e anche in precedenza.<br />
Per quanto riguarda le contese civili, quelle relative ad illeciti commessi sotto l’oligarchia non sembrano esser state<br />
espressamente vietate, ma probabilmente furono posti dei limiti (per esempio non sarebbero state ammesse contese civili<br />
sulle proprietà confiscate che non si adeguassero ai criteri previsti nelle convenzioni); tali illeciti erano infatti privi di<br />
caratterizzazione politica tale da violare la riconciliazione tra le parti; restavano invece pienamente ammissibili contese di<br />
natura civile per reati commessi prima <strong>del</strong> 404/3.<br />
In sostanza, l’applicazione <strong>del</strong>l’amnistia evidenzia una massima volontà di <strong>perdono</strong> in ambito politico, mentre investe in<br />
forma minima l’ambito civile.<br />
5
politica e civile <strong>del</strong>la restaurata democrazia ateniese anche a persone gravemente compromesse con il<br />
regime e con i <strong>del</strong>itti da esso perpetrati.<br />
La posizione di Lisia sul tema <strong>del</strong>l’amnistia e <strong>del</strong>la sua applicazione si rivela, rispetto a quella di<br />
Trasibulo e soprattutto degli ex-terameniani come Archino 11 , assai meno irenista e più incline ad<br />
individuare e a colpire esemplarmente i responsabili, anche politici, dei reati più gravi. Ma prima di<br />
cercare di definire i “criteri alternativi” proposti da Lisia, è bene chiarire che egli non è contrario<br />
all’amnistia in sé. Lisia non si esprime mai contro l’amnistia e semmai ritiene che le vere violazioni<br />
provengano da parte oligarchica (XVIII, 17-19; XXX, 9) e che siano prive di un autentico fondamento<br />
giuridico, provocate come sono da meschini interessi personali piuttosto che da vera sensibilità per il<br />
bene <strong>del</strong>la comunità. Diverso è l’atteggiamento dei democratici: essi riconoscono il valore <strong>del</strong>l’amnistia<br />
e semmai ne contestano, in casi estremi, le modalità di applicazione, chiedendo che essa venga regolata<br />
da criteri diversi rispetto a quelli <strong>del</strong>le clausole canoniche. Una visione nettamente di parte: ma non per<br />
questo pregiudizialmente inattendibile, giacché, almeno per il suo risvolto positivo (la sostanziale fe<strong>del</strong>tà<br />
mostrata dai democratici rispetto allo spirito e alla lettera <strong>del</strong>l’amnistia), il giudizio di Lisia converge con<br />
quelli di Senofonte e di Aristotele, fonti non certo sospette di simpatie democratiche.<br />
Se, insomma, Lisia coglie con acuta sensibilità i rischi connessi con l’amnistia e con una sua<br />
applicazione troppo generosa, non propone però mai una contestazione di principio <strong>del</strong>l’amnistia<br />
stessa, che viene anzi difesa come strumento di recupero <strong>del</strong>la convivenza democratica. Significativa, in<br />
questo senso, è la testimonianza <strong>del</strong>l’Epitafio (II, 61-66), in cui l’oratore propone un caldo elogio dei<br />
democratici <strong>del</strong> Pireo, che seppero avvalersi <strong>del</strong>l’amnistia come di uno strumento di concordia e di<br />
comune salvezza. Ciò basta, io credo, a dimostrare che Lisia non ha nulla contro l’amnistia in sé, di cui<br />
offre in questo passo una valutazione estremamente positiva e sostanzialmente convergente con le linee<br />
di ispirazione <strong>del</strong> suo promotore Trasibulo: sono semmai le modalità <strong>del</strong>la sua applicazione a non<br />
convincere Lisia, perché troppo generose e perché esposte a rischi di strumentalizzazione da parte<br />
antidemocratica. Era dunque compito dei democratici applicare le convenzioni d’amnistia con<br />
sensibilità e attenzione ai singoli casi, assicurandone la fruizione solo a chi ne avesse davvero diritto, e<br />
cioè a quanti non si erano piegati a collaborare fattivamente con il regime, ed evitando generalizzazioni<br />
“garantiste”, che si risolvessero in una eccessiva generosità verso quei collaborazionisti che avevano<br />
condiviso responsabilità di governo e si erano resi complici di reati contro i concittadini, e che quindi<br />
condizionassero pesantemente la rinascente democrazia.<br />
Il corpus lisiano reca le tracce di un articolato tentativo di ridiscutere la questione <strong>del</strong>l’amnistia,<br />
partendo da un’accettazione generale <strong>del</strong>le convenzioni e <strong>del</strong> loro valore, ma discutendone i criteri di<br />
applicazione: il diritto di godere <strong>del</strong>la protezione amnistiale andava regolato su basi diverse da quelle<br />
fissate nei patti, che tenessero conto <strong>del</strong> grado di collaborazione con il regime di quanti fra “quelli <strong>del</strong>la<br />
città” chiedevano, dopo la restaurazione, una piena reintegrazione nella comunità politica e civile. Lisia<br />
individua così criteri alternativi a quelli “trasibulei” e consistenti, in sostanza, nell’ampliamento dei<br />
margini di perseguibilità. Tale proposta, che colloca peraltro Lisia in linea con altre voci di parte<br />
democratica 12 , consiste in concreto nel riconoscere il godimento <strong>del</strong>l’amnistia non, come volevano le<br />
convenzioni, a qualunque cittadino che non fosse stato oligarca (salvo previo rendiconto) e che non si<br />
fosse macchiato di reati di sangue in qualità di autocheir, ma soltanto a coloro di cui si potesse dimostrare<br />
che non avevano avuto parte alcuna nel governo oligarchico, ricoprendovi una qualsiasi carica<br />
istituzionale, e che non avevano commesso reati gravi (non necessariamente i soli reati di omicidio o di<br />
tentato omicidio autocheir) verso i concittadini.<br />
Con ciò, Lisia si mostra in aperto disaccordo con la diversa impostazione data alle convenzioni<br />
da Trasibulo sotto la pressione degli ex-terameniani come Archino: un’impostazione caratterizzata da<br />
un’estrema generosità – giacché pochissimi risultavano perseguibili in base alle rigide clausole stabilite<br />
11 I seguaci di Teramene, protagonista dei colpi di stato oligarchici <strong>del</strong> 411 e <strong>del</strong> 404, dopo la morte <strong>del</strong> loro leader a seguito<br />
<strong>del</strong>lo scontro con Crizia, si erano uniti ai fuorusciti democratici; ora essi, essendo compromessi con il regime, avevano tutto<br />
l’interesse ad una applicazione rigorosa <strong>del</strong>le convenzioni.<br />
12 Come rivelano [Lys.]VI, nello stesso contesto <strong>del</strong>l’amnistia <strong>del</strong> 403, ma anche [Lys.] XX, che rimanda invece al più antico<br />
contesto postoligarchico <strong>del</strong> 410: cfr. C. Bearzot, La XX orazione pseudolisiana e la “prima restaurazione” <strong>del</strong>la democrazia nel 410,<br />
in Studium atque urbanitas. Miscellanea Daris, Papyrologica Lupiensia 9 (2000), Galatina (LE) 2001, pp. 85-99; Ead., La sesta<br />
orazione pseudolisiana e il suo contributo al dibattito sull’amnistia, in Poikilma. Studi Catau<strong>del</strong>la, I, La Spezia 2002, pp. 89-109.<br />
6
dalle convenzioni – e destinata a favorire la ricomposizione politica non solo con i Tremila, ma anche<br />
con gran parte dei fautori <strong>del</strong>l’oligarchia e dei loro collaboratori.<br />
I criteri alternativi cui Lisia fa costante riferimento almeno come indicazione pragmatica, pur<br />
non potendone offrire una formulazione teorica che si contrapponesse espressamente al testo <strong>del</strong>le<br />
convenzioni, non vanno ritenuti espressione di radicalismo e sono meritevoli di apprezzamento da<br />
diversi punti di vista. Essi infatti identificano con chiarezza i reati non amnistiabili (mentre nelle<br />
convenzioni la necessità di dimostrare l’autocheiria degli omicidi equivaleva alla rinuncia a perseguire i<br />
mandanti e, a distanza di tanto tempo, anche molti responsabili diretti); sono ispirati a sostanziale<br />
moderazione (si intendeva colpire solo le responsabilità davvero gravi, si trattasse di omicidi e tentati<br />
omicidi oppure di altri reati contro le persone, come arresti, spoliazioni, <strong>del</strong>azioni, forme di<br />
favoreggiamento o di persecuzione); sono, infine, non privi di valore politico (il loro obiettivo<br />
fondamentale risiedeva nella volontà di impedire lo sfruttamento pretestuoso di uno strumento in sé<br />
eticamente valido e politicamente opportuno, quale era l’amnistia, da parte di ambigui personaggi alla<br />
ricerca di rilegittimazione politica).<br />
Di un simile sfruttamento, i primi anni <strong>del</strong>la restaurazione sembrano offrire una testimonianza<br />
frequente: ad esso Lisia contrappone non certo il ricorso alla spirale <strong>del</strong>le vendette sommarie e<br />
indiscriminate, quanto la via, pienamente legalitaria, <strong>del</strong>la legittima timoria (termine che indica la <strong>vendetta</strong><br />
ottenuta “secondo le leggi”) attraverso il perseguimento in sede giudiziaria di quanti risultassero non<br />
amnistiabili in base ai criteri da lui indicati.<br />
La via alternativa proposta da Lisia, umanamente comprensibile e politicamente non priva di<br />
valore, si differenzia da quella di Trasibulo per la sua impostazione fortemente legata alla dimensione<br />
politica e incapace di rinunciare alla tradizionale etica <strong>del</strong>la <strong>vendetta</strong>. Per capire la posizione di Lisia, è<br />
interessante un confronto con le perorazioni finali <strong>del</strong>le orazioni XII (Contro Eratostene) e XIII (Contro<br />
Agorato): dominate dai concetti di <strong>memoria</strong> (in opposizione all’<strong>oblio</strong> <strong>del</strong> mè mnesikakein) e di <strong>vendetta</strong><br />
(giudiziaria, e dunque, non indiscriminata, ma comunque alternativa al <strong>perdono</strong>), esse ripropongono la<br />
tradizionale etica politica greca, che considera la <strong>vendetta</strong> legittima e anzi, in alcuni casi, addirittura<br />
necessaria.<br />
Nell’orazione XII (Contro Eratostene, uno dei Trenta) la perorazione finale si apre con un appello<br />
ai due partiti, quello “<strong>del</strong>la città” e quello “<strong>del</strong> Pireo”. Nel rivolgersi al “partito <strong>del</strong>la città”, Lisia<br />
introduce immediatamente il tema <strong>del</strong>la <strong>memoria</strong>: non la dimenticanza <strong>del</strong> male subito, ma la sua<br />
<strong>memoria</strong> (anamimneskein) e il conseguente rancore (orgizesthai) devono guidare il voto dei giudici in<br />
tribunale, a qualunque partito appartengano. I due partiti sono così idealmente affratellati nella <strong>vendetta</strong><br />
e nel ripudio <strong>del</strong> presente passato politico, un ripudio che non passa attraverso l’<strong>oblio</strong>, ma attraverso la<br />
<strong>memoria</strong>. Questo tema si sviluppa pienamente nell’appello al “partito <strong>del</strong> Pireo”, tutto giocato sui temi<br />
<strong>del</strong>la <strong>memoria</strong>, <strong>del</strong> mantenimento <strong>del</strong> rancore, <strong>del</strong>la <strong>vendetta</strong>, in netta contrapposizione con l’appello di<br />
Trasibulo ai suoi a non violare il giuramento di mè mnesikakein. I democratici vengono sollecitati da Lisia<br />
non a “dimenticare il male subito”, ma piuttosto a “ricordare” le vicende più dolorose <strong>del</strong> governo dei<br />
Trenta, e a “conservare il rancore”. Lisia insiste in particolare sulla <strong>memoria</strong> <strong>del</strong>le azioni empie dei<br />
Trenta (l’uccisione di uomini strappati dagli altari o dalle braccia dei familiari, l’impossibilità di dar loro<br />
degna sepoltura, la persuasione di essere al di sopra <strong>del</strong>le leggi divine), che li rendono indegni di fruire<br />
<strong>del</strong>l’amnistia: l’empietà dei Trenta dimostra che non l’osservanza dei giuramenti d’amnistia, ma la<br />
<strong>vendetta</strong> dei morti è il solo scrupolo religioso meritevole di essere osservato. E proprio le vittime dei<br />
Trenta sono evocate nel finale, come fossero presenti per chiedere con forza, ai sopravvissuti, la<br />
<strong>vendetta</strong> che si attendono.<br />
Anche nella perorazione conclusiva <strong>del</strong>l’orazione XIII (Contro Agorato, un collaboratore dei<br />
Trenta) Lisia propone una contestazione <strong>del</strong>l’amnistia, in perfetta consonanza con l’orazione XII, e<br />
pone al centro <strong>del</strong>la sua argomentazione il tema <strong>del</strong>la <strong>vendetta</strong> e <strong>del</strong>la sua legittimità tanto politica<br />
quanto etico-religiosa. A livello politico, la <strong>vendetta</strong> trova le proprie ragioni nella necessità di dare un<br />
chiaro segnale di presa di distanza dall’esperienza oligarchica attraverso una condanna esemplare; a<br />
livello religioso, essa si giustifica attraverso il riferimento agli elementi di una religiosità diversa da quella<br />
che sosteneva l’amnistia. Trasibulo aveva impegnato fortemente gli Ateniesi al rispetto <strong>del</strong>l’amnistia con<br />
un giuramento; Lisia cerca di offrire alla sua diversa posizione una giustificazione religiosa attraverso il<br />
7
iferimento all’etica tradizionale, che privilegiava la <strong>vendetta</strong> sul <strong>perdono</strong>. Tornano, quindi, i temi <strong>del</strong>la<br />
piena legittimità, e anzi <strong>del</strong> dovere, <strong>del</strong>la <strong>vendetta</strong>, e <strong>del</strong>la <strong>memoria</strong> <strong>del</strong>le sciagure pubbliche e private<br />
subite dalla città e dai singoli, che alla <strong>vendetta</strong> devono muovere; l’argomentazione tradisce il timore che<br />
si affermi un pericoloso irenismo, inadeguato a distinguere fra i diversi gradi di responsabilità e<br />
orientato pertanto non a superare il passato, in funzione <strong>del</strong>la rinnovata concordia civica, ma a<br />
cancellarne inopportunamente la <strong>memoria</strong>. Il dovere religioso di vendicare i morti viene presentato,<br />
come nella conclusione <strong>del</strong>la XII, come l’unico scrupolo religioso cui i democratici devono sentirsi<br />
legati, meritevole di essere privilegiato anche rispetto all’obbligo costituito dal giuramento di osservare<br />
l’amnistia. Lisia non nega la necessità <strong>del</strong>la riconciliazione, ma ne considera presupposto ineludibile la<br />
condanna per via giudiziaria dei responsabili dei reati più gravi (non solo gli oligarchi e gli omicidi<br />
autocheires, ma anche i mandanti e tutti quanti hanno in qualche modo causato la morte di cittadini<br />
democratici con azioni anche indirette); mentre non gli appare accettabile la prospettiva di Trasibulo,<br />
che privilegia il <strong>perdono</strong> sulla giustizia e considera il recupero <strong>del</strong>la concordia civica un obiettivo da<br />
realizzare a qualsiasi costo. Due posizioni che si propongono sia come l’applicazione di una diversa<br />
prospettiva politica, sia come una diversa e alternativa proposta etico-religiosa.<br />
4. CONCLUSIONI<br />
L’atteggiamento <strong>del</strong> mondo politico ateniese di fronte all’amnistia appare dunque tutt’altro che<br />
unanime. Alla rivendicazione <strong>del</strong>la necessità <strong>del</strong>l’<strong>oblio</strong> per poter procedere, attraverso il <strong>perdono</strong>, alla<br />
riconciliazione nazionale, si contrappone quella <strong>del</strong>la necessità <strong>del</strong>la <strong>memoria</strong>, presupposto <strong>del</strong>la<br />
<strong>vendetta</strong> (se pure per via rigorosamente giudiziaria) e <strong>del</strong>la riaffermazione <strong>del</strong>la giustizia, senza la quale<br />
non appare possibile una vera ricomposizione <strong>del</strong>le fratture civiche. Entrambe queste prospettive, di<br />
carattere politico, non possono essere scisse da questioni religiose. L’<strong>oblio</strong> voluto da Trasibulo sembra<br />
trovare il suo fondamento etico nelle suggestioni religiose promananti dalla pietà eleusina; la <strong>memoria</strong><br />
richiesta insistentemente da Lisia rimanda invece all’etica tradizionale legata alla religione olimpica.<br />
Entrambe le posizioni hanno, in verità, buone ragioni dalla loro parte. Trasibulo, operando una<br />
trasposizione di valori religiosi nel contesto <strong>del</strong>l’esperienza politica e sociale <strong>del</strong> cittadino che si rivelò<br />
ricca di potenzialità positive per il futuro <strong>del</strong>la comunità civica ateniese, permise ad Atene di superare la<br />
crisi politica e morale che l’aveva travolta sullo scorcio <strong>del</strong> V secolo: la forza le venne proprio dalla<br />
concordia faticosamente riconquistata, non senza resistenze e tensioni, attraverso la rigorosa osservanza<br />
<strong>del</strong> mè mnesikakein. Ma alla prospettiva di Lisia, forse meno innovativa e meno affascinante sul piano<br />
etico, va riconosciuto il merito di aver tenuto alta l’attenzione sul rischio <strong>del</strong> “colpo di spugna” su<br />
vicende troppo gravi e dolorose per essere davvero “dimenticate”, e di aver insistito sulla necessità di<br />
evitare un’impunità generalizzata per i responsabili e di non rinunciare ad affermare le esigenze <strong>del</strong>la<br />
giustizia, almeno nei casi più gravi. Nel suo impegno come oratore giudiziario negli anni <strong>del</strong>la<br />
restaurazione, Lisia mostra una costante e coerente riproposizione <strong>del</strong> valore di mneme, orghé e timoria,<br />
“<strong>memoria</strong>”, “rancore” e “giustizia”. L’eco <strong>del</strong>la sua richiesta di non eccedere nella disponibilità all’<strong>oblio</strong><br />
e di dare spazio alla <strong>memoria</strong> ritorna nell’esordio <strong>del</strong>l’orazione XXXIV, giuntaci frammentaria: qui<br />
l’oratore per cui Lisia scrive, un uomo politico in vista di parte democratica che contesta la proposta di<br />
riduzione <strong>del</strong> corpo civico ai proprietari terrieri avanzata dal terameniano Formisio, mentre si<br />
rammarica <strong>del</strong> fatto che le passate sciagure non costituiscano ancora per la città una “lezione<br />
sufficiente”, si rivolge ai concittadini meravigliandosi di loro, in quanto essi sono “gli uomini fra tutti<br />
più pronti a dimenticare”. La proposta di Formisio, che a poca distanza dalla fine <strong>del</strong>la guerra civile<br />
presentava una riforma costituzionale apertamente antidemocratica, è la miglior dimostrazione <strong>del</strong>le<br />
buone ragioni di Lisia, quando esorta a non limitarsi a “dimenticare il male subito” e a mantenere,<br />
invece, la <strong>memoria</strong> <strong>del</strong>le vicende passate. Tanto più che non necessariamente <strong>memoria</strong> e giustizia sono<br />
per lui incompatibili con le esigenze <strong>del</strong>la riconciliazione nazionale.<br />
Cinzia Bearzot<br />
Università Cattolica <strong>del</strong> Sacro Cuore – Milano<br />
8


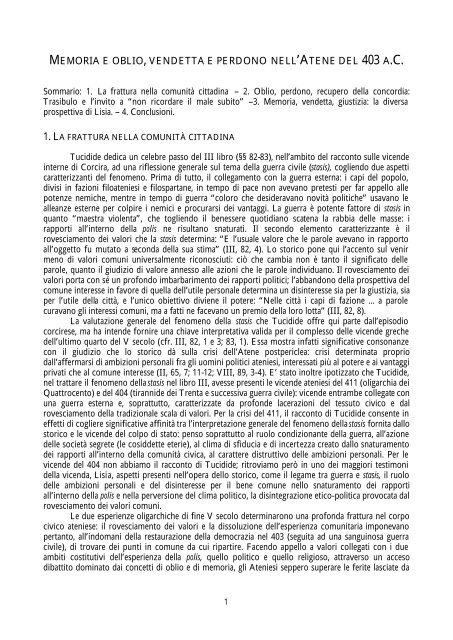





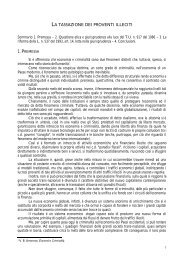








![POLITICA ED ECONOMIA [1970] - Rivista S.S.E.F.](https://img.yumpu.com/46476498/1/184x260/politica-ed-economia-1970-rivista-ssef.jpg?quality=85)