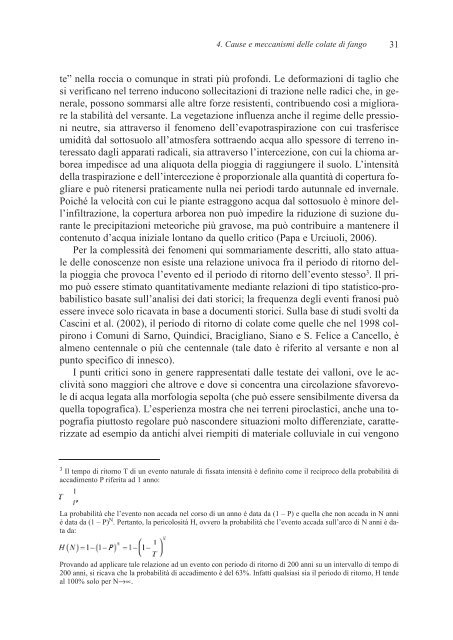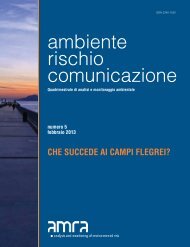Un laboratorio integrato finalizzato allo studio delle colate di ... - Amra
Un laboratorio integrato finalizzato allo studio delle colate di ... - Amra
Un laboratorio integrato finalizzato allo studio delle colate di ... - Amra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4. Cause e meccanismi <strong>delle</strong> <strong>colate</strong> <strong>di</strong> fango<br />
te” nella roccia o comunque in strati più profon<strong>di</strong>. Le deformazioni <strong>di</strong> taglio che<br />
si verificano nel terreno inducono sollecitazioni <strong>di</strong> trazione nelle ra<strong>di</strong>ci che, in generale,<br />
possono sommarsi alle altre forze resistenti, contribuendo così a migliorare<br />
la stabilità del versante. La vegetazione influenza anche il regime <strong>delle</strong> pressioni<br />
neutre, sia attraverso il fenomeno dell’evapotraspirazione con cui trasferisce<br />
umi<strong>di</strong>tà dal sottosuolo all’atmosfera sottraendo acqua <strong>allo</strong> spessore <strong>di</strong> terreno interessato<br />
dagli apparati ra<strong>di</strong>cali, sia attraverso l’intercezione, con cui la chioma arborea<br />
impe<strong>di</strong>sce ad una aliquota della pioggia <strong>di</strong> raggiungere il suolo. L’intensità<br />
della traspirazione e dell’intercezione è proporzionale alla quantità <strong>di</strong> copertura fogliare<br />
e può ritenersi praticamente nulla nei perio<strong>di</strong> tardo autunnale ed invernale.<br />
Poiché la velocità con cui le piante estraggono acqua dal sottosuolo è minore dell’infiltrazione,<br />
la copertura arborea non può impe<strong>di</strong>re la riduzione <strong>di</strong> suzione durante<br />
le precipitazioni meteoriche più gravose, ma può contribuire a mantenere il<br />
contenuto d’acqua iniziale lontano da quello critico (Papa e Urciuoli, 2006).<br />
Per la complessità dei fenomeni qui sommariamente descritti, <strong>allo</strong> stato attuale<br />
<strong>delle</strong> conoscenze non esiste una relazione univoca fra il periodo <strong>di</strong> ritorno della<br />
pioggia che provoca l’evento ed il periodo <strong>di</strong> ritorno dell’evento stesso 3 . Il primo<br />
può essere stimato quantitativamente me<strong>di</strong>ante relazioni <strong>di</strong> tipo statistico-probabilistico<br />
basate sull’analisi dei dati storici; la frequenza degli eventi franosi può<br />
essere invece solo ricavata in base a documenti storici. Sulla base <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> svolti da<br />
Cascini et al. (2002), il periodo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> <strong>colate</strong> come quelle che nel 1998 colpirono<br />
i Comuni <strong>di</strong> Sarno, Quin<strong>di</strong>ci, Bracigliano, Siano e S. Felice a Cancello, è<br />
almeno centennale o più che centennale (tale dato è riferito al versante e non al<br />
punto specifico <strong>di</strong> innesco).<br />
I punti critici sono in genere rappresentati dalle testate dei v<strong>allo</strong>ni, ove le acclività<br />
sono maggiori che altrove e dove si concentra una circolazione sfavorevole<br />
<strong>di</strong> acqua legata alla morfologia sepolta (che può essere sensibilmente <strong>di</strong>versa da<br />
quella topografica). L’esperienza mostra che nei terreni piroclastici, anche una topografia<br />
piuttosto regolare può nascondere situazioni molto <strong>di</strong>fferenziate, caratterizzate<br />
ad esempio da antichi alvei riempiti <strong>di</strong> materiale colluviale in cui vengono<br />
3 Il tempo <strong>di</strong> ritorno T <strong>di</strong> un evento naturale <strong>di</strong> fissata intensità è definito come il reciproco della probabilità <strong>di</strong><br />
acca<strong>di</strong>mento P riferita ad 1 anno:<br />
La probabilità che l’evento non accada nel corso <strong>di</strong> un anno è data da (1 – P) e quella che non accada in N anni<br />
è data da (1 – P) N . Pertanto, la pericolosità H, ovvero la probabilità che l’evento accada sull’arco <strong>di</strong> N anni è data<br />
da:<br />
Provando ad applicare tale relazione ad un evento con periodo <strong>di</strong> ritorno <strong>di</strong> 200 anni su un interv<strong>allo</strong> <strong>di</strong> tempo <strong>di</strong><br />
200 anni, si ricava che la probabilità <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento è del 63%. Infatti qualsiasi sia il periodo <strong>di</strong> ritorno, H tende<br />
al 100% solo per N→∝.<br />
31